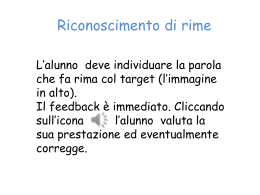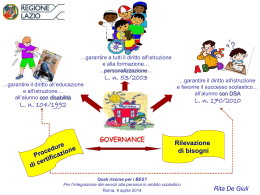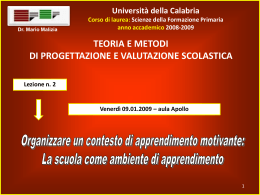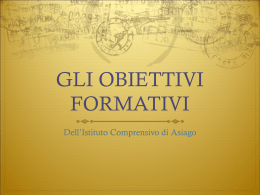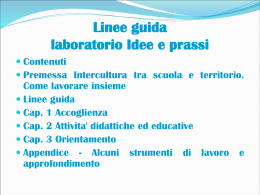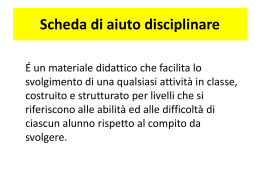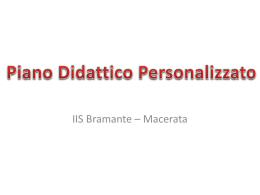STRATEGIE INCLUSIVE: APPRENDIMENTO COOPERATIVO E METACOGNIZIONE Insegnante Nicola Molteni – docente specializzato CTRH BRESCIA CENTRO, 8 maggio 2014 DIDATTICA INCLUSIVA … DIDATTICA PER TUTTI? DIDATTICA PER CIASCUNO? DIDATTICA DIFFERENZIATA / PERSONALIZZATA PER CIASCUNO? NUOVA DIDATTICA? NUOVI APPROCCI DIDATTICI? NUOVI DOCENTI? NUOVA SCUOLA? QUALI FINALITA‟? QUALI RUOLI? UN ESEMPIO … “La situazione” • Contesto classe: 1^ scuola primaria; 25 alunni, di cui 5 con difficoltà (20%). Tra questi: 1 diversamente abile (ipoacusia bilaterale profonda), 1 alunno con “disturbi del comportamento”, 1 alunno segnalato ai Servizi minorili; 1 alunna straniera arrivata a scuola a gennaio; 1 alunno inviato da logopedista per approfondimento diagnostico. Contesto scuola: struttura nuova (soli 4 anni), spazi limitati per numero e dimensione. • Risorse: 3 docenti curricolari con una ora di copresenza settimanale; 1 docente di IRC; 1 docente di sostegno per 11 ore settimanali; 1 educatore per 6 ore settimanali dal mese di gennaio. UN ESEMPIO … Obiettivi cognitivi 1. Comprendere il compito 2. Recuperare strategie già possedute 3. Conoscere strategie 4. Usare strategie 5. Monitorare strategie Principi generali attività di insegnamento • Far acquisire fiducia in sé • Porre al centro l’impegno in prima persona • Favorire l’autovalutazione • Considerare la valutazione come occasione per apprendere • Far acquisire fiducia negli altri Principi generali per lo svolgimento delle attività • Considerare la tempistica • Suscitare interesse proponendo stimoli con dissonanza cognitiva • Utilizzare mediatori diversi: attivi, simbolici, analogici… • Utilizzare varie forme organizzative: - apprendimento cooperativo - laboratori per gruppi omogenei - lezione frontale 5. Considerare le modalità di rilevazione degli apprendimenti e la conseguente valutazione UN ESEMPIO di organizzazione Obiettivo didattico: comporre e scomporre in da e u entro il 20 Livelli di acquisizione e competenze: - un gruppo di 5 alunni con ottima padronanza - un gruppo di 15 alunni con sufficiente/buona padronanza - un gruppo di alunni con appena sufficiente/scarsa padronanza Strategie già utilizzate: - mediatori attivi/concreti - mediatori simbolici Tipologia di lezione: - frontale - a coppie per esercitazione Verifiche svolte: - Individuali, orali (manipolazione materiale) e scritte UN ESEMPIO di attività: “La decina” Gruppo Potenziamento (1 da 5 alunni) Gruppi Consolidamento (3 da 5 alunni) Gruppo Recupero (1 da 5 alunni) Scomposizione in da e u entro il 50 con uso di schede Scomposizione in da e u entro il 20 con uso di schede Scomposizione in da e u entro il 20 con abaco Composizione di quantità entro il 50 con uso di schede Composizione di quantità entro il 20 con uso di schede Composizione di quantità entro il 20 con abaco Addizione e sottrazione con da e u entro il 50 con uso di schede Addizione e sottrazioni con da e u entro il 20 con uso di schede Addizione e sottrazioni con da e u entro il 20 con abaco (eventuale uso di software didattico) Tempi 3 unità di lavoro da 40 minuti ciascuna nel corso di due settimane. Spazi Risorse Aula classe per gruppi di potenziamento e consolidamento Docente di classe Aula esterna o aula LIM per gruppo di recupero Docente di sostegno Il docente di classe e quello per le attività di sostegno possono intercambiare i ruoli. Le attività sono selezionate all‟interno di una progettazione comune e condivisa. In assenza del docente di sostegno, le attività sono svolte in aula classe e gli spazi vengono organizzati in maniera funzionale. Al termine del breve percorso è prevista un verifica individuale orale o scritta. La verifica sarà differenziata in base al livello di padronanza. MODELLO SOCIALE DELLE DIFFERENZE INDIVIDUALI Tutti i bambini possono imparare e tutti i bambini sono tra loro diversi” (UNESCO) DIVERSITA‟ come elemento non discriminante. STILI DI APPRENDIMENTO diversi DIFFERENZE = RISORSE Le LINEE GUIDA per l’INTEGRAZIONE SCOLASTICA degli ALUNNI CON DISABILITA’ (4 agosto 2009) Struttura Capitolo 1 Riferimenti normativi: - Art. 3 e 34 Costituzione - Legge 118/71 e Legge 517/77 - Legge 104/92 - DPR 24 febbraio 1994 Capitolo 2 L‟organizzazione: USR / Rapporti interistituzionali Capitolo 3 La dimensione inclusiva della scuola: - Il ruolo del dirigente scolastico - La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti - Il personale ATA e l‟assistenza di base - La collaborazione con le famiglie PAROLE CHIAVE delle LINEE GUIDA FLESSIBILITA’: - Organizzativa : struttura scuola / classe / orario - Didattica: uso di strategie e strumenti comuni, personalizzati e individualizzati PROGETTO DI VITA: Orientamento fin dall‟ingresso nel sistema scolastico OBIETTIVI A LUNGO TERMINE Correlazione con il PEI Globalità della PERSONA Creazione di una RETE per l’inclusione CORRESPONSABILITA’: - Non solo “a carico del docente di sostegno - Ruolo e funzione del docente di sostegno - Ruolo e funzione dell‟assistente educatore - Ruolo e funzione del personale ausiliario CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTO ICF SOSTEGNO “A”… MODELLO ALUNNO IN SITUAZIONE DI HANDICAP INSEGNANTE = TUTOR INSEGNANTI DI CLASSE INSEGNANTE=APPOGGIO INTERVENTO Interventi individuali Rapporto 1/1 Trattamenti specialistici Delega Interventi settoriali Scarsa autonomia settoriale Rapporto di dipendenza sostegno/classe ALLA CLASSE ALLA SCUOLA INSEGNANTE = RISORSA Corresponsabilità Collaborazione Con titolarità Flessibilità organizzativa Progettualità Programmazione collegiale Impegno diversificato di competenze INSEGNANTE = RISORSA AL “SISTEMA” SCUOLA AL “SISTEMA” SCUOLA / TERRITORIO INSEGNANATE = RISORSA QUALIFICATA E RESPONSABILE D‟ AREA • Individuazione dei nodi Lavoro congiunto di ricerca strategie e tecniche Collaborazione progettuale Miglioramento del tessuto relazionale Costruzione di un efficace ambiente educativo Interfaccia tra scuola ed extrascuola INSEGNANTE DI SOSTEGNO ANALIZZA AVVICINA STIMOLA obiettivi della classe con docente curricolare obiettivi individuali a quelli della classe clima di interazione e inclusione SCEGLIE quelli più adatti all‟alunno ADATTA le attività (materiali, strumenti tempi…) INSEGNANTE DI CLASSE RIPASSO / APPROFONDIMENTO aspetto del programma già affrontato PERCORSI METACOGNITIVI rispetto a strategie e processi ESPERIENZE COLLABORATIVE - tutoring tra alunni - apprendimento cooperativo OPERATIVITA’ estesa a tutte le discipline BES DIDATTICA APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO INTERAZIONE TUTORING Apprendimento cooperativo I WEBQUEST LEARNING TOGETHER COMPITI POLIRISOLVIBILI SOSTITUZIONE FACILITAZIONE METACOGNIZIONE SEMPLIFICAZIONE NUCLEI FONDANTI CULTURA DEL COMPITO DIDATTICA COMUNE MODALITA’ PIU’ INCLUSIVE ATTIVITA’ INCLUSIVITA’ Apprendimento cooperativo - Ruoli sostenibili - Partecipazione al compito Didattica per problemi reali - Componente di attivazione - Componente di scoperta Contatto tra competenze curricolo e competenze alunno - Obiettivi disciplinari comuni - Partecipazione al compito Adattamento obiettivi curricolari - Avvicinamento esigenze dell‟alunno - Partecipazione al compito PERCORSI EDUCATIVI E RELAZIONALI COMUNI LABORATORI CREATIVI, ESPRESSIVI, PRODUTTIVI TIPOLOGIA GRUPPI ATTIVITA’ Gruppi omogenei rispetto a un problema o compito - Stimolazione metafonologica - Esercitazione sulle quattro operazioni - Ripasso proprietà operazioni Gruppi eterogenei rispetto al compito - Costruzione di un libro, di una guida turistica… - Laboratorio di geografia: lo studio delle regioni - Laboratorio scientifico : esperimenti DIDATTICA INDIVIDUALE EFFETTUATA IN RAPPORTO UNO A UNO ATTORI OBIETTIVI Docente sostegno / alunno - Rinforzo - Acquisizione nuovi obiettivi - Semplificazione attività Docente classe / alunno - Rinforzo - Acquisizione nuovi obiettivi - Semplificazione attività Alunno tutor / alunno con BES - Rinforzo su obiettivi conosciuti - Acquisizione conoscenze/ abilità non possedute NON NECESSARIAMENTE IN SPAZI ESTERNI ALLA CLASSE PERCORSI EDUCATIVI E RELAZIONALI INDIVIDUALI IN RAPPORTO UNO A UNO ATTORI ANCHE IN SPAZI ESTERNI ALLA CLASSE OBIETTIVI Docente sostegno / alunno - Autonomia personale - Orientamento nell‟ambiente scolastico - Competenze comunicative - Competenze relazionali - Autonomia sociale - Competenze minime di apprendimento Educatore / alunno - Autonomie (personale e sociale) - Competenze comunicative - Competenze relazionali PERCORSI DIDATTICI PERCORSI PERSONALIZZATI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI PERCORSI INTEGRATIVI OBIETTIVI COMUNI ALLA CLASSE OBIETTIVI DIFFERENZIATI IN PARTE O COMPLETAMENTE OBIETTIVI PERSONALIZZATI E INDIVIDUALIZZATI ATTIVITA‟ PERSONALE E DI GRUPPO ATTIVITA‟ IN ATTIVITA‟ LIBERE PICCOLO GRUPPO E ATTIVITA‟ DI GRUPPO INDIVIDUALE - RICERCA - CONSOLIDAMENTO - RECUPERO -APPROFONDIMENTO - INTERVENTI DI SOSTEGNO - INTERVENTI COMPENSATIVI - CONTENUTI COLLEGATI O MENO AL CURRICOLO - SOCIALIZZAZIONE IL DOCENTE INCLUSIVO: le metodologie INTERAZIONI PROSOCIALI AVVICINAMENTO PROGRAMMAZIONI AUTOREGOLAZIONE COGNITIVA APPRENDIMENTO COOPERATIVO ADATTAMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGIE METACOGNITIVE TUTORING ADATTAMENTO DEI MATERIALI PRODOTTI E PROCESSI IL DOCENTE INCLUSIVO: le azioni CREARE un clima inclusivo: accettazione e rispetto delle diversità ADATTARE stile insegnamento, materiali, tempi, tecnologie SVILUPPARE approccio cooperativo SVILUPPARE didattica metacognitiva TROVARE punti contatto tra le programmazioni (classe e individualizzata) MODIFICARE strategie in itinere FAVORIRE la creazioni di reti relazionali (famiglia, territorio, specialisti…) Passare a una DIDATTICA INCLUSIVA APPRENDIMENTO COOPERATIVO = INTEGRAZIONE SOSTENIBILE NON SOLO rivolta ad alunni con abilità e competenze adeguate ma a TUTTA LA CLASSE. Rispetto dell‟INDIVIDUALITA‟ di ciascun soggetto INTEGRAZIONE delle differenti caratteristiche : conoscenze, abilità, competenze LE DIVERSITA’ STIMOLANO L’APPRENDIMENTO “Si può definire il Cooperative Learning come un insieme di tecniche di conduzione della classe grazie alle quali gli studenti lavorano in piccoli gruppi per attività di apprendimento e ricevono valutazioni in base ai risultati acquisiti “. Comoglio - Cardoso “Ciò che il bambino può fare in cooperazione oggi, può farlo da solo domani “ . Vygotskij Le dinamiche cooperative si realizzano attraverso strategie e tecniche di attivazione dei gruppi, di collaborazione, di cooperative learning, di turoring. Insegnamento tradizionale Insegnamento con gruppo cooperativo LAVORARE DA SOLI LAVORARE CON GLI ALTRI LAVORARE PER CHI NON FA NULLA AVERE UNA PROPRIA RESPONSABILITA‟ APPROFITTARE DEGLI ALTRI AVERE AIUTO DAGLI ALTRI L‟INTERAZIONE con compagni più capaci favorisce la ZONA PROSSIMALE DI SVILUPPO, definita come “distanza tra livello di sviluppo effettivo e livello di sviluppo potenziale dell‟alunno ottenibile attraverso attività di problem solving svolte sotto la guida di un adulto o di compagni più capaci”. Vygotsky Il ruolo del DOCENTE Il docente cambia la scuola cambia Da TRASMETTITORE e DEPOSITARIO di conoscenze a FACILITATORE ORGANIZZATORE PROCESSI DI APPRENDIMENTO … Esperienze di tutoring TUTOR TUTEE RAPPORTO Alunno senza difficoltà Alunno disabile Asimmetrico Rinforzo Alunno disabile Alunno disabile A specchio Demotivante Alunno disabile Alunno senza difficoltà Asimmetrico Rinforzo Alunno della classe Alunno della classe Compagno della classe Omogeneo/Eterogeneo Approf./Rinforzo Alunno di classe “inferiore” Asimmetrico Rinforzo IL TUTORING E’ UNO STRUMENTO PER FAVORIRE RELAZIONI TRA ALUNNI CON ABILITA’ DIVERSE. VANTAGGI PER ALUNNO CON DIFFICOLTA’: - riceve aiuto da compagni “più bravi” , “più competenti” - consegue obiettivi personalizzati - percepisce le situazioni in cui è coinvolto come accessibili perché sono mediate da un compagno e non dall‟adulto - assumendo ruolo di tutor comprende che è in grado di “fare qualcosa di importante” VANTAGGI PER ALUNNO SENZA DIFFICOLTA’: - sviluppa un nuovo senso di competenza personale - acquisisce una maggior padronanza dei concetti e dei processi insegnati Riferimenti a Comoglio, Kagan, Sharan Caratteristiche del PEER TUTORING 1. SCELTA del tutor e del tutee 2. FORMAZIONE delle coppie 3. SCELTA e distribuzione del materiale 4. DURATA dell‟intervento di peer tutoring (la coppia rimane la medesima fino a che l‟intervento non si è concluso) 5. ALLENAMENTO del tutor (attraverso modeling): - stabilire regole da rispettare - chiarire l‟obiettivo dell‟interevento di tutoring - insegnare a rinforzare le risposte corrette - dare suggerimenti su come intervenire in caso di comportamenti problema - facilitare l‟autovalutazione 6. AMBIENTE FISICO : dove? Strategie per favorire l’apprendimento e l’interazione sociale PEER TUTORING (coppia) • ripropone modello insegnante/alunno: un elemento conosce la soluzione del compito • lavoro a coppia • ruoli di tutor e tutee • attività in classe • docente come fornitore di compiti PEER COLLABORATION (da 2 a 5 studenti) • ripropone modello dell‟apprendimento cooperativo • lavoro a coppia o in piccolo gruppo, attività in classe • risoluzione del compito non conosciuta, ricerca collaborativa di strategie ENTRAMBE LE MODALITA’ FAVORISCONO L’INDIVIDUALIZZAZIONE DELL’APPRENDIMENTO I risultati Esiti migliori Relativamente al lavoro svolto in competizione o individualmente Incremento Nell‟impegno e nei rapporti interpersonali (abilità sociali) Studenti in difficoltà Miglioramento delle prestazioni (alunni con BES) Studenti senza difficoltà Miglioramento o stabilizzazione dei risultati No regressione Gli elementi del COOPERATIVE LEARNING 1. INTERDIPENDENZA POSITIVA: - attenzione al “noi” e non all‟ “io” in singolo non può raggiungere gli obiettivi previsti senza il gruppo e viceversa. - condivisione di risorse e spazi - ruoli complementari ed interconnessi - preoccuparsi non solo del proprio rendimento ma di quello del gruppo 2. RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE (soggettiva) E DI GRUPPO (sociale): - la partecipazione attiva di ciascuno favorisce il successo del gruppo - collaborare a favore del compagno in difficoltà per aiutarlo Va prevista una prova di verifica individuale la cui valutazione potrà essere Sommata a quella attribuita alla prova del gruppo. 3. INTERAZIONE SIMULTANEA E COLLETTIVA “FACCIA A FACCIA”: - la partecipazione è fondamentale per l‟apprendimento - fiducia e impegno comune svolto in simultanea agli altri 4. SVILUPPO DI ABILITA’ SOCIALI: - apprendere comportamenti da adottare nei rapporti con gli altri (es. volume basso, ascolto, accordo …) - sviluppare abilità di apprendimento per svolgere il compito in modo efficiente - abilità di risoluzione dei conflitti, prendere decisioni, risolvere problemi 5. RIFLESSIONE (VALUTAZIONE): - riflettere e analizzare come si è appreso assieme - riflettere e analizzare come si è interagito - questionari di autovalutazione individuale e collettiva: “Cosa abbiamo fatto di positivo?” “Come sono stati risolti i conflitti?” “Come fare per migliorare?” Riferimenti a Comoglio, Kagan, Sharan REGOLE PER IL LAVORO DI GRUPPO INSEGNARE EQUA PARTECIPAZIONE: - elimina il problema della dominanza - favorisce le pari opportunità. Per prevenire la tendenza al dominio, sono da adottare le seguenti norme: 1 – esprimere le idee; 2 – ascoltare gli altri, tutti devono parlare; 3 – chiedere agli altri di esprimere le proprie idee; 4 – motivare le proprie ipotesi e saper discutere idee diverse. LA LEADERSHIP E’ DISTRIBUITA. INCENTIVARE il vivace disaccordo in quanto i ragazzi apprendono come conseguenza dell‟esposizione al conflitto cognitivo (punti di vista diversi) UTILIZZARE LA negoziazione, per poter gestire il disaccordo: - adottare richieste positive per esprimersi - evitare l‟uso di messaggi colpevolizzanti. (Rif. Luisella Ciceri) TIPOLOGIA DEI GRUPPI La composizione del gruppo può variare da 2 a 5 componenti, caratterizzata dalla eterogeneità rispetto alle abilità cognitive e sociali. Alunni con più competenze tendono a sviluppare una gerarchia : a loro il gruppo riconosce status più elevato. Ad es. l‟abilità di lettura determina un‟importante condizione scolastica-culturale che si estende a nuove attività che vanno al di là delle richieste del compito (status scolastico -culturale) . L‟abilità acquisita durante il gioco, sia a scuola che fuori, fa sì che lo studente abbia una posizione più elevata tra i pari, dove partecipa più attivamente e lo domina (status rispetto ai pari). Quindi lo status è una classificazione sociale condivisa in cui ognuno trova una sua collocazione in posizione elevata o inferiore. APPRENDIMENTO COOPERATIVO E METACOGNIZIONE Nell‟apprendimento cooperativo il docente sperimenta una DIDATTICA METACOGNITIVA: • chiarisce obiettivi sociali e cognitivi, fasi di lavoro e tempi; • promuove abilità di previsione ed autovalutazione • promuove abilità di autovalutazione e monitoraggio • favorisce la generalizzazione • stimola la riflessione metacognitiva su come migliorare l‟interazione e il lavoro del gruppo (Rif. Michela Busatto) ATTIVITA’ DI APPRENDIMENTO COOPERATIVO: SCUOLA INFANZIA Titolo: “CHI E’?” Alunni: di 3 e 4 anni per un totale di 24 1 diversamente abile di 4 anni con RM Docenti coinvolti: docente di sezione docente sostegno (parzialmente) Strategia didattica: apprendimento cooperativo Formazione coppie: 12 coppie. I bambini prendono una carta e vengono abbinati in base alla coppia di animali che si forma (due gatti, due cavalli …) Spazi: aula scolastica Materiali: libro di favole – carte figurate Tempi: un‟ora e 30 minuti Obiettivi cognitivi: - focalizzare l‟attenzione sui personaggi - focalizzare l‟attenzione sulla struttura cronologica di una storia Obiettivi sociali: -sviluppare interazione in una coppia - ascoltare in modo attivo Fasi di lavoro 1. L‟insegnante narra la storia 2. Formate le coppie l‟insegnante consegna le carte raffiguranti i personaggi della storia 3. L‟insegnante pone domande per verificare la comprensione delle caratteristiche dei personaggi 4. L‟insegnante narra ancora la storia e fa una pausa in prossimità della descrizione di ogni personaggio per dare alla coppia la possibilità di decidere il personaggio (i bambini devono accordarsi) 5. Ogni immagine viene posta una sotto l‟altra per dare un ordine cronologico alla storia 6. L‟insegnante ricostruisce assieme la storia Riflessione metacognitiva L‟insegnante chiede agli alunni se hanno gradito lavorare con un compagno Il docente di sostegno monitora il lavoro della coppia dove è inserito l‟alunno con RM. L‟obiettivo cognitivo per quest‟ultimo sarà solo quello di porre attenzione alle caratteristiche dei personaggi, descrivendo anche le immagini. ATTIVITA’ DI APPRENDIMENTO COOPERATIVO A COPPIE: “ I TRIANGOLI” Titolo: “I TRIANGOLI” Discipline: matematica, geografia Classe: 1^ scuola primaria – mese di marzo N° alunni: 25 1 diversamente abile (ipoacusia bilaterale profonda), 1 con diagnosi di “Disturbo del comportamento”, 1 segnalato al “Servizio Tutela Minori”, 1 straniera arrivata a fine gennaio Docenti coinvolti: Docenti curricolari di geografia e matematica Strategia didattica: apprendimento cooperativo Formazione coppie: 11 coppie e un gruppo da 3 alunni (incluso alunno con disturbo comportamento) Spazi: aula scolastica Materiali: fotocopia fornita dai docenti Tempi: 50 minuti Ruoli condivisi: - lettore - compilatore Obiettivi didattici Obiettivo generale: riconoscere triangoli - usando immagini Obiettivi specifici: - distinguere triangoli da altre figure Obiettivi sociali: - parlare uno alla volta (rispettare il turno di parola) - parlare sottovoce I docenti richiamano la lettura della “Carta a T” precedentemente costruita con la classe ed esposta: cosa vedo e cosa sento Criteri per la formazione delle coppie: Il primo e l‟ultimo dell‟elenco, il secondo e il penultimo… L‟alunno con difficoltà comportamentali sarà abbinato ad una coppia in cui vi sia un compagno con cui ha instaurato buoni rapporti. Intervento sugli obiettivi sociali: Le abilità di parlare sottovoce e uno alla volta verranno simulate, esemplificate. Fasi dell’attività 1. Presentazione attività da parte dell‟insegnante: 5 minuti - Spiega le fasi di lavoro - Richiama il rispetto delle regole sociali 2. Lavoro individuale: 10 minuti - Gli alunni ricevono la fotocopia - Gli alunni coprono con un foglio bianco la parte opposta a quella di cui devono contare i triangoli (delimitata da un riga nera spessa). - Ogni alunno conta i triangoli della propria parte e trascrive il numero (non risponde all‟ultimo quesito). (Gli alunni che si trovano a destra nella coppia contano i triangoli della parte destra..). 3. Lavoro a coppia: 15 minuti - Ogni alunno comunica al compagno le sue risposte che le verifica; la coppia concorda una risposta comune. (Domande guida: “Per me i triangoli a destra sono…”. “Va bene… Non sono d‟accordo”. “Allora scriviamo il numero …”). - I bambini procedono alla somma totale dei triangoli. 4. Riflessione metacognitiva: 20 minuti - Ogni bambino completa individualmente la tabella di rilevazione del rispetto delle regole sociali, colorando la corrispettiva casella. - I docenti fanno leggere le risposte ed evidenziano eventuali incongruenze nelle autovalutazioni espresse da ogni coppia. Valutazione: - a livello di coppia: sarà attribuito un punteggio al lavoro svolto - individuale: sarà presentato un lavoro simile (con rettangoli, ad es.) Il docente evidenzierà come la risoluzione del problema: “Quanti sono tutti i triangoli contenuti della figura?”, non avrebbe potuto avere risposta senza il contributo di ciascuno (conteggio dei triangoli a destra e a sinistra). Inoltre, sottolineerà l‟importanza della revisione da parte del compagno e della definizione di una risposta condivisa. Difficoltà emerse: alcuni alunni tendono a non verificare con impegno la risposta fornita dal compagno all‟interno della coppia di lavoro. ATTIVITA’ DI APPRENDIMENTO COOPERATIVO: A COPPIE “ L’AULA” Titolo: “L’AULA” Discipline: matematica, geografia Classe: 1^ scuola primaria – mese di aprile N° alunni: 25 1 diversamente abile (ipoacusia bilaterale profonda), 1 con diagnosi di “Disturbo del comportamento”, 1 segnalato al “Servizio Tutela Minori, 1 straniera arrivata a fine gennaio Docenti coinvolti: Docenti curricolari di geografia e matematica Strategia didattica: apprendimento cooperativo Formazione coppie: 11 coppie e un gruppo da 3 alunni (incluso alunno con disturbo comportamento) Spazi: aula scolastica Materiali: fotocopia fornita dai docenti Tempi: 55 minuti Ruoli condivisi: - lettore - compilatore Obiettivi didattici Obiettivo generale: individuare la posizione di un elemento nel piano in base ad un sistema di riferimento dato Obiettivi specifici: - dato il reticolato individuare un elemento aventi date coordinate - dato il reticolato individuare le coordinate di un determinato elemento Obiettivi sociali: - parlare uno alla volta (rispettare il turno di parola) - parlare sottovoce I docenti richiamano la lettura della “Carta a T” precedentemente costruita con la classe ed esposta: cosa vedo e cosa sento Criteri per la formazione delle coppie: I primi due numeri pari dell‟elenco, i primi due numeri dispari dell‟elenco … L‟alunno con difficoltà comportamentali sarà abbinato ad una coppia in cui vi sia un compagno con cui ha instaurato buoni rapporti. Intervento sugli obiettivi sociali: Le abilità di parlare sottovoce e uno alla volta verranno simulate, esemplificate. Fasi dell’attività 1. Presentazione attività da parte dell‟insegnante: 5 minuti - Distribuisce la fotocopia e la spiega. Richiama alla mente le informazioni sul reticolato - Ricorda il rispetto delle regole sociali 2. Risposte al 1° gruppo di domande (ogni volta il docente legge le domande): 5‟ - Gli alunni lavorano individualmente e a coppia. Ognuno scrive la risposta alle 4 domande, poi si confronta con il compagno: si stabilisce una risposta comune. 2. Risposte al 2° gruppo di domande (ogni volta il docente legge le domande): 5‟ Gli alunni lavorano a coppia: un bambino individua il nome del personaggio, l‟altro la relativa coordinata. 2. Risposte al 3° gruppo di domande (ogni volta il docente legge le domande): 5‟ Gli alunni lavorano a coppia: un bambino individua il nome del personaggio, l‟altro la relativa coordinata (scambio di compiti rispetto all‟attività numero 2). 3. Revisione: 5 „ Per facilitare la revisione si aggiunge una quarta attività: i bambini devono colorare solo i banchi dei personaggi di cui hanno scritto il nome. Il lavoro è svolto a coppia: a turno i bambini dicono quale sia il banco da colorare. Il docente li invita a verificare (revisionare) ogni singola risposta, prima di procedere alla coloritura. 3. Riflessione metacognitiva: 20 minuti - Ogni bambino completa individualmente la tabella di rilevazione del rispetto delle regole sociali, colorando la rispettiva casella. - I docenti fanno leggere le risposte ed evidenziano eventuali incongruenze nelle autovalutazioni espresse da ogni coppia. Il docente evidenzierà l‟importanza del procedere insieme nello svolgimento del lavoro per poter scrivere il nome di personaggi e le coordinate occupate nel reticolato. Successivamente si procede alla correzione nel gruppo allargato: gli alunni dovranno segnare con un pallino eventuali errori e scrivere a lato il nome o la coordinata corretta. (10 minuti) Difficoltà emerse: - alcuni alunni tendono a non verificare con impegno la risposta fornita dal compagno all‟interno della coppia di lavoro. Gratificazioni: alle coppie che hanno operato rispettando completamente gli obiettivi sociali, sarà concesso un tempo aggiuntivo di 5‟ di intervallo o la possibilità di scegliere di effettuare un disegno libero in un momento della giornata scolastica (da concordare prima). CARTA A “T” per abilità sociali ASCOLTARE L‟ALTRO Cosa vedo comportamento non verbale Sguardo di assenso Cosa sento comportamento verbale “Va bene” Annuire con la testa “D‟accordo” Esprimere meraviglia “Scusa?” Essere protesi in avanti “Puoi ripetere?” Fissare la persona che parla “Puoi fare silenzio?” Mettere in azione le orecchie Voce di chi parla Tenere la bocca chiusa Voci provenienti dalle altre classi e dal corridoio Costruire una "Carta T" con gli studenti significa preparare una tabella sulla quale indicare l'abilità che si intende insegnare, definita attraverso i comportamenti verbali e non verbali che la descrivono. CARTA A “T” per abilità sociali INCORAGGIARE SI VEDE COSI’ comportamento non verbale Sguardo o piccolo movimento della testa che esprime assenso SI SENTE COSI’ comportamento verbale “Ti sei espresso bene” Colpo sulla spalla “Il tuo sforzo ha dato ottimi risultati” Battito delle mani “Continua così! Atteggiarsi della faccia che dimostra meraviglia “E‟ stato di più quello che hai fatto corretto di quello che hai sbagliato” Mettere le dita a V “Sei stato bravo” Pausa di attenzione “Stai andando proprio bene!” Comoglio e Cardoso ATTIVITA’ DI APPRENDIMENTO COOPERATIVO: JIGSAW II Titolo: “L’apparato locomotore” Discipline: scienze, tecnologia Classe: 5^ scuola primaria N° alunni: 22 2 diversamente abili (ADHD – RM medio), 1 in fase di valutazione neuropsichiatrica, 2 in difficoltà di apprendimento. Docenti coinvolti: docente curricolare docente sostegno (parzialmente) Strategia didattica: apprendimento cooperativo – Jigsaw II (Slavin 1980) Formazione gruppi: gruppi base: totale 4 gruppi 2 gruppi da 6 alunni, 2 gruppi da 5 alunni Gruppi di esperti: totale 5 gruppi 2 gruppi da 5 alunni, 3 gruppi da 4 alunni Spazi: aula scolastica – aula informatica Materiali: libro di testo – fotocopie tratte da altri test Strumenti: power point Tempi: mese di novembre 4 ore distribuite su 2 lezioni Scheda di progetto Formazione gruppi: criteri Gruppi base: in ordine alfabetico 1° gruppo da 1 a 5 / 2° da 6 a 10 / 3° da 11 a 14 4° da 15 a 18 / 5° da 19 a 22. Nel gruppo 1 vi saranno due esperti del gruppo A e in quello 2 due esperti del gruppo B. Gruppi di esperti: il primo di ogni gruppo, il secondo … e così via , identificati con lettere: A – B- C- D- E. I gruppi A e B saranno formati da 5 bambini, gli altri da 4. Gruppi di esperti: Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D Gruppo E Lo scheletro Le ossa Le ossa I muscoli I muscoli A cosa serve? Come sono fatte? Quali problemi ossei? A cosa servono? Quali problemi muscolari? Com‟è fatto? Sono tutte uguali? Quale alimentazione? Sono tutti uguali? Quale attività fisica? Obiettivi cognitivi: • saper individuare parole – chiave • saper selezionare informazioni principali • saper elaborare una semplice mappa concettuale • conoscere informazioni di un testo espositivo Obiettivi sociali: • saper mantenere un tono di voce basso • saper rispettare il proprio turno di parola Ruoli: • distributore (consegna il materiale) / timer (controlla il tempo) • lettore (legge le schede) • sintetizzatore 1 (individua le informazioni principali) (uno o due alunni) • schematizzatore (prepara la mappa) • Fasi FASE CHI COMPITO TEMPI 1 Docente Spiegare l‟attività 10‟ 2 Docente Formare i gruppi 5‟ 3 Gruppo es. Individuare i ruoli 5‟ 4 Gruppo es. Distribuire il materiale e leggere i testi 15‟ 5 Gruppo es. Individuare parole-chiave; informazioni principali 40‟ 6 Gruppo es. Preparare mappa informazioni 30‟ 7 Gruppo base Riferire informazioni al gruppo base 50‟ 8 Classe Riflettere sull‟esperienza svolta 30‟ 9 Coppie Elaborazione della mappa con power point 45‟ Tempi complessivi: 230 „ Fino a fase 6 prima lezione Da fase 6 a 9 seconda lezione Materiali Gruppo A : libro di testo pag 197 – Scienze facili pag 181 – Ora so di più 5 pag. 230 e 233 Gruppo B: libro di testo pag. 198 – Ora so di più 5 pag. 231 Gruppo C: Discovery 5 pag. 279, 284, 285 Gruppo D: libro di testo pag. 199 – Scienze facili pag 177 – Ora so di più 5 pag. 232/233 – Discovery 5 pag. 281 Gruppo E: Ora so di più 5 pag. 232 – Discovery 5 pag. 286 – Schede su “Traumi ossei” e “Problemi muscolari” Ruoli docenti -Docente di classe: spiega l‟attività, ricorda i tempi da rispettare, dà indicazioni sul lavoro cognitivo, interviene a risolvere conflitti nei gruppi A – B – C - Docente di sostegno (presente per due ore, una per ogni lezione): interviene a risolvere conflitti nei gruppi D - E Criteri di valutazione Valutazione del docente Obiettivi cognitivi: - da 4 a 10 per individuazione informazioni principali ed elaborazione mappa - da 4 a 10 per interrogazione orale Obiettivi sociali : da sufficiente a ottimo per l‟impegno e il rispetto delle regole Valutazione degli alunni Autovalutazione: - coloritura istogramma per il rispetto dei ruoli e delle regole stabilite - discussione collettiva Accorgimenti Formazione dei gruppi: il docente ha avuto cura di verificare che alunni con problematiche a livello comportamentale o di apprendimento non facciano parte del medesimo gruppo. Ruoli: il docente ha aiutato i due gruppi in cui erano inseriti gli alunni con problemi nell‟assegnazione dei ruoli : lettore per alunno ADHD e distributore/timer per alunno con RM Obiettivi: per l‟alunno con RM l‟obiettivo sarà riferito alla lettura della mappa e alla descrizione di immagini che accompagnano i testi. Scheda di riflessione metacognitiva sull’attività L‟attività svolta mi è piaciuta? [] sì [] in parte [] no Perché? ______________________________________________________________________ Ho rispettato il mio ruolo? (coloro) Ho rispettato le regole? Come giudico il lavoro del gruppo di esperti? Se ci sono stati dei problemi come abbiamo cercato di risolverli?________________________________ ___________________________________________________________________________________ Mi piacerebbe ripetere questa esperienza? ____________ COMPITO Ho rispettato il mio ruolo Ho svolto il mio compito Ho aiutato tutti i compagni a svolgere il proprio compito Ho ascoltato tutti i miei compagni di gruppo Ho aiutato a risolvere i problemi del gruppo SEMPRE A VOLTE MAI METACOGNIZIONE “PENSARE SUL PENSIERO = consapevolezza che il soggetto ha sulla propria attività di pensiero e sulla sua capacità cognitiva di regolare e influenzare tale attività”. (BROWN, 1998) METACOGNIZIONE per ALUNNI CON DISABILITA’ Si riscontra maggior difficoltà nella capacità di previsione di un risultato. Identificazione meno accurata tra problemi risolti correttamente o meno. DEFICIT ABILITA’ DI BASE / DEFICIT METACOGNITIVI DEFICIT ABILITA’ DI BASE • processi cognitivi carenti • esecuzione strategie di apprendimento carente Es.: deficit percezione visiva mancata acquisizione letto-scrittura Intervento: esecuzione di didattica speciale (programma istruzionali) sviluppo abilità di base o loro aggiramento DEFICIT METACOGNITIVI • capacità di previsione non adeguata • mancanza di generalizzazione (no applicazione strategie) Intervento: • aumentare consapevolezza su ciò che richiede il compito • insegnare strategie per eseguire un compito • monitorare le strategie Es. migliorare abilità di memoria, comprensione del testo, espressione scritta risoluzione problemi matematici LA DIDATTICA METACOGNITIVA Conoscenza e uso di strategie Migliora la prestazione nella: risoluzione di problemi pianificazione dell’attività CONOSCENZA DULLE PROPRIE CAPACITA’ COGNITIVE: attenzione memoria Sviluppa: •senso di autoefficacia •autostima •motivazione Sviluppa: senso di autoefficacia autostima motivazione Relazione tra personalità e sistema attributivo (De Beni – Pazzaglia) Situazione di successo Situazione di fallimento Impegno Soddisfazione, orgoglio Senso di colpa, vergogna Abilità Fiducia in sé, superbia Depressione, apatia, vergogna Facilità del compito Sorpresa Pietà Fortuna Sorpresa Sorpresa, pietà Aiuto di altri Gratitudine Rabbia Attribuzione Insegnamento con un approccio metacognitivo 5.Fornire feedback ragionato: 1.Fornire un organizzatore anticipato: •specificare specificare perché si deve apprendere quell’abilità 2. Descrivere e fare dimostrazione della strategia: •pensare ad alta voce (domanda e risposta) •porre domande ed aiutare il b/o a dare una risposta 4.Condurre la pratica autonoma: •il b/o lavora da solo (giochi didattici, computer, schede autocorrezione) 3.Condurre la pratica guidata e il dialogo interattivo: •l’ins. fa domande specifiche •l’ins. fornisce indicazioni sulla procedura e sul controllo •spiegare il risultato •registrare il risultato •valutare il risultato •individuare gli errori •correggere correggere (facendo dimostrazione di un problema simile) •chiedere al b/o di correggersi •dare feedback positivo alla correzione Ruolo docente metacognitivo 1. Guida il bambino con esempi di strategie, aiuti, domande 2. Invita il bambino a ripetere ad alta voce il percorso elaborato 3. Chiede al bambino di pensare nella sua mente: avvio all‟autonomia 4. Chiede al bambino di elaborare una strategia personale: avvio al consolidamento 5. Chiede al bambino di elaborare piani nuovi per problemi diversi: avvio alla generalizzazione Momenti della didattica metacognitiva PRESENTAZIONE DEL PROBLEMA DOCENTE VALUTAZIONE DELLE PRECONOSCENZE DOCENTE CAPACITA’ DI CODIFICARE IL PROBLEMA ALUNNO FORMULAZIONE DEL PLANNING ALUNNO TRANSFER A PROBLEMI ANALOGHI CONSOLIDAMENTO E GENERALIZZAZIONE ALUNNO ALUNNO LE AUTOISTRUZIONI COSA SONO AUTOISTRUZIONI: procedure metacognitive finalizzate all‟ acquisizione di capacità di autoverbalizzazione da parte dell‟alunno. Si tende a sviluppare LINGUAGGIO INTERNO per dirigere : - l‟applicazione di una strategia - il monitoraggio della strategia PER CHI - Per alunni che possiedono DEFICIT NELLE ABILITA‟ LINGUISTICHE - Per alunni che hanno scarse CONOSCENZE DI BASE PERCHE’ - Migliorare CAPACITA‟ DI ATTENZIONE - Migliorare CAPACITA‟ ESECUTIVE - Ridurre DIPENDENZA DALL‟ADULTO QUANDO - Quando gli alunni posseggono una sufficiente ABILITA‟ DI LINGUAGGIO RICETTIVO NELLO SPECIFICO: - L‟AUTOISTRUZIONE aiuta a utilizzare le parole adatte per REGOLARE LE AZIONI - Gli alunni processano PIU‟ INFORMAZIONI per ESEGUIRE un compito - Gli alunni riescono a svolgere COMPITI PIU‟ COMPLESSI, sviluppano, cioè, abilità di PROBLEM SOLVING - Gli alunni sono facilitati nello sviluppare competenze di CONTROLLO della esecuzione di un COMPITO: si chiedono come stanno procedendo e se stanno eseguendo correttamente le STRATEGIE insegnate loro. DIFFICOLTA’ ALUNNI CON RITARDO MENTALE 1. ASSOCIAZIONI SISTEMI VERBALE E MOTORIO 2. ATTENZIONE ALLE CARATTERISTICHE DI UNO STIMOLO 3. MEMORIA A BREVE TERMINE 4. RIEVOCAZIONE MNESTICA: organizzare materiale di studio 5. USARE STRATEGIE MNESTICHE DI RIPETIZIONE AUTOISTRUZIONE E RITARDO MENTALE 1. Agli alunni con RITARDO MENTALE può essere insegnato ad AUTOISTRUIRSI 2. Gli alunni con R.M. diventano più ATTENTI: attenzione focale 3. Gli alunni con R.M. risolvono con maggior abilità i PROBLEMI 4. Gli alunni con R.M. diventano più abili nel VERBALIZZARE le strategie di problem solving GLI ALUNNI CON R.M. IMPARANO A DARSI SUGGERIMENTI VERBALI RILEVANTI CHE GLI CONSENTONO DI FOCALIZZARE L’ATTENZIONE, DI ELABORARE LE INFORMAZIONI, DI REGOLARE IL COMPORTAMENTO MOTORIO ESEMPLIFICAZIONI AUTOISTRUZIONE E MATEMATICA: insegnamento con programmi di insegnamento speciale e con autoistruzione verbale Programma di insegnamento speciale: apprendimento discriminativo senza errori (ADSE) OBIETTIVO: imparare ad eseguire sottrazioni con il minuendo mancante Situazione problematica iniziale: …- =5 Fasi di insegnamento: 1. Porre attenzione sullo stimolo discriminativo (numero mancante e segno meno) 2. Associare allo stimolo discriminativo un disegno (manico padella) 3. Associare disegno padella ad azione richiesta (addizione) 4. Eliminare gradualmente il prompt (aiuto) 1. Penna rossa (aiuto pieno) 3= 5 2. Penna rossa e verde (aiuto pieno) 3= 5 3. Penna rossa e verde (aiuto ridotto) 3= 5 4. Penna rossa e verde (aiuto ridotto) 3= 5 5. Penna rossa (aiuto ridotto) 3= 5 Programma di autoistruzione OBIETTIVO: imparare ad eseguire sottrazioni con il minuendo mancante Situazione problematica iniziale: …- 3 =5 Fasi di insegnamento: 1. Porre attenzione sullo stimolo discriminativo (numero mancante e segno meno) 2. Modeling (modellamento) da parte del docente: dimostrazione delle verbalizzazioni Passi istruzionali: 1. Leggo il problema: un numero meno 3 è uguale a 5 2. Il risultato è uguale a 5 3. Il segno dell‟operazione indica una sottrazione. 4. Il numero che manca è più alto di tutti gli altri 5. Per trovare il numero che manca devo sommare il 5 al 3 6. 5 + 3 = 8 . Il numero che manca è 8 Programma di autoistruzione OBIETTIVO: imparare ad eseguire addizioni con addendo mancante Situazione problematica iniziale: 7 + …… = 12 Passi istruzionali: 1. Leggo il problema: 7 più un numero è uguale a 12 2. E‟ un problema di addizione: faccio un cerchio attorno al segno più 3. Metto 7 gessetti sopra il numero 7 4. Metto altri gessetti sopra i puntini, partendo da 8 5. Conto i gessetti sopra i puntini: sono 5 6. Ci sono 5 gessetti sopra i puntini: scrivo il numero 5 sopra i puntini 7. Il numero che sommato a 7 da‟ 12 è 5 • Una volta risolta una tipologia di problema, bisogna assegnare agli alunni altri problemi analoghi. • Si invitano gli alunni ad applicare le autoistruzioni apprese. • Viene utilizzato il rinforzo sociale (lode) durante le verbalizzazioni corrette. • Inizialmente il docente può fornire suggerimenti per aiutare il bambino. • Successivamente, suggerimenti e rinforzatori sociali vengono attenuati ed Eliminati • Quando l‟alunno presenta una certa abilità nel darsi autoistruzioni apprese, si presentano situazioni problematiche nuove o situazioni a cui deve applicare autoistruzioni non conosciute L’AUTOISTRUZIONE FORNISCE INDICAZIONI CHIARE E DETTAGLIATE, PASSO DOPO PASSO, PER AFFRONTARE UN COMPITO Questionario di ingresso a. Prima di risolvere un problema (X) LEGGO IL TESTO UNA SOLA VOLTA ( ) LEGGO IL TESTO PIU‟ VOLTE ( ) LEGGO IL TESTO E LO RIPETO b. Quando risolvo un problema: ( ) NON COMMETTO ERRORI ( ) COMMETTO POCHI ERRORI (X) COMMETTO MOLTI ERRORI c.Dopo aver risolto un problema (X) NON CONTROLLO ( ) CONTROLLO TUTTO IL LAVORO ( ) CONTROLLO IN PARTE d. Se il giudizio e‟ positivo (max2) ( ) SONO STATO FORTUNATO ( ) SONO STATO ABILE (X) SONO STATO AIUTATO ( ) MI SONO IMPEGNATO (X) IL COMPITO ERA FACILE SCHEMA PER LA RISOLUZIONE DI UN PROBLEMA Come devo leggere un problema? In modo LENTO ed ATTENTO: di chi e cosa si parla? Come faccio per ragionare correttamente? Individuo le INFORMAZIONI ESSENZIALI (sottolineo con un colore i numeri e le parole che lo spiegano – due numeri, due colori -) Individuo la DOMANDA (sottolineo le parole che mi dicono cosa devo trovare – due domande, due colori - ) Come faccio per capire se non ragiono correttamente? Ripeto quello che MI DICE IL PROBLEMA: Ho sottolineato tutte le informazioni necessarie? Colloquio successivo alla lettura del questionario Ins. Sei convinto di non saper risolvere un problema? B/o. Sì Ins. Perché? B/o. Perché non sono capace Ins. Nessuno ti ha mai insegnato come fare? B/o. Sì, ma sono io che non capisco niente Ins. Però conosci le 4 operazioni e a volte le applichi correttamente B/o. Sì, ma perché tu mi aiuti o i problemi sono di seconda Ins. Vorresti imparare a migliorare? B/o. Sì, ma non ci riuscirò. Ins. Proviamo lo stesso? B/o. Va bene. Leggi il testo: Marco ha comperato 10 bustine dei Pokèmon e sua zia gliene regala altre 7. E‟ possibile risolvere questo problema? (No) Bisognerebbe: [] allungarlo con altri dati [x] aggiungere una domanda [] completarlo con domande o dati è la stessa cosa A cosa servono le domande del testo? (Servono a far capire la soluzione) Leggi e scrivi se concordi MOLTO, ABBASTANZA, POCO Per risolvere un problema è necessario CAPIRE I DATI FARE ATTENZIONE ALLA DOMANDA SCRIVERE IN ORDINE I DATI E FARE UN BEL DISEGNO Questionario di uscita a. Prima di risolvere un problema ( ) LEGGO IL TESTO UNA SOLA VOLTA ( ) LEGGO IL TESTO PIU‟ VOLTE (X) LEGGO IL TESTO E LO RIPETO b. Quando risolvo un problema: (X) NON COMMETTO ERRORI ( ) COMMETTO POCHI ERRORI ( ) COMMETTO MOLTI ERRORI c.Dopo aver risolto un problema ( ) NON CONTROLLO (X) CONTROLLO TUTTO IL LAVORO ( ) CONTROLLO IN PARTE d. Se il giudizio e‟ positivo (max2) ( ) SONO STATO FORTUNATO (X) SONO STATO ABILE ( ) SONO STATO AIUTATO (X) MI SONO IMPEGNATO ( ) IL COMPITO ERA FACILE Colloquio successivo alla lettura del questionario Ins. Ora pensi di saper risolvere un problema? B/o. Sì Ins. Perché? B/o. Perché mi sono sempre impegnato e sono diventato capace. Ins. Allora pensi che tutti possono migliorare? B/o. Sì Ins. Qual è la cosa più importante quando si cerca di migliorare, secondo te? B/o. Sicuramente l‟impegno COMPITI POLIRISOLVIBILI Gli alunni disabili e con BES in generale ci conducono a modificare non solo i metodi di insegnamento ma anche a utilizzarne diversi nella medesima situazione didattica. I compiti proposti devono essere POLIRISOLVIBILI, cioè affrontabili a diversi livelli di competenza. Esempio: RIELABORAZIONE BRANO NARRATIVO Approcci diversi (compito polirisolvibile): - Domande verbali - Disegno fumetti - Ritaglio sequenze, - Evidenziazione parole chiave - Ricerca immagini - Ricerca vocabolario OGNI ALUNNO PUO ‟ TROVARE IL PROPRIO SPAZIO E PARTECIPARE ALLE ATTIVITA‟ PENSATE PER LA CLASSE. TIPO DI ADATTAMENTO CONDIZIONE SOSTITUZIONE DIFFICOLTA‟ SENSORIALI DIFFICOLTA‟ MOTORIE DIFFICOLTA‟ PERCETTIVE FACILITAZIONE DIFFICOLTA‟ NON ECCESSIVE DIFFICOLTA‟ SPECIFICHE SEMPLIFICAZIONE DIFFICOLTA‟ DI COMPRENSIONE ED ELABORAZIONE PIU‟ MARCATE SCOMPOSIZIONE IN NUCLEI FONDANTI DIFFICOLTA‟ NOTEVOLI PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA DEL COMPITO DIFFICOLTA‟ NELL‟INDIVIDUARE OBIETTIVI COLLEGABILI Adeguare obiettivi CURRICOLARI 1. LA SOSTITUZIONE: obiettivo uguale, si modifica l‟accessibilità (registrazione audio dei testi, cards per alunni con sordità, uso di C.A.A.) 2. LA FACILITAZIONE: uso di tecnologie motivanti (LIM; software) e contesti didattici interattivi (cooperative learning., tutoring, laboratori…); proposto anche in ambienti reali 3. LA SEMPLIFICAZIONE: modificazione del lessico, riduzione dei concetti, dei criteri di esecuzione del compito (uso calcolatrice, numero di errori più elevato…) 4. SCOMPOSIZIONE IN NUCLEI FONDANTI: identificazione delle attività fondanti (strumentalità di base, lettura e scrittura funzionale, matematica pratica…) 5. PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA DEL COMPITO: far sperimentare sfida cognitiva ottimale, elaborazione di un prodotto…per aiutare l‟alunno a partecipare a momenti significativi LA SOSTITUZIONE L‟OBIETTIVO CURRICOLARE NON VIENE SEMPLIFICATO. SI CURA LA SUA ACCESSIBILITA’. SI USA UN ALTRO CODICE., SI USANO ALTRE MODALITA’ PER: - ascolto/comprensione - risposta/produzione SOPRATTUTTO PER DIFFICOLTA‟ SENSORIALI O MOTORIE ESEMPI AREA: ITALIANO OBIETTIVO: COMPRENDERE UN TESTO - per alunno non vedente: uso di materiale Braille - per alunno DSA: audio del testo (lettore vocale) - per alunno straniero: come per alunno DSA) OBIETTIVO: RISPONDERE A DOMANDE - per alunno non vedendo: uso dattilo Braille - per alunno DSA: uso videoscrittura LA FACILITAZIONE L‟OBIETTIVO NON E’ DIVERSIFICATO. SI STIMOLA UN APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO. SI RIDUCONO LE DIFFICOLTA‟ DERIVANTI DAL CONTESTO O DAGLI STRUMENTI. SI LAVORA CON TEMPISTICA PIU‟ DISTESA. SI ORGANIZZANO SPAZI, MATERIALI (posizione banco e arredi, illuminazione – es. con soggetto autistico). SI INTRODUCONO STIMOLI DI VARIA NATURA: - colori - immagini - mappe - organizzatori anticipati (strategie metacognitive) - autoistruzioni per compiti specifici ESEMPI DI CONTESTO AREA: MATEMATICA OBIETTIVO: ESEGUIRE OPERAZIONI APPLICATE A PROBLEMI - calcolare il resto al mercato AREA: ITALIANO OBIETTIVO: RINFORZARE L‟USO DEI DIGRAMMI E TRIGRAMMI -software didattici per l‟ortografia AREA: STORIA-GEOGRAFIA-SCIENZE OBIETTIVO: COMPRENDERE L‟ORGANIZZAZIONE DI UN ARGOMENTO - fornire mappa concettuale ESEMPI DI CONTESTO AREA: QUALSIASI OBIETTIVO: A SECONDA DELLA DISCIPLINA - contesto didattico interattivo (apprendimento cooperativo, tutoring.) AREA: QUALSIASI OBIETTIVO: A SECONDA DELLA DISCIPLINA - contesto didattico operativo (laboratori, uscite) ESEMPI DI MATERIALI PER SOGGETTO CON DISTURBO GENERALIZZATO DELLO SVILUPPO: - posizionare materiale necessario in ordine (dalla prima scheda all‟ultima) - abbinare all‟esecuzione delle attività l‟AGENDA della giornata - presentare materiali “immediati”, di facile gestione - presentare materiali che non implicano spiegazioni verbali per il loro utilizzo ESEMPI DI SPAZI PER SOGGETTO CON DISTURBO GENERALIZZATO DELLO SVILUPPO: - posizionare il banco lontano da stimoli estrinseci (luce esterna, rumori esterni, porta dell‟aula, cestino della carta, materiale vario, armadi che si possono aprire …) - posizionare il banco in modo che eventuali spostamenti non siano di fastidio alla classe PER SOGGETTO IPOACUSICO: - posizionare il banco di fronte alla cattedra per favorire la lettura labiale e quella gestuale ESEMPI DI STIMOLI PER SOGGETTO CON DISTURBO GENERALIZZATO DELLO SVILUPPO: - presentare fotografie riferite ad attività o discipline (da inserire nell‟agenda) - presentare cards per la comunicazione di bisogni, necessità varie, stati d‟animo - usare cartelli colorati per associare un avvertimento o un giudizio che si può esprimere verbalmente (verde = va tutto bene rosso = attento) PER SOGGETTI CON ADHD: - presentare immagini o fotografie riferite alle attività da svolgere - usare grafici di rilevazione dei comportamenti positivi attesi e contrattualizzati - usare contratto formativo per iscritto per contenere il comportamento problema o per richiamare al rispetto delle regole e di eventuali premiazioni e punizioni PER SOGGETTI DSA E CON DIFFICOLTA‟ COGNITIVE: - usare colori per evidenziare la parola chiave e le informazioni principali - far ricorso a mappe concettuali per sintetizzare informazioni - accompagnare l‟uso delle mappe a disegni/immagini che ne evidenzino i concetti principali per favorire la memorizzazione - presentare script per la stesura di un testo o la sua revisione - far ricorso ad artifici tipografici per favorire la comprensione del testo LA SEMPLIFICAZIONE L‟OBIETTIVO E’ SEMPLIFICATO IN MERITO A: • COMPRENSIONE • ELABORAZIONE • RISPOSTA SI MODIFICA IL LESSICO. SI RIDUCE LA COMPLESSITA‟ CONCETTUALE. SI EVITANO / SOSTITUISCONO ALCUNE PROCEDURE. SI MODIFICANO I CRITERI DI RISPOSTA E VALUTAZIONE (strumenti compensativi) ESEMPI DI SOSTITUZIONE DI PROCEDURE PER SOGGETTO CON DSA , ADHD, RM: - far usare tabelle per l‟analisi grammaticale e logica - far usare la calcolatrice per l‟esecuzione di calcoli - far usare mappe durante l‟esposizione di un argomento ESEMPI DI MODIFICAZIONE DEI CRITERI DI RISPOSTA PER SOGGETTO CON DSA , ADHD, RM, ALUNNI STRANIERI: - concedere tempi maggiori per le risposte - concedere tempi maggiori per l‟esecuzione di verifiche - ridurre la quantità di richieste - consentire un maggior numero di errori , imprecisioni - consentire un maggior numero di approssimazioni nel riferire concetti o argomenti complessi, con particolare riferimento all‟uso di termini specifici ESEMPI DI RIDUZIONE DI COMPLESSITA’ CONCETTUALE: SEMPLIFICAZIONE ATTIVITA’ PER LA CLASSE Quel giorno mi ritrovai in mezzo alla campagna, in una zona di campi verdeggianti dove brucavano mucche dal muso dolce e mite. Davanti a me un sentiero tortuoso scendeva verso la grande conca azzurra del mare. Tra le siepi erbose crescevano viole e primule selvatiche e, quando uscì il sole, il colore dell‟erba rigogliosa si trasformò e divenne verde smeraldo. Poco dopo giunsi a una svolta e vidi un cancello bianco che si apriva tra due bassi muretti. Poi notai un lungo viale che spariva dietro a una curva e ad altre siepi tormentate da un vento implacabile. Finalmente, in fondo al viale, vidi quella che sarebbe stata la mia casa. ATTIVITA’ PER L’ALUNNO DISABILE ERO IN MEZZO ALLA CAMPAGNA. I CAMPI ERANO VERDI. LE MUCCHE BRUCAVANOTRANQUILLE NEI CAMPI. UN SENTIERO SCENDEVA VERSO IL MARE AZZURRO. USCI‟ IL SOLE . L‟ERBA DIVENNE DI COLORE VERDE. ARRIVAI A UNA CURVA. VIDI UN CANCELLO BIANCO. IL CANCELLO ERA IN MEZZO A DUE MURETTI BIANCHI. UNA LUNGA STRADA SPARIVA DIETRO A UNA CURVA. UN FORTE VENTO MUOVEVA LE SIEPI ALTE. LA SCOMPOSIZIONE IN NUCLEI FONDANTI L‟OBIETTIVO E’ SEMPLIFICATO/MODIFICATO, FACENDOLO DIVENTARE PIU‟ ACCESSIBILE. SI IDENTIFICANO ATTIVITA’ FONDANTI. SI IDENTIFICANO ATTIVITA‟ ACCESSIBILI IN BASE ALLE DIFFICOLTA‟ DELL‟ALUNNO. SI PRESTA MINOR ATTENZIONE ALLE NOZIONI DELLA DISCIPLINA. SI PRESTA PIU‟ ATTENZIONE AI PROCESSI COGNITIVI DELLA DISCIPLINA AFFRONTATA. ATTIVITA’ PER LA CLASSE ANALIZZA I NOMI IN TABELLA NOME PR. COM. AN. PER. COS. M. F. S. SCOPA BERRETTI FIORISTA GOCCIA ATTIVITA’ PER L’ALUNNO DISABILE: SCOMPOSIZIONE IN NUCLEI FONDANTI ANALIZZA I NOMI IN TABELLA NOME SCOPA BERRETTI FIORISTA GOCCIA PL. ATTIVITA’ COMUNI SCRIVI L‟AGGETTIVO QUALIFICATIVO: COME E‟? – COME SONO? CAMPI MUCCHE MARE ERBA CANCELLO MURETTI STRADA VENTO SIEPI Per la classe aggiungere i nomi: muso, sentiero, conca, siepi, viole, primule, viale. SCOPRI E CANCELLA L‟AGGETTIVO INTRUSO (CHE NON VA BENE) CAMPO CANCELLO VENTO MARE verde bianco impetuoso (forte) abbagliante (luminoso) alto aperto azzurro azzurro grande acceso gustoso (saporito) acceso brullo (roccioso) rumoroso costante (continuo) limpido (pulito) ATTIVITA’ PER LA CLASSE TRASFORMA LE POTENZE IN OPERAZIONI 4 3 2 3 x 3 x 3 x 3 = 81 5 5 x 5 = 25 3 2 3 2x2x2=8 4 4 x 4 x 4 = 64 ATTIVITA’ PER L’ALUNNO DISABILE: SCOMPOSIZIONE IN NUCLEI FONDANTI COMPLETA RIPETI OPERAZIONE RISULTATO 4 VOLTE IL 3 3X3X3X3 __ __ __ __ 81 2 VOLTE IL 5 5X5 __ __ 25 3 VOLTE IL 2 2X2X2 __ __ __ 8 3 VOLTE IL 4 4X4X4 __ __ __ __ 64 TRASFORMA COME NELL‟ESEMPIO 3+3+3+3 2+2+2 = 3 X 4 = ____ = ___ X 3 = ___ 5+5 = 5 X _____ = ____ 4+4+4 = ___ X ____ = ___ QUAL E‟ L‟OPERAZIONE GIUSTA ? 3X4= 5X2 = 2X3 = 3X3X3X3 3+3+3+3 5+5 5X5 2+2+2 2X2X2 3X3 ATTIVITA’ PER LA CLASSE: GEOGRAFIA VALUTARE LE AZIONI DELL‟UOMO SUI SISTEMI TERRITORIALI LEGGI IL TESTO E INDIVIDUA GLI ELEMENTI ANTROPICI E NATURALI E PROVA A INDIVIDUARE LE MOTIVAZIONI PER CUI L‟UOMO HA MODIFICATO L‟AMBIENTE “Eccoti in Valle d‟Aosta, la regione più piccola d‟Italia, che occupa la valle percorsa dalla Dora Baltea, incuneandosi tra le vette più alte d‟Europa. Questo potrebbe portarti a credere che essa sia isolata, ma l‟autostrada di fondovalle, i valichi alpini, le gallerie del Monte Bianco e del Gran San Bernardo collegano questa regione al resto dell‟Europa occidentale”. ATTIVITA’ PER L’ALUNNO DISABILE: SCOMPOSIZIONE IN NUCLEI FONDANTI INDIVIDUARE E DESCRIVERE GLI ELEMENTI FISICI E ANTROPICI LEGGI LE SEGUENTI PAROLE E CERCA IMMAGINI CHE LE RAPPRESENTANO STAMPALE, RITAGLIALE E INCOLLALE SU UN CARTELLONE E SCRIVI UNA DIDASCALIA PER OGNUNA DI ESSE: - valle - monte - gallerie - autostrada - valico alpino STAMPALE, RITAGLIALE, RAGGRUPPALE IN BASE ALLE LORO CARATTERISTICHE (classificazione) ATTIVITA’ PER LA CLASSE: STORIA INDIVIDUARE LE CAUSE DI UN EVENTO STORICO O DI UN AVVENIMENTO STORICO. ATTIVITA’ PER L’ALUNNO DISABILE: SCOMPOSIZIONE IN NUCLEI FONDANTI INDIVIDUARE FATTI DELLA PROPRIA VITA CHE HANNO PORTATO A DEI CAMBIAMENTI: QUALE CAUSA? - cambio di abitazione - cambio del lavoro del padre o della madre - cambio degli ambienti della casa in cui vive ATTIVITA’ PER LA CLASSE: SCIENZE DESCRIVERE E INTERPRETARE IL FUNZIONAMENTO DEL CORPO COME SISTEMA COMPLESSO. LEGGI ED EVIDENZIA NEL TESTO LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL‟APPARATO RESPIRATORIO ATTIVITA’ PER L’ALUNNO DISABILE: SCOMPOSIZIONE IN NUCLEI FONDANTI AVERE CURA DELLA PROPRIA SALUTE QUALI CAUSE PROVOCANO MALATTIE ALL‟APPARATO RESPIRATORIO? COSA FARE? Livello di semplificazione/scomposizione in base alla gravità del deficit Es. Classe prima sc. Primaria Attività per la classe: apprendere la letto-scrittura con metodo fonetico Attività per l‟alunno con R.M. lieve: leggere parole bisillabe e trisillabe piane Attività per l‟alunno con R.M. medio: avviare ad una lettura funzionale (riconoscimento di parole utili – etichette, insegne, cartelli ). Classe da 3^ sc. Primaria in poi Attività per la classe.: collocare eventi (prima e dopo ) sulla linea del tempo in riferimento alla civiltà studiata. Attività per l‟alunno con R.M. lieve : riordinare immagini riferite ad azioni di vita quotidiana o relative a causa ed effetto Attività per l‟alunno con R.M. medio: saper eseguire in sequenza un‟azione Classe da 3^ sc. Primaria in poi Attività per la classe.: leggere mappe e carte per programmare un viaggio Attività per l‟alunno con R.M. lieve: leggere carte per individuare il tragitto casa-scuola Attività per l‟alunno con R.M. medio: riconoscere la funzione di alcuni ambienti conosciuti Es. Classe prima sc. Secondaria Attività per la classe: produrre testi scritti a seconda degli scopi e dei destinatari Attività per l‟alunno con R.M. lieve: scrivere un semplice testo (cronaca, lettera) Attività per l‟alunno con R.M. medio: avviare a una scrittura funzionale (scrivere messaggi utili – di aiuto, di richiesta, di informazioni) Es. Classe prima sc. Secondaria Attività per la classe: riconoscere situazioni problematiche, individuando i dati da cui partire e l‟obiettivo da conseguire Attività per l‟alunno con R.M. lieve: saper leggere uno scontrino, saper calcolare il resto Attività per l‟alunno con R.M. medio: conoscere le monete (non i centesimi) e le banconote di uso più frequente; saper usare la calcolatrice Lavoro in contesto esterno alla classe SOLO SE anche i compagni svolgono un lavoro individuale PARTECIPARE ALLA CULTURA DEL COMPITO L‟OBIETTIVO E’ PIU’ SOCIALE CHE COGNITIVO. SI FA PARTECIPARE L‟ALUNNO A MOMENTI SIGNIFICATIVI DELL‟ATTIVITA‟ CURRICOLARE DELLA CLASSE. SI INSISTE SUL CLIMA EMOTIVO. SI ATTRIBUISCE IMPORTANZA AI PRODOTTI ELABORATI. OBIETTIVO SOCIALE: interazione, integrazione, inclusione. CONTENUTI: abilità di autonomia (relazione, comunicazione, orientamento …) Occasione per lavorare con gli altri compagni Partecipare alla cultura del compito NON SOLO OBIETTIVI COGNITIVI, MA ANCHE SOCIALI Esempi Storia: Obiettivo ordinare cronologicamente fatti ed eventi Classe: riordinare fatti su una striscia del tempo Alunno disabile: apprendere i concetti di prima e dopo, riferiti alla propria vita personale INTERAZIONE: chiedere ad alcuni compagni o alla classe di collocare sulla striscia del tempo anche fatti significativi della propria vita Italiano: Obiettivo comunicare in modo adeguato Classe: usare registro formale informale Alunno disabile: rispondere a domande semplici INTERAZIONE: chiedere ai compagni quali sono le loro preferenze e comunicare le proprie Matematica: Obiettivo saper risolvere problemi matematici Classe: individuare strategie risolutive (progettazione di uscite al mercato, in gita) Alunno disabile: saper usare il denaro INTERAZIONE: creare un mercatino per la classe; effettuare piccole spese con i compagni Geografia: Obiettivo conoscere le caratteristiche di un territorio Classe: confini, attività economiche, usi e costumi (guide turistiche per la gita) Alunno disabile: organizzare la gita INTERAZIONE: con i compagni individuare luogo, mezzo di trasporto, abbigliamento adatto Scienze: Obiettivo conoscere peso, massa e peso specifico Classe: misurare forze (dinamometro, bilancia) Alunno disabile: effettuare misurazioni con la bilancia, fare previsioni e confrontarle con gli esiti ottenuti INTERAZIONE: chiedere ai compagni di pesarsi, elaborare con loro un istogramma Bibliografia Comoglio M – Cardoso M., Insegnare ad apprendere in gruppo, LAS Roma 1996 Gelati M., Pedagogia speciale e integrazione, op. cit., p.58. Ianes D., Didattica speciale per l‟integrazione, Erickson, Trento 2005, pp.213-224. 35.Cfr. ROLLE Loos S., Giochi cooperativi, Gruppo Abele (1993) Marchi C., I webquest: come utilizzare internet nella didattica, in “Nuova Secondaria”, 10, giugno 2007 Marchi C., I webquest: per usare il computer in classe, in “La Scuola e l‟Uomo”, 3-4, marzo-aprile 2006. McGinnis E. et al., Manuale di insegnamento della abilità sociali, Erickson (1986) Molteni N. et altri., Le attività di sostegno didattico- Tracce svolte per la prova scritta – EDISES 2014 Pavone M., Educare nelle diversità, Erickson, 2001 Pavone M.J., Premesse per una didattica della conduzione integrata della classe, L‟integrazione scolastica sociale, vol.3,n.3 Sharan Yael, Apprendimento cooperativo per alunni con difficoltà di apprendimento, Junior Stella G., Grandi L, La dislessia e i DSA, Giunti Scuola 2011 Vianello R., Tortello M., Esperienze di apprendimento cooperativo, Junior 2000 www.scintille.it www.superabile.it
Scarica