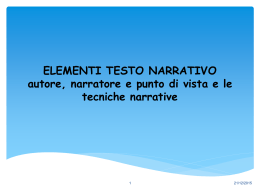Maria Teresa Zattoni - Gilberto Gillini Il latte e il miele Nessuno può portare un altro se non dove è già stato Trarre risorse dalla propria esperienza Portare l'altro dove uno è già stato è un classico della pratica psicoterapeutica: per poter esercitare da psicoterapeuta, bisogna essere stato in psicoterapia. Ma è anche elemento portante della trasmissione della fede: parlare del messaggio delle Scritture senza poggiarlo sulla propria esperienza di fede e sulla propria gioia di essere salvato sarebbe un puro gioco intellettuale. Finiremmo rapidamente al livello delle facoltà teologiche tedesche che pullulano di atei che studiano "scientificamente" la Parola così come studierebbero "scientificamente" i poemi omerici. Non per niente Benedetto XVI, parlando recentemente al clero della diocesi di Roma, ha affermato che nella relazione «i giovani devono sentire che non diciamo parole non vissute da noi stessi, ma parliamo perché abbiamo trovato e cerchiamo di trovare ogni giorno di nuovo la verità come "verità per la mia vita"». Noi ritroviamo una conferma di ciò nella nostra opera di counselling per coppie e famiglie. Nei casi in cui possiamo partire da una comunanza di valori e di fede con la persona che ci consulta, possiamo mantenere ben radicato nel nostro cuore il pregiudizio che in certe scelte, anche dolorose, il binario della fede e il binario della scienza coincidano, per cui alla persona che vuole andare nella terra dove scorre il latte e miele possiamo anche dire che la sua scelta, oltre che di fede, è intelligente e scientificamente significativa. Imparare a vedere il mondo con gli occhi di Gesù A ben vedere, però, "portare l'altro dove si è già stati" è anche, in un suo significato semplicistico, un compito impossibile sia nel caso del terapeuta sia nel caso della trasmissione della fede. In entrambi i casi, sia a livello di fede sia a livello di dinamiche psicologiche, io incontro una persona nuova, che produce una relazione nuova da cui si imparano cose nuove; in una parola anch'io mi addentro in una terra straniera, sconosciuta per certi versi anche a me accompagnatore. Svilupperei questa considerazione con due avvertenze. La prima è un'avvertenza generale e ben nota nei nostri ambienti cristiani. La necessità, che si sviluppa o nella relazione amicale o nella direzione spirituale o nella relazione d'aiuto in generale, di vedere che la strada dell'altro verso il latte e miele consiste nel promuovere in lui la capacità di leggere e vedere il proprio mondo relazionale con lo sguardo di Gesù e, cioè, la capacità di intuire i «cieli e terre nuove» di cui parla San Paolo, sotto la crosta dei "fatti che parlano da soli" (ma che parlano solo in modo monotono e disperante). Eppure proprio qui non possiamo non tenere conto di come questa strada possa essere soggetta al fatto che colui che accompagna nella fede possa spingersi ad una indebita appropriazione dello sguardo di Gesù: nel senso di donna Prassede o nel senso violento del Gott mit uns. L'avvertenza va nel senso della cautela, dell'automonito-raggio o, ancora meglio, nel senso dell'umiltà di farsi monitorare da un altro o da un gruppo. Abbiamo tutti sentito persone di grande sapere teologico esemplificare malamente sul piano psicologico, abbiamo visto persone far coincidere il proprio desiderio di non essere intrusive o fuorvianti con una conduzione purtroppo di fatto intrusiva e fuorviante. Un problema di monitoraggio Penso che le scienze umane potrebbero insegnare a noi cristiani quando entriamo in una relazione che potremmo chiamare di aiuto qualcosa in tema di automonitoraggio. «Più le persone sono lontane dalla realtà scientifica della terapia, più hanno la fantasia che non ci sia bisogno di una supervisione: quante volte, ad esempio in un corso di formazione per operatori volontari, abbiamo colto, più o meno esplicite, osservazioni che sottintendevano: "Se devo sembrare competente, devo essere autosufficiente". Gli psicoterapeuti conoscono invece benissimo la funzione che ha il supervisore, consultato dallo psicoterapeuta durante un trattamento di psicoanalisi o, nelle terapie sistemiche, collocato dietro allo specchio unidirezionale ad osservare la relazione tra terapeuta e cliente». Scrive J.H.Weakland: «Quando una persona sottopone ad un operatore un problema, l'operatore si trova in una situazione di grande potere. Molti si sentiranno a disagio all'idea di avere tanta influenza (nel bene e nel male) sui loro clienti. Ma negare il potere che vi deriva dal vostro ruolo non serve ad annullarlo, serve solo a diminuire il vostro controllo e la vostra autodisciplina in situazioni che richiedono al contrario grande professionalità». Molti operatori che intrattengono una relazione d'aiuto penseranno che, grazie a Dio, loro non hanno clienti, che non hanno niente da vendere o da comprare. Ma non basta non essere in una posizione di autorità o non voler assumere una posizione di autorità per non assumerla veramente. Meglio accogliere le proprie posizioni autorevoli ed usarle come risorse per analizzare le alternative possibili piuttosto che influenzare di fatto negativamente una persona. Il valore del proprio non sapere Passiamo alla seconda avvertenza. Mentre normalmente chi parla crede di essere utile nelle sue inossidabili certezze (e talvolta è davvero così!), capita talaltra che proprio l'incertezza e i dubbi - in una parola l'impotenza e non la potenza - siano di aiuto all'altro. Già San Paolo l'aveva detto: «Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. E mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio» ( 1 Cor 1,20-24). Nei termini della comunicazione è risaputo che, a volte, sia proprio l'atteggiamento impotente e dubbioso che la persona assume nella comunicazione, ad aiutare l'altro a prendere la direzione della terra dove scorrono latte e miele. Personalmente noi ci siamo sempre spiegati così questo fenomeno. Più noi cristiani ci diamo da fare a convincere e polemizzare con gli altri, più li allontaniamo da Lui; se invece spendiamo il nostro tempo a maturare benevolenza tra noi e i nostri simili, il Signore stesso può operare indicando agli altri la sua strada... e riducendo noi all'unico ruolo che veramente ci compete: quello dei servi inutili! Infatti quando una reale e disperante sofferenza della persona che ci sta di fronte rende vana ogni forma di consolazione, e la ragione chiuderebbe la situazione nella disperazione, solo la fede può aprire alla speranza. In questi casi che cosa si comunica? Come si comunica? Si comunica con la relazione: lasciando perdere ogni capacità di comunicare per usare solo la capacità di relazionarci. E la relazione allora diventa a nostro parere un atto creativo, un atto molto vicino alla scrittura di una qualche forma d'arte. In questi casi la relazione diventa allora la narrazione di tutta la propria vita precedente, dove tutte le relazioni passate plasmano ciò che il narratore è nel presente. Dopo queste brevi premesse, vorremmo farvi ascoltare due racconti di fede. Una narrazione musicale Iniziamo con un racconto in musica. È stato composto da un giovane esegeta, don Martino Signoretto che compone musica da dilettante. Vi faccio ascoltare: «Verso un paese dove scorre latte e miele» (Es 3,8). La sua narrazione al pianoforte mi ha colpito per lo stile chiaramente moderno, in apparenza disimpegnato. Mi è sembrato di individuare chiaramente in questa composizione alcuni passaggi che narrano l'esodo verso il paese dove scorre latte e miele. 1) Pochi arpeggi iniziali ascendenti introducono al tema e sembrano dire la povertà del punto di partenza: la nuda aspirazione dell'uomo verso un paese dove scorra latte e miele. Segue immediatamente il tema della narrazione del paese dove scorre latte e miele e cioè dell'annuncio/chia-mata verso questo paese; e il tema narrativo si trasforma, si estende... Ad un certo punto, sfocia nell'urgenza di rapidi arpeggi discendenti che sembrano raggiungere il cuore. 2) La risposta dell'uomo ha allora il sapore di un «Andiamo, mettiamoci in marcia!»: gli accordi si fanno pieni, scanditi, e riprendono sempre di nuovo la tonalità di base con risonanze nuove, più personalizzate. 3 ) Infine torna il tema della narrazione/chiamata; c'è infatti bisogno di un ritorno alla chiamata che invita a oltrepassare sempre e di nuovo l'esistente. Il tema conclude su una sospensione, si ferma, con silenzio e rispetto, là dove le nuove generazioni "ricominceranno" l'esodo. Una narrazione di vita Vorrei proporvi ora un ben più prosaico esodo verso la terra promessa. La casa in cui si svolge il racconto è quella di una nostra amica. «Ven chi, ven chi subit!». «Subit!», gridò di nuovo il mio vecchio padre, nel timore di non essere obbedito, Io feci in tempo a scostare dal fuoco la casseruola del riso e corsi in bagno. Il mio vecchio era là, brutto nella sua ira: i pantaloni calati fino a terra, in piedi a gambe larghe, intorno a lui, lo scempio: cumuli di carta igienica sporchi di feci, mattonelle imbrattate, l'acqua del bidet che scendeva a fiotti. Con un colpo d'occhio capii che aveva voluto lavarsi da solo. - Te l'ho detto che mi devi chiamare, se hai bisogno -gli dissi, dura. - T'ho ciamàtt - osservò lui, in tono perentorio, nascondendo con forza il suo imbarazzo. - Ma prima di far tutto sto casino, no?! - gli urlai, guardandomi intorno disgustata e impotente - Devi chiamarmi, se hai bisogno - ripetei, come una cantilena ribadita infinite volte, a rassicurare me stessa. E mi guardavo intorno, immobile nel disgusto, non sapendo da dove cominciare e con il risotto bene piantato nella mente, il risotto per i "miei", affamati nell'imminente mezzogiorno. Con gesto involontario, raccolsi i grumi di carta igienica, mi guardai le mani con schifo orrendo, tesa nell'espressione, ma la testa di pietra. - A ottant'anni dovresti capire... - borbottai tra me, mentre pensavo: "Ma possibile che sia già così vecchio?!". - L'è el to water che funziona no - disse lui, tirando su il mento, mentre con un gesto maldestro tentava di recuperare le mutande sporche intricate nei pantaloni scesi a terra. Ah no! Questa non me la doveva dire! Eccolo, il superbo, l'irriducibile, quello che non ammetteva mai un suo torto. Assurdo. Veramente assurdo. La Kati bambina che dormiva nella mia mente di pietra si risvegliò in tutte le sue ferite. Il papà duro, dispotico, trasgressivo; eccolo. Eccolo lì sporco, impotente, pieno di cacca: eppure il padrone di sempre. Un fiume di parole mi urgeva in gola, un fiume che si trascina i detriti più impensati, dure scaglie da lanciare alla sua protervia: ma il livore era tale che le parole non uscivano: colpivano me, dal dentro. Qualunque cosa avesse fatto, aveva sempre ragione lui. In ogni caso sarei stata in ritardo: dovevo averlo già pulito e cambiato, dovevo aver eliminato quell'odore insopportabile che mi storceva la bocca, il naso, ogni muscolo del viso. E intanto ero già in ritardo per il mio risotto. Mentre rotolavano i secondi, d'improvviso, lo sguardo mi cadde sull'asciugamano del mio bagno, l'asciugamano da viso, candido, morbido: sporco di cacca. Ma, improvviso, un pieno di tenerezza mi corse dentro, mi invase, mi plasmò... - Oh, testùn - gli dissi piano, accarezzandogli la testa dai capelli arruffati, ancora così stranamente folti. Lui mi guardò sott'occhio, per un istante incredulo. Ma i miei gesti ormai erano morbidi, buoni, coesi con il mio cuore. Il vecchio, allora, lasciò che il suo capo esprimesse il tremito che lui voleva domare: si sentì fragile, indifeso. Sotto la mano, sentii la testa che tremava un poco e lo guardai: era bello, il mio vecchio. Le pieghe della pelle, aggrinzila e rugosa, i nei esagerati, la fronte altissima e quei cocciuti capelli arruffati all'indietro. Era bello, il mio vecchio padre, testardo e impaurito. I gesti della pulizia furono lievi ed efficaci: il vecchio uscì dal bagno perfino con un leggero profumo di talco alla magnolia. Uscì al mio braccio, maestro e re, instaurato nel trono della sua sicurezza. Si lasciò cadere in poltrona e disse con due occhi lucidi: - Cià, bevom. Un buon bicchiere di vino ci farà bene. Non trovai nulla da ridire: le obiezioni del "Ma perché mai bere prima di mangiare" rimasero nel fondiglio della mia anima, perché il cuore era occupato da una nuova esaltazione. II vino era quello di sempre, "da contadini": ma i bicchieri li avevo tirati fuori dalla vetrinetta, due calici. Mentre ne portava uno alle labbra, il vecchio mi guardò e disse: - Te set bela. Mio marito, entrando, ci trovò con il calice in mano. - Che è successo? - chiese, respirando un'aria speciale, incomprensibile. - Ah, scusa - mi affrettai a dire - abbiamo avuto un incidente. Sono un po' indietro con il risotto! Ma mentre correvo ai fornelli, udii mio padre che diceva a mio marito: - Me, me so' stupid, ma le', l'è bela! La vicinanza di quelle due strane categorie, la stupidità e la bellezza, mi faceva cantare dentro, di ebbrezza. Erano le due categorie che "mettevano a posto le cose", in modo così irrazionale, eppure così logico. No, molto di più... "facevano nuove le cose". È lo Spirito in azione, lo Spirito che soffia quando vuole e viene da lontananze siderali. E crea vicinanze inaspettate. Se era per me, in quella situazione, lo avrei insultato, il vecchio, ho avrei fatto fuori, con tutta la sua sicumera. In quello stato, e credere ancora di aver ragione! Mai un "per piacere", mai un riconoscere di aver bisogno. Quando poi ho visto che, nell'orgoglioso tentativo di pulirsi, mi aveva anche sporcato l'asciugamano, allora la misura fu al colmo. Da me, da me soltanto non poteva che arrivare sprezzo e offesa. Invece! La tenerezza che improvvisa mi ha attraversato non era mia: veniva dallo Spirito. Così come viene dallo Spirito il camminare sulle acque: sulle acque della nostra miseria e dei nostri rancori. E la tenerezza che mi ha raggiunto, non come qualcosa che esce da me. E lo Spirito che dona uno sguardo nuovo con cui vedere le stesse cose. Eppure la tenerezza è anche mia, perché io non le ho detto di no, non le ho chiuso la porta; l'ho vissuta io e quindi è mia, anche se mi supera. Avrei potuto dirle di no e ricacciarla indietro come la più inadeguata delle reazioni. Invece mi ci sono affidata! Il fatto, in sé, è perfino banale: il vecchio ha bisogno di aiuto, ma si comporta come un bambino testardo, la figlia è piena di rancore per il disastro che ha combinato, ma ad un tratto gli fa un gesto di tenerezza; e così i due si riconciliano. La forza della narrazione come metodo Vogliamo ora analizzare la forza della narrazione come metodo per trasmettere la fede in famiglia. Seguiremo un nostro recente testo su questo argomento. C'è un metodo che il Signore stesso ha scelto per parlare al suo popolo, anzi per formarsi un popolo, poiché è un metodo che educa, nel senso letterale: e-duca, cioè con duce fuori, dà forma, forza e significato. Dio non si è presentato con belle autodefinizioni, anzi a "rivelare il suo Nome" - nel Primo Testamento - è stato quasi costretto da quel coraggioso di Mosé che si sente inviato a liberare il suo popolo schiavo in Egitto, ma vuole conoscere il Mandante; e sappiamo bene che questa rivelazione del Nome è anche al tempo stesso non-svelamento, poiché il Dio santo è terribile, non si consegna in modo da poter essere "usato" come formula magica: per amore del Santo suo Nome e quindi per amore di noi. Con infinita pazienza Dio ha scelto di narrare sempre di nuovo - nella Prima e nella Nuova Alleanza - come lui il Santo si impatta nella storia della sua gente («Mosé disse a Dio: "Ecco io arrivo dagli Israeliti e dico loro: Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Ma mi diranno: Come si chiama? E io che cosa risponderò loro?". Dio disse a Mosé: "Io sono colui che sono!". Poi disse: "Dirai agli Israeliti: Io-Sono mi ha mandato a voi". Dio aggiunse a Mosé: "Dirai agli Israeliti: Il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione"», Es 3,13-15), come guida fuori il Suo Popolo, come inventa vicinanze misteriose, e come - da ultimo, proprio per i nostri giorni ultimi - è presente nella Eucaristia. Una narrazione teologica Da Lui stesso, perciò, possiamo imparare almeno un poco il metodo del narrare. Visitiamo alcuni tratti della narrazione per gustare il metodo della narrazione dal punto di vista teologico (lasciando ovviamente agli esegeti l'illustrazione delle finalità della narrazione biblica) e dal punto di vista psicoeducativo. Mettiamoci anzitutto dal punto di vista del succedersi degli avvenimenti sul piano fattuale. Tale succedersi è in se stesso "imprendibile", tanti sono i micro e i macro eventi; anche se solo volessi narrare ciò che ho fatto nelle ultime ventiquattro ore, non posso semplicemente prendere gli eventi e metterli in fila; da che cosa comincerò? Dal momento del risveglio e dalle notizie che mi arrivano dal giornale o da come i miei figli tirano fuori le gambe dal letto? Privilegerò gli eventi interni familiari o quelli esterni? Quelli in cui io sono attivo o quelli che subisco? Eccetera eccetera. In altre parole, per narrare ho bisogno di un punto di vista, il quale - inevitabilmente seleziona il coacervo di materiale che altrimenti non sarebbe afferrabile. In altri termini: la pura successione dei fatti non è possibile, vi devo introdurre una chiave che inevitabilmente li seleziona: se devo narrare la mia giornata dal punto di vista della dieta, ad esempio, selezionerò fatti ben diversi da quelli che selezionerei se dovessi narrare tutte le parole che ci siamo scambiati, ad esempio tra me e i miei figli. La narrazione, cioè, è sempre attiva, non è mai pura registrazione. Fin qui l'opera del narratore (e a maggior ragione dello storico che si interessa del passato in quanto tale) per così dire "mondano", orizzontale. Ma quando la narrazione ha a che fare con l'Invisibile, quando educa, forma un popolo che Lo riconosca e Lo adori, non basta un qualsiasi punto di vista. Di solito usiamo la seguente metafora: la vita di ciascuno di noi è una sorta di limatura di ferro, in sé inerte e insignificante; ma se una calamita la percorre da sotto il foglio in cui è depositata, ecco che essa si dispone come un disegno, acquista un senso, una direzione. In altre parole, occorre che un punto di vista insieme più profondo e più alto, irrompa nell'indefinito e uniforme susseguirsi degli eventi per darvi significato. Prendiamo un gruppo di schiavi sulle rive del Mar Rosso: sono usciti dall'Egitto, famiglie intere, con quel poco che avevano; sono usciti sulla parola di Mosé e hanno creduto ad un sogno di libertà; ma in quel preciso momento sentono dietro di loro il terribile rumore dei carri del Faraone mentre davanti hanno il mare insuperabile per una manciata di persone prive di mezzi opportuni. Il mare si erge davanti a loro non soltanto come una difficoltà, ma come l'evidenza immane della loro inanità; alle loro spalle avanza la potenza del Faraone con la sua incombenza di vendetta e di morte. In quel momento, sul far dell'alba, il mare si spalanca, come se avesse braccia per raccoglierli e portarli asciutti all'altra riva, verso la libertà: allora il mare che si divide non è un evento tra i tanti, per quanto grandioso e memorabile, ma è il senso della narrazione; per usare la nostra metafora: è la calamita che dà orientamento. Ciascuno degli Israeliti e tutti insieme possono dire: «Ah, ecco, perché Dio ci ha mossi sulla parola di Mosé. Ah, ecco, questa esperienza è nuovissima, inaudita: Dio si è messo dalla nostra parte e non dalla parte di chi schiaccia i deboli; non siamo stati condotti in una trappola mortale, non ci siamo illusi di essere interessanti per il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe: davvero Lui ci conduce!». Ciò fa esplodere la nostra danza, il nostro canto, la nostra identità: adesso sappiamo chi siamo: non una somma di straccioni indifesi, ma gente con cui Dio si è impattato, inequivocabilmente. Non è questo l'anticipo di una vita facile, senza pericoli, anzi sarà una vita dura, senza sconti, in cui i nostri figli nasceranno e moriranno, soffriranno e gioiranno, vedranno la libertà e la pagheranno a caro prezzo; ma tutto questo, da quel momento in poi, acquista un altro senso. E l'invisibile che irrompe nella realtà e non la cambia magicamente nella sua crosta superficiale, ma la muta di segno e così il credente fa esperienza che la realtà non è solo la crosta degli eventi, ma ha un cuore segreto: colui che la conduce, che rimane Santo, cioè inattingibile e non manipolabile, è reale più della crosta dei fatti, anzi ha effetti visibili. Tutta la storia della salvezza è narrata per condurci a questa meta: l'esperienza del Dio che conduce la storia e si rivela definitivamente nel Figlio. Ma il narratore biblico non sta là confinato nei libri, non ci presenta una storia narrata di cui siamo semplici ascoltatori, non ci prospetta un passato distante da noi, ma si frantuma, per così dire, nei miliardi di narratori, di genitori in particolare, che provano nella loro umile narrazione la stessa esperienza, offrendo in questo nuovo canto la limatura di ferro della propria vita. Perché il narratore narra, se no? Se narra per imbonire, insegnare, far passare istruzioni, è come uno che per vendere la sua merce (sulla cui qualità dubita fortemente) ha bisogno di crearle intorno lustrini e belle vetrine; ma la veste, purtroppo, non ha a che fare con la qualità della merce. E i bambini (e non solo loro!) lo scoprono subito: si annoiano di simili camuffamenti, anzi si sentono un po' forzati (e magari con rabbia più o meno repressa!) e, prima o poi, scoprono che la pillola, per quanto colorata e invitante, sempre pillola è. Se il narratore narra per propaganda, per tirare acqua al mulino della sua verità, per dimostrare che le sue idee sono giuste, prima o poi apparirà come un povero pro-mulgatore che non attira nessuno, un po' malconcio e fine a se stesso; sarà presto abbandonato, soprattutto dai bambini! Allora perché narra il narratore? Perché... non può fare altrimenti, perché ciò che narra lo rende buono, dà sapore alla sua stessa vita. Se ha provato l'esperienza del Padre che guida la sua storia (e non tanto e non solo la sua storia individuale, ma la storia della sua famiglia) allora narra per esigenza del cuore. Poiché, mentre vede che le acque del mare si sono aperte, e lo racconta, afferra il valore aggiunto alle vicende che l'hanno portato fin lì; e allora le stesse cose sono narrate di nuovo, acquisiscono cioè una quarta dimensione, e il narratore fa una particolarissima esperienza: mentre le racconta, esse - proprio esse, le vicende della sua vita - gli fioriscono tra le mani, si dilatano, diventano un flusso. Siamo soliti dire che i ricordi che si depositano nella mente, anche qualora siano stupefacenti, lasciati a se stessi, ritagliati dal flusso della vita, diventano tossici. Gli sposi sanno che se fissano i singoli eventi (quelli della luna di miele, si diceva una volta) dei loro primi tempi della loro vita di coppia come parametri («Oh, come era premuroso/a... una volta!») come ricordi appesi nella mente, non ce ne vengono fuori, rimangono arroccati là e prima o poi uno narra la stessa mortifera e monotona storia a carico dell'altro: «Ecco come oggi non sono amato/a». E lo stesso dicasi, a carico del figlio: «Una volta sì, quando eri bambino, eri espansivo, delizioso! E perché mai ora sei diventato così scostante?». Ma il narratore esce dai vicoli ciechi dei ricordi, perché si lascia portare dalla memoria: proprio come gli Israeliti si lasciavano portare dal flusso della memoria anche nella durezza del percorso nel deserto. La memoria è appunto questo: sapere che c'è il punto alto che offre un disegno alla nostra limatura di ferro, saperlo come si sa che c'è il sole, anche quando le nubi lo coprono. Il narratore sa cos'è la memoria, dentro essa si muove; nel suo procedere afferma una e infinite volte non la sua irreale vie en rose, non l'happy end dei cartoons collocato in uno spazio fantastico extraterrestre, ma come stare qui, ora: «Ah, ecco, adesso vedo un piccolo punto luce». Abbiamo appena fatto questa esperienza con la storia di Kati: ci siamo sentiti più buoni perché la narratrice sa che la narrazione ha reso lei stessa più buona. Una narrazione psicologicamente avvertita Esploriamo ora il narrare dal punto di vista psico-educativo. Cominciamo con il chiederci perché ai nostri bambini piace così tanto sentir narrare le storie. Qualunque genitore sa, ad esempio, che non c'è regalo più bello per il piccolo che va incontro alla notte che stargli accanto con una storia. Proviamo ad analizzare questa esperienza dal punto di vista dei contenuti. Le prime storie sono brevi, elementari, fatte soprattutto di gesti e di toni di voce marcati e chiari; il piccolo è attentissimo, specie se gli si narra qualche brandello della sua storia, tipo: «Sai come facevi le prime volte che mangiavi la pappa? E quando siamo andati a trovare la zia al mare?...». Il piccolo spalanca gli occhi, perché le cose narrate sono in qualche modo oggettivate, acquistano spessore e magari ride divertito se gli raccontiamo che voleva prendere lui il cucchiaio della pappa e... se la infilava in un orecchio! Le cose narrate si moltiplicano e si approfondiscono, possono essere "chiamate fuori" in modo da scorgerne i lati nuovi, magari mai visti. E proprio con lo sguardo con cui si sente guardato, il bambino può esperire e sentirsi guardato come figlio di Dio. Poi, a partire dai quattro/cinque anni il bambino amplia i suoi orizzonti percettivi e allora può lasciarsi prendere da fiabe e storie di principi ed eroi; il piccolo umano sa ormai distinguere (poco alla volta, s'intende) ciò che abita nella sua mente e ciò che abita nella realtà esterna, sa benissimo che pensare un gelato non è lo stesso che mangiarlo! E ancora: quanto più le storie sono "fantastiche" tanto più lo prendono, perché è proprio affascinato dall'esplorare i confini della realtà. Anche in questa età, le storie meravigliose della Bibbia costituiscono un incantamento da non mettere in secondo piano: ad esempio, un profeta che finisce nella pancia della balena o Gesù che cammina sulle acque conservano tutto il loro spessore simbolico in modo intuitivo, poiché - lo abbiamo visto - il bambino è connesso con la mente e con il cuore e non ha ancora imparato a mettere quei limiti rigidi (del tipo: è vero solo ciò che tocco) che tanto ci impoveriscono nella nostra boria di essere scientifici. Di più, il narrare e il costruire insieme storie, proprio a partire da quest'età, è il grande antidoto a quella consegna acritica, passiva e a-creativa che di solito sperimentiamo quando siamo spettatori dei mass-media e dei mezzi tecnologici. Uno spettacolo tv, anche ben fatto, anche specifico per bambini, offre alla mente l'intera gamma dell'immaginario come già precostituito, prefabbricato: al bambino non resta che assorbirlo, conformarsi, starvi dentro. Per essere concreti: una favola come quella del "drago al guinzaglio", se narrata dalla calda voce umana, può prendere nel bambino tutte le misure, tutti i colori, tutte le forme che la sua mente vi dà; anzi, si può star sicuri che la stessa immagine (il drago) sarà diversa da bambino a bambino, ognuno può rappresentarselo in modo attivo, creativo (e magari, in forma di gioco, confrontare i vari draghi che ne emergono!). Lo spettacolo (non per niente lo chiamiamo così: ci rende spettatori, recettori) deruba il bambino (e non solo lui) dell'attività immaginifica, dell'originalità, della specificità della sua capacità rappresentativa: che tristezza sarebbe un bambino che non sapesse costruirsi un drago nella mente! Di solito gli adulti sono ladri di queste compagnie intime, come dice un delizioso libretto per bambini di sei-dieci anni. Va da sé che non occorre spegnere il televisore: anzi, una tv a piccole dosi può incentivare altre immagini e nutrire la mente del bambino, purché non sia consegnato soltanto alla tv. Un bambino che alimenta la propria abilità intuitiva, percettiva e creativa - grazie alla narrazione - è un bambino fortunato, meno manipolabile da adulto. Intorno ai 10-11 anni il ragazzo è interessato di più alla storia che alle storie: cioè a conoscere ciò che è accaduto un tempo, ha desiderio di documentarsi, di sapere: e in questo la Bibbia è un cumulo di sapere, anche storico! E interessato anche al "romanzo familiare" proprio in questo senso: percepisce di non essere "nato stamani", che generazioni l'hanno preceduto, che gli hanno lasciato le loro orme: un ragazzo che non conosce pressoché nulla della sua storia familiare (i genitori, gli zii, i nonni, i bisnonni e su su, fin dove vi sono tracce) è un ragazzo impoverito e stimolato ad essere sempre più egocentrico, a riferire sempre tutto a sé, come se tutto gli fosse dovuto. E necessario allargare gli orizzonti, aiutarlo a farsi una mappa familiare che lo sostenga, anzi lo apra al futuro, gli dia compiti evolutivi. Per i ragazzi a quest'età, anche conoscere come è arrivata a noi la fede è interessante, purché non gli abbiamo ormai sottratto il fascino di questa esplorazione con le nostre ingiunzioni e le nostre prediche. Il circolo del narrare Dopo aver analizzato sommariamente alcune tappe della mente del bambino riguardo al racconto, passiamo ad interrogarci su ciò che accade nel circolo del narrare. Anche qui ci rifacciamo all'esperienza; l'adulto narratore sa che, se vuole incontrare i bambini mediante il racconto, è tenuto sì ad una certa coerenza del contenuto (provate, ad esempio, a cambiare i particolari di una favola, i piccoli vi correggeranno subito, specie a 4-5 anni), ma fa esperienza che la storia non è mai la stessa: la stessa storia raccontata a bambini diversi avrà sfumature diverse, la stessa storia allo stesso bambino in tempi diversi assu mera significati via via diversi. In altre parole, il narrare (a meno che chi narra non sia un registratore!) è un evento, ogni volta, e come tale per certi aspetti, irripetibile. In esso accadono tre espressioni precise, proprie del momento in cui il narrare si snoda tra narratori e ascoltatori/interpreti. La prima di queste espressioni è la modulazione reciproca: narratore e utenti partecipano allo stesso campo di emozioni, di mimica, di tono, di postura, tant'è che un narratore non potrebbe narrare a spalle girate senza guardare in faccia i suoi interlocutori: interlocutori in senso proprio, perché anche qualora stessero zitti, tutti presi dall'evento narrativo, "parlano", cioè introducono locuzioni (spesso involontarie: «oh»), si spaventano, ridono, piangono insieme alla vicenda che scorre, si percepiscono "uno" con il narratore e immaginano ciò che lui sta immaginando; nel contempo, dalla reazione dei bambini il narratore è a sua volta preso, meravigliato della loro meraviglia, felice della loro felicità, moderatore delle sue e loro emozioni. Accade così - ed è la seconda espressione - la rottura dell'isolamento: le barriere vengono momentaneamente abbassate, ci si sente gli uni per gli altri, ci si offre presenza e comunanza; tant'è che quando la storia finisce si resta per un attimo sospesi, anzi si rimane male, quasi che ognuno dovesse riprendersi i confini del proprio io e non potesse stare ancora un po' nel teatro della mente dell'altro. Qualcosa rimane, però, se qualcuno di noi ha avuto esperienza della voce di un padre o di un nonno narrante e magari - oh, vera e buona simbiosi - è stato accolto nelle sue braccia: ancora a distanza di decenni può sentire quel timbro, quel calore che l'ha fatto sentire uno con il narrante. Ambedue le espressioni cui abbiamo accennato culminano nella terza: la mediazione affettiva; e forse è questa la vera ragione dell'incantamento che avviene nella narrazione. Essa si esplica per così dire all'interno, in modo circolare; dicevamo che le parole acquistano significati a seconda dell'affetto che circola tra narratore e bambini e le stesse emozioni-pensieri-condizioni non sono lì invasive, talora violente, a sé stanti: passano da uno all'altro come già mediate; perfino il fatto di un lupo che sbrana una nonna può essere "detto" senza eccesso di spaventi, dentro questa mediazione. Così passano in questa mediazione gli eventi della vita, anche quelli più duri, che diventano nominabili, perché "mediati". La mediazione affettiva si esplica anche all'esterno e cioè dal narratore ad eventi passati che, grazie a lui, diventano interessanti, anzi affascinanti; e per tali racconti normalmente i bambini sono ben contenti di perdere gli asettici, anche se coloratissimi, cartoni animati. Sappiamo tutti che i racconti di guerra del nonno o gli incontri nella foresta dello zio missionario sono lì, vivi, indimenticabili: mediazioni preziose, nel tempo (le storie antiche) e nello spazio (le altre latitudini) che allargano l'esperienza dei bambini e li rendono grati. Sì, grati. Il bambino d'istinto riconosce il narratore ed è disposto a sedersi "ai suoi piedi". Peccato che oggi i narratori - genitori educatori, catechisti e animatori - rischino di non credere più in se stessi come narratori: chissà come, sentono forse un pizzico di inferiorità rispetto alla bellezza formale di certi cartoni, certi film, certi libri descritti. E allora rinunciano: «Vi leggo una storia»; già, i bambini si accontentano e si predispongono ad ascoltare; ma se il narratore dice: «Adesso ve la racconto io (o la invento io, meglio ancora)», diventano entusiasti: «Oh sì, nonno!». E se il nonno si esprime con un lessico limitato e perfino sgrammaticato? I bambini lo accettano, interi; non perché sono di "bocca buona", ma perché sono quei piccoli i cui angeli vedono la faccia di Dio, cioè si affidano. Lasciar passare questo tempo di grazia è un vero peccato.
Scaricare