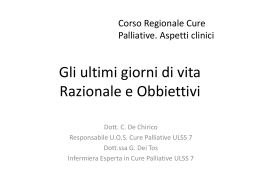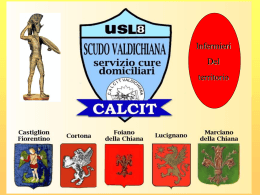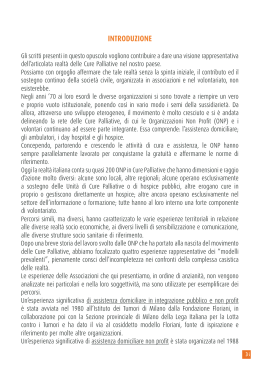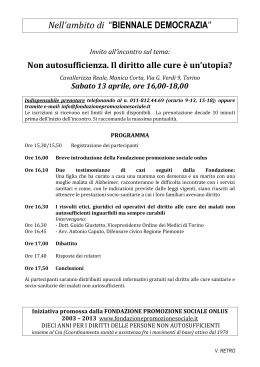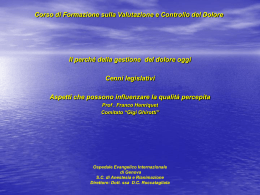morire vivi Gianni Grassi Sul mare di Palinuro (2001) INTRODUZIONE Il 6 febbraio 2007, dopo anni di pesanti terapie oncologiche e otto mesi finali di ricovero all’Hospice Antea di Roma (per una paralisi da infiltrazione al midollo spinale), moriva a 67 anni il “paziente esigente” Gianni Grassi. Sociologo, studioso di bioetica e tenace precursore della battaglia per un vero rapporto comunicativo fra medici e pazienti (che ha perseguito sino agli ultimi giorni). Comunista, sindacalista e sostenitore di forme di lotta alternative nel settore pubblico (pensate non contro ma con gli utenti); impegnato al fianco dei non vedenti (in particolare dei ciechi di guerra, come lo era suo padre) per garantire loro una piena autonomia. E ancora: coerente ecologista d’azione, concreto pacifista (con partecipazione a una missione di interposizione umanitaria in Bosnia), giornalista, curatore di libri e organizzatore culturale. Gianni Grassi è stato tutto questo e molto altro, mostrando sempre come caratteristiche umane una estrema generosità, grande passione ideale e altruismo. Tratti evidenziati dai suoi scritti e dalle sue riflessioni – altrettanto ricche e poliedriche – raccolte in una prima sintesi in questo libro (consultabili integralmente sul sito www.giannigrassi.it). Il lascito quanto mai attuale di un uomo che si è battuto sino in fondo per “morire da vivo, magari scrivendo”. 3 Bisogna salvarsi per poter morire, perché la morte non sopraggiunga senza coscienza, ma chiara, precisa, limpida. (José Revueltas Sànchez, “Il coltello di pietra”, 1957) PREFAZIONE Passando il confine Sen. Ignazio Marino Chirurgo • Presidente Commissione parlamentare d’inchiesta sul SSN S i è salvato Gianni Grassi, è morto vivo come pochi riescono a fare. Si è immerso con pienezza e generosità nel suo tempo, accogliendo l’amore della famiglia e dei tanti amici e ricambiando, moltiplicandolo. Ma ha fatto di più: ci ha ricordato che ciascuno di noi ha il diritto di morire vivo, ogni persona ha il diritto di essere un paziente esigente. La sua esperienza umana si è fatta testimonianza quotidiana, un richiamo per i medici a porsi in ascolto, comportamento che diventa medicina miracolosa, per il paziente e per la sua famiglia. E anche per gli stessi medici che, dall’approccio “due per sapere, due per curare” possono trarre grande nutrimento. Ho avuto con Gianni Grassi una densa corrispondenza e sono stato onorato del suo sostegno alla mia candidatura al Senato della Repubblica, nella primavera del 2006. Un sostegno alla persona, una grande responsabilità. Mi auguro di non aver tradito la fiducia che mi accordò allora. Sono convinto di aver contribuito a dare un’identità chiara sui temi etici a quel Partito Democratico che Gianni Grassi faceva fatica a votare, ma sono consapevole che lunga è la strada ancora da percorrere. Mi sono ritrovato guaritore ferito nei suoi scritti, laddove citando il mio “Credere e curare”, ricordava la mia esperienza di paziente, il cambio di prospettiva cui la vita mi ha costretto anni fa. Certo, come lui affermava, un medico non dovrebbe trovarsi nella malattia per comprendere un malato. Ne resto profondamente convinto e credo che onorare la memoria di una persona come Gianni Grassi voglia dire anche continuare a impegnarsi perché quel “capire insieme” divenga naturale attitudine di chi si accosta al mestiere di medico, difficile e bellissimo. Resto convinto che, come affermava il grande teologo tedesco Paul Tillich, “Il confine è il luogo migliore per acquisire conoscenza”. Gianni Grassi ha vissuto con coscienza chiara, precisa e limpida il suo passaggio e questi scritti, riflessioni e pensieri sono qui non solo come testimonianza, ma come utile strumento di un percorso comune di consapevolezza e rispetto n delle verità scientifiche e della libertà individuale. 5 In auto con “Ninino” in fuga verso la libertà Lettere a un ospedaliere Così Gianni spiegava il suo “testamento” politico e morale racchiuso in cinque lettere scritte tra il 1986 e il 2006 L’ 8 luglio 1986 il mio amico Giovanni Ciccarelli, detto “Ninino”, moriva di cancro nell’ospedale San Camillo di Roma dopo 40 giorni di atroci sofferenze, non sufficientemente alleviate da una deontologia medica punitiva e da una profonda disorganizzazione assistenziale. Peggiorate anzi da forme di lotta sindacale che, nel mio libro Scioperare stanca, definivo “efferate, vigliacche e banditesche”, in quanto forme di violenza contro i malati, tenuti in ostaggio nelle corsie a subire una “terapia” di inquinamento sonoro. Alla memoria di “Ninino” devo l’impegno a studiare per comprendere per quali mai perverse ragioni tante buone persone e tante brave professionalità si rovesciano – una volta messe insieme nell’istituzione sanitaria – in un meccanismo infernale che distrugge ogni dignità loro e dei pazienti a loro affidati. Il giorno stesso della sua morte incominciai a scrivere lettere al miglior medico del reparto ospedaliero in cui il mio amico era stato ricoverato. Quanto tempo occorrerà perché la cultura delle cure palliative (accoglienza, ascolto attivo, comunicazione empatica, presa in cura dei malati inguaribili, sino alla fine, per alleviare i sintomi dolorosi rispettando la loro dignità e i loro desideri di autonomia, senza imporre alcuna forma di accanimento diagnostico o terapeutico) entri finalmente nelle corsie ospedaliere già nella fase delle cure oncologiche, contribuendo a migliorarne l’efficacia terapeutica – ovvero a valorizzare le relazioni tra curanti e curati – e al rispetto delle potenzialità e delle risorse interne dei pazienti? Se non ora, quando? 7 Un dolore ingiusto, indegno, ignobile Scritta l’8 luglio 1986 a Roma e pubblicata nel libro del Gruppo Eventi “Sarà così lasciare la vita” (a cura di Livia Crozzoli Aite, Edizioni Paoline, 2001) C aro dottore, questa notte il mio amico finalmente è morto, solo come un cane. Dico finalmente, perché non ce la facevo più a vederlo soffrire e guaire per il dolore. Un dolore ingiusto, indegno, ignobile. Insopportabile per me, figuriamoci per lui. È morto nel letto che gli era stato assegnato fin dall’inizio del suo calvario, in mezzo agli altri degenti. Perché l’ospedale, per quelli come lui che smentiscono la pretesa onnipotenza della medicina, se non riesce a mandarli a casa o in rianimazione, non ha una stanza appartata dove farli morire dignitosamente, tra i propri cari. E stamattina, quando sono arrivato, ho scoperto che non avete nemmeno un luogo in cui tenerli da morti. Il suo cadavere, in attesa del trasferimento alla camera mortuaria, era celato nel ripostiglio del materiale. Il dolore e la morte, dunque, non vi appartengono? L’altra sera, violando il ferreo patto che prescrive di non scocciare i medici quando non sono di turno in ospedale, ho telefonato a casa sua. Me ne scuso, non mi sarei permesso se lei avesse mantenuto la promessa di prescrivere analgesici efficaci al mio amico, che non meritava affatto di morire con ulteriori inutili sofferenze. Ma nelle disposizioni per l’apparato paramedico, le uniche che contano – come tutte le procedure che nei servizi offuscano i problemi umani e dirottano l’attenzione – nessuno aveva introdotto quella relativa ai mezzi per alleviare i lancinanti dolori del mio amico, pudico e sobrio pur nel dolore più atroce. Anche un medico così onesto, preparato e scrupoloso, come lei, si era dimenticato del trascurabile dettaglio delle sofferenze di un moribondo. Desideravo che lei provvedesse, almeno per telefono, a impartire quella prescrizione di alleviamento della inutile pena, che la macchina ospedaliera non aveva incamerato in memoria e pertanto non accettava da me, ingenuo utente rompiscatole e per di più nemmeno parente, ma soltanto amico del morente. Nella iella, ho avuto la fortuna di incontrare una sua collega 9 che, ricordandosi dei discorsi tra noi e della sua promessa, ha fatto inoculare l’unica fiala in dotazione al reparto. Meglio poca terapia che nessuna. Sono grato alla giovane dottoressa perché, poco dopo, lo stato di spossatezza semi-incosciente è continuato finalmente senza lamenti. Sarebbe bastato così poco, grazie a un minimo rispetto del momento del morire, per aiutarlo a spegnersi serenamente. E invece, alla fine, ha prevalso un meccanismo feroce nella sua disumana indifferenza, addirittura esibita nelle alte sfere. Ieri, infatti, in tarda mattinata, mi ero permesso di importunare per la prima volta il primario. Gli avevo chiesto di poter acquistare a mie spese per il reparto una confezione di quel medicinale analgesico all’amico morente, visto che la notte precedente gli era stata somministrata l’ultima fiala e ora ricominciava a lamentare la ripresa dei dolori. Ebbene, il professore – dopo aver contestato ai paramedici che si sia potuta verificare una così grave lesione della riservatezza sulle dotazioni dei medicinali – mi ha letteralmente dichiarato: “Noi non usiamo morfina. Se il paziente deve soffrire, che soffra purtroppo. Ma noi non diamo certi farmaci”. Questo, oltre a essere falso – perché il medicinale era stato usato, altrimenti sarebbe rimasto a me del tutto sconosciuto – è francamente indecente. È una logica aberrante, anche nell’ambito di una pur rigorosa deontologia professionale. Si teme che il morente diventi tossicodipendente? Ostaggi di stupide sofferenze Mi perdoni, dottore, forse pesano sulle mie parole le notti passate al capezzale del mio amico e l’avvilimento per questa sua morte. A quel camice canuto che se ne andava altero per la corsia ripetendo quelle parole, avrei voluto augurare di non doversi mai trovare nella situazione del mio amico. E glielo auguro. Ma spero anche di non dover mai capitare sotto il suo potere, nonostante ogni possibile garanzia di efficienza e serietà professionale. Io chiederei soltanto di poter morire bene: non quando voglio io, ma almeno come desidero, cioè in pace, senza stupide sofferenze, senza diventare ostaggio delle efferate convinzioni di certi medici. È troppo pretendere questo? Oppure è davvero ancora così diffusa e irresistibile una simile concezione punitiva della medicina? Quando dovremo aspettare perché si realizzi il modello, proposto da Gadamer, dei “guaritori feriti”, cioè dei medici consapevoli della comune matrice umana, corporea e mortale, che li unisce ai malati e ai morenti? Forse... finché non ci san ranno abbastanza pazienti esigenti. 10 Noi siamo un colloquio Scritta il 2 novembre 2002 a Berceto (Parma) e pubblicata nel libro del Gruppo Eventi “Assenza, più acuta presenza” (a cura di Livia Crozzoli Aite, Edizioni Paoline, 2003) R icorda, dottore? “Dottore, dottore, perché mi hai abbandonato?” era il grido di dolore dal capezzale dell’amico morente nel Reparto che ora lei dirige. Dopo la sua morte, tra faticose e atroci sofferenze, altra fatica per riuscire a cremarlo e a portare le sue ceneri nel piccolo cimitero di Lupara, sull’Appennino molisano. E lì interrarle sotto un bel crocefisso. Non ho avuto altra scelta. Come in ospedale non c’è ancora l’Hospice, un posto in cui continuare a essere curati anche se inguaribili e poter morire dignitosamente, così dopo, per i laici, non c’è ancora un posto e un modo in cui poter essere onorati. E così oggi anch’io, non credente, me ne sto nel piccolo cimitero di Berceto, sull’Appennino parmense, partecipe della liturgia religiosa con la comunità che torna dai luoghi in cui è migrata. Il prete ripete le stesse parole, con la stessa cadenza, quasi un rumore di fondo che accompagna la mesta cerimonia e permette a ciascuno di immergersi nei propri pensieri, contemplare i monti, osservare i convenuti, scrivere a un dottore... Ogni anno ricordiamo i nostri cari defunti e insieme ci riconosciamo tra sopravviventi e conosciamo i nuovi venuti, grazie agli immigrati. Anche se, come dice Arundhati Roy, “nessuno di noi ha bisogno di anniversari per ricordare quello che non possiamo dimenticare”. Proprio al mio amico avevo dedicato l’impegno a studiare le istituzioni sanitarie. E stavo facendo ricerche, quando un cancro alla vescica e poi alla prostata mi ha costretto a frequentare un altro ospedale. Un Istituto con una produttività didattica e terapeutica così intensa da rischiare la spersonalizzazione dei malati, se non fosse temperata dalla umana disponibilità del personale. Ho capito che per curare, per prendersi cura, l’efficienza è condizione necessaria ma non sufficiente: ci vuole anche l’anima, la comunicazione. E ho deciso di fare della mia disavventura personale un’opportunità maieutica, politica e sociale: tramutare la sofferenza privata in pubblica ricerca per ottenere miglior comunicazione tra medici e pazienti. 11 Ma come si fa a comunicare, a intendersi senza litigare tra “camici & pigiami”? Occorre che entrambi imparino anzitutto a comunicare con se stessi. I camici chiamati a fare i conti col tabù degli errori e il mancato confronto con gli altrui pareri, insomma la propria arroganza. I pigiami chiamati a dar conto della propria ignoranza che idolatra i dottori e produce paura, isolamento, rassegnazione. Il vostro linguaggio, che dovrebbe essere terapeutico, è criptico, retorico, usa parole di guerra invece che di consolazione. E la guerra, scrive Arundhati Roy, mentre “non può vendicare i morti, è solo una brutale dissacrazione della loro memoria”,“significa svalutare il dolore, svuotarlo di significato”. Geni e relazioni La vostra pratica, che è fatta di poche certezze e molti pareri, nega l’errore sempre e comunque e ignora il consulto, il confronto con altri specialisti, medici di base, tecnici e infermieri. Così il nostro linguaggio resta misero e dipendente, la nostra pratica quella del credente: siamo ancora in pochi a confrontarci coi compagni di viaggio, le associazioni di malati, i comitati in difesa dei loro diritti, in pochi a informarsi, difendersi e riunirsi. Eppure sarebbe terapeutico anche per voi. Come scrive Giovanni Berlinguer, già presidente del Comitato nazionale di bioetica, siamo fatti “di geni e relazioni”. Per dirla con il poeta Hölderlin, “siamo un colloquio” (Borgna, 1999). E sono grato al filosofo Umberto Galimberti di ricordarci pazientemente – magari dall’ultima pagina di un settimanale “femminile” assai diffuso – che serve guardare, sentire, odorare e toccare il corpo, ma insieme interrogare e ascoltare l’anima, con sufficiente lentezza; di ricordare a tutti noi come la morte, “insignificante decorso biologico, talvolta una liberazione”, sia “crudele solo quando separa un amore... Quando si ama è dolore, anzi il dolore, che dunque abita solo le case d’amore”. Caro dottore, in tempi di morte come gioco e spettacolo malato, persino in famiglia, e di immolazione suicida non solo tra i terroristi ma di nuovo tra i disoccupati, i licenziati e i carcerati delusi, sarà mai possibile che l’unico dolore concesso e rispettato in ospedale resti quello che separa un amore? Forse. Se riusciremo a passare dal formale “consenso informato” a una sincera e reciproca “validazione consensuale”, diventando n esigenti soprattutto con noi stessi. 12 La goccia scava la roccia Parte della tesi del Master in bioetica (gennaio 2004). C aro dottore, chi le scrive è un paziente un po’ speciale. A un recente convegno sul consenso informato, a voi riservato, ho chiesto di intervenire perché sarebbe ora che sul consenso informato, e più in generale sul rapporto tra medici e malati, si cominciasse a sentire anche la voce di qualche paziente. Magari parziale e indisponente – all’inizio è sempre così – ma tuttavia indispensabile, trattandosi di un rapporto a due. È sintomatico, infatti, che l’autore di uno dei testi più chiari finora scritti sul consenso informato (Spinsanti, 2002), per di più proteso a delineare il sentiero in salita “dal consenso informato alla decisione consensuale”, lo presenti così: “Questo libretto è dedicato ai medici che hanno poco tempo… L’etica ha molto da dire sul profilo che deve assumere la nuova relazione terapeutica. Ma non saranno gli esperti di etica a realizzarla: gli artefici potranno essere solo i professionisti sanitari. Questo sapere pratico è loro, non devono lasciarsene espropriare né dai magistrati, né dai filosofi, né dai moralisti”. E i malati? Eppure, lo stesso autore ha spiegato (Spinsanti, 1999 e 2003) che a diversi modelli della cura corrispondono diversi ruoli dei curanti e dei pazienti: al modello della malattia come parentesi, chiusa dalla guarigione, corrisponde il malato che “comincia a guarire quando obbedisce al medico”. Ma quel modello funziona solo in una minoranza di situazioni, le acuzie. Nell’ottanta per cento dei casi la “guarigione” è quella sufficiente per continuare a vivere, cioè a convivere con una malattia cronica: cui corrisponde il medico “montessoriano” che aiuta il malato a curarsi da sé. L’ascolto attivo e terapeutico, l’arte di ascoltarsi/osservarsi reciprocamente (Sclavi, 2000), imparando ciascuno dall’altro – medico e malato – e dai propri errori, viene ricondotto al modello della “ricerca della grande salute”. Che richiama un po’ la “grande illusione” e invece vuol dire: realizzare il nostro progetto di vita ovvero “assumere la responsabilità di dare un senso alla nostra finitezza” (Melucci, 1991). Il convegno l’aveva aperto un giornalista scientifico che era riuscito a far convivere la denuncia della “marginalizzazio- 13 ne” dei medici con l’enunciato della “centralità” del paziente. “L’economicismo dilagante si combatte coinvolgendo massicciamente i medici, dando loro più potere, responsabilità e autonomia decisionale”, ha detto. E poi: “L’informazione è reciproca e circolare, il paziente ha un ruolo attivo, è lui che tiene il bandolo della matassa tra i vari soggetti curanti. Dunque ha più potere, responsabilità e autonomia”. Magari fosse. Io mi sento piuttosto come un mozzo che, attraverso i raggi, congiunge otto specialisti che mi ruotano intorno ma non comunicano tra loro: urologo, oncologo, radiologo, radioterapista, psicologo, medico nucleare, medico generale e andrologo. Subito dopo, una psicologa aveva ricordato una cosa importante: se è vero che l’informazione è circolare e il paziente non è un vaso da riempire, è pur vero che quando ci ammaliamo regrediamo, fisiologicamente e psicologicamente. Torniamo neonati, pieni di ansie e aspettative, a volte di terrore, bisognosi di aiuto, protezione, amore (Honegger Fresco, 1987). Possiamo recuperare, certo, ma all’inizio è proprio così. Altro che potere e autonomia.. Voi lo sapete bene. Inoltre, c’è anche la vostra fragilità, la fragilità dei tecnici. Uno studioso di “psicosomatica” ha paragonato la posizione del medico di base all’immagine di chi, camminando su una cresta, gode di un bel panorama su entrambi i versanti: quello esposto alla luce – la medicina razionale misurabile e visualizzabile in modo digitale con la moderna tecnologia – e quello in ombra, l’aspetto irrazionale dell’essere umano, avvicinabile in modo analogico. Un medico svizzero (Schlaepfer, 2003) ha dato seguito a quella immagine sostenendo che: “Il medico e il paziente formano una cordata a due. Il medico è la guida. La meta, la cima, sarebbe il recupero della salute, che non è un dato, un unico obiettivo, ma piuttosto un equilibrio, una strada. La corda che collega i due sarebbe l’intreccio tra la comprensione del medico e la fiducia del paziente. A volte è importante per entrambi la vista del lato luminoso, a volte di quello ombroso. È richiesta la franchezza, quella spregiudicata del medico forse dà la possibilità al paziente di aprirsi anche lui”. “Dove una persona si può spogliare completamente, farsi vedere veramente nuda e onesta, se non dal medico, che non ne ride, al massimo sorride ed è discreto? – prosegue – Che a sua volta può far vedere la propria vera immagine al paziente, in modo che questi realizzi la propria? A volte però, dovendo aggirare un ostacolo insuperabile, non cercano entrambi lo stesso versante; è situazione quotidiana che il medico si comporti in modo troppo digitale e il paziente fugga alla para-medicina. A volte nemmeno mirano alla stessa meta, a volte la corda non resiste allo strappo. Ma – si chiede – dove abbiamo imparato ad ammettere gli errori che, specialmente nel nostro mestiere, sono severamente vietati e che sarebbero tanto uma- 14 ni?”. “Proprio i medici – scrive un filosofo (Valdrè, 1995) – scoprono come nessun altro nel contatto con i malati e con la loro sofferenza l’esistenza di un mondo ben più vasto di quello circoscritto della scienza”. E legge un sintomo di questa convinzione in un episodio del film Ordet di Teodor Dreyer, che descrive così: nel corso della veglia funebre per la giovane protagonista morta di parto, alla presenza dei familiari, del prete e del vecchio medico che aveva tentato invano di salvarla, riappare all’improvviso il cognato scomparso da alcuni giorni. Coinvolto dalla ingenua fiducia della nipotina, non accetta la rassegnazione e cerca la parola che possa mutare un ordine in apparenza irreversibile. Il suo è un atto di fede totale, irrazionale. Ebbene, mentre gli altri – soprattutto il prete – si scagliano indignati contro la sua bestemmia e cercano di impedirgli di parlare, il medico sembra l’unico disposto ad ascoltarlo. Un impulso “antiscientifico” da parte di un medico profondamente convinto del valore della medicina scientifica che, commenta il filosofo, “potrebbe rappresentare proprio un esempio di razionalismo aperto”. Il vissuto dei pazienti In quel convegno la gran parte del tempo era stata dedicata a valenti giuristi perché vi spiegassero le differenze tra dolo e colpa – per imperizia, negligenza o imprudenza – e tra lesione volontaria e atto chirurgico, sempre bene intenzionato anche se sbagliato. E valenti medici legali vi hanno invitato a superare il dispetto verso la “burocratizzazione” (l’invasione di nuovi moduli, compreso quello per la privacy, da inserire in cartelle cliniche quasi sempre incomplete), aprendovi al progetto di un sistema di prevenzione dei rischi e degli errori che comporta la compilazione di nuove schede di registrazione e valutazione. Nell’ultima giornata, dedicata alla riflessione bioetica e alla epistemologia della cura, i filosofi Guido Traversa e Mario Palmaro, premesso che ogni tipo di medicina presuppone un modello di antropologia, vi hanno esortato a non dimenticare il vissuto dei pazienti. Quel vissuto che li fa diversi uno dall’altro e comporta risposte diverse al medesimo protocollo. Del resto, in Italia i medicinali vengono testati ancora solo sugli adulti maschi: per donne, anziani e bambini non esistono prodotti su misura – nemmeno strumenti diagnostici adeguati – per cui si ricorre banalmente alla riduzione delle dosi. Quello dei filosofi è stato un invito a trattarci da persone responsabili e non da “pacchi senza valore che l’ostetrico spedisce al becchino”, come mi pare dicesse Petrolini. Per non ricondurre la “tormentata storia” del rapporto medico paziente (Shorter, 1986) a una relazione tra semidei onnipotenti e fedeli semi-deficienti. Ma neanche ridurla a una transazione tra contraenti formalmente (e falsamente) equivalenti. Per fortuna la 15 realtà umana è dialogica, non solo biologica o merceologica; il dialogo tra medici e pazienti può evolvere nel rispetto e nella fiducia reciproci. Non a caso la vostra è una delle categorie più “moralizzate”: nelle intenzioni, negli esiti, nelle regole stesse che vi siete dati, sia pure unilateralmente. Anche se non basta una moralità “interna”: l’etica è cosa aperta, non riducibile a “etichetta”, ai codici deontologici (Engelhardt, 1999). Tradizionalmente il nostro rapporto è stato rappresentato da questo modello: “scienza e coscienza” del medico, incoscienza e riconoscenza del malato. Ancora pochi mesi fa, lo specialista a cui sottoponevo alcune ipotesi, cioè i miei ragionevoli dubbi, sul preoccupante aumento di un marcatore tumorale, mi ha risposto via mail: “Non pensi da urologo”. Oggi ne discute senza considerarmi un ingrato ignorante, ma ce n’è voluto per non esser più trattato come l’umorista Jerome K. Jerome. Di più. Una brava infermiera, impegnata nel tentativo di allacciare un legame tra la riflessione etica e la pratica sanitaria, afferma: “Il fatto che il malato non appartenga alla categoria delle cose stabili e permanenti in seno alla struttura sanitaria, lo fa apparire come elemento disturbante e paradossalmente distorcente il normale andamento dell’azienda” (Mitello, 2000). E ricorda l’aforisma diffuso nell’apparato, secondo cui “l’ospedale funzionerebbe benissimo... se non ci fossero i malati”. È proprio così? Riprendere tempo e fiato Ho imparato molto dalle vostre domande. Squarci su una realtà quanto mai sfumata e complessa, delicata. Come se il convegno, per parecchi di voi, si rivelasse una delle rare e preziose occasioni in cui riprendere tempo e fiato, per sostare e chiedersi qualche perché. Spero allora di restituirle parzialmente qualcosa di utile e sensato. Ho premesso di essere un paziente un po’ speciale. Ho dunque il dovere di esplicitare la mia equazione personale, fatta di esperienze e valori. Sono un ricercatore di sociologia. Meglio, un amante della sociologia che ha fatto ricerche sui conflitti nei servizi, sulla loro produttività e qualità, sui rapporti con gli utenti: prima nell’assistenza sociale, poi nella giustizia minorile, quindi nella previdenza e infine nella sanità. Nel 1986 ho pubblicato un libro, nella cui introduzione, scritta mentre assistevo impotente alla morte atroce di un amico ricoverato al San Camillo, mi chiedevo (e tuttora mi chiedo): per quali mai perverse ragioni tante buone persone e tante brave professionalità, mediche e “paramediche”, troppo spesso si rovesciano – una volta messe insieme nell’istituzione sanitaria – in un meccanismo che rischia di distruggere la loro dignità e quella dei pazienti loro affidati? Per mettere sotto controllo la variabile efficienza (alcuni sostenevano: “Ovvio, hai sofferto la pesante disorganizzazione romana”) l’anno dopo andai a operar- 16 Insieme a Francesco durante la vendemmia ad Amelia (1995) mi di ernia inguinale in una clinica chirurgica dell’ospedale civile di Parma, culla dell’efficienza. L’operazione è perfettamente riuscita, ma io ho patito proprio le ingiurie dell’efficienza. Avevano trascurato di comunicarmi il piccolo particolare che, dopo l’intervento, avrei dovuto starmene disteso per almeno 12 ore a smaltire i veleni dell’anestesia spinale. Per cui mi sono mosso, cominciando a soffrire un devastante mal di testa che m’impediva di riposare e alimentarmi, ma sembrava incomprensibile: ero un’ernia ottimamente operata, mentre il mal di testa non si vede. L’organizzazione mi infliggeva tutte le offese della sua efficienza: luci, rumori, odori. Insomma, ho cominciato a intuire, sulla mia pelle, che l’efficienza è una condizione necessaria ma non sufficiente. Ci vuole anche l’animus: la comunicazione. E proprio lì fui introdotto ai misteri di quella ospedaliera: un’infermiera m’aveva invitato a seguirla per fare la tricotomia. Avendo studiato il greco, ricordavo che tomia vuol dire tagliare. Ma, nell’ansia pre-operatoria, non ricordavo il significato di trico: “Che cosa mi vuole tagliare?” “Ma i peli! Cos’altro crede?” “E perché non parla come mangia? Perché non dice rasare i peli o depilare?” “Perché qui si dice così”. Amen. Dieci anni più tardi ebbi l’opportunità di fare un altro passo nel mondo ipogeo della comunicazione medico paziente: la radiologa, consegnandomi il referto dell’ecografia pelvica, disse: “Purtroppo è positiva” “Perché purtroppo?” “Perché non va bene” “E allora perché dice positiva invece di negativa?” “Perché in medicina si dice così: positivo se hai il cancro, negativo se non ce l’hai”. Così seppi di avere il k alla vescica, detto “papilloma”. Il figlio primogenito, informatico presso l’Ansa, chiese alla re- 17 dazione scientifica e mi spedì a Padova dagli inventori della VIP, la Vescica Ileale Padovana. In un Istituto con una produttività didattica e terapeutica così intensa da rischiare la spersonalizzazione dei malati, se non fosse temperata dalla umana disponibilità del personale. Lì ho avuto conferma che, per curare, per prendersi cura, l’efficienza è condizione necessaria ma non sufficiente. Intanto, da sociologo studente dell’organizzazione sono precipitato a malato utente di quella sanitaria. Da professionista a pigiama. Dapprima profano, ignorante, esitante. Poi via via paziente più esigente e più informato: innanzitutto dagli altri pigiami, poi dai camici e sempre più spesso da Internet. Quindi, solo da poco sono tornato a essere uno studioso di sociologia dell’organizzazione, in cura per k, che tutto sommato ha avuto una grande occasione di ricerca sul campo. E ha deciso di fare della disavventura personale un’opportunità maieutica, politica e sociale: tramutare la sofferenza privata in pubblica ricerca per una migliore comunicazione medici pazienti. Insomma, sono proteso in avanti. Qualcuno dice che è solo una pretesa, un’illusione. Ma intanto sono passato dalla protesta alla proposta di comunicazione con i curanti, medici e infermieri. Ho insomma l’ambizione di non limitarmi a pregare o predicare i buoni principi ma di “praticare” l’obiettivo, di provarci, mettermi in gioco. Ovvero di applicare alla “vertenza” le linee guida che nel 1986 avevo intravisto nelle forme di lotta sindacale alternative allo sciopero nei servizi, definite “lavoro arbitrario” o sciopero alla rovescia: • più proposta che protesta (più proposizione che opposizione); • più tensione morale che astensione fisica; • più attenzione agli utenti che ai regolamenti. Immettendo quanti più elementi di ricerca nell’attività di “resistenza” (o di resilienza) da svolgere con un “cuore vigile”, quello che permise a Primo Levi e Bruno Bettelheim di sopravvivere persino all’universo concentrazionario del lager nazista (Levi 1986, Bettelheim 1988). Di recente, avendo letto le dichiarazioni del segretario della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (“i medici di famiglia, di fronte allo scarico di responsabilità di Governo e Regioni e alle carenze emerse con l’aumento della mortalità nella popolazione anziana, conseguente al gran caldo, aderiranno allo sciopero”) e quelle del presidente della Federazione degli Ordini dei Medici sui 100 anni del primo codice di deontologia medica, ho scritto una lettera ai giornali. Ho chiesto: “dove erano quest’estate i medici di famiglia che avevano in cura i 7.659 vecchi, morti più per l’aridità della società che per l’arsura della natura? A che è servito il codice deontologico?”. E ancora: “Se, come dite, sono troppi gli anziani senza aiuto, specie quelli non autosufficienti abbandonati dagli ospedali alle famiglie o da soli, perché invece di scioperare contro le ca- 18 renze dell’assistenza, con il bel risultato di aggravarle in realtà contro i malati, i camici non provano a diminuirle? Basterebbe prendersi la responsabilità di scioperare alla rovescia: cioè non di far scioperare i pigiami al loro posto (anche se un’astensione dal consumo di farmaci ci farebbe bene). Bensì nel senso di praticare gli obiettivi invece di limitarsi a predicarli. Se vogliono davvero la continuità assistenziale e migliori cure domiciliari agli anziani, ai malati cronici e ai terminali, perché non provano a sperimentarle come forma di lotta sindacale? Sarebbero più credibili. E noi saremmo loro alleati, invece di essere le loro vittime. A meno che non siano convinti di farci del bene proprio scioperando, visto che negli Usa, durante uno sciopero dei medici, diminuì la mortalità”. La lettera non è uscita ma le domande restano aperte. Ho aperto una breccia La goccia scava la roccia, si dice. Ed io, a forza di insistere, ho aperto una breccia nella rocca patavina. I curanti m’hanno invitato a far loro una lezione sulla comunicazione tra medici e pazienti. Non so se sia la prima volta che succede. Ho chiesto di intitolare il mio breve intervento così: “Due per sapere, due per curare”. Infatti, se il medico è competente sulla malattia, il malato è l’unico competente a dire come la vive e la soffre. La cultura anglosassone, che ha un linguaggio più preciso del nostro e un rispetto più deciso dei dati usa vocaboli diversi per concetti diversi: malattia si dice illness (“hai una malattia”, vissuto medico), sickness (“sono malato”, vissuto personale) e disease (“essere un malato”, vissuto sociale). Se il malato deve saper imparare dal medico le informazioni sulla malattia e la cura, il medico deve saper imparare dal malato le informazioni su come lui vive la malattia e la cura. E per poterlo fare deve riprendere tempo e imparare a comunicare, auscultare il corpo e ascoltare la persona. Solo così si eviterà il ricorso ai falsi medici, ai maghi. Pur consapevoli che “non ci sono due diverse medicine. Ce n’è una sola, che possiede diverse sfaccettature. La gente comune l’ha compreso con molta più chiarezza dei medici. Lo dimostra la crescita costante dei pazienti che chiedono esplicitamente di essere curati con le medicine non convenzionali che permettono un diverso livello di comunicazione; medico e paziente si interrogano insieme sul significato della malattia”. Sto raccogliendo evidenza empirica (moduli di consenso informato, test di verifica della comprensione e questionari di valutazione della qualità delle cure e della vita). Ascolto e imparo, specie da convegni seri. Ne ha svolto uno anche il Master in bioetica parlando onestamente di responsabilità, dignità, autonomia, sovranità di sé. Tutti i medici avrebbero bisogno di parlarne. Non solo quelli presenti ai corsi, certo tra i più moti- 19 vati, ma molti di quelli che ho incontrato nel mio peregrinare per il mondo ospedaliero, lo zoccolo duro, gli strong resistent della corporazione, ne avrebbero tanto bisogno. Per riuscire a rispettare l’autonomia nei malati dovreste essere aiutati a riconoscerla e a recuperarla in voi stessi. Innanzi tutto nei confronti del mercato della salute, dei farmaci e delle tecnologie. Ma mi chiedo: come? Bastano buoni libri, corsi e convegni o ci vogliono anche autentiche esperienze pratiche, comprese le forme di lotta di cui ho parlato? E, ancor prima, se è vero che lo stesso consenso informato è fondato su “un’idea di stereotipo di cittadino che non ancora esiste”, non servono sempre più pazienti esigenti che vi obblighino a collaborare? Altrimenti, se nella prassi medica permane la scissione tra curare e prendersi cura (care), anche il principio del consenso informato può rivelarsi “insufficiente, se non addirittura mistificatorio”, rischiando di coprire “forme di burocratizzazione del rapporto e di deresponsabilizzazione del medico” (Toraldo di Francia, 2003). L’anomalia è stata ben rilevata da un giurista onesto: “La repentina affermazione ai massimi livelli del consenso informato come norma, mentre la pratica sociale e assistenziale vede il rapporto medico-paziente ancora improntato a un paternalismo autoritario, rende la situazione italiana critica e interessante allo stesso tempo. È necessario che queste due idee ispiratrici, l’autonomia del paziente (di principio) e il paternalismo medico (che resiste di fatto) entrino in rapporto tra loro: questo è inevitabile e sta già accadendo” (Santosuosso, 1996 e 2001). Differenza tra la sofferenza Gli stessi giuristi ci hanno ricordato, al convegno, che il consenso informato è un problema medico prima che amministrativo, assicurativo o fiscale. Cioè è il problema bioetico di una buona informazione tra medici e pazienti, per la quale occorrono più rispetto che assetto giuridico, più norme morali che legali. Il consenso informato non è un pezzo di carta, che comunque va scritto bene, ma è un anello importante del processo comunicativo (Tamburini, 1996), “l’inizio di un percorso condiviso” (Crotti, 2003). Come tale deve essere completo e tempestivo, permanente e speculare. Da paziente esigente che di consensi informati ne ha firmati abbastanza (anche se non tutti quelli cui avrebbe avuto diritto), le faccio solo alcuni esempi della giusta estensione e completezza, spaziale e temporale, della informazione ai pazienti. Sto correggendo le bozze di un bel libro in cui la psicologa Lucia Aite ha raccolto le storie narrate dai genitori di neonati con malformazioni genetiche, operati al Bambino Gesù di Roma. C’è una notevole differenza tra la sofferenza dei genitori ai quali l’informazione è stata data prima possibile, durante la gravidanza, e quella di chi l’ha appresa solo al momento del 20 parto. La prima è dura, ma consente di dare un senso alle proprie scelte successive. La seconda è devastante, un incubo. Molto più dura da recuperare e gestire. Non solo: l’informazione va data più presto possibile, la diagnosi corretta è il primo momento, ma nel dovere di informare sta anche quello di indicare subito le possibilità, le località e le istituzioni che garantiscono il migliore intervento, favorendo tempestivamente i contatti. Sia per collaborare tra medici di famiglia, radiologi, analisti e istituzioni sanitarie, sia per sollecitare un ritorno di esperienza tra genitori e medici, che aiuti questi a informare sempre meglio. Nel sito Internet della Società Oftalmologica Italiana c’è un capitolo sul consenso informato come punto di partenza fondamentale per decidere se sottoporsi o no all’intervento di chirurgia rifrattiva. Nel sito si specificano i pro e i contro del trattamento: quando è più indicato, le fasi dell’intervento, le controindicazioni, le possibili complicanze, precauzioni e terapie post correzione. Ogni oculista “è tenuto a dare questo documento quando il paziente chiede di sottoporsi al laser: non per una firma poche ore prima dell’ingresso in camera operatoria”. Con l’aumento del tasso di sopravvivenza, la maggior parte delle patologie sono di tipo cronico e non acuto. Il vero problema diventa quello di informare e aiutare i pazienti non solo a convivere con le malattie, a costruire una strategia terapeutica comune con i curanti, ma anche a informare bene e tempestivamente – a loro volta – i medici, in un processo di retroazione continua. Non possono esistere modelli fotocopia di consenso informato perché non esistono pazienti fotocopia. Con i malati reali il problema è come farsi carico della responsabilità della comunicazione. Che non è scaricabile, nemmeno da Internet. Ne consegue che tendenzialmente, anche sotto l’aspetto della valutazione giuridica, la buona informazione va data prima possibile, deve durare più a lungo possibile e coprire lo spazio più ampio possibile. Ma soprattutto deve alimentarsi il più possibile di reciprocità. Per questo mi piace dire “validazione consensuale” più che “consenso informato”. Voi medici, voi operatori sanitari, siete in prima fila tra i cosiddetti mass media. Siete – dovreste essere – i veri mediatori, il tramite, il traghetto, spesso l’unico, tra le persone malate e l’informazione, che sempre più pazienti vorrebbero corretta e rispettosa della riservatezza e dell’autonomia. Ma, attenti. Non basta essere un canale simbolicamente significativo o formalmente, tecnicamente corretto. Occorre sforzarsi di essere un ponte concreto, un autentico spazio comunicativo. Tutti i giorni, in tutte le sedi, non solo nell’intimità dello studio privato. E con tutti i pazienti: non solo con quelli più esigenti o prepotenti, più ricchi di soldi o di cultura, ma anche con quelli più deboli e poveri, che esigono maggiore disponibilità e creatività co- 21 Rocca di Mezzo (2001) municativa, in primo luogo le persone immigrate. Altrimenti rischiate di essere percepiti come il ricostruito ponte di Mostar, che dovrebbe ricollegare la comunità bosniaco/musulmana con quella cattolico/croata da cui dieci anni fa è partito l’ordine di distruzione. Un bel ponte, tutto nuovo. Ma, senza una validazione autenticamente consensuale delle due comunità, un clone inanimato. Da “neofita” della bioetica, ancora stupito della natura difensiva che questa è venuta consolidando come “bioetica di frontiera” rispetto ai casi estremi sollevati dalla ricerca scientifica, temo il rischio di sottovalutazione del vasto territorio costituito dal rapporto medici pazienti, esperienza veramente centrale e quotidiana. Talmente ordinaria, nella sua drammaticità – a volte nella sua tragicità – che si rischia di trattarla come gli incidenti stradali, con la loro scia di sofferenze, invalidità e morti. Sembrano quasi un costo dovuto al progresso della mobilità, alle sue illusioni di velocità, riservatezza e autonomia. Certo, a volte il prezzo diventa esoso e attira l’attenzione. Ma è il prezzo medio che non fa notizia, mentre i mass media si concentrano su altri eventi (per esempio, la Sars) facendoli percepire come più drammatici. Schermo e maxi-schermo, per dirla con un filosofo (Galimberti, 1983), “ci esonerano dall’esperienza diretta... Qualsiasi informazione... segnala il punto di vista da assumere per prendere in considerazione l’evento che ci viene proposto. E allora ciò che informa ‘codifica’, e l’effetto di codice diventa criterio interpretativo della realtà”. Eppure, come si ricava dai rapporti anglosassoni e dalle stime nostrane – perché da noi l’errore è ancora un tabù, una colpa, invece che un’occasione di miglioramento, e ancora non si mi- 22 surano gli errori sfiorati o accaduti – ne uccidono più le corsie ospedaliere che quelle autostradali. Un indicatore meno di frontiera, anzi vero simbolo della parte centrale della curva gaussiana e non solo delle sue estremità, è secondo me proprio il consenso informato, il quale peraltro è solo un passo della danza comunicativa (Fucci, 1996). La comunicazione, cioè la vita – come attività relazionali degli esseri umani tra loro e con esseri non umani, animali o vegetali – comprende varie sfere di discorso, di ricerca di senso, di azione e interazione. Le sfere di discorso utilizzano giustificazioni (cioè ragioni) e motivazioni (cioè interessi, emozioni, desideri e virtù). Entrambe possono essere usate per descrivere o per prescrivere. La scienza è la tipica attività descrittiva, la ricerca della verità possibile in un tempo dato. L’etica invece prescrive a tutti gli agenti morali consenzienti, coloro che hanno possibilità di scelta, compresi gli scienziati: sia come dimensione personale (sii onesto) sia come dimensione sociale (sia onesta la ricerca, la cura). L’etica ha regole (ragioni) e sanzioni (disapprovazione), le quali a volte vengono raccolte in testi che non hanno valore legale ma costituiscono una guida morale pratica (il vostro codice deontologico). Anche il diritto prescrive a tutti gli agenti, consenzienti o no, e ha regole (norme cogenti) e sanzioni (pene materiali) raccolte in testi di legge e codici. Possono esistere norme giuridiche moralmente sanzionabili ma non sono ammissibili regole morali (o religiose) legalmente imponibili a tutti, anche agli “estranei” morali. Etica non è dare una regola uguale per tutti, bensì dare ragioni plausibili per tutti. È vero che siamo liberi se siamo guidati dalla ragione, non passivamente soggetti al pathos. La bioetica però ha a che fare con la persona non solo pensante, ma anche senziente: il paziente, per principio, va considerato come un fine ma va anche aiutato a non soffrire. Ragione, libertà e autonomia, ideali che non possono essere presupposti, nemmeno nel consenso informato, vanno verificati e costruiti insieme. Diversamente si comportano religione e politica: entrambe descrivono e prescrivono. Ma la prima prescrive amore reciproco alla comunità di credenti, rifacendosi a regole (dogmi) e sanzioni (pene spirituali). La seconda prescrive rispetto reciproco a tutti i “cittadini” utilizzando il diritto. La religione si fonda sulla fede e “trascrive” scienza ed etica in una visione trascendente. La politica le “inscrive” in una azione immanente, ha a che fare col consenso e con la maggioranza. La buona politica, veramente utilitarista, cioè attenta più alle conseguenze delle proprie azioni che alle motivazioni, si fonda sulla fiducia reciproca, unisce metaetica ed etica pratica, memorie, valori e speranze. Sono grato agli organizzatori per aver realizzato, con quel convegno, una buona azione politica. Per aver segnalato alla vostra scienza e alla vostra coscienza che il 23 consenso informato, pur rappresentando in dottrina “il fulcro della valutazione della relazione paziente-medico”, resta ancora nella pratica un mero adempimento formale, spesso funzionale più a ottenere il consenso che a fornire l’informazione sufficiente. Paradossalmente, invece d’essere vissuto come l’assunzione della ulteriore responsabilità di farsi carico dell’informazione, rispetto a quella del prendersi cura, viene accettato da molti di voi come una tutela o subìto come un fastidioso “capestro”, un controllo. Si riduce spesso a un nuovo modo per scaricare le responsabilità comunicative. Eppure, i controlli non sono la nostra/vostra garanzia? La trasparenza morale e scientifica, ideale e professionale, non è la nostra/vostra forza? Sappiamo che l’assenso formale del paziente “non esaurisce la responsabilità morale del medico” e che il consenso informato costituisce “una garanzia necessaria ma non sufficiente”, proprio come l’efficienza. Ci vuole altro: la comunicazione, appunto. La quale, dal concepimento alla morte, è parte essenziale e integrante della “alleanza” o, come preferisce dire chi ritiene questa definizione pre-moderna, del “patto” terapeutico. Il “patto” terapeutico A me, studioso che si trova a essere anche paziente, pare che nella realtà ospedaliera ancora prevalga il pre-moderno rispetto al moderno e al post-moderno. La vecchia mentalità resiste ai timidi tentativi di cambiamento. Forse le tre epoche, le tre impostazioni, sono destinate a convivere per molto tempo negli stessi reparti e nelle stesse corsie. Almeno finché le persone malate non avranno accumulato la consapevolezza, il coraggio e l’autorevolezza sufficienti a imporre i cambiamenti, invece di ricorrere ai risarcimenti civili o penali. Al posto di quelli giudiziari è sperabile si aprano ben diversi processi: innanzitutto un confronto orizzontale tra i malati stessi, cioè la costruzione di un patrimonio culturale condiviso, fatto di esperienze di cura e di comunicazione; quindi un confronto verticale con la medicina, cioè di riappropriazione della scienza medica; infine, una elaborazione e sperimentazione di proprie analisi critiche e proposte autonome, nel merito e nei metodi di cura e di comunicazione. Processi che richiamano le esperienze di studio e di lotta contro la nocività del lavoro e per la salute in fabbrica, sviluppate tra gli anni ’60 e ’70, da cui sono venute conquiste, come lo “Statuto dei diritti dei lavoratori” e il Servizio sanitario nazionale, che ancora resistono all’assedio del mercato. Processi di cui le dirò più avanti. Il problema della salute in fabbrica si pose prima di tutto come problema di comunicazione. Lo stesso che si ripropone oggi per la salute in ospedale. “L’idea della morale medica fondata sul riconoscimento della autonomia delle persone e sul rispetto è che ogni paziente debba poter contribuire a decidere 24 la comunicazione delle notizie che lo riguardano e il trattamento da ricevere” (Azzone, 2003). La realtà invece è diversa, sconfortante. Al Master di bioetica l’infermiera e sociologa Lucia Mitello ci ha fornito i risultati di un’indagine, svolta dal “Coordinamento per i diritti del cittadino” tra centinaia di ricoverati in quattro città (Genova, Varese, Padova e Roma). Ebbene, nel 1994 solo il 38% degli intervistati aveva ricevuto la richiesta di consenso, nel 1997 la percentuale era salita solo al 54,7. Di quel 38%, il 79 per cento non aveva avuto informazioni sui rischi connessi al trattamento consigliato e l’84% sulle eventuali alternative terapeutiche (Di Viggiano, 1999). Un problema non risolto Al vostro convegno partecipava un’altra infermiera, Giuliana Fracassi, che ha avuto la cortesia di farmi consultare la tesi che stava definendo per la Scuola speciale dirigenti assistenza infermieristica dell’Università Cattolica. L’elaborato, che riporta un’indagine su conoscenza e valore del consenso informato in ambito ospedaliero, realizzata dalla stessa infermiera tramite questionario da lei ideato e somministrato a pazienti ospedalizzati, familiari e operatori sanitari (medici, infermieri, tecnici), conferma i limiti della informazione e della sua comprensione. A settembre, a un altro convegno “per un’etica della ricerca scientifica”, il dottor Giovanni Apolone ha presentato i risultati di indagini che vanno nello stesso senso. Anch’io farò ricerche per ottenere dati più recenti, ma temo che l’informazione ai pazienti – se e quando informarli – e i modi in cui trasmetterla, sia tuttora un problema non risolto e rappresenti uno degli aspetti più controversi che ancora dovete affrontare. È proprio il caso di occuparsene tutti di più e meglio. Le giuste e reiterate preoccupazioni circa la persistente carenza di norme potrebbero, a mio parere, essere declinate così: raccogliamo sufficienti e autentiche esperienze di etica pratica per arrivare a definire il prima possibile le migliori regole giuridiche che aiutino e sorreggano tali esperienze. Le quali non possono essere lasciate troppo a lungo alla discrezionalità delle corti. Io però continuo a chiedermi: come si comunica? Come si passa dagli enunciati ai risultati, dalle belle parole una tantum agli umili fatti quotidiani? Rammento un detto orientale che recita: “Se ascolto dimentico. Se vedo ricordo. Se faccio capisco”. E so che la domanda posta dallo psichiatra Franco Basaglia (“Può esservi una possibilità di cura dove questa cura non ha una situazione di libera comunicazione tra medico e malato?”) non ha avuto risposta perché non si è provveduto a predisporre strutture adeguate e personale dotato di preparazione specifica (Turnaturi, 1991). Dunque, come si fa a comunicare, a intendersi senza litigare tra “camici & pigiami”? Occorre che gli uni e gli altri imparino anzitutto a comunicare con se 25 stessi. I camici, chiamati a fare i conti con il tabù degli errori e il mancato confronto con gli altrui pareri. Insomma, con la propria arroganza comunicativa. I pigiami, chiamati a dar conto della propria ignoranza, che idolatra i dottori e produce paura, isolamento, rassegnazione comunicativa. Il vostro linguaggio, che dovrebbe essere terapeutico, è criptico, retorico, usa parole di guerra invece che di consolazione. La vostra pratica, che è fatta di poche certezze e molti pareri, nega l’errore e ignora il consulto, il confronto con altri specialisti, medici di base, tecnici e infermieri. Così il nostro linguaggio, quello dei malati, resta misero e dipendente, la nostra pratica quella del credente. Siamo ancora in pochi a confrontarci con i compagni di viaggio, le associazioni di malati, i comitati in difesa dei loro diritti. Siamo ancora in pochi a informarci, difenderci, riunirci, confrontarci, a raccontare il proprio viaggio e a trasmettere strumenti di comprensione e di azione ai compagni di percorso. Eppure sarebbe terapeutico anche per voi. Il dato divergente Nella mia esperienza di ricercatore ho compreso il rischio di darmi ipotesi e modelli, a volte impliciti, mutando i ragionevoli dubbi in irragionevoli idealtipi. Cioè di innamorarmi della diagnosi del fenomeno da me elaborata e di non cogliere più i segnali divergenti. È quello che spesso capita anche a voi. Mentre è proprio al dato divergente che bisognerebbe dedicare il massimo di sensibilità, una attenzione weiliana (da Simone Weil), insieme alla corretta metodologia popperiana (da Karl Popper). Che è quella di cercare di falsificare le proprie ipotesi per vedere se reggono, invece di accanirsi per verificarle, con il rischio di non vedere ciò che le contraddice. Sempre più e meglio si discute di quanto e come informare i malati per coinvolgerli nelle decisioni che li riguardano. Cresce la domanda di comunicazione onesta e sincera, come dimostrano diversi indicatori. Da una ricerca del Picker Institute fra 8.000 cittadini di 8 Paesi europei – pubblicata sulla rivista “Care” – è emerso il desiderio di avere maggiore e migliore informazione, in primo luogo dai medici, per assumere maggiori e più consapevoli responsabilità nelle decisioni terapeutiche. Contemporaneamente, un vasto gruppo di esperti ha elaborato la prima “Carta” europea dei diritti dei pazienti, allo scopo soprattutto di arginare l’invadenza e la prepotenza della “industria della salute”. Si discute sempre di più e meglio del “dolore inutile” (Zavoli, 2002), delle cure palliative, della spiritualità nei pazienti oncologici. Spesso la sofferenza va oltre il dolore fisico, che si può e si deve alleviare. Purtroppo l’Italia resta agli ultimi posti nell’uso terapeutico di farmaci analgesici a base di morfina, con o senza consenso informato. L’indifferenza è la 26 In visita a Gerusalemme (1995) causa delle principali e più acute sofferenze di tanti malati, ma anche di tanti curanti. Emergono le problematiche relative alla sofferenza spirituale ed esistenziale. La dottoressa Carla Ripamonti dell’Istituto nazionale tumori, insieme a molti clinici e ricercatori, sostiene che è “necessario raccogliere e incorporare la ‘storia spirituale’ dei pazienti all’interno della storia medica standard”. Ma come, se non facendo corresponsabile anche il paziente della cartella clinica che lo riguarda? E che tuttora viene gestita quasi come proprietà esclusiva da voi medici e dalle caposala? Da varie ricerche in Nord America e in Giappone emerge che il benessere spirituale risulta essere uno degli aspetti più disattesi. “Quando si parla di persona – continua la Ripamonti – quando cioè si parla di noi, si considera il corpo, la mente, la psiche, l’anima e le relazioni. Nella nostra pratica clinica utilizziamo quasi sempre strumenti di valutazione della qualità della vita dei nostri pazienti che considerano i sintomi fisici, emozionali e il rapporto con le altre persone. Un recente studio mostra che anche la dimensione spirituale deve essere valutata se vogliamo avere un approccio ‘olistico’ nei confronti del benessere dei nostri pazienti. Anche del nostro”. E se vogliamo comunicare, aggiungo io. Queste giuste considerazioni, insieme ad altre relative all’aiuto ai minori colpiti da k e agli adulti inguaribili o morenti, con i quali bisogna pur continuare a comunicare, le ho tratte da un altro importante convegno che ha messo a confronto “guaritori del corpo e guaritori dell’anima” e ha loro chiesto: cosa fate per informare e aiutare i malati “terminali” e i loro familiari a dare un senso alla malattia e alla vita, senza sottostare ad “acca- 27 nimento terapeutico” o ricorrere a “eutanasia”? Nel frastuono dei diritti si è ricordato che morire è anche un dovere, biologico e sociale, cui corrisponde il dovere di aiutarci reciprocamente a vivere meglio possibile sino alla fine e a morire con dignità. Sarebbe utile un consenso informato personalizzato e magari – come ha proposto l’oncologa pediatrica Franca Fossati – che tutti gli oncologi passassero un periodo in pediatria, tra i bambini malati di k e i loro familiari: forse imparerebbero che cosa vuol dire comunicare? Sono intervenuto anche lì per chiedere: possibile che si debba morire da piccoli, troppo presto, o arrivare troppo tardi, vicini alla morte, per sperare umanamente di essere trattati in ospedale da persone vive, intere, sensate, e non da pezzi, cose senza valore? Purtroppo anche il destino di molti animali è di passare dalla fattoria alla factory, diventando pezzi di carne. La differenza tra umani e manufatti è che noi abbiamo un punto di vista, il diritto a formarci il nostro punto di vista soggettivo. Il problema è farlo diventare il nostro punto di vita. Possibile, ancora mi chiedo qui, ora, che non ci siano negli ospedali operatori altrettanto degni di quelli che partecipavano a quel convegno? E se ci sono, se ci siete, perché non siete contagiosi? Reciproca fiducia Da qualche anno, come paziente che continua a fare ricerca sulla propria malattia, apparentemente infausta, ho capito il rischio di essere ridotto al dato biologico, alla malattia, se non agli organi colpiti, a volte nemmeno considerati insieme: una volta sono una vescica, un tumore alla vescica, un’altra sono una ex prostata, un tumore alla prostata. Quasi mai mi sento trattato come una persona che soffre di un male curabile anche se inguaribile. Ho capito che quello che mi serve non è un rapporto materno, caritatevole, amicale, e tantomeno un rapporto formale, meramente contrattuale. Quello che mi serve, che ci serve – come pazienti e come medici – è un nuovo patto scientifico e morale, cioè politico. Una autentica collaborazione che parta senza demagogia dalla presa d’atto delle asimmetrie di potere e dei rischi di reciproca sudditanza, attuale o potenziale, per dar vita a un nuovo “giuramento” che superi i limiti unilaterali di quello ippocratico. Un patto che si basi sulla reciproca fiducia (O’Neill, 2003) senza ricadere nelle tentazioni prometeiche del delirio di onnipotenza che aleggia sulla nostra attività di ogni giorno. Il problema del riconoscimento reciproco e della fiducia è importante, decisivo, fondante non solo per il rapporto medico paziente ma più in generale. Aver fiducia è una condizione essenziale della convivenza (Roniger, 1992) e della democrazia (Sztompka, 1996). La mancanza di riconoscimento è un attentato alla fiducia (Honneth, 1993). Nel contesto ospedaliero si 28 pone innanzitutto come richiamo alla collaborazione tra voi medici, al consulto reciproco, al lavoro di squadra (come avviene nella famosa Mayo Clinic di Rochester, Usa). Ma immediatamente dopo ripropone la delicata e centrale questione degli/delle infermieri/e, del loro rapporto con voi medici da una parte e con noi malati dall’altra, del loro essere cerniera e filtro nella relazione medici pazienti. Oltreché della collaborazione tra loro, della loro organizzazione del lavoro. Anche la professione infermieristica, il “gigante dormiente” (Kuhse, 2000), è tra le più moralizzate, dotata di collaudatissimi codici deontologici, ma resta tra le meno studiate. Eppure non credo si possa parlare di recupero del riconoscimento, della fiducia, insomma della comunicazione tra medici e pazienti senza passare per questo nodo (Delfino, 2001). Helga Kuhse, nota bioeticista, ha messo in discussione la relazione tradizionale tra medici e infermiere, mostrando che “l’esclusione delle infermiere dalla decisione non costituisce un buon servizio per i pazienti” e sollevando la questione morale delle responsabilità connesse ai ruoli tradizionali (con particolare riferimento al tema della sospensione delle cure). Senza contrapporre al vostro paternalismo di medici una sorta di maternalismo delle infermiere, la Kuhse sottolinea l’importanza che il prendersi cura, ovvero il “senso di disponibilità e apertura a conoscere la realtà connessa alla salute dell’altro” inteso come individuo (e non come un oggetto o come “l’appendicectomia in corsia tre”), non esaurisca l’etica della cura infermieristica. “Né i principi né la cura bastano da soli a dare indicazioni su come agire nelle singole situazioni; è necessaria invece una loro integrazione... Cura e giustizia sono nozioni complementari” (Sala, 2003). Se la cura è un aspetto fondamentale delle relazioni umane, l’etica deve rimanere una “impresa sociale”: è a questo livello che vanno rivisitati i rapporti con i medici (Sala, 2003). A che punto è la notte? In sintesi, caro dottore, il rispetto dell’autonomia delle infermiere, così come del rifiuto delle cure da parte di qualche paziente, (il rifiuto informato, strettamente collegato al consenso informato), mi sembra il primo passo per riuscire a rispettare altre decisioni come l’aborto e l’eutanasia. Per tornare a chiedersi, con la Bibbia e con Shakespeare: a che punto è la notte? Ovvero cercare, confrontare, costruire insieme un giudizio di valore sulla qualità del rifiuto e della vita. Che per voi vuol dire, dato che si presume abbiate più “scienza e coscienza” di noi malati, prendervi la responsabilità personale di aprire e tenere aperto un colloquio. Senza rifugiarvi nell’alibi dell’obiezione di coscienza, che nel codice deontologico è ribadita a 360 gradi, un privilegio che spalanca le porte sul baratro della irresponsa- 29 bilità morale (Santosuosso, 1996). Nell’ordinamento giuridico, l’obiezione è consentita solo in due casi: il servizio militare obbligatorio e l’interruzione di gravidanza. A me non è mai piaciuta, soprattutto quando ha significato solo astensione dal prendersi delle chiare, personali, faticose responsabilità. Da bright, splendente di luce propria senza illuminazione soprannaturale né boria illuministica, la lascio ai credenti e la rispetto in loro. Anche la “regola aurea” della reciprocità preferisco coniugarla e, se possibile, praticarla in modo attivo invece che passivo: fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Non credo che il fine giustifichi i mezzi. Se il fine è buono i mezzi devono essere adeguati al fine e non possono contraddirlo. Non ti posso ammazzare per il tuo bene. Dio ci scampi dallo “Stato etico” che pretende di sapere quel che è bene per noi senza chiedercelo. Un po’ come per secoli avete fatto da medici paterni e paternalisti con i malati. C’è forse, nella pressione che emerge dalle corti di giustizia, nel magma vulcanico che rischia di bruciare ogni speranza di comunicazione tra medici e pazienti, un bisogno atavico di resa dei conti? Si, è probabile, non vale nasconderselo. Uscire dalla rassegnazione Da paziente esigente, innanzitutto con me stesso, spero e opero perché i malati, meglio se organizzati, si ricordino che il primo dovere del paziente – se si vuole davvero rinnovare un patto epocale come quello che ci sta davanti – è quello di prendersi la propria parte di responsabilità della malattia e della cura. Il primo dovere è quello di informarsi, di uscire dalla rassegnazione comunicativa che consente e alimenta la vostra arroganza comunicativa. Io mi sono iscritto al Master in bioetica della “Sapienza”. Un grande investimento: non solo ho capito che senza etica non c’è scienza e viceversa. Ma sto altresì verificando che lo studio rigoroso e la lotta trasparente, cioè una sana conflittualità non violenta per riuscire a conquistare e ricucire brandelli di comunicazione autentica – ossia di comune ricerca, vera e buona – con i miei curanti, è attività terapeutica. E grazie a ciò sono ora in grado di “perdonare” non solo le loro esitazioni, le loro supponenze, i loro errori, ma anche le loro indifferenze, queste sì veramente letali. E di ricordare loro – meglio, dimostrare e non solo dichiarare – che l’efficienza, come l’informazione, è condizione necessaria ma non sufficiente. La nostra consapevolezza richiede informazione, sicuramente, ma questa ha una ampiezza e un significato più limitati rispetto alla comunicazione. “Per altro verso è soltanto un mezzo o uno strumento per raggiungere la consapevolezza della propria situazione, che non è detto che si raggiunga anche se si è informati pienamente e in modo formale” (Santo- 30 Insieme al suo grande amico il maestro Cesare Malservisi suosso, 1996). Non solo. Grazie alla comunicazione con altri pazienti esigenti, ho potuto acquisire un ulteriore elemento di consapevolezza, che vorrei spiegarle brevemente – caro dottore – perché generalmente voi mostrate di esserne totalmente privi: quella non tanto del mio diritto a essere preso in cura, a essere informato e ascoltato, o della mia competenza primaria a esprimermi sul modo in cui vivo la malattia, quanto del mio diritto-dovere di contribuire ad accrescere – proprio come paziente – la scientificità della relazione terapeutica. Insomma: non “più umanità e meno scienza”, bensì più umanità e più scienza. Vorrei spiegarglielo con le parole di alcune scienziate femministe. Come scrive la fisica Enrichetta Susi, la relazione terapeutica (“il momento e il luogo in cui avviene la mediazione tra le conoscenze disciplinari, basate sui grandi numeri, e la persona particolare, con il suo corpo e la sua storia unica e irripetibile”) avviene in un rapporto diretto e dispari tra persone: “Molti critici dipingono questo rapporto come una contrapposizione tra il senso della malattia, che è proprio del malato, e la conoscenza scientifica, di cui è portatore il medico”; in realtà anche per il medico “esiste un senso della malattia, che di solito non è lo stesso del malato (e non è detto che debbano necessariamente coincidere); così come, almeno nella nostra società, il malato ha normalmente un livello più o meno ampio di informazioni scientifiche”. Lo scopo suo e delle altre ricercatrici del gruppo Ipazia è di andare oltre la consapevolezza, forse ormai acquisita, “che l’efficacia di una cura sia legata al buon funzionamento del rapporto con i pazienti”, per mostrare che “questo rapporto, quan- 31 do funziona, non produce solo una cura, ma anche un sapere la cui utilizzazione e circolazione non è codificata, ma segue spesso vie inattese”. Mostrare cioè che la relazione terapeutica è “uno snodo essenziale in cui si incontrano la ricerca scientifica e la clinica, e si gioca la possibilità per la medicina di essere veramente una scienza perché entrano in campo due competenze, quella di chi cura e quella di chi chiede di essere curato”, senza peraltro ignorare la disparità di ruoli e di competenze: “Il compito principale è della medica, che deve trovare la mediazione adeguata al contesto specifico [fatta di] disponibilità ad ascoltare... più un lavoro di interpretazione” (alla “ineliminabile discrezionalità della medica” corrisponde un “livello di contrattazione più o meno esplicito, in cui la paziente gioca il suo sapere di sé”); tuttavia “quando la relazione terapeutica è efficace, si produce un sapere nuovo avvertito come tale dalle due parti... prodotto dell’incontro tra la competenza disciplinare e il sapere di sé” (Susi, 1997). Risvegliare la coscienza In questo quadro risalta non solo “la complessità delle figure che hanno il compito della cura, e l’importanza di figure come quella delle infermiere, considerate di solito secondarie e che invece.. sono la figura più diretta di mediazione con l’istituzione ospedaliera”, ma anche il ruolo di “un fenomeno nuovo e molto ampio come quello delle associazioni di pazienti che... contribuiscono a cambiare la percezione sociale degli sviluppi della medicina e costituiscono già un canale di circolazione delle informazioni e di valutazione della efficacia delle cure” (Susi, 1997). Dalle testimonianze emergono persuasivi esempi dell’incontro e del prendersi cura come ricerca e capacità di “risvegliare la coscienza perché l’interessato possa sviluppare i propri sistemi di guarigione o di miglioramento”: più capacità palpatoria, di capire e mettersi in sintonia, di prendersi responsabilità, di trovare aggregazioni. “Il curare viene molto dopo” (Cometti-Alloli, 1997). C’è il confronto tra l’Università, dove impari “che è importante la definizione nosologica di ogni malattia, indipendentemente dalla persona, dal suo vissuto e dal suo modo unico, peculiare e irripetibile di ammalare”, o apprendi la logica del protocollo da seguire “rigido e schematico nell’anamnesi come nella terapia (la prognosi è approssimativa, soprattutto nelle malattie croniche)”, e la multiforme realtà dei pazienti, la difficoltà ad ascoltarli, a mettersi in relazione con tutti: con la loro competenza anche silenziosa. “Oggi non ho più dubbi sul fatto che una relazione terapeutica, perché possa chiamarsi relazione, necessita di due parti con la loro specifica competenza e che l’una non può funzionare senza l’altra. La mia competenza è quella di ascoltare il più possibile senza pregiudizi... la competenza del/del- 32 la paziente sta nel definire in maniera il più possibile precisa il suo dolore. Non è semplice, perché noi non siamo cresciuti con l’idea che ciò che noi sentiamo è verità. In generale ciò che sente il/la paziente deve rientrare in schemi preconfezionati... Alcuni medici hanno rinunciato alla loro responsabilità di sentire con le loro orecchie e mani e di vedere con i loro occhi, sono diventati esecutori anonimi delle industrie farmaceutiche e dei macchinari diagnostici... Si sono, in una parola, spogliati della loro competenza: come possono sospettare che i loro pazienti ne abbiano una?” (Pomposelli, 1997). Caro dottore, non la riguarda? Detto altrimenti: “Il controllo e il dominio sono elementi primari cui si affida il medico. È quindi più difficoltoso per lui uscire da questa modalità, a meno che non abbia fatto un lavoro di riflessione che lo abbia portato a rimettere in primo piano la relazione con il paziente, piuttosto che con la sua malattia... La relazione è sempre fonte di nuova conoscenza, non solo sulla realtà dell’altro, ma anche per sé” (Boaria, Antonelli e Pasquali, 1997). Anche le infermiere mostrano la stessa matura consapevolezza. Per una di loro, l’aver messo al centro dell’esistenza personale e professionale la pratica di relazione, realizzando una continuità tra stile di vita e stile di lavoro, ha consentito di prendere iniziative, cambiare area di lavoro, studiare, acquisire una autorità personale e professionale e di modificare “il ruolo storicamente subalterno e ancillare” dell’infermiera: “Si va alla formazione di équipe medico-infermieristiche omogenee, condizione ottimale per tentare nuove esperienze. Gli stessi pazienti, accolti con interesse e attenzione autentici, vengono attivamente coinvolti nella gestione del reparto. È quasi sempre possibile trovare la soluzione ottimale, se solo ci si da – ci è dato – il tempo per pensarla e attuarla... per misurarci con i medici, che hanno una certa tendenza ad applicare quel che si sa teoricamente, come pure le varie diagnosi, mettendolo addosso alla persona come un vestito già fatto”; anche se è duro “dover continuamente contrattare spazi di autonomia e riconoscimento”, specie in questi tempi in cui è premiata più la quantità della qualità (Riboli, 1997). Contrattare spazi Per un’altra l’approdo è dall’ospedale, in cui il lavoro è “fare” senza tanto pensare, a un consultorio in cui dar vita allo “spazio pesata” (appuntamento settimanale con le giovani puerpere “in cui passano rassicurazione, conferma, comunicazioni”) e allo “spazio adolescenti” per aiutarle a scegliere, e inventarsi la modulistica per l’informazione sulle vaccinazioni, sino a fare educazione sanitaria nelle scuole (Pontillo, 1997). E le pazienti? Una affetta dalla sindrome da attacchi di panico, l’altra da depressione e poi anche da un k, narrano i rispettivi viaggi 33 alla ricerca di senso e di comunicazione maieutica. Afferma la prima, ricercatrice: “Ho toccato con mano quanto la mancanza di una disposizione alla ricerca renda nei fatti scarsamente scientifica la medicina”: la pratica di includere la persona malata, anzi una sua parte, all’interno di uno schema già prefissato di catalogazione “prescinde dalla relazione come luogo e momento in cui si sperimenta un metodo, un’ipotesi, cioè si fa ricerca”. E aggiunge: “Ho pensato a lungo se, come paziente, avessi anch’io qualche tipo di competenza; questa vicenda mi induce a credere che esiste. Molti medici hanno scoperto la relazione col paziente, nella quale ci si impone di essere gentili, mostrare disponibilità e comprensione, ascolto, ma il più delle volte ciò si traduce in un modo formale e distaccato di restare ognuno al proprio posto. Una vera e propria capacità di lettura relazionale, importante tanto quanto quella chimico-fisica, e una propensione per la ricerca, è un patrimonio scientifico di pochi. La disumanizzazione in campo medico non è frutto di un eccesso di scientificità, bensì di un difetto. Sperimentare, decidendone i criteri, mettendo alla prova le proprie conoscenze, affinché queste riescano a contenere anche quel caso unico, che non è solo sintomi, ma un insieme di vissuto, memoria, esperienza, che proviene da un passato e che avrà un futuro, significa trovare le parole per dire ciò che spesso già avviene nella pratica clinica. Trovato il modo di dirlo, è possibile poi diffondere i risultati perché diventino sapere condiviso e misura fra quanti operano nelle stesse condizioni, evitando che tutto rimanga circoscritto in un inutile soggettivismo: non è questo che fa ogni ricercatore con la propria comunità scientifica?” (Molena, 1997). Sapere condiviso La seconda paziente, un’insegnante, dopo aver riconosciuto che esiste anche una “arroganza del paziente” (chi sa già in anticipo quel che vuole sentirsi dire, vuole una riconferma, invece di incominciare un viaggio a due), parla della cura, appunto, come un viaggio, “un cammino dove si va avanti, ma con soste, inciampi, cadute e attimi di nero sconforto” (Lazzerini, 1997). Un percorso tanto più terapeutico quanto più in compagnia. Ecco il contesto più nuovo e propositivo: nelle associazioni di pazienti non si trova solo uno sbocco alla solitudine e all’isolamento che spesso accompagnano tante malattie, più o meno devastanti, più o meno rare; non si trova solo ascolto e comprensione, senza essere giudicati. “La relazione trova in questo ambito un ruolo primario: nello scoprirsi davanti ad altri, che hanno lo stesso problema di fondo, si impara a prendere coscienza del proprio bisogno di aiuto, dei propri limiti, ma anche delle proprie risorse... si impara col tempo a convivere con un problema che, con molto impegno, può anche diventare 34 una risorsa nuova e diversa”. L’esperienza della malattia e le conoscenze acquisite vengono diffuse per diventare “sapere condiviso”: si parte da piccoli gruppi omogenei, gruppi di selfhelp in cui domina il racconto, individuando tratti comuni e differenze “che formeranno la base per elevare il livello di consapevolezza, a partire dal quale pensare interventi, terapie, strade diverse. Pratiche che conosciamo abbastanza bene e che abbiamo sperimentato per anni nei gruppi di autocoscienza femministi negli anni Settanta” (Molena-Pasquali, 1997). Da quei collettivi sono nati i primi consultori autogestiti (a Milano, Padova, Torino e poi a Roma, intorno alla bella figura di Simonetta Tosi) e varie organizzazioni che hanno contribuito a far approvare nel 1978 la legge 194 contro gli aborti clandestini, prima, e a rivendicarne e controllarne l’applicazione, poi, di fronte al sabotaggio della corporazione medica che praticò in massa l’obiezione di coscienza (Damiani, Graziosi, Moretti, Pivetta, Re, Stella e Zito, 1981). Anche questa è stata una importante esperienza di “validazione consensuale”. Luogo di mediazione Le associazioni sono diventate “luogo di mediazione tra pazienti e medicina”, svolgono un ruolo attivo, critico, propositivo: “Sono depositarie di conoscenze direttamente collegate con le esperienze concrete”, danno nuovo impulso alla ricerca (anche sulla base dei dati epidemiologici dei propri soci). Insomma: “Noi crediamo che medici e ricercatori abbiano una fortuna insperata ad avere una fonte così mirata di informazioni... un impegno... da cui nasce un tipo di competenza di cui può avvalersi anche il medico” (Molena-Pasquali, 1997). Due sono le esperienze narrate, quella in una associazione tra le persone affette da DAP e quella con una organizzazione di solidarietà tra e con le persone sieropositive. A proposito dell’Aids le associazioni si sono trovate ad assumersi il compito di una attenta vigilanza, facendo da tramite con autorità pubbliche e scientifiche, intervenendo anche nel dibattito scientifico a rappresentare il punto di vista dei malati: questo ruolo le ha arricchite di competenze peculiari, tanto più preziose quanto più la malattia comincia a tendere verso una cronicizzazione, grazie ai progressi terapeutici ottenuti anche con l’interazione “tra il sapere scientifico e il sapere acquisito dalle persone coinvolte nell’evento Aids”. “La relazione e la comunicazione tra pazienti affetti dalla stessa malattia, che pur nelle loro differenze sono accomunati da quella comune condizione, è radicalmente diversa da quella tra medici e pazienti (anche la più illuminata) e può contribuire al rafforzamento dei più deboli tra questi, a migliorare la comprensione della propria situazione, di quel che gli viene proposto, e via di seguito” (Botti, 2000). Non solo. “C’è chi con- 35 sidera... che il rafforzamento della posizione del paziente, che è necessario per dare un consenso effettivo... debba conseguire anche dalla relazione con altri pazienti: in questo senso vanno le richieste di consenso collettivo o il riconoscimento del ruolo di gruppi di auto-aiuto”. Anche per la richiesta del consenso informato, da parte delle istituzioni sarebbe possibile fornire le informazioni rilevanti alle comunità o associazioni di pazienti, mettendo a disposizione degli spazi per consentire la consultazione: “Tra l’altro il ricorso a questa pratica (cara agli attivisti Aids), che nel mondo anglosassone va sotto il nome di community consultations, può non solo aprire la possibilità di un rafforzamento reciproco, ma anche contribuire a un riequilibrio della disparità di potere e forze tra professionisti della salute e pazienti”. È possibile comunicare Che non si tratti solo di un lontano riferimento comparativo o di un auspicio teorico, sta a dimostrarlo un’altra esperienza in atto – sia pure in via sperimentale – presso la Sesta Unità operativa di Oncologia polmonare dell’Ospedale Forlanini di Roma, animata dalla responsabile infermiera Lucia Mitello. La quale così l’ha esposta al Master in bioetica: “Un consultorio familiare (sul tipo dei self-help o delle community consultations) aperto due volte al mese, dove medici e infermieri danno informazioni ai pazienti e ai loro parenti sulla malattia, sulle cure, sulle complicanze delle cure e sulla qualità di vita, dove c’è la possibilità di un consolidamento del rapporto e uno scambio reciproco di informazioni per migliorare l’assistenza ai pazienti oncologici”. Dunque è possibile comunicare. Oggi, ci ha ricordato lo storico della medicina Mirko Grmek, si parla di informazione come portatrice di senso, del senso della vita. La comunicazione è elemento costitutivo non solo della cultura ma anche della natura, del mondo, dell’universo. Ma l’informazione non esiste per se stessa. Un messaggio, come quello del genoma, non ha senso se non c’è qualcosa o qualcuno (la cellula vivente) che possa leggerlo e decifrarlo. Oggi si è capito che il dolore è un “messaggio informatico”, che anche il k rappresenta una “patologia della comunicazione” (Biava, 2002) sulla quale si può intervenire. Sono allo studio terapie genetiche personalizzate. Ma occorre tener presente che anche la migliore terapia genetica, antibatterica o antivirale non servirebbero a niente in assenza di una giusta comunicazione relazionale tra curanti e curati. Anzi, potrebbero essere controproducenti, perfino iatrogene. La cura della comunicazione biologica o genetica presuppone, richiede e alimenta la cura della comunicazione biografica, spirituale. Inoltre, come ci ricorda Grmek, possiamo curarci meglio, con più forza e meno dolore, con più efficienza 36 e sapienza, ma non basta. Si possono curare sempre più mali, “vincere sempre più battaglie, ma non la guerra contro le malattie: che restano un modo inevitabile di esistenza, una esperienza dura e inevitabile della vita”. La quale assume senso e valore solo se è animata di informazione, di buona e vera comunicazione, di etica relazionale. Come quella che è circolata nei convegni a cui ho partecipato. E ve ne sono grato. Buon lavoro, dottore. n 37 Alle gentili infermiere Scritta il 26 dicembre 2004 a Rocca di Mezzo (L’Aquila) G entili infermiere del Day Hospital Oncologico di Piove di Sacco (Padova), dice a noi? Vi chiederete. Sì, proprio a voi, di cui ancora non conosco i nomi. Ricordo soltanto quello del bonario volontario che ci intrattiene durante le cure, Pietro, perché è lo stesso del mio primo figlio e poi perché lo leggo ogni volta sul suo cartellino. Nessun nome, dunque, ma tanti sguardi cordiali e accoglienti. E l’immancabile sorriso. E la bravura professionale, sia nelle prestazioni di cura sia in quelle di informazione e di formazione. Di formazione? Vi chiederete ora. Sì, a me sembrate un po’ le maestre montessoriane delle mie nipotine. Avete cioè la propensione a favorire la collaborazione dei malati, a risvegliare le nostre risorse interne, a non scoraggiare lo spirito di iniziativa. Fosse anche solo quello di autoregolare il flusso di una flebo… E perché ci scrive? Potreste a questo punto domandarvi. Non solo perché c’è ancora aria di Natale (anzi, qui in montagna ce n’è fin troppa, una vera tempesta di neve) e anche i non credenti come me rispettano le tradizioni e rinnovano i buoni propositi, insieme ai figli e alle nipotine... Ma soprattutto perché mi siete venute in mente mentre leggevo – specie su “Repubblica” – articoli e lettere polemiche sulla vostra professione. Molte persone lamentano di aver subito trattamenti sgarbati, rozzi e arroganti. Altre rispondono che sono soltanto residui dovuti all’ignoranza, che tutto si risolverà con i nuovi titoli di studio e i nuovi mansionari. Ci ho pensato su, anche alla luce della mia esperienza in ospedali di varie zone. Non credo che si tratti esclusivamente di un problema di titoli o di mansioni, di tecniche. E nemmeno di virtù personali. La comunicazione con i pazienti resta soprattutto una questione di etica pratica, di valori vissuti nei comportamenti quotidiani dagli addetti alle cure e dalla organizzazione in cui sono inseriti. È anche per questo che, nonostante le perplessità e i consigli di amici, medici e non, preoccupati per le metastasi alla mia colonna, ho scelto di cominciare da voi quest’altro giro di giostra offerto dalla chemioterapia e di rimanere “pellegrin che 38 vien da Roma”. Possibile – mi dicono – che in tutta Roma non ci sia un’oncologia dignitosa dove poter fare la chemio senza sobbarcarsi ogni volta a un viaggio di andata e ritorno lungo, faticoso e dispendioso? Certo che sì – rispondo – ma non so se, oltre le cure, troverei lo stesso clima positivo e comunicativo che ho percepito fin dal primo approccio, dalla prima visita del dottor Fornasiero. E che ho ritrovato in tutti gli incontri successivi in cui, prima di ogni terapia, vengo riconosciuto e accolto da voi cortesi persone, addette anche alla segreteria; poi vengo ascoltato, auscultato e visitato con scrupolo dai medici. Magari dopo un bel po’ di attesa, ma questo è il pegno doveroso quando si ha il beneficio di essere seguiti direttamente dal primario. Il quale – ed è la prima volta che mi capita nella mia pur notevole carriera di paziente – si è offerto di mettersi personalmente in contatto con altri specialisti che si sono occupati di me, come i radioterapisti di Roma (oltre che con gli urologi di Padova che mi hanno indirizzato a lui), per consultarsi circa i trattamenti migliori da prescrivere, invece di ignorare o criticare le loro opinioni. Così come ascolta anche la mia, aiutandomi nel faticoso tentativo di restare parte attiva dell’équipe che mi cura, invece che suo oggetto passivo. Direttore d’orchestra Ma non c’è solo il dottor Fornasiero. Lui è solo il direttore d’orchestra. Ci sono i musicisti e i coristi, medici e infermiere: una volta una, una volta l’altra o le altre, ma tutte con uno stile che è si di efficienza (condizione necessaria ma non sufficiente), e insieme è anche di garbo, simpatia, attenzione e presenza. Mi ha colpito in particolare un curioso episodio, accaduto dopo l’ultima cura, il 17 scorso, e che mi è ricomparso vivido e fresco proprio ora, mentre leggo sui giornali peste e corna sulle infermiere scortesi e meschine (se non assassine). Quando quella di voi che era in servizio nel pomeriggio mi ha chiesto se sarei tornato prima delle feste, ho risposto che sarei tornato solo a gennaio, grazie al rinvio concordato con il medico. Allora mi ha sollecitato a passare da lei subito dopo la terapia, prima di scappare a prendere l’autobus. Ebbene, confesso di aver pensato: “Ecco, anche qui succederà che mi chiederanno di aderire all’ennesima sottoscrizione benefica…”. E invece no. Con mia grande sorpresa mi sono visto invitare a scegliere un dono da parte vostra. Si, vabbé, un dono simbolico... ma pur sempre il contrario di quanto avviene negli ospedali, dove i “doni” sono di solito quelli dei pazienti, accettati e a volte sollecitati dal personale. Dunque un dono virtuale ma virtuoso, più vero di certi omaggi dei pazienti al potere dei curanti. Ecco perché mi è venuta voglia di scrivervi, anche se nemmeno so come vi chiamate di nome. Il vostro atto mi ha commosso, mi 39 sembra un segnale di conferma di quello stile armonico e terapeutico che dicevo. E che mi induce ogni volta a venire (almeno finché ce la farò e i medici lo valuteranno opportuno). Certo che tornerò a Roma magari più stanco, ma ogni volta più sereno, rinfrancato e rafforzato nella volontà di curarmi nonostante i disagi della cura. Molte persone si stupiscono del mio stato “positivo”, del mio reggere bene anche alla chemio. Se è per questo, anch’io mi meraviglio. Ma so che ciò è dovuto, oltre che ai nuovi medicinali, al buon rapporto con la vostra équipe. E ve ne sono grato. E cerco di ricambiarvi scrivendo, perché è una delle cose che ancora so fare. Grazie dunque a tutte voi e auguri di buon lavoro anche per l’anno nuovo. n 40 Ascolto montessoriano, attenzione e azione Pubblicata sul n.89/2006 del “Quaderno Montessori”, dedicata a Virginia Ciuffini (morta il 10 settembre 2005) R Alle parole di Myriam David (Quaderno n.87): “La madre ha cura del bambino perché lo ama, l’educatrice lo ama perché ne ha cura”, aggiungerei queste: l’amico cura il malato perché lo ama, il medico lo ama perché ne ha cura. icorda dottore il detto “se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”? Noi malati, come gli alunni a scuola, in ospedale sentiamo qualcosa, vediamo poco e facciamo quasi niente. Così usciamo, quando va bene, che non abbiamo capito un gran che della nostra salute. Che spreco... Mentre ogni classe, ogni corsia, ogni ambulatorio potrebbe essere un laboratorio, per dirla con il pedagogista Francesco De Bartolomeis. E conosce dottore, a proposito di pedagogia, quella montessoriana? Potrei dire in sintesi, avendola garantita fin dalla nascita ai miei figli, i quali ora la estendono alle nipotine, che è un misto di ascolto, attenzione e azione. Ascolto rispettoso e non distratto o sospettoso – per dirla con l’analista Luciana Nissim Momigliano, sopravvissuta ad Auschwitz – com’è ancora quello di molti medici. Saper ascoltare è un’arte, ci ricorda l’antropologa Marianella Sclavi, che parla di ascolto attivo, sperimentale. Attenzione affettuosa e, come l’ascolto attivo, attivante, magari proattiva. Il contrario di quanto avviene nei vostri ambienti, dove compaiono sempre più tv a renderci passivi. Anche in corsia, senza nemmeno le cuffie per renderle meno invadenti. Dove ho fatto la chemioterapia c’era una camera senza tv: quando ho sentito che l’avrebbero piazzata anche lì, ho pregato di lasciare uno spazio per chi vuole pensare, leggere, osservare, comunicare con i compagni di viaggio. Azione maieutica, quella che favorisce e cura l’emersione, l’uso e lo sviluppo delle potenzialità e delle risorse interne, dei bimbi come dei malati. La regola Montessori “aiutami a fare da solo” vale anche per noi pazienti. Chi impara è più contento, mantiene il cuore vigi- 41 le, per dirla con un altro sopravvissuto ai lager nazisti, lo psichiatra Bruno Bettelheim. Montessoriano è il medico che aiuta il paziente a curarsi da sé, grazie all’ascolto vero, terapeutico, reciproco; che ricerca e sperimenta, non limitandosi ad argomentare un po’ di più. Che comunica, per costruire un terreno comune di partecipazione responsabile e di protagonismo creativo, aiutandoci a far parte dell’èquipe che ci cura, a praticare autonomia, libertà e democrazia come forma di vita quotidiana anche negli ospedali. Il malato che sta in voi Ma vede, dottore, per riuscirci dovreste riconoscere nel rapporto con noi il malato che sta in voi, così come maestre e maestri cercano di preservare, nel rapporto con i bambini, il bambino che è dentro di loro. Di più, potreste riconoscere in noi il forte bisogno infantile di un valido interlocutore di riferimento, che infonda sicurezza, che aiuti ad affrontare i cambiamenti, non sempre attesi o graditi. Anche a noi, soprattutto quando cadiamo in una malattia grave o in un suo aggravamento – e torniamo bambini, deboli e impauriti – serve il rispetto di quello che Grazia Honegger Fresco chiama il “periodo sensitivo dell’orientamento”. Perché fate così fatica ad avere consapevolezza della comune matrice umana, corporea e mortale, che ci unisce al di là dei ruoli? A comportarvi da guaritori feriti, come dice il filosofo Hans-Georg Gadamer, seguendo l’invito di pazienti esigenti e preziosi come i giornalisti Gigi Ghirotti e Virginia Ciuffini? Il 27 giugno 2005, Rai Educational ha trasmesso un servizio di Paolo Barnard intitolato “Nemesi medica”, come il noto libro di Ivan Illich: interviste a quattro luminari colpiti da tumore o da ictus (pubblicate parzialmente nel libro “Dall’altra parte” edito da Rizzoli). Sono cambiati, hanno perso distacco e certezze. Uno afferma: “Essere malato è più forte che essere medico”. Ma io mi chiedo: perché dover attendere il male? Perché nemesi e non speranza o riconversione? n E se provassimo a rileggere Maria Montessori? 42 Autobiografia “Nato a Berceto, nella zona dell’Appennino sita tra le colline parmensi, le Alpi Apuane e le Cinque Terre. Studia al ‘Maria Luigia’ di Parma, poi a Roma, dove risiede con due figli e tre nipoti. Collabora con Unione Italiana Ciechi, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ragioneria generale dello Stato e Inps. Attivista politico (Pci, Avanguardia operaia) e sindacale (F.I.D.Enti Pubblici-Cgil) si laurea in Sociologia con tesi sulle forme di lotta alternative allo sciopero nei servizi, pubblicata con il titolo ‘Scioperare stanca’ (Adda, 1986). Al 1997 risale la diagnosi del primo tumore (vescica), al 2000 il secondo (prostata: curato inutilmente con terapia chirurgica, ormoni, radio e chemio sistemica). Nel 2004 consegue il primo Master in bioetica ed etica pratica della Sapienza con una tesi intitolata “Per una validazione consensuale in ospedale”. Dal 3 giugno 2006 ricoverato in cure palliative all’Hospice Antea di Roma per una paralisi dovuta a cedimento midollare da metastasi vertebrali”. “Ho fatto studi seri di sociologia e bioetica; ho assunto responsabilità politiche e sindacali anche ad alto livello; ho contribuito a tirar su una famiglia tutt’altro che parassitaria e consumista. Insomma, davanti al cancro e alle metastasi ossee avrei avuto, forse, non dico il diritto ma almeno l’opportunità di tirare i remi in barca e barcamenarmi un po’. Invece no”. Gianni è morto alle 15.20 di martedì 6 febbraio 2007. È sepolto nel piccolo cimitero del suo paese natale. Sulla lapide c’è scritto: “Uomo generoso, sempre”. 43 Cronologia Dati nome Giovanni Grassi (detto Gianni) nato a Berceto (Parma) il 18 ottobre 1939 morto a Roma (hospice Antea) il 6 febbraio 2007 padre grande invalido cieco di guerra (dec. 1956) madre ex docente di economia domestica (dec. 2008) fratelli Maurizio (dec. 1944) e Giorgio coniuge Silvia Arbicone, ex docente diritto ed economia figli Pietro (1964) informatico e Lorenzo (1966) giornalista nipoti Giorgia (1994), Michela (2000) e Irene (2003) paziente oncologico e pensionato Inps Titoli 1958 diploma al liceo classico “Maria Luigia” di Parma 1986 laurea con lode alla “Sapienza” in Sociologia, tesi “Il lavoro arbitrario nei servizi come forma di lotta alternativa”, pubblicata con il titolo Scioperare stanca, una tesi sulle forme di lotta nella società dei servizi (Adda, Roma) 2004 master con lode alla “Sapienza” in Bioetica ed etica pratica, tesi “Per una validazione consensuale in ospedale” 2005 socio onorario Associazione radioterapia oncologica 2006 socio onorario Società italiana di Psico-oncologia 2006 giornalista pubblicista (Ordine del Lazio) Attività 1958 assistente di un docente grande invalido cieco di guerra 1960/64 correttore e redattore rivista giuridica “Montecitorio” 1962 vincitore premio giornalistico Uic sui problemi dei ciechi 1963/1976 militante del Pci e dirigente di Avanguardia operaia 1964/1979 funzionario nell’ente pubblico Unione ciechi 1968/1978 sindacalista nella Fidep-Cgil (Federazione italiana 44 dipendenti Enti pubblici) e nella Camera del lavoro di Roma 1976/1986 direttore della rivista “Bisogni e servizi sociali”, periodico del Consiglio unitario delegati Uic 1979 curatore e conduttore della trasmissione Assistenza e lotta di classe su Radio Città Futura 1980/1997 funzionario Inps con assegnazione Presidenza del Consiglio dei ministri, segreteria ruoli unici e Ragioneria generale dello Stato, ufficio liquidazione enti; poi responsabile pianificazione e controllo in sedi zonali e sede regionale Lazio 2002/2007 redattore della rivista “l’Incontro”, periodico dell’Associazione italiana ciechi di guerra Pubblicazioni principali 1961 Equivalenza sociale per i ciechi (“Montecitorio”, nn.9-10) 1961 I ciechi e il lavoro (“Montecitorio”, n.11) 1962 I ciechi e il lavoro in Italia (“La Parola del Popolo”, n.57) 1964 Orientamenti in tema di collocamento della manodopera (“Montecitorio”, nn.7-9) 1976 Dipendenti pubblici e controllo popolare (“L’altra Roma”, nn.6-7) 1984 La via italiana alla autoregolamentazione (“Quaderni di Rassegna sindacale”, n.111) 1985 Le forme di lotta in “Cgil, bilancio di quarant’anni” (Quaderni di Rassegna sindacale, n.114-115) 1986 Scioperare stanca. Una tesi sulle forme di lotta nella società dei servizi (Adda, Roma) 1994 L’Inps, un laboratorio a cielo aperto in “Pubblica amministrazione e cambiamento organizzativo. La danza degli elefanti” (“Sociologia del lavoro” n. 54, con Antonio Zazzetta) 2006 Le persone cieche e la comunicazione (“l’Incontro”) 2006 Lettera a un ospedaliere (“Il quaderno Montessori”) 2006 I Professional (commenti al libro di fumetti di Cesare Malservisi pubblicato dall’Antea) L’elenco integrale delle pubblicazioni di Gianni è consultabile, insieme al suo “curriculum oncologico”, sul sito internet www.giannigrassi.it 45 Testamento biologico Dicembre 2006 Giovanni (Gianni) Grassi, nato a Berceto (Pr) il 18/10/1939, residente a Roma, domiciliato nell’Hospice Antea, in possesso della facoltà di intendere e di volere dispone che il figlio Pietro (sostituto fiduciario) Prima della morte In caso di crisi di emergenza, con o senza perdita della facoltà di intendere e volere: non lo affidi al 118 o a un pronto soccorso, ospedale o clinica, ma lo trattenga dove si fosse verificata l’emergenza, contattando immediatamente l’UOCP dell’Antea e applicandone le istruzioni, compreso l’eventuale trasferimento nell’Hospice; non lasci effettuare: tracheotomia, rianimazione cardiopolmonare, ventilazione assistita, alimentazione artificiale tramite sondino naso gastrico e/o infissione di aghi, ovvero qualsiasi forma di accanimento (ma acconsenta all’aggattimento: reidratazione, purché non comporti un danno ulteriore e non sia responsabile del prolungamento del processo della mia agonia; e, in caso di depressione respiratoria o di riacutizzazione dolorosa o di sintomi da astinenza da oppioidi, alle contromisure per alleviare le sofferenze); non chieda e non conceda assenso ad alcuna forma di assistenza e/o rappresentanza per fede (ideologica e/o religiosa). Dopo la morte Segnali la scomparsa sul sito www.giannigrassi.it e sui giornali: “Gianni Grassi, paziente esigente, è morto il (...) lasciando questo messaggio: sono arrivato a 67 anni. A chi m’ha curato bene (medici, infermieri, operatori e volontari) con pazienza, competenza e affetto chiedo di aiutare mia madre a morire con dignità e le nipotine a serbare il ricordo del nonno. Benché abbia l’impressione d’aver raccolto il seminato (pur con difficoltà, incomprensioni e sbagli in famiglia, nel lavoro, nell’attività politica e sindacale, negli studi) ripeto ai professionisti della salute: attenti, informazione, efficienza, consenso informato, evidenza scientifica sono condizioni necessarie ma non sufficienti, ci vuole anche la comunicazione, per ottenere validazione consensuale, cioè un rapporto reciproco di relazioni terapeutiche tendenzialmente paritarie tra curanti e curati”. 46 L’incontro con il presidente Ciampi insieme ai ciechi di guerra (2003) Svolga le pratiche funerarie (cremazione, trasferimento ceneri) e queste esequie: nessuna omelia di preti; con la salma in bara, prima di cremarla, i familiari credenti celebrino il funerale, affidando la parte non musicale a Maria Teresa Carani (Amici di Villa Ada), a Livia Crozzoli (Gruppo Eventi), al dr. Luigi De Salvia e al prof. Giuseppe Piazza; quella musicale alla dr.ssa Paola Pacileo, al coniuge maestro Juan Paradell Solè, al mezzosoprano Marilena Licitra figlia di Maria Occhipinti; con l’urna cineraria, si possa fare una cerimonia laica bright a Roma, sotto forma di rievocazione di quel che ho cercato di dire e fare per la comunicazione tra curanti e curati, magari allietata da musiche, letture e proiezioni, coinvolgendo persone amiche come Silverio Corvisieri; l’urna dovrebbe poi transitare per Rocca di Mezzo (L’Aquila) e consentire altra cerimonia funebre (biblioteca, oratorio o parrocchia) con gli interessati, allietata da musiche, letture e proiezioni con l’aiuto della pianista Luisa Prayer, del prof. Mario Arpea, del bibliotecario Liberato Di Sano; l’urna dovrebbe quindi fermarsi al teatro delle Ariette (valle rio Marzatore, Castello di Serravalle), per eventuale inserimento in edizione speciale dello spettacolo estate-fine; infine l’urna arriverà a Berceto per la tumulazione (con o senza cerimonia funebre, da concordare con la Grande, Giampiero Bernini e la Pupa Agnetti). Garantisca che ogni provento derivante da utilizzazione dei miei scritti sia destinato all’Antea o, in caso di cessazione delle attività di cure palliative, a un’organizzazione similare che, a suo giudizio, meriti tale destinazione. n 47 Pensate che bel paradosso: dover aspettare di essere sul punto di morire, di “lasciare la vita”, per diventare consapevoli e magari (soggetti morali) attivatori di facoltà mai prima esercitate. Altro che risorse residue… A me sembra un po’ come diventare sciamano proprio quando torno polvere, senza altro domani di quello che, da bright, “splendente di luce propria”, avrò seminato sotto forma di memoria condivisa “Vorresti dirmi che strada devo prendere, per favore?” “Dipende, in genere, da dove vuoi andare” rispose saggiamente il Gatto. “Dove, non m’importa molto” disse Alice. “Allora qualsiasi strada va bene” rispose il Gatto. “... purché arrivi in qualche posto” aggiunse Alice per spiegarsi meglio. “Per questo puoi stare tranquilla” disse il Gatto. “Basta che non ti stanchi di camminare” Lewis Carroll (“Alice nel Paese delle Meraviglie”) fine vita L’ultimo evento. Ma non disperato Il dovere, difficilissimo, di perdonare Garantire sino alla fine le scelte fatte in vita Bisogna essere Papa per farsi rispettare? La vera buona morte non è staccare la spina Dialoghi sulle ultime volontà e per morire bene La speranza di morire vivo 51 53 54 57 59 60 63 49 Davanti alla baita assolata dell’Alpe di Siusi dopo una sciata di fondo Recensione al libro “Sarà così lasciare la vita?” pubblicata sul quotidiano “il manifesto” del 20 giugno 2001 P arlare della morte, propria e altrui, è sempre stata – nella nostra cultura – un’esperienza difficile. Ancor più, parlare del morire. Molto, molto più difficile, e sempre più rara, è l’esperienza di prendersi cura – non per mestiere – di una persona morente. E di saperla comunicare, come ha fatto Rossana Rossanda ne La vita breve (Pratiche, 1996). Di morte spettacolo ce n’è tanta, al cinema e in tv. Ma in concreto si muore per strada e in ospedale. Si muore male, si muore soli, anche se – come ricorda Filippo Gentiloni nel libro scritto insieme a Rossanda – non sempre e non tutti allo stesso modo: anche il morire è un fatto politico. In una lettera mai spedita, pubblicata ne Il nespolo (Bollati Boringhieri, 2001) Luigi Pintor, con la figlia “vicina alla morte senza difesa né contro il male né contro la sofferenza”, rivolgeva a un professore questa “forse indebita” domanda: esiste un modo e un luogo per morire degnamente? È la stessa che anch’io avevo scritto a un pur bravo medico ospedaliero mentre, esasperato e impotente, assistevo alla morte dolorosa di un amico, fine vita L’ultimo evento. Ma non disperato diversi anni fa. Possibile che ancora non si percepisca una risposta accettabile? Eppure già nel 1990 i familiari di un altro amico morente, Augusto Ciuffini, avuta notizia di un’organizzazione di assistenza a domicilio (animata dal medico Giovanni Creton) l’avevano utilizzata. E in un’altra lettera, pubblicata su il manifesto, con altri compagni li avevo ringraziati per avergli saputo garantire una morte serena e dignitosa. Ma non approfondimmo più di tanto: si trattava della morte di Augusto, non della nostra mortalità o – come preferisce dire Patrizia Valduga nelle Quartine (Einaudi, 2001) – “moribilità”. Anni dopo, anch’io sono stato colpito dal male che, in una delle sue varianti, aveva ucciso Augusto e poi, in un’altra, impegnato sua figlia Virginia in una dura battaglia, che lei ha raccontato in Vento forte sulla casa rosa (Sperling & Kupfer, 1995) e prosegue tuttora affinché i “pazienti” diventino esigenti. Sono stato così richiamato alla lotta e alla coscienza della mia “moribilità” con più attenzione. Non solo ho capito, grazie alla testimonianza di Remo Girone sul 51 Lungo i sentieri a picco sul mare delle Cinque Terre (1995) Notiziario Airc (gennaio 1997), dove conveniva che mi rivolgessi per farmi curare; ma ho pure scoperto che sempre più gruppi e associazioni si confrontano e si danno da fare per lenire la fase finale della vita, nelle sue dimensioni materiali e spirituali: assistenza fisica e psicologica, sostegno pratico e morale, a domicilio e in ospedale. Insomma, quanto è necessario per aiutare a soffrire di meno, a chiudere i conti della propria esistenza e prepararsi al commiato. Uno di questi organismi l’ho anche frequentato. È il “Gruppo eventi”, animato a Roma dalla psicologa Livia Crozzoli Aite, dalla cui pluriennale attività sono scaturiti scambi di esperienze e adesioni alle associazioni di volontariato. Molte delle relazioni agli incontri – svolte da medici, psicoterapeuti, docenti, rappresentanti dei gruppi – sono pubblica- 52 te in un volume intitolato Sarà così lasciare la vita? (Paoline, 2001), destinato a diventare un testo di riferimento e uno strumento di formazione, come i ben noti Sulla morte e il morire di E. Kubler-Ross (Red, 1981), La morte amica di M. de Hennezel (Rizzoli, 1996), Come moriamo di S. Nuland (Mondadori, 1995) e Chi muore? di S. Levine (Sensibili alle foglie, 2000). Diritti da diffondere Questo libro prova a formulare una risposta alla domanda iniziale (esiste un modo e un luogo per lasciare la vita degnamente?). “Morire mantenendo la propria dignità di essere umano, non da soli, senza dolore o inutili sofferenze – ha scritto Virginia Ciuffini – non è più solo una speranza, è un diritto. Da difendere, da diffondere”. Anche con iniziative come questa del n “Gruppo eventi”. Da un volantino distribuito il 28 ottobre 2003 al convegno “Dolore, cure palliative, eutanasia” promosso dall’Istituto nazionale tumori a Milano D i fronte a tanta ricchezza, a tanta bellezza, a tanta verità e (lo dico da malato di cancro sopravvivente, ma non credente in dio onnipotente e tantomeno nell’onnipotenza dei medici) di fronte a tanta spiritualità competente, avevo deciso di seguire l’invito del filosofo Wittgenstein (“Se qualcuno ha qualcosa da dire, si faccia avanti. E taccia”). Ma non ho resistito a fare pubblicamente una domanda ai medici, a me stesso e a tutti noi insieme. Oggi il frastuono dei diritti ci fa dimenticare che morire è anche un dovere, biologico e sociale, cui corrisponde il dovere di aiutarci reciprocamente a morire il meglio possibile. (I vecchi di quest’estate li ha ammazzati non tanto il caldo, l’arsura della natura, quanto il freddo, l’aridità della società: la solitudine, l’assenza delle famiglie. Ma dov’erano i medici “di famiglia”?). Morire bene, ci è stato ricordato, vuol dire anche riuscire a perdonare i torti dei familiari. Allora chiedo ai medici: ricordate fine vita Il dovere, difficilissimo, di perdonare la domanda onirica dell’esaminatore al vecchio medico de “Il posto delle fragole” di Ingmar Bergman? Insisteva: “Qual è il primo dovere del medico?”. E, di fronte al suo imbarazzo, ricordate la risposta? “È chiedere perdono”. Penso che sia giusto. Ma so bene che è duro, difficile. E a me stesso chiedo: qual è il mio primo dovere di malato? Non è forse quello – tanto più difficile, perché è più duro dare che chiedere perdono – di riuscire a perdonare ai miei curanti non solo le loro esitazioni, le loro supponenze, i loro errori, ma anche e soprattutto le loro letali indifferenze? So bene che è difficilissimo, quasi impossibile. Ma è un passaggio obbligato per arrivare a comunicare. Altrimenti il bambino che resta in me, e le mie amate nipotine, ci chiederebbero: signore e signori, è possibile che si debba morire da piccoli, troppo presto, o arrivare troppo tardi, vicino alla morte, per sperare umanamente di essere trattati da persone vive, intere, sensate, e non da pezzi, cose senza valore? n 53 Garantire sino alla fine le scelte fatte in vita Intervento (non fatto) al convegno “Al limite della vita, percorsi di cura” organizzato a Roma il 4 dicembre 2004 (ma successivamente svolto al “Gruppo Eventi”) T ra i bisogni esistenziali alla fine della vita secondo me c’è, insieme con quelli dell’accompagnamento e dell’alleviamento del dolore, quello del rispetto della propria volontà. Virginio Bonito, che cura malati affetti da Sclerosi laterale amiotrofica, scrive: “L’intervento medico trova il suo fondamento e il suo limite nella richiesta di aiuto espressa dal malato e il prolungamento della vita non basta a giustificarlo. Il rispetto della volontà del malato non è certo il fine della relazione terapeutica ma ne costituisce il prerequisito che la rende lecita”. Di recente sono circolati due film che hanno provocato discussioni: Il mare dentro e Le invasioni barbariche. Il primo narra di un uomo paralizzato che, dopo una vana battaglia legale, trova fuori dalla famiglia una persona disposta ad aiutarlo a suicidarsi con un veleno. Il secondo narra di un professore malato di cancro che, dopo trattamento palliativo e con l’aiuto di parenti e amici, decide di suicidarsi con una overdose di eroina. In entrambi i casi esiste un ambito familiare premuroso e accogliente: nonostante il 54 quale, il primo decide di andarsene comunque da una vita per lui insopportabile; grazie al quale, invece, il secondo decide di aver chiuso bene i conti e di potersene andare. Forse lasciare la vita come questo professore piacerebbe a molti, me compreso (anche se del film dispiace che il diritto a una morte dignitosa scada in privilegio garantito dal denaro). Ma una situazione del genere è rara a prescindere dai soldi. Come risulta dai censimenti, sempre più si vive soli e poi si muore soli, in ospedale, alla mercé dei medici; i quali nell’incertezza preferiscono fare più che omettere (dal momento che il codice deontologico vieta l’accanimento ma la sanzione giuridica è per l’omissione di soccorso). Tuttavia, secondo una nota ricerca, almeno una volta su quattro la morte è l’esito di una precisa, anche se non sempre pienamente consapevole, decisione del medico. Franco Toscani, direttore d’un Istituto di medicina palliativa, riferendo sulla rivista Bioetica del convegno “Il rispetto per il morire” tenuto nel maggio scorso dalla Regione Toscana, scrive: “Il concetto, o le vuole depotenziare, le dichiarazioni) anticipate, e una persona di fiducia che le faccia valere. Però, secondo il Comitato, non possono avere carattere vincolante: sarebbe un attacco alla professionalità del medico, che può essere obbligato solo a prenderle in considerazione e a motivare la sua decisione di attuarle o non. Come se la professionalità fosse in insanabile opposizione con l’autonomia del paziente. A mio parere le espressioni di volontà contenute nelle direttive dovrebbero essere moralmente vincolanti, al pari di quelle rilasciate da ogni persona in possesso della piena capacità decisionale. fine vita meglio, l’illusione che esista una sorta di morte naturale che giungerebbe quando i tempi fossero maturi, per decreto del destino, della natura o della provvidenza, è in molti casi illusorio. Tranne che per le morti accidentali o improvvise, la scienza medica ha pressoché sempre la possibilità di anticipare o rimandare il momento della morte, di poco o di tanto che sia, e la scelta del medico... di fatto decide il momento della morte. È quindi cruciale chiedersi come e perché vengono prese queste decisioni: e se il perché è convincente, se i fatti e le interpretazioni concordano nell’individuare situazioni nelle quali è opportuno, buono e giusto che la morte giunga prontamente, perché mai il momento giusto non dovrebbe essere indicato dallo stesso malato e la sua decisione rispettata?”. Anch’io, come altre persone malate inguaribili, mi porto dentro insieme due esigenze apparentemente contraddittorie, o forse no: a) la volontà di garantire a me stesso di poter decidere autonomamente quando e come lasciare la vita; b) la speranza di essere aiutato a non averne bisogno, grazie a una rete di fiducia, cioè di relazioni etiche, scientifiche e affettive che mi garantiscano dignità sino alla fine. Però volontà e speranza, al momento buono, sono spesso svuotate dalla assenza di un ambito familiare collaborativo o di un ambiente ospedaliero rispettoso. Ecco perché sarebbero importanti le direttive (o, come le chiama non casualmente il Comitato nazionale di bioetica, che Volontà vincolanti Cercando, ho trovato più modelli di direttive: alcuni specifici (come quelle degli Ospedali di Bergamo dove lavora il dottor Bonito, sulla ventilazione artificiale); altri generali: le “disposizioni cristiane preventive” della Conferenza episcopale tedesca e della Chiesa evangelica (che ammettono ogni “aiuto passivo o indiretto a morire” col consenso della persona malata); le “disposizioni sulla propria fine” della Società canadese “morire con dignità”; la “Carta di autodeterminazione” della Consulta di bioetica di Milano (che per me resta il migliore); sino al “testamento biologico” di “Exit Italia per il diritto a una morte dignitosa” di Torino (l’unico che preveda l’eutanasia). Tutti propongono la nomina di fiduciari per la cura del rispetto delle proprie volontà. Anche il Comitato di bioetica ritiene opportu- 55 Con Silvia alla festa della castagna di Corchia (1971) no che le dichiarazioni contengano i nomi di uno o più fiduciari “da coinvolgere obbligatoriamente da parte dei medici nei processi decisionali a carico dei pazienti divenuti incapaci di intendere e di volere”, ma esclude di nuovo che le loro valutazioni possano avere una forza vincolante. Non a caso da noi le direttive non partono, non hanno ancora riconoscimento legale, in Francia ora sì, in America hanno la forma del living will. La loro auspicabile codificazione dovrebbe consentire a ognuno sufficiente libertà per decidere il modo in cui esercitare, direttamen- 56 te o tramite fiduciari, scelte moralmente significative circa le cure cui intende sottoporsi e le modalità della propria morte. È vero che il nostro ordinamento giuridico non riconosce il principio della disponibilità della vita, ma Eugenio Lecaldano, nel suo Dizionario di bioetica, ci ricorda che disporre della vita “è un prerequisito per individuare i modi responsabili ed eticamente accettabili per dare a essa una continuità e un senso”. Dunque, un buon accompagnamento alla morte dovrebbe garantire sino alla fine anche il rispetto delle n scelte morali fatte in vita. Dall’intervento tenuto il 18 marzo 2006 dopo la tavola rotonda “Giurisprudenza e giudizio” al convegno del Comitato di Etica su “Il consenso informato: dal mito alla realtà” presso l’Azienda ospedaliera “Ospedale maggiore” di Crema V oglio fare alcune precisazioni: il ministro Giovanardi, quando paragona la normativa olandese sull’eutanasia alla eutanazia nazista, si dimostra non solo un cattolico integralista ma un ignorante integrale. Eutanasia significa aiuto richiesto da una persona per eliminare la propria vita da lei ritenuta non sopportabile. Eutanazia è stata l’eliminazione non richiesta di persone ritenute non sopportabili dallo Stato etico nazista. C’è una bella differenza, infatti, tra etica e Stato etico (come tra bioetica e medico etico). Lo Stato etico è quello che sa lui, che decide lui qual è il bene dei cittadini e glielo impone (così come il medico etico fa nei confronti dei malati). Ma etica non è imporre regole uguali per tutti, bensì è dare ragioni plausibili per tutti. Compito del diritto è dare regole uguali per tutti, compito della giustizia è applicarle in modo uguale per tutti. Ma possono esistere, esistono purtroppo, leggi immorali e sentenze ingiuste. L’etica sta prima e sopra il diritto. Alla luce delle regole morali possiamo e dobbiamo valutare quelle legali. Alla luce della nostra one- fine vita Bisogna essere Papa per farsi rispettare? stà di ricercatori possiamo e dobbiamo descriverne l’applicazione, spiegarla se ne siamo capaci e poi valutarla. Se questo è vero, o almeno plausibile, chiariamoci innanzitutto sul “testamento biologico”. Sembra di stare a teatro, all’aspettando Godot di Samuel Beckett. Tutti ad aspettare la legge. Ma vi ricordate cosa diceva Ennio Flaiano dei principali vizi italici? Il primo lo definiva “correre in soccorso del vincitore”: l’opportunismo, il servilismo oggi tanto di moda. Il secondo è il nominalismo: nominato il problema, cioè fatta la legge, risolto il problema. Magari fosse. In realtà non c’è buona legge che tenga se prima non c’è l’informazione, la partecipazione, la condivisione, la sperimentazione, insomma una cultura comune. E vi pare che possa bastare una legge sul rispetto delle volontà di fine vita dei pazienti se prima non riusciamo a garantire negli ospedali, nella clinica, nel rapporto con i curanti il rispetto della nostra autonomia e della nostra dignità? Rischiamo altrimenti, se si aggiungono ipocrisia e illusioni, di alimentare devastanti disillusioni. 57 Già il codice deontologico dei medici è un capolavoro di ipocrisia. Come ha rivelato il giurista Santosuosso, prevede il privilegio dell’obiezione di coscienza ben al di là dell’unica fattispecie legale rimasta nel nostro ordinamento, che – dopo l’abolizione della leva militare obbligatoria – è quella nei confronti della interruzione volontaria di gravidanza. Insomma, un comodo alibi per far finta di cambiare le parole e invece cambiare niente o poco nella realtà dei rapporti di potere tra curanti e curati. Vorrei chiudere con un commento all’affermazione di uno dei magistrati, Benito Melchionna, circa la presenza nell’ordinamento italiano del diritto dei cittadini malati a essere rispettati ma l’assenza del diritto alla disponibilità della vita. Se guardiamo solo le norme è così. Però, se guardiamo dietro le norme, nelle pieghe e nelle piaghe della società, scopriamo una realtà ben diversa. E l’ordinamento non è fatto solo della lettera delle norme: si parla perfino di una Costituzione “formale” e di una “materiale”. Innanzitutto ricordiamoci del piccolo particolare che – come finalmente anche in Italia ci mostrano studi autorevoli – si muore più nelle corsie ospedaliere, per errori diagnostici e terapeutici, chirurgici e farmacologici, che nelle corsie autostradali. Chi dispone della nostra vita? Non solo. Altri studi seri mostrano che in ospedale si dispone, 58 eccome, anche della nostra fine vita: i medici, e non da soli, intervengono molto spesso a decidere tempi e modi – anticipati e/o posticipati, più o meno utili e/o rispettosi – della morte delle persone ricoverate. Ormai lo riconoscono quasi tutti, sarebbe sciocco nasconderselo. Un dato illuminante Ma pure a noi poveri pazienti qualcosa è consentito disporre: per esempio, il rifiuto non solo di amputazioni ritenute necessarie, ma anche di cure ritenute “salvavita”, fino alla respirazione artificiale e ad altre forme cosiddette di “accanimento terapeutico”. Certo, conosco anch’io il parere del Comitato nazionale di bioetica che nega sia nella disponibilità dei malati, e perciò dei sanitari, il rifiuto di interventi come la alimentazione artificiale, definiti atti “non medici” bensì vitali. Ma il Comitato (o meglio, la sua maggioranza che tende a imporre le regole del suo credo anche ai non credenti, piuttosto che a discutere regole plausibili per tutti) ha dimenticato un dato di fatto illuminante: non il piccolo Gianni Grassi, ma il grande Papa Giovanni Paolo II ha rifiutato l’alimentazione artificiale e ha chiesto ai medici del “Gemelli” di essere lasciato morire in pace. Quei medici avrebbero dunque violato le regole o hanno, benché cattolici conclamati, rispettato la volontà dell’augusto paziente? Bisogna essere Papa per farsi n rispettare in ospedale? Articolo pubblicato sul quotidiano “Metro” il 21 dicembre 2006 S ono nelle condizioni del signor Welby. Morire non è cosa buona o cattiva, è un dovere biologico e sociale: a farlo rispettare ci pensa la natura. Morire bene, invece, è un diritto alla cui osservanza dovrebbe pensare la cultura, la società: il diritto di non essere abbandonati al dolore e alla solitudine. Ma, mentre il dovere di morire viene esercitato per lo più in ospedale, dove si esercita il diritto di morire bene? E poi, è un vero diritto o resta una speranza? Io lo sto esercitando da 6 mesi nell’Hospice Antea di Roma. Non è un ospedale, è il luogo (e troppo pochi ce ne sono) dove, se dichiarato “inguaribile”, puoi passare alle cure “palliative”: quelle che, oltre a lenire il dolore inutile, ti aiutano a tirar fuori le risorse residue, sino alla fine. L’Hospice da cui scrivo è stato fondato dal dr. Casale, lo stesso che voleva ricoverare anche il signor Welby, che però ha rifiutato. Perché? Forse perché sembra desiderare, più che una “buona morte” (eutanasia) per se stesso, lo spazio di una buona battaglia ideologica per il diritto fine vita La vera buona morte non è staccare la spina dei morenti a veder rispettata dai medici la propria volontà? Per dare un senso alla propria morte? Cioè: no all’accanimento e sì all’eutanasia? Ma allora che cosa significa eutanasia? Io avevo detto: no all’accanimento, sì all’aggattimento, cioè al rispetto della mia volontà scritta nel “testamento biologico”. E stavo in buona compagnia: dal famoso don Verzè, fondatore dell’ospedale San Raffaele di Milano, al noto oncologo prof. Veronesi. Entrambi criticati dal movimento “per la vita”, quello che io chiamo “per l’altrui sopravvivenza a ogni costo”, e tuttora dai fanatici della “sacralità” della vita, anche solo biologica. Ricordiamo quanto ha scritto Santa Teresa: “Cos’è scrivere belle cose sulla sofferenza? Nulla, nulla. Bisogna esserci per sapere”. Il vero atto d’amore per il signor Welby non è “staccare la spina” (lo farebbe solo soffrire), bensì dargli i sedativi giusti e accompagnarlo sino alla fine. Questo a me pare il significato di eutanasia: non una forma di suicidio assistito ma una “buona morte” senza dolore. E senza fan natismi ideologici. 59 Dialoghi sulle ultime volontà e per morire bene Pubblicati fra l’ottobre 2006 e il gennaio 2007 sull’inserto “Salute” di “Repubblica” con questa premessa: “Gianni Grassi, ‘paziente esigente’, è un malato che pone interrogativi e dialoga con il personale sanitario, ma pone domande anche a tutti i ‘sani’” P arlano tutti di eutanasia. Chiedo a un’amica, suor C., già medico responsabile di un Hospice a Milano, che cosa ne pensa. Bisogna evitare un approccio emotivo al problema. Se è vero che la vita ci appartiene, è altrettanto vero che il morire è evento della vita e ha diritto di essere assunto responsabilmente da chi lo vive in prima persona. L’eutanasia è il contrario, il risultato di un brutto accanimento diagnostico e/o terapeutico, che spesso è preteso proprio dai familiari che non si arrendono alla morte del loro caro. Sarà. Ma vi ricordo comunque che l’accanimento lo decidete voi medici.Noi al massimo possiamo chiederlo o respingerlo. Nelle mie “disposizioni di fine vita” chiedo, al posto dell’accanimento, l’aggattimento terapeutico: ovvero meno macchine e più coccole. Bella battuta. Ma perché l’ha messa nel “testamento biologico”, cioè nelle “disposizioni di fine vita”? Non sa che, finché non ci sarà una legge a dargli 60 potere nei confronti dei sanitari, resterà un pio desiderio? L’ho rivolto innanzitutto ai familiari. Ho nominato un figlio “sostituto fiduciario” nei confronti di chiunque dovrà occuparsi di me durante una crisi grave. Dell’Antea mi fido: non mi terrete in vita a tutti i costi, mi aiuterete a morire bene, rispetterete le mie volontà. Ma negli ospedali non va così.È importante che quanti più malati facciano il testamento biologico per far capire ai medici che non possono decidere tutto da soli.L’accanimento protegge solo chi lo fa, lo rassicura di aver fatto tutto per mantenere in vita il malato senza chiedergli se era quello che avrebbe voluto nei suoi ultimi giorni. Con Gianni ci siamo conosciuti tre anni fa a un convegno dell’Istituto nazionale tumori. Ricordo che distribuì un volantino e ci sottopose il caso di un’amica cieca e malata di Sclerosi laterale amiotrofica che gli aveva chiesto di aiutarla a morire. Quell’amica è per caso la persona in carrozzina che stava uscendo dalla stanza? Sono convinta che, se ci fossero più équipes e Hospice come questo dell’Antea, magari finanziati dal Fondo per i non autosufficienti, e fossero approvate le norme sul testamento biologico, non ci sarebbe bisogno di eutanasia. Che c’entra poco con le cure palliative e gli Hospice, anche se sta al centro del dibattito politico, troppo emotivo e ideologico. Meglio parlare dell’accanimento e dei modi per evitarlo. Interviene un’infermiera: Noi dell’Antea all’accanimento contrapponiamo competenza, qualità e passione. A volte ci arrivano malati con piaghe incredibili, buttati fuori dagli ospedali. Qui non si abbandona nessuno. E non facciamo business. La morte di Piergiorgio Welby ha risollevato il dibattito sulla eutanasia, con schieramenti pro e contro.Voi operatori dove vi collocate? Primo infermiere: Dipende. Se con eutanasia s’intende l’omicidio o il suicidio assistito di un paziente, come nel caso del signor Welby, allora siamo contrari: nel senso che qui non la pratichiamo, né ci è richiesta. I malati che altrove sono ricorsi a tali soluzioni sono persone in stato di abbandono o, come il signor Welby, impegnate in campagne ideologiche. Qui non si è mai abbandonato né strumentalizzato alcun paziente. Prima infermiera: La campagna fatta dai Radicali per depenalizzare il reato di chi assiste un aspirante suicida è legittima. Non capisco infatti perché una persona possa suicidarsi mentre, se non è in grado di farlo da sola, si debba incriminare chi l’aiuta. Ma è una campagna che va chiamata con il suo nome: suicidio assistito. Chiamarla eutanasia è un errore. fine vita Sì, è lei. Oggi è una bella eccezione alle statistiche sanitarie che la vorrebbero spacciata ed è venuta a trovarmi. Cerco anch’io di sfuggire alle statistiche dei malati di cancro. Ce la metto tutta per riuscire a sensibilizzare i sani e a cambiare la situazione dei malati negli ospedali e negli ambulatori. Secondo infermiere: Sì, perché la vera eutanasia la facciamo qui, recuperando il senso originario della parola. Eutanasia non vuol dire “uccidere senza dolore”, vuol dire “morire bene”. Nell’Hospice e al loro domicilio noi facciamo morire bene i malati. Cioè pratichiamo le cure palliative. Innanzitutto per aiutarli contro il dolore inutile: è il primo sintomo da eliminare con medicine adeguate, a base di morfina. Il ministro della Salute ha insediato una commissione “sulla terapia del dolore, le cure palliative e la dignità di fine vita”. C’è una vostra collega dell’Antea. Quando ascolterete anche i malati? Seconda infermiera: Molti pensano che le cure palliative si riducano al dolore, che è un sintomo e non una malattia da curare solo nell’Hospice. Sarebbe bene che l’alleviamento dei dolori psico-fisici cominciasse prima, nei reparti e ambulatori in 61 cui si accolgono i malati oncologici. Le cure palliative potrebbero così indirizzarsi verso la prevenzione e la cura delle altre forme di sofferenza di origine non psico-fisica ma organizzativa, sociale: cioè spirituale, nel senso di non corporea. Ma anche verso la ricerca e la valorizzazione delle residue risorse dei morenti come lei. Terzo infermiere: Veramente si discute più in tv. Il dottor Melazzini, in carrozzella perché 62 colpito da Sclerosi laterale amiotrofica, come “guaritore ferito”, cioè medico passato dall’altra parte, ha criticato Riccio, il medico che ha staccato il respiratore a Welby: “Non basta attuare la volontà del paziente in modo burocratico. Bisogna ascoltarlo e prenderne in carico i bisogni reali, condividendo un lungo percorso”. Lui ha creato una associazione di malati di Sla. Se lei la farà con i malati di cancro alla prostata forse sarà ascoltato. n Testo dell’intervista nel documentario “Intorno alle ultime cose” realizzato nel 2007 dalla regista Francesca Catarci e trasmesso il 12 giugno 2008 su Rai Tre nell’ambito del programma Doc3. Il documentario è visibile nell’archivio Rai su internet (www.rai.tv) S ono ricoverato in questo luogo che si chiama Hospice. Se resisto e se ancora ho qualche chance di farla diventare da una disavventura un’opportunità, qual è il mio stile di vita di fronte alle esperienze negative, lo devo al fatto di essere qui. Penso, spero, in questa situazione di riuscire a morire vivo, non di arrivare pre-morto alla fine, ma di arrivarci vivo. E questa secondo me, per ora, è una speranza che posso alimentare solo qui. Hospice ce n’è pochi in Italia, ma sono quei luoghi dove si coltiva una cultura diversa, che è la cultura dell’assistenza, del prendersi cura dei malati – sempre di più – dichiarati “inguaribili”. Spesso si parla di quelli oncologici, come me, che una volta venivano abbandonati perché rappresentavano la sconfitta della medicina; ma siccome stiamo diventando una maggioranza – come un po’ nei sindacati, continuano a dire sindacati dei lavoratori ma sono sindacati dei pensionati – così qui noi siamo la maggioranza: i malati sono cronici. Soltanto che rimangono due tabù rispetto a questa realtà: da una parte il tabù degli errori, fine vita La speranza di morire vivo che è un tabù eccezionale – perché i medici hanno così paura di affrontare il discorso degli errori? – l’altro è la morte. Questo della morte, che poi è il più grande errore che fanno, secondo loro, quello di lasciarci morire (come se non dovessimo tutti morire: è un dovere biologico, sociale). Paura della solitudine Perché c’è chi chiede l’eutanasia? Non è la morte in sé che fa paura, normalmente. Non è la paura del dolore, quella che copre tutte le altre. No, perché oggi si può essere curati anche dal dolore. Oddio, se sei fortunato, se capiti qui. Se capiti in ospedali, anche di eccellenza, può darsi che al dolore della malattia aggiungano quello delle piaghe. Io sono qui da sei mesi e non ho una piaga. Voglio dire, c’è tutta una lotta da fare sul dolore, sul fatto che siamo tra gli ultimi Paesi che usano la morfina, ma queste cose si sanno. Per andare proprio al sodo, qual è la vera paura? La paura della solitudine, l’abbandono. Allora, sono sempre più convinto che ognuno muore come ha vissuto: se hai seminato molto, raccogli molto. E cosa 63 raccogli? Relazioni. Sono convinto sempre di più che la vita è relazione, che la cura è relazione, che il 75 per cento delle cure terapeutiche sono fatte di relazioni terapeutiche, il 25 per cento poi è biologia, tecnologia, farmacologia, statistiche. Seminare relazioni Perché se tu medicina, tu medici, sai – o dovresti sapere – tutto sulla malattia, sulla singola malattia, sulla mia malattia, su come io la vivo e la soffro sono io l’unico competente, o no? Allora o è un confronto, una trattativa, uno scontro tra due competenze, o l’una riconosce l’altra, oppure non è scienza la medicina. Una paura che invece non ho, fin da adesso, è che – nonostante la pesantezza del male – io penso, spero, di avere garantita una tale rete di rapporti, di relazioni, di affetto che mi aiuterà a morire come spero io. Silvia mi chiedeva prima: ‘Allora dettami se non riesci a scrivere’. Bene, io vorrei morire scrivendo. Già questo mi consola e mi obbliga, mi aiuta a non approfondire più di tanto la ricerca stupida – la definisco ‘stupida’ perché mi fa soffrire – di cosa saranno i sintomi della mia morte: se sarà la stipsi o se sarà la difficoltà a respirare. Chi se ne frega: voglio essere lucido, però non voglio essere lucido al punto tale da prevedere tutto. No, qualcosa deve rimanere misterioso. Che cosa significa allora avvicinarsi alla morte, avere la consapevolezza di questo percorso? Da una parte tutte le mattine sempre più mi chiedo: che giornata sarà oggi? Varrà la pena 64 di essere vissuta? Sento subito questa stanchezza preventiva, la stanchezza di vivere, che mi condiziona e mi lascia un po’ in sospeso; dall’altra parte, però, contemporaneamente – e a volte, poi, subentra e mi fa vivere molto meglio – sorge una domanda e una sensazione di questo tipo: sarà un altro momento di ‘soddisfazione’, di pienezza, che andrà a riempire la mia vita? Tanto è vero che io sono arrivato a ridurre tutti i miei progetti, perché è un fatto non soltanto di tempo (i miei tempi ormai si sono ridotti a tempi soggettivi, la nozione di tempo oggettivo mi è sparita); allora in questo aspetto soggettivo del tempo, che sento piano piano restringersi, vorrei salvare un progetto. È un progetto bello, vero, vivificante ed è quello di riraccontare la mia vita alle nipotine. Essere capace di rivedere tutta la mia vita nei suoi tre grumi – infanzia, maturità, malattia – raccontandola però a loro. E sarebbe anche il modo migliore da una parte di essere semplice e vero, perché con i bambini non puoi che essere autentico e se non ti capiscono te lo dicono e se dici una bugia a maggior ragione; dall’altra di aiutarle, di aiutarmi a perdermi, a lasciarmi andare. L’altro polo è quello, paradossale, del rapporto con la persona più anziana che oggi esiste nella mia vita, cioè mia madre che ha quasi 93 anni. Il bello è che l’altro giorno se n’è uscita in questi termini, dice: ‘Gianni tu non preghi, non hai chiesa, non ci credi a dio però non sei cattivo sei buono, sei tanto buono fine vita Insieme alla madre Mariolina sul lungomare di Anzio (2000) che secondo me andrai in paradiso’. Ho detto: ‘Vabbè mamma se vuoi, anche se preferirei l’inferno dove c’è gente più interessante…’. A parte gli scherzi, la cosa importante invece è questa. A un certo punto se n’è uscita dicendo: ‘Tu andrai in paradiso, ne sono convinta. Tanto è vero che quando poi morirò ti verrò a cercare in paradiso perché tu mi faccia da guida’. Non so se mia madre se ne è resa conto sino in fondo, ma questo è stato un bellissimo segnale che mi ha dato, nel quale mi ha già detto che ha colto il mio stato ed è disponibile ad accettare che io muoia prima di lei, togliendomi da una prospettiva di sofferenza – Come faccio a dirglielo? Come faccio a morire prima di lei? A farle vivere questa vergogna di sopravvivere ai propri figli? – ecco adesso sono più sereno. Quando è che sono diventato morente? Guardate, apparentemente non era cambiato niente, non avevo nemmeno la gamba gonfia; però ho cominciato a sentirlo. Io partivo da questa ricerca di autenticità e nel sentirmi io stesso più autentico. E ho colto immediatamente che questa bella, importante situazione umana però è la riprova che stai morendo. Potrei morire adesso È come se fosse successo uno scatto: è bello, lo vivrai una volta sola, però è un gradino in più che fai nella discesa ineluttabile. Questa duplice consapevolezza mi porta a volte a dire: oh come potrei morire adesso, oggi, in questo momento, bello. Però poi mi accorgo che la realtà è “rugosa”, come diceva Pavese, cioè non puoi anteporre i tuoi desideri alla realtà, non puoi confondere i tuoi sogni con la realtà, nemmeno nel modo e nei tempi della tua morte. n 65 Faccio parte della minoranza (37% dei malati) che sa la diagnosi, e di quella ancora più esigua (12,5%) che sa anche la prognosi. Anzi, sono forse uno dei pochi malati non ricchi e potenti che non solo le conosce ma cerca pure di contrattarle con i curanti: una specie di mozzo che, attraverso i raggi, congiunge vari specialisti che gli ruotano intorno ma non comunicano tra loro; aspiro a diventare un onco-sindacalista o sindacalista oncologico. Anche perché ho cercato di organizzare i malati come me, restii a dichiararsi e riottosi a impegnarsi “(Gli Assiri) non avendo medici portano sulla pubblica piazza i loro infermi. Chi si avvicina al malato esprime un parere sulla sua malattia, se per caso ha avuto gli stessi sintomi o se ha saputo di qualcuno che li abbia avuti. Dunque si accostano per dar consigli e ciascuno esorta a fare ciò che lui stesso ha fatto o visto fare a un altro per guarire da una analoga affezione. Non è consentito passare oltre in silenzio senza chiedere all’infermo di quale malattia soffra” Erodoto (“Le storie”) comunicazione Per una “validazione consensuale” in ospedale Due per sapere, due per curare C’è bisogno di costruire una bioetica quotidiana Un terreno comune di ascolto attivo Il dito di Caravaggio nella piaga della ricerca 69 74 86 88 92 67 La famiglia Grassi durante una vacanza in Puglia (1977) Dalla tesi del Master in bioetica (gennaio 2004) P erché questo tema? Ancora mi meraviglia constatare che si è venuta configurando una bioetica “di frontiera” nella quale “si privilegia il riferimento ai casi che rappresentano situazioni limite” (Azzone, 2003), come “riflessione specifica nata dai cambiamenti indotti dalle innovazioni tecnologiche”. Temo che, concentrando l’attenzione sugli estremi, si trascuri il centro della curva: la relazione medico paziente, esperienza quotidiana e di massa. Così ordinaria, nella sua drammaticità, da essere considerata “naturalmente” connaturata al progresso della medicina. Senza che se ne percepisca lo spessore bioetico, se non saltuariamente, per vicende personali o tragici errori o sensibilità di artisti. Perché questo titolo? Avrei potuto parlare di “consenso informato”, di più facile comprensione, inducendo però un’interpretazione riduttiva delle mie intenzioni: invece di stimolare domande avrebbe potuto favorire risposte scontate. Chi ha sentito parlare del consenso informato o ne ha fatto diretta esperienza in ospeda- comunicazione Per una “validazione consensuale” in ospedale le crede di sapere di che cosa si tratti: un modulo, più o meno lungo e complicato, che ti fanno firmare dopo averti spiegato l’intervento che stai per subire. A volte senza nemmeno spiegartelo, a volte dopo che l’intervento è stato effettuato. Comunque, nell’immaginario collettivo, è necessario forse più ai medici che ai malati. Una relativa novità, certo, ma davvero importante? Ebbene sì, è importante. Perché è l’occasione che ha il paziente, a volte la prima, a volte l’unica, per fare domande: tanto più ampie, numerose e approfondite quanto più si sia preventivamente preparato. Sembra un paradosso, invece è la semplice realtà: ai medici puoi chiedere e dai medici puoi ricevere maggiore e migliore informazione, quanto più e meglio ti sia già informato, da colleghi di corsia o di sventura, libri, riviste, radio-tv, internet. Magari da altri medici e infermieri, se è cominciata la transumanza da un istituto all’altro. Il consenso informato può ricondursi a un pezzo di carta o a un puzzle di parole, due aspetti di un rapporto funzionale. È solo un anello, a volte il 69 primo, della catena comunicativa tra curanti e curati, che non si esaurisce in esso ma richiede preparazione e continua manutenzione, fatta di ascolto, attenzione, comprensione reciproca e verificata, basata su osservazioni oggettive e valutazioni soggettive. Un po’ come è avvenuto in fabbrica sulla nocività, tra operai e tecnici al servizio dei proprietari, nella stagione che va dagli anni ’60 alla nascita dei consigli, fino alla conquista delle 150 ore da dedicare allo studio e pagate come lavoro. Ecco perché, per rifarmi in modo esplicito a un’esperienza operaia così definita dai tecnici al servizio dei lavoratori, ho preferito parlare di validazione consensuale. Per capire quella vicenda bisogna rifarsi al 1977. Dopo quell’anno, la spinta propulsiva è andata scemando tanto da essere dimenticata. Sono cambiati infatti, in modo repentino e apparentemente irresistibile, i rapporti sociali di produzione e di riproduzione: all’unità e alle solidarietà diffuse, magari un po’ superficiali, si sono sostituite le diversità e le soggettività, la precarietà e il mercato. Nel 1977 uscirono due testi, uno dal versante medico (Oddone, Re, Briante) e l’altro da quello sindacale (Oddone, Marri, Gloria, Briante, Chiattella, Re), curati dallo stesso gruppo di tecnici che nei primi anni ’60 aveva cominciato a collaborare con gli organismi sindacali più sensibili al problema. Dopo anni di studi e proposte, nel 1967 era nato un “modello di questionario di grup- 70 po” per le indagini ambientali. Ma fu nel 1969, grazie anche a un sindacalista ex operaio con una conoscenza precisa di molti processi produttivi, che esso divenne una preziosa dispensa informativa e formativa, “per risolvere in fabbrica questo problema fondamentale: permettere la comunicazione nei due sensi, dai medici agli operai e dagli operai ai medici”. Non è forse lo stesso problema, tuttora irrisolto, che si pone in ospedale tra medici e malati? La “non delega” La dispensa analizzava i fattori nocivi dell’ambiente di lavoro: quelli generici e quelli tipici della produzione, la fatica fisica e quella psico-fisica ormai prevalente. Alla tendenza padronale di modificare gli strumenti senza cambiare le condizioni di lavoro nocive, contrapponeva quella operaia: modificare l’ambiente e il modo di produzione per controllare ed eliminare la nocività (Berlinguer, 1969). Rivendicava un protagonismo operaio nella ricerca scientifica, con strumenti di controllo alternativi e senza la delega a medici, psicologi e igienisti, utilizzabili come confronto e conforto. La “validazione consensuale” e la “non delega” – affermava – “non si realizzano spontaneamente. All’interno della fabbrica il sindacato deve: individuare i gruppi operai omogenei, fornire i modelli di analisi della realtà ambientale, strutturare su questo modello l’informazione raccolta dal gruppo in termini di osservazione spon- cura e d’informazione sulla nocività di una sostanza. Da allora si è sviluppata la ricerca epidemiologica e sono cominciate a cambiare le domande ai medici, che spesso però continuano a fornire risposte inadeguate. È stata una prima esperienza di collaborazione e confronto con i tecnici aziendali, le loro diagnosi, le loro soluzioni, ma insieme di sperimentazione di quelle elaborate dagli operai. comunicazione tanea, utilizzare i questionari, verificare attraverso la validazione consensuale i momenti della nocività vissuti come fondamentali dal gruppo, ricercare col gruppo le soluzioni, costruire nella contestazione e nella contrattazione il sistema di controllo permanente”. Dunque, il problema della nocività si pose prima di tutto come problema di comunicazione. Si passò da linguaggi e modelli elementari ad altri più articolati e condivisi. E non mancarono i risultati: lo “Statuto dei diritti dei lavoratori” nel 1970 sancì il principio della “non delega” nel processo di ricerca, controllo ed eliminazione delle cause di nocività; nei rinnovi contrattuali andò diminuendo l’aspetto compensativo, la “monetizzazione” della nocività, il contrario di quello che avviene oggi. Ne risentì anche la ricerca sugli infortuni e le malattie professionali, quasi ferma agli studi di Ramazzini del ’700. Lo stesso Servizio sanitario nazionale basato sulla Usl (oggi Azienda sanitaria locale), tradotto in legge nel 1978, viene da quella esperienza che ha in parte modificato i modelli della medicina legale e di quella del lavoro, dell’igiene e della psicologia: i cui manuali insegnavano modi di operare che escludevano la partecipazione dei lavoratori, ai quali erano inutili sia per il linguaggio che per l’impostazione settoriale. I medici del lavoro non avevano rapporti con gli operai se non in corsia: la struttura deputata a rispondere alle richieste di Competenza ignorata Non è forse la stessa esperienza che si proponeva con i “gruppi di autocoscienza” femministi, che si è riproposta con i primi gruppi omogenei di self help tra malati da cui sono nate le loro associazioni, che riemerge quotidianamente tra scienza del medico, che sa o dovrebbe sapere tutto o quasi sulla malattia, e scienza del malato, l’unico a sapere come vive e soffre la malattia? Eppure questa competenza è ignorata, né trova posto nel consenso informato. Peraltro, il percorso degli operai per creare rapporti che producessero un nuovo modello di conoscenza, non è stato facile né lineare. La sequenza potrebbe essere riassunta così: all’inizio si notava unicamente, spesso passivamente, la relazione tra nocività e salute, magari per riuscire a monetizzarla; poi sono cresciute le denunce delle condizioni di lavoro in fabbrica insieme al rifiuto dei compromessi. Attraverso tentativi autonomi di soluzione e migliori rapporti con i tecnici, le proteste hanno cominciato a 71 tramutarsi in proposte, anche di metodo, sul controllo delle condizioni ambientali e di salute: si è così imparato che senza conoscenza non c’è controllo e viceversa. Solo a questo punto si è capito il valore dell’esperienza e del patrimonio di osservazioni del gruppo operaio omogeneo, da tradurre in lingua e scienza condivise con i tecnici, per puntare al controllo etico e scientifico dei modi di produrre e della produzione: di beni benefici o malefici? Di vita o di morte? Un modello alternativo Si è acquisito che non si poteva eliminare la nocività da lavoro se non si cambiava l’organizzazione del lavoro molecolarmente, giorno per giorno: sia recuperando esperienza e responsabilità come lavoratori, sia riappropriandosi della scienza dei tecnici e aiutandoli a recuperare la propria coscienza. Un modo diverso di fare scienza e di comunicare. Si cominciava a capire che il gruppo operaio omogeneo possedeva un patrimonio culturale, la storia epidemiologica del medesimo ambiente e della medesima nocività, che sopravvive alla variabilità dei componenti se si trovano le forme di trasmissione. Diventava necessario elaborare, attraverso la validazione consensuale, un modello di malattia alternativo e complementare a quello dei tecnici, collegando elementi dell’ambiente e disagi psico-fisici individuali e collettivi. Insomma, il processo di validazione consensuale, per non restare un 72 anelito di conoscenza, avrebbe dovuto coinvolgere diagnosi e prognosi, analisi critiche e autonome proposte. Ma non ci si è arrivati. Quando sembrava che le gocce sospese stessero per precipitare in una pioggia rinfrescante, l’esperienza si è rappresa in nebbia opaca. Perché? Sarebbe stato possibile continuare sulla strada intrapresa se all’esterno si fosse costruito un sistema conoscitivo e organizzativo coerente con quello proposto e a volte attuato in fabbrica? Sarebbe bastato “esportare” la propria esperienza di soluzioni, senza riproporre quella di metodo, il processo di cambiamento? Sta di fatto che, anche se il modello di analisi era valido (“la nocività è una, come unico e indivisibile è l’uomo nel momento in cui patisce il danno”) la sua attuabilità si è rivelata più ardua del prevedibile. Nel frattempo la fabbrica e gli operai sono cambiati, ma in altra direzione. Un grande antropologo medico si è chiesto: “Possiamo difendere seriamente un atteggiamento epistemologico – ed etico – che non privilegi le pretese di conoscenza proprie della biomedicina e delle scienze biomediche?” (Good, 1999). Da piccolo “antropologo paziente”, ancor troppo ignorante e forse un po’ impaziente, mi chiedo: è ragionevolmente sostenibile l’ipotesi che il modello della validazione consensuale, adeguatamente rivisto e rivitalizzato, si addica all’ospedale? Il consenso informato potrebbe costituirne la chiave di Danza comunicativa Forse, ma con un’avvertenza: gli operai non avevano bisogno di tecnici amici o compagni, che li aiutassero a recuperare la loro soggettività, così ai malati non servono medici amici o compagni, bensì operatori capaci di osservare e ascoltare, informare e comunicare, consapevoli che si è “due per sapere, due per guarire”: curanti e curati. La danza comunicativa comprende anche il consenso informato, purché non si riduca a balletto liturgico. La fiducia reciproca è l’elemento che rende reale la partecipazione. Altrimenti ogni singola responsabilità viene annegata in un’astratta e irreperibile responsabilità sociale. n comunicazione accesso in questa istituzione “totale”, che la “forza d’animo” oggi può aprire e denudare? 73 Due per sapere, due per curare Dalla “lezione” tenuta il 16 febbraio 2004 all’Istituto di Urologia del Policlinico universitario di Padova M entre festeggiavo con amici la conclusione del Master in bioetica alla “Sapienza”, dove ho discusso una tesi su la validazione consensuale in ospedale, parlavo della “lettura” che avrei tenuto ai miei curanti sulla comunicazione tra medici e pazienti. Uno ha detto: “Ma, non c’è un conflitto d’interessi?”. Ho ripensato a questa battuta: no, non c’è conflitto, abbiamo lo stesso interesse, la miglior salute possibile. Casomai potrebbe esserci un conflitto interno, tra il mio essere un paziente e un ricercatore: da una parte, riconoscente (perché mi è stata salvata la vita) e sofferente (l’ansia per la recidiva, insomma il dover convivere con la malattia). Dall’altra, insofferente dei ritardi, delle superficialità, degli errori comunicativi. Ma a ben guardare è piuttosto una contraddizione vitale tra il mio bisogno naturale come paziente di credervi, darvi fiducia, e quello culturale – come sociologo – di criticarvi, diffidare delle vostre manchevolezze e delle mie stesse debolezze. Di più. È una tensione che mi accompagna da quando vi frequento come paziente un po’ speciale. 74 Cioè un ricercatore che ha recuperato nei vostri confronti la competenza e l’identità professionali preesistenti alla malattia, e insieme un paziente che nella comune esperienza con voi ha rielaborato una competenza e un’identità più mature. Attribuisco al rapporto terapeutico il fatto di sentirmi bene, tanto da avere il coraggio di venirvi a parlare, nonostante le difese immunitarie calate e il marcatore tumorale in crescita. Vorrei che vi rendeste conto, come prima cosa, che l’invito a tenere questa conversazione e la disponibilità ad ascoltarmi in quanto paziente (magari parziale e indisponente), ha costituito una medicina straordinariamente efficace nell’aiutarmi a dare un senso anche alla malattia, a farne un’opportunità di ricerca, dunque di vita. L’invito ha contribuito a sollecitare le mie risorse interne, a rinforzarmi nella scelta – anomala e apparentemente futile alla mia età – di allargare i miei interessi all’etica e alla biologia. Da questa stagione di studi vi riporterò alcune domande, proposte e consigli. Comincio con questi. comunicazione Con il figlio Lorenzo in braccio (1968) Il primo è un film, tanto bello quanto sconosciuto, del regista Mike Nichols e con Emma Thompson: “Wit” (forza di spirito e senso dell’umorismo, ma tradotto “La forza della mente”). Narra il dramma di una docente universitaria, dalla diagnosi di cancro alla sua morte in ospedale: dramma di una persona ma, insieme, della mancanza di comunicazione tra medici e pazienti. Il secondo consiglio riguarda quattro libretti. Quattro libretti Fra le tante pubblicazioni che invadono gli scaffali delle librerie, ho scelto queste per l’esiguità delle dimensioni e la ricchezza dei contenuti. Di una ho già fatto dono ad alcuni di voi perché è preziosa: si intitola “Medici impazienti. Cinque storie americane su medicina e morale”. Non si trova facilmente. Le altre due sono: la prima sui rischi e gli errori, “Per un ospedale sicuro”; la seconda “Chi deci- de in medicina”, uno dei testi più chiari finora scritti sul consenso informato. L’autore, Sandro Spinsanti, lo presenta così: “Questo libretto è dedicato ai medici che hanno poco tempo... L’etica ha molto da dire sul profilo che deve assumere la nuova relazione terapeutica. Ma non saranno gli esperti di etica a realizzarla: gli artefici potranno essere solo i professionisti sanitari. Questo sapere pratico è loro”. E i malati? chiedo io. Infine, la splendida “Lettera a un medico sulla cura degli uomini”, scritta da Giorgio Cosmacini, storico della medicina, e Roberto Satolli, giornalista scientifico, che dovrebbe essere fornita a tutti i giovani medici. Il terzo e ultimo consiglio è, in un cd realizzato dalla cantautrice Luisa Rossaro, la canzone “Vede, dottore…”. Questo il testo: Scusi, infermiera / aspetto da due ore, / non son la sola / con me c’è almeno una trentina di persone / tutte col ticket pagato / 75 tutte con la prenotazione, / io non vorrei sembrarle scortese / ma ogni minuto, qui dentro sembra un mese. Signor dottore, / lei è davvero ben gentile / a visitarmi / con tutto quello, tutto quello che ha da fare, / magari potesse farmi la cortesia / di chiudere la porta dello studio / finché son senza, sono senza biancheria. Vede, anche il dolore / diventa niente / in mezzo a questo andirivieni di gente, / vede, sono io, sono io con il mio male / questo corpo che lei deve visitare. Grazie dottore, / è stato molto chiaro / e il suo ospedale / è una struttura efficiente, efficiente e funzionale, / solo che io / mi sento come una barca nelle onde, / tutti mi parlano / ma non c’è mai nessuno che davvero mi raggiunge. Vede, la malattia / non è un incidente, / occupa gli angoli più scuri della mente. / Vede, dottore / dietro i pensieri sciocchi, se si fermasse / vedrebbe i miei occhi. Angoli scuri della mente La canzone ci dice che l’informazione non è tutto. Ci ricorda che, se è vero che la salute è oggi soprattutto informazione e consapevolezza, il consenso informato è solo un passo, importante ma non esaustivo, della danza comunicativa. Nella quale non bastano le virtù, la sensibilità umana, e non è tanto questione di tecniche. È solo una canzone, ma si sente che è vissuta, viene da un’esperienza personale. Così come i pazienti sentono se di fronte a loro sta un medico pervaso di onnipotenza, oppure dotato di quella maturazione personale che – come 76 scrivono Cosmacini e Satolli – “passa anche attraverso la cognizione del dolore, della sofferenza e della morte”. Uno di quelli che il filosofo Gadamer ha chiamato i “guaritori feriti”, cioè i curanti consapevoli “della comune matrice umana, corporea e mortale, che unisce, al di là dei ruoli, medico e paziente”. Io ne ho trovato traccia in alcune testimonianze. Per esempio, il giornalista Gigi Ghirotti, raccontando il suo viaggio “nel tunnel della malattia”, ha detto l’amara esperienza d’un amico primario ricoveratosi in corsia. Oppure il film “Un medico, un uomo”, con William Hurt nella parte di un altro primario che, una volta diventato paziente, cambia drasticamente l’organizzazione del reparto. Di “guaritori feriti” ne ho incontrati alcuni in carne e ossa. Anche qui. Eppure sarebbe mostruoso dover attendere che, per riuscire a comunicare con un malato, il medico si ammali e sappia che cosa significa avere un cancro. Quella consapevolezza può e deve passare anche attraverso un percorso di maturazione fatto di una diversa formazione, una pratica clinica più completa, una versione aggiornata del famoso binomio “scienza e coscienza”. Al quale, piaccia o non piaccia, corrisponde sempre meno quello di un paziente capace solo di incoscienza e riconoscenza. I malati, a loro volta, ha scritto Virginia Ciuffini, dovrebbero essere “feriti guaritori” e sono mediamente meno profani e più proclivi alla pretesa che all’attesa. Capita più spesso con l’ingresso dei media nella informazione sanitaria s’è fatta triangolare. E voi medici dovreste fare anche i divulgatori, educarci ad autoeducarci, per non rimanere autodidatti forzati. Tanto più che il modello della malattia come parentesi chiusa dalla guarigione, cui corrisponde il malato che “comincia a guarire quando obbedisce al medico”, funziona solo in una minoranza di situazioni, le acuzie. Ormai, il 70-80% di tutti i ricoverati hanno più patologie. E nell’80% dei casi la “guarigione” è quella sufficiente per continuare a vivere, cioè a convivere con una malattia cronica: cui corrisponde il medico “montessoriano” che aiuta il malato a curarsi da sé: grazie all’ascolto attivo e terapeutico, reciproco. comunicazione che all’arroganza comunicativa, che da sempre contraddistingue il paternalismo medico, peraltro fondata sulla rassegnazione comunicativa dei malati, vengano a contrapporsi atteggiamenti speculari. Col rischio di copiare dagli Usa la prospettiva di avere più avvocati che infermieri al capezzale. Domandiamoci: c’è forse, nella pressione che emerge dalle corti di giustizia, nel magma che rischia di bruciare le speranze di comunicazione tra medici e pazienti, un qualche bisogno atavico di resa dei conti? Forse sì, è probabile, non vale nasconderselo. E allora, come si fa a comunicare, a intendersi senza litigare tra “camici & pigiami”? Come ho scritto nella Lettera a un ospedaliere pubblicata nel libro “Assenza, più acuta presenza”, occorre che impariamo anzitutto a comunicare con noi stessi, come persone e come categorie. I camici, chiamati a fare i conti con il tabù degli errori e il mancato confronto con gli altrui pareri, a cominciare dagli infermieri. I pigiami, chiamati a dar conto della propria ignoranza, che idolatra i dottori, passando da “amore e timore” al rancore. Uno dei paradossi della comunicazione è che l’ipercontrollo biomedico e amministrativo induce la perdita di controllo complessivo dell’iter di cura. Mentre il paziente ha un’esigenza di affidamento fortissima che però non è disposto a concedere a priori, il medico per negoziare la fiducia avrebbe bisogno di molto tempo che però l’azienda non concede. Soprattutto oggi che la relazione si è allargata: Cronici e acuti Eppure il problema dell’assistenza ai malati cronici e a quelli non autosufficienti è ancora trascurato da una medicina alla ricerca di prestigio personale e gratificazione economica e da una struttura della spesa notevolmente sbilanciata verso la componente per malati acuti. Non solo. Se è vero che l’informazione è circolare e il paziente non è un vaso da riempire, è pur vero che quando ci ammaliamo regrediamo, fisiologicamente e psicologicamente. Torniamo neonati, pieni di ansie e aspettative, a volte di terrore, bisognosi di aiuto e protezione. Possiamo recuperare, certo, ma all’inizio e in ogni ricaduta è proprio così. Voi sapete bene che non c’è peggior sordo di chi soffre e ha paura e che 77 il non detto condiziona il risultato della consultazione. Inoltre, c’è anche la vostra fragilità, la fatica dei tecnici. Uno psichiatra, dopo aver intervistato molti medici, ha individuato un altro paradosso: “Fare il medico aumenta la paura di morte e questa paura la si attenua facendo il medico che guarisce”. Il “British Medical Journal” ha aperto un dibattito: “Perché i medici sono tanto infelici?”. La risposta più diffusa è stata la cosiddetta sindrome del criceto, la sensazione di “dover correre sempre più in fretta per rimanere fermi”, ovvero “la divaricazione tra gli obiettivi per cui i medici sono stati addestrati e ciò che i pazienti si aspettano da loro”. Sindrome del criceto Ricerche svolte in Svizzera, paese con una medicina efficiente (per esempio: sugli “Annals of Oncology” si legge che il tasso di sopravvivenza per il tumore alla prostata lì arriva al 71,4% rispetto al nostro 47,4), rivelano che i medici locali, per sé e i familiari, ricorrono al chirurgo assai meno di altre categorie, e addirittura che la frequenza dei suicidi tra loro supera del 70% la media della popolazione. Possibile che l’efficienza abbia questi costi? I risultati della medicina vanno valutati da due versanti: le risorse investite (l’efficienza) e gli obiettivi (l’efficacia). L’obiettivo della sopravvivenza dei malati può prescindere da quella dei curanti? Ma lasciamo le domande e veniamo alle proposte. Siccome resta poco tempo, non tratterò una serie di aspetti che è 78 quasi scontato collegare alla comunicazione per soffermarmi su quello, assai meno scontato, su cui ho chiesto di titolare questo incontro. Mi limito a citarli, sempre visti dalla parte del paziente, il secondo di cordata. Alla base di tutto ci sono la formazione e il linguaggio. La prima è carente, spesso ancora assente sul piano bioetico e comunicativo. Occorre migliorare innanzitutto quella universitaria, certo. Ma secondo me non esistono un luogo e un tempo deputati alla formazione: bensì è nella pratica clinica, in quella ospedaliera in particolare, l’esperienza continua di formazione. È qui, nel contatto e nell’ascolto quotidiano, che potreste e dovreste rimediare al vuoto curricolare. Qui, dove la formazione o è reciproca, cioè vostra e dei vostri pazienti, o non è. Da questo punto di vista il ricovero è tuttora un grande spreco. Anche a causa del linguaggio: il vostro, che dovrebbe essere terapeutico, è un gergo criptico, retorico, usa parole di guerra invece che di consolazione. All’università si impara che “è importante la definizione nosologica di ogni malattia, indipendentemente dalla persona, dal suo vissuto e dal suo modo unico, peculiare e irripetibile di ammalare”. La vostra pratica, che è fatta di poche certezze e molti pareri, nega l’errore e ignora il consulto, il confronto con altri specialisti, medici di base, tecnici e infermieri. Così il nostro linguaggio, quello dei malati, resta misero e dipendente. La nostra comunicazione Preso alle spalle dal famelico e goloso gatto Artù (2000) pratica quella del credente. Di norma siete disposti a riconoscere che i pazienti possiedano, appunto, credenze ma non competenze. Un grande antropologo medico, Byron Good, ha dedicato studi a “come la medicina costruisce i propri oggetti”, cioè “descrive il corpo umano e la malattia secondo tratti culturalmente peculiari”: le pratiche della conoscenza degli studenti di medicina, dice, sono “modi specializzati di vedere, scrivere e parlare” che “formulano la realtà in un’ottica specificamente medica”, cioè biologica. Per esempio: l’anamnesi, centrale nel processo comunicativo, spesso unica occasione di un vero incontro tra medico e malato, si riduce a una prassi sciatta, burocratico/poliziesca e riduttiva, da affibbiare agli ultimi arrivati invece che da affidare ai più esperti nell’arte dell’ascolto maieutico, quello che aiuta il paziente a narrare la sua malattia. Oppure le presentazioni al giro visita, in cui “il soggetto della sofferenza viene rappresentato come il luogo della malattia piuttosto che come agente narrante”, della cui presenza e partecipazione si può anche fare a meno. Ancora, la scrittura della cartella clinica, tuttora affare riservato escludente la comprensione del paziente e la responsabilità degli infermieri. Cartelle escludenti Le stesse perplessità permangono verso il consenso informato. Oggi non viene più considerato “un’americanata che non ci riguarda”, però spesso resta “qualcosa che, nella migliore delle ipotesi, è da aggiungere alle proprie idee e alla propria prassi, ma che comunque non pare scalfirle minimamente”. È vissuto alternativamente come capestro o come copertura legale, cioè scarico di responsabilità; tanto che un noto medico legale sostiene che “bisogne- 79 rebbe addirittura abolire i moduli e imporre, invece, la documentazione di un rapporto reale, di un’informazione precisa”. Per fortuna stanno uscendo sempre più lavori seri, anche per l’urologia, che aiutano a elaborare meglio i modelli. Come ricercatore ho ricevuto materiale informativo eccellente che come paziente non avevo mai conosciuto. Ma, dal punto di vista etico, è essenziale l’effettività dell’informazione, non la sua forma: non ci sono modelli fotocopia di consenso perché non ci sono modelli fotocopia di paziente. Alcune proposte Eccomi dunque alle proposte conclusive. La prima riguarda il controllo e l’analisi dei rischi e degli incidenti, per trattare l’errore non come colpa del singolo ma come sintomo di una disfunzione organizzativa, a volte sistemica. Saper riconoscere un proprio errore è un elemento importante della fiducia che deve alimentare il rapporto terapeutico. Ma saper trasformare l’errore in esperienza è ancora più importante. Il sistema medico americano ha saputo farne “un punto di forza della crescita della pratica clinica”, grazie alle Conferenze settimanali sulle malattie e la mortalità in cui si esaminano le procedure che hanno portato alla morte di un paziente e le terapie che non hanno dato i risultati attesi: nessuno viene colpevolizzato e tutti vengono aiutati a non ripetere gli sbagli. Perché non farle anche qui? La seconda riguarda i rap- 80 porti con i pazienti una volta dimessi: esiti istologici, terapie, indicatori di qualità della vita, informazioni varie e reciproche che a volte sarebbero urgenti. Anche qui si tratta di costruire e mantenere un ponte tra l’unità sofferente, la sua comunità e l’unità curante (per me e per i miei io sono unico, per voi sono uno, uno dei tanti). Già due anni fa, da paziente residente lontano che faticava a comunicare con stabili interlocutori, mi rivolgevo al direttore in questi termini: “La nota efficienza della Clinica Urologica, che ha l’ambizione e il merito di richiamare malati da ogni regione, esige una capacità comunicativa adeguata: chiara, completa e tempestiva. Ritardi e disguidi, come quelli capitati a me, stridono con la felice produttività terapeutica e insidiano l’affidabilità”. Esiste un telefono per certi orari, ma ai pazienti sarebbe necessario un presidio con più continuità e flessibilità degli strumenti comunicativi: una mail reattiva e autorevole; un uso più disinvolto di fax e telefono; un sito internet davvero disponibile che, con le dovute garanzie, consenta e favorisca la collaborazione tra i vari medici curanti. Altrimenti il paziente continua a sentirsi come un mozzo che, attraverso i raggi, congiunge vari specialisti che gli ruotano intorno ma non comunicano tra loro. La terza e ultima proposta si può sintetizzare in modo scherzoso per arrivare a concludere con considerazioni serie: perché non organizzate, non organiz- Cioè di innamorarmi della diagnosi del fenomeno da me elaborata e di non cogliere più i segnali divergenti. È quello che spesso capita anche a voi. Mentre è proprio al dato divergente che bisognerebbe dedicare il massimo di sensibilità e attenzione, cercando di falsificare le ipotesi per vedere se reggono, invece di accanirsi a verificarle, ignorando ciò che le contraddice. comunicazione ziamo, una bella associazione di operati di tumore alla prostata? Esistono enti meritori, ma non ho ancora trovato organismi come quelli cui hanno dato vita le donne operate al seno e le persone “stomizzate”. Una in più farebbe bene a tutti, ai pazienti come ai medici. E spiego perché. Le critiche alla medicina come esercizio di potere si sono concentrate sul medico da due versanti: quello verso i pazienti (“padre padrone”) e quello verso i potenti produttori di farmaci o tecnologie e i gestori di aziende di cura o assicurazione (“servitore di due padroni”). La cultura anti-autoritaria, nell’incontro con quella anglosassone dei diritti e dell’autonomia, ha dato vita al consenso informato. La diffusa istanza di “umanizzazione” della medicina sembra invocare meno tecnica e meno scienza. In realtà occorrono più umanità e più scienza. La vostra scienza va arricchita con il “sapere delle relazioni”, che non è esterno alla professione medica. Il vissuto dei pazienti li fa diversi uno dall’altro e comporta risposte diverse al medesimo protocollo. “L’ostacolo maggiore alla comprensione reciproca consiste nella natura intrinsecamente statistica della conoscenza e ancor più del ragionamento medico”, che fa correre il rischio di trascurare come rumore di fondo informazioni essenziali e di perdere la ricchezza di sapere che ogni caso individuale porta con sé. Inoltre, nella mia esperienza di ricercatore ho compreso il rischio di ridurre le ipotesi, i ragionevoli dubbi, a idealtipi. Una persona intera Un altro rischio che corre il paziente è quello di essere ridotto al dato biologico, alla malattia, se non agli organi colpiti: una volta la vescica, un’altra la prostata; di non sentirsi trattato come una persona intera, dotata di corpo e spiritualità. Si discute sempre più e meglio del “dolore inutile”. Ma la sofferenza va oltre il dolore fisico. L’indifferenza è la causa delle più acute sofferenze di tanti malati come di tanti curanti. Secondo un’oncologa dell’Istituto nazionale tumori, sarebbe necessario raccogliere e incorporare la storia spirituale dei malati all’interno della storia medica standard. “Le opinioni dei medici e dei profani sulle cause e i significati delle malattie sono lontane”; ma “le idee dei pazienti, per quanto divergenti, non sono senza capo né coda; anzi... consentono di dare un senso alla salute e alla sua perdita”. Di più. Se il medico è competente sulla malattia, il malato è l’unico competente a dire come la vive e la soffre, il miglior esperto di se stesso, più di ciò che è in grado di esprimere. 81 Se il malato deve saper imparare dal medico le informazioni sulla malattia e la cura, il medico deve saper imparare dal malato le informazioni su come lui vive la malattia e la cura. Il nostro può diventare un incontro tra esperti con diverse competenze: quella di ascoltare il più possibile senza pregiudizi e quella di definire in maniera il più possibile precisa il proprio malessere. Altrimenti non si spiega la crescita costante di pazienti che si rivolgono ad altri “santuari”, alle medicine non convenzionali. Ma perché? Forse perché in quel contesto curante e curato s’interrogano insieme sul male e la cura? Un paziente che cresce Tuttavia non si tratta solo del mio diritto a essere preso in cura, a essere informato e ascoltato, a esprimermi sul modo in cui vivo la malattia. C’è anche il mio diritto/dovere di contribuire ad accrescere, proprio come paziente, la scientificità della relazione terapeutica. La quale “quando funziona, non produce solo una cura ma anche un sapere, la cui utilizzazione e circolazione non è codificata”, un sapere nuovo, condiviso, prodotto dell’incontro tra competenza disciplinare e sapere di sé. Nella relazione “si gioca la possibilità per la medicina di essere veramente una scienza perché entrano in campo due competenze”. Purché si tengano presenti la disparità di ruoli e la pari necessità di garantire due condizioni: autonomia e ricerca. Autonomia: per riuscire a rispettarla nei malati dovreste es- 82 sere aiutati a riconoscere e recuperare la vostra, innanzitutto nei confronti del mercato della salute. Come ha scritto una dottoressa del gruppo Ipazia nel libro che mi ha suggerito il titolo di questa conversazione: “Alcuni medici hanno rinunciato alla responsabilità di sentire con le loro orecchie e mani e di vedere con i loro occhi, sono diventati esecutori anonimi delle industrie farmaceutiche e dei macchinari diagnostici. Si sono, in una parola, spogliati della loro competenza: come possono sospettare che i loro pazienti ne abbiano una?”. Ricerca: senza spirito di ricerca, si finisce per “appiattire un universo umano su poche regole generali”. Un’altra delle autrici del libro, scienziata del CNR e malata, scrive: “Ho toccato con mano quanto la mancanza di una disposizione alla ricerca renda nei fatti scarsamente scientifica la medicina”: la pratica di includere la persona malata, anzi una sua parte, all’interno di uno schema già prefissato di catalogazione “prescinde dalla relazione come luogo e momento in cui si sperimenta un metodo, un’ipotesi, cioè si fa ricerca”. E aggiunge: “Ho pensato a lungo se, come paziente, avessi anch’io qualche tipo di competenza; la mia vicenda mi induce a credere che esiste. Molti medici hanno scoperto la relazione col paziente, nella quale ci si impone di essere gentili, mostrare disponibilità e comprensione, ascolto, ma il più delle volte ciò si traduce in un modo formale e distaccato di restare comunicazione Insieme al fratello Giorgio (2003) ognuno al proprio posto. Una vera e propria capacità di lettura relazionale, importante tanto quanto quella chimico-fisica, e una propensione per la ricerca, è un patrimonio scientifico di pochi. La disumanizzazione in campo medico non è frutto di un eccesso di scientificità, bensì di un difetto. Sperimentare, decidendone i criteri, mettendo alla prova le proprie conoscenze, affinché queste riescano a contenere anche quel caso unico, che non è solo sintomi, ma un insieme di vissuto, memoria, esperienza, che proviene da un passato e che avrà un futuro, significa trovare le parole per dire ciò che spesso già avviene nella pratica clinica. Trovato il modo di dirlo, è possibile poi diffondere i risultati perché diventino sapere condiviso e misura fra quanti operano nelle stesse condizioni, evitando che tutto rimanga circoscritto in un inutile soggettivismo: non è questo che fa ogni ricercatore?”. E torniamo alle organizzazioni dei pazienti. Se ai medici servirebbe potenziare più la formazione che la deontologia professionale, a noi pazienti serve comunicare sia verticalmente che orizzontalmente tra noi. L’arte di trattare Non solo per imparare l’arte di trattare col medico, per rassicurarci e rafforzarci, che già ci farebbe bene. Bensì per elevare il livello di consapevolezza e costruire un patrimonio culturale condiviso, fatto di esperienze di cura e comunicazione, che consenta di ridurre l’ignoranza, di avere un confronto con la scienza medica, di pensare interventi, terapie, strade diverse, nel merito e nel metodo di cura e di comunicazione. Non è utopia. L’hanno fatto operai e tecnici nelle lotte contro la nocività in fabbrica, l’hanno sperimentato le donne nelle lotte contro gli aborti clandestini e nei consultori, lo stanno facendo gli attivi- 83 In piazza del Campidoglio (1997) sti Aids nei centri di studio e cura di vari Paesi: i progressi terapeutici sono stati ottenuti anche con l’interazione tra il sapere scientifico e il sapere acquisito dai malati. In quanto persone dotate di conoscenze (in merito, per esempio, agli effetti dei farmaci sul loro organismo), hanno trasformato diversi aspetti della prassi scientifica, anche il modo in cui si guarda alla malattia. In generale tutte le associazioni di malati sono un “luogo di mediazione tra pazienti e medicina”, svolgono un ruolo propositivo, danno un impulso alla ricerca anche sulla base dei dati epidemiologici dei propri soci. Il senso della vita Insomma, medici e ricercatori hanno una fortuna insperata ad avere una fonte così mirata di informazioni, un impegno da cui nasce un tipo di competenza di cui pure qui potreste avvalervi. Ecco il senso della mia proposta. Ci proviamo? Conclu- 84 do con un auspicio. All’ultimo incontro scientifico su “il linguaggio della ricerca”, nella Giornata nazionale per la ricerca sul cancro, ci è stato spiegato che anche il cancro rappresenta una patologia della comunicazione molecolare su cui si può intervenire e che sono allo studio terapie genetiche personalizzate. Sono intervenuto per chiedere agli eminenti scienziati: “Che ne sarà delle migliori terapie (genetica, antibatterica o antivirale), in assenza di una giusta comunicazione relazionale tra curanti e curati, tra operatori e operati? Potrebbero essere controproducenti. Siccome noi – come dice il poeta – siamo un colloquio, siamo fatti di geni e relazioni, di biologia e biografia, la cura della comunicazione genetica non presuppone e non richiede anche quella della comunicazione bioetica?”. Secondo lo storico della medicina Mirko Grmek oggi si parla di informazione come porta- re gli ricorda: “È chiedere perdono”. Perché? Forse per “il privilegio di nutrirsi della ricchezza dei pazienti, entrando nelle loro vite attraverso la porta della sofferenza”? Non so, così come non so se “perdono” sia la parola giusta. Lo stesso “British Medical Journal” ha preferito “etica dell’ignoranza”, cioè la coscienza dei limiti e delle carenze, personali e della medicina. Da paziente esigente vorrei che i malati, meglio se organizzati, si ricordassero che il loro primo dovere – se si vuole davvero rinnovare un patto epocale come quello che ci sta davanti – è quello di “concedere il perdono”: cioè prendersi la propria parte di responsabilità della malattia e della cura, informarsi, uscire dall’ignoranza e dalla rassegnazione comunicativa. comunicazione trice di senso, del senso della vita. La comunicazione è elemento costitutivo non solo della cultura ma anche della natura, del mondo, dell’universo. Ma l’informazione non esiste per se stessa. Un messaggio, come quello del genoma, non ha senso se non c’è qualcosa o qualcuno (la cellula vivente) che possa leggerlo e decifrarlo. Inoltre, si possono curare sempre più mali, “vincere sempre più battaglie, ma non la guerra contro le malattie: che restano un modo inevitabile di esistenza, una esperienza dura e inevitabile della vita”. La quale assume senso e valore solo se è animata di autentica comunicazione. Quello che serve tra pazienti e medici non è un rapporto materno, caritatevole, amicale, e tantomeno un rapporto formale, meramente contrattuale, ma un nuovo patto scientifico e morale (il “British Medical Journal” ha parlato di nuovo “contratto sociale”). Una collaborazione che parta senza demagogia dalla presa d’atto delle asimmetrie di potere e dei rischi di reciproca sudditanza, per dar vita a un patto basato sulla reciproca fiducia, che aiuti i pazienti a far parte dell’équipe che li cura. Cosmacini e Satolli citano il film “Il posto delle fragole” di Ingmar Bergman. Al protagonista viene chiesto qual è il primo dovere del medico e non sa la risposta. L’esaminato- Sana conflittualità Io per riuscirci ho fatto il Master. Ho capito che senza etica non c’è scienza e viceversa e ho verificato che lo studio rigoroso e una sana conflittualità, trasparente, non violenta, per riuscire a conquistare brandelli di comunicazione autentica – ossia di comune ricerca, vera e buona con i miei curanti – è attività terapeutica. E grazie a ciò sono in grado di “perdonare” esitazioni, errori e indifferenze. Sperando che perdoniate la n mia supponenza. 85 C’è bisogno di costruire una bioetica quotidiana Dalla relazione tenuta il 13 giugno 2004 al “Gruppo Eventi” F requentare il “Gruppo Eventi” mi ha fatto capire che se morire è un dovere, sociale e biologico, morire bene è un diritto, sociale e bioetico: una speranza morale, non ancora un’istanza legale. Per renderla effettiva occorre cambiare gli atteggiamenti sociali nei confronti della morte e dei morenti. E siccome le statistiche dicono che si muore per lo più in ospedale, occorre cambiare quelli degli operatori ospedalieri, soprattutto dei medici (abbiamo il primato mondiale: 607 medici ogni 100.000 abitanti). Per arrivarci, però, occorre conoscere e cambiare il loro atteggiamento nei confronti dei pazienti malati, prima che diventino morenti, per agire sulle strutture e sui bisogni della società. La comunicazione tra medici e pazienti è un grosso nodo etico, prima che un problema di virtù personali, di tecniche comunicative e di organizzazione assistenziale. L’ennesimo scandalo del comparaggio farmaceutico è qui a ricordarcelo. Eppure, nei miei recenti studi mi sono accorto, con meraviglia, che la bioetica si è venuta confi- 86 gurando come un’etica di frontiera, reattiva alle novità scientifiche e tecnologiche. Le possibilità di incidere per via tecnologica sulla vita umana procedono più rapidamente di quanto non avvenga per la riflessione etica. In una ideale curva gaussiana (che rappresenta l’andamento probabilistico medio dei fenomeni sociali) potremmo vederla concentrata sulle code estreme: da una parte l’inizio della vita, la sua definizione, la procreazione assistita, sino alla clonazione; dall’altra la fine della vita, la definizione di morte, sino all’accanimento terapeutico e all’eutanasia. E il grosso della curva, il vivere quotidiano, il rapporto con il dolore, la sofferenza, la cura? L’esperienza della malattia e dell’ospedale? Credo vi sia bisogno di una bioetica quotidiana che ci aiuti ad affrontare proprio lo spessore di questi aspetti ordinari, di massa. Mi trovo oggi a vivere una situazione in cui, alla carenza di energie si sovrappone una sorta di penuria di ottimismo. E ciò non solo perché è difficile restare ottimisti di questi tempi, sempre più inquinati da violenze, comunicazione Sorridendo al figlio Pietro in culla (1965) menzogne e paure, in cui le ragioni della forza vengono spacciate per la forza della ragione e la lotta al terrore con altro terrore sta provocando – come dice Amnesty International – “il più grave attacco ai diritti umani” e alla convivenza globale. Ma anche per un motivo personale alquanto deprimente: rispetto a quattro mesi fa ho iniziato un altro giro di giostra nel mio viaggio terapeutico, un lungo ciclo di radioterapia con effetti devastanti in termini di dolore e avvilimento. Soffro una fiacchezza fisica e morale, anche perché non sono convinto che ne valga la pena. Come diceva il grande Albert Schweitzer “il paziente non lo sa, ma il vero medico è quello che ha dentro di sé. E noi abbiamo successo quando diamo a quel medico la possibilità di fare il suo lavoro”. Sento la fragilità Il fatto è che io lo so, ma sento che il mio medico interiore, il sistema immunitario fisio-psichico, non sta lavorando. Mi spiace, ma dovevo dirvelo, anche per rendervi onestamente partecipi della fragilità, precarietà e reversibilità delle acquisizioni che sembrano reggere un rapporto terapeutico. Comunque, anche se le mie convinzioni vacillano, mi sorregge la serena consapevolezza dei limiti della vita, maturata grazie al “Gruppo Eventi”, insieme alla fondata speranza di solidarietà e di cure n sino alla sua fine. 87 Un terreno comune di ascolto attivo Testimonianza tenuta il 25 maggio 2006 alla tavola rotonda “Il passaggio di comunicazione tra oncologia e cure palliative: si comunica allo stesso modo?” (Master Antea) C omunicare non è solo questione di virtù personali e di tecniche formative, è innanzitutto un problema di coraggio morale. Prendersi delle responsabilità personali nei rapporti di lavoro, senza nascondersi dietro lo scudo della dipendenza da parte di chi rivendica la propria professionalità, è il minimo che si richiede per essere credibili. E così nei rapporti sindacali: il fine non giustifica i mezzi, non penso che per riformare la Sanità sia giusto paralizzarla con uno sciopero che colpisce solo i malati, mi pare sia più corretto sperimentare forme di lotta rovesciate che contengano più proposta che protesta, più tensione morale che astensione fisica, più attenzione ai pazienti che ai regolamenti e agli emolumenti. O sbaglio? Il mio look attuale, con il collare nuovo fiammante, dice di più sul mio stato di tante parole. Sono alle cure palliative, sto vedendomela con il dolore. Avevo smesso le terapie, stufo di curarmi dei danni delle cure, ma non ho la vocazione del martire cristiano o maomettano: il collare serve ad alleviarlo, insieme al cerotto alla morfina e magari al- 88 la Giornata nazionale sul sollievo. A me l’ha prescritto l’oncologo del Gemelli lunedì scorso, con un nuovo busto e nuove applicazioni radioterapiche. Solo che, abituato a farlo per via infraospedaliera, mi ha indicato il modello ma non mi ha detto dove procurarmelo. Così fino a ieri sono impazzito a cercarlo in giro per Roma, finché il solito figlio informatico non ha rintracciato l’unico centro di vendita. La vostra domanda è “Come e quando si comunica?”. Io aggiungo: basta preoccuparsi della diagnosi e della prognosi, oppure sarebbe meglio occuparsi anche di certe piccole cose che però incidono sulla qualità della vita del paziente? E poi mi chiedo: il collare, nel “passaggio di comunicazione” tra oncologia e cure palliative, è un prodotto dell’orto oncologia o un prodotto dell’orto cure palliative? Io non lo so, ma credete forse che il saperlo cambierebbe qualcosa nella mia predisposizione a subirne il fastidio? E così siamo entrati subito in argomento. Scusate se ho messo i piedi nel piatto, ma il collare mi impedisce di abbassare bene la testa. Per fortuna non mi impe- Mistero rinnovato Ha ragione Tiziano Terzani quando scrive, in “Un altro giro di giostra”, che il cancro non è un nemico e tantomeno un amico: è, può essere, “un baluardo contro la banalità del quotidiano”. E di questa banalità fa parte indubbiamente la tendenza a dare per scontate tante cose, direi di più: a dare per scontata la vita stessa. Che invece è un mistero, un dono continuamente rinnovato e, spesso, ampiamente meritato. Forse comincio a capire, con il Galileo di Bertolt Brecht (ripreso da monsignor Gianfranco Ravasi nel suo “mattutino” sull’Avvenire di domenica scorsa), una cosa importante: non sempre è vero “che la strada più diritta e sbrigativa sia la più efficace per superare un ostacolo. Più produttivo può risultare in alcuni casi l’accerchiamento paziente, la strategia lenta e minu- ziosa, la curva progressiva di avvicinamento rispetto alla marcia frontale di sfondamento, la sapienza dell’attesa, la pazienza, la pacatezza, la riflessività rispetto all’irritazione iraconda”. Mentre forse è vero – per citare una frase del romanziere Jules Renard, anch’essa ripresa da Ravasi – che “se si vuol costruire la casa della felicità, è bene ricordare che la stanza più grande dev’essere la sala d’attesa”. In maniera diversa, con le parole di Frank Ostaseski (fondatore e direttore del Zen Hospice Project di San Francisco) riprese dal suo “Saper accompagnare” (Oscar Mondadori, 2006), potrei dirla così: “Quando consideriamo la morte vicina, a portata di mano, il nostro bisogno di gratificazione diventa meno ossessivo. Impariamo a prendere noi stessi e le nostre idee un po’ meno sul serio, o a lasciar perdere con più facilità. Ci apriamo di più alla generosità e all’amore, ci sentiamo più disposti alla gentilezza reciproca”. So di essere un paziente in fase avanzata di malattia, grave (non direi “terminale”, vorrei essere un’eccezione alle vostre statistiche). So, insieme, di essere fortunato, perché finora non ho avuto bisogno di droghe, di fedi, di psicoterapie, di comparse tv, e perché ho tre nipotine che mi tengono sempre innamorato della vita. Ma so anche di essere un privilegiato, di avere delle responsabilità morali e comunicative dovute al mio bagaglio culturale e all’esperienza politico-sindacale che mi ha temprato. Noblesse oblige. Vorrei essere contagioso, un “antivi- comunicazione disce di leggere e di scrivere. La morfina è già più insidiosa: sto faticosamente sperimentando un fragile equilibrio tra il massimo di dolore sopportabile e il minimo di torpore accettabile. Per questo ieri sera mi sono scritto questi appunti: la precarietà è ormai la mia signora, non potevo sapere se oggi sarei stato in grado di intervenire, meglio garantirsi. E se poi va bene e riesco a vivere un’altra intera giornata in modo decente, sai che bella soddisfazione: è un piacere che prima ignoravo, dandolo quasi per scontato, come facciamo per tante cose della vita finché non vengono messe in forse, magari da un cancro. 89 rus” contro il virus dell’indifferenza (individuale e organizzativa) che tutti ci opprime e deprime negli ospedali. Vorrei fare e vincere insieme a voi quella che i responsabili della Società italiana cure palliative hanno chiamato “la battaglia contro l’indifferenza”. Vorrei riuscire a fare della mia sofferenza personale, della mia disavventura privata, un’opportunità di ricerca pubblica, politica, sulla e per la comunicazione tra curanti e curati. Avrei l’ambizione non solo di lasciare una preziosa testimonianza, come il grande giornalista Tiziano Terzani, ma di contribuire già da vivo, nel mio piccolo, a fare della clinica medica una esperienza più umana e insieme più scientifica: una scienza delle relazioni terapeutiche. Nuova Medicina La terapia è fatta soprattutto di relazioni autentiche, di comunicazione vera e buona. Perché se voi sapete o dovreste sapere tutto o quasi sulla malattia, sul cancro, sulla morte da cancro, solo io so o almeno dovrei sapere tutto o quasi su come vivo e soffro il mio cancro e le vostre cure, su come immagino ed esploro il percorso del mio morire. Insieme dovremmo riuscire a far emergere le nostre rispettive, migliori, risorse interne, le nostre potenzialità e a costruire la migliore ricerca e la migliore terapia. È solo dall’incontro – certo non scontato, certo difficile e ancora non sufficientemente sperimentato – delle nostre rispettive competenze, partendo dalle enormi differenze (tra voi e noi, tra ogni cancro, tra ogni 90 malato di cancro) ma non restandovi impigliati, cercando un terreno comune di ascolto attivo, di attenzione “montessoriana”, di comprensione, di comunicazione maieutica, di riconoscimento fiducioso e non fideistico, di azione coerente, che potrà nascere una nuova Medicina (anche palliativa), come nuova scienza condivisa. So bene che i “guaritori feriti”, cioè i medici che hanno sofferto una malattia grave sono i più adatti. Io li annuso immediatamente in ospedale. Ma non accetto, perché sarebbe mostruoso, che per imparare a comunicare con un malato di cancro anche il medico debba ammalarsi di cancro. Anche l’empatia si impara, si coltiva e si innaffia tutti i giorni in corsia, si costruisce insieme. State attenti, vi prego, specie ora che state diventando un’importante istituzione, a non trasformarvi da umili missionari palliativisti in superbi dignitari “pantativisti”, a non voler strafare (magari arrivando a dare a un paziente il numero di cellulare che poi rimane muto nel momento del dolore). Perché chi di noi da utile diventa indispensabile rischia di degenerare, di diventare insieme padrone e schiavo del proprio lavoro. Mentre il vostro delicato e prezioso servizio per aiutarci a vivere e a morire nel rispetto della nostra autonomia e della nostra dignità, cioè da persone libere, anche se malate, richiede – come ricorda un grande curatore greco – medici liberi e non schiavi, operatori liberi che sappiano ascoltarci e valorizzarci, semplice tavola rotonda), pur ricordando che siamo e restiamo pazienti, cioè persone che soffrono. “Il fondamento più importante della medicina – ha scritto il grande medico Paracelso – è l’amore. Se il nostro amore è grande, grande sarà il frutto che la medicina otterrà da lui. Se è piccolo, anche i nostri frutti saranno piccoli”. n comunicazione che sappiano dirsi gli errori e trarne utili lezioni, che sappiano riprendere tempo, comunicare tra loro per collaborare e prendersi cura di noi, aiutarci a narrare la nostra malattia, a tirar fuori tutte le nostre risorse interne: che sono la prima terapia. Che sappiano insomma farci entrare a pieno titolo, da pari, nell’équipe che ci cura (e non solo in una 91 Il dito di Caravaggio nella piaga della ricerca Spiegazione della scelta del quadro “L’Incredulità di San Tommaso” per la prima pagina del sito www.giannigrassi.it. “Non intendo farlo diventare un blog fra i tanti – metteva in chiaro Gianni – deve restare una cassetta degli attrezzi per migliorare la comunicazione tra camici e pigiami. Pare che serva anche a curarsi meglio” O ltre a “paziente esigente”, avevo messo nell’intestazione del sito anche Sociologo, diventato poi Socio-giocologo. Cioè? Un sociologo del gioco? Un sociologo che gioca? Che si prende gioco anche della malattia? No, piuttosto un amante della Sociologia che si mette in gioco. Che si prende le sue responsabilità personali anche come paziente. Paziente esigente, pertanto, con se stesso prima che con i compagni di viaggio e con le controparti, mediche e non solo. L’Incredulità di San Tommaso: si tende a interpretarlo come “un manifesto della nascente cultura sperimentale”, della volontà di verifica, dell’accertamento per prova. Preferisco l’interpretazione di Roberto Satolli, presidente del Comitato etico nell’Istituto tumori di Milano, nell’articolo Il dito di Caravaggio nella piaga della ricerca (“Bollettino d’informazione sui farmaci”, n. 4/2005). Egli osserva “la concentrazione del racconto: il volto dolente di Cristo reclinato in ombra, quasi vergognoso della penetrazione, e la mano sovrapposta a guidare e trattenere il gesto 92 maldestro. L’uomo del quadro concede ai discepoli di fare esperienza, cioè di apprendere, letteralmente sulla propria pelle”. Ma aggiunge: “Nel quadro è il ditaccio con le unghie sporche dell’apostolo che rischia di infettare una ferita miracolosamente pulita. Agli occhi di un medico, il gesto indagatore può richiamare l’agire del clinico deciso ad andare sino in fondo nell’accertamento del male. Allora la mano che lo trattiene (mentre l’altra scosta la veste in un gesto di accondiscendenza) rappresenta la volontà del paziente che dà il suo consenso a essere scrutato e curato, ma che mantiene sempre la possibilità di decidere dove e quando il curante deve fermarsi”. Ricerca con l’uomo Ricorda l’invito di Giulio Maccacaro a “non fare ricerca sull’uomo, ma con l’uomo” e si chiede: “un’utopia fuori dalla realtà?”. Risponde che oggi “quell’utopia è forse più lontana di allora... si è affermata una sottile forma di prevaricazione, che consiste nello sfruttare la buona fede dei pazienti per arruolarli in ricerche che nulla hanno a che vede- comunicazione L’Incredulità di San Tommaso del Caravaggio re con il desiderio di conoscenze, o con la salute della gente, ma che sono concepite e condotte a scopo di profitto. Secondo Richard Smith, ex direttore del British Medical Journal, le riviste scientifiche sono ridotte a estensione del ramo marketing delle compagnie farmaceutiche. Soprattutto in campo biomedico la ricerca non ha più le caratteristiche di un’impresa disinteressata e collaborativa, come era stata definita dal sociologo della scienza Robert Merton. E secondo il premio Nobel per la medicina Karis Mullis probabilmente lo sviluppo scientifico più importante del XX secolo è che l’interesse economico ha rimpiazzato la curiosità come forza trainante della ricerca”. Satolli conclude dichiaran- do il “panorama scoraggiante” dall’interno dei Comitati etici, che pure sono stati individuati come “un possibile argine alla prepotente invadenza del mercato nel mondo della scienza”. Buona volontà “Risulta molto difficile, se non quasi impossibile, proporre e ottenere correzioni sostanziali dei protocolli – chiarisce Roberto Satolli – serve un maggior scambio di informazioni e pareri tra i diversi Comitati... tutto si fonda per ora sulla buona volontà dei singoli”. Bene. Cioè, male, malissimo. Allora con questo piccolo sito di buona volontà vorrei contribuire, come paziente, a difendere la salute, il diritto a vivere e – pern ché no? – a morire bene. 93 Non ho la grazia della fede, né in un dio soprannaturale, né in quella sua caricatura terrena che ancora oggi troppi medici credono di incarnare. Ma serbo la grazia della fiducia in me stesso e negli umani, ovvero nella ricerca della comunicazione con i compagni di viaggio e chi si prende cura di noi. Non parlo delle domande a un dio, ma al dio che dimora in ciascuno di noi, non in un tempio ma nel nostro corpo, nella nostra umanità, nella nostra “comune compassione” “Perché piangi? Soffri?” “No, sono contento” “Cosa è successo?” “Ho incontrato la mia fragilità” “E cosa ti ha detto?” “Ben arrivato, amico mio” Tapa Sudana (Attore balinese) guaritori feriti La nemesi di stare dall’altra parte 97 “Vo’ a casa a morire”. In memoria di Bartoccioni 100 95 Arrampicato sulla cima di un albero (1991) Dalla recensione al libro “Dall’altra parte” di Sandro Bartoccioni, Gianni Bonadonna e Francesco Sartori (a cura di Paolo Barnard) M alato di cancro con metastasi ossee, so cosa vuol dire stare “dall’altra parte”. Ho letto il libro così intitolato, dopo aver visto il servizio “Nemesi medica” realizzato da Paolo Barnard per “La storia siamo noi” di Rai Educational, il 27 giugno 2005. E ne ho parlato in alcuni convegni medici. Anche il 25 maggio 2006, al corso di cure palliative organizzato dall’Antea, associazione romana che assiste malati oncologici in fase avanzata, con varie équipes di assistenza domiciliare e un Hospice: quello in cui sono ora ospite per una improvvisa paralisi. Nel pomeriggio dello stesso giorno avevo fatto in tempo a partecipare alla presentazione del libro e a conoscere di persona i tre autori. Due si erano dovuti recare in carrozzella all’appuntamento: l’oncologo Gianni Bonadonna e il cardiochirurgo Sandro Bartoccioni. Questi aveva appena subito l’ennesimo intervento riparatore degli effetti nocivi delle chemioterapie sperimentali che, da anni, con una specie di auto-accanimento terapeutico, stava tentando su se stesso. Ora è morto (a lui andrebbe intitolato guaritori feriti La nemesi di stare dall’altra parte l’ospedale “Silvestrini” di Perugia, la città cui tanto ha dato e che tanto l’ha fatto soffrire). Avevano accettato l’invito di Paolo Barnard a incontrarsi e parlare pubblicamente della loro sofferenza, ma anche delle manchevolezze del Servizio Sanitario Nazionale. Questa volta però riscontrate dall’altra parte, quella del paziente. Chiudere la distanza L’idea di Barnard è stata quella di “chiudere la distanza tra medici e malattia, per coniugare scienza e sofferenza”: i medici malati, sostiene, soffrono molto di più dei malati normali. Io invece, da paziente esigente, penso che il parere dei medici non possa prevalere anche quando si ammalano. Né mi piace il termine “nemesi”: mi pare mostruoso che un medico, per comunicare con me, debba ammalarsi di cancro. Basterebbe si ricordasse della sua potenziale morbilità e della sua certa “moribilità”. Sento ripetere che alla Medicina servirebbe “più umanità e meno scienza”. Ritengo invece che diventerà più umana e più scientifica solo quando riuscirà a riconoscere proprio 97 l’umanità e la “scienza” dei malati, tuttora non ascoltata né accettata. Infatti, se il medico sa o dovrebbe sapere tutto sulla malattia, sul cancro, solo il malato sa tutto su come vive e soffre la sua malattia, il suo cancro. Bisogna essere in due, con le risorse esterne (biologia, farmacologia, tecnologia, epidemiologia) e con quelle interne, che sono la prima medicina. Quanto dovremo aspettare e soffrire per cominciare a capirlo tutti insieme? Gli autori di questo testo l’hanno capito bene. Hanno detto cose semplici e chiare, di una autenticità disarmante che ha reso il libro contagioso, in un bocca a bocca pari a quello di “Un altro giro di giostra” di Tiziano Terzani. Commiato alla moglie A mio parere, le parti più belle e commoventi sono: il commiato di Sandro Bartoccioni alla moglie (“la gelosia”): “A me hai dato tutto quello che potevi, ora godi al massimo la vita che ti rimane. Pensa un po’ a te stessa e sii per una volta un po’ egoista. Ti seguirò con amore e sarò felice solo se ti vedrò felice, non piangere per me. Ti aspetto” (a lui ho dedicato un ricordo nella rubrica “Se ne sono andati” su “Diario della settimana”, n.25 del 23 giugno); il prologo di Gianni Bonadonna ai lettori: “Ce l’ho messa tutta per far capire che è importante non lasciarsi andare, anche se la tentazione di abbandonarsi è spesso crescente quando il cervello non ha più un corpo che lo segue come nei tempi migliori. Questo mio scritto vuole essere la testimo- 98 nianza che molti malati possono tornare a riempire il mondo con la propria umanità. È scontato che è dura. Ma abbiamo bisogno di questi uomini e donne che, imboccato un tunnel che sembrava senza uscita, hanno saputo trovare la forza di rivedere la luce”; la conclusione di Francesco Sartori, che precede il “decalogo” finale, cioè una proposta per rifare una Sanità che curi davvero, anche chi non può essere guarito: “Sento purtroppo di far parte di un mondo, quello sanitario, che è una parte della nostra Italia malata”. “Il giorno che i treni arriveranno in orario, trasportando persone e non zecche – elenca Sartori – il giorno che la nostra Giustizia ci garantirà processi rapidi con la condanna anche di qualche colpevole, quando la mafia, collusa con la politica, sarà sconfitta, quando non ci sarà più lavoro nero ed evasione fiscale, quando infine il sentimento della ragione (o dell’etica?) avrà prevalso su ogni egoismo, anche la nostra Sanità comincerà a funzionare e potremo dire di vivere in un Paese civile. È una speranza utopica? Forse. Ma non è stato Oscar Wilde a dire che il progresso è il superamento dell’utopia?”. Che cosa aggiungere? Chiudo con le parole di un altro grande medico, Ignazio R. Marino, chirurgo di fama mondiale, specialista in trapianti d’organo, ora presidente della Commissione Sanità del Senato della Repubblica. Nel suo stupendo “Credere e curare”, prezioso perché sintetico, quindi adatto ai medici che leggono poco, scrive: “Per- causa del catetere urinario e il dolore nelle braccia dovuto ai buchi ripetuti delle iniezioni o dei prelievi di sangue. Ho capito perché alcuni pazienti si ribellano a queste imposizioni e cercano di togliersi da soli tubi e drenaggi. L’ho fatto anch’io”. Una dose di dolore guaritori feriti sonalmente credo di aver capito un po’ di più di quello che accade nella mente di un malato e delle aspettative che si creano nei confronti dei medici, nel momento in cui mi sono trovato dall’altra parte della barricata, steso in un letto di ospedale, di fronte alla prospettiva di un intervento chirurgico a cui sottopormi con urgenza. A distanza di undici anni, penso sia stata in qualche modo la provvidenza ad avermi fatto ammalare, costringendomi a provare sulla mia pelle almeno una parte delle sofferenze che io infliggo ogni giorno ai miei pazienti per cercare di portarli sulla via della guarigione”. “È stato in quella occasione che ho compreso davvero il significato di tante cose che non sono scritte nei libri di medicina – prosegue Ignazio Marino – Ho vissuto l’ansia che si prova quando l’anestesista ti prepara per la sala operatoria. Ho capito il dolore e la paura di chi si risveglia dopo un intervento chirurgico con un tubo di plastica in gola e un altro nel naso che fa sentire la sua fastidiosa presenza ogni volta che si deglutisce. Ho capito il bruciore che si prova a “Troppo spesso il medico impone queste sofferenze senza rendersene conto e, dall’alto della sua professionalità, somministra assieme alle terapie anche una buona dose di dolore – insiste Marino – da cui non può che derivare disagio e uno stato d’ansia nel paziente. Un’ansia destinata a raddoppiare in assenza di dialogo col medico. Ho capito bene anche l’attesa e le aspettative per quei minuti che il medico trascorre con te ogni giorno, spiegandoti cosa deve essere fatto e perché, affinché tu possa ritornare a fare ciò che facevi prima di ammalarti”. Da parte mia non aggiungo parole. Posso solo ripetere, con il Wittghenstein del Tractatus: “Tutto quello che si può dire può essere detto chiaramente. Su ciò di cui non si può parlare si n deve tacere”. 99 “Vo’ a casa a morire”. In memoria di Bartoccioni Sabato 3 giugno 2006 a Città di Castello si sono svolti i funerali del professor Sandro Bartoccioni (59 anni) in una chiesa stracolma di gente e di pazienti da lui salvati. All’offertorio si è levata la musica di Vincenzo Cerami da “La vita è bella” P ochi giorni prima in una libreria romana lo avevo conosciuto quando, con la dolce moglie Zaira e i figli Cinzia e Filippo, era giunto in carrozzella dall’ospedale Gemelli, reduce dall’ennesimo intervento dovuto all’ennesima chemioterapia sperimentale cui si era sottoposto. Un vero auto-accanimento terapeutico, tributo personale alla ricerca contro il cancro. Che lui, come Terzani, non riteneva un amico e tantomeno un nemico, ma semplicemente un “baluardo contro la banalità del quotidiano”. Semplice a dirsi ma difficile a farsi. È ospite ma non rompa Eppure Bartoccioni, grande medico e cardiochirurgo di fama internazionale, chiamava il cancro Beppino, con un’ironia pari a quella di un altro medico straordinario Eugenio Picano (direttore del laboratorio di ecocardiografia a Pisa, autore de “La dura vita del beato porco”, edito dal Pensiero scientifico e definito da Paolo Cornaglia Ferraris “un assoluto capolavoro umoristico”). In libreria, pur morente, Bartoccioni ci ha fatto ridere dicendo 100 sul cancro: “Va beh, è un ospite, ma non può rompere i coglioni più di tanto”. Si stava presentando un altro libro fondamentale: “Dall’altra parte” (Bur Rizzoli), in cui Sandro, insieme a Francesco Sartori, primario di chirurgia toracica a Padova e al famoso oncologo Gianni Bonadonna, racconta cosa vuol dire per un medico cadere gravemente malato, diventare un “guaritore ferito”: di cancro o di ictus (Bonadonna, appunto, che ne ha parlato anche nel suo “Coraggio, ricominciamo” edito da Baldini Castoldi Dalai). Il libro è curato da Paolo Barnard, autore del servizio “Nemesi medica” trasmesso e ora più volte replicato da Minoli nella rubrica “La storia siamo noi” di Rai Educational. Altri medici “feriti” si erano rifiutati di partecipare: “Non sono ancora un uomo finito”, avevano detto. Loro tre no, hanno voluto testimoniare che – come ha scritto monsignor Gianfranco Ravasi nel “Mattutino” sull’Avvenire, proprio parlando dell’ictus di Gianni Bonadonna – “è solo dalla perdita di una realtà viva e amata che si riesce a intuirne il valore”. Anch’io, se guaritori feriti Durante un viaggio a Salisburgo (estate 1989) mi è consentita una notazione personale, ora so cosa vuol dire. Non sono un medico, sono solo un paziente “esigente” che vuol fare della sua disavventura privata e della sua sofferenza personale (un cancro allo stadio finale) l’occasione per una ricerca pubblica per una migliore comunicazione tra medici e pazienti. Il 27 maggio ero andato ad abbracciarlo al suo capezzale al Gemelli e mi aveva sussurrato: “Gianni, men vo’ a casa a morire”. Un abbraccio Purtroppo non ho potuto partecipare alle esequie: lo stesso giorno sono stato ricoverato, per un’improvvisa paralisi, all’Hospice Antea di Roma. Ma anche da un letto “terminale” voglio onorare la sua memoria. n 101 Io soffro per me, e già mi basta e avanza, soffrirò e morirò per me, non certo per far piacere a qualcuno. Altro che dolore “altruistico”. Morendo, vorrei poter recuperare un po’ di sano egoismo, circondato e aiutato dall’amore degli altri “L’hospice non è solo un edificio, un modo per proseguire le cure domiciliari quando a casa è impossibile. Sono le persone che lo gestiscono, la medicina che vi si può praticare, la formazione che si può erogare. Occorre vigilare perché i soldi non servano solo a cambiare il nome a dei cronicari ristrutturati” Giovanni Creton hospice e cure Maria Occhipinti, appartenevo ai sofferenti Cure complementari e mobilitazione dell’anima Come riuscire a dare un significato al dolore Una ricerca di senso, speranza e amore Mi sto talmente reinnamorando della vita Canne, dolore e buona morte Dialoghi su cure palliative e hospice Volando in trance sul parco di Villa Ada Diventare sciamano quando torno polvere 105 107 110 113 115 119 120 122 125 103 All’Hospice Antea leggendo favole alle nipotine Irene e Michela (2006) Dall’intervento tenuto nel novembre 2004 al convegno “Dolore, malattia e cura nella vita di Maria Occhipinti” I ntervengo sul rapporto di Maria Occhipinti con il dolore, il suo “appartenere ai sofferenti”, sia come oggetto di mali (le malattie, la maledizione paterna) sia come soggetto che si è preso cura di malati e di ideali. Ne parlo non per dovere di definizione, cioè per il fatto di essere il “curatore” dei suoi scritti per la Sellerio o perché Maria mi ha collocato, con i due medici anomali Brunori e Giardini, tra i suoi “soccorritori”. Bensì per dovere di testimonianza, nel senso che Maria mi ha passato il testimone: dopo la sua morte infatti, alla conclusione di una parabola che l’aveva vista passare da infermiera a inferma, anch’io ho conosciuto la malattia e ho imparato cosa vuol dire diventare un paziente. Come Maria è stata una curante un po’ speciale così anch’io cerco di essere un malato un po’ speciale. Facendo mia la sua lezione, ho cercato di dare un senso alla malattia, di farne una opportunità per una migliore comunicazione tra medici e pazienti. I primi, chiamati a dar conto della propria arroganza comunicativa, basata sul tabù degli errori e hospice e cure Appartenevo ai sofferenti. La lezione di Occhipinti sul mancato ascolto del parere altrui, a cominciare da quello degli infermieri. I secondi, chiamati a dar conto della propria rassegnazione comunicativa, basata sull’ignoranza che idolatra i dottori e sul mancato rispetto della propria competenza. Una vita generosa La comunicazione è tale solo se è reciproca. Comunicare, nel senso di ricercare e ridare verità e speranza, è stato il motivo conduttore della generosa vita di Maria Occhipinti. Il dolore, la sofferenza e il loro lenimento hanno avuto una parte importante, direi fondante. Che cosa si può distillare dalla sua vita generosa e dalla sua dolorosa parabola? Le intuizioni fondamentali di Maria, le sue anticipazioni maieutiche, da cui sto cercando io stesso di trarre lezione, per tentare di farle diventare patrimonio condiviso tra “camici e pigiami”, mi pare siano tre. Prima: il rapporto terapeutico è innanzitutto un rapporto etico, poi è anche un problema di virtù personali, di tecniche comunicative e operative, di organizzazione assistenziale. Il rapporto terapeutico è tale se 105 è fondato sulla fiducia reciproca e non sulla fede nell’onnipotenza biomedica. Altrimenti si ricorre ai miracoli e si rincorrono le mode. Seconda: in ogni persona malata persistono speranze, potenzialità e autonome risorse interne. Compito del curante è innanzitutto quello di farle emergere, di aiutare il paziente a curarsi da sé, a far parte della équipe terapeutica: ascoltandolo e insegnandogli a definire bene il proprio malessere. Se il medico è competente sulla malattia, il 106 malato è l’unico competente a dire come la soffre, il migliore esperto di se stesso. Guaritrice ferita Terza: la sofferenza è qualcosa di più del dolore fisico e i migliori curanti sono quelli che un filosofo ha definito i “guaritori feriti”, cioè consapevoli – magari per esperienza personale di sofferenza – della comune matrice umana, corporea e mortale, che li unisce, al di là dei ruoli, ai pazienti. Maria è stata una grande guaritrice ferita. n Dall’intervento tenuto il 16 dicembre 2005 al convegno “Trattamenti non convenzionali per i malati di cancro. Gli strumenti per un’informazione corretta” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità P er venire a me, che terapeuticamente sono un fallimento: nel 2000, dopo un tumore alla vescica, ho fatto la chirurgia radicale della prostata, poi l’ormonoterapia cui mi sono rivelato resistente, poi la radioterapia che mi ha fatto soffrire, poi oltre un anno di chemioterapia che ho appena deciso di sospendere, d’accordo con i curanti, perché le metastasi alla colonna restano stazionarie mentre aumentano i danni delle cure. Come mai io che sono alla frutta, alle cure palliative, mi sento bene e sto qui a parlarvi invece di stare a casa a piangermi addosso? Forse perché mi sono rivolto a una medicina “alternativa”? In effetti – anche se sono riuscito a non inciampare nella terapia Di Bella – tuttavia, per venire incontro alle insistenze di mia moglie, ho frequentato due esponenti della medicina “cinese”, uno psiconeuroendocrinoimmunologo e un oncologo. Ma è durata poco e mi è rimasta una certa diffidenza. Perché? Primo perché i curanti, pur bravi e buoni, non hanno compilato nemmeno una cartella hospice e cure Cure complementari e mobilitazione dell’anima sulla mia situazione (mentre io, ogni volta che mi presento a uno dei vari specialisti che si occupano di me, e che purtroppo solo raramente si sentono tra loro, porto una scheda completa e aggiornata della mia carriera oncologica): e che si credono di essere, Pico della Mirandola? Privilegio immorale Secondo, perché mi hanno prescritto analisi raffinate e medicine simpatiche (non la pillola intrisa di piscio gettata via da Terzani) ma non coperte dal SSN, troppo care, per una spesa totale costosissima. Sono riuscito a sostenerla, vivendola però come un privilegio (immorale, come tutti i privilegi, qual era secondo me anche la bella fine del protagonista del film di Denys Arcand Le invasioni barbariche): e che si credono, che siamo tutti Re Mida, al dritto o al rovescio, come Berlusconi? No, non ho proseguito. Ma sto cominciando a capire che forse stiamo sperimentando una terza via: un nuovo paradigma delle cure alternative, che anch’io preferisco chiamare “complementari”. Un tipo di cura che, casomai, si potrebbe dire 107 alternativo alle cure “esterne” – classiche, tradizionali o non convenzionali – e che mobilita piuttosto delle cure “interne”, interne a noi malati e forse anche a voi curanti. Cioè le nostre potenzialità e risorse, quelle che emergono nelle situazioni di emergenza. Tuttora mi chiedo: “Quanto sarebbero benefiche queste risorse interne se conosciute e potenziate dai medici in via ordinaria attraverso le relazioni terapeutiche quotidiane?”. Non solo cuore Non mi riferisco solo agli affetti, al “bacino di affettività” per dirla con Tagliaferri. Nel suo stupendo testamento morale e spirituale, Un altro giro di giostra, Terzani accenna a una cosa “che la scienza non è in grado di capire: il solo pensiero di una persona, la cui esistenza giustifica la propria, è di per sé una medicina che prolunga la vita”. Ebbene, anch’io ho una madre anziana, ultra novantenne, e penso che l’impegno morale e sentimentale di garantirle una morte serena, come quella che vorrei per me, sia un formidabile motivo per non andarmene prima di lei. Inoltre godo della presenza di ben tre nipotine, “frammenti di eternità”, e sento che la loro esistenza spiega perché – nonostante le cure m’abbiano sottratto la libido – io sia sempre innamorato e non abbia alcuna voglia di morire prima del tempo (anche se cerco di prepararle pian piano alla mia scomparsa. Casomai sono io che, nonostante tutta l’apparente “scienza e coscienza”, mi sento del tutto impreparato al- 108 l’eventualità che sia una di loro a scomparire. Non so se riuscirei a sopravvivere). Non è dunque solo una questione di cuore. È piuttosto una terapia di mobilitazione di tutte le potenzialità e le risorse, sentimentali e razionali, affettive e intellettuali, biologiche e bioetiche, immunitarie e comunitarie, corporee e spirituali: forse è la “luce dell’anima” di cui parla Tagliaferri? Non ho timore a chiamare anima la comunicazione vera, bella e buona tra curanti e curati, e penso che le risorse da far emergere possano essere sia quelle dei malati sia quelle dei terapeuti, troppo spesso ignorate e rimosse, tranne quelle tecnico-razionali, professionali. Anche perché, secondo me, le persone che cercano di curarci farebbero bene a capire e accettare una cosa: che non si devono preoccupare tanto di guarirci quanto di aiutarci a fare da soli, a curarci un poco insieme a loro e un poco da soli (secondo l’aurea regola montessoriana). Dovrebbero convenire che non si tratta tanto di “combattere” o di “vincere” il tumore, quanto – almeno da un certo punto in poi – di convincerci (noi e i tumori) a convivere al meglio e il più a lungo possibile, con una sana conflittualità ma senza stupidi “accanimenti terapeutici”. La malattia, anche il cancro, è una parte di noi così come la morte fa parte della vita. È la nostra parte malata. Non è un amico, come non credo possa definirsi la morte, ma non è neppure un nemico. Non è da amare (“beata” sofferenza? Macché, non ho la vocazione del martire hospice e cure Abbracciato alla nipotina Michela (2003) cristiano o maomettano), ma neanche da odiare, come fa la povera Oriana Fallaci che, odiando come nemico una parte di sé (paradossalmente, le sue cellule “immortali”) rischia di odiare non solo il mondo musulmano ma addirittura tutto il mondo. Io mi sono trovato a essere piuttosto d’accordo con Terzani: anche per me il cancro, pur costituendo una disavventura, una grave disavventura (inutile nasconderselo), può rappresentare una opportunità, una grande opportunità: “Una sorta di baluardo contro la banalità del quotidiano”. Dunque, per concludere, qual è la novità? Quale il paradigma che presuntuosa- mente cerco di presentarvi? Penso, si parva licet, che sia lo stesso che ha permesso a Primo Levi e a Bruno Bettelheim di resistere al lager, e che il secondo ha chiamato “il cuore vigile”, quello che li ha aiutati a sopravvivere all’universo concentrazionario e perfino ad Auschwitz. Spirito di ricerca Cioè un misto di autonomia morale e di wit (per dirla con il grande film di Mike Nichols ed Emma Thompson): presenza di spirito, spirito di ricerca. Riuscire a portare quanti più elementi di autonomia e di ricerca nel nostro lavoro, nella nostra vita, di n curati e di curanti. 109 Come riuscire a dare un significato al dolore Intervento tenuto il 27 aprile 2006 al tredicesimo convegno della Società Italiana di Cure Palliative D a piccolo paziente esigente che ancora si sente un po’ profeta disarmato, vorrei dire un’altra piccola verità marginale alla grande Società Italiana di Cure Palliative. Scrivono bene Zucco e Caraceni: il ricordo di Cicely Saunders deve motivare i soci a non sentirsi solo perenni “profeti” ma anche umili “artigiani” che “alla meticolosità e alla fatica di ogni giorno aggiungono sempre creatività ed entusiasmo per ciò che fanno. Dobbiamo sempre ricordare – aggiungono – che la nostra energia morale e professionale si fonda sul non perdere mai di vista gli obiettivi e i protagonisti delle nostre attività: le persone malate e le loro famiglie”. Ma state attenti, vi prego, ora che siete diventati un’importante istituzione, a recuperare la missione spirituale originaria. Altrimenti rischiate di tracimare nella infida e mefitica palude del mercato, rischiate di trattarci da consumatori invece che da pazienti. David Frati, nel sito del Pensiero scientifico editore, cita l’antropologo Kalman Applbaum il quale scrive che “nella nostra rincorsa a uno stato quasi 110 utopico di salute perfetta, senza colpo ferire, abbiamo consegnato a delle aziende commerciali il controllo di alcuni tra i principali strumenti di libertà in tema di sanità: l’obiettività della ricerca scientifica, l’etica nell’assistenza sanitaria, il privilegio di somministrare medicine e la libertà di lavorare in autonomia per il bene dei malati”. Domande di ascolto Rischiate di parlare tanto di noi ma poco con noi, di essere frastornati più dal fragore delle vostre risposte, dal frangersi delle onde in superficie, che dall’assordante silenzio delle nostre domande più intime, quelle che – come dice la cantautrice Luisa Rossaro nella sua canzone “Vede, dottore...” – occupano “gli angoli più scuri della mente”, gli abissi più profondi dell’animo. Sono le domande di ascolto e riconoscimento, di verità e autenticità, insomma di senso. E, a proposito di senso, chiudo accennando a come provo e, qualche volta, riesco a dare un senso anche alla mia malattia e, da qualche tempo, ai suoi messaggi di dolore. Questo Venerdì Santo ho vissuto una vera e pro- lo merito, dio bono, sono stato attento, mi sono riguardato, prima di coricarmi ho perfino preso la bustina di Aulin che tenevo di scorta. Ma perché? Ripetevo tra i lamenti. Dapprima sono arrivato all’aberrazione di accendere la tv, pur di infliggermi un fastidio che speravo peggiore del male, pur di cercare un’evasione visiva, una diversione mentale. Ma non è servito, ho preferito fare i conti direttamente con la sofferenza. Poi ho cominciato a pensare che sì, mi stava rovinando la bella esperienza fatta con le belle persone del teatro, la dolce natura del luogo e – direbbero Zucco e Caraceni – il buon “piatto caldo e fumante di tortellini al ragù, innaffiati da un corposo Sangiovese”, e però, se fosse successo prima non sarebbe stato peggio? Meglio dopo la “bazza” che durante lo spettacolo, o no? Finora almeno me la son goduta... E così ho cominciato a rivivere qualcuno dei bei momenti vissuti, a regalarmi attimi di anestesia corporal-spirituale. hospice e cure pria notte di passione: per la prima volta in vita mia ho avuto una vera cognizione del dolore. Eppure ho una soglia alta di tolleranza e sono allenato da un annoso appuntamento con devastanti attacchi di emicrania, oltre che dalla dura esperienza della guerra sulla “linea gotica” (che ci tolse il fratellino minore e contemporaneamente ha lasciato noi orfani e mia madre vedova a soli 40 anni di un uomo già ridotto a grande invalido cieco e amputato, costringendomi a concorrere per ben otto anni a una borsa di studio che mi ha garantito di essere rinchiuso nel Convitto nazionale di Parma per proseguire gli studi). Dapprima sono rimasto preda, come direbbe il professor Campione, della mia animalità, della insensatezza di un dolore insopportabile e insieme della insopportabilità di un dolore insensato. Ma, contrariamente alla sua ricetta (si può recuperare un senso a un simile dolore solo facendolo diventare altruista, cioè soffrendo per una persona che si ama), ho cercato quasi istintivamente e poi razionalmente un’altra strada: dallo sgomento e dalla rabbia iniziali, dovuti alla sorpresa notturna, un vero e proprio agguato dopo due giorni sereni e stupendi trascorsi con gli amici del Teatro delle Ariette proprio qui vicino, nella collina bolognese, sono passato a un tentativo di recupero di senso (di spiritualità?). Ma perché? mi chiedevo, girandomi e rigirandomi inutilmente, anzi dannosamente, nel letto e nella stanza della locanda in cui ero unico ospite. Non me Un’ora senza dolore Anche oggi, mie care e miei cari, sapeste come mi godo ogni giornata, ogni ora trascorse senza dolore. Ho acquisito un piacere più raffinato, più intimo, meno banale, meno scontato. Perfino riuscire a defecare senza pena sta ridiventando una gran gioia, come quando da piccolo soffrivo di stitichezza. Insomma, caro professor Campione, il dolore – anche quello che sembra insopportabile e apparentemente insensato – non può aiutare a ridare un 111 Alla chiesetta della Civita sull’Isola di Ponza (1998) senso alla vita? E poi mi dica, lei che è esperto di “tanatologia”: qual è mai oggi il dolore che siamo disposti a sopportare? Siamo sempre più immersi in una società anestetizzata, dunque medicalizzata, forse proprio perché medicalizzata. Una società moralmente fragile, piena di paure, che scarica domande di sicurezza sulla medicina o su altre fedi, e in cui – come ha scritto Umberto Galimberti sull’inserto Donna di “Repubblica” – esiste l’imperativo terapeutico: “Esperienze ritenute fino a ieri normali oggi vengono rubricate tra le sindromi psicologiche” per “creare in noi tut- 112 ti un senso di vulnerabilità e quindi un bisogno di protezione, di tutela, quando non addirittura di cura”. E infine, lo dico fuori dai denti, ma per alleviare la propria sofferenza insensata, bisogna proprio aggiungere dolore a dolore, soffrire anche per una persona amata? Io soffro per me Io soffro per me, e già mi basta e avanza, soffrirò e morirò per me, non certo per far piacere a qualcuno. Altro che dolore “altruistico”. Morendo, vorrei poter recuperare un po’ di sano egoismo, circondato e aiutato daln l’amore degli altri. Dall’intervento tenuto il 19 maggio 2006, alla Casa delle Letterature di Roma, per la presentazione del libro della psicologa Lucia Aite “Culla di parole. Come accogliere gli inizi difficili della vita” (Bollati Boringhieri), storie di genitori di bimbi con malformazioni genetiche operati alla nascita al “Bambino Gesù” Q uesto libro, queste storie così amorevolmente raccolte, ci ricordano una verità fondamentale. La guarigione, quando c’è, e comunque la cura efficace, non sono dovute soltanto alla tecnologia, alla biologia, alla farmacologia, alla competenza di tutti i curanti: dal medico di famiglia al ginecologo, dall’ecografista all’ostetrico, dal pediatra neonatologo al chirurgo, dallo psicologo all’infermiere, dal volontario all’assistente spirituale. Sono dovute piuttosto alle loro capacità relazionali: fatte di ascolto attivo e di informazione chiara, precisa e tempestiva (quale differenza abissale tra avere la cattiva notizia in gravidanza e averla solo al momento del parto!). Sono dovute alle capacità di accoglienza e rispetto, di fiducia, riconoscimento ed empatia. Insomma di comunicazione vera e buona, anche se a volte nei nostri ospedali servirebbe ancora un po’ di buona educazione. Anch’io – che ho scoperto proprio in questi giorni l’importanza di un’altra cosa che prima davo per scontata: una giornata senza dolore – nella mia carriera oncologica ho sperimentato e hospice e cure Una ricerca di senso, speranza e amore memorizzato l’importanza vitale delle relazioni terapeutiche. Le quali sono fatte insieme di cura del corpo (la malattia, il dolore) e di cura dell’anima (il senso della malattia, la sofferenza). E non ho remore a usare questo termine, anima, come metafora della comunicazione, proprio io che non ho la grazia della fede. Prendersi cura Una cura (oggi si dice “un prendersi cura”) che riguarda sia l’équipe curante, la difficile collaborazione con tutti e fra tutti gli operatori interni ed esterni all’ospedale, compresi quelli tecnici e amministrativi, lo studio degli errori, sia l’unità sofferente: per aiutarla a tirar fuori tutte le risorse interne – che sono la prima medicina – e a confrontarsi, sostenersi e organizzarsi con le altre unità sofferenti (che è la seconda medicina). Questo libro di Lucia Aite dimostra che ciò, che questo progetto (che mi piace chiamare “progetto Orzalesi”), insieme personale e istituzionale, non è più un sogno, è ormai – per dirla con i compianti Marco Lombardo Radice e Alex Langer – una “utopia concreta”. 113 Gianni e Silvia con il figlio Pietro (1966) Pochi giorni fa è morto in terapia intensiva al Policlinico Umberto I di Roma un mio caro anziano parente. Il problema è che, a mio parere, è morto male, in modo indegno, a causa dell’accanimento e del sequestro della sua vita operato dai medici: ha subito più operazioni con anestesia totale, ha finito i suoi giorni legato perché non si strappasse i tubicini che lo tenevano collegato alle macchine, mentre le persone, i parenti, sono stati relegati a un rigido e minimo orario di visita individuale, bardati come marziani. Quei terapisti, insieme purtroppo a tanti altri in giro per l’Italia, ignora- 114 no non solo l’esperienza del “Bambino Gesù” di Roma ma anche quella dell’ospedale Careggi di Firenze che poco tempo fa è emersa sulle migliori riviste scientifiche: una seria ricerca appena conclusa ha dimostrato la grande utilità terapeutica della vicinanza degli affetti anche in terapia intensiva, rispetto al rischio delle infezioni. Gli affetti prevalgono Gli affetti reali prevalgono sui potenziali infetti, sono terapeutici. Grande lezione! Ebbene, questo grande libricino di Lucia Aite lo dimostra meglio di qualn siasi paludata ricerca. Intervento sul tema “Ha senso la riabilitazione in un malato terminale?”, tenuto il 22 giugno 2006 al seminario Antea Formad “La riabilitazione nelle cure palliative: rivoluzione o conferma?” A rticolerò la mia risposta in tre modi: uno di ordine fattuale, uno di disordine ludico e il terzo in stile didascalico-etico. Primo: i fatti. Il paziente Gianni Grassi, sessantaseienne (l’età di Terzani quando è morto) da dieci anni è portatore consapevole di cancro alla vescica, da sei spostatosi alla prostata e subito rivelatosi mortale, cioè con metastasi ai linfonodi, oggi estese a tutto il rachide e alle coste; aderente consapevole a tutte le prescrizioni mediche e farmacologiche offerte dal SSN (chirurgia parziale e radicale, ormonoterapia, radioterapia, chemioterapia topica e sistemica, cure palliative), nonché di quelle dietetiche, di regime di vita e degli esami periodici di monitoraggio (cistoscopie, scintigrafie ossee, radiografie, ecografie, tac, pet e pet-tc, ecodoppler, rmn, test urodinamici). Da venti giorni paralizzato dal costato in giù, per infiltrazione metastatica al midollo spinale, definita inoperabile e irreversibile al pronto soccorso del Gemelli dal dott. Tamburrelli, sabato 3 giugno 2006, e dallo stesso giorno ricoverato (attoni- hospice e cure Mi sto talmente reinnamorando della vita to, dolorante e un po’ incazzato) nell’Hospice Antea... ebbene, ora è qui. La risposta sta nel fatto stesso della sua presenza al convegno: sì, la riabilitazione nelle cure palliative ha senso. Infatti, in forza di che cosa e grazie a chi il paziente sta qui? Passiamo al secondo modo, quello ludico. Vorrei far finta di essere un naufrago stanco e stremato, forse disperato. Come certamente sarei se non fossi approdato all’Hospice. Vedo un faro che illumina la scritta Antea. Che vorrà dire? Mi informo. Tanto per cominciare, è il nome di un quadro del Parmigianino, famoso pittore parmense, che ritrae forse la sua amante: Antea. Bene. La metafora si addice alla mia situazione. Anch’io sono di Parma e l’Antea onlus sta diventando la mia amante. Il rapporto con lei mi ha ridato la voglia – che dico? – il piacere di vivere dopo l’assedio del dolore e il trauma dell’immobilità. E di questo piacere è componente centrale la speranza che mi infonde il fisioterapista ogni volta che mi sposta dal letto e mi fa muovere, sia pure in carrozzella. Mi pare di volare, ho ripreso a sognare. Ma, ditemi voi, anche 115 se questo fosse solo un modo per me di morire bene, da vivo, in dignità e completezza, vi pare poco? A quest’ora, dopo soli venti giorni, in qualsiasi ospedale, fosse pure il Gemelli, temo sarei distrutto dal dolore e dalle piaghe. Forse avrei chiesto invano di essere aiutato a morire prima? Perciò la mia risposta è, lo ribadisco: sì, la riabilitazione nelle cure palliative ha senso. Stare a prua Non so se sia una rivoluzione o una conferma, ma so che a me la vostra scelta, moralmente e scientificamente coraggiosa, appare paradossalmente rivoluzionaria proprio perché conservatrice dei valori più profondi della vita umana. Ma andiamo avanti con il gioco del nome: Antea. Acribico come sono, l’ho cercato sul vocabolario, però non ho trovato la parola. Credo comunque di averne trovato il senso. Infatti si scrive Antea ma andrebbe scritta così: ‘Ante a’, cioè “prima di qualcosa o qualcuno”. Come può un paziente dare un valore metaforico a questo bel nome? È presto detto: ‘Ante a’ sta a significare un’organizzazione di prua, che sta avanti, che viene prima, che anticipa i bisogni dei malati finora definiti “terminali”, cominciando con l’opporsi al dolore, per invertirne la tragica situazione di isolamento e abbandono alla morte anticipata. Vi pare poco? Ma continuiamo il gioco. Il naufrago è approdato fiducioso e, come sapete, nella vita, tanto più a fine vita, nelle cure palliative, la fiducia è la componente 116 fondamentale. Altrimenti, ve lo assicuro, resteremmo paralizzati nei gelidi flutti della paura, dell’angoscia, della morte incombente. E, credetemi, per quanto novellino, ne parlo con cognizione di causa: di recente ho già avuto la mia prima crisi di regressione e disperazione. E non sarà l’ultima. Però, se sono qui a narrarla, addirittura in modo ironico, vuol dire che sono stato aiutato a superarla, almeno in parte. Il bello è che in Hospice, grazie al paradosso della mobilizzazione rivoluzionaria/conservatrice, pur consapevole di essere giunto forse alla fine della vita, mi trovo a godere insieme un altro paradosso, quello di due prospettive apparentemente antitetiche. Vediamole insieme. Da una parte, una sana sensazione di appagamento. Anche morendo, in certi momenti mi sentirei sereno, potrei esclamare: “Ma che bella morte!”, circondato da affetto, curiosità intellettuale, un vero cenacolo di idee e sentimenti. E non parlo solo di amici e parenti, troppo facile. Mi riferisco anche e soprattutto agli operatori. Vi assicuro che la loro presenza rispettosa, il loro spirito di ricerca, la loro empatia, la disponibilità a comunicare con questo paziente rompicoglioni, sono essenziali. Per uno come me, che amava affibbiarsi orgogliosamente la definizione di Erri De Luca, “un albero che cammina”, perché aveva fatto del movimento fisico e intellettuale la sua ragione esistenziale, pensare di lasciare la vita in questo modo, in tale compagnia, sarebbe già consolatorio. Anche se, al dun- hospice e cure Con Silvia nei boschi di Pizzo Deta (1998) que, si muore soli, come ci ha ricordato Norbert Elias ne “La solitudine del morente”. Ma la notizia è un’altra. Il bello viene adesso. In certi momenti mi sto talmente reinnamorando della vita, sto talmente riassaporando – oltre l’ottimo vitto – il mio stile di vita precedente alla tragedia, che tutta questa voglia di morire svanisce. La sete di ricerca riappare, sembra quasi inesauribile, validamente sorretta da mani audaci ed esperte e da ruote di carrozzella ben gonfiate. A volte dunque i grandi problemi teorici di fine vita, le “scelte morali” (ben trattate da Eugenio Lecaldano, il direttore del Master di bioetica ed etica pratica da me conseguito), una volta eliminato il dolore fisico – quello che Sergio Zavoli ha definito “il dolore inutile” – si possono ripresentare come problemi pratici di riavvio della vita, e magari di una vita ancor più interessante di quella di pri- ma. E così posso dire anch’io, con l’amato Terzani, “la fine è il mio inizio”. Anche se non mi voglio ridurre al testamento, preferisco essere contagioso prima di andarmene, una specie – si parva licet – di “Gandhi dei malati”. Un Gandhi dei malati Ho però verificato che anche la misura e la terapia del dolore fisico sono una condizione necessaria ma non sufficiente. L’avevo già intuito da ricoverato nella clinica chirurgica dell’ospedale civile di Parma venti anni fa. Ora sono ancor più consapevole che occorre attrezzarsi, scientificamente e umanamente, per prevedere, ascoltare e alleviare la sofferenza spirituale: quella spesso indotta proprio dall’organizzazione distratta o indifferente oppure da familiari sospettosi o prepotenti, magari con le migliori intenzioni. E passo al terzo modo. Cari curanti dell’Hospice, ci tenevo a 117 essere presente al convegno. Non per esibire la mia forza di spirito, bensì per aiutarvi a riconoscere la mia e la vostra debolezza. Sembra un altro paradosso, ma penso che la frana che ci ha travolto nella mia ultima crisi e la reciproca ammissione di aver toppato in una situazione di emergenza con un paziente speciale, possa restituirvi lo spirito originario, aiutandovi a migliorare. Specie ora che state per fare un salto quantitativo, salto che deve essere anche e soprattutto qualitativo. Insomma, ancora una volta: rivoluzione e conservazione insieme. Per questo, da osservato- 118 re impaziente – che affida alla vostra pazienza la sua inerme nudità, le sue copiose urine e le odorose cacche, giorno e notte, senza mai cogliere un cenno, non dico di fastidio, ma financo di sopportazione, al massimo un segno di stanchezza – mi sono sforzato di distillare la rabbia. Che poi, diciamocelo pure, non cesserà subito. Non è questione di buone maniere. È che non so se potrò, se saprò mai accettare la condanna alla dipendenza e, forse, l’avvicinarsi della morte. Che non credo si possa esorcizzare con una bella definizione: “doln ce”, “amica” o quant’altro. Articolo pubblicato sul quotidiano “Metro” il 24 ottobre 2006 D opo il via del Governo c’è chi dice: “Liberi di farsi le canne”. Sciocchezze. Meglio inserirle nel Monopolio con una tassa: risolveremmo la Finanziaria. Ve lo dice un paziente paralizzato e ricoverato nell’Hospice Antea per metastasi vertebrali, ma in cure palliative, quelle che leniscono il dolore se il cancro non è guaribile. Per garantire una vita dignitosa sino alla fine servono medicine efficaci che l’Italia è tra gli ultimi a usare. L’indifferenza burocratica verso le sofferenze altrui e i pregiudizi hanno accumulato barriere contro i medicinali oppioidi. Finalmente il ministro della Salute fa una vera opera di semplificazione: inserisce due medicinali cannabinoidi tra gli stupefacenti a uso terapeutico (era ora, il principio della cannabis è efficace con nausea e vomito da chemioterapia e altri tipi di dolore: contrattura muscolare, emicrania...). Consente di prescrivere gli oppioidi con il ricettario normale, senza ricorrere a quelli speciali, e ne prevede l’uso anche per altre malattie croniche invalidanti. Se pensiamo che con lo stesso provvedimento hospice e cure Canne, dolore e buona morte vengono eliminati 5 milioni di certificati inutili, ci rendiamo conto della grandiosità dell’operazione. Basta? Hospice e Comitati etici Come paziente esigente che, alla fine della “carriera”, è protetto dal dolore in uno dei pochi veri Hospice italiani, propongo a sani e malati due obiettivi: un Hospice in ogni ospedale, in cui continuare a prendersi cura dei malati dimessi perché inguaribili o da cui seguirli a domicilio con èquipes di cure palliative; un Comitato etico in ogni ospedale per difenderci dall’accanimento, cioè dal tenerci attaccati ai tubi per farci sopravvivere a ogni costo. Invece dell’accanimento serve un po’ di aggattimento: meno macchine e più coccole. Proprio così: chi si avvicina alla morte sente il bisogno di gentilezza, come dice la protagonista del film di Mike Nichols “La forza della mente”. Se molti scrivessero questa volontà e i medici la rispettassero, chi chiederebbe l’eutanasia, cioè una buona fine? Casomai una buona canna n dal Monopolio. 119 Dialoghi su cure palliative e hospice Dagli articoli in forma dialogica scritti fra l’ottobre 2006 e il gennaio 2007 per l’inserto Salute di “Repubblica”. Botta e risposta con una giovane dottoressa dell’Antea di Roma Quali cure garantite in Hospice? Le cure “palliative” a dieci persone. Ma le garantiamo anche al domicilio di molti malati gravi. E cosa sono le cure “palliative”? Il contrario di quello che ha detto il ministro Di Pietro quando è intervenuto sulla Finanziaria: “Se c’è un malato, non gli si può dare un palliativo, bisogna curarlo”. Le nostre “cure” non sono le caramelle. Noi ci prendiamo cura delle persone con un tumore inguaribile, quando il male non risponde più alle terapie oncologiche: radio, chemio. E curiamo soprattutto i sintomi, cioè il dolore. Ma palliativo non vuol dire “placebo”, cioè inutile? La radice “pallium” vuol dire mantello. Non per coprire o, peggio, nascondere. Bensì utile per accompagnare e proteggere, per esempio, dal dolore inutile. Mi viene in mente il “tabarro” dei montanari. Ma anche la mantella dei preti… Sì, era il classico mantello. Quella dei preti probabilmente l’associa al fatto che fino a poco tempo 120 fa dell’assistenza ai morenti se ne occupavano solo loro. Mentre oggi? Oggi esistono strutture come questo Hospice per accogliere i malati che una volta si definivano “terminali” e assisterli, garantendo loro una vita dignitosa sino alla fine. Sono gestite da associazioni come la nostra, con équipes multiprofessionali che operano per lo più a casa dei malati. Qui si viene quando a casa emerge una crisi. E come mai lei, che è giovane, ha scelto di lavorare qui, dove i malati non guariscono? È vero, ancora pochi anni fa un medico “palliativista” era considerato un fallito perché cura gli inguaribili e spesso deve farsi carico dei “fallimenti” altrui. Ma, secondo lei, la vita finisce quando non si può più guarire dal cancro? Oppure comincia proprio in quel momento uno dei periodi più importanti dell’esistenza? La mia esperienza mi fa dire che è così, e non solo per i malati, ma anche per noi medici. Ho imparato molto più qui che all’università. Possibile curare tutte le malattie inguaribili? La medicina “palliativa” è stata definita negli anni ’80: per affermare il valore della vita, non prolungandola o abbreviandola a ogni costo. Per considerare la morte un evento naturale, non una sconfitta della medicina. Per alleviare il dolore aiutando i pazienti a vivere il più attivamente possibile sino alla fine e le famiglie a convivere con la malattia grave, poi con il lutto. In un Hospice o anche a casa? Innanzitutto a domicilio, evitando ricoveri in ospedale. Casa propria è il luogo di cure più ambito, per favorire il recupero delle capacità di autonomia del malato e delle competenze dei familiari. Lo facciamo giorno e notte con équipes formate da medico, infermiere, fisioterapista e psicologa. Ma se la famiglia non regge o interviene una crisi? Allora subentra l’Hospice. Perché non c’è tanto la paura di morire quanto di morire “male”, sof- frendo inutilmente. Quello che genera più disperazione non è tanto la malattia, la sofferenza o la morte, quanto la solitudine che prende quando non c’è più chi ti accompagni alla fine. E voi, così giovani, come accompagnate la morte? Noi non accompagniamo la morte ma le persone. Offriamo cure e farmaci adeguati, terapie riabilitative. C’è un desiderio di vita che ognuno conserva sino all’ultimo, anche nelle situazioni di malattia estrema, e che può essere custodito solo a condizione di essere assistiti e sostenuti insieme alla famiglia. Il nostro non è solo un rapporto di competenza o di carità: è di civiltà. Lavorare in Hospice significa operare al confine della vita, che resta sempre e comunque vita. Accompagnare vuol dire continuare a dare speranza quando tutto gioca contro, rispettando le scelte morali fatte dalla persona morente. hospice e cure “Hospice” vuol dire: ospizio, ospedale o “day hospital”? No, non è per mania di parlare inglese. All’origine c’è Cecil Saunders, una meravigliosa infermiera che 40 anni fa a Londra non abbandonò i malati persi dalla medicina, cioè quelli con malattie croniche “terminali”. Negli ospizi si assistevano i vecchi; negli ospedali si curavano i malati acuti, ma solo finchè c’era speranza di guarigione. Lei fondò l’Hospice per accogliere e curare gli “inguaribili”. Cioè le “disposizioni di fine vita”? Servono qui? In Italia non vale il principio giuridico della disponibilità della vita. Ma, secondo autorevoli ricerche, troppe volte la scelta del medico di fatto decide il momento della morte. Nel Dizionario di bioetica, il filosofo Lecaldano ricorda che disporre della vita con direttive moralmente vincolanti serve al malato per “individuare i modi responsabili ed eticamente accettabili per dare a essa una continuità, un senso”. Le “disposizioni di fine vita” per ora hanno questo importante valore morale. n 121 Volando in trance sul parco di Villa Ada Dall’intervento tenuto il 25 gennaio 2007 al convegno Antea “Psicoterapia ipnotica come ‘auto ipnosi’ nelle cure palliative” S e proprio devo definirmi, all’espressione malato terminale preferisco quella di morente: fin da quando nasciamo siamo tutti morituri, e prima o poi diventiamo quasi tutti moribondi e agonizzanti. Definendomi morente intendo rivendicare il mio essere un soggetto morale che, conoscendo la diagnosi e la prognosi che lo riguardano, sa di essere alla fine della propria vita e cerca di adeguare coerentemente l’una all’altra. Prima di provarla, non avevo idea di cosa fosse la psicoterapia ipnotica sotto forma di auto ipnosi. Pensavo fosse una forma di riabilitazione psicologica. Non m’era noto il significato tecnico-scientifico di auto ipnosi, ma non lo identificavo con quello divulgato dal circo mediatico televisivo. Inoltre, mantenevo ampia diffidenza verso le tecniche psicoterapiche, eccetto il “gioco della sabbia”. Primo, perché ho letto il saggio di Paolo Aite “Paesaggi della psiche” e gli interventi di Livia Crozzoli Aite nei libri curati per il Gruppo Eventi; inoltre, per averlo positivamente sperimentato su me stesso in 122 preparazione di un gruppo di auto mutuo aiuto fra malati di cancro, poi non realizzato. Il gruppo non si era formato, ma la “sabbia” aveva mostrato che dopo ben 50 anni non avevo ancora elaborato il lutto paterno. Insomma, non ero la persona più facile da convincere con proposte di auto ipnosi, rappresentando essa per me piuttosto una sfida: una provocazione, più intellettuale che emotiva, da raccogliere, da smascherare magari, senza farmi guidare dai pregiudizi e mantenendo una certa sana curiosità, insieme a una buona voglia di sperimentare novità e tecniche per distaccarmi dalle tensioni. Ora, dopo averla provata, penso che sia una tecnica utile, ma non da sola, e non per me solo. Lo stile metodologico e operativo della psicoterapeuta (così come quello del fisioterapista) mi pare avviato nella direzione di osservare, recuperare, valorizzare e riabilitare tutte le residue risorse interne dei malati affidati alle loro cure. Scherzando, dico che fa parte di uno dei modi di pensare e di agire esistenti e operanti tra i familiari, gli amici e i curanti intorno a me. Le defini- proccio psicologico, quando le ho usate per ridimensionare e sostenere i disagi del viaggio in ambulanza, dall’Hospice all’ospedale San Giovanni-Addolorata e viceversa, e dell’esame all’interno dell’ambulatorio radiologico. Era una risonanza magnetica total body particolarmente faticosa, i cui tempi si sono rivelati inaspettatamente lunghi rispetto a quelli attesi e predisposti dal primario. hospice e cure sco così: 1) agevolare; 2) agire; 3) fuggire. Della prima fanno parte coloro che cercano di convogliare in un alveo facilitante ogni sintomo positivo o negativo, ogni spiegazione, ogni indicatore. Un alveo scivoloso in cui lasciarsi andare, facendo – appunto – metaforicamente il morto, per morire addormentati. Della seconda fanno parte coloro che, avendo individuato la mia esigenza di fondo di intellettuale, quella di resistere per morire vivo, lucido, mi aiutano a resistere, cioè a nuotare il doppio solo per rimanere fermo al punto in cui sono, vivo: non per non morire, bensì per morire lucido. Della terza scuola posso dire che non si tratta di una drastica differenziazione dalle altre, né di una fuga totale dal difficile appuntamento con la propria morte oltre che con la mia: si tratta più spesso di una fuga parziale, nel tempo e nei modi. Un alto e basso che sta coinvolgendo anche me. Li capisco. Con la psicoterapia ipnotica per me è cambiato abbastanza, ma proprio in quanto mi è capitato di rimanere all’Hospice, di non tornare a casa. Mi pare utile e indispensabile poter usufruire, nella situazione in cui mi trovo, di un supporto del genere. Finora le tracce fornitemi – visiva, sonora, immaginativa, respiratoria e manipolatoria (la sabbia) – per distanziarmi ed estraniarmi dal dolore fisio-psichico e dalle preoccupazioni connesse, nonchè per ridimensionare fastidi come ansia, vertigini e dispnea, hanno funzionato. Fin dalla prima occasione, subito dopo l’inizio dell’ap- Sui sentieri del Sirente I fastidiosi rumori della procedura Rmn consistono in toni dapprima molto differenziati, poi martellanti e continui, poi di nuovo caotici con alternanze di tensione e di durata. Ebbene, i rumori sono “diventati” rispettivamente: dapprima quello del motore di un aereoplanino sul quale immaginavo di sorvolare Villa Ada, parco romano a me caro; poi quello di una carovana di muli carichi di legna e dotati di campanacci, che immaginavo inerpicata sui sentieri del Sirente, una montagna abruzzese anch’essa a me cara; poi quello degli squilli telefonici delle chiamate più affettuose ricevute nelle ore precedenti la prova. Infine, sono riuscito ad alleviare l’insopportabile durata della prova concentrandomi sulla respirazione, come le partorienti, al limite del disagio: ho assunto infatti un respiro convulso, addirittura mi sono mosso, tanto da costringere il tecnico a rifare alcuni esami. Inoltre, nella serie delle crisi interfamiliari, che hanno poi coinvolto l’Antea, importante è stato un altro ruolo della psico- 123 loga: ha ascoltato e ci ha aiutato, svolgendo – non so quanto consapevolmente sino in fondo – una funzione di mediazione e favorendo il recupero di risorse interne alla famiglia come unità sofferente e non solo a me. Così, con mia moglie, ho provato a manipolare la creta, a disegnare e dipingere con le tempere, a leggere poesie, a scriverle. In ciò favorito piuttosto che sollecitato, in un processo non lineare, fino alla trance: nei primi tempi un mero riposo, un chiudere gli occhi, una ricerca di silenzio, buio, ritiro, intimità (a volte di pianto), poi via via di maggior benessere. Di questo piacere si è rivelata componente la speranza indotta dalla terapia le volte che, pur facendomi rilassare, mi ha aiutato a spostarmi metaforicamente dal letto alla carrozzella, ovvero a sedermi sul letto, dal periodo in cui non mi sentivo più in grado di poterlo fare sino ad oggi. Saltando sulle sassaie Prima di concludere desidero far riferimento al nuovo materiale “auto ipnotico” recentemente introdotto dalla psicologa: si tratta di frammenti profumati, dotati di un particolare colore e capaci di produrre rumore. In un primo tempo mi hanno richiamato certe spiagge con una sabbia eccessivamente granulosa, ma poi mi hanno evocato 124 certe “sassaie” da attraversare in alta montagna, specie sotto le pareti: un pietrisco in cui è possibile saltare a piè pari per scendere e attraversare in sicurezza. Basta non soffrire di paure. Ebbene, l’associazione tra le mie esperienze dolomitiche e la nuova esperienza di rievocazione delle sassaie, grazie a questa tecnica auto ipnotica, mi ha permesso di trarne un beneficio importante: l’aiuto per riuscire a superare la pesante crisi determinata dalla necessità di prendere atto del blocco definitivo di ogni movimento (paralisi “inoperabile” e “irreversibile”). La mia conclusione è questa: sì, la psicoterapia ipnotica (auto ipnosi) ha senso nelle cure palliative. Non so se sia una rivoluzione o una conferma rispetto al passato, ma so che la scelta – moralmente coraggiosa – appare rivoluzionaria perché conservatrice dei valori della vita sino alla sua fine. Come paziente che si autodefinisce esigente e morente, cioè consapevole della forza di spirito di cui è portatore e della rete di sostegno affettivo, ringrazio i garanti di questa performance. A partire dalla direzione dell’Antea e dai suoi bracci operativi (la psicoterapeuta Monia Belletti e il fisioterapista Claudio Pellegrini) per finire a tutti i curanti: medici, tecnici, infermieri e operatori, comn presi i volontari. Intervento pubblicato postumo sulla rivista “Fisioterapisti” n.20 Gennaio-Febbraio 2007 S ulla vostra rivista (n.18 del Settembre/Ottobre 2006) è uscito un interessante articolo di Patrizia Brugnoli, della “Fondazione italiana di leniterapia” di Firenze, con il titolo “Trasparenza, informazione, consenso. Cure palliative: quale etica?”. Ho avuto l’occasione di leggerlo presso l’Hospice Antea di Roma, che mi assiste per una paralisi midollare dovuta a metastasi della colonna vertebrale. Infatti, sono un malato oncologico in fase terminale. Il mio primo cancro (alla vescica) risale al 1997, e tuttora sta in fase di remissione; il secondo (alla prostata) è emerso nel 2000, ma fin dall’inizio si è rivelato violento e veloce: esattamente il contrario di quello che succede nella maggioranza dei casi. Infatti il cancro alla prostata ha una progressione lenta e silente, tanto è vero che nell’ambiente gira una battuta di questo tipo: “Si muore col cancro alla prostata, ma non di cancro alla prostata”. Su di me posso dirvi poche altre cose: ho 67 anni e sono sposato da oltre quaranta. Abbiamo due figli, uno informatico e l’altro giornalista, con tre nipotine. hospice e cure Diventare sciamano quando torno polvere I miei studi più recenti sono stati di bioetica. Ho partecipato al Master in bioetica ed etica pratica organizzato all’università La Sapienza. Dunque, mi sono trovato ad affrontare questi temi come studioso e come paziente. Mi sono in seguito coniato un’autodefinizione che riunisse le due identità: paziente esigente, intendendo esigente innanzitutto con me stesso. Potete così immaginare i motivi del mio interesse per l’articolo casualmente incontrato sui tavoli dell’Hospice. Soprattutto laddove si afferma giustamente che “nessuno può rivendicare la superiorità della propria etica rispetto a un’altra”. Tale affermazione si riferisce ai grandi temi della bioetica (inizio vita, disposizioni di fine vita o direttive anticipate, eutanasia) e ribadisce una mia convinzione in proposito. Fin dai primi studi, infatti, mi ha colpito la diversa importanza che si era venuta conquistando l’etica cosiddetta “di frontiera”, quella appunto legata alle scoperte scientifiche e tecnologiche, rispetto all’etica che chiamerei “quotidiana”, quella cioè legata alla malattia, al dolore, al ricovero ospedalie- 125 ro, al parto, al rapporto medicipazienti,ecc. Per cui anch’io mi sono chiesto se per caso qualcuno possa rivendicare la superiorità della propria morale rispetto a un’altra, e anch’io sono convinto (come l’autrice dell’articolo sulla vostra rivista) che in materia di morale ciò che conta sono i comportamenti concreti, piuttosto che gli atteggiamenti o i meri convincimenti. Regole e codici Infatti, a che servono le poche regole reciprocamente plausibili che bastano a fondare un’etica “comune”? Servono a garantire una convivenza pacifica e civile tra persone, comunità e società che si riconoscono in norme morali diverse. Per esempio, non è detto che ai malati vadano bene le regole del “Codice deontologico” che si sono dati unilateralmente i medici e gli infermieri (quelle che un grande bioeticista ha definito “etichette”, per distinguerle dalle regole condivise). Altro esempio: non è detto che a tutti vadano bene le norme desunte da una morale religiosa oppure ideologica, per cui possono benissimo convivere persone che le regole le traggono da una fede e persone che invece (non avendo la “grazia” della fede, come me), se le costruiscono ogni giorno e ogni giorno… si mettono in gioco. L’autrice, peraltro, non si riferisce al rapporto tra una qualsiasi comunità e/o società, bensì a quello assai delicato tra i singoli fisioterapisti (“davanti al tribunale della propria coscien- 126 za”) e “il proprio gruppo di lavoro, nel quale un posto privilegiato è occupato dal paziente e dalla sua famiglia”. Ecco perché mi sono sentito tirato in ballo e mi sono permesso di scrivervi la mia opinione. Tanto più che l’autrice, sottolineata l’importanza che ogni scelta operativa di ciascun professionista “riveste in relazione al tempo e alle risorse che il paziente ha a sua disposizione”, ricorda alcuni punti saldi stabiliti dalle società internazionali di cure palliative, da un lato, e dal movimento hospice, dall’altro: a) che il malato e la sua famiglia partecipano all’équipe; b) che la definizione di cure palliative “pone ogni nostra scelta all’interno di una cornice dai contorni più definiti”. In particolare Patrizia Brugnoli richiama l’attenzione sul valore etico della trasparenza dell’intervento terapeutico nell’ambito delle cure palliative. Tanto più che ancora non esistono protocolli o linee guida circa lo specifico intervento del fisioterapista “nella gestione dei bisogni di una persona in fase avanzata di malattia”. Esistono insomma ampi margini di discrezionalità, a fronte della carenza di un metodo e soprattutto dei princìpi morali che lo fondano. Per concludere, mentre fin qui ho concordato con le osservazioni dell’autrice, da qui non mi ritrovo nelle sue definizioni: per esempio, ella definisce “efficace” l’intervento che “rappresenta una risorsa conoscitiva per gli altri operatori” e “inefficace” o inutile quello che “spreca tem- hospice e cure Coccolando la nipotina Giorgia (1995) po prezioso per le persone che potrebbero utilizzarlo altrimenti”. Mi spiace, ma a me proprio non pare che le cose stiano così. “Inefficace” qui sta per “inefficiente”: l’efficienza, così come l’informazione (il “consenso informato”) e la stessa medicina “basata sull’evidenza”, costituiscono “condizioni necessarie ma non sufficienti” per un’autentica comunicazione tra curanti e curati. Di più. Che senso ha parlare di spreco di tempo prezioso riferendosi solo agli operatori e ignorando noi malati terminali e/o morenti (cioè consapevoli della propria terminalità)? La mancanza di condivisione di tali motivazioni colpisce sia il malato, le sue aspettative, sia il fisioterapista: impedisce un’etica della fisioterapia per le cure palliative. Ovvero per quella fase della vita in cui interventi tera- peutici (come la fisioterapia e magari la psicoterapia sotto forma di auto-ipnosi) apparentemente superflui, si rivelano invece utili e maieutici: utili, per aiutarci a vivere sino in fondo la nostra vita, e maieutici, per consentirci di scoprire, valorizzare e vivere sino in fondo le potenzialità e le risorse. Un bel paradosso Pensate che bel paradosso: dover aspettare di essere sul punto di morire, di “lasciare la vita”, per diventare consapevoli e magari (soggetti morali) attivatori di facoltà mai prima esercitate. Altro che risorse residue… A me sembra un po’… come diventare sciamano proprio quando torno polvere, senza altro domani di quello che, da bright, “splendente di luce propria”, avrò seminato sotto forma di memoria condivisa. n 127 memoria Alla manifestazione del 25 Aprile a Roma (1987) Un eroe mite Silverio Corvisieri E Ha lottato per consentire a tutti di vivere e morire con dignità roismo è una parola che può provocare irritazioni cutanee per l’abuso che se ne è fatto (soprattutto a destra, ma anche a sinistra). Non riesco tuttavia a trovare un termine più adatto per definire il comportamento di Gianni Grassi nella sua ultima battaglia, quella condotta nei lunghissimi otto mesi della fase terminale della sua malattia. Paralizzato dal costato in giù, dipendente da uomini e strumenti sanitari per molte funzioni vitali e anche per il più piccolo movimento, piagato e bucherellato, con il corpo deformato a causa delle terapie in corso da dieci anni, Gianni ha dato il meglio di se stesso nel perseguire quello che da tempo era diventato il suo obiettivo primario: l’“utopia concreta” – così l’aveva definita – di rivoluzionare la comunicazione tra medici e pazienti, una autentica “lotta di liberazione” da “padroni” (camici più o meno arroganti, idoli onnipotenti e indifferenti) e da “dipendenti” (pigiami più o meno ignoranti, credenti impotenti e rassegnati) allo scopo di trasformare, gli uni e gli altri, in “collaboratori nella ricerca del comune sapere, nel rispetto della reciproca autonomia, nella cura delle rispettive manchevolezze e potenzialità”. Nelle notti insonni, febbrilmente impegnato a pensare e a scrivere analisi, proposte, invettive, divagazioni poetiche, ironie emiliane, così come nelle ore del giorno vorticosamente riempite da un incessante confronto dialettico con i medici e da dialoghi stimolanti con familiari, amici, vecchi e nuovi compagni, personalità impegnate nei temi “etici”, Gianni ha continuato a testimoniare e a battersi, fino all’ultimo istante, per consentire a tutti di vivere e morire con dignità. Quest’ultima era la frase che ripeteva più spesso nelle ultime settimane. Tutta una vita d’impegno politico e civile (come militante di Avanguardia operaia, sindacalista, pacifista, ambientalista, sociologo, pubblicista, organizzatore culturale, studioso della condizione dei non vedenti) ha così trovato coronamento in una battaglia che era, al tempo stesso, spirituale e materiale, in una visione di “religiosità laica”. Amava dire che rispetto agli 131 anni giovanili, di cui nulla rinnegava, aveva “più fiducia che fede, più ideali che ideologia”. Eroe, dunque, ma eroe mite che ancora alla vigilia della morte progettava di scrivere favole per bambini e si preoccupava di donare a una futura madre un libro utile alla sua creatura. Ricordo che due anni fa, al termine di una faticosa ascesa al rifugio Sebastiani, in Abruzzo, quando già il suo corpo era minato dalle metastasi, anzichè tirare il fiato e ammirare il paesaggio, trascorse più di due ore a raccontare favole e a conversare con un bimbetto che viveva lassù e che, in mancanza di coetanei, l’aveva atteso con impazienza. Non c’è dunque da stupirsi se per i malati terminali Gianni invocasse l’aggattimento terapeutico al posto dell’accanimento: tenerezza, finezza psicologica, gentilezza e anche farmaci antidolore, insomma “meno macchine e più coccole” come aveva felicemente sintetizzato in uno dei suoi ultimi articoli. I suoi furori e i suoi sdegni contro ingiustizie, ipocrisie, arroganze, meschinità, soprusi e persino, a volte, nei confronti delle persone e delle cose più amate, erano l’altra faccia della medaglia di un uomo sempre pronto a pagare di persona e a dare tutto se stesso. Lo voglio ringraziare ancora una volta, perché purtroppo vin viamo in un mondo che ha ancora bisogno di eroi. Pacato, labbra fine, sguardo chiaro, Più resistente der cement’armato, Lui nemmanco la morte l’ha piegato È questo Gianni Grassi, amico caro, Disponibbile a tutte le richieste Ma sempre e soprattutto intransigente Ner tutelà i diritti della gente Contro ‘r Potere, ch’è la vera peste Concludendo però con il sorriso D’un cuore trasparente come ‘r vetro. E se per caso esiste ‘r Paradiso Quello vero, no quello dei prelati, Lo vedo già a discute co’ San Pietro Pe’ difenne i diritti dei Beati. Carlo Misiano 132 Le cerimonie La mattina del 6 febbraio 2008, ad un anno dalla morte, con una cerimonia alla quale erano presenti un centinaio di persone è stata inaugurata la targa toponomastica con la quale è stato intitolato a Gianni un largo nel parco romano di Villa Ada. Prima che venisse scoperta la targa ha suonato il sassofonista Nicola Alesini. Per il Campidoglio erano presenti gli assessori all’Ambiente e alla Cultura, Dario Esposito e Silvio Di Francia. Nel pomeriggio si è tenuta una seconda commemorazione con un incontro nella Sala della Pace della Provincia di Roma a Palazzo Valentini – grazie alla disponibilità dell’assessore alla Cultura, Vincenzo Vita – dove è stato proiettato il documentario “Intorno alle ultime cose”, realizzato dalla regista di Rai3 Francesca Catarci. Anche il 7 febbraio 2009, nonostante il tempo inclemente, una cinquantina di persone hanno partecipato alla cerimonia in ricordo che si è tenuta nel largo di Villa Ada. Ha suonato nuovamente il sassofonista Nicola Alesini e alla fine tutti i partecipanti – dai bambini sino ai più anziani – si sono dati la mano in silenzio, indirizzando un pensiero a Gianni e formando una catena umana, un inedito girotondo con gli ombrelli sotto la pioggia. 133 Il largo di Villa Ada I l largo intitolato a Gianni dentro Villa Ada (Roma) si trova nella parte alta del parco, raggiungibile dalle entrate su via Salaria. Da queste si scende sino al laghetto superiore, prendendo poi una scalinata che porta ad una stradina in terra battuta che conduce al largo. Sulla targa c’è scritto: Largo Gianni Grassi - Sociologo e giornalista (1939-2007) È bello legare il ricordo di Gianni al prato, alle panchine, agli alberi, ai cespugli, ai tronchi caduti mentre nuovi bambini, ragazzi, coppie, individui ripetono passi liberi e gesti intimi... Questa frase dell’amica Elvira Guida ben sintetizza lo spirito che ha spinto oltre mille persone a sostenere la proposta di intitolazione di un luogo di Villa Ada alla memoria di Gianni, lui che tanto amava e frequentava il parco. L’idea è stata subito accolta dall’assessore all’Ambiente del Comune di Roma, Dario Esposito, che ha scritto: “Mi unisco con entusiasmo alla richiesta, sottoscritta già da tanti cittadini che hanno avuto, come me, la fortuna di aver conosciuto personalmente Gianni e le sue battaglie. Il vuoto che ha lasciato è incolmabile ma far rivivere il suo nome, legandolo al luogo che gli era più caro in assoluto, potrebbe rappresentare un piccolo risarcimento per tutti coloro che lo hanno perso e un tributo di riconoscenza da parte di questa città, per questa Villa che tanto ha contribuito a tutelare”. Immediato anche l’appoggio dell’assessore alla Cultura, Silvio Di Francia, così come quello del presidente vicario del Consiglio regionale Lazio di Italia Nostra, Franco Medici, con queste parole: “Sosteniamo con convinzione la richiesta di intitolazione alla memoria di Gianni Grassi di un largo di Villa Ada, già sottoscritta da tanti cittadini che hanno conosciuto il suo lungo e generoso impegno ambientalista (e non solo). Legare il nome di Gianni Grassi ad un luogo di Villa Ada significa riconoscere la passione e l’onestà morale con la quale si è sempre battuto in difesa di questo storico parco urbano. Significa anche dare valore nella memoria collettiva di Roma a quei cittadini che si sono spesi per la coln lettività, con coerente spirito civico e raro altruismo”. 134 Il largo intitolato a Gianni nel parco romano di Villa Ada Un momento della cerimonia in ricordo tenuta nel febbraio 2009 135 Un sogno realizzato Lorenzo Grassi Discorso all’inaugurazione di largo Gianni Grassi P er noi famigliari oggi si realizza un bellissimo sogno, del quale ringraziamo di cuore Silvio Di Francia e Dario Esposito, che hanno subito accolto e sostenuto la nostra idea. Quando abbiamo lanciato la proposta di dedicare a Gianni un luogo del parco di Villa Ada, neanche noi potevamo immaginare il grande seguito che avrebbe avuto. Per questo ringraziamo i tanti che hanno firmato la richiesta e i molti amici di Villa Ada. Per noi era solo una speranza pensare di riuscire a inaugurare questa targa nel primo anniversario della scomparsa di Gianni. Invece, tutti insieme, ci siamo riusciti. Abbiamo proposto di ricordarlo qui – come ha scritto con poesia un’amica – perché “è bello legare il ricordo di Gianni ai prati, alle panchine, agli alberi, ai cespugli, ai tronchi caduti di Villa Ada… mentre nuovi bambini, ragazzi, coppie, individui ripetono passi liberi e gesti intimi”. Gianni si è sempre battuto – con generosa passione, coerenza e intransigenza – per difendere questo parco dagli inquinamenti “morali e materiali”, ad esempio contro l’invadenza delle auto o per chiedere, concretamente, dei gabinetti. Questo è un parco al quale siamo legati da profondi ricordi personali. Con la mia famiglia, con mio fratello, a Villa Ada ci siamo cresciuti e andati a scuola. Frequentavamo questo slargo sin da piccoli e lo chiamavamo le “tre altalene”, perché un tempo ospitava dei giochi per bambini. Nei prati qui vicino abbiamo passato, con allegri pic-nic, molti degli ultimi momenti belli con nostro padre, prima della sua paralisi. Qui intorno “nonno” Gianni ha tenuto per mano le nipotine che muovevano timidi passi, ha giocato con loro a nascondino dietro gli alberi. Qui ha fatto l’ultima passeggiata sulle sue gambe. È un luogo raccolto e tranquillo: per chi ha voluto e vuole bene a Gianni (che riposa nel cimitero di Berceto, suo paese natale sull’Appennino parmense) sarà bello poterlo venire a ricordare anche qui in mezzo ai prati. Sono state messe delle panchine – che non c’erano più da anni o erano rotte – dove poter sostare, leggere e riflettere in serenità. In futuro, forse, 136 si potrebbero rimettere anche le altalene, per rendere vivo questo largo con le voci dei bambini, che Gianni avrebbe voluto vicini e dai quali era amatissimo, perché li incantava con favole e giochi infiniti. Gianni è stato così tante cose insieme che quando abbiamo pensato a quale scrivere sulla targa ci siamo smarriti: forse “paziente esigente”, per la sua tenace ricerca di un rapporto paritario tra medico e malato e le sue battaglie contro il dolore inutile, per il diritto/dovere di morire bene, con dignità, di ‘morire vivi’ come diceva lui. E ancora: libero pensatore, ecologista, uomo di pace (ma critico con i pacifisti)... e tante altre ancora. Abbiamo scelto Sociologo nel senso più ampio di ‘studioso e indagatore dei rapporti e dei fenomeni sociali’: nella sanità, nel sindacato come nella politica. E Giornalista. Lo era diventato ufficialmente solo pochi mesi prima di morire, ma lo era stato da sempre: nel fondare e promuovere riviste, quotidiani e radio, nel culto della scrittura e nella sua sconfinata curiosità. Gianni – che un amico ha definito un “eroe mite” – amava ricordare che alla fine della vita si raccoglie quanto si è seminato durante l’arco dell’intera esistenza, soprattutto in termini di relazioni e amicizie. I tantissimi amici presenti qui, oggi, testimoniano quanto abbia seminato bene. Ancora grazie di cuore n a tutti e a quanti hanno reso possibile questo sogno. 137 Seguiamo il suo esempio Silvia Arbicone Discorso alla cerimonia del 7 febbraio 2009 a Villa Ada F arò dei flash in modo che ognuno possa ritrovare i suoi ricordi e se desidera condividerli. Persa e in qualche modo liberata, così mi sentivo subito dopo la morte di Gianni; adesso prevale il senso di perdita “se ami un uomo o una donna che muoiono prima di te, allora conosci la vera solitudine”, dice il nonno al nipote in un film russo. Al centro dell’attenzione di Gianni c’era la persona (“facevi sentire tutti esseri pensanti”, così ha scritto la donna che gli puliva la stanza), soprattutto se era più debole: dai ciechi (il padre era diventato cieco, quando lui era piccolo, e sino alla fine ha scritto per la loro rivista); ai bambini handicappati per inserirli nella scuola elementare (“hanno la scusa della cacca cioè di chi li dovrebbe accompagnare al bagno” diceva); agli stranieri per regolarizzarli; ai malati; ai morenti. In tutti individuava limiti ma anche risorse da attivare, insieme, nel Gruppo Eventi come all’Antea. Forse si ricordava di quando, appena nato, sua zia Pina aveva esclamato “l’è brut ma l’è simpatic!”, o di quando era in collegio a Parma. Era stato in collegio dalla prima media al terzo liceo, dove aveva scoperto le differenze di classe, costretto a raccogliere dal cestino i quaderni, appena usati, che i ricchi buttavano, lui che era lì con la borsa di studio, perché i suoi non avevano i soldi per farlo studiare. Il padre cieco non aveva ancora la pensione e lo stipendio della madre insegnante non bastava: anche se la madre si era opposta con tutte le sue forze, perché anche lei era dovuta andare in collegio. In collegio era soprannominato “muscoli zero”, per la sua magrezza, come risposta si era messo a fare atletica, correndo sugli 800 metri. La rapidità di riflessi gli era rimasta e gli aveva permesso di scappare dai fascisti, che lo volevano picchiare, dopo un comizio che aveva tenuto a piazza Tuscolo. Nessuno aveva avuto il coraggio di farlo e lui si era offerto. Il suo più importante modello di riferimento dopo il padre (per la dignità e per la sua intransigenza con sé stesso e con gli altri) è stato lo zio emigrato in America, dove era diventato comunista, morto di leucemia a Roma – Gianni lo aveva accom- 138 In barca a Palinuro (2005) pagnato a visitare la città e fino alla morte – che gli aveva insegnato a non arrendersi Anche qui risorse e limiti indissolubili. Gianni impostava le relazioni sul dialogo, sull’uguaglianza e il rispetto reciproco: quando era studente di Giurisprudenza non era riuscito a laurearsi, perché pretendeva di essere interrogato dal titolare e di esprimere il suo giudizio, più che ripetere il contenuto del libro. Così era il suo rapporto con i medici, durato ben dieci anni, per non farsi medicalizzare, per garantirsi il più possibile una qualità della vita, (“poca morfina, perché dormire è morire”). Più aggattimento e meno accanimento terapeutico è stato il suo slogan finale. Studio e ricerca continui Aveva una sua cartella clinica, che aggiornava prima di ogni visita e che dava al medico, spesso ringraziato (“facessero tutti così!” dicevano alcuni, altri invece si preoccupavano del loro potere assoluto messo in discussione da un “paziente esigente”, come soleva definirsi). Prima di ogni visita preparavamo insieme le domande da fare, per evitare di dimenticarle. Questo lo obbligava ad uno studio e ricerca continui (in collegio doveva, la sera, quando chiudevano le luci, leggere con una piccola pila sotto le coperte), dalla laurea in Sociologia, nel 1985 a 46 anni, con la tesi, diventata poi il libro Scioperare stanca, dedicata alla lotta che aveva fatto per sciogliere gli enti inutili (in particolare l’Unione italiana ciechi dove lavorava) cercando forme alternative allo sciopero, fino all’ultimo Master in bioetica. Intellettuale intransigente, scrutatore di anime, ha fatto sua la sua vita, non tollerando ipocrisia, falsità, imbrogli, mantenendo le promesse. Curioso per tutte le forme di cultura, 139 dalla poesia, al teatro, alla danza (mi faceva ridere la sera, quando dopo uno spettacolo, provava a rifare quello che avevamo visto), alla musica (aveva studiato da piccolo il violino e gli sarebbe piaciuto poterlo ancora studiare insieme al sassofono). Aveva interessi enciclopedici che spesso gli permettevano di essere in anticipo sui tempi e di vedere lontano (in montagna lo prendevamo in giro quando intravvedeva sentieri spinosi, per noi inesistenti, li chiamavamo “i sentieri di Gianni Grassi” che delle volte ci avevano obbligato a tornare indietro o a fare testa a testa con gli stambecchi). Ascolto con empatia L’ascolto, l’empatia, la solidarietà (ricordo che era andato per solidarietà con Radio donna, a Radio città futura, dopo l’attentato, a tenere una trasmissione notturna), la disponibilità fino all’annullamento di sé (spesso motivo dei nostri conflitti) erano le sue caratteristiche. Viveva senza orologio né portafoglio: il suo tempo era soggettivo e senza interesse per i soldi. Le sue radici contadine e di paese sempre valorizzate con l’interesse per la natura e per un turismo di qualità dalle Cinque Terre, a Sabaudia, a Ponza, Rocca di Mezzo, Alpe di Siusi. I viaggi non lo attiravano quando lo sguardo rimaneva esterno: ma Gerusalemme e il giro ipnotico, al suono delle tablas, intorno al tempio d’oro in India lo avevano colpito. Quando l’ho conosciuto aveva 22 anni, si professava esistenzialista, era a Roma da poco, ma la conosceva più di me, perché appena arrivato in un agosto torrido, l’aveva studiata a fondo con la sua caparbietà. Sant’Ivo alla Sapienza l’aveva affascinato per sempre, anche se la fontana delle tartarughe lo attraeva nello stesso modo. C’eravamo incontrati all’università, alla sezione del Psi del quartiere dove il professor De Marchi faceva conversazioni sull’educazione sessuale e soprattutto sulla legalizzazione dei preservativi e poi ad una festa a casa dei miei zii (dove per ballare il rock and roll gli ero saltata addosso, in modo inatteso, facendolo cadere...). Insomma per farla breve... si iscrisse al Pci per amore nei miei confronti (io facevo attività politica già dall’età di 14 anni) e lo dovette pure dichiarare pubblicamente in assemblea, come si usava fare per i nuovi iscritti. Nel 1964 ci sposammo. Usciti sulla piazza del Campidoglio chiedemmo alla compagna che ci aveva sposati a che punto era la legge sul divorzio, per ribadire il desiderio di una libera scelta quotidiana di stare insieme, contro l’indissolubilità. Avemmo subito i due figli (li avevamo sognati vedendo due bambini che giocavano sul mare), ci facemmo aiutare dal Centro nascita Montessori, diretto allora da Elena Giannini Belotti, per prepararci, insieme agli altri, al difficile compito. Poi vennero i centri Rousseau per passare le vacanze in gruppo. Una coppia di lunga durata, amore, conflitti ma tenacia e resistenza 140 nella fiducia e nell’amore. Cominciò una lunga attività politica: io nella scuola, lui nel pubblico impiego (si definiva “civil servant”), nel sindacato e nel Pci, poi nel 1968 lo lasciammo. Gianni si impegnò a costituire Avanguardia operaia a Roma, occupandosi soprattutto del giornale e del finanziamento. Poi con la crisi dei gruppi (avrebbe voluto fare un’inchiesta per sapere dove erano finiti i suoi compagni) ha cominciato a fare sempre di più della sua vita personale un’attività politica (già avevamo cercato di farlo per la famiglia, tentando di trasformarla in una “pattuglia di combattimento”), occupandosi di pace andando in Bosnia, di ambiente, partecipando al Forum sociale a Firenze. Così, nell’ultimo periodo, con l’aiuto di una compagna ex Avanguardia operaia, Virginia Ciuffini, è riuscito anche a considerare la malattia come un manifestarsi della verità della vita, come uno strumento di crescita per sé e per gli altri, come un modo per continuare a fare politica, aiutato dalla sua grande facilità nello scrivere. Noi eravamo i suoi tesori: io la sua volpe argentata, Pietro l’adorato, Lorenzo il cocco segreto (per evitare le gelosie del primo), la madre riscoperta, morta a maggio, il fratello custode dei suoi ricordi più antichi, le nuore che avevano superato il difficile esame di custodire i suoi tesori e che gli avevano donato il regalo più bello: tre splendide nipoti che garantivano la nostra immortalità, diceva Gianni, per le quali avrebbe voluto avere il tempo di scrivere la sua vita. Insieme a tutti gli amici, come voi, che gli hanno permesso di morire “vivo” come desiderava. Una persona straordinaria come molte persone comuni, consapevoli di sé stesse nel mondo, con il desiderio di trasformarsi e trasformare il mondo. n Diamoci da fare seguendo il suo esempio. 141 Un bercetese a Roma Matteo Scipioni Articolo pubblicato il 7 febbraio 2008 sulla Gazzetta di Parma G ianni Grassi non era famoso, ma è diventato “grande”. Non era uomo comune: era “paziente” e “esigente”. A sottolineare queste caratteristiche, la sua coerenza. Gianni Grassi era grande perché si è semplicemente fatto voler bene. Da tutti. La testimonianza, ad un anno esatto dalla morte, arriva da una città che ha amato – ricambiato – e da un luogo che ha adottato, come un figlio, il “polmone” verde di Roma, verde e tranquillo come la sua amata Berceto: il parco di Villa Ada. Si sono attivate più di mille persone perché uno spazio di questo parco fosse dedicato a lui. Ieri l’intitolazione ufficiale. Una targa che porta il suo nome è lì dove lui passeggiava, dove i suoi figli sono cresciuti tra giochi e chiacchierate e dove le sue nipoti corrono. Un luogo che ha imparato ad amare grazie alla moglie Silvia, romana doc. Compagna di una vita da cui ha anche assorbito la passione per la politica. L’assessore alla toponomastica del Comune di Roma, Silvio Di Francia, sottolinea: “Non siamo stati noi a voler intitolare questo spazio a Gianni Grassi, è stata la gente”. Parenti, amici, colleghi di lavoro ma anche chi, fino all’ultimo, ha visto spegnere un vero e proprio vulcano di iniziative e energie dedicandole al prossimo, erano lì a commuoversi ma anche a sorridere pensando a quanto Gianni ha speso e dato per tutti. Villa Ada compresa: fu proprio lui a raccogliere migliaia e migliaia di firme, con la meticolosità che lo caratterizzava, affinché lo spazio privato del parco diventasse pubblico. Così è stato, e la rete che segnava il confine era lì, a pochi metri dalla targa. Ieri pomeriggio, la giornata era stupenda, il sole faceva capolino tra i rami di un parco incantevole. “Largo Gianni Grassi” è nel cuore di Villa Ada, il silenzio è suggestivo, rotto da qualche ragazzino che grida. Nicola Alesini con il sax intona “Bella ciao”, “La ballata dell’eroe” e “La guerra di Piero”, Carlo Misiano ricorda Gianni con una poesia. Roma ha reso onore a questo bercetese che, come ricorda il fratello Giorgio, seguendo un vero e proprio codice genetico di famiglia, “era sempre a caccia della verità e della giustizia. Divenne sociologo e, poco 142 prima di morire, giornalista. Fece il sindacalista, ma non gli piacque e smise: era per le cose giuste, cercava la verità. Era uno che le cose le voleva cambiare, come mio padre”. Gianni ha voluto essere sepolto a Berceto, ha scelto lui il posto: “che ‘guardasse’ la casa dov’era nato”, spiega il fratello Giorgio. La parmigianità Un curriculum di pubblicazioni, quello di Grassi, lunghissimo; sterminati i suoi interventi e gli articoli. Dopo il trasferimento a Roma non ha mai voluto staccare il cordone ombelicale con la sua terra: “Ritornavamo tre volte l’anno – ricorda il figlio Pietro, quello che, più di tutti, ha ereditato la parmigianità del padre – Sapendo che mio padre lavorava all’Inps, tutti venivano da lui a raccontare disguidi e problemi: mai un ‘no’. Si portava le pratiche da esaminare anche a casa”. Ci sono i colleghi più stretti, quelli che con l’accento romano sorridono e ti dicono “Gianni... il parmigiano? Ci riempiva di funghi e castagne”, ci sono anche quelli che con lui avevano rapporti saltuari, ma ieri non hanno voluto mancare: “Una persona straordinaria: limpida e coerente, una vera fortuna aver n avuto a che fare con lui”. 143 Sei poesie Grazie Wit (Per un ospite dell’Hospice Antea) La vita, la tua di certo, è corta. Ma tu sai corteggiarla perché ti renda amore prima che passi il tempo e ti arrenda alla morte. Ma non al dolore: a quello ci pensa il dottore. Dopo una giornata serena “Chi muore tace, chi vive si da pace” l’interpreto così: la pace eterna sinonimo di morte, la pace terrena sintomo di vita, la vita, appunto, in pace. Quella che mi piace. All’Hospice (da Catullo, carme 68) Illa domus Qui è la mia casa Illa mihi sedes Questa è la mia dimora Illic mea carpitur aetas Qui la mia vita continua e si consuma. 144 A Pantelleria (1998) Fine stagione Come se fossi morto mi ricordo la nostra primavera, la sua luce esultante che dura tutto un giorno, la meraviglia di un giorno che passa. Il mio dolore è quieto sta con me, non va via, mi fa compagnia. Vive nell’ultima stagione dell’anno e della vita… Giorno che te ne vai e nulla sai di me, della violetta che tanto amo e del ramo nudo del castagno. Giorno non andar via... Altri giorni verranno e tornerà nel turno delle stagioni un tempo simile a quello che ci fa sentire il primo freddo, il soave morire dell’anno, come un uccellino si ripara nella siepe arruffata. Pesano gli anni sulle spalle che ami. 145 In passeggiata sull’isola di Ponza Alla madre Vieni, andiamo, è ora di lasciare se al Gran Paradiso vuoi arrivare. Io mi fermo alla soglia, voglio un’esequia spoglia ma un gran bel funerale. Perdonami di averti ingannata, ignorata, forse disprezzata, di averti sentita inadeguata al Cervino paterno, al monte Bianco. Vuoi venire con me, urne appaiate, nel gran tour del ritorno bercetese? Alla Rocca, alle Ariette al Marzatore e finalmente a casa al cimitero sotto il Sardello, senza più fardello? 146 A Silvia È l’alba. Dal cortile dell’Hospice il canto di un uccello. Sempre quello. Ogni mattina mi richiama alla vita. Quella vita che non voglio lasciare. Tra poco la stanza splenderà del tuo sguardo solare. E poi verranno i figli, i parenti, gli amici. È bello saperlo, ma non trattengo il pianto e mi compiango. È duro mostrarsi sereno tutto il giorno: forse non rivedrò, da Ponza, Palmarola; l’Altipiano delle Rocche e i Rocchigiani. Non vedrò i fiordi dal postale norvegese, né dal cargo le torri di New York. Non ho registrato le fiabe per le bimbe, né le storie raccolte all’ospedale; non ho finito di leggere Terzani, né di scrivere sul lutto al “Gruppo Eventi”. Quante cose non fatte, quante ne restano da fare. Roba da disperare. Uscirò dallo scrigno ovattato dell’Hospice? A farcela senza affetti e competenze, senza tecniche e virtù etiche, estetiche ed erotiche? Non lo so, ma speranze ne ho. In te soprattutto. Che non vuoi lasciarmi solo sette giorni. Tu, proprio tu, che per strada m’hai lasciato o a Villa Ada, nella vita di prima. Non vuoi lasciarmi solo a questionar con loro senza il filtro del tuo paziente amore? Grazie, ma mi fa incazzare: io vorrei andare al mare a Palinuro, magari in carrozzella. Anche al mio funerale. Per godermelo in pace insieme a te. 147 Ho molto apprezzato i suoi scritti, così vicini al mio pensiero e al mio impegno rivolto ad una sempre maggiore sensibilizzazione verso la necessità di instaurare un rapporto medico-paziente che sottenda empatia e una condivisione del vissuto umano ed emozionale del malato. Allora in quest’ottica anche l’informazione chiara, corretta e puntuale, il comunicare – fatto di tanti come, fino a che punto e quando – pur prendendo in considerazione il problema o gli eventi, deve in qualche modo spostare il suo fuoco di attenzione centrandosi, orientandosi prima di tutto sulla persona. Infatti, come lei, credo che la malattia debba essere vissuta con dignità e che il morire bene sia per il paziente – e cito le sue parole – un diritto sociale e bioetico. Un impegno che, la scienza prima e il medico poi, devono portare avanti con determinazione per difendere dalla sofferenza inutile che tradirebbe – in una fase delicata della vita – l’integrità intellettuale e morale dell’uomo. Non vi è confine allo sforzo di limitare il dolore, non vi è confine alla necessità di privare i volti dei malati dai segni non solo fisici, ma soprattutto psicologici e spirituali, lasciati dalla malattia e dal dolore fisico, dalla cattiva comunicazione. Non vi è confine di fronte al rispetto della vita, non vi è confine che freni nell’obiettivo non solo di “curare” il paziente e il dolore ma di “prendersene cura”, perché la malattia e la sofferenza – seppure parte del naturale ciclo vitale – non devono diventare esperienza mortificante e avvilente per la dignità di ogni creatura umana. Umberto Veronesi (Milano, 30 dicembre 2004) 148 POSTFAZIONE Pieno d’amore per la vita Sen. Umberto Veronesi Chirurgo • Direttore scientifico Istituto Europeo di Oncologia C A Lorenzo Grassi aro signor Grassi, mi permetta di rinnovarle ancora una volta la stima per la figura di suo padre. La ringrazio per avermi segnalato il sito nel quale sono raccolti gli scritti di quest’uomo pieno d’amore per la vita. Non sono riuscito a soffermarmi su tutti i brani, ma quelli che ho letto mi hanno toccato per la profonda attenzione alla dignità del morire, per la lucidità con cui ha analizzato gli aspetti filosofici, etici, biologici e giuridici della fine della vita. Condivido pienamente l’importanza di informare il malato, la necessità di instaurare un rapporto empatico tra medico e paziente, il diritto e il rispetto delle scelte di fine vita. Principi che, vivendo quotidianamente insieme alle mie pazienti la sofferenza e il dolore, ho sempre difeso e sostenuto. La sua proposta di redigere una breve postfazione a questa raccolta di scritti, mi creda, mi ha onorato e insieme commosso. A malincuore, proprio per il sentimento che ho maturato, devo tuttavia dirle di non essere in grado di poterlo fare. Vi ho riflettuto a lungo e penso che il tempo che ad essi potrei dedicare, poche righe scritte tra un impegno e l’altro, non darebbero pregio al valore intellettuale, morale ed umano di suo padre. Sono certo che non sarà la mancanza della mia postfazione a privarlo del doveroso merito. Chiunque si accosterà al lavoro di suo padre con cuore limpido e aperto ne resterà impressionato e saprà coglierne la profonda essenza. (Milano, 30 ottobre 2009) 149 indice Passando il confine di Ignazio Marino 5 Lettere a un ospedaliere 7 Un dolore ingiusto, indegno, ignobile Noi siamo un colloquio La goccia scava la roccia Alle gentili infermiere Ascolto montessoriano, attenzione e azione Autobiografia Cronologia Testamento biologico Fine vita L’ultimo evento. Ma non disperato Il dovere, difficilissimo, di perdonare Garantire sino alla fine le scelte fatte in vita Bisogna essere Papa per farsi rispettare? La vera buona morte non è staccare la spina Dialoghi sulle ultime volontà e per morire bene La speranza di morire vivo Comunicazione Per una “validazione consensuale” in ospedale Due per sapere, due per curare C’è bisogno di costruire una bioetica quotidiana Un terreno comune di ascolto attivo Il dito di Caravaggio nella piaga della ricerca 9 11 13 38 41 43 44 46 49 51 53 54 57 59 60 63 67 69 74 86 88 92 Guaritori feriti 95 La nemesi di stare dall’altra parte “Vo’ a casa a morire”. In memoria di Bartoccioni 97 100 Hospice e cure Maria Occhipinti, appartenevo ai sofferenti Cure complementari e mobilitazione dell’anima Come riuscire a dare un significato al dolore Una ricerca di senso, speranza e amore Mi sto talmente reinnamorando della vita Canne, dolore e buona morte Dialoghi su cure palliative e hospice Volando in trance sul parco di Villa Ada Diventare sciamano quando torno polvere 103 105 107 110 113 115 119 120 122 125 Memoria 128 Un eroe mite di Silverio Corvisieri Le cerimonie Il largo di Villa Ada Un sogno realizzato di Lorenzo Grassi Seguiamo il suo esempio di Silvia Arbicone Un bercetese a Roma di Matteo Scipioni Sei poesie 131 133 134 136 138 142 144 Pieno d’amore per la vita di Umberto Veronesi 149 Grafica e layout • Maria Luisa Battiato [email protected] Le illustrazioni del libro sono di Pino Lena
Scaricare