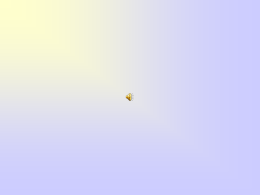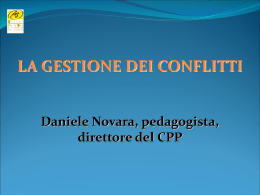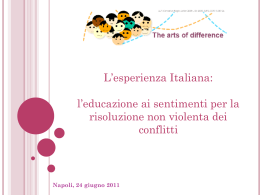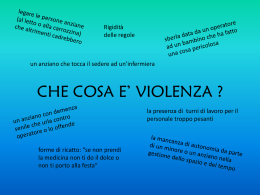Giovanni Bechelloni Enrico Cheli (a cura di) Comunicazione e Nonviolenza Dai problemi di comunicazione alla comunicazione come risorsa Mediascape Edizioni Working Papers Online 1 Questo testo viene distribuito in formato elettronico e gratuitamente. L’utilizzo commerciale integrale o parziale è vietato senza espresso consenso scritto dell’Editore che rimane titolare, insieme agli autori, di tutti i diritti. Ogni altro uso è consentito purché venga citata la fonte. ISBN 88-89240-13-X Copyright © 2004 by Mediascape s.r.l. 50127 Firenze, via Valdichiana, 60 00199 Roma, via di Novella, 11 http://www.mediascape.it e-mail: [email protected] PRESENTAZIONE Questo libro raccoglie gli atti della II edizione del convegno nazionale interdisciplinare La comunicazione come antidoto alla violenza, svoltosi a Firenze il 13-14 giugno 2003 e incentrato sulle politiche e le metodologie di prevenzione e gestione costruttiva dei conflitti. Il convegno, organizzato nell’ambito delle XV Giornate Fiorentine della Comunicazione dalle Università di Firenze e Siena, si è articolato nelle seguenti sessioni: - INTRODUZIONE - LA SOCIETA’ MULTICULTURALE: DAL CONFLITTO DISTRUTTIVO ALLA DIVERSITA’ COME RISORSA - PREVARICAZIONE E VIOLENZA NELLA SCUOLA - LA VIOLENZA NEI MEDIA - CONFLITTI COSTRUTTIVI E DISTRUTTIVI NELLA COPPIA E NELLA FAMIGLIA - LA VIOLENZA SUL LAVORO E NELLA SOCIETÀ CIVILE Sono intervenuti relatori provenienti da Università, Istituti e Centri di ricerca di tutta Italia con un’ampia e diversificata estrazione disciplinare: dai sociologi agli psicologi, dagli urbanisti ai politologi, dai formatori ai manager. Comitato organizzatore: Prof. Giovanni Bechelloni (Università di Firenze) Prof. Enrico Cheli (Università di Siena) Prof. Alberto L’Abate (Università di Firenze) I edizione del convegno: Università di Siena sede di Arezzo, 17-18 maggio 2002. Atti pubblicati in: Enrico Cheli (a cura di) La comunicazione come antidoto ai conflitti, Punto di fuga editore, Cagliari 2003. INDICE Parte 1 Introduzione 9 22 30 1.1. Ambiguità comunicative: esclusione, violenza, violentizzazione di Giovanni Bechelloni (Università di Firenze) 1.2. La rivoluzione interpersonale: comunicazione, consapevolezza e crescita nelle relazioni con gli altri di Enrico Cheli (Università di Siena) 1.3. Formare alla nonviolenza in una società violenta di Alberto L’Abate (Università di Firenze) Parte 2 La Società multiculturale: dal conflitto distruttivo alla diversità come risorsa 39 44 47 54 59 60 2.1. Il conflitto religioso nella società multiculturale di Lucia Ricco (Assemblea Spirituale Bahá’í d’Italia) 2.2. La moltiplicazione delle dignità di Maurizio Lozzi (Università di Cassino) 2.3. Progetto multicultura: la scoperta dell’altro di Elisabetta Damianis (Counselor) 2.4. La gestione costruttiva dei conflitti etnici metropolitani: l’esempio della Polizia di Cristiano Inguglia e Ronan Di Maria (Università di Palermo) 2.5. Violenza e nonviolenza nel “Movimento dei movimenti” di Enrico Euli (Università di Cagliari) 2.6. La comunicazione non verbale e gli immigrati di Ada Cattaneo (IULM) Parte 3 Prevaricazione e violenza nella scuola 75 85 91 99 3.1. Educare al conflitto a scuola: modelli ed esperienze di Angela Dogliotti Marasso (Centro studi D. Sereno Regis, Torino) 3.2. I processi vitali per la pace e nutrimento della vita umana in J. Adams e M. Montessori di Giovanna Providenti (Università Roma Tre) 3.3. Comunicazione dei valori e società “buona”: il ruolo della scuola di Tiziano Telleschi (Università di Pisa) 3.4. Un caso reale di bullismo: Gaetano e Paolo di Paolo Nicosia (Università di Pisa) Parte 4 La violenza nei media 107 4.1. Comunicare la morte quando torna la “vecchia attrice” (Robert Capa) di Paolo Archi (Università di Firenze) 6 111 115 121 Comunicazione e Nonviolenza 4.2. La riduzione polemica dei processi economici di Carlo Catarsi (Università di Firenze) 4.3. Il paradosso della comunicazione dei buoni di Andrea Volterrani (Università di Firenze) 4.4. Il ruolo dei media nella rappresentazione della violenza: pacificatori o amplificatori di conflittualità? di Enrico Cheli (Università di Siena) Parte 5 Conflitti costruttivi e distruttivi nella coppia e nella famiglia 129 133 138 144 152 5.1. La comunicazione con l’inconscio di Daniele Cardelli (Università di Firenze) 5.2. L’intelligenza emotiva: dalla mediazione del conflitto alla relazione costruttiva di Maria Martello (Università Ca’ Foscari, Venezia) 5.3. Il counseling relazionale come approccio costruttivo ai conflitti di Enrica Brachi (Università di Siena) 5.4. Il ruolo della comunicazione nelle teorie della soluzione nonviolenta del conflitto di Antonino Drago (Università “Federico II”, Napoli) 5.5. La comunicazione violenta: la rabbia come allarme ed antidoto alla violenza di Fiorella Tonello (Mediatori Familiari Associati) Parte 6 La violenza sul lavoro e nella società civile 159 162 167 171 178 183 188 195 6.1. La comunicazione agita come risorsa per gestire i conflitti di Carlo Bandiera (IRI Management/Università “Tor Vergata”, Roma) 6.2. Il Mobbing: una trappola della comunicazione e un’atipica sfida per la non violenza di Giuseppe Mani Monteverde (Consulente gestione conflitti) 6.3. Migliorare il clima aziendale attraverso la comunicazione di Iscander Micael Tinto (Consulente e formatore) 6.4. Le rappresentazioni del conflitto nei gruppi di lavoro di Nicola Lopane (Università di Perugia) 6.5. Il bisogno di sicurezza e la difesa civile di Francesco Tullio (Università di Siena) 6.6. Possibilità e vincoli della comunicazione: quando la comunicazione è realmente alternativa alla violenza di Paola Rebughini (Università di Milano) 6.7. Dialogo e violenza: una prospettiva interculturale di Claudio Baraldi e Alberto Dreossi (Università di Modena e Reggio Emilia) Note sugli autori Parte 1 Introduzione Parte 1 - Introduzione 9 1.1. AMBIGUITA’ COMUNICATIVE Esclusione, violenza, violentizzazione di Giovanni Bechelloni 1.1.1. Diciotto citazioni per orientarsi … L’intellettuale non è, in quanto tale, uomo d’azione: anche se agisce per conto d’altri, non è certo per il suo lavoro al servizio del governo o per la sua lotta clandestina che egli è intellettuale. L’uomo d’azione parte da valori che si giustificano da sé; l’intellettuale, al contrario, ne fa l’oggetto stesso della sua riflessione. La sua funzione è essenzialmente critica, ma nel senso costruttivo del termine: constata il dato particolare che tutti noi viviamo nell’universale e crea uno spazio nel quale si possa dibattere la legittimità dei nostri valori. Egli rifiuta di veder ridotta la verità sia alla pura verità-conforme, di adeguamento ai fatti, a cui si richiama lo scienziato, sia alla verità-in-divenire, di svelamento, a cui si richiama il militante; aspira piuttosto a una verità-in-divenire e di consenso, verso la quale si procede accettando l’analisi riflessiva e il dialogo. Tzvetan Todorov (1995), Le morali della storia, p. 302. … l’essere umano si caratterizza per la possibilità di esercitare liberamente la sua volontà, di praticare delle scelte di cui si assume la responsabilità. In breve, è un essere morale. Se la cosa è vera per tutti gli esseri umani, vale ancor più per gli intellettuali, dei quali una caratteristica costitutiva è che essi aspirano ad affrancarsi dalla loro condizione particolare e a giudicare il mondo con criteri disinteressati… Ibidem, p. 303. Si può dunque ammettere che gli intellettuali, a volte, esprimono gli interessi delle loro corporazioni o della loro classe; che, in certe circostanze, mettono le loro capacità al servizio diretto dei loro interessi, della Rivoluzione o dello Stato; e tuttavia affermare che questa constatazione non è sufficiente per farci comprendere la funzione degli intellettuali, poiché in ognuno di questi casi la libertà, necessaria per definirli tali, si trova a essere alienata. Per fare qualche passo avanti, ci servirà gettare un rapido sguardo alla storia recente della nostra società, e vedere che cosa ci insegna al proposito. Ibidem, p. 305. Se si vuole che gli intellettuali abbiano una funzione, allora, bisogna lottare per il mantenimento o il ristabilimento di una vita pubblica, che sia altra cosa dalla giustapposizione e dalla protezione di tante vite private… Ibidem, p. 310. … Un ruolo essenziale spetta dunque a tutti i media, che permettono di stabilire questo contatto tra l’intellettuale e la società: il libro e la stampa, la radio e la televisione, il cui pluralismo è indispensabile alla libera espressione. Contrariamente a quanto pensava Benda (ma egli aveva dei gusti elitari), il giornale quotidiano favorisce la democrazia, invece di intralciarla. Ibidem, p. 311. … l’intellettuale critico non si accontenta di appartenere alla società, egli agisce su di essa - scegliendo di renderla più simile agli ideali a cui essa stessa si richiama. Egli giudica la società attuale non dall’esterno ma restituendo ai suoi principî quell’intensità che hanno perduto; egli richiama l’attenzione non su una rivoluzione radicale, né su un ritorno al passato, ma sulla rinascita di un ideale in qualche modo estinto. Agire in questo modo è più che un diritto: è un dovere che gli viene imposto dal ruolo stesso che occupa in seno alla società democratica. Ibidem, pp. 312-313. Non partecipando alla gestione del potere ma non mostrando disinteresse per la vita pubblica, Socrate trova, per descrivere la sua funzione, un’immagine curiosa: egli si vede “posto dal Dio ai fianchi della città come un tàfano ai fianchi di un cavallo grande e di buona razza, ma proprio per la sua gran- 10 Comunicazione e Nonviolenza dezza un poco tardo e bisognoso di essere stimolato. Così appunto mi pare che il Dio abbia posto me ai fianchi della città: ne mai io cesso di stimolarvi, di persuadervi, di rampognarvi, uno per uno, standovi addosso tutto il giorno, dovunque” [Platone, Apologia di Socrate, in Opere complete Laterza, Bari 1982, N.d.A.]. Giocare il ruolo di tàfano o, ancora, dello sprone della società: ecco, allora quale potrebbe essere la funzione dell’intellettuale moderno, se non ha troppa paura di subire la sorte di Socrate. Ibidem, pp. 313-314. Io credo che l’immagine sia violenta di per sé perché si impone subito con la sua sola presenza, in tutta la sua verità. Perché la violenza è sempre questo: la violenza è sempre una verità che non si dimostra, che non si argomenta, ma che si impone in un colpo solo. Ciò forse vuol dire che la violenza dell’immagine è uguale alla violenza di un colpo, di un colpo che appunto impone così la sua verità… Jean-Luc Nancy (2003), Anche un bacio è violento, p. 22. If we ever hope to experience widespread, domestic tranquility, then the present landscape of our complex societies must be drastically changed. Civil minor communities can no longer be limited to certain protected pockets or regions of a society, but must be extended to every corner of it. For this to happen, we must search for and promote programs that change malignant minor communities that exist anywhere in our society into civil ones. No matter the race, ethnicity, religious creed, or income of the members of a minor community, they should not be condemned to live and die within the confines of a malignant or even a turbulent minor community… Lonnie Athens (2003), Violentization in Large Social Context, p. 37. If more and more of the civil minor communities that comprise our present civil society degenerate into turbulent one as ultra-violent and violent community members start competing with marginally violent ones for dominance and as violent and non-violent dominance engagements start competing for institutionalization within their borders, then we could all find ourselves living in a turbulent major community of society. If more and more of our turbulent minor communities degenerate into malignant ones as ultra-violent and violent community members climb to the top and drive marginally violent people to the bottom of their dominance orders and as violent dominance engagements come to prevail over non-violent ones within their borders, then violent dominance engagements will no longer be an idiosyncratic or even a bastard institution, but a societal one, and then we all could find ourselves living and working within one gigantic, malignant society. If we allow the latter development to become a reality, then our only recourse will be to work and live in sealed-off and heavily fortified minor civil communities or to find another civil society somewhere else on the earth in which to move. Finally, although civil major and minor communities are always preferable to malignant or even turbulent ones, they are now far from perfect in their operation. The non-violent means that marginally violent people now use to win dominance engagements could stand considerable improvement. Otherwise, the most underhanded and expedient, marginally-violent people will not only continue to rise to, but also to stay at the top of the dominance orders in civil major and minor communities - a high cost to pay for preventing ultra-violent and violent people from monopolizing these positions in our society. Ibidem, pp. 37-38. Now, on the topic of war between liberalism and its enemies, the Islamists did have something to say to us, and it was Sayyid Qutb who offered the clearest exposition. Qutb always recognized that Islamism’s truest enemy was not a military force but, instead, an insidious penetration of cultural influences and ideas - the ideas that, in his word, threatened to “exterminate” Islam. The struggle, as he interpreted it, was mental, above all. The war between liberalism and Islamism mirrored perfectly, in this respect, the earlier wars between liberalism and other forms of totalitarianism. Those earlier wars were always decided, in the end, by something other than marching armies. The wars came to an end when the apocalyptic ideologues, in a fit of lucidity, gave up at last on their apocalypses. When people talk about 1989 and the fall of the Berlin Wall, that is what they really mean - the moment when Communists in Eastern Europe finally recognized that communism was an error, which left everyone else free to construct a different kind of society. Communism’s doctrinal collapse in Europe took place without a shot being fired - a nearly miraculous event, if you calculate the odds. Nothing like that in Parte 1 - Introduzione 11 the case of the Fascist Axis. Still, even there, the ultimate triumph over fascism, the triumph that endured, came about only when the main Fascist countries, with a lot of help and guidance from outside, agreed to uproot their own thinking and political cultures in favor of something news - a process that took much longer than the fighting itself, and may still be going on, here and there. In the Second World War, D-Day was a capital event; but de-Nazification was the victory. Paul Berman (2003), Terror and Liberalism, p. 183. The panorama of the Terror War out for this kind of activism in our own time, as well - a Third Force, different from the conservatives and the foreign policy cynics who could only think of striking up alliances with friendly tyrants; and different from the anti-imperialists of the left, the left-wing isolationists, who could not imagine any progressive role at all for the United States. A Third Force, neither “realist” nor pacifist - a Third Force devoted to a politics of human rights and especially women’s rights, across the Muslim world; a politics of ethnic and religious tolerance; a politics against racism and antiSemitism, no matter how inconvenient that might seem to the Egyptian media and the House of Saud; a politics against the manias of the ultra-right in Israel, too, mo matter how much that might enrage the Likud and its supporters; a politics of secular education, of pluralism, and law across the Muslim world; a politics against obscurantism and superstition; a politics to out-compete the Islamists and Baathi on their left; a politics to fight against poverty and oppression; a politics of authentic solidarity for the Muslim world, instead of the demagogy of cosmic hatreds. A politics, in a word, of liberalism, a “new birth of freedom” - the kind of thing that could be glimpsed, in its early stages, in the liberation of Kabul. Ibidem, pp. 189-190. But the totalitarian movements flourished also because the climate of modern life allowed them to flourish. To arrive at a situation in which Nazis have conquered Europe, you not only need to have the Nazis themselves, you need to have all the other right-wing movements that look on Nazis in a friendly light, and you need to have leftwing opponents like the anti-war French Socialists, who cannot see that Nazis are Nazis. To end up with Stalin tyrannizing half of Europe, you not only need the cagey Soviet leaders and the Soviet tanks, you need the naive trade union leaders and the ignorant workers, who believe what they are told. You need the foolish fellow travelers who never intend to be Stalinists themselves but who convince themselves that liberal societies are halfway fascist, anyway, and that communism is a forward step, for all its imperfections. The totalitarian movements arise because of failures in liberal civilization, but they flourish because of still other failures in liberal civilization, and if they go on flourishing, it is because of still more failures - one liberal failure after another. Right now we are beset with terrorists from the Muslim totalitarian movements, who have already killed an astounding number of people, mostly in the Muslim countries, but not just there. What have we needed for these terrorists to prosper? We have needed immense failures of political courage and imagination within the Muslim world. We have needed an almost willful lack of curiosity about those failures by people in other parts of the world - the lack of curiosity that allowed us to suppose that totalitarianism had been defeated, even when totalitarianism was reaching a new zenith. We have needed handsome doses of wishful thinking - the kind of simpleminded faith in a rational world that, in its inability to comprehend reality, sparked the totalitarian movements in the first place. We have needed a political left that, in its anti-imperialist fervors, has lost the ability to stand up to fascism - and has sometimes gone a little further down the slippery slope. We have needed a cynical application of “realist” or Nixonian doctrines over the decades - the doctrines that governed the Gulf War of 1991, the doctrines that even now lead to friendly ties with the most reactionary of feudal systems. We have needed an inability to cling to our own liberal and democratic principles, an inability even to articulate those principle. We have needed a provincial ignorance about intellectual currents in other parts of the world. We have needed foolish resentments in Europe, and a foolish arrogance in America. We have needed so many things! But there has been no lack - every needed thing has been here in abundance. Ibidem, pp. 206-207. We are in an absurd situation. Truly, this is a moment Camus would have appreciated. We have rea- 12 Comunicazione e Nonviolenza son to be terrified; but it is not a good idea to be terrified. Ibidem, p. 208. A war is a war, and there is nothing to draw comfort from. But neither do we have reason to tremble quite as violently as Henry James did, in 1914. James watched the simple hopes of the nineteenth century dissolve into nothing, and he trembled because he knew that all of civilization was floating helplessly toward Niagara. We don’t have to share his fear. Civilization has already gone over the precipice. That was the meaning of the twentieth century. Ibidem, p. 209. … But, unlike James, we do have the experience of the last many years to draw on, and the experience can tell us, in a general way, what aim to bear in mind. Describing the nihilists and their thinking, Camus wrote, “Here, suicide and murder are two sides of the same system”. We are the anti-nihilists we had better be, anyway. Events around the world have demonstrated the existence of an anti-nihilist system, too. The anti-nihilist system likewise has two sides. In the anti-nihilist system, freedom for others means safety for ourselves. Let us be for the freedom of other. Ibidem, pp. 209-210. Proprio per questo la possibilità suprema e più auspicabile consiste nell’affermazione cosciente e volontaria che l’uomo un giorno farà della sua corporeità e quindi della sua finitezza e della sua morte. Soltanto allora egli non dovrà spaccarsi e lacerarsi nella realizzazione della sua trascendenza pratica per quanto resti sulla terra come un guscio vuoto e indifferente - e potrà riappropriarsi della trascendenza teoretica, il primo inizio della sua storia. Essa, la trascendenza teoretica, può dargli la certezza di se stesso come uomo e va al di là di tutti i veicoli spaziali e di tutte le nebulose proprio perché è legata a un essere corporeo, caduco e mortale. Quando egli in modo conforme alle parole dell’Antico Testamento, ma in un senso assolutamente contrario, sembrerà essere diventato “come Dio”, conquisterà la più forte coscienza di rappresentare soltanto un essere che lotta per Dio o che dispera di fronte al nulla, poiché è un essere aperto al Tutto del mondo pur non dominandolo affatto. Ernst Nolte (2003), Esistenza storica. Fra inizio e fine della storia?, p. 622. Il dialogo è una scienza e un’arte. Implica la scienza di conoscere tanto se stessi (ivi compreso ciò che uno pensa e vuole) quanto l’altro; è la scienza che sa che nessuna di queste due conoscenze è esaustiva, né per me né per l’altro; è una scienza molto trascurata in un’epoca come la nostra, nella quale il trivium si è visto svilito in “triviale”. L’educazione alla pace abbraccia tutta l’educazione classica del pensare, parlare e ragionare, ovvero della dialettica, della grammatica e della retorica. Chi si chiude al dialogo potrà essere uno stratega astuto e di valore, ma generalmente è un ignorante per quanto concerne il trivium: non sa parlare né discutere né, in definitiva, pensare, per quanti calcoli e pronostici possa fare. Raimon Pannikar (2003), Pace e disarmo culturale, p. 153. 1.1.2. Pace e guerra, male e bene, ordine e disordine, violenza e comunicazione Le citazioni che precedono e i riferimenti bibliografici che seguono sono le tracce dei percorsi intellettuali che ho compiuto di recente o sto compiendo per affrontare, dal mio punto di vista, i grandi problemi che oggi fronteggiano la condizione umana: pace e guerra, male e bene, ordine e disordine, violenza e comunicazione. Problemi che solo uno sguardo superficiale può ritenere che siano i problemi di sempre. La loro declinazione attuale, infatti, assume una configurazione inedita che è la conseguenza della complessità dei processi di globalizzazione in atto o di quello che Norbert Elias ha chiamato “processo di civilizzazione” o di quella che Ernst Nolte chiama “esistenza storica” o di quella che Paul Berman individua come una nuova fase della guerra tra totalitarismi e liberal-democrazie, tra nihilisti e anti-nihilisti. Una guerra che, prima ancora di essere o diventare una guerra guerreggiata, è soprattutto una Parte 1 - Introduzione 13 guerra ideologica, intellettuale o simbolica. Come intellettuali sono state, prima e dopo la Seconda guerra mondiale, le guerre contro il nazifascismo e contro il comunismo sovietico che si sono combattute in Europa e nel mondo a partire dal 1917 (rivoluzione bolscevica). Il mio richiamo all’importante teoria della violentizzazione (violenza + socializzazione) prposta dal sociologo Lonnie Athens (allievo di Blumer e di Mead) introduce nelle riflessioni che qui svolgerò non solo un riferimento alla genesi della violenza in contesti micro-sociali ma anche all’approccio intellettuale utilizzato da Athens per costruire e scoprire la sua teoria: un approccio olistico all’esperienza biografica del singolo individuo. Come è noto ai lettori di Elias il processo di civilizzazione prevede una riduzione della violenza conseguita attraverso lenti e contraddittori processi di apprendimento che consentono agli esseri umani di imparare sempre meglio a controllare e a gestire le loro pulsioni distruttive: imparando così a distaccarsi da se stessi e a coinvolgersi nelle situazioni e nei contesti sociali nei quali vivono. Secondo Elias i processi di apprendimento che consentono agli esseri umani di vivere pacificamente in società sono lenti e vanno misurati sulle lunghe durate storiche; che ci appariranno meno lunghe se paragonate alla lunga durata della vita sulla terra: quella che ci sta alle spalle e soprattutto quella che ci sta dinanzi. Gli esseri umani, da questo punto di vista, non sono vecchi, come molti sostengono, bensì giovanissimi. Hanno cominciato da poco tempo (poco più di due secoli) a imparare ad autogestirsi attraverso l’invenzione delle istituzioni liberal-democratiche e di quegli specifici saperi che oggi denominiamo “scienze umane e sociali”. E, tuttavia, aggiunge Elias, i progressi che gli esseri umani hanno compiuto attraverso le invenzioni della scienza e della tecnica (molto più “avanzati” di quelli compiuti nelle scienze umane e sociali e nel perfezionamento e nella manutenzione delle istituzioni liberal-democratiche) consentono oggi di porre fine alla vita umana sulla terra: sia attraverso l’uso incontrollato delle nuove armi sia attraverso conflitti reciprocamente distruttivi. Questa novità assoluta della storia umana rende più impellente la ricerca del dialogo. Queste brevi notazioni, queste allusioni, possono meglio chiarire il mio punto di vista. Nell’affrontare temi di così grande momento ciò che innanzitutto mi anima è il desiderio di contribuire al chiarimento intellettuale. Perché credo nella forza delle idee, nello sviluppo della capacità di pensare, nell’utilità pratica della conversazione e del dialogo. 1.1.3. Chiarificazioni lessicali e concettuali Il titolo del nostro convegno - «La comunicazione come antidoto alla violenza» - nasce da una discussione emersa nell’ambito del nostro primo convegno - “La comunicazione come antidoto ai conflitti”. Sembrò allora che la parola conflitti fosse troppo generica per individuare il polo negativo della diade. I conflitti, infatti, possono non solo essere necessari ma anche utili per chiarirsi, se si contengono nell’ambito di un reciproco riconoscimento tra coloro che discutono, conversano o dialogano. Sono davvero pericolosi solo i conflitti distruttivi, quelli che comportano la negazione dell’altro, la distruzione reciproca. Di qui l’idea di centrare la nostra attenzione sulla violenza. Ma, a ben vedere, anche la parola violenza ha molteplici significati e non tutti sono negativi o spregevoli. Come qualsiasi vocabolario della lingua italiana ci può consentire di verificare. Come, per esempio, nelle seguenti 14 Comunicazione e Nonviolenza espressioni: “dolce violenza”, “amorevoli violenze”, “forza impetuosa”, “non la nostra fortuna, ma il nostro merito è capace di far violenza ai cuori”, “la violenza delle umane passioni”. Anche la parola violenza, dunque, può essere intesa in accezioni positive quando è collegata sia a determinazione, forza, carattere, passione sia a sentimenti gentili. E, perciò, anche nel caso di violenza occorre che essa sia accompagnata dalla specificazione “distruttiva”, se vogliamo aver in mente la polarità negativa. A maggior ragione se estendiamo l’ambito della violenza per includervi “la violenza simbolica”, della quale tanto ci ha parlato Pierre Bourdieu, soprattutto nei suoi primi lavori. Oppure se evochiamo la “violenza legittima” che è quella che può (e deve) esercitare lo Stato (e le sue istituzioni) avendone il monopolio, per ristabilire o mantenere l’ordine sociale condiviso, per contrastare forme di anomia o di alienazione sociale che preludono a situazioni di violenza generalizzata (come quella che evoca Lonnie Athens nelle sue ricerche). Ma occorre anche tener conto di altro. Alcune persone con le quali mi è capitato di interloquire in queste settimane che hanno preceduto il nostro convegno mi hanno interpellato con atteggiamenti di sufficienza dai quali emergevano due questioni assai significative ai fini della nostra discussione. Da un lato in relazione alla parola comunicazione, usata in senso generico e riduttivo e per lo più come sinonimo di tecnologie informatiche o di tecniche di manipolazione. Dall’altro lato in relazione alla violenza, della quale venivano sottovalutati gli aspetti negativi, le conseguenze devastanti per tutti coloro che la debbono subire sia come frutto di una forza illegittima e distruttiva sia come frutto di violenza simbolica prevaricatrice e tirannica. Tali reazioni mi hanno parzialmente stupito e mi fanno capire quanto lavoro di chiarificazione intellettuale ci sia da fare per evitare di apparire ad un tempo temerario, ingenuo, semplicistico. Temerario perché può sembrare che si voglia contrastare la forza delle armi, la violenza delle armi, con la forza di parole, teorie e comportamenti la cui forza (non solo morale ma anche intellettuale ed emotiva) sfugge ai più. Come se ignorassero la portata di ciò che comunicazione vuol dire. Ingenuo perché può sembrare che ciò che noi cerchiamo di costruire e sviluppare attraverso questi nostri incontri non sia tanto una nuova cultura della pace quanto la riproposizione di vecchi slogan pacifisti o peggio il mascheramento di ben altre strategie ideologiche. Semplicistico perché può sembrare che nel proporre il nostro tema noi ci accodiamo a tutti quelli che hanno idee molto semplici e bizzarre non solo degli esseri umani in generale ma anche dello stato attuale del mondo e dei conflitti che lo attraversano. Vorrei, a questo punto, chiarire subito che non ho nessuna difficoltà ad apparire o sembrare temerario. Se per temerario si intende avere il coraggio di pensare come possibile - oggi o in un lontano futuro - qualcosa che è molto difficile da realizzare, qualcosa che richiede grande determinazione nel costruire la fiducia necessaria per investire tempo, energie e risorse in un compito intellettuale che può far tremare le vene e i polsi. Come sicuramente è il caso per il progetto che ci vede coinvolti. Un progetto che non è da “voci che gridano nel deserto” o da “profeti disarmati” bensì da persone che stanno e operano nel mondo, che non hanno dimenticato la lezione del grande fiorentino e che sanno bene che gli esseri umani non sono come ci piacerebbe che fossero. Ma che sanno anche che gli esseri umani sono capaci di imparare e che possono essere convinti a farlo. Sanno anche che la battaglia delle idee può essere combattuta e potrebbe essere vittoriosa. Ed è per questo motivo che siamo qua. Per discutere. Per cercare, nel dialogo, le Parte 1 - Introduzione 15 vie da percorrere per costruire una cultura della non-violenza, una cultura della pace. La specificità del nostro apporto a questo dialogo consiste nella presunzione di aver cominciato a percorrere una strada - quella che porta a costruire una nuova e diversa cultura della comunicazione - che può essere di grande utilità per costruire una cultura della non-violenza e una cultura della pace adeguata (e cioè capace di incidere) ai rapporti di forza oggi esistenti, all’altezza, cioè, dei problemi che la globalizzazione sta ponendo. Consapevoli come siamo, io credo, che abbiamo la fortuna di poter agire - pensare, riflettere, dialogare - stando sulle spalle di alcuni giganti che hanno contribuito ad aprirci la mente e a rendere la nostra via meno impervia. Sia i giganti che hanno pensato e agito molto tempo addietro sia i giganti che hanno pensato e agito in tempi ravvicinati. Senza dimenticare tutti coloro che pensano e agiscono intorno a noi animati dal nostro medesimo scopo. Nessuno di costoro è stato o è ingenuo nel senso che a questo termine attribuiscono coloro che ci criticano perché rifuggono dalla complessità, dalla fatica che è necessaria per affrontare intellettualmente problemi complessi. Tutti, però, hanno avuto l’ingenuità di pensare praticamente, l’ingenuità che è necessaria quando si vogliono cercare e percorrere nuove vie per affrontare nuove sfide e nuovi problemi. Ingenui erano, in tal senso, l’ateniese Socrate e l’ebreo Gesù; ingenui sono stati per secoli coloro che hanno creduto nell’universalismo di Roma (VIS et LEX, forza e legge) che ha consentito all’africano Agostino e ai tanti che hanno costruito il cattolicesimo e il cristianesimo di far giungere fino a noi quella tensione universalistica senza la quale non potremmo nemmeno pensare la pace. Ingenui sono stati i nostri tre grandi fiorentini (Dante, Machiavelli e Guicciardini) che hanno per primi pensato quella libertà dei moderni che si incarna nelle costituzioni liberal-democratiche che scaturiscono dalle tre rivoluzioni che fanno nascere la sfera pubblica moderna (l’inglese, l’americana e la francese). Ingenui erano alcuni protagonisti di quelle rivoluzioni: da Thomas Jefferson a Benjamin Constant. Ingenui e temerari, ma anche realisti. Di un realismo che sa fare i conti con il mondo così com’è e, nello stesso tempo, sa intravedere la strada per cambiarlo, per renderlo migliore. Senza buttar via il bambino con l’acqua sporca. E, allora, per chiudere con queste preliminari considerazioni, il mio punto di vista sul nostro tema è quello di chi sentendosi un nano non ha timore di affrontare il grande problema della pace; perché si sente sicuro sulle spalle dei giganti che è riuscito a trovare. E forte di tale sicurezza si è dedicato, negli ultimi tempi, a esplorare temi molto più grandi di lui, rifuggendo sia dal pacifismo di maniera che riempie le piazze e mette in mostra bandiere colorate sopravvalutando la forza dei numeri sia dal realismo brutale di chi sopravvaluta la forza delle armi. Pacifisti e Realisti sottovalutano entrambi la forza delle idee. Io, per parte mia, sono convinto di aver cominciato a metter in campo buone idee, utili agli scopi della pace, della tolleranza, del destino delle liberal-democrazie. Sono, per ora, racchiuse nei quattro libri che ho dato recentemente alle stampe e che sono indicati in bibliografia. 1.1.4. Le ambiguità comunicative e i totalitarismi Se per comunicazione intendiamo l’arte dei sofisti, che già Socrate e Platone bollarono come 16 Comunicazione e Nonviolenza pericolosa e menzognera, se per comunicazione intendiamo le tecniche della manipolazione, della propaganda e della pubblicità, se per comunicazione intendiamo le nuove tecnologie o i supporti mediali, se per comunicazione, in altri termini, intendiamo l’assolutizzazione di una parte per il tutto, di una componente o di un supporto rispetto all’intero processo nel quale la comunicazione si realizza, ALLORA è inutile parlare di comunicazione come antidoto alla violenza. MA, SE per comunicazione intendiamo un processo o un insieme di processi i quali - pur utilizzando una pluralità di linguaggi (parola-immagine-gesto), una pluralità di tecnologie o supporti o media (la voce umana o la scrittura, il giornale o il libro, la radio o la televisione, il cinema o Internet…) e una pluralità di formati - si sostanziano in pensieri, dialoghi e conversazioni, in azioni in comune ALLORA abbiamo a che fare con ciò che più di ogni altro attributo caratterizza gli esseri umani. Senza comunicazione i figli di donna non sopravvivono alla loro nascita, non possono diventare esseri umani. Senza comunicazione non possono imparare a diventare esseri umani. In questo senso la comunicazione è antica, comincia ad esistere quando i nostri lontani progenitori hanno cominciato a diventare esseri umani, hanno cominciato a parlare e sono diventati consapevoli - unici tra tutte le specie viventi - di dover morire. Può sembrare paradossale che la comunicazione come “realtà umana” sia antica e la parola che oggi noi usiamo per denominarla sia recente. Non solo, ma la parola è stata usata (poco) per qualche secolo per denominare altri processi sociali e solo molto di recente tutti la usano a sproposito e comincia appena ad essere usata nell’accezione da me riportata. Dopo che Bateson (e gli altri della Scuola di Palo Alto) scoprirono il double bind (il doppio legame), la comunicazione disturbata tra madre e bambino. A partire dalle foto scattate da Bateson quando, a metà degli anni Trenta, accompagnò la moglie, l’antropologa Margaret Mead, nella celebre ricerca in Nuova Guinea che ripropose, per l’ultima volta, l’ennesima versione del mito del “buon selvaggio”. La madre allatta il bambino e quindi gli comunica un messaggio positivo e inclusivo di amore ma, nello stesso momento, alcune madri compiono gesti o atti che allontanano il bambino, lo respingono. Il bambino si trova così “legato” da una comunicazione ambigua e ambivalente, contraddittoria; non capisce bene se la madre lo ama e lo protegge o lo respinge. Da questa ambivalenza, da questo “doppio legame” possono derivare vari tipi di insicurezze o di disturbi psichiatrici che possono rendere problematici i processi di apprendimento del bambino, i suoi percorsi verso l’autonomia e l’adultità. Questa scoperta apre la strada verso quella che è stata chiamata la “nuova comunicazione”. E sulla scia di questa scoperta molte altre se ne faranno, attingendo a una pluralità di saperi e discipline che vanno dai lavori del primo Novecento della psicoanalisi di Freud e della fenomenologia di Husserl al recupero del grande lavoro di Darwin, dalla linguistica alla filosofia, dall’etnologia all’antropologia, dall’interazionismo simbolico all’etnometodologia fino al “linguistic turn”, all’”etnographic turn” e al più recente recupero dell’individuo e del soggetto che caratterizza l’approccio biografico e autobiografico degli ultimissimi anni nel più ampio campo delle scienze politiche e sociali. A chi scrive è capitato di recente, durante una giornata di formazione rivolta a medici e infer- Parte 1 - Introduzione 17 mieri di un grande ospedale fiorentino, di conoscere una nuova versione di una possibile comunicazione disturbata tra madre e bambino. Senza che io avessi esposto la teoria del double bind una infermiera raccontò l’esperienza di madri che mentre allattano il bambino rispondono al cellulare. Da me sollecitate sono emerse varie versioni di questa situazione: la madre che continua ad allattare mentre parla al cellulare, la madre che allontana il bambino dal seno e gli chiude la bocca con un ciucciotto e così via. Si accese un’interessante discussione dalla quale emerse che nessuno dei presenti aveva la più pallida idea dei possibili significati comunicativi di quelle situazioni. Ho avuto, così, l’ennesima conferma di quanto sia difficile far percepire l’importanza della dimensione comunicativa e di quanto sia diffusa intorno a noi, in quasi tutti gli ambienti, una versione riduttiva e banalizzante dei processi comunicativi e della loro rilevanza per la vita di relazione, per la costruzione delle identità individuali e collettive, per la conversazione e il dialogo, per la costruzione di significati condivisi e via dicendo. Non solo, ma, per certi aspetti, la diffusione quasi a macchia d’olio di una riduttiva cultura della comunicazione, tutta costruita sulle tecniche e sulle tecnologie, sta rischiando di impoverire quella originaria, anche se inconsapevole, cultura della comunicazione che, per certi aspetti, può essere considerata un tratto culturale di lunga durata e largamente diffuso del popolo italiano. (L’ultimo capitolo - «La maledizione del target» - del mio libretto intitolato Svolta comunicativa proprio su questo aspetto accende l’attenzione.) È un sintomo di questa difficoltà a percepire la nuova comunicazione la diffusione di usi lessicali impropri, come se il significato originario delle parole venisse derubato, piegato per dire financo l’opposto, o di comportamenti e gesti inappropriati rispetto agli scopi che si dice di voler perseguire. Non si tratta solo di uno straordinario impoverimento dei linguaggi d’uso quotidiano ma di una vera e propria incapacità a percepire il carattere relazionale del linguaggio, di ogni tipo di linguaggio. Con la conseguenza che se è vero, come è vero, che la comunicazione è innanzitutto tensione e apertura all’altro ciò che possiamo osservare e ascoltare intorno a noi è costituito soprattutto da una ricca gamma di non-comunicazione o di mala-comunicazione piuttosto che di comunicazione. È come se una grande quantità di persone si stesse trasformando in portatori di comportamenti autistici, chiusi all’interlocuzione, sordi alla convocazione. Alla luce di queste poche e sintetiche osservazioni mi pare chiaro che per poter pensare e utilizzare la comunicazione come antidoto alla violenza è necessario lavorare molto per costruire una nuova cultura della comunicazione. Capire che la comunicazione fa problema perché è difficile percepire l’altro, accoglierlo e convocarlo al dialogo. Capire che la comunicazione, così come viene intesa e praticata, è pericolosa (per sé e per gli altri) perché è disturbata e disturbante. Capire, infine, che la nuova comunicazione può diventare una risorsa (per se stessi e per la comunità di cui si è parte) solo se può essere praticata nella direzione opposta rispetto al comando e alla manipolazione (che possono essere forme di violenza simbolica altrettanto distruttive delle forme di violenza fisica). È in questo contesto di analisi come quello che abbiamo sommariamente esposto che il problema del terrorismo acquista tutta la sua drammaticità. Per tanti motivi. Innanzitutto per deliberati equivoci lessicali di cui sono autori i gruppi politici che usano l’arma del terrorismo 18 Comunicazione e Nonviolenza (o che sono alleati, simpatizzanti o sostenitori di tali gruppi). Gruppi politici molto potenti e particolarmente influenti su coloro che operano attraverso i media (anche perché possono contare sull’ignoranza e la superficialità di molti di loro). Vi sono, per esempio, gruppi politici palestinesi che pur usando ad abundantiam l’arma del terrorismo non vogliono che ciò che essi fanno venga chiamato terrorismo mentre vogliono che venga etichettato con tale nome ciò che l’esercito israeliano compie per difendersi dal terrorismo palestinese. E tutti noi possiamo constatare che tale forma di manipolazione non solo è diffusa ma ha qualche successo. In secondo luogo, sappiamo ormai da lungo tempo, noi italiani più e meglio di altri per aver vissuto i cosiddetti “anni di piombo”, che la straordinaria efficacia degli atti di terrorismo è dovuta in gran parte alla copertura mediatica che essi ricevono. Una copertura che è capace di moltiplicare la risonanza e gli effetti simbolici dell’atto terroristico fino a trasformare i media in dispensatori di quelle che già da tempo ho denominato “bombe mediatiche”. I cui effetti, dal punto di vista che qui maggiormente ci interessa (come costruire una cultura della pace) sono ancora più devastanti e pericolosi dell’attentato terroristico in quanto tale. In terzo luogo - e questo punto è il più importante di tutti, data la natura eminentemente politica del terrorismo - gli atti terroristici, a causa della loro dinamica e delle modalità con le quali vengono comunicati, riescono, paradossalmente, a nascondere le idee, i progetti e le intenzioni, di coloro che li compiono. La loro pericolosità, soprattutto agli occhi di coloro che si sentono politicamente, geograficamente o culturalmente, lontani dalle vittime abituali non viene percepita. Sicché risulta oscuro ai più il collegamento ideologico e politico che lega tra loro gli atti terroristici degli ultimi anni. Accade così che le conoscenze storico-filosofiche e ideologico-politiche che consentono di capire ciò che sta accadendo sono patrimonio condiviso di pochi esperti o studiosi che, per lo più, non riescono nemmeno (o non vogliono) comunicare ciò che sanno ai pubblici più ampi che costituiscono una sfera pubblica alimentata dai grandi e piccoli media e da intermittenti movimenti. Sia gli uni sia gli altri poco interessati, per motivi opposti, a illuminare una scena assai poco visibile e molto complicata da raccontare e da mostrare. Ecco, allora, che ci troviamo a parlare di pace sullo sfondo di un contesto molto male illuminato nelle parti più enigmatiche e profonde e fin troppo illuminato nella parti più superficiali e solo apparentemente fattuali. Chi ha già scritto che i fatti da soli dicono meno di quanto si pensi? Da dove viene questa deriva positivistica che ancora predomina sui media di tutto il mondo accecando il nostro sguardo e impedendoci di vedere ciò che, per definizione, non si può vedere? Quando leggo sui muri delle nostre città “Bush terrorista sei il primo della lista” oppure slogan sulla preferibilità dell’amore alla guerra o sulla maggiore pericolosità delle guerre economiche che cosa posso pensare sullo stato delle conoscenze oppure sulle intenzioni di chi scrive quegli slogan? Ingenuità, ignoranza, malafede? Francamente non lo so. Quello che so è che costruire una cultura della pace è maledettamente serio e difficile e vorrei tanto che fossimo in tanti a dedicarvi tempo e attenzione. E so anche che non si può costruire una cultura della pace se non si riesce a capire in quale mondo viviamo, da dove viene il pericolo e di quale pericolo si tratti. Non mi sento affatto tranquillo quando mi rendo conto che la maggior parte delle persone che vivono intorno a me ritiene che l’epoca dei totalitarismi sia morta e Parte 1 - Introduzione 19 sepolta e che i due totalitarismi del ventesimo secolo - quello nazi-fascista e quello comunista-sovietico - non abbiano lasciato eredi intorno a noi. 1.1.5. Dall’esclusione alla violenza, dalla violenza alla violentizzazione La comunicazione disturbata (come nei tanti casi di double bind che possiamo riconoscere intorno a noi nelle tante doppiezze e ambiguità delle quali è intessuta la nostra vita sociale) e la comunicazione disturbante (come è quella attivata nella sfera pubblica dal terrorismo) sono entrambe pericolose, e anche molto pericolose; non solo per il destino individuale di troppe persone intorno a noi che ne sono vittime e ne soffrono ma anche per le nostre comunità e le nostre società. E con la parola “nostre” intendo riferirmi a tutti gli esseri umani che oggi vivono e abitano il pianeta terra. Troppe persone - milioni e milioni, forse la stragrande maggioranza degli esseri umani viventi - è costretta a vivere, per lo più inconsapevolmente, nell’ignoranza più totale di ciò che sta accadendo. E, ciò che è peggio, tale ignoranza viene tenuta in conto da chi ha interesse a manipolarla per i propri scopi particolaristici; che riesce, però, a contrabbandare troppo spesso, per interessi universalistici. L’esclusione, spesso deliberata, dei più, dei tanti - come ho cercato di mostrare nel mio librettomanifesto Diventare cittadini del mondo - dalla conoscenza, dalla coltivazione delle potenzialità di apprendimento, dalla riflessività che a tutti sarebbe utile e necessaria mi sembra la cosa più scandalosa di cui oggi dovremmo occuparci. Tanto più che, invece, questa cosa - l’esclusione dei più dalla conoscenza - non solo non viene percepita come scandalosa ma viene, addirittura, concepita come necessaria, come “naturale” e inevitabile. Ritengo scandalosa tale forma di esclusione perché - a partire dal punto di vista che la cultura della nuova comunicazione può gettare sul mondo - ritengo che tale esclusione sia all’origine della violenza distruttiva e della violentizzazione. Di quella forma di violenza distruttiva che è stata così ben raccontata in due film magistrali il brasiliano Cidade de Deus (City of God, film crudo e senza speranza) e Gangs of New York (il film di Martin Scorsese la cui violenza è aperta alla speranza). 1.1.6. Riferimenti bibliografici I temi e le argomentazioni esposte in questo paper si collegano a un work in progress collegato ai temi dell’esclusione e della violenza, del nihilismo e della morte che sono esposti in altri paper scritti e discussi nello stesso periodo. Essi trovano le loro premesse nelle teorie e nelle esperienze di ricerca che l’a. ha esposto in quattro libri pubblicati tra la fine del 2002 e la primavera del 2003 (con le relative bibliografie), con particolare riferimento ai concetti di “rivoluzione comunicativa” e “svolta comunicativa”. Agamben G., Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino 2003. Athens L., Violentization in Larger Social Context, in «Theories», vol. 4, 2003, pp. 1-41. Athens L., “Domination”. The Blind Spot in Mead’s Analysis of the Social Act, in «JCS - Journal of Classical Sociology», vol. 2 (1), 2002, pp. 25-42. 20 Comunicazione e Nonviolenza Athens L., The Creation of Dangerous Violent Criminals, University of Illinois Press, Urbana and Chicago 1992. Athens L., Starr R., One Man’s Story: How I Became a “Disorganized” Dangerous Violent Criminal, in «Theories», vol. 4, 2003, pp. 53-76. Atran S., In God We Trust. The Evolutionary Landscape of Religion, Oxford University Press, Oxford-New York 2002. Baudrillard J., Power Inferno. Requiem per le Twin Towers. Ipotesi sul terrorismo. La violenza globale, Raffaello Cortina Editore, Milano 2003. Bauman Z. Society Under Siege, Polity Press, Cambridge 2002. Bechelloni G., Diventare Cittadini del Mondo. Comunicazione e cosmopolitismo responsabile, Mediascape Edizioni, Firenze 2003. Bechelloni G., Diventare italiani. Coltivare e comunicare la memoria collettiva, Ipermedium libri, Napoli 2003. Bechelloni G., (2003), Equivoci giochi. Lo stile cognitivo di un artigiano delle parole, Mediascape Edizioni, Firenze 2003. Bechelloni G., Svolta comunicativa. Sette lezioni, Ipermedium libri, Napoli 2002. Bechelloni G., Natale A.L. (a cura di), Narrazioni mediali dopo l’Undici Settembre. Dialoghi e conflitti interculturali, Mediascape Edizioni, Firenze 2003. Beck U., Un mondo a rischio, Giulio Einaudi editore, Torino 2003. Becucci S., Massari M., Globalizzazione e criminalità, Editori Laterza, Roma-Bari 2003. Berman P., Terror and Liberalism, W.W. Norton & Company, New York-London 2003. Ceri P., La società vulnerabile. Quale sicurezza, quale libertà, Editori Laterza, Roma-Bari 2003. De Michelis G., La lunga ombra di Yalta. La specificità della politica italiana, conversazione con Francesco Kostner, Marsilio, Venezia 2003. Fukuyama F., La grande distruzione. La natura umana e la ricostruzione di un nuovo ordine sociale, Baldini & Castoldi, Milano 1999. Giglioli P.P., Intervista con Howard Becker, in «Rassegna Italiana di Sociologia», a. XLIII, n. 4, ottobre-dicembre 2002, pp. 619-631. Honderich T., After the Terror, Edinburgh University Press, Edinburgh 2002. Hughes R., La cultura del piagnisteo. La saga del politicamente corretto, Adelphi Edizioni, Milano 2003. Juergensmeyer M., Terroristi in nome di Dio. La violenza religiosa nel mondo, Editore Laterza, Roma-Bari 2003. Parte 1 - Introduzione 21 Khosrokhavar F., Les nouveaux martyrs d’Allah, Flammarion, Paris 2002. Manent P., Storia intellettuale del liberalismo. Dieci lezioni: da Machiavelli a Tocqueville, Ideazione Editrice, Roma 2003. Manzato A. (a cura di), Il rischio invisibile. La rappresentazione del bioterrorismo nei discorsi dei media, Arcipelago Edizioni, Milano 2003. Nancy J.-L., Anche un bacio è violento. Cinema, realtà, immagini choc: la sfida del filosofo francese, in «La Stampa», 8 giugno 2003. Nolte E., Esistenza storica. Fra inizio e fine della storia?, Le Lettere, Firenze 2003. Ohnuki-Tierney E., Cherry Blossoms, and Nationalisms. The Militarization of Aesthetics in Japanese History, University of Chicago Press, Chicago-London 2002. Panikkar R., Pace e disarmo cultura, a cura di M. Carrara Pavan, Rizzoli, Milano 2003. Pickering M., Stereotyping. The Politics of Representation, Palgrave, Nerw York 2001. Pilati A., Il legame spezzato. Cittadini e politica: 30 anni d’illusioni perdute, Ideazione Editrice, Roma 2003. Rhodes R., Perché uccidono. Le scoperte di un criminologo indipendente, Garzanti, Milano 2001. Scurati A., Guerra. Narrazioni e culture nella tradizione occidentale, Donzelli Editore, Roma 2003. Todorov T., Benjamin Constant. La passione democratica, Trad. di A. Merlino, Donzelli Editore, Roma 2003. Todorov T., Le morali della storia, Einaudi, Torino 1995. Touraine A., Khosrokhavar F., La ricerca di sé. Dialogo sul soggetto, Trad. di C. Rognoni, il Saggiatore, Milano 2003. Trupia P., Potere di convocazione. Manuale per una comunicazion efficace, Prefazione di G. Bechelloni, Liguori Editore, Napoli 2002. 22 Comunicazione e Nonviolenza 1.2. LA RIVOLUZIONE INTERPERSONALE Comunicazione, consapevolezza e crescita nelle relazioni con gli altri di Enrico Cheli La comunicazione costituisce la dimensione primaria della vita e dell’azione sociale dell’uomo, e può essere considerata metaforicamente come il tessuto connettivo e nervoso della società. Ciò nonostante, il riconoscimento della centralità sociale della comunicazione è un fenomeno piuttosto recente, iniziato col diffondersi della democrazia a partire dal XVIII secolo ma emerso come realtà auto evidente soltanto nel corso del XX secolo (Bechelloni, 2003, pp. 51-60). E’ soprattutto grazie all’avvento dei mass media che la comunicazione è divenuta la caratteristica più distintiva dell’epoca attuale, al punto che vari autori hanno coniato, per descriverla, il termine “società della comunicazione”. Tuttavia, oltre al grande sviluppo dei media e della ricerca scientifica ad essi collegata, si è anche avuta nel XX secolo anche una considerevole evoluzione nel campo della comunicazione interpersonale, sia a seguito dei profondi mutamenti sociali e culturali avviati negli anni Sessanta e Settanta, sia grazie ai progressi della ricerca scientifica sia alle esperienze cliniche e educative sulla comunicazione e le relazioni interpersonali. Ciò nonostante, questo secondo fronte di sviluppo è rimasto, per vari motivi, in secondo piano nella percezione collettiva, al punto che, quando si parla di comunicazione, si pensa ormai prevalentemente ai media, quasi ignorando l’ambito interpersonale, che pure è molto, molto importante per il nostro benessere individuale e collettivo. 1.2.1. La rivoluzione interpersonale Per millenni e fino a tutta la prima metà del XX secolo, la vita di relazione si era svolta secondo regole e schemi ferrei, cui dovevano conformarsi tutti i membri di una data comunità; non era pensabile percorrere altre strade, cambiare le regole, vivere il ruolo di genitore, figlio o coniuge in modi diversi dal resto della comunità, se non subendo la riprovazione sociale o sanzioni perfino più gravi. Si tenevano le distanze e ci si dava del lei o del voi perfino tra marito e moglie, tra madre e figli, tra amici: il ruolo e la posizione sociale erano preponderanti sulla personalità e sull’identità personale; importava molto più cosa eri che non chi eri - un nobile, un borghese o un contadino; un padre o un figlio; un dipendente o un padrone; un docente o un discente. L’autorità prevaleva sulla libertà, il controllo sulla spontaneità, la formalità sulla creatività. Poi, a partire dagli anni Sessanta, quell’assetto patriarcale e gerarchico è stato fortemente contestato fino ad entrare irrimediabilmente in crisi e in breve tempo si è passati da rapporti impostati su copioni socialmente prestabiliti e rigidi a relazioni autodeterminate e flessibili, dalla comunicazione formale alla spontaneità, dal controllo e repressione delle emozioni all’espressività senza freni1. 1 In realtà il mutamento parte da più lontano - dal riaffiorare delle idee democratiche durante il rinascimento e soprattutto l'illuminismo, dalle rivoluzioni americana e francese - ma è solo con la controcultura degli anni Ses- Parte 1 - Introduzione 23 Tale cambiamento va considerato come un processo evolutivo positivo, presupposto per una società più libera e creativa, per rapporti umani più gratificanti, costruttivi e consapevoli, per una vita sociale che incarni i principi democratici della libertà, dell’autodeterminazione, della comunicazione. Tuttavia la medaglia ha anche il suo rovescio: col crescere della libertà è cresciuto anche il disagio esistenziale; il senso di identità e i ruoli sociali e sessuali sono entrati in crisi; sono aumentati i conflitti, le separazioni, le controversie e la famiglia è in disfacimento, come pure la solidarietà e la coesione sociale; crescono la solitudine e l’individualismo; il rapporto tra cittadini e istituzioni è sempre più improntato alla sfiducia e l’ordine ne risente sotto più aspetti. I nostri nonni erano indubbiamente molto meno liberi di noi nelle relazioni: dovevano seguire binari prefissati, uguali per tutti, regole rigide e spesso inumane, ruoli formali e affettivamente freddi; non potevano scegliere se sposarsi o convivere, né, spesso, chi sposare, non potevano instaurare un dialogo alla pari col datore di lavoro né spesso manifestare apertamente le loro esigenze. Non erano liberi di esprimere le proprie emozioni e sentimenti, specie in pubblico, né potevano vivere in modo fluido e soddisfacente la loro sessualità. Erano meno liberi, certo, ma anche meno insicuri, meno ansiosi: le stesse norme e vincoli che ne limitavano la libertà erano anche una protezione contro l’incertezza, una guida sicura per orientarsi nella vita sociale, una solida fonte di identità. Una moglie e madre sapeva che cosa era, come doveva comportarsi, cosa doveva aspettarsi dal marito e dai figli. Un giovane non si portava addosso l’incertezza dell’adolescenza fino a trent’anni o più: a sedici o diciotto anni entrava nell’età adulta e gli venivano riconosciute interamente le prerogative proprie di tale stato. Due fidanzati non dovevano confrontarsi e accordarsi sulle regole e sugli obbiettivi della loro relazione ma limitarsi a seguire modelli di comportamento che già i loro genitori, nonni, bisnonni avevano seguito e tramandato. Non che anche allora non vi fossero conflitti e problemi emozionali o sentimentali nelle relazioni, ma erano più sotterranei, più “certi” nelle possibili soluzioni (o repressioni). Le forme del malessere individuale e sociale non erano, come invece oggi, evidenti ed effervescenti, spesso violente: era un malessere che raramente sfociava nella ribellione, più spesso nella rassegnazione, che non prendeva la strada del conflitto esteriore, del confronto aperto o della separazione, ma quella del silenzio, del conflitto sotterraneo, della lenta morte dell’anima. Le relazioni coniugali erano più basate sui valori della famiglia e del patrimonio che non sui sentimenti, l’idea stessa di amore era molto più concreta, materiale. Pur convivendo, i coniugi vivevano per molti aspetti in due mondi separati: non esisteva alcun confronto sui vissuti emotivi perché solo la donna ne era consapevole (e se li teneva per sé o al massimo ne parlava con le amiche più intime): l’uomo aveva fin da bambino rinnegato e rimosso la propria emotività e vulnerabilità e non era in grado di interagire su tale piano (né avrebbe voluto). Non esistevano confronti neppure su piani più intellettuali, poiché alla donna non era dato di avere un’istruzione che non fosse cucito e buone maniere (e spesso neppure questo) né tanto- santa che questo mutamento sociale e culturale si diffonde in tutta la collettività (e non solo in alcune classi sociali), scardinando valori e modelli relazionali vecchi di secoli e aprendo la strada ad una maggiore libertà nel modo di vivere le relazioni con gli altri. 24 Comunicazione e Nonviolenza meno coltivare l’intelligenza razionale. Oggi invece tale confronto è un elemento essenziale al buon andamento non solo delle relazioni coniugali ma anche di relazioni di coppia meno formalizzate: l’emancipazione della donna l’ha portata a cercare e talvolta pretendere dal proprio partner cose che non sempre lui è in grado di darle, perché c’è stata un’emancipazione della donna, ma non ancora dell’uomo, salvo casi isolati. La donna emancipata contemporanea ha mantenuto la competenza emotiva delle sue antenate e in aggiunta ha iniziato a sviluppare il proprio lato maschile, facendo propri alcuni aspetti della personalità in passato riservati ai maschi (la realizzazione individuale, il potere, la razionalità, l’autodeterminazione, l’aggressività); il maschio invece si è limitato a perdere le vecchie sicurezze e privilegi senza guadagnare niente in cambio, perché ancora non ha saputo/voluto imparare a sviluppare il proprio lato femminile (la sensibilità, l’affettività, la capacità di vivere le emozioni senza affogarvi etc.). In una società patriarcale e autoritaria la comunicazione non può che avere un ruolo marginale, poiché i rapporti sociali non vengono liberamente costituiti dalle parti, ma sono predefiniti da norme e gerarchie rigide imposte dall’alto. Sia nei rapporti tra governanti e cittadini/sudditi sia in quelli tra membri di una stessa famiglia i ruoli sono tutt’altro che paritetici: c’è chi comanda e chi deve obbedire, chi indottrina e chi impara. In una società democratica la comunicazione è invece centrale poiché i rapporti sono liberamente costituiti e i ruoli e i poteri possono essere negoziati. Comunicare, come ricorda l’etimologia del verbo2, comporta un flusso bidirezionale di informazione in cui vi è partecipazione paritetica dei soggetti coinvolti - compartecipazione appunto; nella società gerarchica del passato i flussi informativi erano invece unidirezionali, prevalentemente dall’alto verso il basso (dal sovrano ai sudditi, dal patriarca al resto della famiglia etc.). 1.2.2. Nuovi bisogni e libertà con mappe e strumenti di vecchio stampo Ci troviamo nel bel mezzo di una fase di transizione in cui i vecchi valori e i vecchi modelli di comportamento sono crollati o stanno crollando, ma ancora non sono emersi nuovi schemi e regole in grado di far fronte alle mutate situazioni e ai bisogni emergenti che caratterizzano le relazioni interpersonali. Si crea pertanto un paradosso: si continuano ad applicare i vecchi modelli comunicativi alle nuove situazioni, si cerca di soddisfare i nuovi bisogni all’interno di vecchie e inadatte forme di relazione; ovviamente senza alcun esito positivo, anzi con grande frustrazione e irritazione. I più attribuiscono all’altro ogni responsabilità, e solo alcuni affrontano invece il problema in modo autocritico; tuttavia solo una parte delle responsabilità dipende dalle persone coinvolte nella relazione, mentre un’altra parte va attribuita alla società nel suo complesso e alle contraddizioni legate alla transizione, all’ancora incompleto 2 Il termine “comunicazione” deriva dal latino communis - cum (con, insieme) e munia (doveri, vincoli), ma anche moenia (le mura) e munus (il dono). Communis significa quindi: essere legati insieme, collegati dall'avere comuni doveri (munia), dal condividere comuni sorti (le mura che proteggono e accumunano) dall'essersi scambiati un dono. Anche in greco antico comunicare è sinonimo di unire, congiungere mentre in tedesco la parola rinvia a compartecipare, condividere (mitteilen = spartire, suddividere, tagliare insieme). Comunicare ha la stessa radice di comune, comunità, comunione, condivisione e difatti si comunica per “compartecipare”, per “avvicinarsi fino a collegarsi”. Parte 1 - Introduzione 25 mutamento. Facciamo alcuni esempi. Il matrimonio come forma istituzionalizzata dei rapporti di coppia è palesemente in crisi, e ciò nonostante la maggior parte delle persone continua a sposarsi, perché non vede alternative credibili, anche se poi nella maggior parte dei casi divorzia3. La maggior parte dei separati e divorziati pensa di aver sbagliato partner, ma forse hanno anche sbagliato forma relazionale. Certo, molti matrimoni falliscono perché in realtà non avrebbero mai dovuto aver luogo, perché i due partner non si amavano o non erano sufficientemente compatibili, ma che dire di quei rapporti che procedono bene per anni, anche convivendo, e poi si incrinano poco tempo dopo il matrimonio? Non è forse possibile che la colpa non sia tutta dell’aver sbagliato persona ma anche della forma di relazione “matrimonio” che non è adatta a preservare e sviluppare l’amore semplicemente perché questo non è lo scopo per cui è nata? Come è noto la funzione sociale del matrimonio era in origine principalmente, anzi esclusivamente, quella della procreazione, della trasmissione ereditaria del nome e dei beni della famiglia, della alleanza tra famiglie, mentre oggi tali scopi sono sempre più secondari, prevalendo invece il reciproco benessere affettivo, sessuale e materiale dei coniugi. Attrazione e innamoramento sono ritenuti ingredienti fondamentali di un rapporto di coppia e dunque - per conseguenza - del matrimonio, e non sono i soli ingredienti, poiché la relazione di coppia mette in gioco molte altre dimensioni - intellettuali, esistenziali, e anche strettamente pratiche - che portano inevitabilmente ad un incontro e ad un confronto di personalità e di mentalità. In passato i coniugi, pur abitando sotto lo stesso tetto, vivevano per molti aspetti in due mondi separati: ad esempio non esisteva alcun confronto sui vissuti emotivi perché solo la donna ne era consapevole (e se li teneva per sé o al massimo ne parlava con le amiche più intime): l’uomo aveva fin da bambino rinnegato e rimosso la propria emotività e vulnerabilità e non era in grado di interagire su tale piano (né avrebbe voluto). Non esistevano confronti neppure su piani più intellettuali, poiché alla donna non era dato di avere una istruzione che non fosse cucito e buone maniere (e spesso neppure questo) né tantomeno coltivare l’intelligenza razionale. Oggi invece tale confronto è un elemento essenziale al buon andamento non solo delle relazioni coniugali ma anche di relazioni di coppia meno formalizzate. Ciò pone un problema di non poco conto: può una forma istituzionalizzata di relazione come il matrimonio - originatasi in un ben preciso contesto culturale, patriarcale e materialista, e con precise funzioni sociali - può tale istituzione adattarsi al nuovo spirito del tempo e stravolgere il suo imprinting in modo tale da soddisfare le esigenze e gli obbiettivi di oggi? Molti ritengono - e io tra questi - che non sia possibile modificare l’istituzione matrimonio e che per vivere in modo soddisfacente i rapporti di coppia occorrano forme istituzionali del tutto nuove, fluide e ampiamente personalizzabili dai partner. Ma ammettiamo pure che sia possibile adattare il matrimonio alle nuove esigenze: ciò sta forse già avvenendo? Gli organi legislativi, le religioni, la società civile hanno forse provato a introdurre 3 Negli USA quasi il 70% dei matrimoni finisce in un divorzio; in Italia la percentuale è più bassa ma in costante crescita, oltre al fatto che i dati ufficiali non rendono conto di tutti quei matrimoni finiti che non sfociano in una separazione solo a causa delle notevoli difficoltà economiche e burocratiche che ciò comporta. 26 Comunicazione e Nonviolenza qualche innovazione propositiva nel matrimonio? La risposta, come ben sapete, è no! Nonostante che tutto intorno e dentro di noi sia cambiato, il matrimonio ha mantenuto saldamente la sua identità arcaica, specie quello religioso. L’unica novità di rilievo è che diversamente che in passato ci si può separare, divorziare, risposare anche, ma lo schema interno non è realmente cambiato. Anche nelle imprese e nelle organizzazioni pubbliche e private mancano validi modelli di relazione adeguati ai nuovi principi democratici e alle nuove esigenze delle persone: i vecchi modelli - piramidali e gerarchici - non funzionano più, ma i nuovi sono ancora in fase di collaudo, sono poco applicati perché poco conosciuti e perché suscitano dubbi, oltre al fatto che richiedono abilità e competenze comunicative ancora troppo poco presenti sia nella dirigenza sia nei lavoratori. I rapporti tra insegnanti e allievi sono fallimentari e spesso ingestibili, poiché si sono abbandonati i modelli autoritari, inefficaci e non più accettabili, senza però sostituirli con nuovi modelli ma semplicemente con un malinteso atteggiamento di rassegnato lasseiz-faire, che lascia insoddisfatti sia gli uni che gli altri. Il fatto è che né gli individui, né i gruppi o le organizzazioni dispongono di un adeguato know how emotivo-relazionale per sfruttare le grandi potenzialità positive insite nella nuova libertà sociale del terzo millennio; al contrario, sono spesso vittime inermi dei molti effetti collaterali negativi. Ognuno è in balia di se stesso, e deve imparare sulla propria pelle, da autodidatta, per tentativi e (dolorosi) errori come nuotare o almeno stare a galla in questo mare agitato - un mare divertente, spumeggiante e ricco di opportunità creative per un nuotatore esperto, ma estremamente faticoso e perfino letale per un principiante - e oggi siamo più o meno tutti principianti, pionieri alla conquista di territori inesplorati, affascinanti ma anche estremamente insidiosi. Per sfruttare i “vantaggi potenziali” di questa nuova e ampia libertà e gestire le tensioni e le incertezze che essa comporta sono dunque necessarie nuove “bussole” e “mappe” comunicativo-relazionali che mettano in grado le persone di orientarsi in questi nuovi territori della interazione sociale: nuovi adeguati strumenti conoscitivi e operativi e nuove competenze, ben diverse e assai più complesse di quelle dei nostri antenati, poiché un conto è seguire binari prestabiliti, uguali per tutti, altra cosa è orientarsi tra più strade possibili o addirittura in mare aperto; un conto è accontentarsi di sopravvivere, altra cosa è credere nelle proprie aspirazioni e quindi essere capace di scegliere, tra le molte possibilità, quella più adatta alla nostra realizzazione. Il problema è che nessuno ci ha mai insegnato a comunicare e ad impostare in modi sani e costruttivi i nostri rapporti con gli altri, anche perché tali abilità avevano poco rilievo nella società patriarcale e autoritaria basata sui doveri e non su reciproche e paritetiche negoziazioni. Gli obbiettivi educativi di oggi fanno ancora riferimento all’assetto socioculturale di mezzo secolo fa: è per questo che impariamo a parlare e a scrivere ma non ad ascoltare e comprendere realmente l’altro in quanto diverso da noi. Parimenti, ci viene insegnata una storia umana fatta di guerre ma non ci viene detto niente su come poterle evitare. Riceviamo una formazione professionale senza alcuna formazione relazionale per prepararci ai rapporti che avremo con i colleghi e con i superiori, che pure incideranno in modo determinante sulla nostra soddisfazione o insoddisfazione, sulla gratificazione o frustrazione che ricaveremo dal Parte 1 - Introduzione 27 lavoro e quindi anche sul nostro rendimento. Insomma, possiamo anche conoscere perfettamente più lingue, avere una solida istruzione scientifica, tecnica o umanistica e ciò nonostante essere poco più che analfabeti sul piano relazionale. La nostra è certamente una civiltà tecnologicamente avanzata ma è assai meno evoluta sul piano comunicativo-relazionale. Nonostante le riforme susseguitesi negli ultimi decenni, il sistema scolastico è ancora fortemente imperniato su una educazione di tipo logo-logico, che si rivolge essenzialmente all’intelligenza cognitiva, trascurando o addirittura ignorando altre importanti dimensioni intellettive. Capacità come il saper comunicare con efficacia, l’affrontare con armonia le relazioni interpersonali, l’esprimersi con chiarezza, il saper ascoltare le altre persone, il saper trovare un punto d’incontro tra le proprie e le altrui esigenze sono sempre state considerate soggettivamente utili ma socialmente marginali, e inoltre le si riteneva in larga misura doti innate, legate al carattere della persona e quindi non educabili. Questa tesi è oggi totalmente superata e sappiamo anzi che così come possiamo educare l’intelligenza cognitiva, possiamo - con opportuni metodi e strumenti - educare anche altre forme di intelligenza, quali quella emotiva e quella comunicativo-relazionale. Oltre ad insegnare agli studenti a parlare una o più lingue possiamo dunque insegnargli ad usare consapevolmente i codici e i linguaggi della comunicazione non verbale, a saper osservare e capire le dinamiche relazionali che si svolgono “dietro le quinte”, a comprendere le emozioni che si smuovono in noi e nell’altro, a riconoscere gli obbiettivi reali della comunicazione da quelli apparenti, a distinguere i ruoli e le maschere che vengono rappresentati da colui o colei che sta dietro quelle immagini. La scuola dà giustamente grande importanza alla competenza linguistica, ma essa si rivela un guscio vuoto se non è affiancata da una valida competenza comunicativa. Comunicare non è solo una dote innata ma è un’arte che, come tutte le arti, si può imparare a poco a poco, se siamo motivati a farlo e se disponiamo degli strumenti e delle condizioni adeguate. Il primo passo verso una buona comunicazione è il superamento del nostro egocentrismo, cioè la tendenza a percepire noi stessi come “centro del mondo”. Questo tratto è tipico dell’infanzia e decresce man mano che si procede verso l’età adulta, senza però scomparire del tutto: moltissimi casi di incomprensione e conflitto tra esseri umani adulti sono dovuti anche o prevalentemente all’egocentrismo dei comunicanti. La comunicazione, per essere efficace, richiede una grande capacità di uscire dall’egocentrismo e porsi nei panni dell’altro attraverso l’ascolto, la consapevolezza, il confronto. Solo se sappiamo ascoltare e comprendere possiamo giungere al passo successivo: esprimersi in modo appropriato alle situazioni e alle persone. Ciò richiede una conoscenza adeguata dei molti linguaggi e livelli su cui si sviluppano i processi comunicativi ma anche la capacità pratica di usarli nei modi e nei tempi appropriati ai propri obiettivi, alla situazione, agli interlocutori. Conoscenze teoriche e abilità tecniche devono essere devono poi essere applicate con consapevolezza, pena lo sconfinare in quello che è un insidioso ostacolo alla buona comunicazione: il tecnicismo. Troppo spesso si tende a ridurre la comunicazione ad un puro discorso di tecniche, di strategie prefabbricate, di moduli standardizzati e tecnologie ready to eat; e questo sia da parte di formatori e istituti di formazione professionale sia anche da parte di talune sedi universitarie. Il modello di riferimento di un tal modo di procedere è quello ingegneristico, con risposte il più possibile predefinite a domande ampiamente prevedibili (FAQ). 28 Comunicazione e Nonviolenza Ma le interazioni tra esseri umani sono ben altra cosa di quelle tra travi di cemento armato, ingranaggi meccanici o componenti elettronici, e per essere adeguatamente affrontate richiedono una grande elasticità di schemi, che non forzino la situazione in caselle predefinite, in casistiche note, in risposte già date ma che semmai si adattino ad essa creativamente. E questo vale non solo per la comunicazione in ambito professionale ma anche nella vita privata, anche perché le due sfere sono strettamente collegate: la comunicazione non è solo un problema da sbrigare o una soluzione da trovare, ma una dimensione fondamentale dell’esistenza umana, che non possiamo lasciare in ufficio alla fine della giornata ma che portiamo con noi in ogni momento della nostra vita, che lo vogliamo o meno. L’educazione comunicativo-relazionale dei bambini e degli adulti dovrà quindi essere tra le priorità dei prossimi anni se vogliamo perseguire una politica sociale imperniata sulla qualità della vita e sulla prevenzione - del disagio psico-sociale, della microconflittualità urbana e familiare, del mobbing e di tutte le altre patologie sistemiche che affliggono la nostra vita sociale. 1.2.3. Nuove professioni per facilitare le relazioni interpersonali Oltre alla prevenzione - che si sviluppa principalmente attraverso i programmi educativi suddetti - è indispensabile e urgente istituire un’adeguata rete di servizi di assistenza volti ad affrontare le problematiche già conclamate e le emergenze comunicativo-relazionali. Quale risposta spontanea della società civile alle nuove esigenze e ai nuovi problemi relazionali, da alcuni anni stanno emergendo nuove professioni incentrate proprio sulla comunicazione e le relazioni interpersonali: il consulente relazionale, il mediatore familiare, lo psicoterapeuta familiare, l’addetto alle relazioni col pubblico (negli URP ad esempio), etc. Non solo, ma anche molte professioni tradizionali si stanno accorgendo dell’importanza di questi temi e numerosi professionisti cercano di integrare la propria formazione con saperi e tecniche attinenti la comunicazione interpersonale (si pensi agli avvocati impegnati in separazioni e divorzi, che sempre più spesso si trovano a dover svolgere un vero e proprio compito di mediazione tra i coniugi, o ai manager d’impresa che vogliono gestire efficacemente le dinamiche di collaborazione-conflitto e quelle di routine-creatività). Tuttavia si tratta per lo più di iniziative private e numericamente esigue, mentre le strutture pubbliche preposte alla salute non sono nella maggior parte dei casi attrezzate ad affrontare in modo adeguato tali problematiche, se non demandandole (spesso impropriamente) a medici, psichiatri o psicologi, etichettandole così facendo come patologie di singoli individui, invece che come incompetenze comunicative di un’intera società. Ciò appesantisce, invece di alleggerire, la già elevata ansia e vergogna di coloro che necessiterebbero di educazione e assistenza, contribuendo ad allontanarli. Specie per l’utenza più giovane è necessario uscire dagli approcci medicalizzati ed adottare strumenti e linguaggi più agili, che sdrammatizzino i problemi, non minimizzandone la gravità ma presentandoli come problemi collettivi della nostra epoca e non come sindromi private di pochi “anormali” malati o disadattati. Ne consegue l’esigenza di approcci non medicalizzati e non terapeutici quanto piuttosto basati sull’informazione, la formazione, la consulenza, come ad esempio l’istituzione di gruppi di auto aiuto; le realizzazione di portali web di Parte 1 - Introduzione 29 documentazione e condivisione; l’offerta di servizi di counseling relazionale. 1.2.4. Conclusioni Concludo questo mio intervento con l’auspicio che questo convegno, e iniziative analoghe di dibattito e confronto, possa rappresentare un punto di partenza per una reale collaborazione scientifica e formativa tra tutti coloro che, nell’Università e nella società civile, si impegnano a favore della pace e della comunicazione tra gli individui, i popoli, le culture. Uniti, potremo riscuotere la giusta attenzione politica e ottenere adeguate risorse per grandi interventi di sensibilizzazione, di educazione, di formazione e consulenza che coinvolgano attivamente la scuola, l’università, i media, gli enti socio-sanitari; interventi che attraverso un reale miglioramento della comunicazione e delle relazioni interpersonali ai diversi livelli, depotenzino i vecchi schemi culturali di conflittualità distruttiva e di competizione a somma zero sostituendoli con confronti costruttivi e creativi che si traducano in un maggior guadagno individuale e sociale per tutti. Solo così potremo davvero creare i presupposti per una vita sociale costruttiva e soddisfacente e per una pace interna ed internazionale effettiva e duratura. 1.2.5. Riferimenti bibliografici Bechelloni G., Svolta comunicativa, Ipermedium, Napoli 2001. Bechelloni G., Equivoci giochi, Mediascape, Firenze 2003. Cheli E., (a cura di), La comunicazione come antidoto ai conflitti, Punto di fuga, Cagliari 2003. Cheli E., Teorie e tecniche della comunicazione interpersonale. Una introduzione interdisciplinare, Franco Angeli, Milano 2004a. Cheli E., Relazioni in armonia. Sviluppare l'intelligenza emotiva e le abilità comunicative per stare meglio con gli altri e con se stessi, Franco Angeli, Milano 2004b. Giddens A., Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita, Il Mulino, Bologna 2000. Melucci A., Il gioco dell’io. Feltrinelli, Milano 1991. Melucci A., Passaggio d’epoca, Feltrinelli, Milano 1994. Stone H., Stone S., Tu ed Io: incontro, scontro e crescita nelle relazioni interpersonali, MIR edizioni, Montespertoli 2003. 30 Comunicazione e Nonviolenza 1.3. FORMARE ALLA NONVIOLENZA IN UNA SOCIETA’ VIOLENTA di Alberto L’Abate Ho scelto questo titolo perché quando abbiamo aperto, due anni fa, presso l’Università di Firenze, un corso di laurea triennale per la formazione di Operatori per la Pace gli studenti della Facoltà di Scienze della Formazione che l’ha promosso (insieme a Scienze Politiche), in una loro guida alternativa per le matricole hanno commentato, così, con sarcasmo, l’iniziativa: “L’idea è buona: peccato che attualmente trovino occupazione più gli operatori di guerra che quelli di pace!”. Infatti dobbiamo affrontare questo grave problema. Non abbiamo aperto il nuovo corso per votare alla disoccupazione i nostri laureati, quindi dobbiamo lavorare perché la situazione attuale venga modificata e perché si sviluppi, nella nostra società, una cultura di pace e di nonviolenza. Una cultura che dia modo ai nostri laureati di trovare un lavoro dignitoso ed utile onde permettere loro per lo meno di vivere dignitosamente, con la coscienza di svolgere una attività che consenta alla nostra società di progredire, e di essere sempre più all’altezza dell’uomo, anziché delle “bestie”. Come ci ha dimostrato Cazzola, nella sua eloquente relazione introduttiva, viviamo infatti in un mondo nel quale la guerra è un fatto quotidiano, “normale”, si potrebbe dire, mentre la pace è considerata solo come “assenza di guerra” e cioè nella sua accezione negativa, quasi come situazione anormale, eccezionale. Per questa ragione è assolutamente indispensabile dar vita ad una cultura che veda la pace, non nel suo aspetto negativo, ma in quello positivo: e cioè come previsione e prevenzione dei conflitti armati, riconciliazione dopo il conflitto, superamento della violenza strutturale, giustizia sociale, capacità di convivenza tra persone anche di colore e di cultura diversa, come un mondo di “rapporti comunicativi” che implicano, perciò, come sosteneva Danilo Dolci, relazioni orizzontali, alla pari, bidirezionali, tra le persone, e non “trasmissivi”, che comportano invece l’esistenza e la prevalenza di rapporti verticali, dall’alto verso il basso, di tipo autoritario (Dolci 1995 e 1997). Ma, data la situazione attuale, nella quale un quinto della popolazione dei paesi più ricchi utilizza oltre l’80 per cento delle risorse del mondo, lasciando agli altri quattro quinti solo le briciole1; dato che il mondo ricco, od almeno il paese che di questo mondo sembra aver preso la guida, e cioè gli USA, fa guerre, come quella in Iraq, senza alcuna valida giustificazione legale (lotta al terrorismo? in realtà questo comportamento invece che sconfiggerlo lo rinforza; possesso di armi di distruzione di massa? non sono mai state trovate; rapporti con Al Qaeda?, almeno prima della guerra non erano mai stati provati; per la democrazia?, in quanti paesi non esiste, dovremmo forse fare la guerra a tutti i paesi dove non c’è democrazia? Inoltre l’Iraq è tuttora molto distante da un sistema democratico, e sembra in preda alla più 1 La letteratura sugli squilibri sociali nel mondo è estesissima. Per non citare che pochi titoli: Atlante di Le Monde Diplomatique, Il Manifesto, Roma 2003, pp.48-49; Gallino L., Globalizzazione e disuguaglianze, Laterza, Bari 2001 (VI edizione); Martirani G., Il drago e l’agnello, Edizioni Paoline, Milano 2001; Friedmann J., Empowerment: una politica per lo sviluppo alternativo, Edizione Quale Vita, Torre dei Nolfi 2003. Parte 1 - Introduzione 31 bieca anarchia); data la violenza strutturale2 attuale che condanna l’Occidente alle malattie dell’opulenza e miliardi di persone del mondo povero alla morte per fame. Dato tutto questo risulta assolutamente necessario, se vogliamo andare verso un mondo di pace, unire la lotta contro le attuali ingiustizie ad un lavoro per la costruzione di un mondo più giusto, più umano. E questo è, secondo me, possibile solo con la “nonviolenza”, o con la “resistenza nonviolenta”, come definita in questo Convegno da Maselli. Questa infatti unisce la lotta contro le ingiustizie al programma costruttivo per dar vita ad una società migliore dell’attuale. Ma la lotta va portata avanti distinguendo tra peccato e peccatore, tra il ruolo di oppressore e la sua persona. Come ci insegna Gandhi vanno combattuti il peccato ed il ruolo ingiusto, mentre il peccatore e la sua vita vanno rispettati, cercando di convertire e non di uccidere. Per questa ragione formare “operatori di pace” significa formare alla nonviolenza, alla trasformazione nonviolenta della società nella quale viviamo, quindi a quella che Capitini e Dolci hanno definito “rivoluzione nonviolenta dal basso” (Capitini 1968; Dolci 1972). Ma quali risorse teoriche e pratiche possiamo utilizzare per questo compito? Il primo insegnamento utile è quello di Freire (Freire 1971), cui si aggiungono, sulla stessa lunghezza d’onda, quelli di Gandhi, Capitini, Dolci, Don Milani: la “pedagogia degli oppressi”, che consiste nell’ unire il “processo di coscientizzazione”, di presa di coscienza dei conflitti, anche di quelli latenti, molto più numerosi di quelli espliciti, al processo di trasformazione della realtà nel senso desiderato, per l’eliminazione delle strutture alienanti, dando vita a strutture più partecipative, dove tutti i cittadini, anche i più poveri ed emarginati, abbiano voce in capitolo nella presa di decisioni collettive. Ciò implica il superamento della democrazia puramente rappresentativa, basata sulla delega, per andare verso quella democrazia partecipativa che Capitini definiva “potere di tutti”, e Friedmann, un pianificatore sociale tra i più noti del mondo, chiama invece “democrazia inclusiva”. Sempre nel campo pedagogico un secondo grande insegnamento ci viene da un importante studioso dei sistemi informativi, Von Foster , che distingue le domande “illegittime”, alle quali i docenti sanno già rispondere, da quelle “legittime”, alle quali invece non sanno ancora rispondere. Come è emerso chiaramente in un convegno internazionale sulla educazione alla pace svoltosi qualche anno fa a Bologna3, l’insegnamento fatto con le domande illegittime (che dal convegno è emerso essere quello più diffuso e “normale”) stimola negli allievi il nozionismo, la passività, l’alienazione (il senso di impotenza nel cambiamento dell’ambiente intorno a loro), la carenza di capacità critica. Invece quello fatto attraverso le domande legittime, e cioè, soprattutto, con la ricerca “insieme” tra docenti ed allievi, stimola nei discenti la 2 L'autore che ha più contribuito a distinguere tra violenza diretta e violenza strutturale è J. Galtung. Si veda, in particolare: Galtung J., Hoivik T., Structural and direct violence, A note on operationalization, in «Journal of Peace Research», n. 1, 1971. 3 Gli atti del convegno di Bologna in cui è stata sottolineata l'importanza della distinzione, da parte di V. Foster, tra questi due tipi di domande, sono stati pubblicati in Catti G. (a cura di), Studiar per pace, Edizioni Thema, Bologna 1988 (2 volumi). 32 Comunicazione e Nonviolenza capacità critica, la creatività e l’innovazione. Per questo, dal convegno su citato, era emersa la chiara indicazione della necessità, per educare alla pace, di utilizzare questo secondo tipo di insegnamento. Un terzo insegnamento, che si ricollega a quello precedente, ci viene dal campo della metodologia della ricerca, di cui mi occupo professionalmente, ed in particolare dalla ricerca applicata ai problemi della pace (o peace research): si tratta della “ricerca-intervento”, o “ricerca per l’azione”4. Questa sottolinea la necessità di superare la ricerca tradizionale che vede i conflitti dall’esterno, come oggetti, con occhi distaccati, e senza alcun coinvolgimento da parte del ricercatore, cercando invece di entrare nei conflitti o, come dice uno studioso dell’Università di Lovanio, in Belgio (che è l’autore del primo manuale di costruzione della pace) “adottando un conflitto” (Reichler e Paffenholz, 2001). Secondo questa impostazione, il ricercatore deve aiutare i gruppi in conflitto tra di loro a coinvolgersi essi stessi nella ricerca di soluzioni. Infatti i ricercatori per la pace si sono resi conto, dopo ripetuti fallimenti (e quanto sta succedendo nel conflitto Israele-Palestina ci dovrebbe essere di insegnamento) che la pace non può essere imposta dall’esterno, ma richiede la partecipazione diretta delle popolazioni stesse che vivono il conflitto. La ricerca-intervento, aiutata da ricercatori esterni neutrali, che non si sostituiscano alle persone in conflitto, ma le aiutino in un processo maieutico (vedi l’insegnamento di Dolci5) nel cercare tra di loro possibili soluzioni, accettabili da ambedue le parti, è un notevole passo in avanti. Ma questo, dal punto di vista metodologico, richiede un ulteriore passo in avanti, e cioè l’accettazione della “scienza trilaterale”6 Secondo questa impostazione i dati, le teorie, ed i valori, si confrontano continuamente tra di loro, nella ricerca di una società “possibile-desiderabile”. Secondo Galtung, infatti, che ha diretto per anni l’Istituto di Ricerca per il Futuro delle Nazioni Unite, tra la realtà e l’irrealtà esiste infatti una terza dimensione che è quella della realtà “possibile-desiderabile”, quella cioè che emerge da tutte le nostre ricerche come realizzabile, pur non essendo ancora diventata realtà storica. Il raggiungimento di questa realtà è perciò un compito importante, che ricorda quella che Ernest Bloch chiamava “l’utopia concreta” (Bloch, 1980). Per far questo, senza uscire dalla scienza cadendo nell’ideologia, è fondamentale che la sociologia non resti ad un livello descrittivo, o anche solo analitico, ma che diventi anche una scienza sperimentale, che metta cioè in atto delle innovazioni, tenendole sempre sotto controllo, attraverso la ricerca di nuovi dati, in modo da poter dimostrare la validità di questo modo di procedere. 4 Si veda l'aureo libretto di S. Sharoni, La logica della pace: la trasformazione dei conflitti dal basso, EGA, Torino 1997. 5 Sulla maieutica di Dolci, si vedano, di lui stesso: La struttura maieutica e l'evolverci, La Nuova Italia, Firenze 1996; e, su questa, Mangano A., Danilo Dolci educatore, Edizioni Cultura della Pace, Firenze 1992; Morgante T.R., Maieutica e sviluppo planetario in Danilo Dolci, Edizioni Lacaita, Manduria-Roma 1992. 6 Sulla scienza trilaterale ed il costruttivismo metodologico si veda Galtung J. Empiricism, criticism, constructivism: three aspects of scientific activity, in Galtung J., Methodology and Ideology, C. Ejlers, Copenhagen 1977; L'Abate A., Introduzione ai metodi di analisi nelle scienze sociali (Dispense Universitarie Anno accademico 1992-93), Centro Stampa Toscana Nuova, Firenze. Parte 1 - Introduzione 33 Questa unione tra apprendimento e trasformazione sociale richiede, inoltre, un cambiamento di tutte le modalità di insegnamento all’interno dell’Università. Questo è tuttora basato principalmente su lezioni cosiddette “frontali” o accademiche (che Dolci definirebbe trasmissive e non maieutiche) che considerano l’uomo come un essere dotato solo di conoscenza e di ragione, e non tengono conto, invece, della sua emotività, delle sue capacità empatiche, dell’importanza del suo corpo, di quella che una nostra ricerca sulla partecipazione della popolazione dei quartieri ferraresi ha sottolineato come la forma di partecipazione più diffusa, e più apprezzata dalla popolazione, e cioè quella che abbiamo definito la “partecipazione manipolativa”, in quanto ci porta ad essere attori, e non passivi ricettori di ricette calate dall’alto. Per questo, nell’insegnamento universitario, vanno sviluppate “metodologie più attive”, come il lavoro di gruppo, i training per l’apprendimento di capacità varie (assertività, capacità di ascoltare e di comunicare, avere rapporti empatici, utilizzare il metodo maieutico, superare le proprie paure, lavorare con la gente e non per la gente, risolvere nonviolentemente i conflitti, ecc.), laboratori per la gestione costruttiva dei conflitti, giochi di ruolo, teatro dell’oppresso7. Vale anche, e soprattutto, l’esempio8. Partecipare ad attività ben organizzate ed efficaci sulla previsione e prevenzione dei conflitti armati, o per il superamento della violenza nei quartieri, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, negli stadi, etc., svolte da Organizzazioni Governative o Non Governative, attraverso tirocini ben guidati, è un elemento fondamentale della formazione di persone che aspirano a diventare, professionalmente, “Operatori per la Pace” Ma non basta: occorre anche prendere in considerazione l’influenza della società esterna sul comportamento delle persone. Come si può insegnare la nonviolenza, e la gestione costruttiva dei conflitti, quando i potenti del mondo non tengono in alcun conto le opinioni delle popolazioni (si pensi ai 110 milioni di persone che hanno manifestato, in settanta paesi del mondo, il 15 Febbraio 2002, contro la guerra in Iraq, che si è voluta fare ugualmente), e trovano solo parole nuove (guerra “umanitaria”, guerra “preventiva”, guerra al terrorismo, guerra per la democrazia, etc.) per fare la solita vecchia cosa, la “guerra”, che distrugge sia persone che beni, inquina l’ambiente, e serve solo, e soprattutto, ai costruttori e venditori di armi ed ai loro manutengoli. Se nel mondo si continua a mandare avanti il concetto che la “ragione sta nella forza” e non si crede nella “forza della ragione” in che modo possiamo educare alla pace ed alla nonviolenza le nuove generazioni, come ci chiedono di fare le Nazioni Unite che hanno 7 Anche su questo tema la letteratura è vastissima. Un utile manuale per l'apprendimento e la formazione a questo tipo di tecniche è Euli E., Soriga A., Sechi P.G., Puddu Crespellani S., Percorsi di formazione alla nonviolenza: viaggi in training (1983-1991), Satyagraha, Torino 1992. Per esempi di applicazione di questa formazione in vari settori si veda anche il libro L'Abate A. (a cura di), Giovani e Pace: Ricerche e formazione per un futuro meno violento, Pangea Edizioni, Torino 2001. Per un gioco di ruolo, molto utile nella formazione in scuole superiori o nell'Università, che prende in analisi il conflitto israelia-no-palestinese, si veda: Marasso A., Tropea M.C., La mia storia, la tua storia, il nostro futuro. Un gioco di ruolo per capire il conflitto israelo-palestinese, EGA, Torino 2003. 8 Sull'importanza, nell'educazione alla pace, dell'esempio, si vedano i saggi di A. Carbonaro, Education for peace, in "The new Era", n. 9, 1966, e La scuola per una educazione alla pace in «Critica Sociologica», n. 18, 1971; si veda anche l'articolo di A. L'Abate, Antonio Carbonaro e l'educazione alla pace, in «Satyagraha», n. 2, 2002. 34 Comunicazione e Nonviolenza dedicato a tale scopo questo decennio9? A tale scopo è assolutamente necessaria “una rivoluzione culturale”, che renda la pace un fenomeno normale, quotidiano, e la guerra, invece, un fenomeno eccezionale, solo episodico10, una rivoluzione che ci porti a prendere nella dovuta considerazione la previsione e la prevenzione dei conflitti armati, anziché aspettare che esplodano, per poi sostenere la necessità dell’intervento armato. Da questo punto di vista basti pensare che per la prevenzione della guerra del Kossovo, secondo i miei calcoli, si è speso 1 Euro contro ogni 140 Euro spesi, invece, per fare la guerra, per affrontare le emergenze umanitarie che questa ha comportato, e per la ricostruzione di quanto la guerra aveva distrutto11, senza tenere conto che ci sono cose che non possono essere ricostruite, come le vite umane perse, od i rapporti sociali amichevoli tra gruppi diversi che dopo la guerra si trasformano in odi reciproci profondi, difficilmente superabili. Non pretendo che i miei calcoli economici siano esatti, non sono un ragioniere, e mancano dati precisi su questi fenomeni, ma ho comunque tenuto conto, nel fare questo calcolo, di tutti i dati che era possibile recuperare. Quello che è certo è che si è speso e si spende per prevedere i conflitti, per risolverli pacificamente , per prevenirne l’esplosione, infinitamente meno di quanto si faccia invece per preparare la guerra, per portarla avanti, e per cercare di riparare ad alcuni dei suoi danni. Se l’umanità continua ad andare avanti in questo modo, e non cambia strada, non ci dobbiamo meravigliare se il suo futuro sarà pieno di guerre, di conflitti armati, di violenza strutturale, e di quella è già stata definita la “guerra infinita”. Non è forse venuto il momento di cambiare strada? Riferimenti bibliografici AA.VV., Atlante di Le Monde Diplomatique, Il Manifesto, Roma 2003, pp.48-49. L’Abate A., Antonio Carbonaro e l’educazione alla pace, in «Satyagraha», n.2, 2002. L’Abate A. (a cura di), Giovani e Pace: Ricerche e formazione per un futuro meno violento, Pangea Edizioni, Torino 2001. L’Abate A., Vivere i conflitti a livello macro. La prevenzione dei conflitti armati: il caso del 9 Le Nazioni Unite, su richiesta di vari premi Nobel per la Pace, in una mozione del 10/11/1998, hanno dichiarato il perio-do 2001/2010 come il "decennio internazionale per una cultura di pace e nonviolenza per i bambini del mondo": ed hanno, in seguito, approvato la "Dichiarazione per una cultura di Pace per il nuovo millennio" (13/9/1999), con uno specifico pro-gramma di azione. 10 Per la riscoperta della normalità della pace anche nella storia passata dell'umanità si vedano i lavori di uno storico spagno-lo che dirige l'Istituto Pace e Conflitti dell'Università di Granata, ed, in particolare, i suoi saggi su quella che lui definisce la "pace silenziosa" : Lopez Martinez M., Hacia una historia de la paz, e Munoz F.A., Lopez Martinez M., El re-conocimiento de la paz en la Historia in, F.A. Munoz, M. Lopez Martinez, Historia de la paz, Tiempos, Espacios y Actores, Eirene, Istituto de la Paz y los conflictos, Universidad de Granada 2000. 11 Sulle possibilità ed i modi per prevenire la guerra e del Kossovo, purtroppo non ascoltati, e sui costi umani e sociali che ha comportato l'averla fatta, si veda: L'Abate A., Kossovo. Una guerra annunciata, Edizioni La Meridiana, Molfetta, 1999 (II edizione). Si veda anche l'articolo di L'Abate A., Vivere i conflitti a livello macro. La prevenzione dei conflitti armati: il caso del Kossovo, in ,Servitium, n. 138, Novembre/Dicembre 2001. Parte 1 - Introduzione 35 Kossovo, in «Servitium», n.138, Nov./Dic. 2001. L’Abate A., Kossovo. Una guerra annunciata, Edizioni La Meridiana, 2a ed., Molfetta 1999. L’Abate A., Introduzione ai metodi di analisi nelle scienze sociali, Dispense Universitarie, A.A. 1992-93, Centro Stampa Toscana Nuova, Firenze. Bloch E., Lo spirito dell’utopia, La Nuova Italia, Firenze 1980. Capitini A., Il potere di tutti, La Nuova Italia, Firenze 1968. Carbonaro A., La scuola per una educazione alla pace, in «Critica Sociologica», n.18, 1971. Carbonaro A., Education for peace, in «The new Era», n. 9,1966. Catti G. (a cura di), Studiar per pace, Edizioni Thema, Bologna, 1988. Dolci D., Comunicare, legge della vita, La Nuova Italia, Firenze 1997. Dolci D., La struttura maieutica e l’evolverci, La Nuova Italia, Firenze 1996; Dolci D., La comunicazione di massa non esiste, Edizioni Lacaita, Manduria 1995. Dolci D., Cosa è pace, in Dolci D., Inventare il futuro, Laterza, 3a ed., Bari 1972. Euli E., Soriga A., Sechi P.G., Puddu Crespellani S., Percorsi di formazione alla nonviolenza: viaggi in training (1983-1991), Satyagraha Editrice, Torino 1992. Freire P., Pedagogia degli oppressi, A. Mondadori, Milano 1971. Friedmann J., Empowerment: una politica per lo sviluppo alternativo, Edizioni Quale Vita, Torre dei Nolfi 2003. Gallino L., Globalizzazione e disuguaglianze, Laterza, 6a ed., Bari 2001. Galtung J., Empiricism, criticism, constructivism: three aspects of scientific activity, in Galtung J., Methodology and Ideology, C. Ejlers, Copenhagen 1977. Galtung J., Hoivik T., Structural and direct violence, A note on operationalization, in «Journal of Peace Research», 1, 1971. Lopez Martinez M. , Hacia una historia de la paz, e Munoz F.A., Lopez Martinez M., El reconocimiento de la paz en la Historia in, Munoz F.A., Lopez Martinez M., Historia de la paz, Tiempos, Espacios y Actores, Eirene, Istituto de la Paz y los conflictos, Universidad de Granada, 2000. Mangano A., Danilo Dolci educatore, Ed. Cultura della Pace, Firenze 1992. Marasso A., Tropea M.C., La mia storia, la tua storia, il nostro futuro. Un gioco di ruolo per capire il conflitto israelo-palestinese, EGA, Torino 2003. Martirani G., Il drago e l’agnello, Edizioni Paoline, Milano 2001. Morgante T.R., Maieutica e sviluppo planetario in Danilo Dolci, Edizioni Lacaita, Manduria- 36 Comunicazione e Nonviolenza Roma 1992. Reichler L., Paffenholz T. (a cura di), Peace Building, a field guide, Lynne Rienner Publ., Boulder/London 2001. Sharoni S., La logica della pace: la trasformazione dei conflitti dal basso, EGA, Torino, 1997. Parte 2 La società multiculturale: dal conflitto distruttivo alla diversità come risorsa Parte 2 - La società multiculturale: dal conflitto distruttivo alla diversità come risorsa 39 2.1. IL CONFLITTO RELIGIOSO NELLA SOCIETA’ MULTICULTURALE di Lucia Ricco L’argomento che intendo trattare è il pregiudizio religioso come elemento di conflitto nell’ambito di una società multiculturale. Lo scopo è quello di suscitare la comprensione dei sentimenti vissuti nell’appartenere a una minoranza, sentimenti difficilissimi da capire per chi è nato e vissuto nella religione e nelle tradizioni di maggioranza del proprio Paese. Perché trattare il pregiudizio religioso quando sopravvivono ancora forme di discriminazione come quella razziale o nei confronti delle donne? Se i due processi dell’integrazione razziale e dell’emancipazione delle donne hanno compiuto grandi progressi nell’eliminazione del pregiudizio razziale e di quello di genere, l’ipotesi che le grandi religioni del mondo siano tutte egualmente valide per natura e per origine è [ancora] caparbiamente ostacolata da antiquati modelli settari di pensiero. Di fatto, la maggior parte dei Capi religiosi resta trincerata su posizioni esclusiviste. In altre parole essi insegnano che la propria religione è l’unica vera e che le altre sono nell’errore. Nel migliore dei casi, ossia nella visione inclusivista, i Capi religiosi insegnano che le altre religioni sono espressioni umane e minori della Verità spirituale assoluta e definitiva insegnata dalla propria. Le conseguenze di queste posizioni sono state e sono tuttora disastrose, perché la religione non solo “resta un elemento inestinguibile della coscienza umana”, ma “è altresì capace di influenzare profonda-mente la struttura dei rapporti sociali”1. La tematica riguarda direttamente il nostro paese. 2.1.1. Situazione nel nostro paese Qual’è la mentalità corrente in Italia nei confronti di chi appartiene ad una religione differente da quella di maggioranza? Vi sono 2 livelli di atteggiamento: quello della gente comune che si differenzia, a sua volta, se colui che appartiene ad un’altra religione è italiano o di altra nazionalità; quello degli addetti ai lavori, dei leader religiosi e del mondo laico. Origine del pregiudizio. L’attitudine a voler vedere noi stessi proiettati negli altri e non gli altri nella loro essenza conduce a sfuggire la diversità come ricchezza, a rifiutarne l’indagine, a voler incasellare il nuovo all’interno di categorie a noi già note e a darne, quindi, un giudizio aprioristico: il pregiudizio, appunto. A livello della categoria (a), quella della gente comune, il pregiudizio si manifesta nei confronti ad esempio dei cittadini italiani “convertiti” con un atteggiamento di sospetto. Il sospetto. Nasce dalla mancanza di accettazione della diversità, è un retaggio che proviene dal passato e 1 Casa Universale di Giustizia, Ai capi religiosi del mondo. 40 Comunicazione e Nonviolenza colpisce tanto i cattolici che i laici italiani. La difficoltà di aprirsi all’arricchimento è un segnale di debolezza sui valori ed è, per questo, preoccupante. In genere, nella mia esperienza personale, tale atteggiamento viene manifestato più da chi vive una fede di tipo formale rispetto a chi, invece, ha una fede profonda e vissuta. Il sospetto è differente se la persona che appartiene ad un’altra Fede è italiana o straniera: per quest’ultima si dà abbastanza per scontato che possa appartenere ad una religione “altra”, soprattutto per la tendenza inconsapevole a considerare il Cristianesimo un fenomeno italiano. Oltre a questo tipo di sospetto generico, vi è, da parte dei cattolici italiani, quello più specifico che na-sce dalla convinzione che qualcuno ti abbia costretto o plagiato. Questo tipo di sospetto è particolarmente offensivo sia nei confronti della Fede che hai scelto sia per le tue capacità mentali e sottintende che nessuno sano o libero di mente potrebbe scegliere una religione che non sia quella cattolica. Senza volerlo, si trasmette un sentimento di arroganza misto a compatimento. Il tutto, il più delle volte, senza che l’altro sappia nulla di ciò che io ho scelto. Le formalità, le cadenze del mondo sia laico che religioso italiano, vengono altresì usate come elementi discriminanti (vedi, ad esempio, i bambini che frequentano la terza elementare e che non si preparano come gli altri alla Prima comunione: non c’è inclusività del diverso in questo evento così lieto). A livello comunitario esistono altri generi di ombre: - superficialità e disinformazione - sospetto nei confronti delle attività promosse dalle altre comunità religiose. Il problema essenziale è la mancanza di fiducia: solo con un’amicizia genuina sapremo quali sono i valori degli altri e resteremo sorpresi dal vedere che non corrispondono ai nostri preconcetti. Spesso istituzioni politiche e religiose, supportate da un’informazione sui mezzi di comunicazione su-perficiale o addirittura errata, con il termine “setta” alimentano un allarmismo generalizzato e quindi infondato nei confronti di tante persone non violente o addirittura impegnate in organizzazioni per la promozione dei diritti umani. La paura, infatti, ci impedisce a volte di riconoscere la familiarità di certe usanze: a me non sembra strano pregare quotidianamente o meditare sui Testi Sacri perché me l’hanno insegnato nella mia famiglia cattolica. Anche il digiuno veniva praticato con grande entusiasmo e le abluzioni prima della preghiera non sono differenti dal segnarsi con l’acqua santa all’ingresso della Chiesa. La perdita dell’identità mistica del Cattolicesimo conduce gli stessi credenti a ignorare le basi e le radici dalle quali provengono, simili alle vergini stolte che non riconoscono lo sposo. 2.1.2. Il dialogo interreligioso A livello globale non si può affermare che ci sia il dialogo. Ci sono alcuni gruppi che lo fanno in maniera del tutto spontanea e autonoma ma sono emarginati: anzi, il desiderio profondo dei seguaci delle varie Religioni di abbattere il muro di ignoranza reciproca è stato visto da alcune istituzioni religiose come un tentativo di operare uno sterile sincretismo o relativismo culturale o sintesi dottrinale. Ciò che invece il dialogo vuole perseguire è impegnarsi a rispet- Parte 2 - La società multiculturale: dal conflitto distruttivo alla diversità come risorsa 41 tare l’altro nella sua identità di fede anche quando non possiamo condividere le sue idee religiose. Si deve quindi creare una cultura del dialogo che comprenda un mondo intero di relazioni positive. Tra queste possiamo individuare quelle di: - capire come si possa vivere insieme in una società pluralista dove ognuno abbia la propria dignità; - comprendere cosa possiamo fare per promuovere la giustizia e il benessere per l’umanità; - studiare insieme. In sintesi, dialogare non significa entrare nel merito di disquisizioni teologiche, bensì lavorare sui valori positivi comuni. 2.1.3. Passi fondamentali già concordati In alcuni Paesi del mondo ci sono stati e ci sono dialoghi ufficiali tra leader che hanno concordato alcuni passi fondamentali ma che non hanno però avuto alcuna ricaduta degna di rilievo all’interno di ciascuna comunità religiosa. Nel 1893 si riunì, per la prima volta a Chicago, il Parlamento mondiale delle Religioni che, nel corso delle celebrazioni del suo centenario nel 1993, ha espresso l’esigenza di un’etica globale. Dal 25 al 28 Ottobre 1999, 200 partecipanti provenienti da quasi 50 Paesi e rappresentanti di 20 diverse tradizioni religiose, si sono riuniti nella Città del Vaticano per un’assemblea interreligiosa avente per oggetto la collaborazione fra le diverse religioni. Alla fine dei lavori è stato emesso e firmato da tutti un documento che pone le basi per un lavoro comune e rappresenta un impegno assunto da ogni Religione. Nell’introduzione di legge: “noi…riconosciamo la responsabilità che hanno le Religioni di modellare il futuro, un compito che implica lasciar perdere gli errori del passato e cercare nuove vie per andare avanti”. A proposito del dialogo dice: “Il dialogo è riconosciuto come uno strumento di collaborazione per formare una società migliore per l’umanità” Seguono alcuni suggerimenti - rimanere in contatto regolare gli uni con gli altri, specialmente in situazioni di crisi o di conflitto; - cercare di lavorare insieme per prevenire stereotipi, odio e violenza; lavorare invece per promuovere amore reciproco; - aiutare i mass-media a promuovere valori positivi, attraverso la collaborazione diretta ai programmi e attraverso appelli; - lavorare insieme per aiutare a superare l’ingiustizia e la povertà e la negazione della dignità umana. 2.1.4. Le iniziative Bahá’í La visione. Quando qualcuno pensa di non avere niente da imparare dagli altri nasce il fondamentalismo: è triste che a prendere le iniziative siano sempre i fanatici e che le persone aperte si limi- 42 Comunicazione e Nonviolenza tino a reagire. Bisogna prendere l’iniziativa di costruire una società pluralistica e per far ciò i Bahá’í propongono: - L’abbandono di ogni forma di pregiudizio (fin quando esisteranno l’umanità non avrà pace; demoliscono l’edificio dell’umanità); - La libera e indipendente ricerca della verità (così che il mondo dell’umanità possa essere salvato dalle tenebre dell’imitazione e conseguire la verità). “L’uomo deve amare la luce senza badare da quale alba essa appaia; deve amare le rose senza tener conto del terreno nel quale crescono....Il vero deve essere accettato indipendentemente da chi lo enuncia. Le verità debbono essere accolte prescindendo dai libri che le contengono. Se è in noi un pregiudizio esso sarà causa di privazioni e di ignoranza” 2 . “La Religione dovrebbe unire i cuori, causare la scomparsa, dalla faccia della terra, delle guerre e delle lotte, dar vita alla spiritualità, infondere vigore e luce nei nostri cuori. Se la religione diviene la causa di contrasti, odio e dispute, è meglio non averla e il separarsi da una simile religione sarebbe invero un’azione pia. E’ chiaro che lo scopo di un rimedio è di curare, ma se il rimedio aggrava il male è meglio abbandonarlo. Ogni religione che non è causa di amore non è religione” 3 . 2.1.5. La Consulta delle Religioni Tra le attività incoraggiate e sostenute dai Bahá’í italiani c’è stata la creazione della Consulta delle Religioni di Roma. Il 16 dicembre 2002 è stato siglato il Protocollo d’intesa fra il Comune di Roma e la Consulta delle Religioni presenti nella città. Tale organismo permanente, che vede fra i suoi membri i leader di tutte le religioni, ha tra i suoi obiettivi la promozione delle seguenti attività: - Incontri e seminari sul tema del pluralismo religioso; - Incontri di dialogo interreligioso nello spirito del confronto tra culture e fedi; - Incontri tesi a favorire la conoscenza del patrimonio spirituale delle diverse comunità di fede; - Visite guidate nei luoghi di culto delle diverse religioni; - Eventi musicali, artistici e culturali in genere tesi a promuovere una cultura della pace, del dialogo e del rispetto dei diritti umani; - Rispetto dei diritti delle minoranze; - Formazione degli operatori nei vari campi; - Attività tese a garantire informazione diretta e corretta. Nell’ambito di questi obiettivi, la Consulta delle Religioni è riuscita a far sì che il Campidoglio diventasse la “casa” di tutti: là si sono svolte quest’anno le più importanti festività religiose delle minoranze quali la nascita di Bahá’u’lláh, il Capodanno cinese e quello dei Sikh, 2 Abdu'l-Bahà, da una conferenza tenuta negli Stati Uniti (Bahà'ù'llah e la Nuova Era, p.95) cfr. conferenza di Abdu'l-Bahà a Parigi (La saggezza pp.158-159) e negli Stati Uniti (Star of the West, volume VIII pag.76). 3 Parte 2 - La società multiculturale: dal conflitto distruttivo alla diversità come risorsa 43 la conclusione del mese di Ramadan. Si è inaugurato un luogo, all’interno del cimitero monumentale del Verano, nel quale i credenti delle varie religioni ma anche i non credenti possano ricevere degne onoranze funebri. Si stanno individuando i terreni e gli edifici di proprietà del Comune di Roma da destinare a luoghi di culto per le minoranze ma, soprattutto, si incomincia a capire che la pace passa attraverso il rispetto dei diritti dei singoli e delle comunità, piccole o grandi che siano. 2.1.6. Il Messaggio ai Capi religiosi Del dialogo interreligioso ho già scritto, ora vorrei analizzare gli attuali limiti di questa comunicazione così come la sterilità degli appelli contro il fanatismo o il terrorismo: “E’ chiaro purtroppo che queste iniziative mancano di logica intellettuale e impegno spirituale”4. Nel panorama attuale è singolarmente interessante la recente iniziativa della Casa Universale di Giustizia, organo di governo della comunità internazionale Bahá’í e che ha coinvolto tutti i leader religiosi del pianeta. Il messaggio Ai Capi religiosi del mondo, edito dalla Casa Editrice Bahá’í nella versione italiana e che nel 2002 è stato consegnato a tutte le autorità religiose italiane, offre l’opportunità di intraprendere un decisivo passo in avanti nel dialogo fra le religioni. Il documento prende atto della paralisi delle posizioni religiose di fronte al futuro: “La maggior parte della religione organizzata, invece, resta paralizzata sulle soglie del futuro, stretta nella morsa di quei dogmi e di quelle pretese di accesso privilegiato alla verità che hanno prodotto alcuni dei più aspri conflitti che abbiano diviso gli abitanti della terra”. e invita i capi religiosi non solo a voler rivedere quegli aspetti che possono alimentare se non addirittura giustificare il fondamentalismo ma anche a voler ratificare ciò di cui molti credenti sono già convinti: “Dio è uno e… al di là di ogni diversità di espressione culturale o interpretazione umana, anche la religione è una”. Il riconoscimento di questa unità è fondamentale, perché, come ha scritto Bahá’u’lláh, il Fondatore della Fede Bahá’í: “Non v’è alcun dubbio che i popoli del mondo, a qualsiasi razza o religione appartengano, si ispirano a un’unica Fonte celeste e sono sudditi di un solo Dio. La differenza degli ordinamenti sotto cui vivono deve attribuirsi ai mutevoli bisogni e alle cangianti esigenze del tempo in cui essi furono rivelati”. Non posso prevedere quale esito avrà questo invito ai Capi religiosi ma sono certa che quanto prima tale concetto sarà fatto proprio dalle organizzazioni religiose, tanto prima si potrà sviluppare un cammino di pari dignità e di pacifica convivenza fra gli esseri umani. 4 Casa Universale di Giustizia, Ai capi religiosi del mondo. 44 Comunicazione e Nonviolenza 2.2. LA MOLTIPLICAZIONE DELLE DIGNITA’ di Maurizio Lozzi “Colui che si sente a suo agio soltanto a casa propria, nel proprio paese, è un individuo assai imperfetto. E’ certamente più perfetto l’individuo che si sente a suo agio un po’ dappertutto. Compiutamente perfetto è però l’individuo che si sente a disagio ovunque si trovi”. L’inizio di questo intervento è volutamente ispirato al pensiero di Ugo di San Vittore (1090 - 1141), filosofo del XII secolo. Si tratta in fondo di un pensiero antico, ma che trasposto oggi ad oltre novecento anni di distanza, appare invece fortemente moderno se decidiamo di commisurarlo alla realtà in cui la nostra società multiculturale si trova immersa. Una realtà che, dopo la cupa atmosfera di morte e distruzione innescata prima ad un livello circoscritto, ma ritenuto invece planetario, con l’11 settembre e poi invece ad un livello planetario, ma ritenuto invece circoscritto, con la guerra definita ipocritamente “preventiva” o persino “umanitaria” contro l’Iraq, ci ha paradossalmente proiettati verso un processo di livellamento e di globalizzazione della paura - o come diceva più ingenuamente Ugo di San Vittore, di disagio - che ci ha reso tutti compiutamente perfetti. Perfetti e simmetrici però non nei valori dell’accoglienza, dell’apertura o della comprensione, ma in quelli della paura, del terrore e dell’incertezza. Tutti elementi questi che hanno contribuito a spingere verso rigidi e preoccupanti processi di globalizzazione del nemico concorrendo ad allontanare sempre più le possibilità di (ri)generazione di rispettosi e dinamici processi per il riconoscimento di quella che oggi è nella nostra società l’esistente moltiplicazione delle dignità. Si pensa alla dignità umana molto spesso come ad un fardello che sta alle nostre spalle, in un certo senso ad un carico che ci è difficile riconoscere e che, frequentemente, preferiamo non considerare. Quando però ci appare visibile anche la dignità che gli altri posseggono, ecco allora che sentiamo messe in pericolo le pretese di rispetto per la nostra. Non è infatti un caso se oggi, nella perfezione compiutamente simmetrica generata dai sentimenti di paura e di disagio nei quali - dopo l’attacco alle Twin Towers e la guerra in Iraq ci ritroviamo tutti globalizzati, venga persino a cadere il concetto stesso di rispetto, parola questa che dopo i raccapriccianti eventi ai quali abbiamo dovuto assistere, sta allontanandosi sempre più dal suo significato originario sul quale invece è bene riflettere. Respicere, radice etimologica latina di rispetto, significa infatti guardare, osservare, avere riguardo o come diceva anche E. Fromm: “capacità di vedere una persona com’è, di conoscerne la vera individualità”. Dall’11 settembre alla guerra in Iraq, vedersi per come si è non è stato più possibile. Si è passati da timidi processi di avvicinamento e di co-esistenza con l’altro, a rigide modalità di distanziamento e di re-sistenza all’altro. E’ stato chiaro sin dall’inizio che gli attacchi alle Twin Towers ed all’Iraq avrebbero cambiato Parte 2 - La società multiculturale: dal conflitto distruttivo alla diversità come risorsa 45 profondamente le considerazioni di ognuno di noi rispetto al concetto di dignità, anche perché dubbi sulle legittimità delle azioni belliche, iniziate da quella battezzata Enduring Fredoom non è che abbiano poi trovato grandi spazi nelle “verità” diffuse a livello planetario dai media che ormai possiamo definire tranquillamente non più mezzi di comunicazione, ma mezzi di “distrazione” (voluta) di massa. La globalizzazione del nemico è diventata subito l’indicatore di una caduta di dignità delle intelligenze occidentali, alle quali pochi spazi - quasi nulli - sono stati concessi per consentire di non ridurre nel tormentone semplicistico “o con noi o contro di noi”, i tragici e, in ogni caso, condannabili eventi ai quali impotentemente abbiamo dovuto assistere. In un articolo pubblicato tempo fa dal settimanale americano Newsweek con il titolo La giustizia tenuta al buio (Justice kept in the dark) sono stati raccontati episodi riguardanti musulmani arrestati in America, nei giorni seguiti all’11 settembre, nel pieno disprezzo dei loro diritti processuali, facendo incrinare quella solida figura che agli Stati Uniti abbiamo sempre attribuito di patria dei diritti civili. Tra le voci fuori dal coro, anche quella ad esempio di Human Rights Now, associazione presieduta da Michael Ratner1 che ha affermato come ormai ci si stia sempre più muovendo verso un clima globalizzato di sospetto e di paura, tanto che la gente è persino spaventata nel tentare di dire ciò che pensa. Affermare che una società controllabile e militarizzata possa assicurare pace e dignità è probabilmente un’utopia e la dimostrazione continua a venire purtroppo ogni giorno dallo scacchiere internazionale, dove l’idea di un Occidente militarizzato e chiuso su posizioni indiscutibili non fa altro che allontanare la ricerca della comprensione di quelle dignità che noi continuiamo ad ignorare e sulle quali invece i manipolatori dei fondamentalismi agiscono fanaticamente. Se esiste una risposta da dare subito, la domanda è questa: c’è più dignità nel garantire ostentatamente la nostra indiscutibile sicurezza oppure c’è più dignità nell’assicurare i diritti civili degli altri che con visione eurocentrico-occidentale riteniamo il più delle volte discutibili? Mentre a questa provocazione tentiamo di trovare una saggia risposta, è importante ricordare un insieme di fatti recenti, e nei confronti dei quali i media preferiscono fare silenzio, dimostrandosi ancor più per la massa “mezzi di distrazione” anziché di comunicazione. Sul quotidiano israeliano «Haaretz» ufficiali dell’esercito di Sharon hanno pubblicato, in uno spazio a proprie spese, il loro rifiuto di obbedire agli ordini che impongono di commettere azioni repressive nei Territori occupati e il movimento Yesh Gvul, che da anni assiste i soldati israeliani nel rifiutare la violenza2, pretende non che questi abbandonino l’esercito, ma che 1 Michael Ratner è, inoltre, negli Stati Uniti d’America procuratore per i diritti civili del consiglio nazionale del Centro dei diritti costituzionali. 2 Yesh Gvul in ebraico significa “C’è un limite” ed è il nome scelto da questo gruppo di pace israeliano impegnato da anni nel supportare i “Refusnik”, ossia quei membri delle forze armate israeliane che rifiutano ordini di natura repressiva e aggressiva, attivando la pratica del cosiddetto “rifiuto selettivo”. Si tratta di un concetto unicamente israeliano tendente a far applicare all’interno delle forze armate ebraiche i principi di disobbedienza civile, pioneristicamente introdotti dal Mahatma Ghandi e da Martin Luther King Jr., ad un contesto militare. Pur riconoscendo la legalità del servizio militare universale, il “rifiuto selettivo” sollecita il diritto ed il dovere di ogni soldato a scrutinare gli ordini ricevuti e rifiutare compiti che egli trova moralmente o politicamente ripugnanti. 46 Comunicazione e Nonviolenza si facciano invece portatori di valori come il rispetto per la dignità e la vita umana insieme al diritto di tutti di poter serenamente vivere sulla propria terra. Nel suo Breviario minimo, il filosofo polacco Leszek Kolakowski sostiene che “per quanto le esperienze storiche non invoglino a praticarlo, il terrorismo continuerà ad esistere, visto che non c’è motivo di credere che le ingiustizie e gli accumuli di odio scompaiano” e in un certo senso, anche se con un punto di vista diametralmente opposto, si pronuncia anche Paul Watzlawick all’interno del volume Di bene in peggio in cui afferma che “l’ordine senza una componente di disordine diventa pericoloso, perché soffoca ogni possibilità di ulteriore evoluzione”. L’evoluzione verso un pieno riconoscimento della moltiplicazione delle dignità esistenti nel nostro mondo globalizzato malgrado tutto va avanti e milioni di persone lo hanno dimostrato. Tutto é accaduto quattro mesi fa, esattamente sabato 15 febbraio, giorno in cui il meccanismo dei “mezzi di distrazione di massa” si è inceppato grazie a visibili milioni di persone che in tutto il mondo sono scese in strada elevando in alto la loro dignità e dimostrando come si possa essere capaci di moltiplicare la propria e quella degli altri autorganizzandosi pur partendo da culture e da percorsi molto diversi che, paradossalmente, davanti ad una guerra in ogni caso già decisa, hanno avuto possibilità di incrociarsi. Habermas e Weber sostenevano in fondo che il conflitto è un elemento sì inevitabile, ma per la società vitalizzante. Quanto accaduto conferma che la vitalità di una società anche globalizzata come la nostra è in grado di sfuggire ai mezzi di “distrazione”, fomentatori dello “scontro di civiltà”, attivando consapevoli processi di moltiplicazione delle dignità decisamente lontani dalle spirali dell’odio fomentate dai terrorismi sia integralisti che di Stato, ma fortunatamente vicine invece ai profondi desideri di ascolto, di accoglienza e di comprensione che invece, nella piena valorizzazione d’ogni dignità, consentono l’incontro delle civiltà. Riferimenti Bibliografici Fromm E., Anatomia della distruttività umana, Mondadori, Milano 1975. Habermas, J. L'etica del discorso, Laterza, Roma-Bari 1983. Kolakowski L., Breviario minimo. Piccole lezioni per grandi problemi, Il Mulino, Bologna 2000. Ugo di San Vittore. Soliloquium de arrha animae. Watzlawick P,. Di bene in peggio. Istruzioni per un successo catastrofico, Feltrinelli, Milano 1987. Parte 2 - La società multiculturale: dal conflitto distruttivo alla diversità come risorsa 47 2.3. PROGETTO MULTICULTURA “La scoperta dell’altro” di Elisabetta Damianis 2.3.1. Educazione all’interculturalità “Che l’uomo conosca ciò che è divino, che lo conosca; questo è tutto. Se un greco è indotto al ricordo di Dio dall’arte di Fidia, un egiziano dal culto degli animali, un altro uomo da un fiume, un altro dal fuoco - non mi adiro per il loro disaccordo; basta che conoscano, che amino che ricordino”. Massimo di Tiro, sofista - II sec. a. C. La relazione ha come scopo quello di illustrare il progetto d’intervento che da quattro anni si sta svolgendo presso la scuola media statale Ascoli-Favetti di Gorizia. Tale progetto è attuato in collaborazione con l’Università degli studi di Trieste, facoltà di Scienze Politiche, corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche. L’obiettivo è quello di facilitare l’integrazione degli studenti stranieri e di arricchire la cultura di quelli italiani in un istituto scolastico caratterizzato da un recente considerevole afflusso di studenti immigrati. La tipologia d’intervento, che si è evoluta nel corso degli anni, è stata inizialmente decisa di concerto con l’opinione degli insegnanti. Si è proceduto anzitutto delineando quello che è risultato essere il bisogno centrale dell’Istituto. In effetti, ciò che in un primo momento è apparsa come una necessità esclusiva di approfondire i diversi usi e costumi e di effettuare degli interventi al fine di “far integrare gli stranieri” per risolvere il “problema”, ad uno sguardo più attento si è rivelato essere una necessità generale non riguardante esclusivamente gli stranieri. Si è cominciato così a considerare il pluralismo culturale non più solo come un “problema di integrazione”, ma come una risorsa interna alla scuola, come occasione di scambio, di trasformazione reciproca e di ridefinizione dei propri orizzonti. Questo cambiamento del punto di vista sul problema, ha reso possibile l’emergere della necessità di educare ed educarci reciprocamente all’interculturalità. L’educazione all’interculturalità implica il rimettersi in gioco, tutti in prima persona, al fine di una ridefinizione culturale reciproca. Ciò non significa sacrificare le differenze sull’altare dell’assimilazione ma anzi, al contrario, creare una tipologia relazionale che permetta il dialogo tra le diversità, divenendo così occasione di cambiamento e di crescita. Uno spazio in cui identità e differenze siano tenuti assieme in un rapporto d’interazione e reciprocità. Non si vuole con questo esaltare l’una o soffocare l’altra ma valorizzarle entrambe, nella loro struttura che connette, in altre parole, appunto, la relazione. Questo percorso d’apprendimento non mira tanto ad ampliare la conoscenza sull’Altro in senso nozionistico, ma vuole modificare il modo, l’atteggiamento, che si ha nel conoscere l’Altro al fine di stabi- 48 Comunicazione e Nonviolenza lire una “mentalità multiculturale”. In altri termini, ciò significa divenire capaci di entrare in empatia con l’Altro, riuscire a sentire cosa sta provando, ospitarlo ed accoglierlo dentro di sé, senza dimenticarsi che l’Altro è un individuo separato, diverso da noi stessi. L’empatia ci permette in pratica di sentire profondamente l’Altro, di accoglierlo, evitando reazioni di distacco che fuggono dal contatto o di simbiosi che annullano l’identità, il Sé nell’Altro. In questo modo di dialogare si concreta quella coesistenza tra identità e differenza o meglio tra Sé e l’Altro. Addestrarsi all’empatia significa essere in grado di: saper vestire i panni dell’Altro, saper cambiare il proprio punto di vista, conoscere il proprio mondo emotivo per capire di più noi stessi e gli altri; migliorare il livello di contatto umano e di comunicazione attraverso un allenamento all’ascolto attivo e ad un atteggiamento proattivo e collaborativo. Portare a coscienza e riscoprire tali attitudini già insite nell’essere umano ma spesso dimenticate e poco o mal utilizzate nel quotidiano, va, come si diceva, nella direzione di ampliare la personale capacità di empatia e dunque anche di accoglienza. L’interculturalità si lega in tal senso a doppio nodo con l’accoglienza. Accogliere vuol dire saper essere ospitali, ovvero essere in grado di far spazio dentro di noi per percepire la presenza dell’Altro, ascoltare i suoi bisogni, valorizzarlo nella sua diversità, apprezzarlo per le sue risorse, festeggiarlo per la sua crescita e autorealizzazione. Se l’accoglienza viene meno si passa da un atteggiamento di ascolto, di comprensione, ad uno di giudizio e spesso di pregiudizio accompagnato da dinamiche di bullismo, espulsione, esclusione, emarginazione, perfino di razzismo. Attraversare questi ambiti educativi, consente inoltre di migliorare la consapevolezza che “essere in gruppo” non significa “essere un gruppo”. Si diventa gruppo, o alcuni direbbero comunità scolastica, quando i membri stabiliscono dei legami relazionali e si impegnano al benessere e all’autorealizzazione di ciascun componente. Riconoscersi gruppo significa in altri termini riuscire a stimare gli altri per la loro singolarità, per le risorse di ognuno che, se condivise in un clima collaborativo, diventano risorse della classe, del gruppo, della comunità. Nel proporre uno stile collaborativo anziché esclusivamente competitivo, non si può tuttavia prescindere dal considerare, far emergere, valutare, i conflitti presenti all’interno del gruppo al fine di favorirne una gestione non distruttiva. Questo stile di trasformazione dei conflitti in forme relazionali maggiormente empatiche, si sposa infine con ideali di pace, intesa in quanto convivenza fondata sul riconoscimento dell’alterità come necessaria premessa per lo scambio, la relazione e la partecipazione ad un processo comune. Si tratta in sostanza più che di ‘fare la pace’ di ‘es-sere pace’ e di ‘sentirsi nel mondo’ con la consapevolezza che nessuna identità può costituirsi senza l’alterità o meglio non vi può essere alcun Sé senza al contempo la presenza dell’Altro. 2.3.2. Il tema centrale: la relazione tra il Sé e l’Altro “Chi posso in generale riconoscere come mio nemico? Evidentemente soltanto colui che può mettermi in questione.Riconoscendolo come nemico riconosco ch’egli mi può mettere in questione. E chi può mettermi in questione? Solo io stesso o mio fratello. Ecco l’Altro è mio fratello. L’Altro si rivela fratello mio, e mio fratello mio nemico”. (Carl Schmitt) Parte 2 - La società multiculturale: dal conflitto distruttivo alla diversità come risorsa 49 Le basi teoriche su cui poggia questo intervento hanno matrice psico-sociale e si focalizzano sull’idea forza del rapporto tra il Sé e l’Altro. Dal punto di vista più strettamente psicologico, secondo l’interpretazione junghiana, il Sé viene inteso in quanto unione degli opposti ovvero coincidentia oppositorum tra l’Io e l’Ombra o Altro interno, o ancor meglio l’inconscio. L’Ombra, il lato oscuro dell’uomo, ciò che di se stesso egli non riesce a riconoscere, l’Altro, è l’elemento che spesso si rivela in senso proiettivo nel nemico, il diverso, l’emarginato, lo straniero per eccellenza. Egli appare, nella descrizione di R. Escobar, come colui il cui disordine conferma il nostro ordine, la cui disumanità conferma la nostra umanità, la cui mostruosità conferma la nostra normalità. L’Altro, il nemico-fratello, in quanto proiezione dell’inconscio, non è che una maschera dietro la quale si nasconde il lato più profondo, trascendente dell’uomo. In tal senso il vero nemico sembra rivelarsi nella paura di guardare l’Ombra, l’Altro interno, di contattarlo, di ascoltarlo, di ospitarlo. Accogliere l’Altro significa quindi in primo luogo accogliere l’altra parte di noi stessi, entrare in dialogo con essa, riconoscerne la diversità. In quest’ottica pare ribaltarsi il concetto stesso di normalità poiché essere veramente ‘normali’ non sembra avere altro significato se non quello di scoprirsi diversi, speciali, unici. Colui che ci mette in discussione, che ci costringe al confronto ed al contatto, dovrebbe perciò essere non un nemico ma l’amico per eccellenza che consente quell’unione senza la quale non vi può essere alcuna individuazione di Sé. In tal senso l’Altro deve essere scoperto. L’essere umano risulta dunque indistinguibile dalla sua dimensione sociale. Con l’esistenzialismo (Heidegger 1976), si può sostenere che la vita umana è racchiusa tra due estremi. Quello - a partire dalla nascita - in cui l’Io invade il mondo. Quello al termine dell’esistenza, in cui il mondo riassorbe l’Io. Tra questi due estremi ha il proprio corso la scoperta dell’Altro. Questa si svolge attraverso diversi gradi - l’Altro come oggetto, l’Altro come soggetto uguale all’Io, ma diverso - indicanti un percorso sociale e culturale riguardante non solo l’individuo, ma la società nel suo complesso. Nella sua evoluzione, la civiltà occidentale ha dapprima dimostrato una grande capacità nel “comprendere” l’altro per distruggerlo. Nell’analisi sulla conquista del Messico, Todorov (1992) illustra in maniera convincente l’abilità dell’uomo bianco nel “comprendere-perdistruggere”. Indica anche la sua superiorità tecnica nella comunicazione con le altre culture, che andava però a discapito della comunicazione con il mondo. Il colonialismo ha, infatti, provocato un’omologazione del diverso (per cultura, lingua e religione), che ha iniziato a “globalizzare” il mondo con un certo anticipo. Quando però l’occidente ha dimenticato l’estraneità dell’Altro esteriore, ha trovato un Altro interiore con la scoperta dell’inconscio. Nella società contemporanea, si è passati dall’omologazione conflittuale dell’estraneità ad un complesso dialogo tra uguaglianza e differenza. Nel senso che la ricerca dell’uguaglianza non significa inseguire un’identità in senso omologante, mentre la differenza non viene più coniugata secondo lo schema gerarchico inferiorità/superiorità. Ciò significa trasformare anche il paradigma stesso del processo di socializzazione, codificato nell’ambito della società di massa. La scoperta del Sé attraverso il contatto con l’Altro e gli altri sostituisce l’esigenza della scomparsa dell’Io nel Noi, come prerequisito di una società ben funzionante. A livello di tecnica sociologica, ciò significa assumere un concetto di socializzazione capace di salvaguardare l’autonomia individuale (Palmonari 1990; Baraldi 1992; 2003). In altre paro- 50 Comunicazione e Nonviolenza le, si ritiene che il processo di socializzazione sia corrispondente a quello di individuazione (di un Io e del Sé). La formazione del Sé è allora fortemente connessa con le capacità relazionali. In particolare si può affermare che il Sé non è che il frutto della relazione tra l’Io e l’Altro i quali tra loro più che ‘essere’ in modo autonomo, “inter-sono”. Né l’Io né l’Altro possono quindi esistere solo in virtù di se stessi. 2.3.3. Descrizione dell’intervento Le diverse fasi del progetto, hanno visto impegnati alunni, insegnanti, genitori, e la nostra équipe formata dal prof. Ungaro (docente di sociologia presso l’Univ. di Trieste e di Teramo); la dott. Damianis (dottoranda in sociologia e counsellor) ed una quarantina di studenti del corso di laurea in Scienze In-ternazionali e Diplomatiche in veste di mediatori culturali. I momenti centrali dell’intervento possono così essere riassunti: - La formazione degli insegnanti - Il lavoro di intervento nelle classi - La mostra multicultura - I colloqui di counselling con gli alunni che hanno dimostrato particolari disagi e con i loro genitori. Di seguito, vengono illustrati alcuni di questi punti. 2.3.4. Il lavoro d’intervento nelle classi Il programma proposto nelle classi, differenziato per prime, seconde e terze è di tipo teorico/esperienziale. Come si è detto, tema centrale è il rapporto tra Sé e l’Altro ed in particolare si sono afrontati i temi del contatto con sé e gli altri, passando attraverso: - L’alfabetizzazione emotiva che mira a migliorare la capacità di riconoscere ed esprimere le emozioni legandosi a doppio nodo con la personale capacità di “fare contatto”con l’Altro (sia interno che esterno a noi). - La capacità di riconoscere la propria mappa rappresentazionale e la propria “visione del mondo”, ma anche di comprendere l’importanza che ha il sapersi mettere nei panni dell’altro, l’accogliere l’altrui visione al fine di ampliare la propria. - L’acquisizione di strumenti - come l’ascolto attivo, la capacità di farsi capire in modo proattivo e di dirimere conflitti in modo non distruttivo - utili al fine di instaurare con gli altri uno stile di “comunicazione sana”. Il programma progressivo ideato per le classi prime e seconde si è in particolare focalizzato sui primi due punti. L’affrontare tali temi nel biennio è risultato propedeutico al lavoro sulla comunicazione proposto alle classi terze. Gli strumenti utilizzati durante tali incontri (due incontri di quattro ore ciascuno più un’ora per la somministrazione dei questionari), hanno incluso l’ascolto attivo, l’uso di metafore, la proiezione di lucidi, le simulazioni in aula ed i lavori di gruppo. Nel proporsi al gruppo classe, si è cercato di considerare i ragazzi come il nostro Altro. A tal motivo, si è voluto astenersi dall’imporre ad essi un sapere preconfezionato da assimilare passivamente. L’ascolto reciproco, la richiesta di feedback, l’uso di brainstorming, hanno permesso di conoscere meglio le loro idee. In altre parole, si è evitato di vestire Parte 2 - La società multiculturale: dal conflitto distruttivo alla diversità come risorsa 51 i panni dei colonizzatori che mirano a diffondere la loro civiltà senza accogliere quella altrui, questo anche per non correre il rischio di risultare simili a chi insegna solo perché ha perso la facoltà di imparare e di stupirsi degli altri. Questa linea generale di dialogo e reciprocità, si è bilanciata con il bisogno di contenimento dei ragazzi in questa particolare fase di sviluppo. Si sono così posti loro dei “limiti di sicurezza” fondati sul contatto ,dialogo, coscienza di gruppo ma soprattutto regole condivise, proposte dagli stessi ragazzi. A questa specifica funzione hanno contribuito in maniera determinante i mediatori culturali dell’Università (studenti del SID). Questi, oltre a far comprendere e partecipare attivamente alcuni ragazzi stranieri che non avevano ancora piena padronanza della lingua italiana, seguivano personalmente chi, indipendentemente dalla nazionalità, dimostrava un particolare disagio o difficoltà. Hanno inoltre effettuato un lavoro osservazione partecipata nei lavori di gruppo e sono stati fondamentali nel supportare tali gruppi. 2.3.5. I colloqui di counselling Durante il lavoro nelle classi, spesso è capitato di incontrare ragazzi che vivono particolari situazioni di disagio e che rischiano di alimentare il fenomeno della dispersione scolastica. Con alcuni di questi sono stati realizzati, previo consenso dei genitori, dei colloqui di counselling. Spesso tali incontri con il /la ragazzo/a hanno incluso anche dei colloqui con i familiari ed in alcuni casi, particolarmente gravi si è richiesto, in accordo con la scuola, l’intervento dei servizi territoriali di assistenza sociale. La figura del counsellor all’interno della scuola, si è rivelata quindi utile sia al fine di creare maggiore relazione all’interno dell’istituto scolastico, tra i vari attori, ovvero tra studenti, insegnanti e genitori ma anche come elemento di collegamento con le strutture operanti sul territorio con le quali auspichiamo una sempre maggiore collaborazione e connessione di rete. 2.3.6. Analisi dei dati La dimensione sociologica dell’intervento - oltre che rispetto all’ipotesi base fondamentale, consistente nel considerare equivalenti il processo di socializzazione e di individuazione (formazione del Sé) - consiste anche nell’elaborazione dei dati derivanti dalla somministrazione dei questionari suddetti. L’analisi delle domande aperte ha permesso di valutare la situazione emotiva degli studenti, soprattutto dal punto di vista della loro accettazione. La letteratura rilevante sui processi di socializzazione enfatizza il bisogno di riconoscimento e accettazione degli adolescenti e dei pre-adolescenti, soprattutto in quella sfera sociale, definita mondo vicino, collocata tra il mondo interno della famiglia ristretta e quello impersonale delle istituzioni. Da questo punto di vista, la scuola svolge un ruolo essenziale e delicato perché opera sia come istituzione dedicata all’educazione degli studenti, sia come mondo vicino luogo di riconoscimento, affettività, accettazione. Nelle risposte degli studenti emerge con chiarezza come il tema del riconoscimento sociale e dell’accet-tazione diventi costitutivo della loro identità personale. L’ambito del disagio si concentra su tutti gli atteggiamenti che implicano disattenzione, distacco, incomprensione verso le loro esigenze. 52 Comunicazione e Nonviolenza Alla domanda aperta “Non mi sento capito quando l’altro”, le risposte più frequenti sono, quando “Non mi guarda”, “Non mi ascolta”, “E’ disattento”, “Si distrae quando parlo”, “Mi ignora”, “Non mi risponde”. L’esigenza di apprendere la tecnica dell’ascolto attivo da parte degli educatori risulta quindi piuttosto urgente. Anche l’ambito dell’accettazione/rifiuto è molto sensibile. Alla domanda aperta: “Pensa all’ultima volta in cui hai avuto la sensazione di non essere accettato o compreso all’interno di un gruppo dei tuoi coetanei e descrivi la situazione”, (sia in ambito scolastico che extrascolastico). La maggioranza degli studenti ha enfatizzato i rifiuti eventualmente subiti in classe o nel gruppo dei pari in ambito extrascolastico. La frequenza di tali riferimenti non deve essere sottovalutata, specialmente perché i dati più recenti indicano nel “bullismo” un fenomeno crescente nelle scuole italiane, che distingue tra l’altro in negativo l’Italia rispetto ad altri paesi europei. La corrispondenza tra intense situazioni di rifiuto e il bullismo come fenomeno, sia pure regressivo, di richiesta di riconoscimento e affetto è provata da vari esperimenti e analisi psico-sociali. In sintesi, i dati rivelano come sembra crescere notevolmente il bisogno di accettazione e riconoscimento sociale e psicologico da parte degli studenti. Da questo punto di vista, l’importanza di un progetto dedicato “alla scoperta dell’altro” risulta ulteriormente rafforzata. L’analisi dei dati dimostra come siano essenzialmente le relazioni verticali (con gli insegnanti) ad entrare in una fase di complessità. Il passaggio tra il docente-genitore e il docente-istituzione si manifesta con evidenza proprio in questa fase. Anche le relazioni orizzontali conoscono una trasformazione. Tale cambiamento può essere indicato come passaggio dalla qualità alla prestazione. Dove per qualità si intende un rapporto con l’altro improntato ai caratteri specifici dell’alter (simpatia, conoscenza da lunga data, ecc.), mentre per prestazione si intende un rapporto basato sul conseguimento di determinati risultati (successi sportivi, possibilità di condividere giochi sofisticati, successo con l’altro sesso, ecc.). Proprio in tale passaggio di relazione emergono, inoltre, dei comportamenti che possono sfociare nel rifiuto della multiculturalità (come viceversa, invece, nella sua accettazione). L’altro “straniero” risulta eventualmente escluso non per la sua qualità di straniero, ma per le sue insufficienze di prestazione (è povero, non parla in maniera adeguata, non è cool, alla moda). 2.3.7. Riferimenti bibliografici Bandler R., Grinder J., La struttura della magia, Astrolabio, Roma 1981. Baraldi C., Socializzazione e autonomia individuale. Una teoria sistemica del rapporto tra comunicazione e pensiero, Franco Angeli, Milano 1992. Baraldi C., Comunicazione interculturale e diversità, Carocci, Roma 2003. Bateson G., Mente e natura, Adelphi, Milano 1984. Berruti F. (a cura di), L’educazione all'interculturalità, Gruppo Abele, Torino 1998. Di Pietro M., L’educazione razionale - emotiva, Erickson, Trento 2001. Parte 2 - La società multiculturale: dal conflitto distruttivo alla diversità come risorsa 53 Di Pietro M., L’ABC delle mie emozioni, Erickson, Trento 1999. Escobar R., Rivalità e mimesi: lo straniero, in La contesa tra fratelli, Giappichielli, Torino 1993. Heidegger M., Essere e tempo, Longanesi, Milano 1970. Jung C.G., Gli archetipi e l’inconscio collettivo, Boringhieri, Torino 1980. Palmonari A., Processi simbolici e dinamiche sociali, Il Mulino, Bologna 1995. Pentini A., Lorenz W., Per una pedagogia antirazzista, Junior, Bergamo 1995. Polito M., Attivare le risorse del gruppo classe, Erickson, Trento 2000. Thich Nhat H., Essere pace, Astrolabio-Ubaldini, Roma 1989. Todorov T., La conquista del Messico. Il problema dell’“altro”, Einaudi, Torino 1984. 54 Comunicazione e Nonviolenza 2.4. LA GESTIONE COSTRUTTIVA DEI CONFLITTI ETNICI METROPOLITANI L’esempio della polizia di Cristiano Inguglia e Rodan Di Maria 2.4.1. Immigrazione, conflitti etnici e forze dell’ordine Il consolidamento di flussi migratori verso paesi che, come l’Italia, non avevano ancora affrontato il tema della multietnicità, richiede una serie di riorganizzazioni strategiche delle politiche pubbliche e sociali da parte di questi stati. Al livello sociale, ad esempio, sembra importante promuovere l’integrazione sociale e un sentimento di cittadinanza attiva nella popolazione immigrata, da un lato, e prevenire i pregiudizi e i conflitti etnici, causati dalla maggiore possibilità di interazione interetnica, dall’altro (Di Maria, 2003). In particolare, i conflitti etnici metropolitani - gli scontri tra gruppi etnici all’interno dei quartieri a composizione multietnica di grandi città - hanno raggiunto una certa diffusione in Italia (Cotesta, 1999) e rappresentano un’emergenza sociale, che dovrebbe essere affrontata sia al livello nazionale che a quello locale, dalle amministrazioni delle città italiane. In quest’ottica, il presente contributo ha come obiettivo generale l’individuazione di un modello di intervento per la gestione costruttiva di questi conflitti. L’identificazione di tale modello si basa su alcuni presupposti. Nelle scienze sociali, il conflitto è visto come un’opportunità per lo sviluppo di relazioni positive ed adeguati canali di comunicazione tra i gruppi in conflitto. Esso non rappresenta necessariamente un fenomeno positivo o negativo; è piuttosto la maniera in cui gli individui gestiscono i conflitti che può condurre ad esiti costruttivi o distruttivi. Ogni disputa o scontro può trasformarsi in un’ottima occasione per sviluppare nuovi e più adeguati canali relazionali tra le parti in conflitto (Nadler, 2000; Rumiati e Pietroni, 2001). In questa prospettiva, ogni conflitto etnico sviluppatosi nel contesto di un paese di immigrazione può essere un’occasione per trovare e negoziare nuovi schemi di relazione interetnica, nella prospettiva di una pacifica convivenza; la responsabilità principale dell’esito di questa interazione è da imputare alle modalità di intervento messe in atto dalle istituzioni dello stato ospitante, come i programmi di prevenzione e di gestione dei conflitti etnici. Solo attraverso interventi di gestione dei conflitti efficaci, le dispute e gli scontri a carattere etnico possono trasformarsi in occasioni di co-costruzione di regole di convivenza tra i diversi gruppi etnici. Un ruolo speciale dovrebbe essere giocato dalle forze dell’ordine, che sempre più spesso sono implicate in questo genere di conflitti. Da quanto riporta Cotesta (1999), negli ultimi anni è sempre maggiore la percentuale di situazioni di conflitto etnico che vede coinvolta la presenza di agenti delle Forze dell’Ordine: sembra che la presenza della Polizia contribuisca ad intensificare le situazioni di conflitto tra gruppi di immigrati e, in alcuni casi, possa contribuire anche a provocarle direttamente1. 1 Per un approfondimento è consigliata la lettura di Palidda, Polizia Postmoderna, Feltrinelli, Milano 2000. Parte 2 - La società multiculturale: dal conflitto distruttivo alla diversità come risorsa 55 La motivazione è che gli agenti sono chiamati ad intervenire in situazioni caratterizzate da un’alta tensione emotiva, in cui è frequente il ricorso alla forza e a metodi coercitivi, come l’arresto, senza intraprendere tentativi di comunicazione con le parti in causa (Cotesta, 1999). Ma gli atteggiamenti repressivi non rimuovono le cause del conflitto, possono produrre una rapida escalation del conflitto originale e contribuire ad esacerbare le relazioni interetniche nel contesto d’intervento. In quest’ottica, dotare gli agenti di Polizia di abilità e competenze legate alla gestione di questo tipo di situazioni si configura come un possibile strumento per ridurre i rischi sopraccitati. L’importanza della formazione della polizia sul tema della gestione dei conflitti etnici è ampiamente stabilita all’interno della Carta di Rotterdam (1996), che stabilisce i principi e le linee-guida che dovrebbero regolare la polizia europea nei contesti multietnici. Secondo questo documento, buona parte dell’aggiornamento delle forze di polizia dovrebbe riguardare il conferimento di competenze per fronteggiare in modo professionale situazioni in cui culture diverse si incontrano o scontrano, come i conflitti etnici. Tuttavia, questo tipo di interventi sono abbastanza rari nel contesto italiano2. Il presente contributo si configura come un tentativo di applicare questi principi al contesto della città di Palermo e riguarda un corso di formazione per agenti di polizia sulla gestione dei conflitti etnici metropolitani. 2.4.2. Conflitti etnici: quale modello di intervento? La letteratura sul conflitto (Burton, 1990; Isajiw, 2000) distingue almeno due approcci alla gestione dei conflitti. Le strategie mirate al raggiungimento di un accordo tra le parti in conflitto (conflict settlement), che si riferiscono a tutte quelle metodologie, centrate sul risultato, tese a raggiungere soluzioni accettabili e/o a porre fine al conflitto diretto, senza necessariamente intervenire sulle cause che sottendono al conflitto stesso. In questa prospettiva, le parti in conflitto sono viste come attori razionali, che calcolano i propri interessi e lavorano assieme in vista di un obiettivo razionale e reciprocamente vantaggioso. Tuttavia, queste strategie si originano da un’idea relativamente limitata di accordo, che viene definito come una soluzione veloce ed accettabile da entrambe le parti. I metodi finalizzati alla risoluzione del conflitto (conflict resolution), invece, si riferiscono a tutte quelle attività, centrate sui processi, che mirano a risolvere le cause che sottendono al conflitto (Burton, 1990). Il conflitto è definito come il naturale esito di bisogni umani insoddisfatti; conseguentemente, la sua origine può essere ricercata nei bisogni sottostanti dei suoi partecipanti (come quelli di identità o di sicurezza). Questo approccio, con la sua enfasi sui bisogni, richiede strategie che vadano ben oltre quelle centrate sul risultato. Si tratta di strategie centrate sul processo e sulla relazione, comprendenti attività non-coercitive, come la facilitazione e la consultazione, in forma di problem-solving workshop o di tavole rotonde. La facilitazione, intesa in questo modo, costituisce un tentativo di una terza parte di stimolare una soluzione creativa dei proble- 2 Un esempio è il Progetto NAPAP realizzato a Modena e Bologna. 56 Comunicazione e Nonviolenza mi attraverso la comunicazione diretta e l’analisi in profondo del conflitto. La risoluzione del conflitto implica una trasformazione delle relazioni tra le parti, che vada a rimuovere i problemi che hanno causato il conflitto. Uno degli assunti principali è che soltanto le parti in competizione possiedono gli strumenti ed i mezzi per giungere ad una durevole soluzione del conflitto. Un utile esempio di metodo finalizzato alla risoluzione dei conflitti etnici è offerto dal modello della School For Peace (SFP) di Neve Shalom/Wahat al-Salam (Israele). La SFP è una delle più grandi istitu-zioni educative per outreach in Israele. Le sue attività si incentrano prevalentemente sul conflitto israelo-palestinese, ma il suo modello di intervento viene applicato anche in altre parti del mondo. Il metodo di lavoro dei facilitatori consiste nell’organizzare una serie di incontri di facilitazione tra i membri dei gruppi in conflitto e si basa su alcuni assunti fondamentali (Halabi e Sonnenschein, 2000): - Le concezioni e le credenze su cui si fondano l’identità e gli atteggiamenti di una persona sono stabili e ben radicati. Generalmente sono inconsapevoli e resistenti al cambiamento. Pertanto i facilitatori dovrebbero mirare a rendere i partecipanti agli incontri capaci di comportarsi liberamente, quanto più possibile in linea con la realtà, in maniera tale che essi possano esaminare le loro idee più radicate e cercare di confrontarsi con esse. - Il conflitto avviene tra due o più gruppi etnici, non tra individui. Il gruppo è visto come qualcosa di essenziale, come qualcosa di maggiore della somma degli individui che lo comprendono. Le interazioni tra gli individui vengono modellate dalle loro affiliazioni di gruppo, ed essi si riferiscono a se stessi ed agli altri come rappresentanti di questi gruppi. Ogni individuo viene considerato alla stregua di un portavoce del gruppo al quale esso/a appartiene. - Il gruppo di incontro è visto come un gruppo aperto, che è collegato, che proviene dalla, e ritorna alla, realtà esteriore. Pertanto i facilitatori cercano di comprendere cosa avviene nel gruppo, nel contesto di eventi che si verificano all’esterno, e sperano che i cambiamenti osservati nei partecipanti durante l’incontro possano più tardi avere un’influenza su chi li circonda e sulla società in cui vivono. Pertanto, il principale obiettivo degli incontri è quello di suscitare la consapevolezza delle parti in conflitto riguardo il conflitto medesimo ed il ruolo giocato in questo da essi, oltre che rendere i partecipanti capaci di esplorare ed elaborare i propri vissuti attraverso l’interazione con gli altri. I facilitatori non forniscono verdetti e non suggeriscono alcuna soluzione riguardo il conflitto; il loro lavoro è finalizzato allo sviluppo di nuovi canali di comunicazione tra le parti in causa, rimuovendo barriere culturali, sociali e psicologiche. 2.4.3. Descrizione del corso “Il servizio di Polizia in una società multiculturale” Il corso di formazione è mirato alla professionalizzazione di 20 agenti della Polizia di Stato, che operano in aree della città di Palermo con problematiche di integrazione culturale e razziale3, 3 I destinatari sono gli agenti delle Forze dell’Ordine che operano nelle zone ad alta residenzialità di cittadini appartenenti ad altri gruppi etnici, in particolare il centro storico (Circoscrizione 1). Parte 2 - La società multiculturale: dal conflitto distruttivo alla diversità come risorsa 57 attraverso il metodo di formazione della SFP. Il progetto è stato presentato dal Dipartimento di Psicologia a valere del Fondo Sociale Europeo, POR Sicilia, Quadro Comunitario di Sostegno OB. 1, 2000/2006 ed è tuttora in attesa di finanziamento. Di seguito ne vengono sinteticamente descritti gli obiettivi e la struttura4. L’obiettivo generale è fornire ad agenti delle Forze dell’Ordine, quotidianamente impegnati nel contatto con soggetti immigrati, gli strumenti, teorici e pratici, per affrontare e gestire le situazioni di conflitto etnico. In particolare, il corso di formazione è mirato a fornire: - Strategie di comunicazione e relazione con altri gruppi etnici e culturali; - Tecniche di mediazione e di gestione del conflitto interculturale; - Conoscenze sulle pratiche culturali e sociali dei principali gruppi etnici del territorio di riferimento; - Una metodologia di lavoro di rete che consenta di sfruttare le risorse presenti nel territorio al fine di facilitare la comunicazione e lo scambio interculturale. Il corso prevede una divisione in 6 moduli ed una durata di 100 ore. Il primo modulo ha un carattere introduttivo e vuole fornire competenze base di inglese e di utilizzo di Internet. Il secondo modulo è di carattere socio-culturale e cerca di illustrare usanze, rituali, stili di vita e valori dei principali gruppi etnici presenti sul territorio, attraverso piccoli laboratori e strumenti multimediali. Questo modulo prevede una serie di visite guidate per consentire un miglior apprendimento degli aspetti socioculturali, caratteristici dei principali gruppi etnici presenti nel territorio palermitano, attraverso l’osservazione diretta e partecipata di cerimonie, feste e rituali tipici. Il terzo modulo riguarda la situazione normativa che regola la condizione di immigrato. Questo aspetto verrà approfondito attraverso l’impiego di esperti operanti nel campo che forniranno un quadro approfondito della legislatura in tema di immigrazione. Il quarto modulo riguarda aspetti teorici e pratici della psicologia delle relazioni interetniche. Si partirà dalla nozione di conflitto interetnico e verranno analizzati i complessi processi affettivi, cognitivi e sociali che intervengono nell’incontro tra uno o più gruppi, fino ad arrivare alle tecniche per la prevenzione e la trasformazione dei conflitti. La metodologia utilizzata sarà quella della SFP (cfr. infra par. 2). Il quinto modulo ha carattere tecnico-applicativo e cerca di fornire ai corsisti i saperi pratici essenziali per il lavoro di mediazione dei conflitti etnici. Esso ha come obiettivo lo sviluppo delle competenze riguardo la comunicazione e la facilitazione finalizzate alla risoluzione dei conflitti interetnici. La metodologia utilizzata sarà quella della SFP. Il sesto modulo è teso ad effettuare un lavoro di mappatura delle risorse esistenti nel territorio considerato, in base ai bisogni dei diversi gruppi etnici presenti, al fine di potere offrire una prima consulenza informativa e stimolare il lavoro di rete. Esso prevede delle visite didattiche con lo scopo di favorire la conoscenza di alcuni servizi, pubblici e privati, rivolti alla popolazione immigrata. In particolare, verranno visitate strutture finalizzate al trattamento sanitario degli immigrati, all’accoglienza dei rifugiati e ad erogare servizi ricreativi e culturali. 4 Per una trattazione più esaustiva del corso si consulti Di Maria e altri (2003). 58 Comunicazione e Nonviolenza 2.4.4. Riferimenti bibliografici Burton J. W., Conflict: Resolution and prevention, St. Martin’s Press, New York 1990. Cotesta V., Sociologia dei conflitti etnici, Laterza, Roma-Bari 1999. Di Maria R., Inguglia C., Lo Coco A., Pace U., Zappulla C., Using urban ethnic conflict management for facilitating immigrants’ social integration. A training corse for police officers, Paper presented at the Connection Conference “Active citizenship and multiple identities”, Leuven (B), 4-6 settembre 2003. Halabi R., Sonnenschein N., How we approach our work in Halabi R., Identities in Dialogue, School for Peace Press, NSWAS 2000. Isajiw W., Approaches to ethnic conflict resolution: paradigms and principles in «International Journal of Intercultural Relations», n. 24, 2000. Nadler A., Intergroup conflict and its reduction: A social-psychological perspective, in Halabi R., Identities in Dialogue, School for Peace Press, NSWAS 2000. Palidda S., Polizia Postmoderna, Feltrinelli, Milano 2000. Rumiati R., Pietroni D., La negoziazione, Cortina, Milano 2001. Parte 2 - La società multiculturale: dal conflitto distruttivo alla diversità come risorsa 59 2.5. VIOLENZA E NONVIOLENZA NEL “MOVIMENTO DEI MOVIMENTI” di Enrico Euli In termini comunicativi, relazionali e contestuali, il movimento attuale legge e contesta la libertà che viene proposta - ma sarebbe meglio dire “imposta e propinata” dal liberismo come la forma più subdola, pericolosa e distruttiva di violenza. Le conseguenze operative più ovvie e dirette per l’azione esterna del movimento sono: - l’esplicitazione e lo svelamento di questa violenza globale, operazione difficilissima proprio perché essa è permanentemente e più o meno sapientemente coperta ed ammantata dalla retorica della libertà; - l’obiettivo della liberazione, intesa come processo attraverso cui “liberarsi della (sedicente ed autopro-clamatasi) libertà”. Ad un livello interno, intanto, il movimento prova (con risultati alterni ed ancora insoddisfacenti) ad organizzarsi coerentemente al suo obiettivo, sperimentando forme e modalità di comunicazione ed azione alternative ai modelli dominanti (organizzazione a rete, metodo del consenso, azioni dirette nonviolente, principio di rotazione negli incarichi e nelle deleghe, trasparenza…). Più in specifico, il movimento individua, a mio parere, quattro dimensioni prioritarie d’azione: Liberarsi della libertà 1 (il nodo del “potere”): l’insufficienza e l’inadeguatezza della “democrazia” intesa, com’è attualmente, in termini elettorali, maggioritari, plebiscitari; la riproposizione, invece, di dinamiche partecipative dirette, omnicratiche, inclini all’empowerment di ciascuno e di tutti, orientate a “democratizzare la democrazia”; Liberarsi della libertà 2 (il nodo del “lavoro”): la divaricazione crescente tra senso dell’esistenza e ruolo produttivo, tra tempo e lavoro, tra ricchezza economica e qualità della vita; la proposta di stili di vita sobri, ma esteticamente orientati al piacere, alternativi al consumismo e alla monetarizzazione, immersi nel gioco di azioni non funzionali; Liberarsi della libertà 3 (il nodo del “diritto”): la non accettazione automatica della legalità, ma una sua subordinazione a principi di giustizia e a valutazioni di legittimità; le azioni pubbliche di protesta e di contrasto, anche illegali, che fungano da catalizzatrici per una prospettiva costituente di nuova legalità (come già accaduto per il diritto allo sciopero o all’obiezione di coscienza); Liberarsi della libertà 4 (il nodo della “società”): il rifiuto di un’idea di ‘sicurezza’ che porta a separare il “noi” da “altri”, intesi come “nemici”, minaccia per il nostro ordine e per il nostro benessere di parte; la costruzione di fiducia, di legami sociali, di “comunità” aperte all’ibridazione e alla reciproca accoglienza come unica base credibile per la costruzione di una vera, indivisa, sicurezza. 60 Comunicazione e Nonviolenza 2.6. LA COMUNICAZIONE NON VERBALE E GLI IMMIGRATI di Ada Cattaneo 2.6.1. Introduzione I - Scopo Lo scopo della ricerca1 è di esaminare alcune componenti della comunicazione non verbale che influi-scono sulle relazioni interpersonali tra la popolazione autoctona lombarda e i newcomer cercando di identificarne i contributi ad aumentare o ridurre comportamenti, reazioni o atteggiamenti aggressivi e violenti dei primi nei confronti dei secondi. II - Presupposti Il lavoro è stato eseguito tra gennaio e febbraio 2003, perciò i risultati delle indagini non risentono della diretta influenza né della guerra USA-Iraq, né dell’epidemia di SARS che ha particolarmente colpito i paesi orientali. Una simile premessa è tanto più indispensabile perché, tra le comunità studiate ci sono da un lato, l’egiziana e la marocchina, comunemente etichettate come arabe, dall’altro i cinesi e i filippini. La scelta dei gruppi etnici segue due precisi criteri: 1-geografico, considera i cinque principali bacini di provenienza dei flussi migratori2; 2- quantitativo, seleziona le maggiori comunità in Lombardia per cia-scuna area. Pertanto, lo studio verte su: albanesi, marocchini, egiziani, cinesi, filippini, peruviani3. 2.6.2. Metodo I - Fasi Il metodo etogenico4 adottato coniuga i risultati ottenuti con tecniche qualitative e quantitative ripar-tendo il lavoro in 4 successive fasi: 1-preliminare: con un’indagine bibliografica e la formulazione delle ipotesi da verificare sul campo; 2-estensiva: con la realizzazione di interviste qualitative e la somministrazione di un questionario quantitativo a domande aperte e chiuse, batterie, scale; 3-analitica: con l’esame delle risposte e l’analisi statistica dei dati mediante il pro1 Altri dati del medesimo studio sono stati presentati nel paper Cattaneo A., Local People and Newcomers in a multicultural and multiethnic town: Milan al VI European Conference of Sociology, ESA, 23-26 September 2003, Murcia (Spagna) Stream 5, Session 3. 2 I dati ufficiali indicano come le maggiori aree di origine dei flussi: Est Europa, Africa, Medio-Oriente, Asia, America Latina; Blangiardo G.C.(a cura di), L'immigrazione straniera in Lombardia. Rapporto 2001, Ismu, Milano 2002. 3 Albanesi- presenze: N=41050, percentuale degli immigrati in Lombardia: 9,8%; marocchini- N=58400; 13,9%; egiziani- N=31850, 7,6%; cinesi- N=22250, 5,3%, filippini- N=31200, 7,4%; peruviani- N=19400, 4,6% (Blangiardo, 2002). 4 Harre R., La costruzione sociale delle emozioni, Giuffrè, Milano 1992. Parte 2 - La società multiculturale: dal conflitto distruttivo alla diversità come risorsa 61 gramma “SSPSS 10.0 per Windows”; 4-conclusiva: con il commento dei risultati, la stesura del report, la preparazione della presentazione in Power Point. II - Campione I requisiti fondamentali richiesti ai soggetti per rientrare nel campione sono: -essere di origine italiana; -abitare in Lombardia; -conoscere newcomer appartenenti ai 6 gruppi prescelti. I due campioni esplorativi, non proporzionali ma equamente divisi per genere e fascia di età5, sono costituiti da: -50 interviste qualitative focalizzate; -300 questionari quantitativi; 2.6.3. Risultati e discussione I - Profilo del campione I lombardi analizzati… - hanno un livello socio-culturale piuttosto elevato il che dovrebbe garantire una certa capacità di espressione e valutazione; 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Livello socio-culturale autoattribuito 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5 6 7,7% m-b medio m-a Frequenza ai riti religiosi 23,0% 14,0% n ii ma - a livello politico appartengono all’area di centro-destra, comunemente, ritenuta più predisposta a atteggiamenti di chiusura o, persino, aggressivi nei confronti degli immigrati6; 34,3% 9,7% 2,7% basso - sono abbastanza assidui frequentatori dei riti religiosi, perciò non è escluso che condividano i valori della Chiesa ed abbiano una sensibilità filantropica ispirata al rispetto, l’amore per il prossimo, l’accoglienza, l’uguaglianza; 45,7% 6m n 2i 1- 6m Tendenze politiche sin centro dx 9,0% lm 1a 38,7% 15,3% lm 3a 2- 31,4% alto t. et is n og 19,3% 49,3% Le fasce di età prese in considerazione sono: 15-20 anni; 21-30; 31-45; 46-65; over-65. Compasso A., Extracomunitari in Europa. Immigrazione, razzismo, xenofobia, Gangemi Editore, Roma 1994. 62 Comunicazione e Nonviolenza - malgrado le loro simpatie ideologiche, nella maggior parte dei casi si considerano scarsamente razzisti e nessuno ha posizioni integraliste7; 35% Livello di razzismo autoattribuito 30,7% 30% 25% 20% 16,3% 13,3% 9,7% 15% 10% 9,7% 8,0%7,0% 5,3% 5% 0,0% 0,0% 0% - a confermarlo, il sesso, l’etnia e il colore della pelle sono i criteri che meno utilizzno per definire le differenze8 tra uomini, dando invece molto rilievo al look, il comportamento, i ruoli sociali, il modo di vestire e di esprimersi; 10 9 1 3 7,9 7,8 7 4 5 6 7 8 9 10 Importanza dei criteri per definire le differenze tra uomini 8,3 8 2 7,7 7,5 7,2 7,1 6,9 6,3 6 5 4 4,3 3 3,2 2 - la centralità dell’aspetto viene ribadita nel definire l’importanza dei vari tipi di comunicazione9 dove occupa il secondo posto dopo i messaggi di natura verbale. Sufficiente è la quotazione di prossemica e cinesica, mentre la paralinguistica suscita perplessità in quanto meno immediata e decodificabile; - una controprova dell’ampio potere dell’aspetto è il fatto che venga considerato il più forte catalizzatore di reazioni interetniche negative10. 10 9 9,4 8,2 8 se ss o pe lle a et ni a cu lt ur od or e st at us ru ol i ab bi gl i. es pr im . lo ok co m po rt . 1 Importanza dei vari tipi di comunicazione 7 6,3 5,9 6 5 3,5 4 3 2 1 cv aspet pross cines paral I catalizzatori di reazioni negative 9 7 9,2 5,6 8,9 8,7 7,3 6,9 atteg contat sguar odore 5 3 1 aspet volto 7 Il livello di razzismo autoattribuitosi dal campione è misurato con una scala decrescente a 10 punti dove 1=per nulla razzista e 10=estremamente razzista. 8 L’importanza dei diversi tipi di criteri di differenziazione tra gli uomini sono misurati con una scala decrescente a 10 punti. 9 Le 5 modalità comunicative (verbale, tramite l’aspetto fisico, prossemica, cinesica, paralinguistica), sono valutate mediante una scala di importanza a 10 punti. 10 La funzione di catalizzatori di reazioni negative dei 6 tipi di comunicazione non verbale (aspetto, atteggiamenti, contatto fisico, sguardo, odore, volto) sono misurati su una scala decrescente di importanza a 10 punti. Parte 2 - La società multiculturale: dal conflitto distruttivo alla diversità come risorsa 63 II - I newcomer Per definire il contributo specifico della comunicazione non verbale nelle dinamiche autoctoni-newcomer, ne vengono passate in rassegna le 5 principali modalità e i corrispondenti risvolti negativi: a) aspetto fisico; b) prossemica; c) cinesica; d) volto e sguardo; e) paralinguistica. a) Aspetto fisico. L’identikit che i Lombardi tracciano per ogni gruppo etnico è scandito da 10 punti: altezza, corporatura, carnagione, tipo di pelle, colore occhi e capelli, tipo di capelli, acconciatura, particolari maschili, abiti. -i marocchini non sono molto alti ma, nel complesso, la corporatura robusta, ne conferisce un aspetto piuttosto prestante. La loro pelle è butterata e, soprattutto, “nera”11. Hanno occhi scuri, capelli neri e ricci. Le donne indossano il chador e gli uomini hanno barba o baffi. Tutti concordano nel ritenere che i marocchini non si curino affatto del proprio abbigliamento. - gli albanesi sono abbastanza alti e di corporatura normale. Sono bianchi e con pelle butterata: “che è una cosa ripugnante”, secondo un intervistato. Si caratterizzano per i capelli castani e lisci, gli occhi verdi, la barba degli uomini e le acconciature europee delle donne. Infine, il campione è quasi unanime nel denunciare l’assoluta trasandatezza dei capi indossati. 11 Non si tratta di un semplice errore, ma, come precisa un intervistato, è l’esito di un diffuso sillogismo: “I primi migranti in Italia erano Marocchini e facevano i vu’ cumprà. Poi sono arrivati i Senegalesi che, svolgendo lo stesso lavoro, sono stati chiamati, a loro volta, vu’ cumprà e poi marocchini, anche se non lo erano. Da qui la confusione”. 64 Comunicazione e Nonviolenza - gli egiziani sono mediamente alti, robusti, meticci, butterati, con occhi neri, capelli scuri e ricci, baffi. Nell’indagine qualitativa il loro aspetto viene spesso riferito all’immagine di Saddam Hussein. Le donne hanno quasi sempre il chador. La sensibilità al vestiario pare equamente distribuita. -il ritratto dei cinesi è fortemente stereotipato: bassi, con corporatura normale, pelle morbida e gialla, occhi scuri, capelli neri e lisci, glabri. Le donne si pettinano all’europea. La loro cura per l’abbigliamento è ampiamente riconosciuta dai Lombardi interpellati. Parte 2 - La società multiculturale: dal conflitto distruttivo alla diversità come risorsa 65 -i filippini sono bassi, con corporatura normale, carnagione olivastra e morbida pelle, occhi marroni, capelli neri e lisci. Le donne acconciano i capelli secondo lo stile europeo e gli uomini sono glabri. L’attenzione per l’abbigliamento è abbastanza diffusa. -i peruviani sono bassi, con fisico normale, pelle meticcia e secca. Hanno occhi marroni, capelli castani, leggermente mossi. Gli uomini sono glabri, le donne si pettinano all’europea. Non si preoccupano dell’abbiglimento. In generale, le descrizioni di albanesi, egiziani e marocchini sono più negative: le barbe, i baffi, la pelle butterata, l’aspetto negletto e i corpi vigorosi alludono a una loro natura irrazionale, selvaggia, istintiva, che, quindi, li connota come pericolosi e temibili. Comunicazione e Nonviolenza 66 a1) Influssi dell’aspetto fisico. Le reazioni degli autoctoni all’aspetto fisico dei newcomer si possono misurare su tre particolari fattori di comunicazione non verbale: 1-la pulizia personale, 2-la cura per il proprio aspetto, 3-l’attrattiva fisica12. La pulizia degli asiatici e la speciale attenzione dei cinesi per il proprio aspetto vengono apprezzati dai lombardi intervistati che li interpretano come segni di civiltà e di un vago desiderio di integrazione, perciò, non esitano a dichiararsi alquanto disponibili nei loro confronti. Il “culto” dell’immagine degli egiziani è letto, invece, come segno di vanità, ostentazione, orgoglio o persino di sfacciataggine quindi diventa un motivo di irritazione. Sul versante opposto, mentre la sporcizia e la trasandatezza di albanesi e marochini suscita reazioni ampiamente negative che rasentano il disgusto producendo repulsione, le stesse caratteristiche presenti nei peruviani diventano motivo di compassione e commiserazione. La giustificazione della differenza dipende dall’effetto alone esercitato dal mito dei paesi sudamericani che imperversa in Italia negli ultimi anni. 10 10 Quanto sono puliti 8 4 7 5,9 6 3,6 3,3 2,8 12 4 4,2 3,2 3 2,1 2 1 mar alb 5,5 5 2 1 6,1 6 4,6 3 7,9 8 6,8 7 5 Cura dell'aspetto 9 9 egi cin fil per mar alb egi cin fil per Questi dati e i seguenti sono calcolati mediante la valutazione del campione di ciascun argomento mediante scale di importanza decrescente a 10 punti. Parte 2 - La società multiculturale: dal conflitto distruttivo alla diversità come risorsa 67 I risultati riguardo al potenziale erotico vanno letti tenendo presente tutto ciò, i dati ufficiali sulla composizione percentuale della componente maschile nelle sei comunità e le riflessioni emerse dai colloqui. Di nuovo, il seppur relativo successo pe-ruviano, nonostante l’incuria e la sporcizia, va ascritto al fascino sudamericano. In contraddizione con le dichiarazioni preliminari del campione, le differenze somatiche sono tanto il comprovato motivo dello scarso riscontro ottenuto dagli orientali quanto del notevole successo degli albanesi che, malgrado i dissensi, restano comunque “i nostri fratelli di Albania”. Infine l’insensibilità per due etnie arabe, a prevalenza maschile, nasconde il più o meno conscio timore per la duplice minaccia che rappresentano in qualità di rivali, per gli uomini lombardi e di violentatori, per le donne. Componente maschile (fonte ISMU, 2002) 10 0 % 90% 80% 67% 65,9% 73,3% 7 52,5% 60% 39,1% 36,3% 5 4 30% 20% 3 10 % 2 1 0% alb egi cin 6,1 6 40% mar Attrattiva fisica 9 8 70% 50% 10 fil per 3,2 mar 3,4 alb egi 3,9 cin 4,1 3,5 fil per b) Prossemica. Nonostante gli italiani siano abbastanza inclini a non rispettare la “zona di intimità”13, i soggetti studiati hanno reazioni e comportamenti contrariati quando sono gli stranieri non rispettarne i confini convenzionali. Pertanto, l’abitudine di cinesi, peruviani e filippini a limitare le interazioni fisiche è molto gradita ai lombardi, che, invece, vivono come problematica e fastidiosa la propensione di marocchini, egiziani e albanesi ad avvalersi spesso di questo tipo di comunicazione. Lo scarto tra la reazione al contatto fisico con l’etnia europea nei confronti delle due arabe (marocchini, egiziani) è sintetizzato 10 8 8,1 8,6 9 8,2 8 7 7 6 6 5 5 4,1 4 3,9 3 3 13 10 Abitudine al contatto fisico 9 1 1 egi cin 7,9 5,8 3,3 3 2 alb 8,4 4 2 mar Incidenza sulle reazioni negative fil per 2,1 mar Hall E.T. (1966) La dimensione nascosta, Bompiani, Milano 1980. alb egi cin 1,7 fil per Comunicazione e Nonviolenza 68 nelle parole di un’intervistata: “degli albanesi mi fa schifo solo che sono sporchi… dei marocchini e gli egziani, invece, ho proprio paura che mi attacchino qualche stana malattia delle loro…”. b1) Postura. Potendo scegliere tra 10 diverse posture, opportunamente selezionate, la maggior parte dei lombardi studiati immagina egiziani e marocchini in atteggiamento risoluto, gli albanesi iroso, i cinesi e i filippini di accoglienza e i peruviani di bisogno. La postura più comune di ogni tipo di newcomer 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% mar alb egi cin f orte 13% 5% 11% 2% agit 11% 15% 15% 7% 3% 7% 2% 5% 26% 39% 14% 11% 17% 23% 15% 7% 42% 28% bisog preoc 1% af f et 7% accog 9% 2% iroso 2% 42% 9% risol 31% 18% 33% 1% 4% 14% 10% 4% 22% 1% 16% 2% repuls indif 2% 5% f il ecu 2% 3% 7% 13% 23% c) Cinesica. Il frequente ricorso alla gestualità da parte dei marocchini, egiziani e albanesi è apprezzato e 10 9 Frequenza uso comunicazione con gesti 8 7,6 5,6 4,5 4 5,2 6 6,9 6,7 5,3 5 4 3,1 3 7,4 7 5 3,9 3 3,2 2 2 1 9 8 6,9 7 6 Problemi provocati dalla cinesica 10 1 mar alb egi cin fil per mar alb egi cin fil per Parte 2 - La Società multiculturale: dal conflitto distruttivo alla diversità come risorsa 69 riconosciuto dal campione come un valido supporto nelle interazioni che manca, invece, cerando delle difficoltà, quando gli interlocutori sono asiatici o latinoamericani. d) Volto. Essendo tra i canali privilegiati per l’espressione delle emozioni nelle relazioni interpersonali, il volto e lo sguardo dei newcomer forniscono ulteriori informazioni per l’indagine. Gli elementi sui quali focalizzare l’attenzione sono tre: 1 - la forma del viso che, con il sussidio della morfopsicologia14 può aiutare a definire il carattere attribuito agli immigrati; 2 - l’espressione del viso che fornisce un continuo commento alle parole e ai pensieri più o meno espressi dal soggetto; 3 - le sopracciglia che svolgono un ruolo determinante nell’espressione degli stati affettivi. Unendo i vari risultati in funzione della nazionalità si ottiene che: - marocchini e egiziani condividono lo stesso gruppo di tratti: il volto triangolare, con la punta rivolta in basso ne denota la natura cerebrale che, assommata ad un’espressione indifferente e alle sopracciglia aggrottate, indice di cattiveria, restituisce un’immagine complessiva poco rassicurante, infida, con dei tratti luciferini; - il viso trapezoidale degli albanesi, con la prominenza dalla zona bassa che corrisponde alla parte più terrena, ancorata alla materialità, li dipinge come istintivi. L’espressione triste e le sopracciglia completamente inarcate conferiscono loro un’aria brutale ma attraversata da un qualche stupore che lascia intuire una vaga inclinazione a redimersi dalla propria “ferinità”; - il sorriso e il volto esagonale dei cinesi, non si discostano dai tradizionali stereotipi convenzionali utilizzati per identificarli), mettendone in rilievo la natura preminentemente affettiva e positiva. L’indifferenza desumibile dalle sopracciglia rilassate, non è necessariamente in contraddizione con la suddetta emotività in quanto, come emerge dalle interviste qualitative, “i 14 Binet C. (1988) Il manuale della morfopsicologia, Hobby & Work, Milano 1997. Comunicazione e Nonviolenza 70 cinesi hanno un maggiore autocontrollo di noi che si vede anche in questo”; - i filippini, condividono con i cinesi “l’espansione emotiva” del viso e il sorriso, ma, la forma spiovente delle sopracciglia, getta un’ombra di mestizia sul loro aspetto generale; - nei peruviani, l’istintività allusa dal volto trapezoidale si coniuga ad una profonda tristezza che si manifesta nell’espressione del volto, rafforzata da quella delle sopracciglia. d1) Comunicazione con viso e sguardo. Confrontando la frequenza media di utilizzo della comunicazione con il viso e lo sguardo che i lombardi attribuiscono ai newcomer si riscontra che i cinesi sono il gruppo che se ne serve in modo più abituale, seguiti dappresso dai filippini, ossia le due etnie ad “espansione emotiva”. I meno inclini sono, invece, gli egiziani, che, di conseguenza, creano i maggiori problemi nei contatti visivi e vengono percepiti, insieme ai marocchini, come infidi, sfuggenti. 10 9 Abitudine all'uso della com. con viso e sguardo 8,3 8 7 5 4 7 7,8 6,9 6 5,8 5 4,3 3,4 3,2 3 4,2 4 3,2 3 2,1 2 2 1 9 8 7,7 6,5 6 Livello di problemi che comporta 10 1 mar alb egi cin fil per mar alb egi cin fil per e) Paralinguisica. Le principali fonti di fraintendimenti e complicazioni per i lombardi nella comunicazione non verbale con gli immigrati sono di tipo paralinguistico. Nel complesso, il tono, il timbro e il ritmo della voce di tutti creano varie difficoltà, il fenomeno è più accentuato nel caso di egiziani e i marocchini mentre tende a ridursi con i peruviani. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Quanto è elevato il ritmo della voce 8,8 8,2 7,9 10 Q u a nto è e le va to il tono de lla voc e 9 8 7 6,1 6 5,7 6,7 5,6 5 3,6 5,3 4 ,9 4 4 ,3 4 ,5 3 2 mar alb egi cin fil per 1 m ar a lb egi c in fil pe r Parte 2 - La società multiculturale: dal conflitto distruttivo alla diversità come risorsa 10 9 Quanto è elevato il timbro della voce 9 8 7 7 5,6 6 4,9 5 4 3 3,5 4,5 4,6 3,3 71 Problemi provocati dalla paralinguistica 8,9 8,7 8,4 7,9 6,8 6,7 5 3 2 1 1 mar alb egi cin fil per mar alb egi cin fil per III - “Antidoto”. A titolo riassuntivo dell’indagine si può analizzare l’influsso che il campione ritiene abbia ciascuno dei 5 fattori della comunicazione non verbale dei 6 gruppi di newcomer come “antidoto alla violenza”. L’aspetto fisico, la postura, che caratterizzano gli orientali come miti, pacifici, umili, disponibili e i peruviani come passibili di compassione o pietà, contribuiscono in modo sostanziale ad alleviare le frizioni con gli autoctoni. L’effetto opposto si riscontra nel caso di egiziani, marocchini e albanesi innescando reazioni emotive di repulsione, diffidenza, sospetto. In parallelo, la reticenza ai contatti fisici e l’abitudine a quelli visivi di cinesi e filippini è molto apprezzata laddove, invece, l’eccesso di interazioni fisiche e la scarsità di visive con i membri delle comunità arabe accentuano ulteriormente fastidio, disagio, sospetto, diffidenza, atteggiamenti difensivi rasentando, persino, associati con la sporcizia e la trasandatezza, il limite dello “schifo” nei confronti degli albanesi. La dimensione cinesica di questi ultimi tre gruppi, abbastanza sviluppata in conformità alla tradizione dei popoli mediterranei, è reputata il più efficace ammortizzatore nelle dinamiche non verbali durante le interazioni con i lombardi. Al minore ricorso alla gestualità da parte di filippini e cinesi consegue una certa insoddisfazione dei soggetti esaminati. Infine, in sintonia con i risultati precedenti, la paralinguistica si rivela il punto più delicato dove soltan-to filippini, peruviani e, solo in parte i cinesi, ricevono la piena sufficienza. 2.6.4. Conclusioni A fronte di ciò si può concludere che le differenze nelle modalità di utilizzo della comunicazione non verbale da parte dei newcomer appartenenti alle varie comunità presenti sul territorio regionale, in generale, sono percepite dagli abitanti locali più come una fonte di incomprensioni, di malintesi, di scontri che alla stregua di opportunità di avvicinamento, di incontro, di scambio, di apertura. Ciò dipende soprattutto sia dalla mancata conoscenza, quindi dalla difficoltà di comprensione, sia da certi comportamenti pregiudiziali, di istintiva chiusura, diffidenza messi in atto da parte dei lombardi verso le “altre” culture. Comunicazione e Nonviolenza 72 10 9 Importanza della cnv come antidoto a frizioni e violenza -scala a 10 punti 8,3 8 7,1 7 6 5 4 9,3 8,9 8,2 7,6 6,6 9,1 8,8 8,8 8,9 8,7 4,9 5,2 4,1 3,6 3,2 Mar Egi Fil 7,2 7,1 4,1 3,3 3,4 4,3 3,9 3,2 6,4 6,7 5,8 5,3 4,8 4,1 3,9 3,3 Alb Cin Per 4,4 3,5 3,2 3 2 1 aspetto volto prossem postura cinesica paraling 2.6.5. Riferimenti bibliografici Binet C., Il manuale della morfopsicologia, Hobby & Work, Milano 1997. Blangiardo G.C. (a cura di), L’immigrazione straniera in Lombardia. Rapporto 2001, Ismu, Milano 2002. Cattaneo A., Local People and Newcomers in a multi-cultural and multiethnic town: Milan, paper presentato al VI European Conference of Sociology, ESA, 23-26 September 2003, Murcia (Spagna) Stream 5, Session 3. Compasso A., Extracomunitari in Europa. Immigrazione, razzismo, xenofobia, Gangemi Editore, Roma 1994 Hall E.T., La dimensione nascosta, Bompiani, Milano 1980. Harre R., La costruzione sociale delle emozioni, Giuffrè, Milano 1992. Parte 3 Prevaricazione e violenza nella scuola Parte 3 - Prevaricazione e violenza nella scuola 75 3.1. EDUCARE AL CONFLITTO A SCUOLA Modelli ed esperienze di Angela Dogliotti Marasso Questa breve comunicazione si divide in due parti: nella prima cercherò di mettere a confronto due modelli di gestione dei conflitti e di individuare le caratteristiche essenziali di quello che potrebbe essere un percorso di formazione alla trasformazione costruttiva di essi, nella prospettiva della Peace Research; nella seconda parte esemplificherò questo percorso presentando alcune ricerche ed esperienze in corso. 3.1.1. Modelli conflittuali violenti Partendo da una preliminare distinzione concettuale tra violenza ed aggressività1 e cercando di mettere a fuoco ciò che caratterizza le modalità violente di gestire i conflitti, si potrebbe sostenere che, in ultima analisi, esse fanno riferimento a quella che J.Galtung (2002) chiama la “sindrome DMA”: dualismo, manicheismo, armageddon. Tale modalità si basa su una distinzione rigida tra le due parti in conflitto, che sono percepite come contrapposte, in una polarizzazione che identifica il bene con una e il male con l’altra, da cui deriva una implicita necessità di scontro tra di esse, volto a far prevalere l’una sull’altra. Patfoort (1992, 2001) usa un modello analogo, M-m, maggiore-minore, per rappresentare il contenuto di violenza di una relazione conflittuale. Quando scatta la sindrome DMA ciascuna parte attribuisce all’altra l’errore, la malvagità, la colpa, e ciò è condizione per autogiustificarsi, autoassolversi, deresponsabilizzarsi. Ora, come sappiamo bene, nella realtà concreta della vita e delle relazioni è ben difficile che in un con-flitto si possa attuare una simile distinzione netta tra le parti, e, invece, proprio per il carattere interdipendente dei processi conflittuali, vi sia una certa corresponsabilità nello stato della situazione, almeno quando i conflitti sono simmetrici. Nel caso di conflitti asimmetrici, in alcuni contesti particolari e in una certa misura, è possibile che tra le parti vi sia una diversa distribuzione di responsabilità, e una di esse si trovi in una condizione di ingiustizia, sofferenza, subordinazione a causa dell’altra. Anche in questo caso, tuttavia, l’applicazione del modello DMA è inadatta ad una trasformazione costruttiva del conflitto, perché non fa che innescare dinamiche di escalation o di propagazione della violenza, o di autodistruttività, come abbiamo sotto gli occhi in tanti esempi, sia a livello di micro, sia a livello di macro conflitti che, proprio anche a causa di simili dinamiche, diventano “intrattabili”. E’ allora di vitale importanza individuare i percorsi che possono contrastare la meccanica 1 Tra gli altri: Fromm E., Anatomia della distruttività umana, Milano 1975; Semelin J., Per uscire dalla violenza, Torino 1985; Goss-Mayr H., L’Abate A. (a cura), Giovani e pace, Torino 2001; Dogliotti Marasso A. in «Satyagraha», Quaderno n 1, Pisa, 2002; si veda anche la nota 7 nel saggio di L’Abate A., Struttura sociale e pregiudizio. Una ipotesi e le sue prime verifiche, in Baracani N. e Porta L. (a cura di) Il pregiudizio antisemitico. Una ricerca intervento nella scuola, Angeli, Milano, 1999, pp.20-21. 76 Comunicazione e Nonviolenza risposta DMA, in favore di processi più articolati, consapevoli e costruttivi. E ciò vale a qualsiasi livello, ma è di particolare rilevanza nel contesto educativo. 3.1.2. Modelli conflittuali nonviolenti Quali possono essere, le caratteristiche essenziali, dal punto di vista delle relazioni tra le parti, di un modello conflittuale alternativo a quello violento? C’è ormai un’ampia letteratura in merito. Se si dovesse esemplificare una tipologia di comportamento nonviolento nei conflitti in alcune attitudini di base, mi pare che potrebbero essere le seguenti: 1) Saper riconoscere la propria violenza, oltre che la violenza dell’altro e comprendere come in un contesto di interdipendenza, relazionalità, circolarità sistemica, quale è ogni contesto conflittuale, la propria parte di violenza agisce sul comportamento dell’altro, condizionandolo in un intreccio di responsabilità incrociate, che Sari Nusseibeh ha descritto con grande lucidità parlando delle relazioni tra palestinesi e israeliani nel conflitto che li coinvolge da più di un secolo e sembra diventato “intrattabile”: Noi abbiamo il bullo che ci sta seduto sopra, noi siamo la parte più debole, ma la cosa strana è che non riusciamo a far sì che questo bullo si sposti da noi e se ne vada. Egli non lo farà a meno che, in qualche modo, non riesca a capire che, se si alza, noi non salteremo su di lui per picchiarlo o atterrarlo. In qualche modo egli deve guadagnare fiducia in quelle che sono le nostre intenzioni. E’ una condizione strana: lui è il bullo, lui è più forte, ma in qualche modo il suo comportamento dipende da quello che pensa di noi, delle nostre azioni, di noi più deboli… …la chiave del futuro, dei destini e degli interessi palestinesi è in mano dell’opinione pubblica israeliana e la chiave dell’opinione pubblica israeliana è nelle mani della modalità palestinese di agire e di affrontare le cose. Noi, in un certo senso, potremmo riuscire a determinare, a forgiare il nostro futuro. Noi che siamo sotto occupazione potremmo determinare il nostro futuro. Però oggi non lo facciamo, o meglio non lo facciamo nel modo giusto, ma anzi in quello controproducente (Nusseibeh, 2003). Persino di fronte al male estremo, Etty Hillesum, poco prima di morire nel lager di Westerbork, scrive nel suo diario: Non vedo nessun’altra soluzione, veramente non ne vedo nessun’altra che quella di raccoglierci in noi stessi e di strappar via il nostro marciume. Non credo che si possa migliorare qualcosa nel mondo esterno senza aver prima fatto la nostra parte dentro di noi. E’ l’unica lezione di questa guerra, dobbiamo cercare in noi stessi, non altrove (Hillesum, 1985). Parole profondissime e di grande attualità, per riflettere e non perdersi di fronte alle manifestazioni più tragiche del male nella storia dei singoli e delle collettività. Seppure in contesti e con finalità diverse, Patfoort sostiene qualcosa di analogo quando afferma che uno dei principi su cui si basano i processi di crescita della violenza è quello per cui “le persone sono molto più facilmente consapevoli di essere in posizione m di quanto non lo siano di essere in posizione M” (Patfoort, 2002). Il non essere consapevoli della propria parte di violenza nelle relazioni ci rende ciechi di fron- Parte 3 - Prevaricazione e violenza nella scuola 77 te alle motivazioni del comportamento dell’altro e incapaci di comprenderlo, di metterlo in relazione a noi, e dunque di trovare una strada per contrastare dinamiche relazionali violente. Tale consapevolezza è tanto più difficile quanto meno la violenza è esplicita, appariscente, fisica. Nelle modalità comunicative, soprattutto a livello di relazione ci può essere, come sappiamo, un alto tasso di violenza: nella svalorizzazione dell’altro, derivante da un atteggiamento di superiorità nei suoi confronti; nella pretesa di farlo simile a sé, annullando le differenze e assimilandolo ai propri schemi, senza rispet-tarne le diversità; nella manipolazione che, consapevolmente o meno, tende a piegare, utilizzare, strumentalizzare l’altro per i propri fini (per quanto “nobili” essi siano). Riconoscere la propria violenza è anche un modo per imparare a trasformarla, sviluppando, invece della violenza, l’assertività, l’affermazione positiva dei propri bisogni attraverso una comunicazione nonviolenta efficace. Mentre si può anche essere molto poco aggressivi ma molto violenti, la comunicazione assertiva può anche essere “forte” nell’espressione dei sentimenti e dei bisogni, senza essere violenta. Come scrive I.Filliozat, infatti, la violenza non è la collera, ma lo scacco della collera: La collera è una reazione alla frustrazione e all’ingiustizia. Da essa scaturisce l’energia per l’affermazione di sé, che serve al mantenimento dei nostri confini fisici, psicologici e sociali e alla difesa dei nostri diritti. La collera è funzionale all’armonia (Armonia è figlia di Marte, dio della guerra e di Venere, dea dell’amore)… L’armonia è l’equilibrio trovato tra due esseri che si confrontano. E’ importante non confondere la collera con la violenza e la presa di potere sull’altro (Filliozat, 1997). E’ piuttosto l’impotenza nel gestire ciò che si prova in situazioni difficili, nell’esprimere i propri bisogni e nel ricevere soddisfazione, che presiede alla violenza. Dunque ragionare sulla propria violenza conduce al cuore del problema: l’accettazione e la gestione del-le emozioni nelle dinamiche conflittuali. 2) Sapersi decentrare; “pensare doppio”, sviluppare l’empatia e l’assertività. Ogni anno porto gli allievi di Saint-Joseph al grande memoriale di Gerusalemme sulle origini e la realizza-zione del genocidio: lo Yad Vashem. Voglio mostrare loro quello che hanno sofferto i loro “nemici”, voglio che tocchino con mano l’orrore in una delle sue manifestazioni più compiute e che comprendano che chi conside-rano oggi “il carnefice”, ieri è stato vittima del delitto più abominevole. Io stesso ho subito, durante una visita a Dachau negli anni sessanta, uno degli choc più forti della mia vita….Il nazismo è un fenomeno unico nel-la storia mondiale. Voglio che i miei allievi lo sentano. E vorrei che in seguito comprendessero quanto ha pe-sato la Shoah sulla sensibilità ebraica ed evitino le facili confusioni che continuano ancora oggi (Shoufani, 2003). In questo brano di Emile Shoufani, un prete melchita di Nazaret, arabo-israeliano, che organizza da anni incontri tra ebrei e palestinesi, c’è il modello di ciò che significa decentramento, nelle sue essenziali componenti di ascolto ed empatia. Di ascolto, cioè di “percezione del quadro di riferimento interno dell’altro” (Rogers), che richiede presa di distanza da sé, da ciò che ci preoccupa, per far posto all’altro, poter riconoscere e comprendere empaticamente il suo punto di vista e il suo sentire. Quanto all’empatia, intesa come “un’esperienza emotiva di condivisione mediata da processi cognitivi” (Bonino, 1998), ciò che blocca la capacità empatica è il focalizzarsi solo sulla propria soffe- 78 Comunicazione e Nonviolenza renza e il non saper vedere quella dell’altro; in alcuni casi, ad esempio quando c’è o è stata costruita una grande distanza sociale e i contatti sono minimi o inesistenti ciò può giungere fino alla de-umanizzazione, al non riconoscere l’altro come essere umano. Talvolta accade che la mancanza di empatia verso l’altro si accompagni ad un’incapacità di riconoscere i propri sentimenti e bisogni, perché, come ha evidenziato Fornari, il meccanismo di difesa della de-umanizzazione agisce sia verso l’oggetto, sia verso il soggetto: I due aspetti della deumanizzazione, quella orientata sull’oggetto e quella orientata verso se stessi, si rafforzano a vicenda. Quanto più infatti la gente tenderà a considerare gli altri come dei subumani, degli inumani o dei superuomini, per cercare di liberarsi dalla paura, dal rimorso, dall’inquietudine, tanto più rischierà di perdere qualcuna delle qualità umane che le sono proprie (Fornari, 1960). L’empatia aiuta invece, attraverso la sospensione del giudizio e l’apertura ai bisogni dell’altro, a individuarne gli obiettivi condivisibili, a trovare dei canali di contatto e di dialogo con lui, per superare le paure e contenere la violenza. Tutto questo però comporta una sorta di “visione doppia”, che tiene conto parallelamente di sé e dell’altro, e si situa perciò in una prospettiva relazionale, anziché individualistica, nella quale è più facile che si instauri un rapporto fondato sull’equivalenza, intesa come riconoscimento di ugual valore all’altro, che sia attivata la capacità di comprensione empatica e che i soggetti assumano un’etica della responsabilità, intesa nell’accezione che ne dà Gilligan, come di una prospettiva morale basata sull’intuizione dell’esistenza di un’interconnessione tra gli esseri umani la quale “porta a riconoscere che, come la violenza risulta alla fine distruttiva per tutti, così le attività di cura responsabile finiranno per arricchire sé e gli altri” (Gilligan, 1987). Quanto all’assertività, intesa come capacità di esprimere positivamente i propri bisogni e punti di vista, senza far violenza né subirla, diverse ricerche concordano nel ritenerla una delle competenze essenziali per una trasformazione costruttiva dei conflitti. L’assertività consente anche di resistere alle pressioni esterne, e dunque di operare delle scelte consapevoli e responsabili. Negli studi condotti da A. L’Abate, sulle condizioni che ostacolano o favoriscono l’insorgere del pregiudizio, essa risulta essere, in definitiva, una delle variabili più significative, nel senso cha sembra emergere una correlazione tra alto livello di assertività e basso livello di pregiudizio. Componenti fondamentali di un atteggiamento assertivo sono le modalità comunicative nonviolente, analizzate, tra gli altri, da Rosenberg2. 3) Cooperare invece che competere; sviluppare la creatività nella ricerca di soluzioni condivise. La cooperazione nel conflitto (conflict partnership), secondo Weeks (1995) è un “metodo efficace per affrontare i conflitti e per migliorare le relazioni in tutte le dimensioni della società umana”; essa significa, in primo luogo, concepire il conflitto come una sfida, per rispondere alla quale tutte le parti devono cooperare. 2 Rosenberg M., Les mots sont des fenetres, Syros 1999 ; non riprendo qui questi aspetti, trattati nella comunicazione al precedente convegno, Dinamiche di escalation e de-escalation dei conflitti: il ruolo della comunicazione, in Cheli E. (a cura di), La comunicazione come antidoto ai conflitti, Punto di fuga, 2003 (atti convegno di Arezzo 2002). Parte 3 - Prevaricazione e violenza nella scuola 79 Cooperare nel conflitto significa anche circoscrivere il problema e non lasciare che coinvolga l’intera relazione. E’ più facile, infatti, cooperare per affrontare una questione sulla quale si è manifestata una divergenza o una concorrenza, se essa è concepita come un evento isolato, che riguarda solo una parte della relazione. Un approccio cooperativo, inoltre, affrontando il conflitto secondo l’ottica del “noi”, che tende a mettere in luce i bisogni condivisi da tutte le parti, aumenta la possibilità di trovare soluzioni “sostenibili” e soddisfacenti per tutti. Nella ricerca di soluzioni condivise la competenza da sviluppare è la creatività che consente, uscendo dagli schemi consueti, di mettere in pratica strategie capaci di tener conto sia degli scopi, sia delle relazioni e di “trascendere” il conflitto, ristrutturandolo secondo nuove prospettive. In sintesi, si potrebbero confrontare i due approcci, della cooperazione e della competizione, attraverso alcune caratteristiche sintetizzate in parole-chiave, come nel seguente schema (non esaustivo): Paradigma della cooperazione Fiducia Apertura Equivalenza Intelligenza-comprensione Generosità Condivisione Distinzione Differenze Paradigma della competizione Controllo Segretezza Superiorità Astuzia-raggiro Esclusività Appropriazione Contrapposizione Disparità 3.1.3. Ricerche ed esperienze di formazione al conflitto in ambito scolastico Delineato per sommi capi il quadro teorico di riferimento, si possono proporre ora alcuni esempi di percorsi formativi in sintonia con gli orientamenti suddetti. Molte sono ormai le esperienze di formazione al conflitto, anche in ambito scolastico. Ne prenderò in esame alcune, a titolo esemplificativo, riconducibili a due tipologie: a) prevenzione di violenza e bullismo a scuola; gestione dei conflitti e mediazione tra pari; b) lavoro sul conflitto attraverso l’analisi di macro-conflitti con la metodologia dei giochi di ruolo strutturati. a) Una delle più significative esperienze europee di formazione alla mediazione tra pari è quella che ha dato luogo, in Francia, alla rete di Génération Médiateurs. Partendo dal problema della violenza a scuola nella banlieu parigina, un gruppo di insegnanti francesi dell’IFOR (International Fellowship of Reconciliation) ha elaborato all’inizio degli anni novanta un progetto-laboratorio di “Gestione dei conflitti e mediazione tra pari”, proponendo contestualmente stage di formazione per i docenti. Obiettivi del laboratorio sono: - conoscersi meglio; prendere coscienza dei propri valori; sviluppare la fiducia nelle 80 Comunicazione e Nonviolenza proprie capacità; - prendere coscienza della violenza in sé e intorno a sé; - riflettere sui propri modi di reagire alla violenza e sulle proprie strategie nei conflitti; - comprendere che l’altro può avere un punto di vista diverso; - imparare a comunicare meglio per esprimere i propri bisogni in modo assertivo; sviluppare l’ascolto e l’empatia; - saper prendere le giuste distanze nei conflitti per reagire costruttivamente; saper dialogare nel rispetto reciproco e distinguere tra conflitto e persona in conflitto; - sviluppare l’immaginazione e la creatività in modo da trovare soluzioni senza vincenti né perdenti; - apprendere le tecniche della mediazione tra pari. Il laboratorio utilizza una metodologia attiva che consente ai ragazzi di “mettere in parole ciò che hanno vissuto e prendere le distanze da sé…in modo da osservarsi senza paura di essere giudicati”. Inoltre, poiché “gli esercizi di mediazione propongono un lavoro pratico e concreto che produce effetti visibili” (Goddet, 2002), gli adolescenti sono aiutati a superare il senso di impotenza e frustrazione che spesso è all’origine dei comportamenti violenti verso se stessi o verso gli altri. Il Centro studi “D.Sereno Regis”, ispirandosi a questo modello, ha proposto analoghi percorsi di formazione in diversi contesti scolastici. In tale occasione è nata la collaborazione al progetto di prevenzione del bullismo elaborato dall’Istituto “Datini” di Prato, progetto particolarmente interessante, perché prevede l’intervento a tutti i livelli: - laboratori per studenti, che hanno coinvolto circa 400 allievi; - corsi di aggiornamento per docenti; - attività di coinvolgimento dei genitori. Nella descrizione del progetto si legge: L’oppressione, il dominio dell’io sull’altro sono spesso ritenute l’unico modo per manifestare la propria sicurezza personale, l’affermazione del proprio coraggio, a difesa del proprio status con i compagni. Il fenomeno del bullismo, come ogni squilibrio di potere in cui una parte domina sull’altra, può essere prevenuto solo attraverso l’educazione al conflitto, all’espressione di sé attraverso forme positive di comunicazione dei propri fondamenti individuali. Con il progetto si intende quindi lavorare sull’assertività… i ragazzi faranno esperienze di apprendimento cooperativo attraverso la valorizzazione dei propri punti di vista nel rispetto dell’altro… valorizzando la capacità di intervento dei ragazzi sulle dinamiche conflittuali presenti nel proprio gruppo classe… i ragazzi diventeranno, insieme ad esperti nella gestione dei conflitti relazionali, dei cofacilitatori della comunicazione tra parti coinvolte in episodi di violenza3. Uno degli aspetti più interessanti del progetto è il tentativo di uscire dalla logica “giudiziaria” della colpa-pena, che consiste nell’identificare il colpevole nel bullo; nell’esprimere un giudi3 Incontriamoci. Progetto di prevenzione al bullismo, espressione di malessere sociale, Istituto “Datini”, Prato, 2002. Parte 3 - Prevaricazione e violenza nella scuola 81 zio negativo nei suoi confronti (es.: “è un debole, un vile, incapace di relazioni normali, che ha bisogno di schiacciare gli altri per affermarsi…”); nel punirlo, infine, per il suo comportamento. Ma la semplificazione aggressore/vittima, torto/ragione non aiuta ad evidenziare diversi altri aspetti presenti nel fenomeno del bullismo: - oltre all’aggressore e alla vittima ci sono gli “spettatori”, il cui ruolo non è affatto estraneo alla relazione bullo-vittima, anzi, talvolta è così essenziale ad essa che, se non ci fossero gli spettatori, non ci sarebbe nemmeno l’evento; esso è agito, infatti, in funzione di un riconoscimento sociale da parte del gruppo (è questo il caso delle forme “mafiose” di bullismo); in ogni caso, il tipo di reazione degli spettatori condiziona il comportamento sia del bullo, sia della vittima; - la vittima ha un potere da attivare da parte sua: anche il suo modo di reagire all’aggressione può condizionare il comportamento del bullo; - il comportamento del bullo va decodificato: è necessario chiedersi cosa esprime, o cosa nasconde, o cosa manifesta, altrimenti l’intervento fatto sarà sul sintomo, non sulla causa; - il comportamento del bullo non è identificabile con la persona che lo mette in atto, è un atto sbagliato, compiuto da una persona che deve essere messa in condizione di prendere coscienza del proprio errore. Tutto ciò rimescola le carte e richiede un approccio diverso, anche perché, in genere, la semplice repressione è inefficace se non dannosa, perché tende a riprodurre all’infinito lo schema vincitore/vinto. Essa conferma infatti il bullo nel proprio ruolo, rendendogli difficile il cambiamento, aumenta la sua voglia di vendetta, mobilita la sua energia aggressiva, riproduce lo stesso schema, nel quale può rispecchiarsi, rafforzando così in lui una identità che solo apparentemente è trasgressiva, ma che in realtà è in sintonia con la cultura profonda che si esprime in modalità relazionali competitive e violente, presenti a tutti i livelli nella nostra società. Solo un intervento capace di conoscere meglio il contesto e il fenomeno nelle sue concrete manifestazioni e di comprendere come tali fenomeni si colleghino da un lato al contesto sociale e familiare e dall’altro al lavoro e alle relazioni scolastiche, consente di intervenire in modo adeguato per interrompere questa catena, come tenta di fare il progetto di Prato, insieme a tanti altri4. b) “La vittoria ottenuta con la sconfitta violenta del nemico non conduce alla pace”5. Se ciò vale nelle relazioni interpersonali, a maggior ragione è vero per i macro-conflitti. Ragionare sulle dinamiche di un macro-conflitto, preso in esame come caso di studio, può 4 Tra le tante esperienze di prevenzione-intervento realizzate in questo ambito si segnalano in particolare quella, più recente, del Comune di Ferrara, che ha prodotto il video “Togliamoci la maschera”, e, tra le prime, la ricerca-intervento coordinata dal sociologo Franco Prina, nelle scuole del quartiere Vallette, a Torino, negli anni novanta. Percorsi di formazione in questo ambito sono proposti anche dal Centro Studi Difesa Civile, [email protected] e dal Centro psicopedagogico per la Pace, [email protected]. 5 Panikkar R., Nove sutra sulla pace, in Cem/mondialità, marzo, 2003, pag.8. 82 Comunicazione e Nonviolenza essere un modo, oltre che per meglio comprendere quella situazione nella sua complessità, anche per individuare quali competenze possono essere utili nella gestione dei conflitti a diversi livelli, compreso quello dei conflitti quotidiani. Partendo da questa ipotesi, e in considerazione del fatto che non è sempre facile in-serire un percorso di educazione al conflitto nell’offerta formativa della scuola superiore, abbiamo pensato di proporre un’unità didattica che potesse essere agevolmente inserita nei programmi curricolari delle discipline storico-sociali, centrata su un gioco di ruolo appositamente creato sul caso del conflitto Palestina/Israele. Dal punto di vista metodologico, il gioco di ruolo che abbiamo elaborato si basa sui lavori di Elena Camino e del suo gruppo di Ricerca e didattica delle scienze dell’Università di Torino, per affrontare le questioni complesse e controverse6. Tale metodologia, proponendo come elementi prioritari di conoscenza aspetti tratti dalle storie di vita di personaggi delle parti in causa, e mettendo in campo i diversi vissuti e punti di vista presenti nello scenario proposto, si è rivelata un efficace strumento di lavoro didattico. Nel nostro caso gli specifici obiettivi individuati sono i seguenti: - diventare consapevoli della complessità della situazione; comprendere meglio le diverse prospettive ed esperienze, i diversi punti di vista e vissuti delle parti in causa, nelle loro articolazioni interne; - entrando concretamente nel vivo di una dinamica conflittuale , capire come evolve, cosa può renderla più distruttiva, cosa può invece contenerne la violenza e aprire strade di ricomposizione e riconciliazione; - comprendere quali sono le competenze da sviluppare per trasformare un conflitto in modo nonviolento e sperimentarne alcuni aspetti, relativi in particolare alla comunicazione efficace, all’ascolto e all’empatia; - sviluppare un atteggiamento di cittadinanza attiva e di responsabilizzazione Dal punto di vista del tema trattato, l’impostazione complessiva del lavoro prende spunto anche da diverse ricerche ed esperienze di formazione in corso da anni ad opera di studiosi ed attivisti per la pace palestinesi ed israeliani. Nei lavori di educazione alla pace nel contesto dei conflitti “intrattabili” di Gavriel Salomon (2003), ad esempio, viene data grande rilevanza alla ricostruzione storica dai diversi punti di vista, ed essa viene usata anche quale strumento per promuovere il decentramento cognitivo e favorire l’empatia; si utilizza lo studio di un conflitto “esterno” per acquisire competenze di analisi e abilità di gestione del conflitto nel quale si è coinvolti ; si ritiene che la conoscenza ravvicinata delle prospettive e delle sofferenze dell’altra parte in conflitto sia un potente strumento di contenimento della violenza e delle distorsioni nella percezione dell’altro. Nell’approccio della riflessione e della fiducia (TRT) proposto da Bar-On e Adwan7, la condivisione della memoria e la comunicazione dei vissuti ad 6 si vedano, tra gli altri: Camino E., Calcagno C., Un livido giorno di pioggia. Gioco di ruolo sulle piogge acide, EGA, Torino, 1992; Camino E., Colucci L., Educazione ambientale e sostenibilità. Lo studio di un caso: la controversia sugli allevamenti di gamberetti in India, EGA, Torino 2000. 7 Albeck J.H., Sami Adwan, Dan Bar-On, Dialogue Groups: TRT’s Guidelines for Working Through Intractable Conflicts by Personal Storytelling, in Peace and Conflict, Journal of Peace Psycology, vol.8, n.4, 2002. Parte 3 - Prevaricazione e violenza nella scuola 83 essa collegati in un contesto protetto, aiutano a ricostruire identità non congelate nel vittimismo, ma più complesse e articolate, capaci di comprendere anche la sofferenza dell’altro. Mettendo insieme questi spunti con le riflessioni e le esperienze ricavate da diversi gruppi e movimenti che lavorano per la pace, ci siamo proposte di creare con il gioco di ruolo uno scenario attraverso il quale mettere in atto simulazioni finalizzate a entrare concretamente nel merito di alcune dinamiche conflittuali, a sperimentare, in particolare, il ruolo fondamentale della comunicazione nella trasformazione costruttiva dei conflitti, in un contesto caratterizzato da significativi risvolti cognitivo-emotivi, capaci di produrre un apprendimento efficace. Questi sono alcuni dei commenti raccolti dopo le prime sperimentazioni del gioco: “avere i punti di vista di tanti personaggi ci aiuta a cogliere le diverse sfaccettature e a prendere coscienza della complessità del problema”; “ho fatto fatica ad accettare di assumere il ruolo di questo personaggio, perché mi ritrovavo più d’accordo con l’altra parte, ora ho capito meglio le ragioni di entrambi”; “il gioco mi ha aiutato a modificare il mio punto di vista sul conflitto, che era superficiale”; “mettersi dal punto di vista dell’altro serve in tutti i conflitti, anche nei nostri conflitti quotidiani”. Il lavoro va proseguito, ma sembra promettente. Lo schema riassuntivo che segue mette a confronto i principali obiettivi formativi delle esperienze proposte, in relazione agli obiettivi-tipo di un percorso di educazione al conflitto in ambito scolastico. Mediazione tra pari - prendere coscienza della violenza in sé e intorno a sé; Riconoscere le forme di - riflettere sui modi di reagire alla violenza e sulle violenza proprie strategie nei conflitti -comprendere che l’altro Decentramento ed em- può avere un punto di vista diverso; patia - sviluppare l’ascolto e l’empatia -esprimere i propri bisogni in modo assertivo Progetto bullismo Gioco di ruolo P/I - riconoscere e decodificare i comportamenti violenti (verso se stessi e verso gli altri); - capire cosa può contenere la violenza e cosa può incrementarla in una dinamica conflittuale -ascolto attivo ed empatico; - auto-consapevolezza emozionale - Comprendere le diverse prospettive, i punti di vista e i vissuti delle parti in causa - sviluppare l’assertività e adeguate competenze comunicative in tutti gli attori (bullo, vittima, spettatori) -individuare le competenze per trasformare in modo nonviolento un conComunicazione nonvioflitto e sperimentarne alculenta ni aspetti, relativi, in particolare, alle modalità comunicative - sviluppare l’immaginazio- - apprendimento cooperati- - sperimentare metodoSviluppare strategie co- ne e la creatività per trovare vo; co-facilitazione e coo- logie di consensus building soluzioni senza vincenti né perazione nel conflitto su aspetti specifici di un operative perdenti contesto conflittuale 84 Comunicazione e Nonviolenza 3.1.4. Riferimenti bibliografici L'Abate A., Struttura sociale e pregiudizio. Una ipotesi e le sue prime verifiche, in Baracani N. e Porta L. (a cura di), Il pregiudizio antisemitico. Una ricerca intervento nella scuola, Franco Angeli, Milano 1999, pp.20-21. Albeck J.H., Adwan S., Bar-On D., Dialogue Groups: TRT's Guidelines for Working Through Intractable Conflicts by Personal Storytelling, in «Peace and Conflict, Journal of Peace Psycology», vol.8, n.4, 2002. Bonino S. et al., Empatia, Giunti, Firenze 1998. Camino E., Colucci L., Educazione ambientale e sostenibilità. Lo studio di un caso: la controversia sugli allevamenti di gamberetti in India, EGA, Torino 2000. Camino E., Calcagno C., Un livido giorno di pioggia. Gioco di ruolo sulle piogge acide, EGA, Torino 1992. Cheli E. (a cura di), La comunicazione come antidoto ai conflitti, Punto di fuga, 2003 (atti convegno di Arezzo 2002). Filliozat I., L’intelligence du Coeur, Marabout, Paris 1997. Fornari F., Dissacrazione della guerra. Dal pacifismo alla scienza dei conflitti, Feltrinelli, Milano 1969. Fromm E., Anatomia della distruttività umana, Mondadori, Milano 1975. Galtung J., Uscire dal circolo vizioso tra terrorismo e terrorismo di stato: alcune condizioni psicologiche, in «Satyagraha», n.2, Pisa 2002. Gilligan C., Con voce di donna, Feltrinelli, Milano 1987. Goss-Mayr H., L’Abate A.(a cura), Giovani e pace, Pangea, Torino 2001. Goddet Tartar E., Génération Médiateurs, «Info», n.9, novembre 2002. Hillesum E., Diario 1941-1943, Adelphi, Milano 1985. Panikkar R., Nove sutra sulla pace, in «Cem/mondialità», marzo 2003. Patfoort P., Costruire la nonviolenza. Per una pedagogia dei conflitti, La Meridiana, Molfetta 1995. Patfoort P., Non possiamo cambiare il passato, ma possiamo cambiare il futuro in «Satyagraha», n. 2, 2002. Rosenberg M., Les mots sont des fenetres, Syros, Paris 1999. Semelin J., Per uscire dalla violenza, EGA, Torino 1985. Shoufani E., Attendo la pace, San Paolo, Milano 2003. Weeks D.-Truder A., Scotto G., Cooperazione nel conflitto, Qualevita, Torre dei Nolfi 1995. Parte 3 - Prevaricazione e violenza nella scuola 85 3.2. PROCESSI VITALI PER LA PACE E NUTRIMENTO DELLA VITA UMANA IN JANE ADDAMS E MARIA MONTESSORI di Giovanna Providenti Comunicare la pace attraverso la pratica quotidiana nei luoghi del proprio vivere e lavorare può essere un antidoto potente alla violenza che, spesso inavvertitamente e inconsciamente, ci sovrasta fino al punto di ritenere naturale ospitare ogni giorno immagini e parole di guerra fin dentro le nostre case, attraverso i mass media. Ma come si fa a comunicare la pace in tempi di guerra? Come si fa a parlare di “pace e pane in tempi di guerra”, per usare un accostamento fatto da Jane Addams, impegnata durante la Prima Guerra Mondiale a nutrire le popolazioni affamate e a sostenere l’urgenza immediata della cessazione di ogni conflitto, e il cui titolo di un suo libro del 1922 recita appunto Peace and bread in time of war1? Innanzitutto affermando la possibilità concreta di una società in cui la guerra non abbia motivo di esserci, perché i conflitti vengono pienamente vissuti ed elaborati dalle persone, e perché il valore culturale della vita è quello della sua più piena asserzione e sviluppo: niente ha più valore della vita e delle sue infinite potenzialità, presenti in ogni singolo e differente individuo. Per meglio riuscire a comunicare questa idea, che affonda le sue radici in una concezione, definibile “femminile”, tesa a rilevare nel termine vita la componente della nascita e della crescita più che quella della morte, e tesa a sottolineare lo stretto nesso tra pace e sviluppo di tutte le potenzialità della vita, può aiutare la lettura di due autrici pacifiste del secolo scorso: Jane Addams e Maria Montessori. Queste due pensatrici nel parlare di pace propongono una dimensione simbolica che abbia a che fare con il dinamismo, il gioco, la vitalità, piuttosto che la rinuncia o l’assenza: esse hanno imparato a giocare e a sentirsi vive non limitandosi soltanto a scrivere e a parlare, ma mettendo in pratica le loro idee attraverso la realizzazione di strutture alternative. Jane Addams fonda nel 1889 il Social Settlement HullHouse, un centro sociale residenziale in cui si svolgono attività formative e culturali rivolte agli abitanti di un sobborgo industriale multiculturale di Chicago. Maria Montessori fonda nel 1906 la Casa dei Bambini, una scuola per l’infanzia in cui l’eterno conflitto bambino-adulto si trasforma in un’opera di cooperazione della parte più forte verso la graduale autonomia della parte più debole, il bambino2. 1 Jane Addams, Peace and Bread in time of war, Macmillan, New York, 1922. Vedi anche Newer Ideals of Peace Chautauqua Press, New York 1907 e The Long Road of Woman’s Memory, Macmillan Co., New York 1916. Sulla pace proposta dalle donne in tempi di guerra segnalo i recentissimi: Lanfranco Monica e G.Di Rienzo Maria (a cura di), Donne Disarmanti. Storie e testimonianze su nonviolenza e femminismi, Edizioni Intra Moenia, 2003; Lusiardi Delfina (a cura di), Fare pace dove c’è guerra. Ruanda, Eritrea, Kosovo, Bosnia, Serbia, Algeria,Italia..., in «Via Dogana», n.44/45, Settembre 1999. 2 Montessori dedica molte pagine al rapporto tra adulti e bambini, che spesso si presenta conflittuale, e che lei definisce “il primo dissidio dell’uomo che fa ingresso nel mondo”, In un paragrafo di Educazione e pace, Garzanti, Milano, 1979, (1938), ella denuncia una concezione della educazione tendente a mortificare con rimproveri e punizioni l’istinto del bambino a crescere, minando la salute psichica stessa del bambino e risultando “fatale per l’umanità”: “il fallito, l’indebolito, lo schiavo infine, l’essere non sviluppato, è sempre l’uomo uscito da un’educazione che è lotta cieca tra il forte e il debole” (pp. 18-19). 86 Comunicazione e Nonviolenza Sia Addams che Montessori, si presentano come delle protagoniste di processi di cambiamento, che a partire dal sé possono arrivare a coinvolgere l’intera società. Inoltre, esse sono state per tutta la vita profondamente persuase che un mondo migliore e senza guerre sia possibile: e le istituzioni educative da loro fondate, e in parte ancora vive, sono uno strumento verso tale direzione. Le due pensatrici del Novecento attraverso la loro pratica politica e formativa, e attraverso i loro scritti, hanno affermato la possibilità di una società migliore, e ciò che più rende originali ed attuali le loro idee va rintracciato nella scelta, più o meno consapevole, di utilizzare la propria differenza sessuale come una risorsa culturale e simbolica per esprimere ciò a cui più tenevano: per costruire la pace bisogna nutrire la vita umana (Addams), bisogna educare bambini e bambine liberi/e in grado di sviluppare pienamente tutte le potenzialità della propria personalità. Per Montessori: “nello sviluppo della personalità, due strade sono possibili: quella dell’uomo che ama, e quella dell’uomo che possiede; da un lato l’uomo che ha conquistato la sua indipendenza e che si associa con gli altri in modo armonioso, dall’altra l’uomo schiavo, che, volendosi liberare, diviene schiavo del possesso e giunge all’odio. (…) Queste due diverse vie non sono il frutto di una libera scelta, bensì la conseguenza dello sviluppo normale od anormale dell’uomo. (…) La nostra speranza per la pace futura non risiede negli insegnamenti che l’adulto può dare al bambino, ma nello sviluppo normale dell’uomo nuovo”3 (Montessori, 1979, pp.82-83). Questo modo di percepire la vita come amore, come nutrimento, come formazione possibile di persone libere e in grado di amarsi reciprocamente affonda le sue radici in competenze storicamente possedute dalle donne. Nella esperienza e fiducia femminile in fatto di cambiamento/evoluzione di cose e persone. Nella visceralità, sia materiale che spirituale, di vicende e momenti della vita con cui soprattutto le donne hanno avuto e tuttora hanno a che fare. La materia tocca i temi del nascere e del nutrire: la bambina/il bambino viene partorita/o, viene nutrita/o, nasce, cresce, trasforma gradualmente la propria inizialmente informe materia umana in esseri compiuti: donna e uomo. Perché questo sviluppo, fatto di continui e inevitabili cambiamenti, possa compiersi è assolutamente indispensabile nutrirsi. Lo spirito riguarda la dimensione interiore: non è prerogativa femminile, ma le nostre due autrici accostano l’esperienza della nascita e della crescita materiale a quella spirituale: lo spirito si nutre di cam-biamento interiore, di disponibilità a trasformare passo dopo passo la propria vita verso il contatto con il sentimento divino dell’essere4. Ma ciò che forse più accomuna le due autrici, è il loro modo di intendere l’educazione come collaborazione allo sviluppo di tutte le potenzialità umane, ed il fatto di considerare il processo, in educazione come in politica, più importante del fine. Il processo è ciò che sta in mezzo tra l’informe e il formato: sono i nove mesi di attesa, è il 3 L’A. utilizza il termine “uomo” intendendo “essere umano”. A questo proposito vedi gli ultimi lavori di Luisa Muraro: Sull’essere in relazione come capacità di essere, in Brezzi F. (a cura di) Amore ed Empatia, Franco Angeli, Milano 2003; Il Dio delle donne, Mondadori, Milano 2002. 4 Parte 3 - Prevaricazione e violenza nella scuola 87 momento del parto, è il nutrimento al seno, è l’attimo prima e prima ancora di essere semplicemente sazi. O di avere la certezza di essere in relazione con l’essenza spirituale assoluta, col divino. Prima dell’ottenimento di ogni cosa vi è il processo per arrivare ad essa: e a loro parere il fuoco va posto sul modo in cui si crea qualcosa e non solo sulla realizzazione finale. Per costruire la pace è necessario rivolgersi ai processi, far sì che essi non intendano semplicemente contrapporsi alla violenza, ma siano soprattutto pienamente rivolti alla vita: vita intesa come sviluppo, come potenzialità, come processo e fine precedente alla morte, e di cui la morte non è un fine e non è nemmeno contemplata, non ancora. Maria Montessori in Educazione e pace dichiara di essersi posta il compito di conoscere ed organizzare la sfera dell’universo interiore per comprendere quale possa essere la migliore educazione di un essere umano costruttore di pace e di giustizia. Il tono del testo, scaturito da interventi orali tenuti dalla pen-satrice tra il 1932 e il 1937, è quello di una scienziata e pensatrice che parla con autorità5. Dall’apice di una carriera lunga e riconosciuta è ormai arrivato il momento di affermare nel modo più esplicito possibile ciò che più conta veramente6: “bisogna chiarire la differenza profonda, l’opposto orientamento morale della guerra e della pace… La vera pace fa pensare al trionfo della giustizia e dell’amore tra gli uomini: fa pensare a un mondo migliore ove regni l’armonia. Un chiaro orientamento differenziale tra guerra e pace, non è che il punto di partenza. Per fare luce su questo argomento, come su ogni altro, occorre una ricerca positiva” (Montessori, 1979). Una ricerca scientifica tesa a comprendere le cause umane della guerra e a penetrare le vere ragioni del cuore, per apprendere cos’è che veramente tiene in vita e motiva alla vita, cioè a perseverare nel desiderio della scoperta, già a partire da quando si è piccoli, con lo stesso entusiasmo dei bambini “scoperti” dalla pedagogista italiana: “quando si offre loro il materiale Montessori, vi si gettano sopra con un entu-siasmo che finora era considerato incredibile” (Montessori, 1943, p.27). Anche nella idea di un’altra entusiasta, Jane Addams, la pace ha un valore positivo in sé ed un significato molto più ampio rispetto alla semplice negazione della guerra: la pace va costruita sulla base di una serie di processi vitali produttivi e di una effettiva valorizzazione dell’individualità personale, materiale, morale e spirituale, di ogni essere umano. Nei molti discorsi da lei tenuti durante la lunga campagna pacifista, iniziata subito prima lo scoppio della guerra mondiale e proseguita fino agli ultimi giorni di vita, la pensatrice-riformista di 5 A proposito dell’atteggiamento autorevole e “dell’audacia intellettuale e morale con cui sfidava opinioni, costumi, comportamenti secolari, ai quali contrapponeva la sua scoperta di un bambino fino ad allora oscurato dall’errore dell’adulto” vedi Scocchera A., Maria Montessori. Quasi un ritratto inedito, La Nuova Italia, Firenze 1990 (citazione a p. 11) e Maria Montessori. Una storia per il nostro tempo, Ed. Opera Nazionale Montessori, Roma 1997. 6 Come scrive Valitutti in L’educazione e la pace nel pensiero di Maria Montessori, Ed. Vita dell’Infanzia, Roma, 1957, p. 3: “mentre la sua vita volgeva ormai alla fine sulla terra e pareva perciò più ansiosa di esprimere l’essenziale, ella diede forma definitiva al suo insonne pensiero sull’educazione e la pace, sull’educazione come attività creatrice della pace e sulla pace come condizione necessaria e perfetta dello sviluppo della vita dell’uomo raggiungibile solo mediante l’educazione”. 88 Comunicazione e Nonviolenza Chicago, morta nel 1935, ha sempre insistito nel ribadire la stretta connessione tra libera e ampia realizzazione di ogni individuo, possibile soltanto in una società sostanzialmente democratica, e costruzione di un mondo migliore, in cui la guerra sia bandita. Il processo vitale da lei ipotizzato deve rivolgersi alla graduale costruzione di quella che lei definisce una “democrazia etica sociale”. La creazione di strutture sociali e formative, del tipo del Social Settlement Hull-House, ma anche della Casa dei bambini, che mirino a sostenere e formare ogni individuo verso la pienezza personale di un’autentica libertà di pensiero e di azione, sono rivolte alla edificazione di una tale democrazia autenticamente e stabilmente democratica e pacifica. In Democracy and Social Ethics, del 1902, Addams non si sofferma solo a indicare utopisticamente come dovrà essere una tale società, ella anche prova a individuare i processi, attraverso cui il passaggio dalla società attuale alla futura dovrà avvenire, analizzando non tanto gli andamenti istituzionali quanto le relazioni interpersonali, di natura sia privata che pubblica. In ciascun capitolo di Democracy and Social Ethics (un testo considerabile di teoria politica), la pensatrice americana sceglie di trattare argomenti come assistenza sociale, relazioni filiali, riorganizzazione della casa, miglioramenti industriali, metodi educativi e riforme politiche, dal punto di vista delle relazioni interpersonali che essi comportano. Le relazioni tra beneficiario e beneficiato, tra genitori e figli (e più propriamente tra padre e figlia femmina), tra colf e padrone di casa, tra operaio e padrone d’industria, tra docenti e allievi e tra leader/candidati politici ed elettori vengono analizzate innanzitutto per la loro natura di relazione tra un elemento più forte ed uno più debole. La figura più debole viene proposta e fatta emergere, come pro-tagonista di un processo, che Addams reputa debba compiersi verso il graduale superamento del conflitto tra le due parti e la realizzazione di una coesistenza pacifica. A suo parere, in una società democratica lo scopo di tali relazioni non può essere la predominanza di una o dell’altra parte, tutte le energie dovrebbero piuttosto essere rivolte all’attuazione di una produttività positiva, ed i conflitti tra parti equamente superati. L’analisi svolta in Democracy and Social Ethics riguarda dunque la relazione interpersonale che struttura le istituzioni, e che precede ogni possibile riforma: per migliorare le istituzioni, a parere di Addams, bisogna partire dalle persone che le compongono e dal loro essere in relazione reciproca. La loro relazione da impari, in cui vi è una parte debole ed una forte, dovrà divenire pari, equa: ognuno dei due potendo dare/ricevere il proprio diverso modo di appartenere alla istituzione in questione. Per meglio comprendere questa idea nonviolenta di Jane Addams può aiutare la lettura del saggio Gandhi e Tolstoi, scritto nel 1931, in cui negli ultimi paragrafi si legge: “La sollecitazione non proviene da ordinamenti predefiniti, ma dalla scoperta di un modo nuovo di instaurare le relazioni umane. Il mondo politico sta proprio adesso iniziando ad accorgersi degli effetti deprimenti e dello spreco di energie che si hanno nel contrapporre forza a forza, modalità estenuante sia nel processo stesso che nell’effetto del reciproco annullamento delle parti. […] Ovunque nel mondo, al presente momento, vi è una sbalorditiva tendenza a sperimentare questa nuova tecnica e ad osservare cosa essa possa fare. Nelle industrie, il temibile caposquadra di reparto è stato sostituito da formato personale direttivo; nell’istruzione, il maestro dominatore ha lasciato il campo a un nuovo tipo di educatori tenden- Parte 3 - Prevaricazione e violenza nella scuola 89 ti ad evocare l’abilità dei suoi studenti, così come nel campo medico il dottore, come mai prima d’ora, ritiene fondamentale cooperare con il proprio paziente; il giudice dei tribunali dei minori non assolve nè condanna, ma utilizza ogni mezzo possibile, inclusa la forza morale del criminale stesso, per rettificare una data situazione. Ovunque nel mondo gli uomini sono desiderosi di trovare una tecnica che che possa essere adeguata nell’affrontare le straordinarie complessità del mondo moderno” (Addams, 1931). Questo tipo di coerenza tra mezzi e fini preclude la strada per una concezione della politica non più impostata sul conflitto tra parti differenti, ma al contrario sull’integrazione e il dialogo costruttivo tra esse. L’etica politica, in Addams, come nei suoi autori di riferimento, Gandhi e Tolstoi, rifiuta la concezione dualistica secondo cui “il fine giustifica i mezzi”, o secondo cui per difendere il bene di un certo gruppo (Stato, nazione, partito o classe), è possibile fare uso di comportamenti non leggittimi, ovvero non rispettosi nei confronti del diritto alla vita e alla dignità di un’altra persona, e non rispondenti alle leggi morali umanamente condivise. Per affrontare le straordinarie complessità del mondo moderno, Jane Addams e la sua quasi coetanea d’oltreoceano, Maria Montessori, propongono e realizzano istituzioni culturali e formative che puntino ad essere coerenti col fine della costruzione di una società pacifica. Con il loro esempio e con i loro scritti esse propongono possibili antidoti alla violenza: partire da sé, da ciò che si è e si è in grado di fare per costruire la pace; dare importanza ai processi, ovvero ai modi, anche personali (linguaggio, comportamento, disponibilità, ecc) di ottenere una determinata cosa; trovare strumenti, educativi e culturali, coerenti col fine di pace propostosi; recuperare e valorizzare competenze e culture delle parti diffusamente considerate più deboli, minori, come ad esempio i bambini, gli immigrati e le donne. Questo pensiero politico pacifista appartiene innanzitutto alla cultura femminile, ma può anche considerarsi parte della corrente politica denominata con il termine “nonviolenza”7, intesa come dottrina aperta che “si pone come tentativo di dare una risposta adeguata e comprensiva ai nuovi e gravi problemi posti dall’enorme sviluppo degli armamenti, dalla escalation della violenza politica, dalle tendenze totalitarie insite nello Stato moderno, dallo sviluppo incontrollato dell’industrialismo (non solo capitalistico) e dall’ognora crescente divario fra popolazioni povere e popolazioni ricche” (Pontara, 1990, p. 694). A mio parere non soltanto queste due autrici del Novecento potrebbero essere annoverate tra i pensatori e le pensatrici della nonviolenza, ma anche il loro pensiero andrebbe maggiormente considerato e studiato in vista dell’ulteriore contributo che esso potrebbe dare alle scienze politiche. La loro speculazione diversa, contenente delle componenti femminili, potrebbe risultare interessante per recuperare una maggiore praticabilità della proposta nonviolenta, diffusamente ritenuta utopistica e poco attualizzabile. 7 A proposito della idea di nonviolenza nelle dottrine politiche vedi: Pontara G., Nonviolenza e Gandhismo in Bobbio N., Matteucci N., Pasquino G. (a cura di), Dizionario di politica, II edizione, Utet, Torino 1983, pp. 46165 e pp. 693-696; Bori P.C., Lo sviluppo dell’idea di nonviolenza: la non-resistenza in L. Tolstoi, in AA.VV., La nonviolenza come strategia di mutamento sociale, Cedam, Padova 1992; Bobbio N., Il problema della guerra e le vie della pace, Il Mulino, Bologna 1979; Sharp G., Politica dell’azione nonviolenta, EGA, Torino 1985. 90 Comunicazione e Nonviolenza Riferimenti bibliografici AA.VV., La nonviolenza come strategia di mutamento sociale, Cedam, Padova 1992. Addams J., Tolstoy and Gandhi, «Christian Century» XLVIII, 25 novembre 1931. Addams J., Peace and Bread in time of war, Macmillan, New York 1922. Addams J., The Long Road of Woman’s Memory, Macmillan, New York 1916. Addams J., Newer Ideals of Peace, Chautauqua Press, New York 1907. Bobbio N., Il problema della guerra e le vie della pace, Il Mulino, Bologna 1979. Bori P. C., Lo sviluppo dell’idea di nonviolenza: la non-resistenza in L. Tolstoi, in AA.VV., La lunga via del pacifismo russo. L’ideale della pace internazionale e interna nel pensiero russo filosofico-religioso e politico-sociale, Institut vseobsceij istorii, Moskva 1997. Brezzi F. (a cura di), Amore ed Empatia, Franco Angeli, Milano 2003. Lanfranco M. e Di Rienzo M.G. (a cura di), Donne Disarmanti. Storie e testimonianze su nonviolenza e femminismi, Edizioni Intra Moenia, 2003. Lusiardi D. (a cura di), Fare pace dove c’è guerra. Ruanda, Eritrea, Kosovo, Bosnia, Serbia, Algeria, Italia..., Supplemento al n. 44/45 di «Via Dogana», Settembre 1999. Montessori M., Educazione per un mondo nuovo, Garzanti, Milano 2000 (1a ed. 1943). Montessori M., Educazione e pace, Garzanti, Milano 1979. Montessori M., La scoperta del bambino, Garzanti, Milano 1950. Pontara G., Nonviolenza e Gandhismo, in Bobbio N., Matteucci N., Pasquino G. (a cura di), Dizionario di politica, Utet, Torino 1983. Scocchera A., Maria Montessori. Una storia per il nostro tempo, Edizioni Opera Nazionale Montessori, Roma 1997. Scocchera A., Maria Montessori. Quasi un ritratto inedito, La Nuova Italia, Firenze 1990. Sharp G., Politica dell’azione nonviolenta, EGA, Torino 1997. Valitutti, L’educazione e la pace nel pensiero di Maria Montessori, Edizioni Vita dell’Infanzia, Roma 1957. Parte 3 - Prevaricazione e violenza nella scuola 91 3.3. COMUNICAZIONE DEI VALORI E SOCIETÀ “BUONA” Il ruolo della scuola di Tiziano Telleschi Il tema affronta le condizioni per le quali la scuola può produrre valori, quindi comunicarli all’interno e all’esterno, sì da contribuire - in forza di certe condizioni politiche - a produrre società, non una qualsiasi, ma una società “buona” nella quale i conflitti siano gestiti e composti sulla base delle esigenze dell’io e le ragioni dell’altro. Riconosco che il tema è senza alcun dubbio pretenzioso, giacché mette in azione la scuola tra due temi “forti”, i valori culturali e la società “buona”; e perché in specie al secondo non posso qui dedicare che un accenno. La società “buona” è quella che cercano di prefigurare i communitarians, i teorici dell’etica delle virtù civiche, Habermas e altri ancora, ed ha a che vedere con la formazione di nuovi valori sotto la spinta di una idea di democrazia aggiornata dalle innovazioni del pensiero socio-politico. Un livello macro, questo, che è importante tener desto come termine ad quem per dimensionarvi il livello micro, quello della formazione e comunicazione dei valori nella (e ad opera della) scuola. All’altro tema, i valori culturali, rivolgo invece una più ampia attenzione. Innanzitutto occorre precisare che formare e comunicare valori non è processo di creazione ex-nihilo né rimanda direttamente a quei valori alti e astratti, come libertà, partecipazione sociale, democrazia, giustizia, uguaglianza e, oggi, solidarietà e altruismo. Bensì c’è un terreno preliminare di germinazione del valore culturale, generalmente poco coltivato dalle scienze umane e sociali, che attiene all’esperienza minuta del quotidiano1. Voglio dire che non potremmo pensare alcuna forma di “bene comune”, di “società buona”, di coesione sociale o di valore culturale, se non possedessimo una suscettibilità naturale a “legarci a” (cose e persone); e non solo a legarci ma a percepire che quel legame relazionale è importante e “vale”la pena di esse-re vissuto. Questa suscettibilità eticizzante investe e colora di sé i più minuscoli aspetti dell’esistenza. Per dirla con P. Donati “la relazione ha una sua ‘radice’ (o una referenza, e si preferisce) non contingente, mentre essa si dispiega nella contingenza” (1998, p. 80). Chiamo “valevole” quel che prende corpo dalla spinta emozionale a “legarci” e che precede e determina la consapevolezza morale. Troviamo insomma nell’essere umano uno slancio emozionale spontaneo e irriflessivo verso gli altri, che talvolta chiamiamo empatia o altruismo, talaltra compassione o anche amore, amicizia etc. Comunque lo chiamiamo, è una spinta relazionale di tipo etico in quanto il qualcosa all’altro capo della relazione diventa per noi tanto importante che non vorremmo mai staccarcene o perderlo, proprio perché fa tutt’uno 1 In un esame della morale kantiana e del neo-utilitarismo, Franco Crespi, osserva: “l’intento perseguito da queste forme della morale è prevalentemente quello di fissare delle regole che assicurino un consenso funzionale alla costruzione di ordini sociali caratterizzati dalla solidarietà e dalla giustizia, lasciando però in ombra quelle dimensioni dell’esperienza soggettiva che possono anche andare al di là del problema di una migliore integrazione sociale e addirittura essere in contrasto con essa” (1991, p. 16). 92 Comunicazione e Nonviolenza con noi, “ci teniamo”, tanto da sentirci responsabili del suo esistere e mutare. Valevole è ciò che prende forma quando l’atto relazionale è tutt’uno di quel che facciamo con quel che pensiamo, quando non disgiungiamo quel che si vive (il fine) dal modo di sentirlo e viverlo (i mezzi)2 : non qualunque relazione è intrisa di valevole ma quella in cui inflettiamo, proiettiamo qualcosa di noi (emozioni, paure, speranze, aspettative etc.) e ciò facendo diamo esistenza contemporaneamente alla cosa-e-noi. Questa relazionalità valevole è il “costitutivo” dell’individuo per diventare essere sociale, tanto che se egli la sospendesse avrebbe sospeso la relazione-con-il-proprio-sé, avrebbe affievolito la certezza di esistere. Dalla favola dell’aviatore-filosofo Saint’Exupéry ci viene il significato più immediato e autentico di cosa si debba intendere per valevole; questo avviene quando la volpe parla al Piccolo principe dell’importanza di “addomesticare”: “E’ una cosa molto dimenticata. Vuol dire ‘creare legami’ […] Tu, fino ad ora, non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l’uno dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo”. Vale a dire sviluppiamo la nostra sensibilità verso cose e persone quando si dedica loro una “cura” autentica (come, in altro esempio riportato, di una rosa: annaffiarla, esporla al sole, parlarle etc.). Quella cosa (oggetto, persona ma anche una nozione) esiste dal momento in cui vi inflettiamo qualcosa di noi, e mentre ci prendiamo cura della sua sorte ne diventiamo man mano responsabili fino a che, pur nella dualità irriducibile, ci diventa inalienabile e va a costituire l’embrione inalienabile di quel che comunemente chiamiamo la nostra identità. Per di più, colui che suscita in altri la disposizione al valevole, come ad esempio l’insegnante, mentre induce gli studenti a “legarsi” alle nozioni, al contempo accresce la propria capacità di sentire quel che fa e pensa. In questo giro di considerazioni, creare dei legami implica non una fusione identitaria bensì “diventar padrone della propria esistenza” ed includervi responsabilmente la “esteriorità” dell’altro (E. Levinas 1985); implica nondimeno definire l’altro dimensionandolo in una scala di rilevanza disposta da una relazione di riconoscimento/inclusione ad una relazione di negazione/esclusione: in modo intrinsecamente ambiguo nella relazionalità valevole si annida il veleno dell’appartenenza-al-simile e dell’opposizione-al-dissimile, cioè il germe del conflitto. Il valevole, quale “propulsore” della relazione etica, è peraltro dato, e si rigenera continuamente, ma non è la ragione che lo genera [la ragione non può far nascere l’amore materno!]: la ragione può farlo considerare un bene prezioso da riconoscere, accogliere, coltivare, proteggere e far prosperare: il valevole sta all’interno della sfera del privato, del soggettivo, ma que2 La corrispondenza fra quel che si dice e si fa con quel che si pensa e si sente, come disposizione a fare un tutt’uno di sé con le proprie produzioni - che si trova teorizzata nella “autenticità” di M.Heidegger - è una qualità che esemplarmente possiede l’artigiano (e a livelli eccelsi l’artista). L’artigiano è colui che “tiene” al proprio lavoro, ha pazienza, mette attenzione ai detta-gli di quel che fa, ma soprattutto possiede una sorta di armonia con il proprio lavoro. Il materiale e i pensieri dell’artigiano cambiano in sintonia, in una progressione di mutamenti fluidi e regolari; di lui si dice che ciò che fa gli “interessa”, che è “coinvolto” nel lavoro. E ciò che segnala questo coinvolgimento è l’assenza di separazione tra sé e l’oggetto: “tenerci” non è altro che un profondo modo di identificazione di pensiero e agire, sentire e pensare, con la consapevolezza che la cosa e noi siamo entità differenti ma costruende in modo congiunto. Più in generale, “tenerci” implica amare devotamente e responsa-bilmente ciò che facciamo, sentiamo e comunichiamo (cfr. V. Martinez Gúzman, 2001). Parte 3 - Prevaricazione e violenza nella scuola 93 sto “quid” soggettivo è l’humus imprescindibile dei valori morali - se intendiamo la morale come etica pubblica, dalla responsabilità verso di sé ma anche verso gli altri. Ben altrimenti la morale sorge solo se la ragione inventa un’idea di ciò che è “bene”, propone i mezzi per ottenerlo e quindi i mezzi per gestirlo e consolidarlo, cioè i mezzi di attuazione e verifica: diremo, se la ragione trasforma la spinta etica, la solidarietà irriflessiva in patto (F. Alberoni, S. Veca 1988). Importante è qui notare che il valevole non nasce direttamente dalla legge o dalla coercizione né da un atto intenzionale, bensì da una solidarietà pre-contrattuale, un sensus communis depositario di forti emozionalità e aspirazioni ideali. La solidarietà pre-contrattuale inventa e attiva procedure e rituali con cui il gruppo sociale accende ed esalta i sentimenti degli individui verso i propri ideali e fini. In buona sostanza rivestiamo gli atti di moralità perché siamo attaccati sentimentalmente alla “società ideale” prefigurata da un particolare gruppo; e i rituali sono forme speciali di azione sociale che il gruppo utilizza come “mezzi di produzione emotiva” per ricreare il fervore dell’appartenenza e rafforzare il calore avvolgente della moralità “ideale” (E. Durkheim 1963): questa traduzione della spinta eticizzante in morale è atto di natura politica. Mi preme sottolineare che il sentimento morale richiede l’interrelazione di due fattori: il sollevamento emotivo verso la cosa, che è il ponte col quale il soggetto entra in interazione diretta col mondo (immedesimazione) e il governo ‘politico’ di questa relazionalità (responsabilità degli effetti delle relazioni). La scuola può suscitare un valevole così definito? E soprattutto: può dirigerlo in modo da non favorire l’individualismo etico (che esalta il “primato” della relazione col simile e l’opposizione al dissimile) e invece creare, proprio su quella piattaforma, valori culturali inclusivi, che contribuiscano a produrre una società “buona”? Occorre dapprima guardare a come nasce il valevole, e a come lo si comunica. Allo stesso modo di quanto avviene - dice Aristotele - con la virtù e ogni arte, ché nasce e si corrompe [...] dalle medesime azioni e per mezzo delle medesime azioni: infatti dal suonar la cetra vengono fuori i buoni e i cattivi citaredi. Analogamente, per i costruttori di case che per tutti gli altri artigiani ché, edificando bene, si diviene in seguito buoni edificatori; edificando male, cattivi [...]. Lo stesso vale per le virtù: giacché è compiendo certe azioni nelle relazioni con gli uomini che diventiamo gli uni giusti, gli altri ingiusti […]. In una parola, gli abiti nascono dagli atti di ugual natura. Bisogna dunque badare alla qualità degli atti che compiamo, poiché dalla loro differenza deriva la differenza degli abiti (Etica Nicomachea, vol I, 1103 b). In buona sostanza, l’agire etico nasce, si sviluppa o deperisce a un parto con i rituali, le procedure (normative) o le tecniche (educative) della medesima natura che la ragione riconosce degni di essere esercita-ti nella vita quotidiana. Seguendo l’evoluzione che è stata impressa al tema (da Simmel, poi da Habermas), abbiamo che le for-me dell’etica non scaturiscono per un atto intenzionale del soggetto ma connascono in modo irriflessivo con i rituali e le convenzioni e per la forza delle emozioni che intridono/impastano quei rituali stessi. Si aggiunga il dato durkheimiano per il quale l’emozionalità naturale acquista durata e struttura, diventando emozione, per un intervento dall’esterno, ossia tramite idee-forza collettive che stanno nelle coscienze e che sono suscitate dalla società in virtù di adeguati rituali sia normativi che informali. 94 Comunicazione e Nonviolenza E’ importante notare che nel momento in cui si lega alla cosa come proiezione della società, l’emozionalità naturale si trasforma in una emozione speciale ossia diventa il tramite essenziale che allerta il passaggio dalla cosa alla cosa-valore, in definitiva partecipa della categoria del vincolo morale. Queste emozioni speciali si estendono come “macchia d’olio”, si uniscono profondamente alle cose facendole esistere: il “contagio” non è pertanto un procedimento secondario in virtù del quale si propaga il carattere “morale” delle cose, una volta che sia acquisito, bensì è il procedimento col quale si acquista il vincolo morale (E. Durkheim 1969). Ritornando alla scuola, guardiamo all’insegnante e ai modi per i quali può indurre disposizioni morali. Egli ha in primo luogo la funzione di far aderire gli alunni ad un progetto cognitivo e ad un metodo di apprendimento, che vuol dire farli affezionare alle nozioni maturando anche un senso di responsabilità per gli effetti su di sé e sugli altri che l’applicazione di quelle nozioni può provocare nei campi più disparati della vita. In buona sostanza, l’insegnante induce sentimenti morali più o meno durevoli verso cose e persone oltreché schemi cognitivi. Non dispone tuttavia di un modello collaudato, pur se nella prassi didattica fa costantemente appello alle risorse della propria sensibilità per dotarsi di un modello strutturato. A tale carenza tento qui di supplire illustrando in itinere un modello altrove elaborato3. Consiste nell’intervenire sulla disposizione dell’insegnante a “legarsi” con l’altro, per affinare le sue sensibilità verso i desideri dell’alunno così che possa trasmettergli - in virtù di esperienze ludiche e in modo istrionico - la disposizione a sentire vividamente quel che sta facendo e imparando, col risultato di abituarlo a porsi in ogni sua operosità al servizio di sé, a sentire dentro ed amare quel che fa e non disgiungere i mezzi dai fini. Di per sé questa ritualizzazione non si limita ad esaltare l’espressività soggettiva e i bisogni individuali, ma sprigiona una tonalità emozionale che si propaga, per contagio, a tutti gli alunni della classe: in tal caso, il dato scolastico (nozioni e sapere, abilità, relazioni con altri alunni e con gli insegnanti, etc.) si arricchisce di una connotazione e di un’energia del tutto speciali che lo rendono al contempo valevole per il soggetto singolo (cioè degno di essere conservato come un importante aspetto della propria vita) e oggetto devozionale comune (cioè da condividere con i compagni di classe e l’insegnante): la condivisione emozionalmente reiterata dei contenuti scolastici dà luogo all’ethos della classe, all’appartenenza al gruppo-classe. Inoltre, quegli oggetti devozionali comuni, ponendo riflessivamente a confronto costante punti di vista differenti, smussano la quota di soggettività insita nel valevole impedendo che si trasformi in un individualismo etico. Fin qui il discorso educativo svolto dal singolo insegnante. Ma affinché il valevole possa farsi fattore attivo nel dilatare l’esperienza soggettiva e privata in direzione di un’esperienza di gruppo fino a costruire un bene comune, è opportuno sia coinvolta appieno l’istituzione scolastica e si faccia ricorso ad interventi di intergruppo. La scuola è l’arena pubblica che possiede le caratteristiche adeguate per dare il via alla sfida: accoglie ragazzi inclini a cercare il fellow companion, opera su gruppi a volte omogenei (gruppo-classe, collegio dei docenti) altre volte non omogenei (gruppo di laboratorio o di attività speciali). Se a questo si aggiunge l’eccellente strumento “politico” di coordinamento e di discussione pubblica che è la normativa 3 T. Telleschi (2003); su tale modello s’incentra il progetto biennale sulla pace nelle scuole pisane (2002/2003) svolto con finanziamento della Regione Toscana, secondo la L.R. 55/1997. Parte 3 - Prevaricazione e violenza nella scuola 95 organizzativo-didattica sull’Autonomia scolastica e il Piano dell’Offerta Formativa-POF4, allora la scuola può farsi sede paradigmatica ove il pacifismo finalistico si integra col pacifismo istituzionale. Infatti le discussioni che promuove-provoca nei distinti gruppi in classe su temi di rilevanza etico-sociale, quali ad esempio l’aggressività e la violenza, l’ambiente, l’infanzia, rapporti fra gruppi, le relazioni tra le razze, la sessualità e i rapporti di coppia, i rapporti genitori-figli o alunni-insegnante ecc. (secondo la prospettiva propria di ciascuna materia: storia, diritto, filosofia, educazione civica, religione…), sono grosso modo gli stessi temi inseriti nella programmazione degli obbiettivi didattico-professionali del POF che gli insegnanti discutono con i differenti operatori del territorio (famiglie, operatori economici e industriali, mediatori culturali, amministratori pubblici come gli assessori alla cultura e alle politiche sociali, associazioni private e pubbliche, ecc.). Con tali discussioni aperte [“megaloghi” morali, li chiama A. Etzioni 2000, in quanto hanno come fine un’idea di società buona], il POF diffonde nei vari gruppi il senso del valevole e intensifica in essi la percezione dell’esistenza di un legame con “qualcosa” che è più ampio dei gruppi coinvolti nel POF, che è l’appartenenza sociale. L’appartenenza sociale non è però condivisione astratta di principi e obbiettivi, non richiede soltanto una consapevolezza della più ampia società, bensì un senso di responsabilità nei confronti dei conflitti che nascono fra gruppi portatori di differenti interessi. Le condizioni in grado di rendere possibile la solidarietà di intergruppo e il perseguimento del bene comune sono individuate dalla più aggiornata riflessione sociologico-politica nella democrazia deliberativa e nella governance. Aderire all’idea di democrazia deliberativa comporta in primo luogo l’abbandono della definizione liberale di democrazia e di politica, intesa come delega e rappresentanza di decisioni vincolanti per tutti, a favore di un’idea di democrazia che è tale quanto più è capace di assicurare agli individui e gruppi il controllo delle loro possibilità di realizzazione personale (diritti civili, sociali, culturali). In tal senso riconcettualizza il potere, intendendolo come funzione razionale collettiva, poiché combina il diritto individuale alla soddisfazione dei bisogni con il diritto di partecipare alle decisioni su come tale soddisfazione dovrebbe realizzarsi. Per questo fine le procedure della democrazia deliberativa sono sovraordinate da un’autorità legittimata superiore5. Sono per ciò stesso atti politici con cui lo stato, attraverso norme e 4 Il POF nasce con il DPR 275/1997 Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. L’Articolo 3 recita: “Ogni istituzione scolastica predispone il pof. Il pof… esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia… riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale...”. La sinergia scuola-territorio viene consolidata dal D.Lgs. 300/1999, che istituisce un organo collegiale, con rappresentanti dello Stato, Regione e autonomie locali, a cui compete il coordinamento e la valutazione della realizzazione degli obbiettivi programmati. 5 E’ tema fondamentale quello di definire chi dà accesso alla cittadinanza, risponde alle istanze di autodeterminazione delle minoranze sociali; ovvero a chi concerne il ruolo, principale o meno, di attore morale: se allo stato, all’individuo o alle forme sociali intermedie. La risposta della teoria socio-politica cui aderiamo concepisce che il pluralismo delle fonti del senso debba essere governato dallo Stato, a condizione che quest’ultimo si proponga di rafforzare il nesso di diritti e doveri civili, politici e sociali, per ricondurli - tutti - alla superiore idea di benessere collettivo (superiore anche rispetto alle sfere di autonomia di gruppi o minoranze sociali o etniche, anche per fronteggiare i rischi di intolleranza che possono discendere dal pluralismo delle varie forme sociali autonormate): cfr. P. Donati 1998, cap. 7. 96 Comunicazione e Nonviolenza politiche ad hoc (di tipo economico, sociale, culturale), interviene sul livello delle aspettative dei singoli e dei gruppi per coordinarle in una prospettiva cooperativa. In tal senso la democrazia deliberativa include e patrocina la governance delle risorse locali. Local governance vuol dire azioni di politica sociale e culturale mirate ad attivare e ottimizzare le risorse esistenti di un territorio, quelle materiali (beni e servizi: dalla scuola e dalla sanità ai servizi per la prevenzione del disagio sociale etc.) e quelle immateriali (sapere, relazioni interpersonali e sociali) per farne ingrediente centrale di una complessa operazione di reinvenzione di un “tessuto educativo integrato” locale6. Da quanto sopra deriva che, qualora le discussioni pubbliche si tengano, secondo una attenta governance, in ogni ambito di vita (nella scuola, su radio e televisioni locali, tra gruppi di vicinato, tra gruppi dell’associazionismo laico e religioso, etc.) offrirebbero precisi risultati quale antidoto alla violenza, in quanto: a - conferiscono alla capacità di legarsi (“valevole”) una razionalità collettiva di tipo morale; b - creano vincoli e controlli sugli atti degli organi politici chiedendo loro prove di “universabilità” permanente; c - applicano una riconcettualizzazione del potere, ora inteso come funzione razionale collettiva; d - sottopongono riflessivamente al vaglio delle esigenze di contesti più ampi i valori maturati nei micro-contesti come la scuola; e - creano un tessuto educativo integrato locale. Con questi concetti (valevole, “megaloghi”, democrazia deliberativa, governance, società buona), ho tratteggiato il tentativo di impostare una comunicazione morale a partire dal basso dell’istanza etica e delle relazioni sociali7. Per altro verso, con il tema del valevole (privato) che si struttura in valore (pubblico) ho indicato le linee di un modello educativo suscettibile di farsi testimonianza e sperimentazione 6 Come esempi di Local Governance, si vedano i Rapporti (2002) della Provincia di Pisa e della Provincia di Livorno. Sui temi di democrazia deliberativa e di ‘local governance’, si rimanda all'ampia discussione proposta da L. Pellizzoni (2002). 7 V'è qui un paradosso da superare. Come è possibile stabilire una ideale società 'buona' se non disponiamo di un criterio esterno, oggettivo, per “fondare” in maniera solida un primato morale? Con Raymond Boudon (2000) penso che bisogna ammettere che esistono valori e credenze “migliori” di altri. A patto però di saper scegliere dei principi che davvero possano indicare, in forza delle conseguenze attivate, un “progresso morale”: come nella scienza sono le conseguenze che confermano o invalidano i principi, allo stesso modo nel campo morale sono le conseguenze che risultano “buone” nel tempo a giustificare la scelta intuitiva dei principi stessi. Il metro di riferimento sono le conseguenze che derivano dai principi intuitivamente assunti come esplicativi di quelle che poi saranno le conseguenze. La circolarità non è tautologica: le scoperte in campo etico non sono scontate né lo è la loro affermazione, ma quando esse mostrano, sulla base delle loro ragioni intrinseche e alla prova dei fatti, tutta la loro forza, diventa palese il carattere oggettivo e irreversibile. Al proposito Boudon fa l’esempio dell’abolizione della pena di morte, del principio della divisione dei poteri, della democrazia, del suffragio universale: tutte idee sofisticate e complesse ma che hanno superato, nei fatti, obiezioni che sembravano insormontabili in modo che, diventando “giuste”, hanno costituito progresso morale. Parte 3 - Prevaricazione e violenza nella scuola 97 nella scuola8. Per concludere, il modello proposto trova un utilizzo esemplare là dove vigono gruppi dotati di una certa autonomia e dove il potere decisionale è quantomeno in via di decentramento9. Riferimenti bibliografici Alberoni F., Veca S., L’altruismo e la morale, Garzanti, Milano 1988. Aristotele, Etica Nicomachea, vol. I (traduzione e note di C. Mazzarelli), Bompiani, Milano 2000. Baraldi C., Un bambino piange. L’educazione e la cultura dell’infanzia nella società contemporanea, «Rassegna Italiana di Sociologia», n. 3, 2001. Boudon R., Il senso dei valori, Mulino, Bologna 2000. Crespi F., Etica e scienze sociali, Rosenberg & Sellier, Torino 1991. Dahrendorf R., Classi e conflitto di classe nella società industriale, Laterza, Bari 1970. Donati P., Teoria relazionale della società, Franco Angeli, Milano 1998. Durkheim E., L’educazione morale, Utet, Torino 1969. 8 Segnalo un conflitto che l’educazione al valevole può suscitare fra scuola e famiglia. Infatti la differenziazione sistemica vuole che l’educazione espressivo-affettiva (mirante alla personalizzazione-emancipazione) spetti alla famiglia, mentre la formazione cognitiva (che è preparazione ad aspettative di ruolo, di mobilità sociale) spetti alla scuola. La separazione non solleva frizioni solo nei casi in cui l’insegnante svolga con un ruolo impersonale l’educazione affettiva (vedi i casi paradigmatici dell’immaginario sociale messi in evidenza da Baraldi, 2001: quello esemplificato in Mary Poppins a cui non è dato di con-giungere il suo ruolo impersonale di istitutrice rigorosa e austera con la magia personale; quello del Professor Keating del film L’attimo fuggente che unisce la duplice funzione affettiva/formativa solo in quanto trasmette empaticamente le nozioni in occasioni extra-scolastiche). Insomma il conflitto viene tollerato dalla famiglia nel caso in cui l’insegnante utilizza il criterio di personalizzazione emotiva unicamente per far apprendere dei contenuti scolastici (dunque interviene sulle aspettative di mobilità sociale) e non invade il campo delle funzioni di educazione espressivo-affettiva (per questo motivo le formule di life-long education, e-learning, knowledge society sono ben accette dalla famiglia). In definitiva, il sistema scolastico deve sperare nel successo di una personalizzazione affettiva preliminarmente avviata dalla famiglia per poter costruire una formazione efficace. 9 Per un’economia espositiva dobbiamo mettere in nota - pur considerandola primaria - una riflessione sui rapporti di potere tra parti in conflitto. Sappiamo che vi sono conflitti negoziabili e conflitti non negoziabili, e che la loro rilevanza varia se-condo i contesti culturali e la tipologia dei gruppi. La distinzione fra le due categorie non è sempre ben chiara, come ci avverte A.O. Hirschman (1994), perché i temi non negoziabili hanno in genere alcuni elementi che sono negoziabili; viceversa, i conflitti che appaiono sotto la dimensione di essere “più o meno” negoziabili presentano spesso una componente non trattabile. Oltre a ciò, certe relazioni di compromesso sono meno disponibili quando le parti che formano la società sono divise da questioni di religione, di lingua, di etnia o di genere. Per altro verso, comune alle società pluraliste e a quelle in via di un pluralismo democratico è la possibilità di gestire conflitti “familiari”, quelli per i quali esiste una storia nota di rapporti antagonistici (come quelli sindacali, forse quelli localistici), tenendo presente che questa tipologia di conflitti può creare una “mobilitazione” (R. Dahrendorf 1957) proprio in forza della omogeneità culturale di una parte dei contendenti. 98 Comunicazione e Nonviolenza Durkheim E., Le forme elementari della vita religiosa, Edizioni di Comunità, Milano 1963. Etzioni A., Creating Good Communities and Good Societies in «Contemporary Sociology», 29,I, 2000. Hirsch O., I conflitti come pilastri della società democratica a economia di mercato, «Stato e mercato», n. 41, agosto 1994. Lévinas E., Umanesimo dell’altro uomo, Melangolo, Genova 1985. Martinez Gúzman V., Filosofía para hacer las paces, Icaria, Barcelona 2001. Pellizzoni L. , Dilemmi della democrazia nel “Participatory Technology Assessment”, in «Sociologia e Politiche sociali», vol. 5-1, 2002. Saint'Exupéry A. de, Il Piccolo principe, Bompiani, Milano 1978. Salvini A., Ruggeri F. (a cura di), Rapporto sulla programmazione sociale in provincia di Pisa 2002, Osservatorio delle Politiche sociali, Provincia di Pisa/Regione Toscana, Pisa 2002. Telleschi T., Educazione ai valori e formazione continua in Taliani E. (a cura di), Verso nuove dimensioni formative, Seu, Pisa 2003. Parte 3 - Prevaricazione e violenza nella scuola 99 3.4. UN CASO REALE DI BULLISMO Gaetano e Paolo di Paolo S. Nicosia Gaetano è un ragazzino che frequenta da ripetente la prima media inferiore, è un robusto giovanotto che gioca a calcio ed è molto capace nelle discipline sportive, meno nelle altre materie, nonostante sia estremamente intelligente. E’ l’intelligenza vivida e pratica di chi è dovuto maturare prima del tempo in un contesto familiare e sociale difficile: Gaetano è figlio di genitori separati e vive con il padre, in una casa di periferia di una città del sud, assieme al fratello minore. In quella periferia, dove anche le infra-strutture basilari non sembrano essere un diritto, vige la legge del più forte e Gaetano è riuscito a farsi rispettare assumendo un atteggiamento da duro, che gli procura la stima dei suoi pari, in famiglia e delle ragazzine che lo ammirano. Paolo, è poco più di un bambino, perché è andato a scuola con due anni di anticipo (iniziando con la “primina” a 4 anni e poi passando in seconda elementare) e frequenta la stessa classe di Gaetano. Dall’inizio della scuola, cinque anni prima, Paolo è ritornato nel luogo di origine della sua famiglia con i genitori e la sorella, dal nord-est dove è nato ed è cresciuto i primi anni della sua vita. Diversamente da Gaetano, Paolo è di costituzione gracile, non gioca a calcio e, nonostante i buoni risultati scolastici, non riesce a farsi valere e neanche a rendersi simpatico tra i compagni, dai quali viene spesso isolato e richiesto solo per gli aiuti che può dare ai compiti in classe o a casa, mentre le compagne sembrano più sorelle maggiori che chiaramente non lo degnano di considerazione. I genitori di Paolo, pur vivendo in un clima di persistenti tensioni, anche dovute alle difficoltà del reinserimento in un ambiente non congeniale a nessuno dei due, continuano a stare insieme, svolgono professioni di un certo rilievo (insegnante e psicologo) e vivono al centro della città. Come spesso succede in tali casi, Paolo è facilmente diventato la “vittima” nella classe, in particolare è diventato il bersaglio preferito di “particolari attenzioni” di Gaetano, che è il “bullo” della classe e dei suoi sostenitori e non mancano gli insulti, i dispetti, le prepotenze, a cominciare da una mattina quando, nel corridoio di scuola, durante la ricreazione, l’irruenza di Gaetano è sfociata in un vero e proprio attacco alle “diversità” di Paolo. I ragazzi della classe, trasportati dalla forte personalità di Gaetano, stavano intonando le canzoni dialettali della zona quando, vedendo Paolo non partecipare attivamente all’improvvisato coro, Gaetano lo ha sollecitato insistentemente ad unirsi a cantare. Paolo, non cantava insieme con gli altri sia per timidezza, sia perché gli piacevano piuttosto altre canzoni, quelle della zona dove era nato e cresciuto, cantate in un dialetto che a lui suonava molto più dolce e melodioso di quello della zona dove era tornato, le cui espressioni gli suonavano troppo dure, arroganti e comunque estranee, diverse. Così i dispetti di Gaetano si sono fatti sempre più insistenti e mirati alla sua sempre più sentita diversità rispetto a Paolo. Dalle parole forti, alle botte e agli spintoni il passo è stato davvero breve. L’aggressività di Gaetano è andata crescendo, grazie anche al supporto ed incenti- 100 Comunicazione e Nonviolenza vo che gli altri compagni davano alla causa, anche se non si è mai arrivati ad un livello tale da suscitare il clamore che altre simili vicende hanno avuto, arrivando anche a tristi onori di cronaca. La storia si conclude alla fine dell’anno scolastico solo perché Gaetano viene bocciato un’altra volta e si ritira dalla scuola e Paolo prosegue nel suo facile percorso scolastico e nel più complicato processo di maturazione umana, date le sue difficoltà di integrazione nel gruppo di coetanei, la sua eccessiva sensibilità e timidezza e la sua oggettiva piccolezza, di età e di corporatura. Il bullismo non è stato nominato per tanto tempo, nonostante sia sempre esistito, ritengo, nei rapporti tra compagni, tra deboli e forti, come nella vita. Solo dalla fine degli anni settanta, quegli anni in cui Paolo si trovava vittima degli atteggiamenti di Gaetano e degli altri che lo seguivano, il problema esplose in tutta la sua gravità quando in Norvegia si suicidarono due ragazzi che avevano compiuto tale gesto a seguito delle prepotenze subite in continuazione a scuola. Olweus fu il primo a denominare tali comportamenti con il termine “bullismo” e condusse una ricerca sulle prepotenze a scuola su tutto il territorio norvegese e scandinavo tra gli studenti di età compresa tra gli 8 ed i 16 anni: risultò che la percentuale di vittime si attestava vicino al 10% degli studenti, mentre la percentuale dei bulli era intorno al 7%. A risultati simili condussero le ricerche condotte in Gran Bretagna da Smith e Sharp sugli studenti delle scuole medie, mentre allarmante fu il dato ricavato dalle scuole elementari, con il 27% di studenti che ammetteva di essere stato vittima di prepotenze ed il 12% di prepotenti. Addirittura in Italia gli studi condotti da Genta-Menesini-Fonzi-Costabile portavano al 40% la percentuale delle vittime di abusi nelle scuole elementari, con il 20% di bulli, mentre nelle scuole medie le percentuali scendevano, rispettivamente, al 30 e 15%1. La definizione rimane la stessa di quella data all’inizio da Olweus: “Si dice che una persona subisce una prepotenza quando viene continuamente esposta ad azioni negative da parte di una o più persone”, per cui un ragazzo (in evidente stato di inferiorità, fisica o psicologica o anche semplicemente numerica) subisce prepotenze quando “un altro ragazzo o un gruppo di ragazzi gli dicono cose cattive o spiacevoli. E’ sempre una prepotenza quando un ragazzo riceve colpi, pugni, calci e minacce, quando viene rinchiuso in una stanza, oppure quando riceve bigliettini con offese e parolacce, quando nessuno gli rivolge mai la parola e altre cose di questo genere”. Tutte cose che Paolo aveva conosciuto sulla sua pelle, sia come prepotenze dirette alla sua persona, sia sotto forma di esclusione e di isolamento, a seguito dei comportamenti di Gaetano (che si potrebbe definire il bullo “attivo” della classe) e degli altri (cosiddetti bulli “passivi”, che partecipavano alle iniziative di Gaetano, prendendovi parte come gregari, anche se ai danni della stessa vittima). Al momento delle prepotenze Paolo si sentiva solo ed abbandonato, non aveva amici e veniva lasciato spesso solo alla ricreazione. Rimaneva debole fisicamente e non partecipava ai giochi di gruppo, né alle partite di calcio: la sua debolezza e vulnerabilità sembrava aizzare ancor di più i suoi persecutori. Paolo viveva la scuola come un luogo di tormento, anche se riuscì a mantenere alto il livello di concentrazione e di rendimento scolastico che, per quanto aumen1 Dati tratti da Anna Costanza Baldry Bullismo a scuola e mediazione tra pari, in Pisapia G. e Antonucci D. (a cura di). La sfida della mediazione, pp. 149 e seg. Parte 3 - Prevaricazione e violenza nella scuola 101 tasse i motivi di attacco o di sfruttamento da parte del gruppo dei bulli, almeno non faceva precipitare del tutto il suo livello di autostima. Questo fu un elemento di diversità rispetto alle “classiche” risposte delle vittime di bullismo scolastico, assieme alla capacità di comunicare tali difficoltà, sia ad alcuni docenti, che non facevano finta di niente come altri, sia ai genitori. Purtroppo le iniziative degli insegnanti più attenti si limitavano alla ripresa o all’esortazione verbale diretta a Gaetano e ai suoi gregari, che poi ricominciavano magari più di nascosto. Quello che invece andò bene fu la comunicazione tra Paolo, i suoi genitori e gli insegnanti più attenti: queste figure riuscirono ad infondere fiducia nelle capacità di Paolo, stimolandolo anche ad esperienze all’estero che fecero vedere i loro buoni frutti nel tempo. La storia quindi non ha avuto un classico “lieto fine”, se non nel tempo, quando si è visto che le debolezze fisiche e relazionali di Paolo non sono state un limite alla sua crescita umana e professionale, che anzi ha dato risultati superiori a quelli che, dati i presupposti, ci si poteva aspettare. E questo principalmente perché la comunicazione (che è stata uno dei motivi di insorgenza di questa conflittualità, per le diverse modalità espressive di un bambino “di buona famiglia” ed un “bullo di periferia”) è stata poi gestita come risorsa, sia da insegnanti di Paolo che dai suoi genitori. Se fossero esistiti allora i servizi di mediazione scolastica, il caso sarebbe stato passibile di un tentativo del quale non potremmo conoscere gli esiti perché non c’è stato, ma del quale tratteggieremo (nel paragrafo seguente) gli elementi di analisi, sulla scorta degli studi che sono stati fatti da un quarto di secolo a questa parte sul bullismo a scuola e sullo sviluppo dei servizi di mediazione scolastica. Una possibile analisi del caso di bullismo descritto Ma vediamo come si sarebbe potuta condurre una mediazione scolastica, analizzando la situazione secondo le griglie comunemente utilizzate nelle esperienze di mediazione scolastica che da alcuni anni si stanno sperimentando anche in Italia. Si immagina quindi il possibile intervento di un mediatore o di una mediatrice, interni alla struttura scolastica che frequentavano Paolo e Gaetano o esterni ad essa, chiamati per facilitare la soluzione del caso di prevaricazione descritto, una volta che lo stesso fosse stato comunicato dalla vittima ai propri insegnanti e da questi al responsabile della struttura e si fosse attivata la procedura, con accettazione dei due protagonisti. Partendo dall’analisi dei bisogni di Gaetano, il mediatore o la mediatrice designati avrebbero sicuramente evidenziato l’importanza dell’affermazione per il ragazzo all’interno del gruppo, notando proprio in questa continua ed insistente smania di leadership, la sua ricerca di autostima, e ricerca del rispetto altrui. Durante i colloqui con Gaetano potevano emergere importanti e non sottovalutabili aspetti emo-zionali e psicologici del ragazzino che, dalla separazione dei genitori e nel contesto sociale difficile nel quale viveva, avrebbe più volte creduto di essere investito di responsabilità “genitoriali” nei confronti del fratellino più piccolo, più timido ed introverso di lui e sociali nei confronti della famiglia, non essendo il padre un “bullo” a sua volta. Queste sarebbero potute emergere come le motivazioni profonde per le quali Gaetano spesso ostentava la propria aggressività, credendo di poter grazie alla propria forza, un forte punto 102 Comunicazione e Nonviolenza di riferimento per il fratello ed una difesa per la famiglia, oltre che un modello “sociale”, pur caratterizzato da aspetti negativi, che però in un contesto di prevaricazione diffusa si dimostrano spesso utili non solo a difendersi, ma anche a farsi rispettare e perfino ammirare. Per questi motivi, in più episodi, Gaetano è stato giustificato da alcuni insegnanti (“è solo un ragazzino un po’ vivace”) e le punizioni più o meno severe inflitte da altri insegnanti hanno riportato risultati tendenzialmente limitati al caso specifico, ma spesso controproducenti, perché mancava quella fondamentale componente comunicativa che è l’ascolto, in tal caso dei reali problemi di Gaetano e del suo modo violento di rispondere alle sollecitazioni esterne. Dopo alcuni incontri con la madre, la mediatrice ha sollecitato l’esigenza di un colloquio con entrambi i genitori di Gaetano, notando che il possibile conflitto occasionale ed evidente (la violenza nei confronti di Paolo), era probabilmente nato da un conflitto ben più profondo e non analizzato, quello scaturito dal rapporto dei due partner sulla gestione dei figli dopo la separazione. Non è raro, quando si analizzano le situazioni, trovarsi a fare i conti con dei conflitti interni più profondi non ancora risolti, o peggio ancora non ben evidenziati. Dagli incontri con Paolo, il mediatore o la mediatrice avrebbero potuto individuare bisogni riconducibili all’esigenza di difendersi da ogni forma di discriminazione, violenza psicologica e fisiche e possibili emarginazioni future. Anche Paolo, peraltro, come Gaetano, e come ogni altro bambino o ragazzino, aveva bisogno della propria affermazione all’interno del gruppo, ricercando in esso la propria accettazione. Paolo avrebbe potuto comunicare al mediatore o alla mediatrice, di aver sofferto molto per quegli atteggiamenti subiti, non avrebbe mai pensato che la propria diversità, o comunque la diversità in genere avrebbe potuto essere oggetto di violenze. Disagio, paura, impotenza, rabbia, consapevolezza della diversità e voglia di affermazione, sono questioni emozionali importanti, che Paolo avrebbe espresso, come in effetti nella realtà fece all’interno della sua stessa famiglia. La stessa famiglia, in effetti, risentiva comunque della situazione di disagio di famiglia migrante in un altro contesto socio culturale, pur essendo quello di origine e pur trasferendosi con uno status ed una rispettabilità indiscusse, ma comunque portatrici di elementi di differenziazione non facili da integrare, anzi da reintegrare in un contesto comunque difficile a livello generalizzato, caratterizzato comunque da una cultura chiusa e rigida. In tale vicenda però la famiglia fu un punto forte per Paolo, di riferimento, condivisione, partecipazione e gestione delle problematiche, grazie ad una comunicazione a tutto campo, aperta all’ascolto, all’accompagnamento, al sostegno reciproco, condividendo comunque valori e situazioni di fondo. Se Paolo non avesse avuto modo di comunicare all’interno di una famiglia dove trovava accoglienza e sostegno, solo la sensibilità e l’accortezza da parte di docenti (ed eventualmente compagni) sensibili sul versante della mediazione avrebbero potuto recuperare in positivo quello che il conflitto poteva causare in Paolo in termini di sfiducia e di chiusura. Parte 3 - Prevaricazione e violenza nella scuola 103 Riferimenti vivliografici Baldry A.C., Bullismo a scuola e mediazione tra pari, in Pisapia G. e Antonucci D. (a cura di), La sfida della mediazione, CEDAM, Padova 1997. Buzzi I. (a cura di), La Mediazione Scolastica. La Risoluzione Positiva dei Conflitti in Ambito Scolastico,Edizioni Carlo Amore, Roma 2003. Jefferis-Duden K., Mediatori efficaci. Come gestire i conflitti a scuola, La Meridiana, Molfetta 2001. Martello M., La mediazione, una risorsa per la scuola, in Pisapia G. (a cura di), Prassi e teoria della mediazione, CEDAM, Padova 2000. Nigris E., I conflitti a scuola. La mediazione pedagogico-didattica, Bruno Mondadori, Milano 2002. S. Pinna, M. Spissu, G. Spissu (a cura di), Mediare e prevenire nella scuola, Punto di Fuga, Cagliari 2003. Parte 4 La violenza nei media Parte 4 - La violenza nei media 107 4.1. COMUNICARE LA MORTE QUANDO TORNA LA “VECCHIA ATTRICE” (Robert Capa) di Paolo Archi 4.1.1. “La guerra è come un’attrice che invecchia. E’ sempre meno fotogenica e sempre più pericolosa” (Robert Capa, «Life», 1944). La guerra in Irak (la vecchia attrice di Capa) ha riproposto al tempo del digitale antiche questioni che travagliano il fotogiornalismo di guerra dal tempo del famoso progetto Harvest of death portato avanti da Mattew Brady nella guerra civile americana, periodo in cui storiograficamente nasce la documentazione fotografica della morte in battaglia. Si cominciò allora, circa centocinquanta anni fa, a ricomporre e presentare, secondo i dettami del nascente pittorialismo, i pietosi resti dei cadaveri nordisti e sudisti, per far riflettere l’opinione pubblica americana, abituata a vedere la morte solo nei quadri e nelle incisioni. Ma la morte, nelle foto di Brady e del suo gruppo, è al servizio di un’ideologia pacifista: i cadaveri messi in fila, con un chiaro riferimento ai mucchi di grano falciato, le facce rivolte a terra tranne una, il fucile e la fiaschetta accanto al morto isolato; la messa in scena è un richiamo intelligente ad un paesaggio agricolo “straziato” che scatena orrore e riflessione sulla strage fratricida (si vedano le fotografie nella sezione “American memory collection” del sito della Library of Congress). Per circa cento anni, fino agli anni Settanta ed alla splendida stagione dell’ultimo «Life» (con Larry Burrows, Nick Ut ed i grandi testimoni della tragedia indocinese) la morte analogica della fotografia tradizionale ha scandito tappe importanti della cultura, della storia e dell’arte del Novecento. Come è noto, sono state proprio le grandi inchieste fotografiche sulla tragedia indocinese ad influenzare un’importante stagione del cinema di guerra legato alla New Hollywood, ma anche a far mutare in modo sostanziale l’opinione pubblica americana. Oggi, nel 2003, ai tempi della nuova guerra in Irak, non è tanto lo sviluppo tecnologico della fotografia digitale (nella sua variante wireless di questi ultimi mesi), quanto la stessa straordinaria “morte della morte” nella nostra post-modernità occidentale ad alterare profondamente la raffigurazione del trapasso. E’ quindi inutile fare, come Susan Sontag in Davanti al dolore degli altri, un appello alla capacità della fotografia di emozionare ancora (“the ability of shock”), o prendersela, come Baudrillard, con la capacità dell’infotainment di fagocitare e trasformare in simulacro ogni presenza della morte reale nell’universo dei media. La questione non riguarda il mondo virtuale, ma la storia reale del nostro tempo: nell’universo occidentale si è verificata lo sradicamento della soglia più importante dell’esistenza, ne abbiamo coscientemente cancellato simboli, immagini, silenzi, parole, comportamenti rituali ed icono-logie. La negazione contemporanea del morire, la sparizione del dolore e del lutto, la fine del senso di colpa dei superstiti ed invece la sua corposa e fascinosa presenza in altre civiltà a noi contrapposte, come quelle delle culture meno sviluppate, crea ed approfondisce un baratro, un vero e proprio digital divide (non sul piano tecnologico ma delle idee), che distrugge una forma comunicativa ed artistica fondamentale, come quella dell’icona fotografica, ed impedisce una 108 Comunicazione e Nonviolenza visione culturale comune ai vari popoli: da qui la necessità di ritrovare delle nuove figure di visual storytellers capaci di risignificare la morte nostra e loro, per creare un ponte fra le diverse civiltà, ma soprattutto per ridare senso all’esistenza nell’emisfero occidentale1. La cultura americana, per certi versi molto più pragmatica e meno ideologica della nostra, non esita a trovare nuovi impieghi per il fotogiornalista di guerra. Peter Howe, presentando il suo Shooting under Fire: The World of the War Photographer (2002), si accontenta del fatto che le fotografie sulle ultime guerre sono accolte come prove al tribunale sui crimini contro l’umanità. 4.1.2. E’ un falso luogo comune il discorso che la guerra e la morte siano state per anni, con la fotografia analogica, legate alla verità di un’istantanea, mentre adesso, con il digitale, tutto sia più ambiguo e sfuggente e quindi anche la morte possa essere falsificata. Quindi il problema del vero/falso nella fotografia, come si è presentato anche nella ultima guerra in Irak (come vedremo più avanti) e che costituisce una delle questioni più attuali riguardanti la fotografia digitale, è assolutamente ininfluente riguardo alla morte: già dai tempi della guerra civile americana, dietro la fotografia della strage, c’è spesso una regia che compone abilmente una “diegesi” narrativa, proprio perché l’istantanea non deve cogliere (alla Cartier-Bresson) solo un “momento decisivo”, ma dare a quello un senso che carichi la morte del rispetto e del significato ideologico ed esistenziale di un’intera generazione. Ecco che la famosa fotografia di Robert Capa sul miliziano spagnolo, Icona universale, può essere benissimo un falso clamoroso, il suo senso nella storia resta quello di un Novecento dove era importante morire per la libertà della Spagna2. Ed il soldato di Eugen Smith, con il bambino appena nato in braccio, arriva ad un livello compositivo forse ancora più sottilmente manieristico, poiché, alla fine della seconda guerra mondiale, può solo significare l’uscita dalla guerra con il rilancio della vita e dell’amore3. La fotografia di Nick Ut nel Vietnam (Ohan Thi Kim Phuc in Vietnam napalm, 8 giugno 1972), altra testimonianza fotografica esemplare del nostro secolo, testimonia il momento in cui la vita trae valore dalla morte: la composizione ha uno schema classico, tripartito, e la bambina con le braccia aperte richiama apertamente un immagine di Cristo sofferente. 4.1.3. Il primo assaggio del tempo vuotato dalla morte parte dalla propaganda militare degli Usa. Se si vede il sito dell’esercito americano (www.army.mil., nell’archivio della sezione “army images”), una breve e facile ricognizione ci presenta (nel corso degli anni, dal 1999 al 2003) un prevalere crescente delle fotografie stile “Rambo” con soldati (sia uomini che donne) armati che mirano a imprecisati nemici o si allenano su sentieri impervi con evidenti richiami (poco ironici né critici) non tanto al grande cinema pacifista, ma ai videogiochi di guerra. I soldati che curano, portano in braccio bambini o soccorrono civili vanno via via perdendo campo: la morte monetizzata è presente solo in un afgano, che sventola dei dollari ricevuti come compenso per la morte del congiunto colpito da fuoco amico. 1 Per un sunto intelligente della questione si veda Urbain J.D., Morte in Enciclopedia Einaudi, vol X, Torino 1980, pp. 519-555). 2 Si veda il capitolo Il miliziano colpito a morte in Kershaw A., Robert Capa, Rizzoli 2002, Milano. 3 Wounded Dying Infant Found by American Soldier in Saipan Mountains, Giugno 1944, in Smith W.E., Masters of Photograph, Koneman 1999. Parte 4 - La violenza nei media 109 Tuttavia, dopo la grande stagione vietnamita, le guerre successive sembrerebbero contraddire profondamente il nostro assunto critico: quella iugoslava degli anni Novanta è stata coperta mirabilmente dal gruppo dei “Seven” (una specie di remake della Magnum, nel quale sette grandi fotografi si autofinanziano e scelgono autonomamente quali inchieste coprire). Le immagini di C. Morris (www.viiphoto.com) e dei suoi sodali spaziano dalla Bosnia alla Cecenia ed alle guerre dimenticate in Africa: immagini terribili dove il morto è già isolato dai vivi, e si comincia a preferire l’immagine simbolica del corpo fatto a pezzi. Eppure è proprio la guerra nei Balcani ad aver suscitato le più aspre polemiche, con i fotoreporter scatenati alla caccia dei cervelli spappolati e beccati dalle galline. Da quel momento Uliano Lucas, il decano dei fotogiornalisti italiani, ha accusato le nuove leve di farsi “paparazzi del dolore” per poche lire, interpretare la tragedia dei vari conflitti solo in termini di scoop terrificante. Da questa accusa (che nel mondo anglosassone ha preso l’indicazione dispregiativa di war pornography) non è stato indenne nemmeno il grande James Nachtwey (drammatico il portfolio presentato nel suo Inferno, 2000), che per «Time» ha coperto l’Aids in Africa e guerre sparse per i diversi continenti. La sua tecnica di accostarsi alla morte quasi come per fare una macro (una mano bruciata, un teschio, un povero resto indefinibile) ha portato all’estremo la famosa affermazione di Capa (se non viene bene la foto vuol dire che sei troppo lontano): anche il più concerned dei fotografi deve al tempo stesso, per le leggi dell’infotainment, produrre nello spettatore uno shock terrorizzante, ma seduttivo per la sua tecnica raffinata e la bellezza estetica dell’immagine. Queste morti atroci, viste in fotografia, perdono radicalmente ogni legame con lo spazio, con il tempo, con la storia, fanno il pari con il più “immediato” (nel senso letterale che cancella il ruolo del media) effetto speciale cinematografico che affascina lo spettatore: sei lì sopra e addosso al morto, o al suo pezzetto di carne, e proprio perché è così non c’è più una storia, un contesto, un legame visuale con la morte né sua né tua; l’iperrealismo riesce a cancellare la realtà, la pornografia di guerra ottiene lo scopo di dis-locare la morte dal suo specifico storico. C’è inoltre un uso meno nobile della guerra, ma non meno frequente, che è quello della pressante finalità politica, oggi incalzante a causa delle tecniche digitali che permettono spesso delle volgari contraffazioni. Brian Walski (fotografo del «Los Angeles Times», 31/03/03) è stato licenziato in tronco perché ha ritoccato una fotografia della seconda guerra in Irak, facendo sì che un soldato inglese indicasse a dei civili di proteggersi, mentre in realtà era del tutto indifferente a loro. Ed un civile irakeno, con una bambina ferita in braccio, per l’«Unità» (22/03/03) è diventato un padre disperato con la figlia morta. Questi ultimi casi (specie la fotografia dell’AP cambiata dalla didascalia del quotidiano italiano), ci confermano che sulla morte si può speculare politicamente proprio perché, ormai, se ne ignora il senso profondo di collegamento con le radici antropologiche di ciascun popolo. 4.1.4. Restando sempre nell’attuale guerra irachena, che mi ha dato spunto per queste riflessioni, voglio citare invece un caso controcorrente, di chi comincia a fare considerazioni simili alle mie direttamente “sul campo”. Il fotografo indipendente Peter Turnley4 aveva testimo4 Vedi il suo bellissimo servizio “The Unseen Gulf war” by P.T., nel «Digital Journalist» del dicembre 2002 visibile in www.Thedigitaljournalist.org. 110 Comunicazione e Nonviolenza niato - abusivamente perché, si ricordi bene, erano stati accreditati solo otto fotografi nel primo conflitto anti-Saddam - quell’incredibile vicenda del “Death mile”. Si trattava di quella strada della morte fra il Kuweit e Bagdad piena di corpi bruciati, con gli autocarri intatti, colpiti da chissà quale nuova arma americana, una strage orrenda in pieno stile pornografico. Invece dieci anni dopo, Turnley, nell’aprile 2003, è andato in Irak a testimoniare la morte altra, quella del dolore e dei cortei dei parenti, uno stile fotografico completamente diverso, dal di dentro delle case e del lutto della popolazione civile5. Ha acquisito quel senso più profondo di cui parlava Sebastiao Salgado, nelle bellissime foto della morte dei bambini fra i Sim Tierra brasiliani. Non c’è pietismo in lui, la morte nel Sud del mondo è rito, magia, manifestazione sociale e fatto naturale al tempo stesso6. Questi fotografi ci ricordano un po’ i funerali ed i “consoli” dei grandi neorealisti alla fine degli Cinquanta, Pinna e Gilardi, quando, al seguito di Ernesto De Martino, giravano il Meridione, la “terra del rimorso”, per i quali la morte, la sua rielaborazione nelle civiltà contadine, era uno dei modi per reagire e difendersi dalla devastante modernità proveniente dal Nord. La fotografia è stata sempre uno strumento per testimoniare un momento irripetibile, ma in questo ca-so, nella raffigurazione della morte, deve tornare ad essere uno motivo di unione della family of men (vi ricordate la famosa esposizione di Edward Steichen del 1955?). Bisogna, superando il crescente digital divide, offrire anche agli altri la possibilità di esprimere, con gli strumenti della cultura visuale, la loro visione dell’ultimo passaggio, perché in tal modo la riscopriremo anche noi. James Nachtwey, nel suo notevole portfolio sull’11 settembre (www.time.com), ci presenta la nuca di un uomo (soldato o pompiere) che guarda un muro, quel pezzo dolorante di New York pieno di nomi e richieste di notizie sui morti degli attentati: il fotogiornalista occidentale vede un futuro di scontro, di morte e di devastazione per la nostra civiltà digitale. Anche Edgar Roskis7 ha dato per spacciato il fotogiornalismo, annegato nel conformismo e, aggiungerei io, negli schizzi di sangue che abbiamo visto nei telefonini wireless dei fotografi embedded colpiti da fuoco amico o nemico che sia. Non sarei tanto pessimista, la fotografia non è ancora ridotta ad un’ arte bellissima, come le vetrate delle cattedrali gotiche, ma del tutto scomparsa nella sua versione sociale. Rimettiamo al centro dell’immagine fotografica la rappresentazione dei momenti chiave dell’esistenza umana, la morte, la vita, la solitudine e lo stare con gli altri, senza paura né di adoperare la nuova strumentazione digitale, né di ibridarla con altri o nuovi media; essa riprenderà forza e vigore anche nella società della simulazione e dell’insignificanza. 5 cfr. Seeing Another Gulf War, particolare la fotografia della Mother of Mohammed Bassin sempre nel Digital Journalist. 6 www.terra.com.br/sebastiaosalgado. 7 Tant de clichés et si peu d’images, «Le monde diplomatique», gennaio 2003. Parte 4 - La violenza nei media 111 4.2. LA RIDUZIONE POLEMICA DEI PROCESSI ECONOMICI di Carlo Catarsi 4.2.1. Azione in scenario La riflessione sugli aspetti veritativi della comunicazione giornalistica è ancora del tutto aperta e costellata di esiti “indecidibili”. Con buona approssimazione, si può stabilire che costante generatore di indecibilità permane la distanza epistemica emergente fra operazioni analitiche prodotte, sopra un medesimo messaggio, ai distinti lati della sua emittenza e della sua ricezione. Se lo statuto di “oggettività” di indagini inerenti gli “effetti comunicativi” deve essere perciò attentamente relativizzato, è comunque lecito produrre osservazioni ed ipotesi sull’esistenza di connettivi fra emittenza e ricezione, oggettivamente desumibili dal testo trasmesso ed imputabili all’intenzionalità dell’emittente. In particolare, è lecito domandarsi se messaggi costruiti con un dimostrabile intento di “legare” comunicativamente il ricettore (con strategie che talvolta si approssimano al double bind) abbiano effetti pragmatici comparabili a quelli di messaggi esposti tramite una logica meno “catturativa”. Il rilievo di dati oggettivi a livello di emittenza implica, ovviamente, la possibilità di un bilanciato accertamento sul lato della ricezione. (Propongo cautele forse scontate, ma alcune reazioni di diniego, manifestate con micro-comportamenti e trattenuti cenni di critica durante l’intervento da me svolto al Convegno, mi fanno pensare che proprio i sostenitori di metodologie interattive siano talora tentati da esiti di relativismo ermeneutico, volti alla quasi-esclusiva collocazione del significato sul versante del ricettore). Distanziandomi un poco dal clima accaldato ed affollato di alcune pubbliche sessioni delle trascorse Giornate Fiorentine, torno quindi a proporre - in margine ad alcune rilevazioni, ancora artigianali, su stilemi editoriali del più diffuso quotidiano nazionale di informazione economica («Il Sole 24-Ore») - un semplice interrogativo epistemologico: l’emittente che costantemente abbina - all’interno di un genere narrativo connotato, sul versante del ricettore, da particolari aspettative di “informazione” (o “aspettative cognitive”) - un certo tipo di azione con un determinato scenario di conseguenze, non assume forse la “responsabilità” comunicativa (congiunta alla propria “autorità” di emittenza) di dare oggettiva rilevanza ad un preciso nesso causale fra le classi di azione connesse? Per esemplificare, l’abbinamento dell’azione orientata alla fabbricazione di un burattino di legno con lo scenario consequenziale delle avventure di Pinocchio configura ed oggettiva nessi causali plausibili nel contesto del genere narrativo “fiaba a sfondo familiare” (o simili). Assumendo questa prospettiva di genere1, Carlo Lorenzini, detto Collodi, può essere considerato “autore” ed “informatore” narrativamente credibile. Un immenso pubblico di lettori di varia età ed appartenenza socio-culturale ha infatti seguito, appreso e diffuso il testo di Collodi, prendendolo ad ispirazione per “variazioni sul genere” che sono comunque ricon1 Per una rapida attualizzazione del concetto di “genere discorsivo-narrativo”, si vedano Jensen (1999) e Cavalli (2003). 112 Comunicazione e Nonviolenza ducibili al medesimo prototipo. Se qualcuno ci suggerisse invece che la narrazione del Collodi è fondamentalmente da inquadrare secondo il genere “automi ribelli” (tipo Golem, Mr. Hyde, Frankenstein ecc.), avremmo forse qualche difficoltà a giustificare l’universale successo di Le avventure di Pinocchio e la sua tipica connotazione di classico letterario. Quando poi, come ha fatto recentemente un vescovo cattolico (per la precisione, l’Arcivescovo di Bologna Cardinale Biffi), si volesse interpretare la narrazione di Collodi come un’allegoria della redenzione del “figlio dell’uomo” attraverso una rifigurazione delle vicende della “sacra famiglia” di Nazareth (con Geppetto e la Fata Turchina quali trasformazioni archetipiche di Giuseppe e di Maria), crescono le difficoltà a dimostrare, per tale chiave interpretativa, la ricezione universale della fabula originaria. Sarebbe infine quasi del tutto implausibile connettere, nella sequenza narrativa di Collodi, l’azione di fabbricare un burattino di legno con uno scenario di conseguenze causate dalle particolari qualità magiche del legno di pino (dato che, come tutti abbiamo letto e come la denominazione “Pinocchio” evidenzia, si racconta che il burattino venne fabbricato proprio con un pezzo di questo tipo di legno). Gli slittamenti al genere discorsivo-narrativo degli “automi ribelli”, dell’allegoria evangelica ed infine del “legno magico” sono insoddisfacenti non in base ad una presunta ortodossia interpretativa, ma perché risultano tutti, nel caso specifico, variazioni parziali del più ampio e comprensivo genere “fiaba a sfondo familiare”. Il filo discorsivo-narrativo di Collodi si lascia seguire perché imbastito delle avventurose trame che una relazione parentale comporta. A questo filo si possono attaccare anche fantasie sugli “automi ribelli”, meditazioni su Gesù Bambino o decantazioni delle magiche virtù del pino silvestre: prototipo comunicativo generico resta il primo ed è anzitutto sugli esiti delle trame parentali prodotte che noi ci rendiamo ascoltatori, partecipi e complici dell’autore Collodi. Il quesito - come il lettore osserverà - non evoca lo spettro del nesso causale “meccanico”, o false naturalistic, all’interno di relazioni socio-culturali (nesso peraltro sepolto, specialmente nel campo dei cultural studies, da un imponente strato di critiche, che è superfluo ricordare). Esso piuttosto rinvia all’esame dei vincoli cognitivi che basilarmente costituiscono il legame fiduciario fra emittente e ricettore: una fiducia che, fra l’altro, si fonda e si rinnova sul manifesto rispetto di aspettative cognitive (Luhmann, 2002; Bourdieu, 2003). Ma che cos’è il rispetto delle aspettative cognitive se non adeguatezza e coerenza in ordine alla logica pragmatica del genere di narrazione volta a volta assunto ed attuato? E’ vero che nella comunicazione (animale, codificata su base automatica, ma soprattutto di carattere socio-culturale) è possibile l’“ironia infinita” della relativizzazione delle cornici (frames of reference) e delle revoche successive del senso comunicativo iniziale (Borrelli, 1995). Ma l’ironia infinita, per mantenere natura di processo socialmente identificabile, conoscibile e valutabile, non può essere nel contempo indefinita: ogni slittamento di cornice ed ogni passaggio di genere narrativo, se non sono in qualche modo demarcati da un segno di intesa culturale (chi può dimenticare la differenza funzionalmente essenziale riconosciuta da Geertz fra lo strizzare l’occhio per un tic nervoso ed il farlo invece con l’intento di una complice allusione?), si perdono in una deriva comunicativa indistinta. Le cornici in cui sono iscritti gli abbinamenti fra azioni e scenari consequenziali fanno parte di “generi discorsivi” che possono essere creativamente elaborati, ma non senza tener conto di elementi e di regole contrattuali, precedenti le Parte 4 - La violenza nei media 113 rielaborazioni attuali, che costituiscono il fondo cognitivo di prototipi comunicativi consolidati. Si ripropone cioè qui , in modo ricorsivo, una dialettica analoga a quella che trascorre fra la metafora ed il referente realistico di cui la metafora è traslato: senza tener conto del “gioco” (qui da intendersi nell’accezione di game, non di play) fra tale referente ed il prodotto metaforico, il senso del traslato non ha consistenza logico-comunicativa. 4.2.2. Uno scenario para-bellico per l’agire economico Dalla più famosa opera di Von Clausewitz (Della guerra) è stata diffusamente desunta la massima che la “guerra è un modo di continuare la politica con altri mezzi”. Più incisivamente, il senso dell’accostamento fra le due sfere d’azione significa che entrambe sono iscrivibili nel genere dell’agire strategico e che sono perciò sempre possibili e coerenti, all’interno di un medesimo decorso progettuale, gli slittamenti dall’una all’altra sfera. Un imponente repertorio di cronistorie - da Erodoto ai Bignami di nostra scolastica memoria - conferma la “regola descrittiva” di Von Clausewitz. C’è però da sottolineare che, nel pensiero dello stratega prussiano, lo stereotipo dello slittamento non ha soltanto un senso retrospettivo, ma anche prospettico: in altre parole, legando descrizione e prescrizione attraverso esemplificazioni rese in forma di racconto storico, Von Clausewitz fa del suo connettivo narrativo un insegnamento che congiuntamente rivolge a leaders politici e militari: disponetevi a progettare e ad agire, vicendevolmente e senza soluzioni di continuità, fra guerra e politica. Ma quale genere discorsivo-narrativo si produce, quando connessioni fra classi di azioni e di scenari consequenziali, tipiche dei bollettini di guerra, si trasferiscono costantemente nell’informazione inerente i conflitti politici, sportivi ed economici? E, circoscrivendo, quali prospettive di ordine causale si possono oggettivamente trasmettere, quando la cronaca economica sia quotidianamente costruita come un campo di mosse a somma zero, dove la sopravvivenza di singoli attori/agenti in conflitto è decisa in forza dei rispettivi coefficienti di accelerazione commerciale, resi con un lessico descrittivo di carattere meccanico o termodinamico? Non è questa forse la base logico-linguistica di una cronaca inclinata ad esiti polemogeni? Abbiamo un testo giornalistico prevalentemente caratterizzato secondo lo schema semiotico e lo stile linguistico sopra definito in corsivo: si tratta di quel nucleo che, nel quotidiano «Il Sole 24-Ore», è costituito dalla prima pagina e dalle successive due della rubrica “In Primo Piano” (periodo di rilevazione: gennaio-maggio 2003). Considerati i limiti editorialmente prescritti alla presente comunicazione (e che auspichiamo universalmente rispettati), è inopportuno aprire qui un resoconto dettagliato dell’analisi di contenuto finora condotta: i dati documentativi, rapidamente esposti durante le Giornate, sono disponibili a parte (anche per diretto accesso del lettore alla fonte giornalistica). Ad oggi, è stato posto un quesito di ordine epistemico ed è stato indicato un esempio di riferimento: a mio parere, il tutto è sufficiente per avviare una precisa riflessione. 114 Comunicazione e Nonviolenza 4.2.3. Riferimenti bibliografici Borrelli D., Ironia senza limiti, Costa & Nolan, Genova 1995. Bourdieu P., Il mestiere di scienziato, Feltrinelli, Milano 2003. Cavalli N., Sociosemiotica e generi comunicativi: una proposta per analizzare la comunicazione Web, in «M@gm@», vol. 1, n. 4, 2003. Jensen K. B., Semiotica sociale dei media, Meltemi, Roma 1999. Luhmann N., La fiducia, Il Mulino, Bologna 2002. Parte 4 - La violenza nei media 115 4.3. IL PARADOSSO DELLA COMUNICAZIONE DEI BUONI di Andrea Volterrani “…Viviamo in un epoca in cui non è più possibile scherzare. Non è dato immaginare qualcosa che, per quanto ridicolo, non si trasformi subito in realtà sotto i tuoi stessi occhi…”. Tom Wolfe, A caccia della bestia da un miliardo di piedi. 4.3.1. L’origine del paradosso Pietà, compassione, disgrazia, sfortuna, casualità. Sono queste cinque parole chiave con le quali si affrontano anche attraverso la comunicazione sociale temi e problemi strettamente collegati e collegabili con la vulnerabilità e l’esclusione sociale. Per questo il panorama mediale della comunicazione sociale tende ad essere buono, comprensivo, apparentemente accogliente. Ma l’essere, o meglio il pensare di essere “buoni” fa spesso riferimento alla mappa concettuale disegnata dai quei concetti senza che si sia riflettuto sufficientemente sul loro significato e sulle conseguenze possibili. Esistono due nodi che non sono stati sciolti. Innanzitutto non ci si pone il problema delle relazioni fra i tre mondi (pensiero, linguaggio, realtà)1 e della complessità di analisi e comprensione dei concetti nuvola (Piasere, 2002). Spesso non si tiene conto che, per poter costruire comunicazione sociale (ma anche comunicazione in genere), è necessario acquisire la capacità di: a) di spostarsi in modo sensato da un mondo all’altro; b) di “tradurre” concetti e situazioni complesse nei vari mondi. In secondo luogo non ci accorgiamo che quel tipo di concetti, in una società aperta che pone al centro l’individuo, rischia di provocare danni ben maggiori di quelli generati da atti intenzionalmente violenti da un punto di vista comunicativo. I processi che portano alla vulnerabilità e successivamente all’esclusione sociale agiscono spesso in modo integrato nelle varie sfere della vita e, soprattutto, con una gradualità che provoca micro-fratture nell’esperienza di vita di un singolo individuo (Castel, 1995). Queste micro-fratture spesso sono interpretate e confermate da coloro che circondano l’individuo (familiari, colleghi di lavoro, amici, conoscenti, etc.) proprio attraverso quelle categorie che anche la comunicazione sociale tende a riproporre. Il risultato possibile è un’incisività maggiore del processo di vulnerabilizzazione e di esclusione sociale in atto. 4.3.2. Una prima ricostruzione Per ricostruire un panorama sociale utile alla costruzione di comunicazione sociale “non violenta” è necessario analizzare le fonti che lo alimentano (Volterrani, 2003). Proviamo a fare un esempio su una famiglia ipotetica e sulle possibili relazioni familiari (figura 1). 1 Non tenendo conto delle possibili variazioni nella percezione della realtà. Sul tema delle realtà multiple e della percezione della realtà vedi Schutz (1995). 116 Comunicazione e Nonviolenza In questo caso le relazioni fra le quattro generazioni presenti nel contesto familiare allargato si sostanziano in processi comunicativi alquanto complessi e integrati fra loro che hanno come possibile esito l’attivazione di un processo di esclusione sociale (per una parte della famiglia allargata e per la badante, anche se l’attività di quest’ultima tende ad essere a sostegno del contesto familiare). Se ci spostiamo a livello di comunicazione mediata esempi di questo tipo si possono rintracciare nelle molte situazioni di cronaca, ma anche nella comunicazione che ha come obiettivo la “lotta” all’esclusione sociale (non a caso si utilizza il termine lotta). Quelli che seguono sono solo alcuni dei titoli utilizzati dai principali quotidiani italiani negli ultimi mesi che contribuiscono a confermare la concettualizzazione escludente all’interno del nostro ipotetico contesto familiare: “Lasciata sola legata al letto” (Corriere della Sera), “Ruba i soldi della pensionata con la quale stava da tre mesi” (La Repubblica), “Espulsa badante dell’est” (La Stampa), “Soli o male accompagnati?” (La Stampa), “Lotta al lavoro nero” (La Repubblica), “Lo sfruttamento del lavoro femminile” (Il Manifesto). Se proviamo ad approfondire e a riflettere su questo specifico panorama sociale, troveremmo elementi diversi sui quali proporre attività di comunicazione sociale. Il tema dell’allungamento del ciclo di vita della popolazione italiana non è una novità (in alcune aree del centro e del nord dell’Italia la percentuale degli anziani sopra i 65 anni sfiora il 30 per cento sul totale complessivo della popolazione) ed è, invece, una tipica situazione dove la ricostruzione del panorama sociale rende conto della complessità sociale e culturale. Pur avendo presenti le molteplici caratteristiche degli anziani italiani (vita quotidiana, consumi, aspirazioni, relazioni intergenerazionali, etc) ci soffermeremo su due aspetti che generano vulnerabilità ed esclusione: a) la non autosufficienza; b) la cura della non autosufficienza. Entrambi intervengono profondamente sulla vita quotidiana delle famiglie italiane che si trovano ad operare scelte o, più spesso, a subire delle conseguenze inaspettate e sconvolgenti. I molteplici bisogni assistenziali di questa parte della popolazione anziana sono soddisfatti oltre che dai servizi pubblici di assistenza domiciliare e dalle residenze sociali - dalle famiglie di appartenenza e dalle collaboratrici familiari provenienti prevalentemente dall’Est europeo, ma anche dalle Filippine e, in misura minore, dai paesi dell’Africa centrale. Parte 4 - La violenza nei media 117 Se nel primo caso si evidenzia il carico sociale e assistenziale sulle donne nell’ambito delle famiglie, nel secondo si intrecciano bisogni diversi. Infatti, da un lato il lavoro di cura sommerso delle donne dell’Est europeo (fino ad oggi clandestine) risponde al bisogno di assistenza degli anziani non autosufficienti gravi e molto gravi, dall’altro le immigrate pongono nuovi problemi sia di integrazione sia di gestione di un progetto di migrazione non definitivo (una sorta di pendolarismo migratorio), nonché di nuovi processi comunicativi e culturali con le famiglie italiane ancora da esplorare. Queste persone sono state definite “badanti” sia dalle amministrazioni pubbliche sia dai media, mentre le famiglie che usufruiscono di questo servizio fanno prevalentemente riferimento alla loro provenienza (“ho in casa una polacca, ucraina, rumena, etc.”) ponendo l’accento più sulla loro presenza in uno dei più importanti contesti della vita quotidiana (l’abitazione), piuttosto che allo stereotipo apparentemente più diffuso legato al lavoro di cura. Nelle azioni comunicative che sono state proposte sia rispetto al tema della non autosufficienza sia delle attività di cura non si è tenuto conto della complessità accennata precedentemente, ma si è, invece, ritenuto che esistesse un immaginario condiviso nelle famiglie italiane2 dando per scontate percezioni, problemi ed esigenze della vita quotidiana. Su questi aspetti, ad esempio, l’ultimo romanzo dell’americano Jonathan Franzen (2002) esplora con arguzia, intelligenza e capacità descrittiva la storia di una famiglia americana dove il padre sessantenne una volta andato in pensione inizia ad avere i sintomi del morbo di Alzheimer. Le conseguenti reazioni dei familiari (moglie, figli e nipoti) sono quelle tipiche di chi vive un evento spiazzante (Meo 2001) in un contesto sociale e culturale della contemporaneità: inizialmente l’ignoranza del problema, poi l’incomprensione e le difficoltà comunicative, successivamente il tentativo di rimozione e, infine, la ricerca di soluzioni interne ed esterne al contesto familiare. Ricostruire il panorama sociale significa anche tenere conto di questi aspetti che modificano profondamente le percezioni e gli atteggiamenti delle persone coinvolte, ma anche di coloro che sembrano marginali rispetto al problema (amici, colleghi di lavoro, conoscenti). In questo modo si accresce anche la consapevolezza in chi volesse costruire strategie di comunicazione sociale capaci di incrociare immaginari diversi sul tema specifico. 4.3.3. Dentro al paradosso Con il processo descritto precedentemente si contribuisce a formare nuovi panorami sociali con nuovi stereotipi e nuovi pregiudizi che sono, appunto, alimentati dalla vita quotidiana, dalla semplificazione necessaria a livello di mondo del pensiero per poter condividere e comunicare e anche dai media narrativi che possono confermare, ampliare o aprire nuovi spazi nell’immaginario collettivo. Inoltre sembra quasi che in alcune occasioni colpire l’immaginario, essere forti, disturbare la quotidianità degli individui su temi sociali sembra essere l’atteggiamento che sempre di più si va diffondendo nell’ambito della comunicazione sociale. 2 Ad esempio l’ultima campagna della Provincia di Parma ha adottato lo slogan Meno male che ci sono le badanti. 118 Comunicazione e Nonviolenza Dove sta il paradosso della comunicazione dei “buoni”? Innanzitutto nel fatto che quasi nessuno si preoccupa di valutare adeguatamente l’immaginario e gli slittamenti di senso che sono presenti proprio su questi temi. In secondo luogo non si valutano i panorami sociali, ma anzi si evita accuratamente di analizzare e riflettere su quello che ci circonda. Infine non si esplorano gli stereotipi diffusi rispetto al tema che vorremmo affrontare e se ne propongono altri altret-tanto escludenti, anche se apparentemente politically correct. Fare comunicazione sociale non significa “falsare” il contesto nel quale si produce la vulnerabilità e l’esclusione sociale, ma nemmeno potenziarne la capacità attrattiva. Alcuni esempi possono aiutare a comprendere meglio il ragionamento. Il primo è quello dell’adozione a distanza. A questo proposito da qualche anno in Italia si è diffusa una nuova azione di cooperazione internazionale che è definita Adozione a distanza. L’AiBi. (Amici dei Bambini) è una ONG (Organizzazione non governativa) che opera soprattutto nei progetti di cooperazione e sviluppo (in Albania, Bolivia, Bosnia, Brasile, Bulgaria, Cile, Colombia, Croazia, Ecuador, Iraq, Libano, Marocco, Moldavia, Perù, Romania e Ucraina) che sono sovvenzionati con i fondi provenienti dalle adozioni a distanza. Uno dei messaggi utilizzati per la campagna di comunicazione è stato L’altro mio figlio sovrapposto ad una fotografia di un bambino di colore. La campagna gioca evidentemente con uno slittamento di senso (Hofstadter, 1996) del concetto nuvola di adozione senza porsi il problema delle relazioni fra i tre mondi (pensiero, linguaggio, realtà). Nella tabella 1 sono esemplificate le possibili relazioni fra i concetti nuvola di sedia, adozione e adozione a distanza e i tre mondi. Mondo del pensiero Concetto nuvola di sedia (generalità e astrazione bassa) Mondo del Linguaggio Termine sedia (abbastanza condiviso) Mondo della realtà Oggetto sedia (abbastanza condiviso) Concetto/i nuvola di adozione (generalità e astrazione alta) Molti termini nel linguaggio per Molti situazioni e contesti nella descriverlo realtà (non necessariamente condivisi) (non necessariamente condivisi) Concetto/i nuvola di adozione a Molti termini nel linguaggio per Difficile individuare situazioni e distanza descriverlo contesti nella realtà (generalità e astrazione alta) (non necessariamente condivisi) (non necessariamente condivisi) Slittamento di senso rispetto ad adozione Tabella n.1 - Le relazioni fra pensiero, linguaggio e realtà nel caso dell’adozione a distanza Se le motivazioni che sostengono la promozione dell’attività di comunicazione (il sostegno a progetti di cooperazione internazionale rivolti ai bambini) sono assolutamente legittime, le conseguenze sull’immaginario e sulla vita quotidiana potrebbero andare esattamente nella direzione opposta, ovverosia verso una maggiore esclusione del problema dall’orizzonte degli individui. Un secondo esempio è collegato all’ultima campagna di comunicazione dell’AVIS (associa- Parte 4 - La violenza nei media 119 zione laica dei donatori di sangue) che ha investito molto nella comunicazione sociale negli ultimi quindici anni. In questa ultima campagna, offerta gratuitamente da Fabbrica di Benetton (figura 2), non sono stati valutati gli slittamenti di senso. Nel caso specifico il problema non è quello di valutare il gusto individuale (mi piace/non mi piace) o l’eventuale impatto, ma, piuttosto, porsi i seguenti interrogativi che non sono stati esplorati adeguatamente in precedenza: - quale è il panorama sociale della donazione del sangue? - quale è l’immaginario rispetto al tema? - ci siamo posti il problema della multiculturalità e della multireligiosità? - abbiamo ricostruito l’immaginario collegato e collegabile al testo mediale utilizzato? Figura 2 - Campagna di comunicazione Avis Nell’ottica di una comunicazione sociale diversa, sarebbe stato interessante esplorare le audience sulla percezione e sull’interpretazione della produzione mediale e simbolica proposta. Una particolare attenzione alle relazioni con la vita quotidiana e alla relazione con la spiritualità individuale avrebbe aiutato a comprendere se la semplificazione proposta è un problema o una risorsa per l’individuo, amplia l’immaginario individuale sul tema o lo restringe. 4.3.4. Per andare oltre… Il paradosso non è stato affrontato, da chi si occupa di comunicazione sociale, in primo luogo perché si da per scontato che i temi della vulnerabilità e dell’esclusione sociale possano essere affrontati con approcci e strumenti della comunicazione del mercato. In secondo luogo si evita di ricostruire i panorami sociali, pensando di conoscere bene sia l’immaginario sia il significato dei concetti che si affrontano. Infine si dà per scontato che il tema che affrontia- 120 Comunicazione e Nonviolenza mo sia inequivocabilmente positivo. E’ possibile superare il paradosso? Sì se le strategie di comunicazione tengono conto delle persone per come sono, per come vivono e non per come vorremmo che fossero o vivessero. Sì, infine, se le storie non sono relegate nelle trasmissioni ghetto o autoreferenziali. La comunicazione è risorsa per la riflessività individuale, ma può anche essere ostacolo, paradossalmente, alla comprensione. L’eccesso di approfondimento e di informazione può interessare un ristretto nucleo di persone, elitario e particolarmente attento ai temi sociali; dall’altra parte il grande pubblico non è attratto da questi approfondimenti e, soprattutto, non li reputa utili per capire qualcosa in più al di là della personale esperienza di vita quotidiana. Ognuno di noi tende a dimenticare, a “cacciare” nell’oblio ciò che disturba, che provoca problema, ansia, paura, orrore, ma allo stesso tempo ne è affascinato. Quali strategie comunicative adottare allora? Non esistono ricette o vademecum precisi e specifici, ma, piuttosto, la crescita e lo sviluppo di una riflessività e di una responsabilità maggiore in tutti i soggetti che da punti di vista diversi sono chiamati ad occuparsi della comunicazione sociale, se vogliamo che le sfide etiche alla comunicazione non rimangano semplici affermazioni di principio. 4.3.5. Riferimenti bibliografici Bechelloni G., Svolta comunicativa, Ipermedium libri, Napoli 2002. Bichi R., L’intervista biografica. Una proposta metodologica, Vita e Pensiero, Milano 2002. Castel R., Les metamorpheses de la question sociale, Fayard, Paris 1995. Franzen J., Le correzioni, Einaudi, Torino 2002. Giordano M., Attenti ai buoni. Truffe e bugie nascoste dietro la solidarietà, Mondadori, Milano 2003. Hofstadter D.R., Concetti fluidi e analogie creative, Adelphi, Milano 1996. Jedloswki P., Fogli nella valigia. Sociologia, cultura, vita quotidiana, Il Mulino, Bologna 2003. Meo A., Vite in bilico, Liguori, Napoli 2001. Piasere L., Un etnografo imperfetto, Laterza, Roma-Bari 2002. Schutz A., Don Chisciotte e il problema della realtà, Armando, Roma 1995. Volterrani A., Panorami sociali. Il sociale nei media, i media nel sociale, Liguori, Napoli 2003. Wolfe T., A caccia della bestia da un miliardo di piedi, Leonardo, Milano 1991. Parte 4 - La violenza nei media 121 4.4. IL RUOLO DEI MEDIA NELLA RAPPRESENTAZIONE DELLA VIOLENZA Pacificatori o amplificatori della conflittualità? di Enrico Cheli Sia nell’informazione giornalistica sia nella fiction e nell’intrattenimento la violenza è certamente uno dei temi più frequenti, forse il più rappresentato in assoluto: negli USA oltre il 60% di tutti i programmi TV contiene almeno una scena di violenza e per i film e telefilm la percentuale sale addirittura al 90%; inoltre i tipici programmi a contenuto violento propongono almeno 6 eventi di violenza per ogni ora di durata1. Anche se mancano dati certi, sappiamo che le cose non sono molto diverse in Italia: la violenza, sia essa fisica o psicologica, la fa da padrona. Dunque i media mostrano come modalità prevalente (se non unica) di gestione del conflitto, quella violenta, mentre sono assai rari gli esempi di conflitti affrontati in modo costruttivo e pacifico. Come evidenziano anche E. Wartella e D. C. Whitney (2002), due dei ricercatori che hanno realizzato la suddetta ricerca, questa prevalenza della via violenta su quella nonviolenta può comportare numerose conseguenze: 1. Imitazione - gli spettatori tendono a valorizzare e imitare gli atteggiamenti e comportamenti aggressivi, specie se ad agire violentemente sono gli eroi in cui essi si identificano. Ciò contribuisce, sia nel bambino che nell’adulto, ad aumentare i livelli di aggressività nelle relazioni interpersonali e di gruppo, aspetto, questo, assai deleterio per la qualità dei rapporti con gli altri. 2. Paura cronica - gli spettatori, a forza di leggere cattive notizie, vedere atti criminosi, ascoltare “bollettini di guerra” si intimoriscono e hanno paura di essere vittime di atti violenti, quindi assumono atteggiamenti di diffidenza e mettono in atto comportamenti iper-protettivi, che li rendono meno socievoli, specie con gli estranei. 3. Desensibilizzazione emozionale - col tempo e la continua esposizione, molti spettatori si “induriscono”, diventano cinici e, come si suol dire “fanno il callo” e non si impressionano più (ma solo in apparenza) di fronte a certe informazioni, immagini, scene. I suddetti effetti interessano non solo gli adulti ma anche i bambini, per i quali le preoccupazioni dovrebbero essere ancora maggiori; invece, perfino nei film, nei fumetti e nei programmi televisivi a loro specificamente dedicati la violenza la fa spesso da padrona, associata ad una competizione selvaggia per affermare la legge del più forte. Gran parte dei cartoons (specie quelli giapponesi) si imperniano su una esasperata competizione, e mostrano la violenza come unico modo di risolvere i conflitti. L’affermazione implicita è che chi ha più forza 1 Cfr. National Television Violence Study, vol. 1, 2, 3, Sage Publications, Thousand Oaks, CA, 1997, 1998. 122 Comunicazione e Nonviolenza bruta (rappresentata non solo dalla potenza muscolare ma anche dai vari superpoteri dei personaggi) e vince, è nel giusto, è il migliore. Come già avevano ben intuito oltre 50 anni fa Horkheimer e Adorno, “Se i cartoni animati hanno un altro effetto oltre a quello di assuefare i sensi del nuovo ritmo, è quello di martellare in tutti i cervelli l’antica (e ideologica) verità che il maltrattamento continuo, l’infrangersi di ogni resistenza individuale, è la condizione della vita in questa società.” (Horkheimer M., Adorno T., Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino, 1966 p. 149 - tra par. ns.). Purtroppo la mancanza di alternative, da un lato, e la grande dinamicità e immediatezza delle scene, dall’altro, fa molto apprezzare questo genere di cartoni dai bambini. Qui il genitore e l’educatore devono stare molto attenti e intervenire con decisione a tutela dei bambini, i quali sono inconsapevoli degli effetti collaterali di certi programmi e quindi non ancora in grado di autoregolarsi. Il seguente esercizio può risultare molto utile per stimolare una più ampia visione del conflitto nei bambini. Box 1 - Esercizio per i bambini - Immaginare modi alternativi di risolvere i conflitti Molti storie dei cartoni animati si basano su lotte e litigi. Guardate assieme al bambino una scena del genere e poi chiedetegli di rispondere alle seguenti domande, meglio se per iscritto: - quanti personaggi sono stati colpiti, feriti o danneggiati? - quanti sono stati uccisi? - qual'era il motivo della lotta? - era proprio necessario combattere o si poteva risolvere il litigio in altro modo? Chiedetegli di immaginare dei modi alternativi e non violenti di risolvere la questione. E' insomma come costruire una nuova storia, con un finale diverso, e il bambino può immaginarne più d'uno e magari anche disegnarli. In questa fase è importantissimo non preoccuparsi se i finali proposti siano appropriati o no, verosimili o meno, è bene lasciare al bambino totale libertà immaginativa ed espressiva. L'adulto si limiterà a prendere nota delle varie alternative senza commentare né correggere, anzi incoraggiando il bambino ad esprimersi senza timore di essere giudicato. La violenza è veramente inevitabile e intrinseca alla natura umana o è un problema culturale che può essere trasformato costruttivamente con vantaggio per tutti? Una divergenza di vedute e/o un conflitto di interessi devono necessariamente sfociare in comportamenti aggressivi, violenti, distruttivi, o vi sono altre vie, più costruttive, per risolverli? Come per i punti precedenti anche a questo riguardo i media mostrano un orientamento ambivalente: a) da un lato stimolando il relativismo culturale, favoriscono una visione più aperta e costruttiva della realtà e dei rapporti interpersonali e interculturali. b) dall’altro, tendono ad adottare una visione non dissimile da quella finora dominante, secondo la quale la diversità tra identità, punti di vista, interessi porta inevitabilmente a un conflitto risolvibile solo mediante una competizione o uno scontro che decida il prevalere di una parte sull’altra. Parte 4 - La violenza nei media 123 In realtà la diversità può essere vista anche in altro modo, cioè non come antagonismo ma come complementarità: infatti è proprio grazie alla diversità che esiste il nostro mondo, fisico, psichico e sociale. Tutti i fenomeni, da quelli cosmici a quelli della vita biologica e sociale fino a quelli sub-atomici esistono proprio grazie ad un gioco di diversità, di polarità opposte-complementari. Poli opposti non vuol dire necessariamente antagonisti, anzi semmai complementari: gli elettroni sono necessari alla materia non meno dei protoni, così come le donne sono necessarie per la specie umana non meno degli uomini. L’universo, la vita, la materia esistono grazie al flusso e alla dinamica prodotta da opposizioni cooperative tendenti a un equilibrio2. Dunque, se si vuole davvero pervenire ad una più ampia visione della realtà, è necessario liberarsi dal pregiudizio che diversità voglia dire necessariamente e solamente antagonismo e conflitto. Su questo aspetto il ruolo di innovazione culturale dei media potrebbe essere determinante, ma al momento gli articoli e i programmi che propongono questa nuova visione cooperativa delle differenze sono del tutto minoritari, mentre predominano quelli basati sulla vecchia concezione: differenza = conflitto. C’è poi un ulteriore pregiudizio culturale, connesso a quello appena illustrato, che contribuisce ad aggravare il problema: la credenza che si possano soddisfare i propri bisogni solo penalizzando qualcun altro. Questo modo di vedere è stato definito dalla “teoria dei giochi” come gioco a somma zero: un gioco, cioè, dove la posta è limitata e non è sufficiente per soddisfare le esigenze di tutti i soggetti coinvolti (ad es. due naufraghi che si contendono un unico giubbotto di salvataggio o due tribù che lottano per un unico lembo di terra fertile, insufficiente per i fabbisogni di entrambe)3. Per millenni i rapporti sociali, ad ogni livello, si sono basati ciecamente su questo assunto e quindi sulla legge del più forte. Solo da poco stiamo scoprendo che in gran parte delle relazioni sociali non solo si può vincere entrambi, ma addirittura si vince di più se si vince tutti. Le relazioni di coppia o familiari, quelle tra insegnanti e allievi, medici e pazienti, imprenditori e lavoratori e molte altre seguono appunto le leggi di questo secondo genere di gioco, definito a somma positiva. Il gioco a somma zero è caratterizzato da una accesa competizione, in quanto uno vince (+1) ciò che l’altro perde (-1), da cui +1 -1 = 0. In tal modo è possibile al massimo giungere a compromessi, spartendosi la posta in proporzioni variabili, ad es. un terzo a te due terzi a me, oppure metà e metà, ma resta il fatto che la posta è fissa (o per lo meno i due contendenti la ritengono tale). Nei giochi a somma positiva invece, al guadagno di uno non deve necessariamente corrispondere una perdita per l’altro, poiché, se collaborano, aumenta la “torta” da spartirsi e il guadagno di ciascuno è maggiore di quello che avrebbe combattendo e sconfiggendo l’altro. Ad esempio, se due aziende A e B entrano in concorrenza secondo il modello a somma zero, il massimo che quella vincitrice potrà ottenere sarà una parte della quota di mercato dell’altra; se entrambi avevano l’uno per cento e A sottrae a B lo 0,3%, A sale a 1,3%, B scende al 0,7% con una somma finale di +0,3% -0,3% = 0. Se invece collaborano si collocano nell’ambito dei giochi a somma positiva, dove non solo B non perderà niente ma anche A 2 3 Per un più approfondito esame di questo aspetto rinvio ad un altro mio lavoro: E. Cheli, 2004a. Cfr. J. von Neumann e O. Morgensten, 1944. 124 Comunicazione e Nonviolenza potrebbe guadagnare di più di quanto guadagnerebbe combattendo B. Unendo le loro forze potranno realizzare risparmi e sinergie di investimento che gli permetteranno di puntare a traguardi che nessuna da sola avrebbe potuto immaginare e potrebbero guadagnare ciascuna un 1% netto di aumento di quota di mercato con una somma finale positiva: +1 +1 =2. La differenza tra i due tipi di gioco è ben evidenziata dal grafico di figura 30, elaborato da P. Patfoort (1992) dove il triangolo di sinistra rappresenta l’opzione a somma zero e quello di destra l’opzione collaborativa a somma variabile. Figura 30 - I triangoli di violenza e non violenza (da P. Patfoort, 1992) L’unica possibile soluzione “costruttiva” del triangolo di sinistra è il punto centrale del “compromesso”, in cui ognuno dei due contendenti ottiene il 50% della posta in gioco, ma più spesso la violenza porterà a spartizioni meno eque dove al più forte andrà, poniamo, l’80% e all’altro il 20%. Le basi fondanti di questo triangolo sono la violenza, il lavoro dell’uno contro l’altro e la sfiducia reciproca. Nel secondo triangolo predominano invece i valori della nonviolenza, del lavoro insieme e della fiducia reciproca e ciò spinge a cercare soluzioni che comportano per ambedue i contendenti vantaggi maggiori di quelli ottenibili con lo scontro o col compromesso. La teoria dei giochi è applicabile a qualsiasi genere di risorsa, anche di tipo immateriale (affettivo, sociale etc.). Si prenda ad esempio la relazione insegnante-allievo: è evidente che più l’allievo apprende con profitto, più l’insegnante è appagato (cioè guadagna sul piano emozionale e sociale), e viceversa, più l’insegnante è gratificato, meglio insegnerà e più positivamente si porrà nei confronti della classe, con conseguenze positive (guadagno di rendimento, di motivazione, di gratificazione emozionale e sociale) anche per l’allievo. Dobbiamo prendere Parte 4 - La violenza nei media 125 coscienza che gran parte dei nostri obbiettivi - come individui, come gruppi e popoli - non sono affatto antagonistici a quelli altrui ma possono anzi realizzarsi di più e meglio se collaboriamo. Tra l’altro, i giochi a somma zero comportano una competizione esasperata che spesso si trasforma in violenza e in molti casi ciò trasforma il conflitto in un gioco a somma addirittura negativa, dove cioè perdono entrambi: si pensi ad esempio ai rischi di una guerra atomica che porti alla distruzione dell’intero pianeta, dove non ha più nessuna importanza chi abbia vinto la guerra perché tutti alla fine avrebbero perso; oppure ad una coppia in crisi che intraprende la strada della separazione giudiziale senza esclusione di colpi dove tutti alla fine perdono: non solo lo sconfitto ma anche quello che legalmente viene riconosciuto “vincitore”, che potrà forse guadagnare sul piano pratico, economico e dell’orgoglio ma subirà anche lui/lei tali perdite sul piano affettivo, emozionale, relazionale che nessun guadagno materiale potrà mai compensarle: perdite dirette (indurimento, sfiducia verso l’altro sesso e verso le relazioni, perdita di disponibilità ad aprirsi e innamorarsi di nuovo, stress e probabili disturbi psicosomatici etc.) e indirette (ad esempio le ricadute sugli eventuali figli). Conclusioni L’idea che i conflitti possano essere affrontati e risolti in modo costruttivo, non competitivo e nonviolento è alquanto recente, e nella cultura e mentalità dominanti prevale ancora la vecchia idea. Per poter affermare questa nuova concezione è quindi necessaria una vasta operazione di sensibilizzazione culturale, in cui la collaborazione dei media risulta determinante. Non si può più invocare l’alibi secondo cui non compete ai media lo svolgere una funzione pedagogica: di fatto essi già la svolgono, quindi è essenziale che i modelli e le idee che propongono siano costruttivi. Continuare a dare spazio solo o prevalentemente alla vecchia concezione competitiva e aggressiva di gestione delle differenze e dei conflitti non è una scelta neutrale, è già prendere posizione: perché allora non prendere posizione per una nuova cultura delle relazioni? Tuttavia non possiamo limitarci ad aspettare che qualcuno dall’alto migliori la situazione: dobbiamo e possiamo attivarci in prima persona, impegnandoci ad educare bambini e adulti ad un uso più consapevole dei media. Parallelamente, è necessario educarli anche ad una più consapevole e costruttiva gestione delle relazioni interpersonali, imperniata sulla comunicazione e sulla collaborazione e non più sulla competizione e l’aggressione. Tale educazione dovrà essere tra le priorità dei prossimi anni se vogliamo perseguire una politica sociale imperniata sulla qualità della vita e sulla prevenzione del disagio psico-sociale, della microconflittualità urbana e familiare, del mobbing e di tutte le altre patologie sistemiche che affliggono la nostra vita sociale. E non andrà fatta solo nelle aule scolastiche (che comunque sarebbe già molto) ma anche tramite i media, proponendo agli utenti (nei notiziari come nella fiction) non solo conflitti che sfociano in violenza ma anche situazioni che vengono affrontate in modo costruttivo. Solo così potremo davvero creare i presupposti per una vita sociale costruttiva e soddisfacente e per una pace interpersonale e internazionale effettiva e duratura. 126 Comunicazione e Nonviolenza Riefimenti bibliografici Braquet-Lehur M., I vostri figli sono teledipendenti?, Edizioni scientifiche Ma.gi., Roma 2001. Cheli E., La realtà mediata. L'influenza dei mass media tra persuasione e costruzione sociale della realtà, Franco Angeli, Milano 1992. Cheli E., Relazioni in armonia. Sviluppare l’intelligenza emotiva e le abilità comunicative per stare meglio con gli altri e con se stessi, Franco Angeli, Milano 2004. Cheli E., Olismo e riduzionismo nella scienza, nella cultura e nella mente, in corso di pubblicazione, 2004a. Cheli E., Difendersi dai media senza farne a meno, in corso di pubblicazione, 2004b. Gerbner G., Violence in Television Drama: Trends and Symbolic Functions, in G.A. Comstok and E.A. Rubinstein (eds.) Television and Social Behaviour, U. S. Government Printing Office, Washington D.C. 1971. Gerbner G., Le politiche dei mass media, De Donato, Bari 1980. Gerbner G., Grass L., Morgan M., Signorelli N., Living with Television: the Dinamics of the Cultivation Process, in J. Bryant, D. Zillman (eds) Perspectives on Media Effects, Lawrence Erlbaum, Hillsdale N.J. 1986. Mazza V., Usare la TV senza farsi usare, Edizioni Sonda, Casale Monferrato 2002. Oliverio Ferraris A., TV per un figlio, Laterza, Roma-Bari 1995. Wartella E., Whitney D. C., Violence and U.S. Television. In Bachmair B., CavicchiaScalamonti A., Krees G. (eds.), Media, Culture and Social Worlds, Liguori, Napoli 2002. Parte 5 Conflitti costruttivi e distruttivi nella coppia e nella famiglia Parte 5 - Conflitti costruttivi e distruttivi nella coppia e nella famiglia 129 5.1. LA COMUNICAZIONE CON L’INCONSCIO di Daniele Cardelli Non so se la comunicazione possa effettivamente configurarsi come antidoto alla violenza, in ogni caso prima di asserire ciò, occorre precisare che questa possibilità può rivelarsi soltanto dopo un percorso; quando è possibile scegliere la comunicazione costruttiva, quando è possibile uscire dalla violenza verso il colloquio, vuol dire che si è già fatto un tragitto, che si sono sperimentati i disagi, le ansie e le pene della violenza come realtà e potenzialità psichica. Proprio l’esperienza della brutalità che si accompagna alla violenza, sia essa endogena, vissuta cioè come conflitto fra agenti interiori, o piuttosto proiettata, cioè vissuta socialmente, ci invita a rivolgersi altrove e ci suggerisce la ricerca di una soluzione pacifica come la più benefica da perseguire per la propria salute psichica. Ma questo passaggio dalla violenza alla comunicazione come risorsa, non è né semplice, né affatto scontato: ecco perché il tema ci conduce direttamente alla necessità di “una comunicazione con l’Inconscio”; comunicare con l’Inconscio significa affacciarsi all’imprevisto e all’imprevedibile, all’ignoto, a quello che non avevamo immaginato, significa rovesciare il proprio modo di pensare, rivedere la validità dei valori in vigore fino ad un istante fa, entrare in contatto con una realtà profonda, inconscia, mitica, con una realtà spesso negata e proprio per questo causa e motore del nostro disagio nevrotico e patologico: e cos’è più inconscio della violenza, mai auspicata eppure spesso così presente nei meandri del quotidiano, della vita sociale, degli echi del mondo: in fondo non sappiamo perché viviamo e patiamo i conflitti in famiglia, con i colleghi di lavoro, con gli altri, in noi stessi, conflitti fra scelte diverse che tirano ciascuna in due o più direzioni opposte, con ragioni opposte, non sappiamo perché siamo violenti eppure lo siamo. Parlare dunque di comunicazione come risorsa o come beneficio antidotico alla violenza significa perlomeno aver superato il quadro archetipico del conflitto fra gli opposti e dunque aver compiuto l’operazione fondamentale affinché questa pacificazione possa avvenire: il riconoscimento cosciente degli opposti in conflitto e delle loro ragioni. Dobbiamo aver operato una trasmutazione: dal conflitto fra nemici, con gli inseparabili compagni, odio e violenza, al colloquio come rappresentazione comunicativa del desiderio di capirsi e allearsi; dobbiamo uscire da un quadro ed entrare in un altro, passare da un archetipo ad un altro: tutto questo non è semplice e può essere fatto soltanto con la presa di coscienza, attraverso quel “processo d’individuazione” che, se riesce, ci potrà rivelare, alla fine, il senso del conflitto, come funzionano i conflitti da sempre, chi ero e chi sono. Del resto le diverse forme di comunicazione, da quella verbale a quella corporea, dalle vibrazioni energetiche alle gestualità simpatetiche sono figlie della volontà di incontrarsi, sono prodotti della coniuctio oppositorum, dell’armonizzazione degli opposti e per arrivare a ciò è necessario conoscere i modi e le vie per uscire dalla violenza iniziale, dallo stato di cattività (fase della nerezza) del conflitto e passare ad una comunicazione positiva, desiderata. Proprio per comprenderne i motivi e le dinamiche, occorre analizzare la violenza come real- 130 Comunicazione e Nonviolenza tà psichica, metterne in evidenza i connotati, parlarne (diventa indispensabile una comunicazione con l’Inconscio). Questo ci sembra, oltreché utile, anche salutare sul piano psicologico; come ogni altro noumeno psichico anche la violenza infatti si attiva autonomamente, arriva, avviene, ha dinamiche proprie e poiché nessuno la desidera mai, vuoi per averne già sperimentato gli indesiderabili effetti o per averne intuito la dannosità, essa viene rimossa: e proprio qui stanno il rischio e il paradosso, se gli Agenti scatenanti del conflitto, diversi da situazione a situazione, restano nell’Inconscio possono alimentare la loro potenzialità fino a livelli devastanti; rimuovendo il conflitto si ingenera nuovo conflitto dotato di una forza superiore e distruttiva. Anche per la violenza vale dunque l’avvertimento di un’osservazione più acuta, vale la stessa dinamica del conflitto in Iraq: nessuno lo voleva, eppure è successo. La violenza come fattore psichico si annida potenzialmente in ogni situazione, relazione e scelta individuale; è una realtà che accompagna il quadro archetipico del Conflitto e fa riferimento ad Ares1 e a Marte; ben aldilà dunque dei luoghi comuni sulla preferibilità del dialogo rispetto alla violenza, le situazioni concrete del vissuto ci testimoniano invece che questa si presenta come situazione spesso non eludibile: vi sono cioè, per dirla in altre parole, situazioni che paiono portarci dritti dritti in un quadro di scontro, uno scontro di natura quasi sempre accidentale, come le liti dopo un sinistro in auto, quelle in famiglia, con i colleghi, quelle con se stessi: sono le stesse singole situazioni dell’esistenza a porci in tutta la sua evidenza quanto grande sia la componente inconscia del conflitto: scontri nella vita professionale tanto aspri quanto le guerre fra gli stati. Tuttavia, se proviamo il desiderio d’incontrare e comprendere l’altro, beh dobbiamo forse anche dire grazie alla nostra storia precedente, ai suoi attori e alle sue durezze, alle lunghe guerre, alle annose, interminabili, estenuanti e forse inevitabili esperienze di conflitto e di violenza. Del resto dobbiamo ripeterlo sono le situazioni a dirci col tempo qual è lo sfondo mitico e archetipico in gioco: se è l’incontro o lo scontro, se è più Ares o più Atèna e quanto sia difficile passare dall’Uno all’Altra, come, con tutta evidenza, pare confermarci il mito stesso. I conflitti sono generati sempre per un motivo qualsiasi, in un momento qualsiasi, anzi nel momento meno atteso, semplicemente perché dovevamo vivere quell’Esperienza, viverla per avere una più ampia consapevolezza spirituale. Con questa chiave di lettura siamo anche pronti a riconoscere che la violenza ha ed è un modo di comunicare, per quanto primordiale e grezzo, tanto più utile da confutare, crediamo, proprio nell’ambito delle scienze della comunicazione; non vi nego che quando ho letto il titolo del convegno mi sono subito chiesto di quale comunicazione si parlasse: quale comu1 Su Ares: gli altri Dèi lo snobbano per il Suo carattere turbolento e litigioso (tanto da sembrare più un demone che il Dio della guerra nell’aspetto distruttivo). Gli fa da contraltare Atèna; Diomede, proprio con l’aiuto di quest’ultima, nella guerra fra Greci e Troiani, ferisce Ares. Egli è il solo Dio che in un duello olimpico venga atterrato (Iliade, XXI), e non è un caso che sia proprio Atèna a compiere l’azione. Atèna, Dèa della Ragione (da cui Ateneo, l’Universitates degli Studi) è anch’essa Dèa della guerra, ma incarna l’eroismo intelligente in contrapposizione alla sanguinaria brutalità di Ares; singolare è che la Dèa della guerra sia anche la Dèa della ragione, come se la ragione presupponesse una guerra, ma una guerra interiore, intelligente. Parte 5 - Conflitti costruttivi e distruttivi nella coppia e nella famiglia 131 nicazione è una risorsa? E quale non lo è? Non esiste forse una comunicazione o la comunicazione, ma molte comunicazioni possibili, molti modi e soprattutto molte dinamiche comunicative che rispondono ad altrettanti diversi archetipi, archetipi che, lo si voglia o no, vengono vissuti; siamo pertanto portati a credere che vi siano alcune forme immediatamente armoniche di comunicazione ed altre più negative, ombrose, il cui senso positivo sarà noto soltanto dopo un’analisi: la violenza crediamo sia proprio una di queste ultime. Le mie ricerche sugli approcci maschile e femminile nella politica rivelano peraltro con una certa evidenza come l’opposizione mitologica fra Sparta ed Atene sia parimenti opposizione di linguaggio: Sparta e Atene parlano da sempre lingue diverse perché qui parlano due Archetipi differenti, Ares e Atèna, e così è, allo stesso modo, per ogni realtà politica, fondata sopra miti diversi. La comunicazione cui più spesso facciamo riferimento e più in generale nell’immediata associazione immaginale, sgorga da lidi femminili, è suadenza, è Peitho. Affinché Peitho o la comunicazione al femminile possa però entrare in gioco occorre che gli opposti, attraverso la presa di coscienza e il ritiro della proiezione, cessino di confliggere, se ne riconoscano le apparentemente inconciliabili ragioni e che la violenza sia pacificata perché riconosciuta come via possibile e come realtà psichica, e come tale rispettata. Perché dunque la comunicazione rientri in un quadro di maggiore suadenza, più femminile e meno spigolosa, occorre dunque che si prenda coscienza, anche tramite la violenza, del quadro archetipico della dualità e della conflittualità maschile. Questo è decisivo per la cura dell’Anima. La comunicazione, femminile, è dunque un’altra possibilità rispetto alla violenza, oltreché, o piuttosto che, un antidoto, una possibilità certo più auspicabile, che tuttavia non arriva subito, va guadagnata. La comunicazione diventa antidoto, dunque, soltanto dopo che si è conosciuta anche la violenza, non prima, alla fine del processo e non all’inizio. Esattamente come le storie dei popoli dimostrano da sempre2, non diversamente dalle storie degli individui, esattamente come nell’Olimpo, dove proprio Atèna, la Ragione, non il raziocinio si badi, la Ragione, riuscì, col favore di tutti gli Dèi, ad aver ragione di Ares (la distruzione e la brutalità del conflitto); sostenere dunque eo ipso che la comunicazione è un antidoto alla violenza rischia di sembrare un “luogo comune” o un mero auspicio in attesa di fare i conti con l’Inconscio. E’ ora chiaro che ciò che vogliamo dire è che affinché si possa avvenire il passaggio da Ares, con la Sua violenza, ad Atèna o ad altre forme di comunicazione più ragionevole, occorre che il primo venga riconosciuto. Per cui psicologicamente, aldilà della spontanea tendenza verso opzioni pacifiche, occorre riconoscere i modi capaci di produrre un quadro comunicativo più soddisfacente; ciò può essere fatto prendendo coscienza della nostra ferita, della propria crisi, nella quale risiede sì il dolore, ma anche un’incommensurabile ricchezza: del resto ogni disturbo della comunicazio2 La Confederazione Elvetica, prima di passare indenne gli ultimi due conflitti bellici mondiali, ha attraversato numerosissimi conflitti interni fra Cantoni ed ha fornito molti uomini alle guerre tra gli altri stati: come un prezzo da pagare per la pace. 132 Comunicazione e Nonviolenza ne è un disturbo psichico; riconoscendo l’altro che si oppone all’io, che vuole cose impretendibili, che parla un linguaggio opposto, inconcepibile, antipatico; lavorando su questo conflitto con l’altro attraverso il mettervi luce, attraverso il lavoro maieutico che tira su fantasie, sogni, rivendicazioni e desideri, all’inizio assai poco piacevoli. Così noi non violentiamo più noi stessi e ricominciamo a costruire un dialogo con il Sè, perché riconosciamo che il conflitto ha senso, perché diamo senso al Rosso della passione e al Blue dell’accoglimento e della distensione: è da questi opposti che nasce il Viola e dal Viola la Violenza. In un modo o nell’altro, e in una certa misura, il contatto con la violenza non potrà essere eluso, ognuno di noi, se sarà serio con se stesso, riconoscerà i prodromi e gli effetti di questo contatto con l’archetipico e nondimeno sarà pronto per accettarla come prodotto e possibilità psichica, evitando così di generarne di nuova; il pericolo maggiore per l’Anima, lo ribadiamo, viene proprio dalla negazione del conflitto almeno come possibilità temporanea. Se il conflitto, e la violenza come Sua accompagnatrice, restano Inconsci allora si che diventano pericolosi e quando debordano causano effetti negativi su sé stessi, nella famiglia, nelle relazioni sociali, nella politica. Questo discorso sulla violenza vuole essere un omaggio a quel dominio del rimosso e dell’ Irrazionale che è l’Inconscio, all’archetipo del Conflitto e al Suo corteggio, ma anche un omaggio a Firenze che nel Viola e nondimeno nella violenza ha trovato e trova alcuni dei tratti peculiari del Suo mito e della Sua storia3. Anche la “non violenza” Gandhiana si fonda del resto, come molte discipline spirituali dell’Oriente, sull’armonizzazione degli opposti: qui risiede la possibilità di un passo in avanti e forse l’esito positivo del proprio “processo d’individuazione”. 3 Dalla Fondazione con il tempio a Marte, al gioco del Calcio in costume, fino alla partecipazione domenicale di massa allo stadio del Campo di Marte per tifare guardacaso proprio i colori viola; tutto questo fa parte dello stesso quadro, il cui riconoscimento ci porta a comprendere un po’ meglio il mito di Firenze e il perché la Sua è la storia di un’incessante battaglia interiore: del resto che si chiami appunto Florentia Viola o Fiorentina, è il colore Viola il tratto comune, un elemento simbolico distintivo e animante del mito e del calcio a Firenze e la violenza come Ens (l’ente) del Viola, un altrettanto significativo elemento costitutivo. Parte 5 - Conflitti costruttivi e distruttivi nella coppia e nella famiglia 133 5.2. L’INTELLIGENZA EMOTIVA Dalla mediazione del conflitto alla relazione costruttiva di Maria Martello In questa comunicazione non ci guida la credenza in una società perfetta secondo un immaginario utopico, bensì una preoccupazione. Pare particolarmente allarmante l’accelerazione di un processo in atto da tempo e sempre più deteriorantesi: l’imbarbarimento nelle relazioni interpersonali e collettive. Lo stile della convivenza civile si sfilaccia e lascia il posto al clima di giungla in cui il più forte, o il più arrogante, il più ricco o il più furbo, il più potente o il più prevaricatore, non pretende nemmeno di farsi ragione sforzandosi di convincere chi la pensa diversamente, ma si impone semplicemente facendo così diventare il suo comportamento l’etica dominante. In ogni discussione c’è chi alza i toni del linguaggio abbassando il livello del contenuto; si alimenta il culto dell’immagine e del successo, si esalta la competizione sfrenata e si osanna il più forte, la violenza, l’aggressività, la volgarità. Nella vita di tutti i giorni è poi normale avere a che fare con vari tipi di persone e di situazioni. Infatti sia che noi apparteniamo al tipo “eremita”, e che non abbiamo propensione a socializzare vivendo qualsiasi contatto con gli altri individui come una necessità (sopportiamo le persone e le persone devono sopportarci) sia che apparteniamo al tipo “mondano”, per cui non possiamo vivere da soli, scegliamo di trascorrere il nostro tempo con gli altri, pur magari disdegnandoli, o in cocktail parties estenuanti, ci poniamo sempre in relazione. Ciascuna di queste è sempre un’occasione di perdita o di guadagno. Non solo materiale, ma anche psicologico ed emotivo. Possiamo trarne soddisfazione o stress, conferma o disconferma. Le variabili sono curiose, a volte ci sentiamo sprovveduti in quanto ci rendiamo conto che una determinata azione che ci ha visti attori, grosso modo, si è rivelata una perdita per noi e un vantaggio per l’altro; altre volte invece siamo vittime dell’iniziativa di chi si procura un vantaggio a spese nostre. Capita nella vita lavorativa, ma quello che più scotta è quando capita in quella privata. Noi proponiamo una sfida considerando due azioni estreme. L’una, quella di danneggiare qualcuno senza trarne vantaggi e addirittura danneggiandoci. L’altra, quella di agire per ottenere vantaggi e procurarne agli altri. Quasi un conto aperto che è attivo per l’uno tanto quanto per l’altro, un conto in cui il nostro guadagno ne determina uno all’altro. “Alle parole” del malessere sostituiamo “la parola” del malessere. Alla folla di nomi, bullismo, incomunicabilità, pedofilia, violenza, isolamento, cinismo, insuccesso, separazione, abbandono, consumismo, per citarne alcune che catalizzano molta parte delle risorse della società civile e impegnano vari professionisti di volta in volta ricercati come esperti, vogliamo contrapporre un solo nome: il conflitto. La disattenzione nei suoi confronti, la poca preparazione a gestirlo, la mancanza di educazione alla relazione, l’incapacità a comunicare, in modo subdolo, quasi impercettibile, intaccano inesorabilmente le microsituazioni corrodendole. Si avvia un processo simile a quello del cancro per il fisico: appare evidente quando esplode 134 Comunicazione e Nonviolenza nella gravità estrema, nelle forme più drammatiche. Così quanto inizialmente appartiene alla dimensione normale del vivere, il sano confronto ed anche conflitto, fa il suo ingresso in quella della patologia, le parole di prima, spesso irreversibilmente e con gravi costi in termini di spesa, sofferenza, di malessere e insicurezza sociale. A nostro parere urge tornare un po’ indietro per poterci proiettare in avanti. Restituire attenzione all’etica, all’educazione alle relazioni, alla gestione del conflitto, apprendere l’alfabeto della comunicazione empatica, fin dai primi anni di vita, significa dare risposte ai bisogni ontologici dell’uomo alle prese con l’angoscia del vivere, prima che diventino “malattie dello spirito”, come le definisce Umberto Galimberti, e creare le condizioni per un futuro vivibile. Seguire criteri etici nella relazione interpersonale è certamente vantaggioso. Quando l’altro risponde sullo stesso piano, i risultati sono gratificanti a livello personale ma anche fruttuosi per gli obiettivi professionali e, non ultimo, generatori di effetti benefici per la società intera. Si tratta di rapporti “intelligenti” in cui ad un’azione corrisponde un vantaggio per chi la fa e per chi la riceve. E’ ugualmente utile quando l’altro si dissocia tenendosi lontano da questa dimensione del vivere. Resta infatti lo stesso salvaguardata la scelta etica dell’uno e forse anche sollecitata al cambiamento quella dell’altro: una testimonianza stimolante seppur a volte inquietante. Allo stesso modo reciprocamente utile risulta scegliere la Mediazione per risolvere un conflitto, una nuova tecnica basata sulla parresia dei greci, sul parlar chiaro, sull’essere franco tentando di togliere di mezzo gli equivoci, non contraria alla ricerca della verità e non mero compromesso. Questa linea di intervento, che prevede precise procedure e non generiche vie di mezzo, tende a far giungere a soluzioni gradite ad entrambi, rispondenti alle aspettative di ciascuno, originali in quanto frutto della ricerca del bisogno profondo che ciascuno nasconde dietro il motivo apparente, quello oggettivo, del conflitto. Soluzioni quindi non appiattite a clichè teorici, astratti, standardizzati, in cui ciascuno poco si riconosce, bensì individualizzate. Apprendere questa metodologia d’intervento significa aprirsi spazi professionali molto ampi ma anche un’opportunità per rivedere e sanare i propri conflitti, quelli conseguenti la relazione con l’altro, quelli frutto del dialogo sempre difficile con se stessi. Per questo stiamo proponendo una formazione dinamica in cui man mano che si impara a fare i mediatori si diventa tali nel proprio vivere. Si sostituiscono modalità egoriferite, intolleranti della diversità dei punti di vista con una rinnovata capacità di ascolto e di accoglienza dell’altro. Si ricerca un equilibrato scambio nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze. In tal senso la formazione alla Mediazione coincide con quella alla relazione costruttiva e al comportamento etico ed implica lo sviluppo dell’intelligenza emotiva. Oggi che le relazioni per molti motivi sono diventate complesse, e spesso mettono a dura prova il bisogno di qualità di vita, la capacità di orientarle in modo costruttivo non può essere affidata ad un apprendimento puramente esperienziale ma deve essere oggetto di attenzioni, modalità e tecniche specifiche. Partendo dalle strategie di formazione alla Mediazione, abbiamo predisposto un percorso sperimentale applicabile subito per migliorare il proprio quotidiano e renderlo sempre più vicino alla aspettativa di ciascun essere umano di sentirsi riconosciuto nella sua dignità, capito Parte 5 - Conflitti costruttivi e distruttivi nella coppia e nella famiglia 135 nella sua originalità, soddisfatto nel suo bisogno di condivisione e complicità, approfondendola fino all’acquisizione di un nuovo habitus: quello del mediatore. Una formazione per tutti, organizzata dall’Istituto Deva (www.istitutodeva.it). Chi mai penserebbe che l’intelligenza razionale sia qualcosa che si ha per nascita e non vada sviluppata? Eppure tale dubbio esiste per l’intelligenza emotiva. Molto scetticismo rimane nonostante da qualche tempo si è richiamati al suo valore da studi prestigiosi e ricerche statistiche. La constatazione di essere tutti impreparati, in quanto ben formati e strutturati solo nella dimensione razionale, crea una certa ansia e insicurezza che piuttosto che far scattare il fascino di ricercare in simil ambito, ancora misterioso, fa arroccare nella strenua difesa del già noto, del certo, negando ciò che non si padroneggia. Eppure è ovvio che ogni abilità dell’uomo può essere sviluppata, educata, orientata secondo i principi che in libertà ognuno stabilisce come buoni per la sua vita. Non si può non prendere atto che il livello emotivo costituisce il criterio privilegiato in base al quale riconosciamo un valore positivo o negativo a quanto accade. Rendersene conto è il primo passo per lasciare che l’intelligenza emotiva si esprima sempre di più; esercitazioni, specificamente ideate, costituiscono invece il volano per il suo sviluppo. Dalla sperimentazione sul campo, che ha modulato e attuato quanto prima accennato, ne è nato un volume che documenta i progetti, le procedure, i risultati, le valutazioni dei partecipanti. I vari progetti rispondono ad una tipologia di soggetti e di situazioni diversi tra loro. Cambia il committente, cambia la durata, cambiano i fruitori, cambiano le attività proposte. Resta fermo l’ambito, che sinteticamente ho intitolato L’intelligenza emotiva: dalla Mediazione del conflitto alla relazione costruttiva e simile è la valutazione che di volta in volta ho fatto come formatore e che ho raccolto dai fruitori. L’educazione alla relazione dovrebbe, a nostro parere, far parte del curriculum fin dai primi anni di scuola assecondando l’apertura che i bambini naturalmente hanno verso l’altro e contrastando l’isolamento dell’attuale stile prevalente di vita. Si accompagnerebbe così la nascita della dimensione sociale della persona e si eviterebbe che l’incompetenza e i conseguenti errori blocchino la fiducia verso l’esterno come disperata ed unica difesa dalle vulnerabilità emotive ed affettive. Inoltre è il periodo in cui si è più recettivi, non c’è ancora l’urgenza di acquisire strumenti operativi e professionali da spendere subito nell’inserimento nel mondo del lavoro. Si è ancora quindi pronti e disponibili a riflettere sul senso del fare come espressione dell’essere. Questo apprendimento ritengo vada anche inserito, con corsi fondamentali, in ciascun percorso universitario costituendo un ponte tra la scienza di riferimento e la prassi, una sinergia tra la teoria e l’esperienza applicativa: una vera preparazione all’inserimento lavorativo dove, più che mai, il successo è legato alle competenze relazionali. Queste infatti fanno la differenza tra un dipendente e l’altro, costituiscono la variabile che determina lo sviluppo della carriera di uno più dell’altro. Le competenze tecniche infatti sono il dato di partenza che accomuna all’assunzione tutti i lavoratori. Uno spazio particolarmente ampio dovrebbe averlo nell’ambito dei corsi di laurea che prepa- 136 Comunicazione e Nonviolenza rano all’insegnamento, alla formazione e alle relazioni d’aiuto. Si deve trattare però di una formazione profonda che va ben oltre i programmi di tecniche di comunicazione e che sembrano, a volte, arenarsi ad un livello di superficie, di apprendimento di strategie simili a sovrastrutture che si sovrappongono alla persona, modi di essere formali non congruenti con il modo di sentire vero. E’ investendo sul sentire profondo che si ottiene naturalmente l’esprimersi efficacemente e non viceversa! Il presupposto di tale formazione restano i principi della Mediazione umanistica, intesa sia come ambito di studio e di apprendimento sia come servizio offerto all’utenza, a chi è in conflitto. Il modello umanistico infatti consente a chi lo accosta di approfondire la propria formazione umana e professionale, di rivedere ed elaborare i propri conflitti archiviati e di sviluppare le proprie capacità di relazione umana esercitandosi anche nell’espressione della propria intelligenza emotiva. Senza questo lavoro preliminare è pericoloso fare i mediatori per la risoluzione pacifica dei conflitti, i problemi degli utenti rischiano di riattivare il dolore del professionista per i suoi ancora aperti o latenti e non ben riconosciuti. Non si può assicurare a chi fruisce del setting di mediazione l’esperienza unica di considerare il conflitto come un dato della vita molto eloquente e per questo da non sottovalutare. Come un evento che, se considerato nel giusto modo e con giusti tempi, permette di comunicare con l’altro con cui si litiga, di cogliere elementi di conoscenza del suo mondo, di precisare a se stessi il senso profondo che ha determinato le proprie azioni e reazioni. Non si può neanche portare le parti ad una ripresa del rapporto con l’altro, in una rinsaldata relazione fondata su principi realistici e su dati più profondi: la controparte rischia di restare il “nemico”. Si fa perdere inoltre un’occasione per oltrepassare il livello razionale e oggettivo, che traspare alla superficie dei conflitti, e anche banalizzare una esercitazione per imparare a cogliere il livello più profondo, di tipo emotivo e affettivo, che ne è il motore. Vogliamo richiamare quindi all’urgenza di diffondere percorsi di formazione ad hoc, a tutte le età e in tutti i ruoli. Il modello che noi abbiamo creato e che stiamo attuando, con le opportune variazioni, è adeguabile a fasce d’età diverse, agli studenti dei vari ordini di scuola e dell’Università, agli educatori, agli operatori sociali, ai dipendenti pubblici e privati, ai dirigenti, agli avvocati, agli operatori della giustizia, agli psicologi e al mondo del volontariato. Tale formazione necessita di particolari caratteristiche di rigore, profondità, significatività; non può perciò essere pensata in modo lineare ma circolare. Nel volume a cui prima facevo riferimento si indicano alcuni punti di attenzione da tener presenti e si fornisce la documentazione delle iniziative di formazione trasversali attuate, aperti a persone provenienti da molti ambiti di ricerca e di lavoro, che intendono abilitarsi alla nuova professionalità del Mediatore da spendere in settori molteplici, da quello sociale a quello commerciale ed educativo. Questi corsi non fanno “scoppiare la pace”, né assicurano l’armonia stabile nei rapporti interpersonali, né producono metamorfosi. Sembra che innestino però un circuito virtuoso che diventa promotore di ulteriori e continue Parte 5 - Conflitti costruttivi e distruttivi nella coppia e nella famiglia 137 modificazioni. Un cammino lento ma possente, saldo e generatore di ulteriori dinamiche di cambiamento di cui quando meno ce lo si aspetta si prende atto. Fanno sentire un po’ più in vita, fanno vibrare quelle corde emotive quasi atrofizzate, non più sentite e non utilizzate. Fanno riscoprire l’entusiasmo del sentirsi capiti e dell’imparare ad ascoltare gli altri, la possibilità di ricevere e di dare amore, la ricchezza di ogni attimo e di ogni rapporto. 138 Comunicazione e Nonviolenza 5.3. IL COUNSELING RELAZIONALE COME APPROCCIO COSTRUTTIVO AI CONFLITTI di Enrica Brachi 5.3.1. Introduzione La qualità delle nostre relazioni incide significativamente sulla qualità della nostra vita. Nella nostra civiltà definita “tecnologicamente avanzata”, ma poco più che primitiva sul piano affettivo-relazionale viviamo costantemente immersi in una sfida che quotidianamente ci invita alla “capacità di presenza”, all’interno del flusso denso e molteplice, che il tempo crea, tra la standardizzazione sociale e l’esperienza soggettiva (il tempo dell’anima), per trovare un filo, una continuità, tra le diverse parti; una ritmica nell’alternanza di movimento e quiete, tensione e rilassamento. Di fronte all’ambivalenza del cambiamento, all’incertezza che accompagna il nostro agire e alla responsabilità, intesa come capacità di rispondere, di riconoscere ciò che siamo e di situarci nelle relazioni, l’identità diviene un “processo di costante negoziazione” (si parla infatti di identizzazione) tra la diversità insita dentro di sé, nei tempi e negli spazi, nei sistemi di relazione. “Un mondo che vive la complessità e la differenza non può sfuggire l’incertezza che chiede agli individui la capacità di mutare forma restando se stessi...L’io, non più imperniato in una identificazione stabile,ha gioco, oscilla e si moltiplica...Di questo movimento l’io può tremare, e perdersi. Oppure può imparare a giocare.” (A. Melucci, Passaggio d’epoca, Feltrinelli, 1994, pag. 11). All’interno di questa situazione divengono necessari nuovi ed adeguati strumenti conoscitivi e operativi, che mettano in grado le persone di orientarsi in questi “territori della interazione sociale” e di gestire le tensioni e le incertezze che essi comportano. 5.3.2. Verso un approccio non medicalizzato alle problematiche emotivo-relazionali Il sempre più disagio diffuso emotivo-relazionale non deve essere inquadrato come patologia individuale ma anche e soprattutto come fenomeno collettivo, derivante dai mutamenti sociali e culturali in atto del singolo soggetto. Invece la visione “medicalizzata” e psicologistica di tale fenomeno, tutta centrata sul singolo, appesantisce, invece di alleggerire, la già elevata ansia e vergogna di coloro che necessiterebbero di educazione e assistenza, contribuendo a disincentivare le loro richieste di aiuto e la loro disponibilità ad intraprendere percorsi terapeutici o formativi. Per affrontare tali problematiche risulta pertanto necessario offrire servizi capaci di non intimorire l’utente, di non etichettarlo come patologico; servizi facilmente accessibili e che adottino strumenti e linguaggi che sdrammatizzino i problemi, non minimizzandone la gravità, ma presentandoli come problemi collettivi della nostra epoca e non come sindromi private di pochi “anormali” malati o disadattati. Tali servizi andranno sviluppati in almeno tre direzioni: 1) l’organizzazione di attività di formazione specificamente incentrate sulle competenze comunicativo-emotivo-relazionali rivolte a bambini, ragazzi e adulti; 2) l’istituzione di punti di ascolto e di counseling e in particolare di counseling rela- Parte 5 - Conflitti costruttivi e distruttivi nella coppia e nella famiglia 139 zionale; 3) il potenziamento dei servizi di psicoterapia individuale e familiare all’interno del servizio sanitario nazionale. Tali iniziative dovranno necessariamente essere inserite tra le priorità dei prossimi anni se vogliamo perseguire una politica sociale imperniata sulla qualità della vita e sulla prevenzione del disagio psico-sociale, della microconflittualità urbana e familiare, del mobbing e di tutte le altre patologie sistemiche che affliggono la nostra vita sociale. Presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo dell’Università degli Studi di Siena stiamo lavorando già da vari anni su tali tematiche, sia sul fronte della ricerca, pura e applicata, sia su quello della formazione specialistica di nuove figure professionali - quali il counselor relazionale e il formatore esperto in competenze comunicativo-emotivo-relazionali - che sviluppino una visione più consapevole della dimensione comunicativo-emotivo-relazionali e che siano in grado di operare nei diversi contesti sociali, dalla scuola al mondo del lavoro, dalla vita familiare ai rapporti amicali1. 5.3.3. Il Counseling Relazionale - un nuovo servizio di aiuto alla persona Il counseling, come è noto, è un servizio di aiuto psico-sociale finalizzato a stimolare e facilitare l’individuazione di soluzioni pratiche a problemi di tipo personale, esistenziale, psicologico o comunicativo-relazionale. Il counseling relazionale è una branca specialistica del counseling, rivolta a singoli, famiglie, gruppi con problemi specificamente inerenti i rapporti con gli altri, cioè attinenti alla sfera comunicativo-relazionale. Si tratta pertanto di una area professionale ben delimitata, da non confondersi con il counseling tout court né tantomeno con la psicoterapia, pur presentando interconnessioni con entrambi questi campi. Il counseling non è una terapia, tantomeno lo è il counseling relazionale: tutti possono trovarsi, in alcuni momenti della loro vita, a vivere conflitti, dilemmi e difficoltà nei loro rapporti con altre persone, nella vita privata o in quella lavorativa senza per questo dover essere considerati nevrotici o necessitare di psicofarmaci o di interventi psicoterapeutici. Rivolgersi a un counselor è un modo sano ed efficace per esprimere la propria volontà di crescere e di cambiare il modo di affrontare le situazioni problematiche. Attivarsi per risolvere i problemi prima che si aggravino è la decisione ottimale ma anche dopo che già si sono aggravati è comunque possibile trovare nuove possibilità per risolverli. Purtroppo escludendo alcune iniziative private numericamente esigue, le strutture pubbliche preposte alla salute e alla sua promozione non sono nella maggior parte dei casi attrezzate ad affrontare in modo adeguato le problematiche emotivo-relazionali, se non demandandole (spesso impropriamente) a medici, 1 Fanno parte di tale attività: 1) un Master di I livello in “comunicazione e relazioni interpersonali” destinato ai laureati in sociologia, psicologia, scienze della comunicazione, scienze dell’educazione, pedagogia, servizio sociale e equipollenti che otterranno, a seconda delle specificità formativo-professionali, i titoli di - Esperti in: Counselling relazionale, mediazione e risoluzione pacifica dei conflitti o - Esperti in: Comunicazione e relazioni nei contesti organizzativi pubblici e privati; 2) un Corso di Perfezionamento su: “CULTURA E CONSAPEVOLEZZA DEI SENTIMENTI E DELLE EMOZIONI”, rivolto a insegnanti, educatori, psicologi, sociologi, medici, assistenti sociali, infermieri desiderosi di approfondire le tematiche oggetto del Corso. 140 Comunicazione e Nonviolenza psichiatri o psicologi, etichettandole così facendo come patologie di singoli individui, invece che come incompetenze comunicative di una intera società. 5.3.4. La figura del Counselor relazionale Per svolgere la professione di counselor relazionale è necessaria una solida base formativa nel campo delle scienze psicosociali (laurea in: psicologia, sociologia, scienze dell’educazione, pedagogia, servizio sociale) su cui si innesta un percorso formativo specialistico post-laurea, ad esempio un Master universitario o comunque erogato da strutture qualificate e riconosciute. Oltre ad un idoneo bagaglio formativo, l’aspirante counselor dovrà dimostrare una buona base di partenza nel campo della “intelligenza emotivo-relazionale”; ad esempio deve essere una persona portata all’empatia, alla obiettività e al relativismo, disponibile a mettersi in discussione ed inoltre cortese, estroversa e con un buon grado di autoconsapevolezza. Ovviamente tali doti verranno ulteriormente coltivate e affinate anche durante la formazione post-laurea ma non è pensabile svilupparle da zero, quindi nella selezione vanno preferiti coloro che dimostrino giù un discreto possesso di tali capacità. Il ruolo del counselor è in primo luogo basato sull’ascolto e la comprensione e quindi - una volta compresa la natura del problema, i tratti di base delle persone in esso coinvolte e del contesto socioculturale in cui esse vivono - è rivolto a facilitare la soluzione del problema; ciò non tanto fornendo soluzioni preconfezionate dall’alto” bensì stimolando nei clienti quelle capacità di autoconsapevolezza, reframing (reincorniciatura) e creatività che li mettano in grado di pervenire il più possibile autonomamente alle possibili soluzioni, facilitando l’empowerment del soggetto, inteso come “capacitazione” (Piccardo), attivazione-risveglio delle capacità, potenzialità, risorse comunque presenti nell’individuo. Il counselor svolge dunque un’attività d’ascolto, d’orientamento; di sostegno e di rinforzo; chiarisce gli obiettivi dell’incontro o degli incontri; aiuta a comprendere i problemi; partecipa al processo di empowerment individuale e responsabilizzazione del soggetto; non dà consigli o soluzioni, ma facilita l’elaborazione personale di concrete proposte come possibili e sostenibili soluzioni al problema individuato. I suoi possibili ambiti lavorativi sono: - l’attività di counseling relazionale in ambito pubblico(AUSL, consultori, SERT, servizi sociali, università etc.); - la libera professione quale counselor relazionale in studio proprio o presso ass. di volontariato, comunità, grandi aziende, associazioni di categoria quali ass. ind.li, confcommercio e simili; - l’attività di mediazione familiare e di risoluzione pacifica dei conflitti interpersonali in ambito pubblico e privato; - la collaborazione ai servizi sociorelazionali di assistenza alla persona presso i consultori, i SERT, le comunità di recupero, le associazioni di volontariato; - le attività di supporto alla assistenza sociale e alla gestione del disagio presso AUSL, enti locali, associazioni di volontariato, centri sociali etc.; - le attività di educazione e formazione delle capacità emotivo-relazionali (corsi nelle Parte 5 - Conflitti costruttivi e distruttivi nella coppia e nella famiglia 141 scuole per insegnanti e studenti, corsi organizzati da ass. di volontariato, da gruppi pacifisti etc.). 5.3.5. Il progetto www.relazioniinarmonia.it come esempio di intervento integrato Relazioniinarmonia è un portale web finalizzato alla educazione, prevenzione e risoluzione costruttiva dei conflitti e delle incomprensioni nelle relazioni interpersonali. Il progetto si basa sul collegamento tra diversi approcci, da quello puramente informativo-divulgativo al confronto e condivisione in gruppo fino al counseling relazionale on line e alla psicoterapia sul territorio. Il portale offre dunque varie tipologie di servizi, tra cui: 1. Schede informative sui principali nodi e aspetti psicosocioculturali delle relazioni con livelli progressivi di approfondimento. L’impostazione è per problemi e non per discipline e gli argomenti e il linguaggio cercano di riflettere il più possibile il modo di vedere le cose e di ragionare dell’utente. 2. Forum e chat line su aree problematiche specifiche (separazione, mobbing, rapporti genitori-figli, difficoltà nei rapporti a scuola; rapporti con gli amici etc.) attraverso le quali gli utenti possono comunicare con altre persone che stiano vivendo o abbiano vissuto problemi simili. 3. Servizio di Counselling relazionale on line individuale espletato in diretta (in orari e giorni prestabiliti) da counselor qualificati. L’utente descrive per iscritto il proprio problema o la domanda e il counselor risponde in tempo reale; l’utente a sua volta replica e così via. La durata di ogni seduta è di 30 minuti per un massimo di 3 sedute (dopo di che, se l’esigenza non è soddisfatta l’utente viene invitato a rivolgersi ad un servizio sul territorio di cui il counselor può fornire i recapiti). 4. Data base di orientamento ai servizi presenti sul territorio allo scopo di informare sui servizi educativi e consulenziali esistenti, sulla natura e specificità dei diversi metodi e servizi; sui centri specializzati e/o i professionisti - pubblici e privati - più vicini alla zona di residenza dell’utente: indirizzi, recapiti telefonici e web, orari, offerta di servizi, costi. Questi molteplici strumenti di aiuto psicosociale si rivolgono a tutti coloro che avvertono l’esigenza di migliorare la propria comprensione e competenza nei rapporti con gli altri, e di affrontare in modo efficace e costruttivo i momenti difficili nei rapporti interpersonali. Più specificamente si propone di aiutare gli utenti a: - comunicare con maggiore efficacia; - sviluppare una più attenta consapevolezza di sé e dell’altro nelle relazioni; - vivere le relazioni interpersonali in modo più sano e reciprocamente soddisfacente; - affrontare in modo pacifico e costruttivo eventuali situazioni di conflitto o di disagio; - gestire efficacemente le proprie e altrui emozioni e esprimere appropriatamente i sentimenti. Continuo sarà il tentativo di integrazione sinergica dei molteplici servizi strutturati su diver- 142 Comunicazione e Nonviolenza si livelli tra cui: - Erogazioni delle informazioni ed offerta di documentazione con livelli progressivi di approfondimento tramite schede di base, di approfondimento, con storie di vita e/o storie di casi e di orientamento sui metodi e servizi formativi, consulenziali e terapeutici esistenti per facilitare la risoluzione dei problemi emotivo-relazionali. - Condivisione e confronto di esperienze mediante chat lines attraverso le quali gli utenti possono comunicare con altre persone che stiano vivendo o abbiano vissuto problemi simili. - Counselling relazionale on line di gruppo su vari temi espletato in diretta (in orari e giorni prestabiliti) mediante chat line riservata coordinata da un counselor qualificato. - Counselling relazionale individuale on line o telefonico. - Orientamento e mappa dei servizi presenti sul territorio - Counseling face to face presso una delle strutture o professionisti aderenti al network. - Seminari di approfondimento su tematiche e contesti specifici. 5.3.6. Conclusioni Dato che non si può dare una sola risposta ad un problema che non ha un unica causa, nel counseling relazionale si lavorerà evitando le soluzioni semplicistiche che riducono la complessità e si condurrà il soggetto a scoprire l’opportunità di gestire la complessità “situazionalmente”, di volta in volta, con una consapevolezza capace di vedere “ciò che è normalmente invisibile agli occhi”. Così nel processo si evidenzierà la necessità di conciliare creativamente i nostri ed altrui bisogni scoprendo le possibilità concrete di coesistenza pacifica e collaborativa tra questi diversi bisogni, dentro e/o fuori di noi; si favorirà, attraverso il dialogo, la comprensione che il conflitto, esplicito o latente, è un opportunità di trasformazione personale e/o della relazione e che saper esprimere un conflitto (dallo scontro al confronto) evita di cadere in un circolo vizioso, che spesso automaticamente giunge ad una escalation di violenza distruttiva. Concludiamo dunque questo intervento rimarcando l’esigenza di sviluppare una visione consapevole delle molteplici con-cause e risvolti di ogni problematica comunicativo-emotivorelazionale, e di approntare interventi lungimiranti, plurimi ed integrati a diversi livelli e contesti: il counseling relazionale, nelle sue diverse forme, segue appunto una modalità di approccio al conflitto multidimensionale e costruttiva, capace di aiutare concretamente il singolo a relazionarsi nel suo contesto intrapersonale e microsociale. Così come ogni viaggio, sia pure di mille miglia, inizia con un singolo passo, anche la “rivoluzione umana” nel micromondo può essere un concreto inizio di cambiamento della coscienza planetaria. 5.3.7. Riferimenti bibliografici Castelli S., La mediazione, Raffaello Cortina Editore, Milano 1996. Cheli E. (a cura di), La comunicazione come antidoto ai conflitti, Punto di fuga, Cagliari 2003. Cheli E., Teorie e tecniche della comunicazione interpersonale. Una introduzione interdisciplina- Parte 5 - Conflitti costruttivi e distruttivi nella coppia e nella famiglia 143 re, Franco Angeli, Milano 2004a. Cheli E., Relazioni in armonia. Sviluppare l'intelligenza emotiva e le abilità comunicative per stare meglio con gli altri e con se stessi, Franco Angeli, Milano 2004b. Di Fabio A., Il counseling. Dalla teoria all’applicazione, Giunti, Firenze 1999 Melucci A., Passaggio d’epoca, Feltrinelli, Milano, 1994 Scott T., Davis R., Guida al counseling, Franco Angeli, Milano 1994. 144 Comunicazione e Nonviolenza 5.4. IL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE NELLE TEORIE DELLA SOLUZIONE NONVIOLENTA DEL CONFLITTO di Antonino Drago 5.4.1. Premessa: la teoria dei conflitti di Galtung Da pochi anni abbiamo acquisito una teoria dei conflitti molto importante, quella di Galtung. Questa novità gli è stata riconosciuta dall’ONU, che gli ha affidato la pubblicazione del primo manuale ONU per la soluzione dei conflitti (Galtung, 2000). Secondo Galtung, un conflitto non è riferibile ad un oggetto materiale; non è definibile con più oggetti; né è la semplice contrapposizione di due idee precisate a priori. Piuttosto, un conflitto è un A-B-C. Cioè un conflitto è tutt’assieme il complesso di: Assunzioni, Comportamenti (Behavior) e Contraddizione. Nel seguito utilizzeremo questa definizione come strumento interpretativo1. 5.4.2. La comunicazione nelle rappresentazioni parziali di un conflitto Consideriamo i casi in cui il conflitto non viene visto nella sua pienezza, perché manca una (o due) delle tre parti A, B e C che Galtung ha indicato. Allora la visione parzializza il conflitto e gli attori in gioco; il coinvolgere solo parte della nostra intellettualità certamente ci facilita nel pensare il conflitto; ma chiaramente ne compromette la capacità di soluzione. Visione del conflitto A B C X X X X X X X X X Sua rappresentazione mediante pensieri reazioni istintive sentimenti traumi psicologici vicende passate o viste dall'esterno atti intenzionati (litigio in atto) Teorie coinvolte Ideologie Sociologia Religione, Psicologia Religione, Psicoanalisi Storia, Tribunale Diritto Tabella 1 - Le rappresentazioni delle comonenti di un conflitto La tabella fa notare la povertà di queste descrizioni del conflitto, così tanto riduttive che nei primi due casi non c’è proprio la comunicazione tra le due parti; nel terzo caso c’è una comunicazione solo con se stessi e/o con Dio da parte di un contendente isolato; nel quarto c’è con 1 In effetti, ritengo di aver generalizzato la teoria di Galtung in una teoria più comprensiva (“Il cambiamento di paradigma nella risoluzione dei conflitti”, in Drago A. e Soccio M., Per un modello alternativo di difesa nonviolenta, Editoria Universitaria, Venezia 1995, pp. 215-229; “A paradigm-shift in conflict resolution: War and peace from a history of science viewpoint”, in Koller P. e Puhl H., Current Issues in Political Philosophy. 19th Int. Wittgenstein Symposium, Kirchberg 1996, pp. 106-114). Ma per una prima discussione del problema, non sarà necessario allargare le categorie interpretative oltre quelle di Galtung. Parte 5 - Conflitti costruttivi e distruttivi nella coppia e nella famiglia 145 l’analista e, solo per suo tramite, con parti di se stesso; nel quinto caso, c’è con un giudice che vorrebbe condensare formalmente il quadro di riferimento della storia umana; nel sesto non c’è proprio, perché in ogni attore C prevale su tutto. Come si vede, solo prendendo in considerazione tutti i tre aspetti c’è la possibilità di una comunicazione piena; e viceversa, durante un conflitto una vera comunicazione deve includere ciascuno degli aspetti A-B-C2; e allora ogni teoria potrebbe essere utilizzata, perché la comunicazione dovrebbe saper comprendere la natura umana dell’avversario e le strutture sociali in cui è immerso. 5.4.3. La comunicazione nelle istituzioni preposte alla soluzione dei conflitti Ora consideriamo la tematica dei conflitti storicamente, esaminando le modalità di soluzione che sono state istituite dagli uomini. Esse sono riportate nella prima colonna della tabella 2. Nelle altre colonne sono indicati il tipo, il ruolo e il contenuto della comunicazione; quest’ultima è ricavabile da informazioni di dominio comune su che cosa le due parti in causa manifestino del conflitto. Istituzione Tipo di comunicazione di Ruolo della comunicaziociascuna delle parti in ne causa Contenuto della comunicazione A B C Prevaricazione di uno solo verso l'altro minimo Negoziazione tra ambedue centrale X Arbitrato verso l'arbitro preparatorio X Tribunale X Mediazione formalizzata verso il giudice funzionale verso il gestore e generica doverosa e minima all'altro soprattutto verso il media- basilare tore Concil. di terza parte generale tra i tre X Marx combattimento soppressivo opposizione X X Freud dialogo - transfert liberatorio X X totale X Gestione Nonviolenza gandhiana gettare ponti / empatia totale X X X X X X X X X X Tabella 2 - La comunicazione nelle istituzioni di soluzione del conflitto Le istituzioni (delle quali le ultime tre sono teorie) sono ordinate secondo la maggiore presenza della comunicazione (solamente su A o su C, o su tutte le parti del conflitto). Si nota: a) la crescita delle istituzioni, avvenuta nella storia dell’umanità, come si vede nella prima 2 In uno scritto precedente (“Il cambiamento di paradigma…”, op. cit.) ho indicato che usualmente la progressione temporale di questa comunicazione è C-A-B: per prima cosa si possono comunicare le sensazioni, poi si può cercare di capirsi nelle motivazioni e infine ricostruire i fatti, per valutarli serenamente, senza più ripetere il conflitto. 146 Comunicazione e Nonviolenza colonna; b) la quarta e quinta colonna indicano come tuttora le istituzioni sociali (esclusa la conciliazione di una terza parte) danno rappresentazioni riduttive, che (vedi la seconda colonna) riducono la comunicazione e la dinamica completa dei conflitti; c) la faticosa crescita di una teoria dei conflitti, osservabile nelle ultime tre righe; 4) la maggiore capacità di comunicazione nelle istituzioni informali (prime righe). In particolare il punto b) indica che nella storia (occidentale) la conflittualità è rimasta un grande problema irrisolto; giustamente la società odierna sta ricercando nuove istituzioni; ad esempio la difesa popolare nonviolenta. 5.4.4. La comunicazione nelle teorie di Marx e di Freud In realtà, già nel secolo XIX erano nate due teorie dei conflitti. Ma esse sono rimaste ambigue. Innanzitutto a causa dei loro cambiamenti storici. E’ facile notare che all’origine ambedue le teorie erano alternative a quelle dominanti al loro tempo. Ma poi nel marxismo è prevalso l’autoritarismo e l’inseguimento di un progresso che sarebbe stato sicuramente liberatorio; mentre nella psicoanalisi si è imposta la delega all’analista e la sessualità è stata mitizzata. Inoltre la teoria di Marx è apparsa come recrudescenza del conflitto (di classe); quella di Freud, come una mera facilitazione dei conflitti interiori. In effetti, ambedue sono teorie parziali. La prima non affronta il conflitto individuale (a parte i Manoscritti giovanili), né quello armato tra gruppi o nazioni, ma solo quello sociale interno ad uno Stato. La seconda teoria affronta solo il conflitto interiore della persona (a parte tentativi di giungere ad una psicoanalisi sociale; v. Fromm e Reich). Quale ruolo per la comunicazione? Nella prima teoria Marx ha indirizzato il proletariato allo studio delle leggi (pressoché ineluttabili) della storia sociale: un dialogo socialmente autoreferenziale, che va a formare una ideologia; la quale, al posto della comunicazione, fa da collante nei rapporti di solidarietà tra le persone del proletariato (e con chi non essendo del proletariato si introduce nella sua ideologia!). La comunicazione diretta tra proletariato oppresso e capitalisti oppressori è trascurata come irrilevante; Marx ha dichiarato come necessario il contrasto aperto e finanche distruttivo tra lavoratori e capitalisti (è il B della reazione istintuale). Perciò i partiti dei lavoratori si sono contrapposti all’altra parte come nemico bellico; il che ha spinto i capitalisti alla controffensiva repressiva. Tutto ciò ha inasprito il conflitto sociale di classe, fino a produrre repressioni sanguinose e rivoluzioni distruttive. Invece nella teoria di Freud la comunicazione è molto curata. Però questa viene spostata dalla comunicazione tra le diverse parti in conflitto nella personalità malata, a quella tra il paziente e l’analista (soprattutto: il paziente racconta all’analista i suoi sogni; quindi solo C e simbolizzato); al punto che tutto il metodo risolutivo viene ristretto in questo canale comunicativo. Inoltre, quando Freud ha voluto esprimere il suo metodo, andando oltre l’analisi dei singoli casi clinici, l’ha precisato solo parzialmente; tuttora la comunicazione (ad es., nel transfert e nel controtransfert) richiede approfondimenti. Comunque queste teorie hanno generato delle nuove istituzioni sociali: il sindacato e la professione di psicanalista. Sono stati i sindacati, perché costretti a subire il quadro d’azione della fabbrica e quindi la esi- Parte 5 - Conflitti costruttivi e distruttivi nella coppia e nella famiglia 147 stenza inevitabile del padronato, che hanno dovuto recuperare una capacità di dialogo con il padronato (su B e C). Ciò è avvenuto contrastando A, non solo l’ideologia capitalista, essenzialmente mercificante i lavoratori, ma anche operando indipendentemente dalla teoria di Marx. Nella storia umana, la capacità di costruire e mantenere il dialogo nonostante queste difficoltà ideologiche, avuta dai sindacati, è un grande insegnamento per le soluzioni sociali dei conflitti. Inoltre il ruolo professionale dello psichiatra è ormai riconosciuto dagli Stati; oggi esso costituisce un’istituzione molto importante nel panorama delle istituzioni preposte alla risoluzione dei conflitti ed esprime una capacità abbastanza diffusa di risoluzione dei conflitti interiori. In più da ambedue le teorie è possibile trarre delle indicazioni relative ai conflitti generali, le quali vanno a coincidere con molte di quelle del metodo nonviolento (Amato-Drago, 1997; Drago-Zerbino, 1996). 5.4.5. La comunicazione nei maestri della nonviolenza Da fuori Europa è giunta una nuova teoria della soluzione dei conflitti: la nonviolenza. I maestri della nonviolenza (Gandhi, Capitini, Lanza del Vasto) hanno sempre sottolineato con forza che il dialogo ha un’importanza basilare, anche subendo repressioni brutali e avendo un avversario anonimo, qual’è un’istituzione formale della società moderna. Ogni maestro ha una concezione della comunicazione durante un conflitto. Gandhi ricorre a delle immagini (gettare un ponte tra le due rive di un fiume sulle quali sono collocati i due avversari; oppure allargare la comprensione del conflitto al di là di quella che possono avere delle formiche, che di un elefante percepiscono solo una delle tante sue parti). I due maestri italiani suddetti hanno una vera e propria teoria. Lanza del Vasto vede i processi di soluzione nonviolenta come un convergenza dialettica (Bottone-Drago, preprint) che riesce a conciliare qui sulla terra la Carità con la Giustizia (sua definizione della nonviolenza). Da qui la sua proposta di risolvere un conflitto essenzialmente con un appello alla coscienza dell’avversario e alla fine a Dio3. Qui la comunicazione è essenziale, perché è la base del processo risolutivo ed è totale, a partire da A. Capitini ha sviluppato una concezione della nonviolenza ancor di più attorno alla comunicazione. L’apertura, il farsi centro, il tu-tutti, la realtà di tutti, la coralità, la omnicrazia, la festa sono sue felici espressioni dello sforzo che occorre per superare i limiti di un conflitto aperto (o i limiti della propria condizione di incomprensione, o di una malattia, o della morte e della nostra differenza con gli animali). Questo comunicare viene da lui sintetizzato nella capacità di apportare una “aggiunta” (che è la sua versione personalistica dell’hegeliano Aufhebung)4, ad ogni situazione limitata, anche se 3 Lanza del Vasto, La Trinité Spirituelle, Denoel, Paris 1973, pp. 181-183. Da qui segue la concezione della nonviolenza che è stata espressa in vari libri: ibidem, pp. 133-140; I quattro Flagelli, SEI, Torino 1996, pp. 526-541; Che cosa è la nonviolenza, Jaca book, Milano 1978, pp.14-20 e 31-34; Vinoba, o il nuovo pellegrinaggio, Jaca Book, Milano 1980, pp. 54-61. 4 In generale sul pensiero di Capitini è ottima l’antologia di Cacioppo G. Il messaggio di Aldo Capitini, Lacaita, Manduria 1977; la “aggiunta” è sottolineata nello scritto “L’avvenire della dialettica” (pp. 189-194), che è quello in cui più esprime la sua concezione dei rapporti dell’uomo col mondo intero e in particolare la sua concezione della nonviolenza (ripresa nelle pp. 227-231). 148 Comunicazione e Nonviolenza apparentemente insuperabile; questa è secondo lui la nonviolenza, che chiaramente coinvolge nell’ordine C, A e B (dove A in Capitini sono i “valori”). 5.4.6. La comunicazione nei recenti teorici dei conflitti Molte teorie recenti della soluzione del conflitto si sforzano di raggiungere una maggiore intellettualità, però appaiono carenti sulla comunicazione5. Pontara (1983) definisce la nonviolenza positiva mediante cinque punti; nessuno riguarda il mettersi in relazione, salvo uno, “IV) L’impegno costruttivo”, che però non indica la comunicazione come importante. I pur autorevoli Mellon e Sémelin (1999) fanno della nonviolenza o un atteggiamento critico intellettuale o un’azione. Ha avuto un certo successo la teoria di P. Patfoort6. La quale parte da C, semplificata nella sola relazione minore/Maggiore (m/M); alla luce di questa contraddizione enuncia “quattro principi”, che di fatto ricostruiscono A e B da C; la comunicazione (“dialogo senza pregiudizi”) è poi una raccomandazione giustapposta. La rappresentazione del conflitto è rozza; ma può essere uno come strumento pedagogico molto utile. Mi soffermo su Arielli e Scotto (1998) perché citano la teoria di Galtung. Essi presentano molti aspetti del conflitto, anche la teoria dei giochi (Capitolo 5); ma mai la religione, né la filosofia (se non per rapidi cenni all’inizio); la psicoanalisi è risolta in 18 righe (p. 39). Il loro atteggiamento sociologico, tipicamente miope verso la comunicazione (p. 19, ultime tre righe), prevale su tutti gli altri, anche nel cap. 9, dedicato a “Comunicazione e conflitto”. Con una pagina (la 20) gli autori riportano la teoria di Galtung, ma solo per presentare una tra le tante classificazioni che essi danno sui conflitti (non verrà più ripresa; poi Galtung verrà citato più volte, ma per singoli contributi alla teorizzazione dei conflitti). Né parlano dei quattro modelli di sviluppo di Galtung, nonostante essi considerino “quattro formazioni conflittuali” (pp. 18-19) e quattro “tipi di conflitti” (par. 3.1). D’altronde essi lo citano cambiandolo: mentre in Galtung A e B sono personali e C riguarda la relazione conflittuale, in loro B e C sono personali mentre A è nella relazione conflittuale. In generale la soluzione dei conflitti (motivati con “bisogni”, benché malamente definibili, par. 2.3) è appoggiata sulla “fiducia” (da porre in C, al posto della sofferenza deprimente) e sulla “cooperazione” (come atti di B). Ma gli autori non sanno spiegare come fiducia e cooperazione possano appartenere ad una persona. La nonviolenza viene presentata non all’inizio per trovarci indicazioni teoriche, ma solo alla fine (pp. 218-222), quasi come omaggio ad una particolare suggestione. Correttamente essa viene collocata non solo a livello personale, ma anche come metodo di lotta sociale e come rifondazione della società (però manca la caratteristica politica della nonviolenza: l’alternativa al tipo di sviluppo occidentale). Poi essi cercano di interpretarla con quanto hanno cerca- 5 E’ anche quanto nota un autorevole studioso nel suo ultimo libro. Martin B., Nonviolent Communicating Against Repression, Cresskill NJ, Hampton P., 2003. Per ora tralascio i sociologi, perché con la loro pretesa di oggettività, vedono quasi solamente la comunicazione sociale dei mass media. 6 Tra i vari suoi scritti scelgo quello più recente. Patfoort P., “Non possiamo cambiare il passato, ma possiamo cambiare il futuro” in «Satyagraha» , n. 2, 2002, pp. 44-58. Parte 5 - Conflitti costruttivi e distruttivi nella coppia e nella famiglia 149 to di costruire in precedenza; la nonviolenza sarebbe “autolimitazione” (dei bisogni fondamentali, A), “rafforzamento delle proprie qualità” (da intendere come B; è il gandhiano ‘programma sociale costruttivo’), ed infine “profonda disponibilità al dialogo”, visto come il prodotto della “fede” di saper portare ad una “conversione”; e quindi “fiducia” e “cooperazione” (cioè C). Ma tutte queste caratteristiche sono conseguenza della “fede”, della quale gli autori mai hanno parlato in precedenza e che di certo non possono essere attinti gratis dalla vita quotidiana. Allora, o la nonviolenza è semplicemente un cappello alla soluzione dei conflitti, o gli autori hanno mancato di chiarire il sostegno di ciò che essi vogliono. 5.4.7. La comunicazione nei trainings nonviolenti Le azioni compiute nel teatro, role-playing, psicodramma e trainings sono solo simboli di quelle della realtà. In questo contesto artificioso, il tema della comunicazione durante un conflitto viene proposto ai partecipanti in una maniera del tutto appariscente, e anche ludica. Che valore dare alla comunicazione in un training nel quale, ad esempio, un condannato a morte si rivolge al suo giustiziere in una maniera che deve risultare solamente non incredibile7? Ovviamente ciò comporta che anche le soluzioni individuate dei conflitti rappresentati siano degli artefatti; pertanto esse hanno un valore educativo minimo. In particolare il training non forma ad avere delle A, cioè delle convinzioni; ma piuttosto ad assumere qualsiasi A; il che è educazione alla teatralità e alla politica della mediazione, ma non all’adesione alla verità (satyagraha) e alla politica di principio. Eppure questa pratica del training è molto diffusa, per sostituire sia la comunicazione verbale diretta (che invero nella realtà è spesso impacciata) sia quella di un maestro (qualificata malamente come “frontale”, parola che include il sospetto di una prevaricazione). C’è da temere una caduta verticale della pedagogia della comunicazione tra i nonviolenti. 5.4.8. Interpretazione di questa decadenza Perché questa tendenza, teorica e pratica? Ricercando una spiegazione di tipo strutturale, si può notare un passaggio storico. I maestri della nonviolenza avevano indirizzato alla comprensione della nonviolenza nei rapporti interpersonali, sottolineando soprattutto il lavoro preliminare e personale. Ma le istituzioni occidentali interagendo attraverso rapporti anonimi, impediscono il rapporto dialogico, sin dal suo sorgere. Dagli anni Sessanta Galtung ha chiarito che alla violenza interpersonale occorre aggiungere la violenza strutturale, quella esercitata dalle istituzioni; la quale è ancor più pervasiva ed efficace di quella interpersonale. Allora i teorici della soluzione nonviolenta, per adattarla al mondo istituzionale occidentale, hanno considerato sempre di più l’aspetto della comunicazione che è visto dalle istituzioni: l’azione. A questo punto si presenta un bivio: la comunicazione sarebbe importante solo nei rapporti interpersonali, ma non nei conflitti con le istituzioni, dove invece conterebbero le azioni, possibilmente di massa? 7 Ho espresso più dettagliatamente una prima analisi critica dei trainings in: Un contributo critico, in Euli E., Soriga A. e Sechi P.G., Reti di formazione alla nonviolenza, Pangea, Torino 1999, pp. 233-240. 150 Comunicazione e Nonviolenza Nella nonviolenza di Gandhi non ci sono stati jati tra personale e strutturale. Per cui la comunicazione, sia pur mutatis mutandis, deve essere ritrovata anche nella lotta tra e contro le strutture, le istituzioni; allora occorre sapere definire la comunicazione anche sociale, magari volta per volta; cioè teorizzare come cambi il tema della comunicazione per la soluzione nonviolenta nel passare dal personale allo strutturale. Più in generale una teoria nonviolenta, per passare dei rapporti interpersonali allo strutturale, ha il problema di darsi una teoria sociale. Di essa Galtung ha già dato lo schema di riferimento: i quattro modelli di sviluppo, dei quali quello nonviolento è il verde8. Ma mancano le analisi delle articolazioni della società in settori e nelle istituzioni intermedie. Allora qui c’è una precisa direzione di ricerca, nella quale lo studio sociologico e antropologico della comunicazione sociale ha il ruolo principale. 5.4.9. Riferimenti bibliografici Amato F., Drago A., Marxismo e nonviolenza, in AA.VV., Marxismo e Nonviolenza, La Lanterna, 1977. Arielli E., Scotto G., I conflitti. Introduzione a una teoria generale, Bruno Mondadori, Milano 1998. Bottone A., Drago A., Una nuova interpretazione del pensiero di Capitini: oltre la dialettica hegeliana (pre-print). Cacioppo G., Il messaggio di Aldo Capitini, Lacaita, Manduria 1977. Drago A., Un contributo critico, in Euli E., Soriga A. e Sechi P.G., Reti di formazione alla nonviolenza, Pangea, Torino 1999. Drago A., Zerbino E., Sull’interpretazione metodologica del discorso freudiano, in «Rivista di Psicologia, Neurologia e Psichiatria», n. 57, 1996. Drago A., A paradigm-shift in conflict resolution: War and peace from a history of science viewpoint, in Koller P., Puhl E. (eds.), Current Issues in Political Philosophy, 19th Int. Wittgenstein Symposium, Kirchberg 1996. Drago A., Soccio D., Il cambiamento di paradigma nella risoluzione dei conflitti, in Per un modello alternativo di difesa nonviolenta, Editoria Universitaria, Venezia 1995. Galtung J., Conflict Transformation by Peaceful Means, UNDP, New York 2000 (La Trasformazione dei Conflitti con mezzi pacifici, EGA, Torino 2000). Lanza del Vasto G., La Trinité Spirituelle, Denoël, Paris 1973. Lanza del Vasto G., Che cosa è la nonviolenza, Jaca Book, Milano 1978. Lanza del Vasto G., Vinoba, o il nuovo pellegrinaggio, Jaca Book, Milano 1980. Lanza del Vasto G., I quattro Flagelli, SEI, Torino 1996. 8 C’è un esempio nel passato: Don Milani ha dato le analisi di due settori, il difensivo e l’educativo, all’interno di una comunicazione personale (lettere). Parte 5 - Conflitti costruttivi e distruttivi nella coppia e nella famiglia 151 Martin B., Nonviolent Communicating Against Repression, Hampton P, Cresskill NJ. 2003. Mellon C., Sémelin J., La Non-violence, PUF, Paris 1999. Patfoort P., Non possiamo cambiare il passato, ma possiamo cambiare il futuro, in «Satyagraha» n.2, 2002. Pontara G., Il satyagraha. Definizione di violenza e nonviolenza nei conflitti sociali, Movimento Nonviolento, Edizioni del movimento non violento, Perugia 1983. 152 Comunicazione e Nonviolenza 5.5. LA COMUNICAZIONE VIOLENTA La rabbia come allarme ed antidoto alla violenza di Fiorella Tonello I tipi di comunicazione che gli individui usano determina la qualità dei rapporti tra di loro. Ci troviamo di fronte a due tipi di comunicazione che possono apparire antitetici ma che in realtà sono vasi comunicanti, che si possono alimentare reciprocamente. Ci muoviamo continuamente su due livelli di comunicazione: uno interno e l’altro esterno. Quando si dice che comunichiamo con noi stessi, che cosa effettivamente avviene lo sappiamo in parte poiché dipende da quanto ci lasciamo condurre dai nostri bisogni e quanto seguiamo ciò che gli altri vogliono da noi: quindi queste due istanze che sono costantemente presenti in noi si giocano il posto d’onore tra loro in modo continuativo. Questi due livelli sono continuamente intrecciati: quando comunichiamo con noi stessi, cerchiamo sintesi e mediazioni fra i nostri bisogni e quello che gli altri vogliono da noi, quindi interno ed esterno sono continuamente presenti. Quando parliamo con altri non sono solo persone che vivono e si muovono intorno a noi, ma appartengono in parte al nostro mondo interno. A volte invece ci lasciamo trasportare da chi ci convince, senza veramente ascoltarci e quindi non rispondiamo in modo da esserci veramente nella comunicazione. Quando si parla di “esserci nella comunicazione” si intende una presenza che coinvolge il nostro essere nella realtà contingente, nel “qui ed ora”, un momento unico e irripetibile che chiede una risposta congrua. Cogliere questi attimi è fondamentale ed importante per costruire un modo adeguato di rapportarsi al mondo e sembra uno degli esercizi più difficili: può richiedere molto tempo riuscire a muoversi rapidamente in sintonia con la realtà, e peraltro necessita esercizio. In che modo la rabbia può essere un allarme, come ho detto nel titolo, e come evitare reazioni o atti violenti? La rabbia è spesso un impulso non controllato dal soggetto, che si trova in non poche occasioni a subirne le conseguenze, magari senza nemmeno averne capito le cause. A questo punto mi ricollego al momento in cui parlavo di mettersi in contatto con i nostri bisogni: sono queste le guide del nostro agire nel mondo. Quando non si ascoltano le proprie istanze interne, il nostro agire diventa stereotipato e risultiamo scollegati da noi stessi. Un comportamento di questo tipo produce inoltre la frustrazione di non essere considerato, di non essere visto... Ecco che succede che si possono creare manifestazioni di istinti come l’aggressività, la rabbia che generalmente etichettiamo come negativi, pericolosi perché ci avvicinano ad un mondo animale che ci fa paura. Questa pulsione combattiva é presente sia nell’animale che nell’ uomo ed in entrambi é spesso diretta contro appartenenti alla stessa specie: a questo proposito Lorenz che ha prodotto eccellenti studi al riguardo considera l’aggressività - i cui effetti vengono spesso avvicinati a quelli dell’istinto di morte - un istinto come ogni altro e in condizioni normali anch’esso al servizio dell’individuo e della specie. Nell’uomo il meccanismo si complica poiché la struttu- Parte 5 - Conflitti costruttivi e distruttivi nella coppia e nella famiglia 153 ra culturale e sociale si mescola a quella degli istinti creando un groviglio di effetti reciproci che rendono più difficile l’individuazione dei nessi casuali e l’accettazione di far parte di un universo ed essere sottoposto a leggi naturali. Queste emozioni primariamente ci fanno paura per la modalità con cui si presentano a livello fisiologico. Prendiamo come esempio la rabbia, essa si manifesta nei modi più svariati: l’attività cardiaca e la circolazione sono sempre alterate; la faccia arrossisce e diventa purpurea e le vene della fronte e del collo si dilatano. L’arrossamento della pelle è stato osservato nei pellerossa del Sud America e anche nei negri, dice Darwin, nei quali si arrossano anche le cicatrici bianche lasciate da vecchie ferite; e pure le scimmie diventano rosse per la rabbia. Come ci dimostra Darwin questa emozione e la sua espressione è manifestata nella stessa maniera in tutto il mondo. Se si parlava prima della sofferenza del non essere visti, si può parlare delle conseguenze che una carenza di contatto con se stessi e una sua perdita sono da considerarsi fra i fattori più determinanti di aggressività e rabbia. Se parliamo oggi di capacità proprie del sistema nervoso di produrre stimoli senza aspettare di riceverne dall’esterno, e quindi la reazione non è l’unico comportamento, abbiamo la possibilità di rispondere a come mai succede che dopo una lunga inattività di un comportamento istintivo il valore di soglia degli stimoli che lo innescano si abbassa. Ogni vero movimento istintivo, privato nel modo sopra esposto della possibilità di sfogo, ha la proprietà di rendere tutto l’organismo animale inquieto e di fargli cercare attivamente gli stimoli che innescano quel movimento. Lorenz parla di “ingorgo” dell’attività istintiva, che ha luogo dopo una lunga assenza degli stimoli che la innescano, che provoca sia un aumento della propensione ad agire ma anche processi più radicali che coinvolgono l’intero organismo. Quindi se valutiamo tutto questo in una visione d’insieme, la rabbia e l’aggressività non risultano poi manifestazioni così pericolose, bensì funzionali non solo per la conservazione della vita in senso stretto ma, aggiungerei, per una migliore qualità della vita. La rabbia accumulata può scegliere il suo oggetto di scarica, e si possono avere oggetti “vicarianti” e quindi si creano le cosiddette azioni sostitutive; vorrei portare un esempio mutuato dalla etologia. Un pesciolino isolato, non potendo più aggredire i suoi simili, scarica la sua tensione con azioni sostitutive quali mordere il fondo della vasca. In realtà la ri-direzione dell’attacco è l’espediente più geniale che l’evoluzione abbia inventato per costringere l’aggressività su binari innocui. Ci sono stati molti teorici che nel corso del tempo hanno cercato di dimostrare che le pulsioni fondamentali sono “buone e sociali”, esagerando e schierandosi così dalla parte degli angeli; in realtà ciò che è accaduto negli ultimi cinquant’anni è una rivoluzione straordinaria nei costumi e nelle valutazioni sociali, di modo che gran parte di quel che una volta veniva considerato cattivo non lo è più. L’uomo non cerca di essere buono, il buono consiste in ciò che è oggetto dei tentativi umani. Possiamo dedurre che nella formazione della personalità i fattori sociali sono essenziali: in questo senso un comportamento personale è anti-sociale nel pieno significato del termine se tende a distruggere qualche aspetto delle consuetudini o della personalità correnti in un luogo o in un tempo dati. 154 Comunicazione e Nonviolenza In terapia dobbiamo assumere che un comportamento delinquenziale che sta in contraddizione con la natura sociale di un individuo possa essere modificabile e che i suoi aspetti violenti svaniranno con un’ulteriore integrazione. Se si parla di integrazione, l’individuo che cerca con sforzo ancora maggiore di adattare la società a se stesso invece che adattare se stesso alla società, rimane un problema aperto e non risolutivo. Prendiamo come esempio la rabbia, un’emozione socialmente poco apprezzata, che possiamo sentire verso una persona cara. Spesso succede che non la vogliamo accettare e la proiettiamo sugli altri proprio per l’intensità distruttiva che noi le attribuiamo e quindi viene inibita la pulsione. Contrariamente, se la rabbia viene liberata e accettata come parte di noi stessi, si rivela diversa ai nostri occhi, meno pericolosa, meno antisociale di quanto pensavamo: l’atto di rimuovere è in realtà un atto di aggressione verso di sé e questa aggressività può essere invece attribuita alla pulsione. La rabbia contiene in sé componenti aggressive come distruzione, annientamento e iniziativa; quest’ultima dà calore alla rabbia. In un primo momento l’ostacolo viene considerato semplicemente come parte della forma esistente da distruggere, e viene aggredito con un calore piacevole. Man mano che diventa manifesta la natura frustrante dell’ostacolo, la tensione in atto del sè impegnato diventa dolorosa, e all’appetito caldo e distruttivo viene aggiunto il bisogno freddo di annientare. Talvolta si trascende completamente l’appetito, cioè il movimento verso la meta, e si giunge ad una furia feroce ed incandescente. In generale la rabbia è una passione simpatetica: unisce le persone perché è mischiata con il desiderio. Quando avviene una rimozione del desiderio e il trascendere di quest’ultimo, allora il sé è completamente impegnato in un attacco ostile, e se la rimozione si dissolvesse all’improvviso perchè ci si sente più al sicuro....il desiderio improvvisamente si cristallizzerebbe in amore. A questo proposito, la formula che sentiamo spesso ripetere: “la frustrazione dà luogo all’ostilità” è vera ma troppo semplicistica, poiché omette di menzionare l’appetito caldo della aggressività rabbiosa! Il passaggio più difficile da comprendere e da elaborare è perché la rabbia, o una disponibilità ad arrabbiarsi, persista una volta che l’annientamento dell’ostacolo è stato efficacemente raggiunto. Infatti un figlio può essere arrabbiato con i genitori seppure morti perché essi costituiscono ancora parte del bisogno incompiuto: non è sufficiente per lui capire che, in quanto ostacoli, essi sono stati eliminati. E la vittima della vendetta e dell’odio è una parte del proprio sé, inconsapevolmente amato. In ogni caso, è la mescolanza dell’annientamento con l’ira che fa insorgere un senso di colpa così intenso nei confronti di oggetti difficili ma amati; quello che succede è che non possiamo permetterci di annientare, di ridurre al nulla, ciò di cui abbiamo bisogno, anche quando ne riceviamo delle frustrazioni. Diventa chiaro il meccanismo per cui la rabbia persistente, che unisce l’appetito e l’annientamento, dà luogo all’inibizione completa dell’appetito e costituisce una causa comune dell’impotenza, dell’inversione di tendenza e così via... La rabbia, come la distruzione, l’iniziativa e l’annientamento, sono tutte funzioni del buon contatto, necessarie per la sussistenza, la protezione di ogni organismo in un campo difficol- Parte 5 - Conflitti costruttivi e distruttivi nella coppia e nella famiglia 155 toso perché abbiamo anche della componente di piacere in esse. Nel compiere le aggressioni, l’organismo si gonfia, per così dire, e tocca l’ambiente, senza danneggiare il sé; l’atto di inibire le aggressioni non le estirpa ma le volge contro il sé: senza l’aggressività, l’amore si intorpidisce e diventa privo di contatto, poiché l’atto di distruggere costituisce un mezzo di rinnovamento. In generale, quando un appetito è rimosso, cioè mantenuto inconsapevole, il sé esercita un’ostilità fissata contro se stesso. Parte 6 La violenza sul lavoro e nella società civile Parte 6 - La violenza sul lavoro e nella società civile 159 6.1. LA COMUNICAZIONE AGITA COME RISORSA PER GESTIRE I CONFLITTI di Carlo Bandiera 6.1.1. Premessa La trattazione che intendo proporre richiede il riferimento, seppur in forma estremamente sintetica, a due aspetti (più propriamente due elaborazioni concettuali) che influenzano in maniera determinante, a mio avviso, l’efficacia della comunicazione attuale. 1. La comprensione della nuova realtà socio-relazionale in un’ottica cognitiva e la sua applicazione nell’ambito dei fenomeni comunicativo-relazionali. Faccio riferimento alla necessità, che la realtà ci impone, di passare da una impostazione cognitiva di “conciliazione tra gli opposti” ad una di “gestione dei duali”. Si è passati in questi ultimi anni da una realtà la cui comprensione rendeva indispensabile la capacità di conciliare una fase passiva (cfr. l’ascolto) con una fase attiva (cfr. l’esplicitazione comunicativa) ad una realtà in cui vigono i duali (cfr. ascolto/relazione, locale/globale, pluralismo/soggettivismo, pubblico/privato…) che, come dice il nome, sono due aspetti discordanti ma solo apparentemente contrapposti. E’ evidente che questa nuova realtà necessita di una trasformazione culturale ancora non del tutto attuata. 2. I risultati della ricerca “Competere nel 2000” ed in particolare la loro applicazione allo specifico comunicativo (Il testo “Comunicare nel 2000” scritto con Laura Marozzi li riporta in maniera esauriente). Tale ricerca evidenzia che i fattori critici competitivi per l’inizio degli Anni Duemila sono: il Tempo, il Metodo e la Creatività, che vanno declinati poi nei vari ambiti tematici di applicazione. 6.1.2. Personalizzazione “competere nel 2000” La personalizzazione dei risultati della ricerca “Competere nel 2000” al tema oggetto di questa relazione conduce alla necessità di considerare: 1. Il tempo, in una visione non processuale; ciò significa non riconoscere valore ai trend - imperniati sull’evolversi passato/presente/futuro - ma dar valore all’analisi di vari presenti in differenti ambiti. Mentre in passato si poneva attenzione ai processi e quindi alla continuità, oggi sempre di più si pone attenzione alle discontinuità, quindi a tutto ciò che non è processuale. D’altronde i processi evocano azioni sequenziali, mentre il non processuale evoca azioni parallele. Ogni qualvolta la complessità cresce, quando cioè vari sistemi alternativi interagiscono l’uno con l’altro, è necessario basarsi su logiche parallele, non processuali. 2. La creatività, basata su quelle tecniche che aiutano maggiormente a reimpostare gli aspetti alla base del conflitto. La quantità di creatività che si mette in gioco in un’attività, sia essa un processo pro- 160 Comunicazione e Nonviolenza duttivo o creativo, determina anche il suo posizionamento e quindi la sua capacità di reimpostare i termini di base di una questione o, nello specifico, di un conflitto. La personalizzazione dell’apporto creativo in questo ambito va intesa come la necessità di ricercare la tecnica creativa che risulti di maggior ausilio alla tipologia del conflitto in studio. 3. Il metodo, inteso come la personalizzazione delle logiche operative di successo ovverosia la modalità di individuare quegli aspetti culturali di un ambiente che più lo caratterizzano. Il metodo è la variabile che sta cambiando profondamente il modo di essere della comunicazione: si sta fortemente scindendo quella che si chiama arte della comunicazione (quindi piacere del comunicare o comunicazione intesa come mettersi in rapporto), dalla comunicazione come tecnica, capace cioè di estrarre e diffondere gli aspetti che più caratterizzano l’ambiente oggetto di studio e raggiungere così l’obiettivo prefissato. L’aspetto innovativo non è solo nell’efficienza della comunicazione, ma anche nella oggettualizzazione della comunicazione: la comunicazione diviene il fine, l’elemento caratterizzante il processo intrapreso e, come tale, deve precedere sempre l’evento, l’oggetto, il prodotto/servizio o, comunque, l’elemento che si pone come finalità del processo stesso. 6.1.3. La metodologia precomunicativa Quanto sopra esposto può essere la base concettuale sulla quale innescare due studi/ricerche che consentano di comprendere al meglio l’ambiente oggetto dello studio. Uno studio è volto a rilevare gli aspetti caratterizzanti le specifiche culture in gioco, con particolare riferimento alla declinazione dei principali valori rilevati negli specifici ambiti. In una società in cui si debbano “gestire i duali” è fondamentale parlare di valori e non di interessi. In una società pluralista, per di più inserita in un processo di globalizzazione, in cui i soggettivismi di necessità tendono ad emergere, la logica della comunicazione rivolta ai portatori di interessi viene vanificata dalla impossibilità di dialogo contemporaneo con tutti i soggetti e quindi la logica della comunicazione dei valori diventa l’unica perseguibile. L’operatività è resa possibile solo a seguito della rilevazione dei valori in gioco. La compilazione, per ogni differente cultura, di una matrice che riporti in ascisse i valori fondamentali rilevati ed in ordinate la declinazione degli stessi negli specifici ambiti risulta essere la modalità operativa appropriata (Modalità del tutto simile a quella in uso per strutturare una matrice di successo utilizzando le logiche operative di successo.) L’altro studio è rivolto invece ad individuare le regole di autorevolezza nelle specifiche culture. Tale studio è teso a rilevare quei fattori che più contribuiscono ad imporre o ad accrescere la rilevanza di un dato valore; elemento questo assolutamente imprescindibile in quanto con- Parte 6 - La violenza sul lavoro e nella società civile 161 sente di attribuire una gerarchia di rilevanza ai valori in essere o in accrescimento. 6.1.4. Regola ed azioni comunicative Se i due studi/ricerche sono stati eseguiti correttamente è possibile procedere alla fase operativa. Tale fase consta dell’applicazione di una regola, valida in tutti i casi in cui il riferimento siano le logiche operative di successo, e della ricerca dell’appropriato modello di relazione su cui impostare azioni comunicative congruenti. La regola di base è la seguente: una comunicazione, culturalmente ed autorevolmente caratterizzata, sui valori in gioco deve sempre precedere l’azione. L’emergere di tutte le componenti valoriali in gioco, liberamente espresse dai vari soggetti, sottoposte poi ad un processo di composizione relazionale creativo con quanto emerso dagli studi/ricerche effettuati, fornisce le basi per ridefinire caso per caso quel “modello di relazione” che consente di gestire ed anche prevenire il conflitto nel particolare ambiente. Una volta definito il modello di relazione ottimale è difatti possibile attuare una comunicazione che inglobi quelle caratteristiche che la fanno naturalmente assurgere al ruolo di strumento fondamentale per la prevenzione dei conflitti. Di seguito è proposto il processo schematizzato1. La comunicazione agita come risorsa per gestire i conflitti PREMESSA La comunicazione agita come risorsa per gestire i conflitti Personalizzazione “Competere nel 2000” • Modernità ⇒ da conciliazione tra opposti a gestione dei duali ( ascolto/relazione, pluralismo/soggettivismo, locale/globale, privato/pubblico…) Su ciò è necessario lavorare per “accettazione culturale” • Risultati ricerca “Competere nel 2000” Fattori competitivi: . Tempo . Metodo . Creatività La comunicazione agita come risorsa per gestire i conflitti La metodologia precomunicativa Utilizzo di due studi/strumenti: • Rilevazione aspetti caratterizzanti le culture in gioco, in particolare individuazione valori agiti nei vari ambiti e loro declinazione in essi ( compilazione matrice valori/ambiti di riferimento d’interesse con declinazione valori per ambiti d’interesse ) • Rilevazione delle regole di autorevolezza nelle culture in gioco (individuazione fattori che fanno imporre o accrescono la rilevanza di un valore) 1 ⇒ passaggio da processuale a non processuale • Metodo ⇒ utilizzo “logiche operative di • Tempo successo ” (saper estrarre quelle caratteristiche che più individuano lo specifico ambiente) • Creatività ⇒ scelta tecniche creative pi ù efficaci per reimpostare gli aspetti a base del conflitto La comunicazione agita come risorsa per gestire i conflitti Regole ed azioni comunicative (In una società pluralista con soggettivismi emergenti il “modello di relazione” deve essere reimpostato ) • Regola (sempre valida nel caso di utilizzo di “logiche operative di successo”) una comunicazione sui valori propri ed in gioco, culturalmente ed autorevolmente caratterizzata, deve sempre precedere l’azione , per indirizzarla • Azioni comunicative va studiato caso per caso , in relazione ai valori emersi ed usualmente utilizzando tecniche creative, il “modello di relazione” da seguire e le congruenti azioni comunicative Per le nozioni di base sulle logiche operative di successo e Competere nel 2000 si può consultare il testo: Bandiera C., Marozzi L., Comunicare nel 2000, Franco Angeli, Milano 1999. 162 Comunicazione e Nonviolenza 6.2. IL MOBBING Una trappola della comunicazione e un’atipica sfida per la nonviolenza di Giuseppe Mani Monteverde 6.2.1. Introduzione Il mobbing1 ovvero il terrorismo psicologico sul posto di lavoro, è un conflitto sociale e quotidiano trascurato a livello istituzionale e dimenticato nell’ambito della nonviolenza, anche se in Italia è particolarmente diffuso per motivi culturali e per il problema della disoccupazione. I primi studi su tale fenomeno sono di C. Brodosky nel 1976 in Canada, mentre in Europa fu lo svedese H. Leymann, nella seconda metà degli anni Ottanta, ad analizzare il mobbing. E’ da notare che il mobbing rientra nell’ambito delle perversioni morali, come, tra l’altro, il bullismo2, le molestie morali3 e lo stalking4. Per motivi di brevità questa relazione avrà una struttura schematica nella forma e nei contenuti, in quanto ritengo che sia necessario accennare ai molteplici aspetti del mobbing per così divulgare maggiormente la conoscenza di questo problema. Invero, se affrontassi tale fenomeno soltanto in rapporto alla comunicazione e alla nonviolenza, rischierei di proporre degli argomenti troppo riduttivi. Il mobbing è infatti una realtà ancora troppo sconosciuta e confusa per essere considerata, anche se in modo approfondito, solo settorialmente. 6.2.2. Che cos’è il mobbing? a) Definizioni5 Il mobbing (dall’inglese: to mob: l’aggredire, l’accerchiare di una folla tumultuosa) consiste in una comunicazione conflittuale sul posto di lavoro tra colleghi (mobbing orizzontale) o tra superiori e dipendenti (mobbing dall’alto) e viceversa (mobbing dal basso). La vittima viene posta in una posizione di debolezza, aggredita, isolata, emarginata, discriminata e danneggiata direttamente o indirettamente da una o più persone in modo sistematico, frequentemente e per un lungo periodo di tempo, con strategie volte alla sua distruzione psicologica, sociale e professionale e con lo scopo e/o la conseguenza della sua estromissione dal posto di lavoro. E’ quindi un lungo processo di terrore psicologico sul posto di lavoro, in cui il sistema delle relazioni tra gli individui si caratterizza in un’escalation in base a una serie ripetuta di strate- 1 Termine coniato dall’etologo K. Lorenz nel 1971: indica l’attacco in modo sistematico di un gruppo di animali di taglia più piccola ai danni di un altro animale di dimensioni maggiori. Cfr. Depolo, 2003, pp. 17-18; Baldassarri - Depolo, 1999. 2 Cfr., Marini - Mameli, 1999, pp. 45-56; Depolo, 2003, pp. 18-20. 3 Cfr., Hirigoyen, 2000, pp. 5-6. 4 Ferraris, 2001, pp. 18-25. 5 Mi sono liberamente ispirato per le definizioni del mobbing e del bossing ai seguenti autori: Ege, 1996, pp. 510; Ege, 2001, p. 25; Depolo, 2003, pp. 26-28; Baldassarri - Depolo, 1999. Parte 6 - La violenza sul lavoro e nella società civile 163 gie negative stabili, subdole e spesso irrazionali e che ha per origine un conflitto non risolto e non dichiarato. Il bossing è una forma di mobbing programmata dall’azienda che ha per scopo d’indurre la vittima a dimettersi in vista di una riduzione dei posti di lavoro, eludendo nel contempo le vertenze sindacali e legali. b)Le sei fasi + 2 del mobbing * La condizione zero (pre-fase): è un conflitto quotidiano sul posto di lavoro derivante dalla “legge della giungla”. 1. Conflitto mirato: esso ha una scopo ed è canalizzato contro qualcuno di preciso e diventa soggettivo. 2. Inizio del mobbing: gli attacchi creano un senso di disagio e di fastidio, senso di colpa, terrore parossistico di sbagliare. 3. Primi sintomi psicosomatici: insonnia, insicurezza, patologie gastrointestinali, attacchi di panico, mal di schiena, emicranie, stress,… 4. Errori di valutazione e abusi dell’amministrazione del personale: il conflitto diventa pubblico e a sfavore della vittima. * Doppio mobbing: la vittima non gode più del sostegno psicofisico della famiglia e degli amici, che lo attaccano per difendersi dalla sua depressione. 5. Serio aggravamento della salute psicofisica della vittima, anche irreversibile: depressione e auto-colpevolizzazione generale, burnout. 6. Esclusione dal mondo del lavoro, dropping out e depressione totale. c) Attori e indifferenza degli spettatori Il mobber è l’aggressore. Le sue motivazioni sono importanti da riconoscere solo per difendersi o bloccarlo meglio e non per giustificarlo, poiché compie un atto perverso e criminale. Il mobbizzato è la vittima. Chiunque prima o poi può essere mobbizzato e soprattutto non vi sono delle categorie a rischio a priori: è sufficiente essere nel posto sbagliato al momento sbagliato per essere attaccati. Gli spettatori vengono sempre coinvolti nel conflitto, anche se indirettamente o a loro insaputa, per via della distorsione comunicativa o per interessi personali. Gli spettatori attivi sono i side-mobber, cioè coloro che appoggiano direttamente i mobber per motivi propri o perché manovrati. Gli altri si appartano dal conflitto per indifferenza o per non essere a loro volta mobbizzati isolando ulteriormente la vittima. 6.2.3. Il mobbing: motivazioni di un conflitto perverso e falsificazione della comunicazione Le motivazioni possono essere varie, tuttavia rientrano in due categorie principali: quelle oggettive (carriera, soldi, paura di essere estromesso dall’azienda,...) e quelle soggettive (narcisismo, desiderio di predazione o persecuzione - stalking -, invidia, gelosia,...). Queste ultime motivazioni possono sommarsi o incentivare le altre, però vi è sempre una perversione morale di fondo. Inoltre vi è una proiezione narcisista sulla vittima dei propri difetti e conflitti. 164 Comunicazione e Nonviolenza La falsificazione della comunicazione e l’isolamento comunicativo (Jelfs, 1993, pp. 63-67) sono i cardini del mobbing. Infatti vi è una mancanza di comunicazione voluta e un isolamento della vittima (diffamazione, sabotaggi, aggressione fisica, cattiverie di ogni genere). E’ un attacco totale, una guerra, un tentativo di omicidio psichico. A causa della distorsione subdola della comunicazione, il mobbing non è prontamente individuabile; anzi l’aggressore attacca senza lasciare indizi e la vittima non immagina o rifiuta di credere di essere attaccata e quando se ne accorge è troppo tardi. Spesso il mobbizzato nega di esserlo, o perché non riesce a immaginare tanta cattiveria o perché ammetterlo significherebbe veder crollare il suo mondo in quanto fallimentare. Dovrebbe infatti cercarsi un altro posto di lavoro, ma, se ha una certa età, una famiglia da mantenere e una formazione lavorativa non flessibile, egli piuttosto preferirà negare l’esistenza del mobbing e resisterà fino allo sfinimento. 6.2.4. La legge del più forte proiettata nello status lavorativo, frutto di una cultura del vincente Il mobbing è una perversione morale in cui la vittima è colpevolizzata perché perdente e l’aggressore giustificato ed elogiato perché vincente; ciò è possibile in quanto vi è un fenomeno sociale sottostante: la legge della giungla o del più forte derivanti - e nel contempo giustificati - dal mito del successo. Il mobbing deriva da un abuso della forza o del potere per soggiogare la vittima seguendo lo schema Maggiore-minore, da cui scaturisce una catena della violenza (Patfoort, 1995, pp. 1745). Il mobbizzato in questo clima terroristico, nel quale si sente perdente, accentua le proprie debolezze psicofisiche: se soffre - anche se lievemente e saltuariamente - di mal di schiena, di disturbi gastrointestinali, di emicranie o di ansia, questi fenomeni si acutizzeranno. Inoltre il terrore di sbagliare porterà il mobbizzato a fare errori assurdi, che un tempo non avrebbe mai commesso. Egli potrà assumere atteggiamenti irrazionali e frenetici di compiacimento verso il mobber e gli spettatori o di aggressività, oppure di passività, che, al di fuori di questa atmosfera, non avrebbe mai avuto. Inoltre in questa situazione la vittima tenderà ad essere compulsiva e iperattiva o, al contrario, rimarrà paralizzata. Infine perderà la capacità di giudizio abituale nel valutare le situazioni, gli altri e se stessa, giustificando ulteriormente gli attacchi del mobber e inimicandosi gli spettatori e l’azienda. E’ da rilevare che i supporti medici, psicologici, psicanalitici o psichiatrici classici non valutano ancora a fondo il problema e tendono a colpevolizzare ulteriormente la vittima in quanto malata, masochista, nevrotica o paranoica. Chiunque può essere una potenziale vittima perché troppo brava, debole, sensibile, o anche per politica aziendale. In realtà, tutti possono essere almeno dei potenziali side-mobber. 6.2.5. Il mobbing e nonviolenza: difficoltà specifiche al mondo del lavoro Le principali difficoltà per la risoluzione di questa tipologia conflittuale derivano, sia dalla necessità della sopravvivenza in un ambito concorrenziale (Novara F. - Sarchielli G., 1996, pp. 189-324.) in piena crisi occupazionale, sia dalla regressione di un minimo etico in favo- Parte 6 - La violenza sul lavoro e nella società civile 165 re del mito del successo a tutti i costi. E’ un conflitto quantitativamente asimmetrico: potere spropositato del mobber e impotenza totale della vittima, a differenza dell’asimmetria qualitativa della nonviolenza che riguarda la diversità dei mezzi e dei fini. Il sistema d’Equivalenza (Patfoort, 1995, pp. 48-72) non esiste a priori in caso di bossing; mentre negli altri casi rimane una volontà di non risoluzione del conflitto. E’ da notare che l’azienda spesso diventa complice del mobber perché crede che il mobbing sia una forma di competizione produttiva lasciata al libero arbitrio dei propri dipendenti. Oppure essa constata il calo delle prestazioni della vittima e invece di cercare di capire l’origine di questo peggioramento, progetta di sostituirlo o lo considera il capro espiatorio. Questo insano atteggiamento proviene principalmente dalla cultura soggiacente al mondo del lavoro nella quale si suppone che chi diminuisce le proprie prestazioni o non riesce ad emergere è un perdente e quindi inadatto all’azienda. Mentre, se in questa situazione vi è un emergente (il mobber), egli viene corteggiato in quanto vincitore e perciò potenzialmente assai produttivo. Infine a livello legale il problema è l’accertamento del mobbing (Ege, 1996, pp. 61-69; Depolo, 2003, pp. 61-73; Hirigoyen, 2000, pp. 249-255), in quanto il mobber agisce in modo subdolo e senza lasciare tracce. I colleghi raramente sono disposti a testimoniare contro i mobber per paura di essere a loro volta mobbizzati. Inoltre, per l’azienda la vittima diventa un dipendente scomodo perché non più produttivo e soprattutto rappresenta un disagio diffuso in seno all’organizzazione. Ora, se il mobbizzato perde la causa sarà licenziato in tronco per giusta causa. Allora la sua situazione sarà probabilmente la seguente: distrutto psicologicamente e fisicamente, estromesso dal mondo del lavoro e affettivamente solo a causa del doppio mobbing. E’ la disfatta totale, il suicidio per la vittima si prospetta come una soluzione allettante. 6.2.6. Conclusione: elementi di prevenzione e di gestione E’ una sfida atipica per la nonviolenza perché il mobbing non riguarda direttamente l’ambito politico, morale, macroeconomico, pedagogico o familiare; bensì è un fenomeno interpersonale e microeconomico fortemente sostenuto culturalmente. E’ necessaria una comunicazione chiara e cautelativa sia per evitare le trappole della comunicazione (Liss, 1992, pp. 14-38) sia per smascherare il mobbing. Anche il jujitsu transazionale può rivelarsi assai utile6. Inoltre è necessaria una consulenza interna o esterna all’azienda per monitorare il clima lavorativo e per razionalizzare in conflitto. Solo da queste premesse è possibile generare un sistema d’Equivalenza nel quale vi sia preferibilmente anche un coinvolgimento positivo degli spettatori. In Italia, per contrastare questa realtà, è necessario dapprima divulgarla maggiormente ed evitare confusioni con altri fenomeni come le molestie sessuali, il burnout o lo stalking che possono essere le cause, gli strumenti o le conseguenze del mobbing, ma non sono la stessa cosa. 6 Per il concetto di jujitsu transazionale mi sono liberamente ispirato a: Sharp, 1997, III volume, pp. 185-212; Jelfs, 1993; James - Jongeward, 1985. 166 Comunicazione e Nonviolenza E’ necessaria una prevenzione, una diagnostica e una formazione nel mondo del lavoro e degli operatori sociali per bloccare il mobbing sul nascere. Ma, per attuare questa politica, le aziende devono accorgersi che le loro perdite a causa di questa perversione possono giungere fino all’80%. Mentre il legislatore deve considerare che il costo sociale per un mobbizzato allo stadio ultimo è di circa un milione di euro. E’ da constatare che il simbolo reale e concettuale per intraprendere una lotta contro il mobbing non è di tipo morale, bensì economico. Infatti sono i costi aziendali e sociali derivanti dal mobbing i veri punti di rottura e, quindi, di possibile svolta positiva7. 6.2.7. Riferimenti bibliografici Baldassarri B., Depolo M., Mobbing: veleno letale, in «Psicologia contemporanea», n. 152, 1999. Depolo M., Mobbing: quando la prevenzione è intervento. Aspetti giuridici e psicologici del fenomeno, Franco Angeli, Milano 2003. Ege H., Mobbing conoscerlo per vincerlo, Franco Angeli, Milano 2001. Ege H., Mobbing. Che cos’è il terrore psicologico sul posto del lavoro, Pitagora, Bologna 1996. Ferraris A.O., Stalker, il persecutore, in «Psicologia contemporanea», n. 164, 2001. Hirigoyen M.F., Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro, Einaudi, Torino 2000. James M., Jongeward D., Nati per vincere, analisi transazionale con esercizi di Gesthalt, EP, Torino 1985. Jelfs J., Tecniche di animazione di gruppo per la coesione nel gruppo e un’azione sociale non-violenta, ELLE DI CI, Torino1993. Liss J.K., La comunicazione ecologica. Manuale per la gestione dei gruppi di cambiamento sociale, La Meridiana, Molfetta 1992. Marini F., Mameli C., Il bullismo nelle scuole, Carrocci, Roma 1999. Novara F., Sarchielli G., Fondamenti di psicologia del lavoro, Il Mulino, Bologna 1996. Patfoort P., Costruitre la nonviolenza. Per una pedagogia dei conflitti, La Meridiana, Molfetta 1995. Sharp G., Politica dell’azione nonviolenta, EGA, Torino 1997. 7 Esistono già vari esempi di prevenzione e di gestione del mobbing all’estero. Ne cito solo due per brevità. La legge svedese di prevenzione e di repressione del mobbing è un esempio notevole di normativa contro il mobbing. Nelle “Disposizioni relative alle misure da adottare contro forme di persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro” del 1994 sono previste la figura dell’osservatore di reparto, il quale deve monitorare il clima lavorativo e troncare sul nascere le possibili iniziative mobbizzanti, e quella di un garante antimobbing. E’ interessante la soluzione intrapresa dalla Volkswagen, che ha voluto dei garanti antimobbing all’interno dell’azienda stessa. Parte 6 - La violenza sul lavoro e nella società civile 167 6.3. MIGLIORARE IL CLIMA AZIENDALE ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE di Iscander Micael Tinto Quando si parla di clima organizzativo si esprime un’idea analoga a quella di clima meteorologico; infatti il clima organizzativo possiamo immaginarlo come dato da una serie di fattori, variabili, la cui conoscenza permette di prevedere ad esempio, la maggiore incidenza di conflitti e litigi fra persone, oppure la presenza di collaborazione e di rapporti di reciproca fiducia. L’analisi del “clima aziendale” consiste nell’analisi dell’insieme delle caratteristiche stabili e durature che descrivono l’organizzazione e influenzano e condizionano il comportamento e la motivazione dei membri. Si tratta di un processo psicologico ossia di una misura percettiva intesa a descrivere la situazione organizzativa e le relazioni interpersonali. Questa analisi consente di conoscere i processi comportamentali di un certo sistema sociale, le credenze delle persone, i valori che li legano ossia il clima in cui lavorano. L’analisi del clima fa anche emergere i bisogni formativi delle persone: tutto viene integrato in modo da avviare un processo organico e sistematico al fine di creare un ambiente di lavoro sostenibile e positivo. In questo articolo mostreremo come attraverso l’analisi del clima organizzativo, sia possibile migliorare i rapporti tra le persone che operano in azienda quotidianamente, attraverso la comunicazione. Verranno presentate esperienze pratiche dalle quali si è sviluppato il presente scritto. L’indagine di Clima è un tipo di analisi organizzativa che viene caldamente suggerita ogni qualvolta si stiano intraprendendo processi di miglioramento e/o di riorganizzazione aziendale che abbiano tra le proprie finalità anche quelle di: - avere la condivisione diffusa della Vision aziendale tra il proprio personale con impatti chiari nelle azione e nelle scelte lavorative; - avere comportamenti orientati al team allargato (team unico verso un comune obiettivo); - avere una circolazione spontanea e veloce di comunicazioni ed informazioni intra-settoriali e inter-settoriali; - avere comportamenti collaborativi capaci di favorire la crescita sia individuale, sia collettiva; - avere comportamenti personali di ruolo flessibili in sviluppo ed in linea costante con le attese organizzative. L’azienda, in quanto “sistema socio-tecnico”, non può procedere all’attivazione di miglioramenti procedurali, o alla formulazione di obiettivi sempre più articolati ed esigenti a livello di partecipazione e di coinvolgimento del singolo, senza tener conto del reale “stato climatico” interno. Ogni intervento organizzativo avrà successo se prenderà atto, infatti, non della realtà “ogget- 168 Comunicazione e Nonviolenza tiva”, ma della realtà soggettiva; cioè di quella percepita dai componenti dell’organizzazione. Per questi ultimi la vera realtà non è quella raccontata da altri, bensì quella che loro stessi percepiscono e credono tale. Di conseguenza, qualsiasi intervento sia esso di sviluppo organizzativo, sia esso di sviluppo del potenziale e delle capacità delle risorse umane, non può prescindere da una precisa ed attenta raccolta di informazioni “soggettive” sulla situazione esistente. Il fine è di elaborare ed attivare piani e strategie di intervento realmente efficienti ed efficaci non solo nel per il breve ma anche per il medio e lungo periodo. 6.3.1. Alcune spiegazioni tecniche sull’indagine di clima In psicologia, per motivazione si intende la “spinta” a compiere un’azione che porti al soddisfacimento di un bisogno. In un’organizzazione con il livello di motivazione si indica il “livello di attrazione” che l’azienda è in grado di esercitare nei confronti dei suoi membri. - Quanto le persone si sentono spinte a rimanere nell’impresa? - Quanto si sentono spinte a dare il proprio contributo nella direzione desiderata dall’impresa? Così inteso, il livello di motivazione all’interno di un’organizzazione dipende dalla capacità di quest’ultima di soddisfare una serie di bisogni dei suoi membri, quali ad esempio: - bisogni di sicurezza (remunerazione); - bisogni di appartenenza (sentirsi parte di un gruppo); - bisogni di socializzazione (buoni rapporti con colleghi e superiori); - bisogni di stima (qualità, prestigio derivanti del proprio ruolo professionale); - bisogni di auto-realizzazione (corrispondenza tra attese organizzative e attese personali); - bisogni di potere (quanto la persona sente di contare nel contesto in cui opera) etc. L’indagine di clima è altamente significativa in quanto analizza nel dettaglio una serie di variabili in grado di dare la reale mappatura dei sentimenti organizzativi, delle propensioni ad agire, delle dinamiche relazionali e di potere esistenti, capaci di condizionare significativamente ed inevitabilmente la qualità e l’intensità dei processi lavorativi ed organizzativi. Le principali variabili indagate sono: - percezione della credibilità degli attori organizzativi (colleghi stretti di settore, colleghi di altri settori, responsabili diretti e direzione generale, organizzazione nell’insieme della sua Vision); - percezione soggettiva di potere, relativa a quanto ciascuno all’interno dell’organizzazione sente di poter contare (avere voce in capitolo), potendo quindi incidere sia nel proprio lavoro, sia nella propria organizzazione per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi (questa variabile è cruciale per l’efficienza organizzativa); Parte 6 - La violenza sul lavoro e nella società civile 169 - percezione dello stile di comando esistente (questa variabile è determinante per verificare “che tipo di clima si respira all’interno di un’organizzazione” e più precisamente: come circolano le informazioni, la qualità delle relazioni interpersonali, i livelli di stress, di partecipazione e/o di competitività tra le persone ed i reparti, etc.); - percezione di stress, cioè la percezione del soggetto di essere più o meno adeguato alle richieste (quali-quantitative) prestazionali provenienti dall’ambiente organizzativo in cui è inserito. Si ricorda che questa variabile è significativa per le valutazioni sui reali carichi di lavoro e per effettuare riorganizzazioni di ruolo maggiormente efficaci. Questa variabile infatti offre l’indicazione di quanto le persone percepiscano, ad esempio, come onerosa una situazione che magari rispetto alle attese organizzative non viene ritenuta come tale. Ma è solo facendo i conti con la percezione delle persone e quindi con la loro “realtà”, che è possibile attivare quegli interventi maggiormente idonei nel rapporto situazione/obiettivi; - percezione del sentimento di gruppo, cioè la propensione delle persone a lavorare più volentieri da sole, in coppia o in gruppo. Questo determina i livelli di efficacia nel raggiungimento di task collettivi (obiettivi aziendali) ed i livelli qualitativi con cui le attività vengono svolte (componenti affettive che determinano comportamenti favorenti invece che ostacolanti, comportamenti di collaborazione invece che conflittuali, etc.). 6.3.2. Alcuni esempi pratici L’intervento pratico, una volta presi i contatti con il committente, si sviluppa attraverso alcune fasi nelle quali sia la proprietà sia i collaboratori sono attivamente coinvolti in modo da creare subito una certa trasparenza nelle azioni da intraprendere, per evitare malintesi e situazioni di ulteriore conflitto. La fase di analisi consiste nella somministrazione di un questionario costituito da una settantina di domande a cui i candidati devono rispondere indicando quanto le frasi presentate siano vere o false, e successivamente attraverso un’intervista nella quale si chiede ai candidati quali sono i punti di forza, i punti di debolezza dell’azienda e quali sono i possibili miglioramenti da effettuare. Viene inoltre richiesto alle persone intervistate qual’è stata la prima impressione che hanno avuto entrando il primo giorno in azienda. “L’analisi delle idee” si basa sull’immagine che i dipendenti si fanno della loro azienda e dell’organizzazione che in essa vige e quindi come vengono messi in rilievo quegli aspetti che per i dipendenti sono più o meno positivi e che influenzano il loro comportamento sul luogo di lavoro. L’analisi è svolta attraverso la somministrazione di un questionario ed un colloquio personale con i componenti dell’azienda inclusa la direzione. Fra le domande poste durante il colloquio vi è anche quella della “Prima Impressione” che consiste nel comprendere l’immagine percepita da ogni dipendente intervistato della realtà dell’azienda al momento del primo colloquio. Questa domanda prende spunto dalla teoria dell’imprinting di Konrad Lorenz ed esamina il comportamento delle persone appena assunte, in fase di orientamento ed addestramento, la relazione e l’imitazione delle persone con le 170 Comunicazione e Nonviolenza quali entrano in contatto, quasi questi fossero modelli culturali da imitare. Per avere un quadro più completo della percezione dell’azienda da parte degli intervistati, è stato inoltre chiesto a ciascuno di loro di presentare quelli che secondo lui o lei sono i “punti di forza”, i “punti di debolezza” e quali “miglioramenti” che apporterebbe all’interno dell’azienda. Passando a presentare alcuni casi pratici, talvolta i rapporti tra i titolari e i collaboratori erano molto deboli, a volte anche conflittuali, con conseguente atteggiamento di disinteresse per il lavoro fra i dipendenti e compromissione della produttività. In altri contesti, le tensioni tra le persone erano mitigate dalle corrette scelte strategiche della direzione, la quale pur non coinvolgendo il personale, era riuscita a non accendere le tensioni latenti. Interessante è il caso di alcune aziende, nelle quali le persone vivono un clima stimolante, caratterizzato da una forte ricerca dell’innovazione e del coinvolgimento delle persone in questa direzione e da un’azione finalizzata all’integrazione multirazziale del personale che opera in azienda. Attraverso l’analisi del clima un’altra ditta è riuscita ad avviare un graduale processo di acculturamento del titolare prima e dei collaboratori poi, allo scopo di introdurre un sistema più industriale di gestione dell’azienda. Riferimenti bibliografici Bolognini B., Comportamento organizzativo e gestione delle risorse umane, Carocci, Roma 2001. Majer V., Marcato A., D’Amato A., Organizational Questionnaire, Unipress, Padova 2001. Majer V., Marcato A., D’Amato A., La dimensione psicosociale del clima organizzativo, Franco Angeli, Milano 2003. Morgan G., Images, Franco Angeli, Milano 1995. Pfiffner J., Sherwood F., Manuale di organizzazione. Franco Angeli, Milano 1992. Schein E., Cultura d’azienda e leadership, Guerini e Associati, Milano 1999. Schein E., Culture d’impresa, Raffaello Cortina, Milano 2000. Weick K., Senso e significato nell’organizzazione, Raffaello Cortina, Milano 1997. Weick K., Organizzare, Isedi, Torino 2001. Parte 6 - La violenza sul lavoro e nella società civile 171 6.4. LE RAPPRESENTAZIONI DEL CONFLITTO NEI GRUPPI DI LAVORO di Nicola Lopane Partendo dal presupposto che i gruppi sono realtà complesse, con fenomeni dinamici specifici che li rendono intellegibili e in qualche modo prevedibili, con rituali di partecipazione e di socializzazione, con regole gerarchiche e di funzionamento che danno un’identità al gruppo stesso e agli individui che vi entrano, abbiamo voluto analizzarne un aspetto importante e ricorrente: il conflitto. In particolare ci siamo soffermati sul modo in cui viene percepito e vissuto e quali strategie vengono adottate per risolverlo. La psicologia sociale insegna, infatti, come all’interno delle dinamiche di gruppo esistano forze centripete che tengono unito il gruppo nel tempo (la coesione, la conformità, le forme di influenza, etc.) ma anche forze contrarie o centrifughe che potrebbero portare il gruppo alla disgregazione, se non gestite consapevolmente, quali la devianza, i conflitti e gli scismi (Speltini, Palmonari, 1999). In particolare, oggetto della nostra analisi è stato il gruppo di lavoro. La scelta è caduta su questa tipologia in quanto al suo interno sono osservabili e analizzabili le dimensioni fondamentali dell’interazione (Lai, 1973). Per rilevare le rappresentazioni del conflitto si è svolta una raccolta di dati tramite un questionario appositamente costruito (composto da 11 domande, di cui 10 a scelta multipla e 1 aperta). Si è optato per un campionamento casuale di 500 soggetti operanti in diversi contesti e gruppi lavorativi, sia del settore pubblico sia del settore privato, in Umbria, Marche e Puglia1. La maggior parte ha un’età compresa tra i 24 e i 53 anni. Si è registrata una leggera prevalenza di soggetti di sesso femminile (261 su 500). La provenienza è ripartita abbastanza equamente tra impiegati del settore pubblico e privato, a seguire la categoria dei docenti delle scuole primarie, i liberi professionisti operanti in piccoli e medi studi o agenzie, i dirigenti del settore pubblico e privato. Per quel che riguarda l’ampiezza dei gruppi di lavoro, abbiamo riscontrato una prevalenza di gruppi composti da un minimo di 3 a un massimo di 10 persone che collaborano a stretto contatto. Si evince dalle risposte iniziali che l’ambiente lavorativo è per lo più considerato piacevole o normale, nonostante successivamente emerga dalla lettura dei dati una presenza di conflitti fortemente riconosciuta dai soggetti. La maggioranza dei soggetti in questione tende dunque a presentare il proprio ambiente di lavoro sotto una luce positiva, fornendo forse una risposta socialmente desiderabile. Questa propensione non necessariamente va interpretata come un sintomo o un tentativo deliberato di frode che i soggetti pongono in essere rispondendo al questionario, quanto piuttosto come un segno di difficoltà o di resistenza a prendere atto 1 Un contributo indispensabile, sia per la costruzione sia per la somministrazione del questionario, è stato dato dagli studenti del Corso di Scienze della Comunicazione dell’Università di Perugia, che hanno partecipato al gruppo di lavoro sul tema del conflitto, istituito durante il corso di Psicologia Sociale (Professoressa Paola Nicolini), Anno Accademico 2002/03: Alessandra Bianchi, Daniel Brusco, Clara Castellana, Federico Cerqua, Maria Cerullo, Valentina Ciolfi, Simone De Bellis, Filippo Franch, Angela Lembo, Valentina Pompa, Lorenza Ristori, cui va il mio ringraziamento. 172 Comunicazione e Nonviolenza delle tensioni e delle conflittualità interne al proprio ambiente lavorativo. Sulla base della classica suddivisione tra gruppi orientati al compito o gruppi orientati alle relazioni (Pinkley, 1990), abbiamo chiesto ai soggetti di stabilire quale delle due dimensioni ritengano più importante: dalle risposte emerge che il proprio gruppo di lavoro è considerato attento sia al compito da svolgere sia alle relazioni tra i membri, nella stessa misura. Questa domanda ci è stata utile, in quanto spesso la causa principale di conflitto è il differente posizionamento su una dimensione piuttosto che sull’altra (compito o relazioni) dei membri appartenenti ad uno stesso gruppo lavorativo. Infatti possono esserci membri del gruppo di lavoro che generalmente tendono a salvaguardare le relazioni con gli altri componenti del gruppo e quindi operano e lavorano spinti da una volontà di gestione costruttiva delle relazioni. In questo caso le origini e le finalità del conflitto riguardano la qualità della relazione con la controparte. Al contrario altri membri generalmente si incentrano sul compito, che per lo più viene percepito come prioritario. Per questa ragione, però, può succedere che, ad esempio in alcune situazioni aziendali, in nome di un obiettivo o di altre questioni (denaro, proprietà, prestigio, status, distribuzione del lavoro) vengano trascurate le relazioni tra i membri in favore del compito; questa può essere una causa di conflitto che porta a situazioni di rottura. Questi primi item miravano ad analizzare il clima generale in cui i soggetti vivono nei rispettivi gruppi di lavoro. Le successive domande, invece, erano dirette a rilevare rappresentazioni, cause e strategie di risoluzione dei conflitti. Il campione ritiene che essi siano causati principalmente da colleghi e da superiori in egual maniera. Anche in questo caso sono state confermate le spiegazioni teoriche che vedono nelle disuguaglianze fra i componenti (dovute alle posizioni, agli status, ai ruoli, alle dinamiche e ad altre forze presenti all’interno) una minaccia per la stabilità di un gruppo e dunque una permanente possibilità di conflitto. Tenendo conto delle principali teorie psicologiche sugli effetti costruttivi e distruttivi del conflitto nei gruppi (Deutsch, 1973; Doise, Mugny, 1981) abbiamo chiesto ai soggetti di classificare i due tipi di effetti (da noi definiti “positivi” e “negativi”) in rapporto alle relazioni tra colleghi e ai compiti di lavoro. Le risposte sono illustrate nella tabella seguente: Effetti dei conflitti Numero persone Negativi ai fini dei compiti e negativi ai fini delle relazioni 222 Positivi ai fini dei compiti e positivi ai fini delle relazioni 82 Positivi ai fini dei compiti e negativi ai fini delle relazioni 56 Negativi ai fini dei compiti 38 Negativi ai fini dei compiti e positivi ai fini delle relazioni 30 Negativi ai fini delle relazioni 25 Positivi ai fini dei compiti 16 Positivi ai fini delle relazioni 15 Positivi e negativi ai fini delle relazioni 5 Positivi e negativi ai fini dei compiti 3 Nessuna risposta 8 Totale 500 Tabella n.1 Parte 6 - La violenza sul lavoro e nella società civile 173 La maggioranza (222) ritiene che gli effetti dei conflitti siano negativi sia ai fini dei compiti sia ai fini delle relazioni. Questo dato conferma l’idea che i conflitti sono pensati come forze distruttive, dunque i soggetti si rapportano ad essi in maniera negativa, li temono. Il dato più interessante sembra invece il numero di soggetti (82) che vede nei conflitti una positività sia in funzione dei compiti sia delle relazioni, anche se non è possibile sapere per quali motivi. Se a questi associamo i soggetti (31) che vedono una positività nei compiti o nelle relazioni, superiamo le 100 persone. A questi vanno aggiunti 56 soggetti che vedono una positività ai fini dei compiti e una negatività per le relazioni, mentre 30 asseriscono il contrario, vale a dire che vedono una positività per le relazioni e una negatività per i compiti. Le risposte probabilmente più interessanti per l’intera ricerca ci sono pervenute quando abbiamo chiesto ai soggetti, attraverso un’associazione di idee, di definire il conflitto nei gruppi di lavoro. In generale si sono individuate due grandi categorie di risposte che prevedono associazioni negative e associazioni positive; all’interno di esse poi sono state individuate alcune sottocategorie, come illustrato nelle tabelle seguenti2. Associazioni negative CARATTERISTICHE NEGATIVE DEGLI ALTRI (prepotenza, arroganza, immobilità sulle proprie idee, orgoglio, ipocrisia, opportunismo, prevaricazione, invidia, gelosia, incompetenza, ignoranza, arrivismo, non rispetto del pensiero altrui, maleducazione, intolleranza, egoismo, individualismo, diffidenza, etc.) ICOMPRENSIONI, DIFFICOLTA' DI COMUNICAZIONE, PROBLEMI DI RELAZIONE (incomprensione, discordanza di idee, divergenza di opinioni, malintesi, carenza di comunicazione, mancanza di dialogo, timore di interferenze, scarsa collaborazione, incrinatura dei rapporti, etc.) NEGATIVITA' PER IL LAVORO (scarsa produttività, scarso profitto, conseguenze negative per il lavoro, suddivisione dei compiti, divergenze professionali sull'organizzazione del lavoro, diverse modalità di lavorare, inoperosità, disorganizzazione, incompatibilità formativa, difficoltà per gli obiettivi, problemi gerarchici, etc.) Numero risposte 185 138 103 DISAGI PSICOLOGICI, SENTIMENTI NEGATIVI (disagio, frustrazione, insoddisfazione, amarezza, impotenza, malumore, stress, malessere, delusione, rabbia, ira, astio, ansia, agitazione, noia, etc.) 81 SCONTRO APERTO (competitività/competizione, rivalità, contrasto, litigi, guerra, lotta, ecc.) 57 SITUAZIONE NEGATIVA (atmosfera pesante, tensione, situazione sgradevole, disappunto, disturbo, confusione, ecc.) 44 Tabella n.2 2 In questo caso i dati sono stati conteggiati per risposte date e non per soggetti del campione, in quanto qualche individuo ha esplicitato più di un’associazione. 174 Comunicazione e Nonviolenza Numero risposte Associazioni positive MOMENTO DI CRESCITA (miglioramento, confronto, crescita di rapporti, chiarimento, aumento della creatività, liberazione, problem solving, ecc.) 24 MOMENTO DI SCAMBIO (scambio di idee e di opinioni, discussioni, integrazione dei diversi punti di vista, etc.) 20 Tabella n.3 Solo 103 risultano le associazioni negative per il livello del lavoro, di contro 505 quelle che richiamano comunque a situazioni relazionali. Le 44 associazioni positive si distribuiscono tra i due livelli. Sembra interessante notare come dagli oltre 100 soggetti che, nella domanda precedente, ritrovano almeno una positività tra gli effetti dei conflitti si arriva alle sole 44 associazioni positive; probabilmente il fenomeno conflitto è percepito come ostile/distruttivo, mentre i suoi effetti possono apportare finanche a ristrutturazioni positive. Inoltre i risultati mostrano come all’interno delle associazioni negative i soggetti tendano a posizionare le risposte sia su un “asse relazionale tu-io” (i conflitti sono associati prima agli altri poi a disagi personali) sia su un “asse situazionale” (i conflitti sono associati a scarsa produttività nel lavoro e a situazioni negative in generale). All’interno delle associazioni positive invece l’asse relazionale è invertito, nel senso che sembra essere del tipo “io-tu” (i conflitti sono positivi prima per il soggetto interpellato e poi per gli altri). Successivamente abbiamo chiesto di scegliere tra 5 strategie frequentemente adottate per gestire e risolvere i conflitti: evitamento (o fuga), contrasto, accomodamento, compromesso e negoziazione. Ecco i risultati: Tabella n. 4 Strategie di risoluzione al conflitto Negoziazione Compromesso Evitamento Contrasto aperto Discussione, dialogo, collaborazione, confronto Accomodamento Numero risposte 210 144 52 36 34 7 L’alto numero di scelte per la negoziazione sembra incoerente rispetto alle domande precedenti: si pensa alla negoziazione come una tecnica efficacemente utilizzata nel proprio gruppo di lavoro, ma ci sembra che essa abbia un valore più simbolico che reale. Infatti, da un lato è vero che la negoziazione consiste nel “processo centrale per la collaborazione: si traduce nell’identificare il proprio punto di vista, nel confrontarlo con gli altri, considerando che quello del gruppo di lavoro deve essere costruito, e nel congiungere il punto di vista degli altri con il proprio secondo la logica dell’e, non la logica dell’o” (Quaglino, Casagrande, Castellano, 1992, p. 28), favorendo così le relazioni personali e il compito. Per un altro aspetto, è vero Parte 6 - La violenza sul lavoro e nella società civile 175 anche che i soggetti, che asseriscono di utilizzare questa tecnica, nelle domande precedenti ci dicono che il conflitto genera risultati distruttivi sia a livello relazionale sia a livello produttivo. Nel comprendere le ragioni di questa incoerenza si può pensare sia al fatto che la capacità dei membri del gruppo di arrivare ad una negoziazione è in stretta connessione con le modalità di lavoro attuate, sia al fatto che la negoziazione non è un traguardo facilmente raggiungibile, in quanto presuppone che ci sia un alto livello di consapevolezza. Abbiamo poi cercato di individuare il ruolo che il singolo soggetto preferirebbe assumere in situazioni conflittuali. Una gran parte opterebbe per “l’azione in prima persona per cercare di risolvere le cose”. Probabilmente i soggetti hanno risposto in questo modo perché in genere sono socialmente considerate migliori le persone che si attribuiscono responsabilità in prima persona piuttosto che darla ad altri (locus of control). Il dato invita ad alcune riflessioni: gli individui si mostrano più in linea con una visione negativa del conflitto, probabilmente questa è frutto di pregiudizi o stereotipi intrinseci alla semantica stessa del termine conflitto; un’altra ipotesi è che i soggetti non abbiano ben chiari gli effetti di una negoziazione o non abbiano le reali competenze per affrontarla; oppure le risposte fornite potrebbero essere solamente espressione di desiderio e non delle reali dinamiche agenti nei propri gruppi. La maggior parte dei soggetti afferma inoltre che il conflitto incide molto o abbastanza negativamente (282) sulla propria soddisfazione, una parte si mostra indifferente (46), per alcuni esso incide molto o abbastanza positivamente (160)3. Ciò potrebbe indicare che i soggetti non reagiscono al conflitto in maniera totalmente passiva, al contrario potrebbero esserne stimolati tanto da arrivare ad avere impulsi positivi sulla soddisfazione personale. Infatti si richiedeva di descrivere il proprio stato d’animo durante l’ultima situazione conflittuale. La delusione e la rabbia sono state le risposte più frequenti. Abbiamo però notato che non pochi intervistati hanno espresso uno stato d’animo positivo, come attenzione, sollievo e soddisfazione, confermando la riflessione precedente. Giunti a trarre le conclusioni possiamo affermare che i soggetti del nostro campione hanno esplicitato una rappresentazione sostanzialmente negativa del conflitto. Il lavoro svolto invita a una riflessione sul modo di favorirne una diversa mentalizzazione adeguando il vocabolario, modificando l’immaginario collettivo, reimpostando le relazioni e gli scambi comunicativi con gli altri. L’assunto di questo lavoro, infatti non è che i conflitti interpersonali siano necessariamente negativi o distruttivi, e dunque si debba inevitabilmente tentare di eliminarli o di ridurli. In molti casi le divergenze interpersonali, la competitività, la rivalità e altre forme di scontro hanno un valore positivo per i partecipanti e contribuiscono all’efficienza del contesto nel quale si verificano. La comunicazione ha però avuto un ruolo fondamentale nel trasferire questo fenomeno sul piano simbolico e pare che le persone siano in grado non di agire, ma di parlare di qualcosa per cui vorrebbero agire (in questo caso attraverso la negoziazione). Inoltre, sempre a livello simbolico, prima di giungere all’una o all’altra soluzione, emerge dall’inchiesta la volontà di operare o agire in prima persona all’interno del processo conflittuale, in quanto il conflitto implica, come si evince dalle risposte, prevalentemente rabbia e delusione e apporta comun3 12 persone non rispondono alla domanda. 176 Comunicazione e Nonviolenza que uno stress psicologico. Per evitare questo dispendio di energie sarebbe auspicabile educare al conflitto sui luoghi di lavoro per trasformarlo in una risorsa (parliamo di creatività di un team, di gestione costruttiva delle relazioni e di prestazioni più efficienti) e per fare ciò riteniamo utile attribuire al concetto di formazione di gruppo un valore dinamico: essa dovrebbe presupporre un cambiamento di atteggiamenti, di competenze (cognitive, sociali, relazionali), di interpretazioni, di comunicazioni, nei confronti di sé stessi e degli altri. Essa chiama in causa: - una dimensione individuale, in quanto è l’individuo (con le sue strutture cognitive) l’unico responsabile dei cambiamenti e dell’evoluzione; - una dimensione intersoggettiva, perché il lavoro di gruppo può offrire ai partecipanti l’opportunità di utilizzare apprendimenti intersoggettivi, scaturiti dal confronto e dalla negoziazione (gruppo = ricchezza da utilizzare); - una dimensione cooperativa, la capacità di cooperare non è naturale, ma è un’abilità appresa, essa si rivela un’operazione intelligente (Pojaghi, 2000). Alcuni elementi chiave per l’obiettivo formativo: - la consapevolezza dell’interdipendenza (Lewin, 1951), i membri di un gruppo rappresentano e portano al suo interno competenze diverse, dove vengono integrate e valorizzate (si sviluppa così l’identità gruppale); - la discussione e il confronto delle idee, questi sono i principali mezzi di scambio di informazioni, così come di esplicitazione di disaccordo, conflitto, differenze; - il ruolo produttivo della negoziazione (Pojaghi, Nicolini, 2003). L’attivazione delle suddette competenze può capovolgere la mentalizzazione negativa del conflitto, aiutando a sbarazzarsi della tradizionale visione di rottura non ricomponibile e di necessaria disgregazione: affrontare i conflitti in un’ottica costruttiva appare indispensabile per acquisire abilità negoziali come bagaglio di competenze di chiunque voglia produrre cambiamenti e sviluppo in ambito professionale, aziendale, comunicativo e relazionale. Numerosi fenomeni socioeconomici stanno portando la negoziazione a divenire un’attività via via più frequente, diffusa e fondamentale. Tra essi vi sono la crescente mobilità professionale, i continui processi di ristrutturazione aziendale, la transazione verso una società multietnica, l’esplosione del settore dei servizi e la globalizzazione. Queste evoluzioni, portando con sé le condizioni per potenziali conflitti, rendono la negoziazione uno strumento cruciale per fronteggiare il futuro (Rumiati, Pietroni, 2001). Riferimenti bibliografici Deutsch M., The resolution of conflict, Yale University Press, 1973. Doise W., Mugny G., La costruzione sociale dell’intelligenza, il Mulino, Bologna 1982. Lai G., Gruppi di apprendimento, Boringhieri, 1973. Lewin K., Teoria e sperimentazione in psicologia sociale, il Mulino, Bologna 1972. Pinkley R., Dimensions of conflict frame, in «Journal of Applied Psychology», 75, 1990. Parte 6 - La violenza sul lavoro e nella società civile 177 Pojaghi B., Il gruppo come strumento di formazione complessa. Il farsi e il disfarsi delle idee, Franco Angeli, Milano 2000. Pojaghi B., Nicolini P. (a cura di), Contributi di psicologia sociale in contesti socio-educativi, Franco Angeli, Milano 2003. Quaglino G.P., Casagrande S., Castellano A., Gruppo di lavoro. Lavoro di gruppo, Cortina, Milano 1992. Rumiati R., Pietroni D., La negoziazione, Cortina, Milano 2001. Speltini G., Palmonari A., I gruppi sociali, il Mulino, Bologna 1999. 178 Comunicazione e Nonviolenza 6.5. IL BISOGNO DI SICUREZZA E LA DIFESA CIVILE di Francesco Tullio 6.5.1. Il bisogno di sicurezza Dopo l’11 settembre 2001 emerge un filo conduttore ampiamente condiviso nella riflessione dell’Occidente: evento traumatico, minaccia del terrorismo, bisogno di sicurezza, bisogno di difesa. Delle divergenze si rilevano invece nelle analisi delle radici del terrorismo e nelle scelte operative. L’oggetto di questo intervento è la interpretazione della sicurezza. La nozione di “sicurezza” in scienze politiche viene tradizionalmente connessa a due settori, quello estero e quello interno. Il primo tratta le eventuali minacce provenienti da altri paesi a cui si risponde operativamente con la disponibilità di un potenziale militare adeguato a dissuadere eventuali aggressori, ma spesso anche idoneo a tutelare con la forza i propri interessi all’estero. L’altra accezione del termine sicurezza tratta il rischio per l’integrità dello stato di fronte ad organizzazioni politiche, movimenti criminali e tendenze disgreganti interne. Questo seconda implicazione rimanda operativamente perlopiù alla disponibilità di adeguate forze di pubblica sicurezza. Dalla fine della guerra fredda risulta evidente che le minacce alla sicurezza di un paese o di una società non sono più solamente di tipo classico: la crisi ecologica globale, con la minaccia di un repentino cambiamento climatico, rappresenta un pericolo sempre più concreto, al quale naturalmente non esiste una risposta armata. Il concetto classico è stato ridefinito negli Anni Novanta in particolare da Buzan, che ha introdotto le cinque dimensioni seguenti della sicurezza: 1. militare, comprendente le capacità offensive e difensive degli stati e le percezioni relative; 2. politica, riguardante la stabilità degli stati in quanto organizzazioni; 3. economica, riguardante la stabilità dei rapporti finanziari, commerciali e produttivi; 4. sociale, che si rifà agli aspetti culturali, linguistici e religiosi del vivere comune; 5. ambientale, che riguarda il mantenimento della biosfera e degli ecosistemi locali (Buzan, 1991). Questa nuova nozione di sicurezza è stata fatta propria dalle autorità politiche e militari dell’Occidente per esempio nello Strategic concept della NATO dell’aprile del 1999 che recita al paragrafo 25: “l’Alleanza si impegna in un approccio ampio alla sicurezza, che riconosce l’importanza dei fattori politici, economici, sociali e ambientali in aggiunta all’indispensabile dimensione della difesa”. Tale riconoscimento di principio tarda a tradursi in adeguate linee operative. La complessità del sistema con le sue contraddizioni, le sue smagliature, le sue lotte di potere e di possesso non hanno potuto prevenire la catastrofe dell’11 settembre. Un avanzamento nel senso della nuova concezione della sicurezza è avvenuto nella bozza di costituzione europea che nella parte I, titolo V, articolo 40 sulle “Disposizioni particolari relative all’attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune” recita: “1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Assicura che l’Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e mili- Parte 6 - La violenza sul lavoro e nella società civile 179 tari. L’Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite”. Nella bozza di convenzione è stata anche inserita una proposta di agenzia per gli armamenti. Le reti europee con le quali Centro Studi Difesa Civile collabora (EPLO - European Peace Liason Office) propongono, per equilibrare il peso di una tale agenzia, una modifica al testo della convenzione che preveda la realizzazione accanto alla Agenzia per gli armamenti di una Agenzia del Peacebuilding e per la Gestione Costruttiva dei Conflitti. La politica della EU è molto orientata alla prevenzione dei conflitti. La stessa EU è il risultato di una riduzione delle sovranità nazionali in una logica di dialogo e di prevenzione che dovrà essere auspicabilmente applicata anche ad ulteriori ambiti. 6.5.2. Riflessioni sugli aspetti soggettivi della sicurezza e la comunicazione in democrazia Il presente capitolo intende indicare due diverse implicazioni del concetto di sicurezza. Il primo è assicurare i vantaggi acquisiti, il secondo è collegato al senso di paura diffusa che si radica nella paura dei singoli. Sono processi che si intrecciano e si mescolano in proporzioni diverse nelle diverse singole persone. Applico alla riflessione che segue i seguenti postulati: a) Il senso di insicurezza e di paura sono concetti che si riferiscono inevitabilmente ad una radice soggettiva. Queste dimensioni si riflettono sulle istituzioni e sulle modalità sociali di gestione dei conflitti all’interno della collettività e con l’esterno (Stavros). b) Esiste anche una relazione fra bisogni valori ed approcci individuali, scelte di sviluppo collettive e conflitti internazionali. Esiste un nesso fra tensioni interiori (insoddisfazioni personali e malcontento sociale), i modi di affrontare il vissuto di crisi (serenità e maturità d’animo, rabbia o impotenza con le loro sfumature e comportamenti connessi, sia personali che collettivi) e la stabilità/instabilità nazionale, internazionale ed ambientale. Esiste cioè un nesso fra micro e macroconflitti e fra aspetti psicologici, economici e politici della sicurezza. c) Queste diverse dimensioni si influenzano reciprocamente fra di loro. E’ una scelta prenderle in esame in un’ottica sistemica, di circolarità fra di esse e non di semplice relazione causa - effetto. d) La comprensione delle dinamiche relazionali e delle personalità individuali e collettive coinvolte nei conflitti è utile per identificare nodi irrisolti, per costruire strategie di intervento e per individuare le modalità comunicative più efficaci da applicare di volta in volta per uscire dalla crisi. Questo sapere è di per sé neutrale. Esso può essere utilizzato per personale avidità ed ambizione e/o per il bene comune. e) Una politica che si definisca democratica non può applicare per definizione forme di comunicazione manipolative con i propri membri e non può favorire una strutturazione interna verticistica e programmi puramente repressivi. Essa deve favorire anche la comunicazione sincera con il competitore, con l’avversario e con il potenziale nemi- 180 Comunicazione e Nonviolenza co, perché la competizione senza limiti esita inevitabilmente in scontro1. Essa deve dunque favorire la cooperazione almeno quanto enfatizza la competizione e deve favorire il rispetto degli altri popoli, una maturazione emotiva collettiva, lo sviluppo delle competenze e degli strumenti di gestione costruttiva dei conflitti. La traccia nove del concetto di diplomazia multipla (Diamond - McDonald, 1991) si riferisce al ruolo dei mezzi di comunicazione di massa ed alla comunicazione in genere per informare il pubblico relativamente alla cultura, i bisogni e la filosofia dell’altro in due nazioni in conflitto fra loro con l’intenzione di umanizzare il nemico, ridurre l’ostilità, facilitare le operazioni degli altri canali. Si tratta di un punto nodale per la costruzione strategica di una politica di pace. Un passaggio imprescindibile di questa traccia riguarda il rapporto fra l’opinione pubblica, i gestori dell’informazione e del potere decisionale ed in particolare il rapporto fra la comunicazione verticale e quella orizzontale all’interno della società (Ebert, 1984). Theodor Ebert, teorico della difesa civile, descrive la società come una piramide. La base è rappresentata dalla popolazione, il vertice dai capi di governo e dello stato e nel mezzo vi sono i dirigenti intermedi, che possono essere locali (i sindaci, i caporeparto, i direttori di aziende, di uffici pubblici, delle scuole, dei giornali etc) ed intermedi (parlamentari, dirigenti di grandi imprese e federazioni a livello nazionale, ministri etc ). La comunicazione fra questi diversi livelli può essere di tipo orizzontale e verticale. Una dittatura è caratterizzata da un flusso di decisioni che vanno esclusivamente dall’alto verso il basso. In una democrazia invece c’è un processo comunicativo bidirezionale e le scelte vengono prese attraverso un continuo confronto fra base e vertici. Questo processo non è sempre fluido, vi possono essere strozzature, deformazioni, attriti. Un problema sta nel fatto che i vertici possono non raccogliere i messaggi che provengono dalla base della piramide per l’assenza di modelli idonei alla loro interpretazione, per imperizia o per scelta. I mezzi di comunicazione di massa si prestano ad una possibile deformazione del sistema democratico, quella di trasferire solo informazioni verso il basso, che si tratti di pubblicità o di propaganda più o meno velata. Il sistema democratico, se è solido, mantiene una tensione dialettica fra base e dirigenti locali, fra questi e quelli intermedi ed infine con i vertici. La informazione è quindi bidirezionale è comunicazione, è dialogo. Ma quello che rende stabile, compiuta e sicura una democrazia è la comunicazione orizzontale laddove i membri della società interagiscono fra di loro e mantengono la capacità di esprimere per democrazia i propri vertici. Non si tratta solo di eleggere ma di confrontarsi, partecipare, scegliere insieme dopo un confronto diretto con i propri concittadini e non dipendere da decisioni precostituite fornite da canali di comunicazione unidirezionali. Se questo per contro avviene, si genera un circolo vizioso che in una ottica sistemica va considerata conseguenza ed allo stesso tempo causa di dipendenza ed immaturità. I mezzi di comunicazione possono contribuire a crearlo, possono cercare di forzare questa dipendenza a favore del capo unico. 1 Come dice Simone Weil “da un lato la guerra non fa che prolungare quell’altra guerra che si chiama concorrenza; dall’altro tutta la vita economica è attualmente orientata verso una guerra futura”. Parte 6 - La violenza sul lavoro e nella società civile 181 6.5.3. La difesa civile La difesa civile (Tullio, 2001) è un progetto per affrontare in chiave democratica, anche nei periodi di tensione e di crisi, il nodo fra sicurezza, ordine pubblico e difesa. Questo progetto deriva dalle esperienze storiche della resistenza nonviolenta, dalle esperienze interdisciplinari e multidimensionali della gestione costruttiva dei conflitti, dalle nuove frontiere della ricerca per la pace. Dal punto di vista pratico la difesa civile indica alcuni strumenti concreti da adottare ed adattare caso per caso, per migliorare la sicurezza nei quartieri, negli stadi, per resistere alla malavita ed alla diffusione della violenza. Le risposte più funzionali possono essere predisposte ed esercitate, ma non possono essere completamente predefinite e date a priori. Esse devono adattarsi al processo in corso fino ad indirizzarlo. Le risposte dipendono fra l’altro dai valori che si perseguono. La crisi implica spesso delle difficili scelte di priorità, delle decisioni in condizioni di non prevedibilità degli esiti, dei dolorosi passaggi emotivi, alleanze con il meno peggio. L’elasticità mentale di chi possiede valori etici e non si aggrappa rigidamente alle ideologie può essere utile. La gestione della crisi è talvolta analoga al trial medico in caso di grave catastrofe: devi scegliere a chi o cosa dedicarti prima! Parte della stessa difesa civile è la costruzione delle condizioni necessarie, solo in parte già esistenti ed in parte da sviluppare, affinché un popolo possa resistere ad un invasore straniero o ad un’involuzione autoritaria interna, limitando al massimo l’uso della forza e sostituendola con l’uso strategico e contemporaneamente etico della comunicazione, della disobbedienza civile, della noncollaborazione. Vengono presi in considerazione gli aspetti strutturali, economici e culturali della società che la rendono solida e resistente se esiste un reale scambio comunicativo all’interno di essa e con l’altro da sé. La difesa civile rileva quindi l’importanza del confronto e della coesione sociale come espressione di una comunicazione orizzontale fra i cittadini e la necessità di sganciarsi dalla suggestione della propaganda verticale e centralizzata. L’opzione per la difesa civile sarebbe facilitata dalla scelta parallela di un processo di transizione verso un modello di sviluppo più equilibrato. Le scelte forzate dello sviluppo e gli alti costi ambientali e finanziari della deterrenza determinano nei fatti un rischio per la sicurezza delle società, uguale e forse maggiore della minaccia che può venire dal dispiegamento degli armamenti nemici. La difesa deve quindi essere calibrata, proporzionata non solo ai pericoli esterni ma anche alle esigenze ed ai mezzi di una nazione, altrimenti si trasforma in un sistema per cui il riarmo drena tutte le risorse impoverendo il substrato della società per garantire dei vantaggi a gruppi limitati e diventando controproducente per la maggioranza dei cittadini di uno stato democratico (Wehr, 1979). A tale proposito appare utile rivedere come si alimenta la struttura del potere interno ed internazionale, partendo dai bisogni, dalle dinamiche e dalle contraddizioni interpersonali ed intergruppali. Secondo la tesi da me rappresentata esistono dei meccanismi politici ed economici, radicati nella struttura psichica collettiva, che rendono la nostra civiltà occidentale espansionistica ed allo stesso tempo vulnerabile, ma incauta e parzialmente ignara delle conseguenze della propria crescita. Più una società è vulnerabile, più la sua politica è aggressiva e provocatoria, più conseguentemente adotta sistemi d’arma e progetti di difesa offensivi (Galtung). 182 Comunicazione e Nonviolenza Il modello occidentale di sviluppo, pur avendo bisogno per perpetuarsi di imporre le proprie condizioni e regole e di scaricare i costi sull’ambiente, sulle altre culture e sulle generazioni future, presenta al suo interno differenti livelli di consapevolezza e differenti capacità di gestire i conflitti interni ed esterni. Lo sviluppo o meno di queste caratteristiche può portare ad esiti diversi. Le più concrete applicazioni della difesa civile consistono attualmente negli interventi di solidarietà alle società civili attraversate dalla violenza2 nelle esperienze internazionali dei Corpi Civili di Pace, e nella insistente richiesta ai vertici politici italiani ed europei della loro istituzionalizzazione3. Il Centro Studi Difesa Civile è ad esempio impegnato nella rete italiana dei corpi civili di pace4, nella rete europea dei servizi civili di pace5, nel progetto Colombia vive e nelle Nonviolent Peaceforce6. 6.5.4. Riferimenti bibliografici Buzan B., People, States and fear. An agenda for international security studies in the post-Cold War era, Hempstead, Wheatsheaf 1991. Diamond L., McDonald J., Multi-Track Diplomacy: A Systems Guide and Analysis, The Iowa Peace Institue, Grinnell Iowa USA 1991. Ebert T., La difesa popolare nonviolenta, Gruppo Abele, Torino 1984. Galtung J., Peace by peaceful means, SAGE, Londra 1996. Galtung J., Peace Reseach, ed Christian Ejlers, Copenhagen 1975-1988. Galtung J., There Are Alternatives! Four Roads to Peace and Security, 1984. ed.it Ci sono alternative! Quattro vie per la pace e la sicurezza, Ed. Gruppo Abele, Torino 1986. Galtung J., Methodology and Ideology, C. Ejlers, Copenhagen 1977. Stavros M., Interpersonale und Isntitutionalisierte Abwehr, Suhrkamp, Frankfurt am Main. Tullio F. (a cura di), La difesa civile ed il progetto Caschi Bianchi; peacekeepers civili disarmati, Franco Angeli, Milano 2001. Wehr P., Conflict Regulation, Westview Press, Boulder Colorado USA, 1979. 2 Si veda ad esempio il progetto Colombia Vive. Per approfondimento sui processi di resistenza civile non violenta della Colombia, vedi: Camminar en Dignidad in http://www.comune.narni.tr.it/pace.htm che descrive la comunità di pace di San José de Apartadó; L’impegno della società civile in Colombia e Costruendo segnali di pace sul sito del CSDC www.pacedifesa.org. 3 sul sito del CSDC www.pacedifesa.org. 4 http://www.corpidipace.too.it. 5 il sito di European Network of civil peace services (EN.CPS) è: http://www.en-cps.org. EN.CPS fa parte dell’European Peace Liason Office (EPLO) che rappresenta le Ong per la costruzione della pace all’Unione Europea: http://www.eplo.org/. 6 www.nonviolentpeaceforce.org. Parte 6 - La violenza sul lavoro e nella società civile 183 6.6. POSSIBILITA’ E VINCOLI DELLA COMUNICAZIONE Quando la comunicazione è realmente alternativa alla violenza di Paola Rebughini La riflessione che vorrei proporre parte da alcuni interrogati d’obbligo per il tema di questo convegno: comunicazione e violenza corrono sempre su due binari distinti? Ovvero, la comunicazione è realmente alternativa alla violenza? E se lo è, in quali condizioni questo si verifica? A queste domande tendo a rispondere affermando che la comunicazione non è necessariamente opposta alla violenza e che lo è soltanto quando si situa in una prospettiva chiaramente dialogica, basata sul pieno riconoscimento dell’altro. La violenza infatti può in alcuni casi diventare un codice comunicativo: si può comunicare anche attraverso atti di violenza, per esempio nel contesto della guerra o della lotta politica. La questione della comunicazione implica quindi anche quella della rappresentazione e della valutazione dell’altro. Contemporaneamente la comunicazione e il dialogo non sono necessariamente delle cure o degli antidoti universali alla violenza, possono semmai essere una terapia di prevenzione. L’efficacia della terapia comunicativa dipende quindi dalle condizioni della comunicazione, oltre che dalla definizione che noi diamo al concetto stesso di comunicazione. In questo contesto credo che sia più interessante intendere per comunicazione un modello relazionale, ovvero la relazione tra due attori sociali o due gruppi sociali in compresenza, escludendo quindi tutta quella parte che riguarda la comunicazione mediata da un qualunque mezzo, e che richiederebbe un discorso di altro tipo. Se questa comunicazione diretta avviene all’interno di una relazione di tipo dialogico, basata su uno status di parità, dove i due interlocutori si riconoscono reciprocamente, la comunicazione è sicuramente alternativa alla violenza. In quanto la violenza si definisce - in modo opposto - in base a un rapporto squilibrato di potere in cui una delle due parti è in grado di nuocere e l’altra, la quale non può fare a meno di subire. Il tema della comunicazione si lega allora a quello della violenza da due punti di vista: a) Quello della comunicazione come veicolo del riconoscimento dell’altro e quindi come alternativa radicale alla violenza. b) Quello della comunicazione come potere e come possibilità che non necessariamente distribuiti in modo equo nella struttura sociale. In questo senso il potere di comunicare si associa al potere stesso di definire la violenza, di individuarla e di farla esistere, selezionando soprattutto quali tipi di violenza saranno degni di nota e quali invece saranno ignorati. Queste due prospettive fanno capo a due concezioni diverse di intendere l’atto comunicativo: - l’una si richiama alla tradizione etica e dialogica che propone la centralità della comunicazione e del linguaggio come chiave della convivenza sociale, la comunicazione è reale solo se ci si riconosce reciprocamente, se l’Altro in quanto interlocutore è riconosciuto pienamente; 184 Comunicazione e Nonviolenza - l’altra sottolinea le differenze sociali e di potere implicite nell’atto di nominare il mondo e nella possibilità di stabilire i suoi codici di interpretazione. In questo caso lo spazio del discorso è percepito come un’arena di conflitti da cui la violenza non può realmente venire espulsa. Oltre a queste due posizioni antitetiche ne esiste tuttavia una terza, quella rappresentata dagli approcci interessati all’aspetto linguistico della comunicazione, che vedono nel riconoscimento della pluralità dei discorsi e delle narrazioni, l’unica soluzione possibile per uscire da una violenza basata innanzitutto sull’imposizione di un’unica interpretazione del mondo, una sola verità imposta attraverso sistemi di comunicazione utilizzati a senso unico. La prima posizione propone la comunicazione come atto di responsabilità soggettiva verso l’Altro, quindi come antitesi radicale alla violenza. La seconda posizione propone un atto critico, volto a svelare gli inganni della comunicazione che nascondono rapporti di potere, di sopraffazione e quindi di violenza. La terza posizione è propositiva, va al di là della critica e ritiene che la comunicazione plurale sia il migliore antidoto alla violenza. 6.6.1. Le filosofie dell’Alterità come antidoto alla violenza Il tema della violenza è stato al centro di molte riflessioni filosofiche seguite agli orrori della Seconda Guerra mondiale, tra queste troviamo le cosiddette filosofie dell’alterità basate sulla riflessione etica radicale di autori come Levinas e Buber e in sociologia da un autore come Bauman nonché dalle teorie sul multiculturalismo che fanno riferimento alla questione del rispetto dell’Altro. Da tutti questi autori la comunicazione è indicata come il centro di un processo di riconoscimento reciproco e di costruzione delle reciproche posizioni. Il mancato riconoscimento di una posizione paritaria con l’altro da sé non potrà mai portare a una comunicazione capace di essere un antidoto alla violenza. L’aspetto dialogico e fondamentalmente etico del rapporto con l’altro rappresenta quindi un antidoto naturale alla violenza. Secondo Lévinas l’individuo può trovare il senso della propria esistenza solo nel confronto e nella relazione comunicativa con l’altro, in particolare nella responsabilità per l’altro e nell’essere-per-l’altro. Il riconoscimento del rapporto irriducibile con l’altro non può quindi che essere un’alternativa radicale alla relazione basata sul potere e sulla violenza (Lévinas, 1980). Lévinas propone un’uscita netta dalla tradizione del conflitto che interpreta la violenza come la guerra di tutti contro tutti, ma anche dalla tradizione della negoziazione liberale, proponendo una filosofia basata nettamente sull’etica e sul riconoscimento dell’altro. Tale riconoscimento dell’altro deve essere radicale e non formale, il principio è quello del riconoscere che l’altro sono io e pertanto io sono responsabile dell’altro come lo sono di me stesso, il volto dell’altro mi ricorda il mio volto e mi ricorda che tutti e due siamo persone. In sociologia Bauman ha attualizzato il problema sollevato da Lévinas in rapporto alla società della globalizzazione e alla necessità di fondare un’etica nuova basata proprio sul principio del dialogico e della comunicazione, unico antidoto al moltiplicarsi delle violenze e delle micro violenze caratteristiche delle nuove forme di economia globale, provocate dalla solitudine del cittadino globale, dall’insicurezza esistenziale e dalla razionalizzazione burocratica. Parte 6 - La violenza sul lavoro e nella società civile 185 La risposta morale, la sfida posta all’etica contemporanea di cui parla Bauman (1996) consiste nello sforzo di riconoscere l’Altro, in un ambito necessariamente “non simmetrico”, ovvero riconoscendo l’Altro come altro-da-sé, nella sua irriducibile differenza, ma assumendo l’ambivalenza della relazione. Tra le filosofie del dialogo comunicativo, si può ricordare anche l’opera di Capitini, padre del pensiero pacifista italiano che pone il dialogo come imperativo etico assoluto, l’unico che può permettere la convivenza, la libertà e l’uscita da una situazione di violenza. 6.6.2. Violenza e linguaggio: quando la violenza può essere detta? La corrente filosofica poststrutturalista, centrata nell’opera di Foucault (1976), ha proposto una diversa visione del legame tra violenza e comunicazione, cercando di svelare criticamente ogni forma di violenza presente nel linguaggio e nei codici comunicativi. Tale corrente di pensiero ha il merito di aver sottolineato, rispetto alle dinamiche del potere, l’importanza di nominare il mondo e di stabilire i codici d’interpretazione. In effetti nel considerare la problematica della violenza, alcuni autori si sono soffermati sugli aspetti della violenza contenuti nel linguaggio, ovvero nella possibilità di definire un fatto come violento, ma anche nella possibilità tout court di poter parlare, considerando lo spazio del discorso come un’arena di conflitti e di rapporti di forza dove solo alcune posizioni finiscono con l’avere visibilità a scapito di altre. Quella che in filosofia viene chiamata la “svolta linguistica” ha avuto una certa influenza anche sulle teorie della violenza. Le teorie anglo-americane della teoria del linguaggio, per esempio la teoria degli atti linguistici di Austin, secondo la quale “le parole sono azioni” ovvero hanno un effetto pratico, introducono una prospettiva nuova nel considerare il rapporto tra linguaggio e vita pratica, attribuendo una priorità chiara al linguaggio rispetto alla prassi. Rispetto al tema della violenza questo suggerisce un modo nuovo di prenderla in considerazione, ovvero a partire dalla sua possibilità di esistere attraverso il linguaggio - il poter essere detta - invece di considerarla a partire dai suoi effetti materiali. L’attenzione allora non è più rivolta a classificare materialmente la violenza - guerra, omicidio, etc. - ma la domanda diventa: chi può dire che cosa è violenza e che cosa non lo è? Rispetto alle teorie liberal-democratiche che vedono la violenza e il linguaggio come mutuamente esclusivi, in questa visione linguaggio, violenza e potere assumono confini in parte sovrapposti in quanto si ritiene che il linguaggio sia appunto uno spazio in cui possono essere esercitati sia il potere che la violenza. Come nel caso delle teorie del riconoscimento dell’alterità, che vedono nel rispetto dell’altro l’unica strada possibile per l’uscita dalla violenza, anche gli approcci interessati all’aspetto linguistico vedono nel riconoscimento della pluralità dei discorsi e delle narrazioni, l’unica soluzione possibile per uscire da una violenza basata su un’unica narrazione e dunque una sola verità. 6.6.3. L’etica della comunicazione Gli esponenti principali dell’etica del discorso e della comunicazione sono oggi Apel e Habermas. 186 Comunicazione e Nonviolenza Secondo Apel il tema dell’intersoggettività si sviluppa essenzialmente attraverso il medium del linguaggio. In polemica con gli aspetti nichilistici, scettici o radicalmente relativisti, Apel crede nella razionalità del discorso e dell’argomentazione come sfera pratica dell’agire etico. Anche Habermas fa della competenza comunicativa la sfera privilegiata dell’etica e dell’incontro con l’altro. L’etica e la giustizia possono avere un fondamento razionale nel linguaggio, il conflitto e la violenza possono quindi essere risolti nella sfera argomentativa e dialogica del discorso. Habermas (1983), che è certo cosciente della difficoltà effettiva a raggiungere un tale obiettivo, parla di “situazione discorsiva ideale”, intesa come obiettivo ultimo verso il quale tendere. Questo significa inoltre che la questione etica non può essere risolta nella coscienza del singolo (come riteneva Kant) ma essa fa parte di un processo pratico, dialogico e intersoggettivo. L’etica della comunicazione tende così verso un’etica della responsabilità sottolineando le possibilità di accordo e di libertà reciproca anziché quelle di dominazione e di potere insite nell’atto del nominare. Questa posizione può poi essere associata alla prospettiva della pluralità delle narrazioni. Secondo quest’ultima posizione il passaggio a una società post-moderna e post-strutturalista implica la rinuncia, sia pratica che teorica, a una narrazione unica dell’esistente, riconoscendo la pluralità dei punti di vista. La competenza comunicativa è plurale e occorre riconoscere sia la diversità culturale dell’altro sia la sua modalità di comunicare. Rispetto alle teorie critiche, anche questa prospettiva - come quella dialogica - sembra puntare sull’azione pratica e sull’impegno individuale e collettivo, evitando quindi il pericolo di un nichilismo inconcludente. 6.6.4. La realtà empirica e i limiti della teoria La debolezza dell’insieme di queste teorie sta - nel primo e terzo caso - nella loro implicita insistenza su una sorta di volontarismo dell’attore, individuale o politico e istituzionale, mentre nel secondo caso, la tradizione critica, l’insistenza sull’onnipresenza del potere rischia di non essere capace di intravedere vie d’uscita. Dietro la comunicazione vi sono diverse concezioni culturali del mondo, la comunicazione può essere un’alternativa all’uso della forza, ma da sola non basta a risolvere problemi che sono di natura strutturale (il divario di forze) o che riguardano la gestione del pluralismo in un contesto sempre più multiculturale. Lo stesso limite si incontra sia quando analizziamo contesti internazionali - la diplomazia e il dialogo come prevenzione delle guerre - sia contesti locali e precisi, come i tentativi di prevenire la violenza giovanile attraverso il dialogo e la conoscenza delle loro esigenze e del loro disagio, o ancora i tentativi di risolvere i problemi di violenza domestica attraverso terapie e psicoterapie basate sulla parola. Solo un’educazione alla comunicazione potrebbe permettere di intervenire “a monte” del problema prima che immagini reciproche e distorte si formino creando situazioni di violenza. In caso contrario la comunicazione rischia di rimanere un comportamento virtuoso da proporre, da insegnare e su cui insistere, ma che non si realizza automaticamente, proprio perché esula dalla semplice volontà individuale e richiede una cooperazione che non necessariamente si Parte 6 - La violenza sul lavoro e nella società civile 187 realizza: non posso costringere l’altro a comunicare con me se non vuole! Questa è anche la banale esperienza della nostra vita quotidiana. La comunicazione funziona se si è disposti a mettersi in discussione riconoscendo l’altro e attuando una prospettiva dialogica nella relazione. Solo in questo caso la comunicazione, anche se non raggiunge completamente i suoi obiettivi, può riuscire a ridurre quella situazione di tensione e di conflitto che può poi sfociare nella violenza e nel rapporto di forza. 6.6.5. Riferimenti bibliografici Bauman Z., Sfide dell’etica, Feltrinelli, Milano 1996. Foucault M., Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino 1976 Habermas J., L’etica del discorso, Laterza, Bari 1983. Lévinas E., Totalità e infinito, Jaca Book, Milano 1980. 188 Comunicazione e Nonviolenza 6.7. DIALOGO E VIOLENZA Una prospettiva interculturale di Claudio Baraldi e Alberto Dreossi In questa breve presentazione, il rapporto tra dialogo e violenza viene trattato nel quadro di una teoria della comunicazione, nel tentativo di fornire una spiegazione dei fondamenti sociali della violenza e delle possibilità di sostituirla con forme comunicative efficaci. Per tale scopo, si può partire da una prospettiva sistemica (Luhmann, 1990; Luhmann - De Giorgi, 1992) per la quale i processi sociali sono da intendersi come processi di comunicazione, inclusi in sistemi codificati. Questa prospettiva consente di affrontare soltanto marginalmente i temi specifici del dialogo e della violenza, ma costituisce il solido punto di partenza di un percorso che può essere integrato ed arricchito attraverso altri studi sulla comunicazione e sulle forme culturali. Ogni processo comunicativo è orientato da forme simboliche peculiari, date da condensazioni di simboli che, sorte nella comunicazione stessa ed avendo avuto successo come suoi orientamenti, assumono una funzione strutturante nei sistemi sociali (Baraldi, 2003). La violenza è stata spesso interpretata come un’azione con valenza comunicativa, in quanto trasmetterebbe qualche tipo di messaggio o indicherebbe una qualche forma di relazione. Tuttavia, l’atto violento, qualunque sia la motivazione che lo muove, colpisce qualcuno per zittirlo, cioè per sostituire un silenzio carico di significati alla comunicazione in atto o possibile. Di conseguenza, la violenza in se stessa non ha un significato comunicativo, bensì ha l’effetto di interrompere la comunicazione, impedendo di continuarla. In tal senso, la violenza è interpretabile come un surrogato della comunicazione, che si impone quando una forma di comunicazione si rivela improbabile, o viene considerata inaffidabile: si tratta di un’azione non comunicativa che mette fine ad una comunicazione, sostituendola quando fallisce. In tal senso, la violenza non è in se stessa un atto sociale, poiché nega le possibilità ulteriori di esperienza della comunicazione, ponendovi termine. La violenza è peraltro connessa alla comunicazione in due sensi diversi: da una parte, essa assume un significato culturale nella comunicazione, in quanto forma culturale di negazione della persona; dall’altra parte, essa ha un fondamento sociale, essendo il risultato di precedenti forme di comunicazione fallimentari. In particolare, ci interessa qui questo secondo aspetto: la violenza scaturisce dalla mancanza di comprensione o di accettazione della comunicazione. Le cause concatenate di questa mancanza sono (1) il primato della prospettiva dell’Io individuale o del Noi del gruppo di appartenenza, come più rilevante di ogni altra e (2) l’affermazione della necessità di condivisione di tale prospettiva. L’obiettivo è la condivisione ed il mezzo per raggiungerlo è l’imposizione di una prospettiva particolare che si ritiene debba essere condivisa. Se il mezzo non consente di raggiungere l’obiettivo, la comunicazione fallisce e si avvia la violenza, intesa come azione efficace per produrre la condivisione della prospettiva proposta. In sintesi, la violenza è un’azione non comunicativa legittimata da una forma culturale che determina la necessità di condividere una prospettiva particolare. Tale Parte 6 - La violenza sul lavoro e nella società civile 189 forma culturale viene definita anche “cultura della violenza”. La cultura della violenza ha la funzione paradossale di risolvere i conflitti sociali. Un conflitto sociale è un sistema di comunicazioni basato su una contraddizione tra posizioni opposte, che ha un effetto immunologico per un sistema sociale, poiché mette in evidenza i problemi che si creano al suo interno (Luhmann, 1990). Esso però crea anche un blocco nel sistema e quindi richiede una soluzione rapida per poter riavviare il normale funzionamento dei processi comunicativi: il problema centrale non è dunque l’insorgenza del conflitto, che di per sé non costituisce un fattore negativo in un sistema sociale, bensì i tempi ed i modi della sua scomparsa. La violenza viene proposta come soluzione rapida di un conflitto, quando il ripristino di una forma di comunicazione efficace è osservato come improbabile. Il successo della violenza deriva dal fatto che essa viene osservata come un’azione in grado di cambiare un processo o una struttura sociale, a vantaggio della futura condivisione degli orientamenti normativi proposti. Tuttavia, la violenza non ha alcuna funzione nella ricostruzione delle forme di comunicazione: la rottura che essa determina può essere sostituita da nuove forme comunicative, ma le caratteristiche di tali forme non ne sono per nulla determinate e i suoi effetti su di esse sono del tutto imprevedibili. In particolare, la violenza su scala societaria è determinata dal tentativo di imposizione della prospettiva valoriale di un particolare gruppo sociale. Essa origina dal tentativo di creare una forma di comunicazione etnocentrica, basata sul primato di un Noi (di un gruppo) su di un Loro (di un altro gruppo) osservato come minaccioso o inferiore (Pearce, 1992). Il fallimento di una forma etnocentrica di comunicazione crea le condizioni della violenza. Ciò è causato dalla sottovalutazione di due fattori intrinseci all’evoluzione socioculturale: 1) l’inadeguatezza crescente dei valori nel creare uno standard condivisibile da gruppi sociali diversi; 2) la rilevanza sociale crescente delle forme di meticciato nella comunicazione interculturale. Anzitutto, uno standard valoriale generalizzato che garantisca l’integrazione sociale è implausibile nell’era della globalizzazione: la rilevanza della diversità culturale, che si esprime nelle idee del multiculturalismo, nelle forme relativiste di osservazione (femminismo, afrocentrismo, queer theories, etc.), nel costruttivismo, nelle teorie post-moderne, segnala il fallimento di questo standard, sia come “standard di civiltà” (come ci si esprimeva alla fine del Diciannovesimo Secolo) sia come standard dei valori umani (come va di moda un secolo dopo). In secondo luogo, appare oggi chiaro che, come osserva il protagonista del film Mio figlio il fanatico, sceneggiato dal noto scrittore Hanif Kureishi, “tutto è già mescolato”. Le teorie dell’ibridazione, del meticciato, della creolizzazione, tutte formule che indicano la mescolanza di prospettive culturali, sono ben note tra coloro che si occupando di società multiculturale. Tuttavia, la loro diffusione culturale si traduce raramente in forme comunicative efficaci nella pratica sociale: di conseguenza, questa mescolanza è sistematicamente sottovalutata ed è riproposto un modello di unità, fusione, integrazione della diversità culturale. La sottovalutazione dell’inadeguatezza degli standard valoriali e della rilevanza delle forme culturali meticcie rende probabile l’affermarsi di prospettive di separazione tra gruppi sociali, che rendono a loro volta probabile la violenza, laddove sia comunque indispensabile un contatto sociale, come accade nell’era della globalizzazione. 190 Comunicazione e Nonviolenza La preoccupazione per queste condizioni difficili di comunicazione, in una società multiculturale che ambisce a diventare mondiale, ha prodotto la ricerca di alternative, che al momento si esprime soprattutto sul piano concettuale e poco su quello pratico. Il concetto che ha avuto maggiore successo è quello di dialogo: la forma comunicativa del dialogo viene proposta come antidoto anche e soprattutto per la violenza. Il dialogo è una forma di comunicazione che richiede l’espressione della diversità, cioè che richiede che ciascun partecipante osservi gli altri come individui competenti nell’esprimere aspirazioni personali e culturali. Il dialogo prende avvio dall’osservazione che la conoscenza è sempre costruita nella comunicazione: di conseguenza, la comunicazione di diversità arricchisce la conoscenza. Le due caratteristiche fondamentali del dialogo sono la partecipazione attiva e l’empatia (Gudykunst, 1994; Kim, 2001; Baraldi, 2003). Il dialogo richiede la partecipazione attiva alla comunicazione da parte di individui che evidenziano la propria diversità ed insieme richiede il decentramento delle prospettive individuali, correlato alla considerazione del punto di vista altrui, affinché tale diversità venga accettata da tutti. Queste due caratteristiche producono le condizioni di un’apertura reciproca dei partecipanti, che permette loro di apprendere gli uni dagli altri e creare simboli culturali accettabili nella comunicazione. Il dialogo ha un valore intrinseco: non importa su che cosa si dialoghi, ciò che importa è la costruzione del dialogo. Due caratteristiche ulteriori del dialogo, derivate dalle precedenti, sono la reciprocità, cioè il bilanciamento del potere di agire dei partecipanti, e l’attenzione consapevole (mindfulness) nei confronti dei processi comunicativi in atto. Queste quattro caratteristiche sono il fondamento per altre significative forme della comunicazione dialogica. In primo luogo, è centrale per il dialogo la verifica dell’espressione dell’altro (perception cheking). In secondo luogo, è centrale l’ascolto efficace ed attivo, che evidenzia il coinvolgimento personale nella comunicazione, lo sforzo di comprensione e lo sforzo di chiarimento. In terzo luogo, è rilevante la retroazione (feedback): il monitoraggio sugli effetti della comunicazione, mirato a rafforzarne la comprensione. In quarto luogo, il dialogo è promosso dalla formulazione di asserzioni non aggressive, dalla conferma della posizione altrui, dalla considerazione costante dell’interlocutore. Il dialogo è una forma comunicativa ambiziosa e improbabile, che attualmente non ha molte probabilità di prodursi nelle situazioni di conflitto che coinvolgono individui non adeguatamente formati, come i mediatori interculturali. Al di là della sua improbabilità in queste situazioni sociali, la forma del dialogo evidenzia inoltre un paradosso. La forma del dialogo esalta la dimensione del “tra”, cioè di ciò che sta in mezzo alle diverse posizioni culturali dei partecipanti, un “in mezzo” che viene prodotto socialmente e che porta alla fine ad una forma culturale diversa da quelle iniziali. Il primato del “tra” produce la congiunzione tra forme culturali: l’obiettivo del dialogo è la produzione di un’identità culturale congiunta, che arricchisca quelle iniziali contrapposte creando armonia tra di esse. Il paradosso consiste nel fatto che il dialogo dovrebbe valorizzare la diversità ed insieme produrre una dimensione simbolica unitaria, che connetta le diversità culturali, arricchendole attraverso la congiunzione. Il dialogo esprime la diversità per giungere ad un’unità condivisa. Spesso i sostenitori del dialogo, siano essi pedagogisti, operatori sociali, o uomini politici, Parte 6 - La violenza sul lavoro e nella società civile 191 esprimono l’idea paradossale che il mantenimento della diversità coincida con la costruzione dell’armonia e dell’unità. L’osservazione di questo paradosso blocca la comunicazione e crea le condizioni di nuovi conflitti, all’apparire di difficoltà significative nel congiungere la diversità e del fallimento della ricerca di un nuovo standard. Il dialogo contrasta la violenza in quanto non propone un’azione contro un interlocutore, quindi l’imposizione di una prospettiva: tuttavia, l’obiettivo della congiunzione ripropone condizioni che portano alla violenza. Il metodo dialogico può impedire la violenza, ma la congiunzione ne ricrea le condizioni sociali, date dal primato della condivisione. Se la congiunzione fallisce, come assicurare che l’imposizione della condivisione non ridiventi centrale nella comunicazione? Può il dialogo sopportare la mancanza di congiunzione? Il problema è se il dialogo può essere orientato verso un obiettivo diverso, di coordinamento tra prospettive diverse che ne accetta il conflitto, evitando che l’asserzione in favore di qualcosa si trasformi in un’aggressione contro qualcuno: in altri termini, il problema è la separazione tra l’asserzione e l’aggressione, evitando la condivisione e gestendo i conflitti. Anziché una congiunzione, il dialogo può proporre una forma di coordinamento che non disdegna il conflitto. L’accettazione del conflitto comporta il rifiuto di ogni forma di solidarietà per i valori che causano la violenza, e di tutte le posizioni del tipo né/né, che esprimono una neutralità che è empiricamente impraticabile (Melucci, 2000). Il dialogo può sostenere un conflitto che possiamo definire cosmopolita, che assicura la produzione di comparazioni tra prospettive diverse, in vista dell’obiettivo di un coordinamento (Pearce, 1992). Per citare Theodore Zeldin una posizione cosmopolita “non offre la completa liberazione dal dubbio, né la certezza che sia possibile conquistare il rispetto col solo fatto di appartenere alla parte vincente e di seguirne pedissequamente i leader, né offre la speranza che si realizzi un giorno una società in cui tutti concordino su ciò che è rispettabile, perché le divergenze cominciano ad essere accettate come inevitabili, e persino come una virtù” (Zeldin, 1999, p. 39). Tale posizione assicura il consenso su ciò che è rispettabile in altro modo, cioè attraverso l’operare “di mediatori, di arbitri, di sostenitori e di consiglieri, o di quelli che le saghe islandesi chiamano tessitori di pace, che non pretendono di avere una cura per ogni malattia, e la cui ambizione si limita ad aiutare gli individui ad apprezzarsi a vicenda e a lavorare insieme anche quando non sono pienamente d’accordo, assicurando che le dispute non diventino suicide” (Ibidem, p.39). Riferimenti bibliografici Baraldi C., Comunicazione interculturale e diversità, Carocci, Roma 2003. Gudykunst W., Bridging Differences. Effective Intergroup Communication, Sage, London 1994. Kim Y.Y., Becoming Intercultural. An Integrative Theory of Communication and Intercultural Adaptation, Sage, London 2001. Luhmann N., Sistemi sociali, Il Mulino, Bologna 1990. Luhmann N., De Giorgi R., Teoria della società, Franco Angeli, Milano 1992. 192 Comunicazione e Nonviolenza Melucci A., Culture in gioco, Il Saggiatore, Milano 2000. Pearce P., Comunicazione e condizione umana, Franco Angeli, Milano 1992. Zeldin T., Storia intima dell’umanità, Donzelli, Roma 1999. Note sugli autori Note sugli autori 195 NOTE SUGLI AUTORI GIOVANNI BECHELLONI Giovanni Bechelloni è nato a Firenze nel 1938, vive tra Roma e Firenze dividendo il suo tempo tra la scrittura, la vita accademica e i viaggi. E’ professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nella Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università degli Studi di Firenze dal 1984. Ha insegnato nelle Università di Bari e Napoli (I.U.O. e Federico II). Ha collaborato con Fabrizio Onori alla redazione di «Tempi moderni» (1964-1968). Ha scritto e curato numerosi saggi, pubblicati, tra gli altri, presso Il Mulino, Liguori, Ipermedium, Mediascape. ENRICO CHELI Enrico Cheli insegna Sociologia delle comunicazioni di massa e Sociologia delle relazioni interpersonali all’Università di Siena dove dirige un Master sulle relazioni interpersonali, il counseling e la gestione costruttiva dei conflitti e vari corsi di perfezionamento sulla intelligenza emotiva, la consapevolezza e la comunicazione dei sentimenti e delle emozioni (www.unisi.it/mastercom). È fondatore e direttore del CIRPAC - Centro interuniversitario di ricerca per la pace, l’analisi e la mediazione dei conflitti. Ha pubblicato numerosi libri sui temi della comunicazione e dei confliti tra cui: La realtà mediata. (FrancoAngeli); La comunicazione come antidoto ai conflitti (Punto di fuga); Teorie e tecniche della comunicazione interpersonale (FrancoAngeli) Relazioni in armonia (FrancoAngeli). *** PAOLO ARCHI Paolo Archi vive e insegna a Firenze, ha conseguito un Phd nella Università del Connecticut ed è socio fondatore del CRAIAT, uno dei più importanti centri di ricerca sui media e la comunicazione esistenti in Italia. E’ docente a contratto nel corso di Laurea di Media e Giornalismo e nel corso di Laurea specialistica in Teorie della Comunicazione di Cinema, fotografia e televisione”. E’ studioso dei rapporti fra letteratura e media tradizionali, e si occupa delle trasformazioni subite dall’immagine fotografica a seguito della rivoluzione digitale. CARLO BANDIERA Carlo Bandiera (Roma, 1949) è laureato in Fisica (teorica) e Matematica (economica) e specializzato all’UCLA in Gestione dell’informazione aziendale. Dal 1993 è coordinatore delle attività interaziendali di Iri Management e dirigente del Gruppo IRI dal 1982, dopo esperienze quadriennali nel Gruppo ENI ed in Olivetti. Da vari anni è docente di Comunicazione all’Università di Roma Tor Vergata. Numerose le pubblicazioni, tra esse: Per una nuova immagine di sé. Un approccio strutturato 196 Comunicazione e Nonviolenza alla costruzione dell’immagine personale (Franco Angeli) e con Laura Marozzi Comunicare nel 2000. Tendenze della comunicazione nel nuovo millennio (Franco Angeli). CLAUDIO BARALDI Claudio Baraldi, professore associato, docente di Sociologia e Sociologia dell’educazione e coordinatore del Corso di Laurea in Scienze della Cultura, all’Università di Modena e Reggio Emilia; vicedirettore del Centro Universitario di Ricerche e Studi sulle Famiglie (CURSF) dell’Università di Urbino. Autore, co-autore e curatore di numerosi volumi sulle forme della comunicazione nella società contemporanea, tra i quali Il disagio della società (Angeli, Milano 1999). ENRICA BRACHI Enrica Brachi è docente di “Teorie e tecniche della comunicazione interpersonale” presso il Master “Comunicazione e relazioni interpersonali” dell’Università degli Studi di Siena, sede di Arezzo. Si occupa inoltre di formazione alle abilità comunicativo-relazionali e alla mediazione costruttiva dei conflitti e tiene in proposito corsi per insegnanti, medici, operatori URP etc. DANIELE CARDELLI Daniele Cardelli, docente di Psicologia della Politica all’Università degli Studi di Firenze, è tra i fondatori del Circolo Carl Gustav Jung di Firenze di cui è il Direttore; membro dell’AMAA, dove si è formato come analista, è fondatore di Anima e Polis ed autore di numerose conferenze e pubblicazioni sull’approccio della psicologia analitica alla politica. E’ stato tra i relatori del primo convegno di Psicopolitologia organizzato a Firenze in collaborazione con l’Istituto di Psicologia Analitica di Zurigo. CARLO CATARSI Docente di Sociologia dei Processi Culturali presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Firenze, Carlo Catarsi ha esplorato i connotati ideologici ed organizzativi di varie forme di esclusione. Fra le pubblicazioni più recenti, si ricordano: Competenza e capacità (Franco Angeli, Milano 2001, 2003); La “distance”: condizione di responsabilità in Bechelloni G. (a cura di), Narrazioni mediali dopo l’11 settembre (Mediascape, Firenze 2003); Emergenti ragioni dell’agire contrattuale (in G. Ceccatelli Gurrieri [a cura di], Le ragioni della sociologia, Franco Angeli, Milano, imminente). ADA CATTANEO Laureata in Filosofia all’Università Cattolica (Mi), dal 1999 collabora le cattedre di Sociologia del Turismo, Sociologia generale e del Tempo Libero all’Università IULM (Mi). È nell’èquipe e nell’Ass. ISTUR di F. Alberoni; docente di Comunicazione in corsi FSE; Segretario e nell’Amministrativo del Centro d’Iniziativa Regionale e Europea CIRE (Mi). Ha pubblicato Note sugli autori 197 Valige, gadget, souvenir: gli oggetti del turista anziano; Il Turismo d’argento; The travel: experiences and emotions of time and space in young people; A polysensitive method for qualitative research; Local people and newcomers in a multicultural and multiethnic town Milan; La società sensibile polisensorialità e postmodernismo. ELISABETTA DAMIANIS Elisabetta Damianis è Gestalt Counselor e Dottoranda di ricerca (ciclo XIX) in Politiche Sociali e Sviluppo Locale presso l’Università di Teramo. RODAN DI MARIA Rodan Di Maria è laureato in filosofia e dottorando di ricerca in Pubbliche Relazioni presso l’Università degli Studi di Palermo. Nel 2002 ha partecipato ad un corso internazionale per facilitatori nei conflitti tra gruppi, presso la School For Peace, Neve Shalom/Wahat al Salam (Israele). I suoi interessi di ricerca riguardano le tematiche della convivenza multietnica e la mediazione dei conflitti etnici e sociali. ANGELA DOGLIOTTI MARASSO Angela Dogliotti Marasso si è laureata in Pedagogia, indirizzo psicologico, presso l’Università di Torino, nel1973; ha tenuto un corso di perfezionamento in “Scienze sociali e relazioni interculturali” presso l’Università di Firenze (a.a. 1999-2000); è docente di ruolo nella scuola secondaria superiore fino alle dimissioni per quiescenza, nel 1993; coordinatrice del Gruppo di Educazione alla Pace “M.Cardone” presso il Centro Studi “D.Sereno Regis” di Torino; membro dell’International Peace Research Association e della Peace Education Commission. Da diversi anni svolge attività di ricerca e formazione presso Associazioni, Scuole, Università; ha partecipato in qualità di relatrice a seminari e convegni nell’ambito della Peace Research ed ha pubblicato saggi ed articoli su diverse riviste. ANTONINO DRAGO Antonino Drago, laureato in Fisica all’Università di Pisa nel 1961, è dal 1986 Professore Associato di Storia della Fisica nell’Università “Federico II” di Napoli, e dal 2001 Professore supplente di Strategie della Difesa Popolare Nonviolenta presso il corso di Laurea in Scienze per la Pace dell’Università di Pisa. Autore di cinque libri e circa 300 pubblicazioni di o sulla scienza; fondatore (1978) e membro dell’Italian Peace Res. Institute e di Transcend. Autore di circa 9 libri e 150 pubblicazioni sui temi della pace, educazione alla pace, obiezione di coscienza, nonviolenza, difesa popolare nonviolenta. ALBERTO DREOSSI Alberto Dreossi è dottorando in Sociologia dei processi culturali presso le Università consorziate di Modena-Reggio Emilia ed Urbino. Ha svolto lavori sulla comunicazione intercultu- 198 Comunicazione e Nonviolenza rale in Niger e su quella tra adulti e bambini. E’ autore di alcuni saggi e curatore di alcune pubblicazioni multimediali su questi temi. Attualmente collabora alle ricerche dell’equipe di sociologia dell’Università di Modena e Reggio Emilia dove conduce seminari sulle tecniche della video-osservazione della comunicazione tra bambini e adulti. ENRICO EULI Nato nel 1961, laureato in filosofia, psicologo. Formatore alla nonviolenza, autore di testi sul training e sull’azione diretta, impegnato nei movimenti ecopacifisti e lillipuziani. Docente a contratto di Metodologie e tecniche del gioco e del lavoro di gruppo all’Università di Cagliari (Scienze della Formazione). CRISTIANO INGUGLIA Cristiano Inguglia, laureato in psicologia, è Dottore di ricerca in Pubbliche Relazioni e professore a contratto di Psicologia Sociale presso l’Università degli Studi di Palermo. Nel 2002 ha partecipato ad un corso internazionale per facilitatori nei conflitti tra gruppi, presso la School For Peace, Neve Shalom/Wahat al Salam (Israele). I suoi interessi di ricerca riguardano lo sviluppo dell’identità etnica e degli atteggiamenti etnici nei bambini immigrati e la mediazione dei conflitti etnici e sociali. ALBERTO L’ABATE Alberto L’Abate insegna Sociologia dei conflitti e ricerca per la pace al corso di laurea in Operatori per la pace dell’Università di Firenze. Ha partecipato con Aldo Capitini alla fondazione del Movimento Nonviolento Italiano ed ha diretto per 15 anni la scuola estiva di formazione alla non violenza presso la casa per la pace di S. Gimignano. E’ autore di molti articoli e libri sull’argomento della pace. Il suo ultimo libro si intitola: Giovani e pace. Ricerche e formazione per un futuro meno violento, ed. Pangea, Torino, 2001. NICOLA LOPANE Nicola Lopane è laureato in Scienze della Comunicazione all’Università di Perugia. Si occupa di dinamiche di gruppo, di gestione dei conflitti e di negoziazione. Ha esperienza di conduzione di piccoli gruppi, universitari e non. Ha pubblicato con altri: Un ipertesto per la storia della psicologia, Perugia 2000; Eur-ed: an hypertextual framework to compare teacher education, Perugia 2003. Ha di recente presentato la relazione Il conflitto dal micro al macrosociale: definizioni e fenomenologia al Convegno Internazionale “Psicologi e Forze Armate”, Perugia ottobre 2003. MAURIZIO LOZZI Maurizio Lozzi, giornalista e sociologo con Master europeo in A.D.R. Alternative Dispute Resolutions, si occupa di Mediazione pacifica e nonviolenta dei conflitti attivando nelle scuo- Note sugli autori 199 le seminari di formazione e di aggiornamento per studenti ed insegnanti. Docente a contratto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino dove insegna Sociologia e Sociologia del Lavoro e anche Dottorando di ricerca in Studi strategici e difesa della Pace presso l’Università degli Studi “S. Pio V” di Roma. Partecipa come relatore in convegni e conferenze, collabora con il Centro Psicopedagogico per la Pace e la Gestione dei Conflitti di Daniele Novara, presiede l’associazione di volontariato EuroMedias, Unione Euromediterranea per la Mediazione consensuale dei conflitti, fa parte del direttivo della S.I.D.D. (Società Italiana di Demodossologia per gli studi e le ricerche sociali) ed è Presidente della sezione territoriale di Frosinone dell’Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani. Collabora, infine, al comitato editoriale di Conflitti. Rivista nazionale di formazione e ricerca psicopedagogia (CPPP, Piacenza) di Mediares - Semestrale sulla mediazione (Edizioni Dedalo, Bari) e di Quaderni Satyagraha, rivista di Peace Studies del Centro Gandhi e dell’Università degli Studi di Pisa (Edizioni Plus, Pisa). GIUSEPPE MANI MONTEVERDE 1998: Laurea in Teologia morale presso l’Accademia Alfonsiana di Roma, con una tesi sul Satyagraha. 1998-1999: alcuni seminari sulla gestione dei conflitti nelle imprese e nei gruppi di trasformazione sociale all’Università di Bologna. 1997: esperienza operativa circa la gestione del potere in un villaggio in Tchad. 1996-1998: formatore degli obiettori di coscienza e dei volontari della Caritas a Roma e Assisi. 1992-1997: coordinatore di campi nazionali sulla nonviolenza in Sila. Attualmente consulente nella gestione dei conflitti a Genova. MARIA MARTELLO Maria Martello è Docente a contratto di Psicologia dei rapporti interpersonali presso l’Università di Venezia. Ha creato l’Istitutodeva (www.istitutodeva.it) che offre servizi di mediazione dei conflitti, di formazione e di progettazione di interventi. Giudice on. presso il Tribunale Minorile di Milano. Ha ideato un percorso nuovo di formazione nell’ambito delle Tecniche di Risoluzione Alternativa delle Dispute. Ha Pubblicato, oltre a molteplici contributi e articoli: Percorsi di civiltà, con allegato : Leggi e istituzioni, Ghisetti e Corvi, Milano 1994 e Oltre il conflitto: dalla mediazione alla relazione costruttiva, McGraw-Hill, Milano 2003. PAOLO S. NICOSIA Laureato in Scienze Politiche all’ Università di Perugia, Paolo S. Nicosia ha frequentato corsi ADR presso l’Harvard Negotition Project (USA), il CEDR e l’ADR Group (GB), l’ISDACI (MI), Curia Mercatorum (TV) e la Camera Arbitrale di Roma, della quale è conciliatore (incarico ricoperto anche per le CCIAA di Milano e Perugia). Amministra la società CONCILIA, è docente di “Mediazione e conciliazione” al Corso di Laurea in Scienze per la Pace dell’Università di Pisa e coordinatore degli stage del modulo professionalizzante in mediazione e conciliazione. E’ autore di alcune pubblicazioni sull’ADR. 200 Comunicazione e Nonviolenza PAOLA REBUGHINI Paola Rebughini è ricercatore presso il Dipartimento di Studi Sociali e Politici dell’Università Statale di Milano. Ha svolto attività di ricerca e di insegnamento in Francia e in Gran Bretagna. È autore di Violenza e spazio urbano. Rappresentazioni e significati della violenza nella città contemporanea (Guerini, 2001); Letture di sociologia (con L.Leonini, Guerini, 2002); La medicina che cambia. Terapie non convenzionali in Italia (con E. Colombo, Il Mulino, 2003); La violenza (Carocci, in stampa). LUCIA RICCO Lucia Ricco è nata a Cagliari nel 1958. Laureata in Chimica, è attualmente membro dell’Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahá’í d’Italia e Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Esterne a Roma. In precedenza ha lavorato come imprenditore nel campo della comunicazione televisiva, gestendo una società di servizi ai network nazionali ed europei e curandone per 15 anni le relazioni esterne. E’ membro del direttivo nazionale del Club di Budapest Italia e della Consulta delle Religioni del Comune di Roma. TIZIANO TELLESCHI Specialista di ricerca in sociologia al Dipartimento di Scienze sociali, al Corso di Laurea in scienze della Pace, alla SSIS-Scuola di Specializzazione per Insegnanti delle Scuole Superiori di Pisa, dell’Università di Pisa. Attualmente è visiting lecturer al Master Internacional Post-Doctorado en Estudios para la Paz y el Desarrollo, Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, Spagna. E’ stato Fulbright Scholar alla Vanderbilt University - TN, Usa; e C.N.R. Scholar alla Universidad de Sevilla, Spagna. Ha svolto studi e ricerche su quattro direttrici: Linguaggi discorsivi e non discorsivi; Politiche sociali e sanitarie; Processi di inclusione/esclusione di comunità (linguistiche, di giovani, anziani, immigrati); Educazione alla pace e “Local governance”. Coordinatore della Commissione di Ricerca “Pace e Sicurezza” al CISP di Pisa. Coordinatore del Progetto Pace nelle scuole, anni 2002 e 2003, svolto con finanziamento della Regione Toscana. Responsabile del Plan on Local Governance and Peace Education, un’area speciale della convenzione di ricerca MIUR Italia-Serbia “Studies on Peace”. ISCANDER MICAEL TINTO Iscander Micael Tinto ha conseguito la laurea internazionale in “World Order Studies” presso l’istituto svizzero per lo sviluppo delle risorse umane “Landegg Academy” con sede a Wienacht (San Gallo), studiando con particolare attenzione materie tra le quali economia, psicologia, filosofia, storia e sociologia. Laureando in psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso l’università degli Studi di Padova, svolge la libera professione collaborando come consulente formatore presso importanti aziende ed Enti di Formazione del Nord e Centro Note sugli autori 201 Italia, insegnando la comunicazione e le sue tecniche, l’organizzazione aziendale, l’assertività, l’analisi transazionale, il lavoro di gruppo e la negoziazione. Collabora con il Wilmette Institute di Chicago come consulente a distanza su temi quali la storia, la storia delle religioni, il misticismo e la filosofia. FIORELLA TONELLO Fiorella Tonello, psicologa, mediatrice familiare e consulente del Tribunale di Firenze. Formazione clinica junghiana e gestaltica, si occupa di formazione attraverso la conduzione di gruppi. Svolge attività didattica presso scuole di formazione, enti ed associazioni. FRANCESCO TULLIO Docente di psicoterapia breve Università di Perugia; esperto in gestione costruttiva dei conflitti e problem solving. Svolge attività di consulenza e terapia a Roma e Perugia. Consulente del Comune di Roma per i problemi del disagio e della violenza a scuola. Ha curato per il Ministero della Difesa la ricerca La difesa civile ed il progetto Caschi Bianchi; peacekeepers civili disarmati (Franco Angeli, Roma 2001) e per l’ufficio ONU del Ministero Affari Esteri la ricerca Le ONG e la gestione dei conflitti. Il confidence-building a livello di comunità nelle crisi internazionali. Analisi, esperienze, prospettive. (Ed. associati, ed. internazionale, Roma 2002). ANDREA VOLTERRANI Assegnista di ricerca del Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia dell’Università di Firenze, Andrea Volterrani è docente a contratto nelle Università di Firenze e di Siena. E’ interessato ai temi della comunicazione sociale e dei processi di costruzione e trasformazione degli stereotipi. E’ redattore della «Rivista Italiana di Comunicazione Pubblica». Pubblicato online sul sito: http://www.mediascape.it dicembre 2004
Scarica