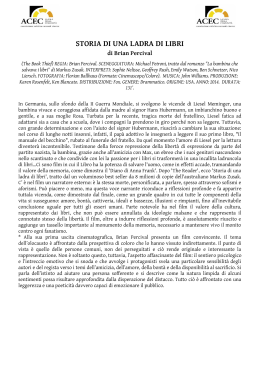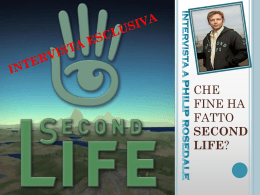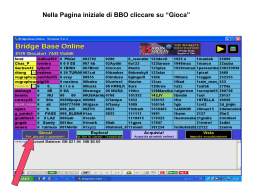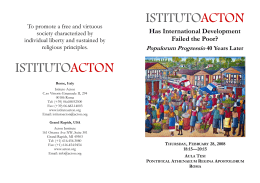L’ASCESA DEL GOVERNATORE ROBERT KIRKMAN E JAY BONANSINGA by TWD FAN Italia twdfan.altervista.org T ut t i i personaggi, le organizzazioni e gli event i descrit t i in quest o libro sono prodot t i della f ant asia degli aut ori o usat i in maniera f it t izia. T HE WALKING DEAD 1: L’ASCESA DEL GOVERNAT ORE Un libro di Panini Comics, divisione edit oriale di Panini S.p.A. Redazione e direzione: Panini Comics, viale Emilio Po 380, 41126 Modena. www.paninicomics.it THE WALKING DEAD: RISE OF THE GOVERNOR. Copyright © 2011 by Robert Kirkman and Jay Bonansinga. All rights reserved. Originally published by St. Martin’s Press, LLC as the original publisher of the work. “In My Dreams” by Jeanie B! copyright © 2004 by Jeanne Bonansinga. Used by permission. Per l’edizione italiana: © 2012 Panini S.p.A. Direttore editoriale MARCO M. LUPOI Direttore mercato Italia SIMONE AIROLDI Marketing ALEX BERTANI Publishing manager Italia SARA MATTIOLI Coordinamento editoriale LEONARDO RAVEGGI Redazione GIAN LUCA RONCAGLIA, GIULIA BALLESTRAZZI Ufficio grafico PAOLA LOCATELLI Ufficio produzione ALESSANDRO NALLI Traduzione STEFANO MENCHETTI e VANIA VITALI per LIBR@RY MOUSE Cura editoriale MATTIA DAL CORNO Per l’edizione digitale: Supervisione CARLO DEL GRANDE Grafica e impaginazione ILARIA INGROSSO Foto di copertina ©iStockphoto.com/shaunl A Jeanie-B, Joey e Bill… gli amori della mia vita. —Jay A Sonia, Peter e Collette… vi prometto che lavorerò di meno quando il college sarà pagato. —Robert RINGRAZIAMENTI Un ringraziamento speciale a Robert Kirkman, Brendan Deneen, Andy Cohen, David Alpert, Stephen Emery e a tutti i bravi ragazzi del Circle of Confusion. —Jay Pollice in alto per Jay Bonansinga, Alpert e il resto del Circle of Confusion, i bravi ragazzi della Image Comics e il “timoniere” Charlie Adlard. Tutta la mia stima per Rosenman, Rosenbaum, Simonian e Lerner. E, ovviamente… Brendan Deneen. —Robert PARTE PRIMA Gli Uomini Vuoti “Non c’è niente di glorioso nel morire. Possono farlo tutti.” —Johnny Rotten UNO Rannicchiato nell’oscurità che sa di chiuso, col terrore a comprimergli il petto e il dolore a pulsare nelle ginocchia, Brian Blake pensa a una cosa: se solo possedesse un secondo paio di mani, potrebbe tapparsi le orecchie e tenere lontano il rumore di teste umane fatte a pezzi. Purtroppo, le sole mani che Brian possiede sono impegnate a coprire le piccole orecchie della bambina che gli sta accanto nell’armadio. La bimba di sette anni continua a tremargli tra le braccia, sobbalzando per via del l ’i ntermi ttente THWACK-GAHHHH-THUMP che proviene da fuori. Poi cala il silenzio, spezzato soltanto dal rumore appiccicoso di passi di stivali sulle piastrelle insanguinate e da un’ondata di imprecazioni sussurrate nel vestibolo. Brian comincia a tossire di nuovo. Non può evitarlo. Per giorni ha combattuto contro quel dannato raffreddore, contro il dolore ostinato alle articolazioni e contro il naso perennemente chiuso. Gli capita ogni autunno, quando le giornate in Georgia si fanno umide e buie. L’umidità gli entra nelle ossa, gli risucchia tutte le energie e gli toglie il fiato. E adesso, a ogni colpo di tosse, sente anche il martellare della febbre. Piegato in due da un altro spasmo soffocante, continua a tenere le mani pressate sulle orecchie della piccola Penny. Sa che il rumore della sua tosse richiamerà l’attenzione di quanti sono fuori dalla porta dell’armadio, nei meandri della casa, ma non può farci niente. A ogni attacco di tosse sottili strisce di luce, come filamenti di fuochi d’artificio, gli attraversano le pupille chiuse. L’armadio, largo appena un metro e venti e profondo forse novanta centimetri è buio come l’interno di un calamaio e puzza di naftalina, merda di topo e cedro stantio. Le buste di plastica, che rivestono gli abiti, pendono nell’oscurità e gli sfiorano il viso. Il fratello minore di Brian, Philip, gli ha dato il permesso di tossire. In realtà gli ha detto di tossire pure fino a strozzarsi poiché il rumore avrebbe fatto venir fuori i mostri, ma avrebbe fatto meglio a non attaccare il suo dannato raffreddore alla bimba, la figlia di Philip. Se l’avesse fatto, allora Philip gli avrebbe spaccato la testa in due. L’attacco di tosse passa. Alcuni istanti dopo, un altro rumore di passi strascicati disturba il silenzio fuori dall’armadio: un’altra cosa morta entra nella zona di neutralizzazione. Brian preme le mani sulle orecchie di Penny con più forza, e la bambina sobbalza alla nuova interpretazione dello Schiacciamento di Teste in Fa Minore. Se gli fosse chiesto di descrivere quel baccano, probabilmente Brian Blake tornerebbe indietro ai suoi giorni da imprenditore, fallito, di un negozio di musica e direbbe che il rumore delle teste schiacciate ricorda una sinfonia di percussioni suonata all’inferno, come uno scarto allucinato di Edgard Varese o un assolo di batteria dopato di John Bonham, con versi ripetuti e cori: il respiro pesante degli umani… i passi incerti di un cadavere semovente… il sibilo di un’ascia… il THUNK dell’acciaio che si conficca nella carne… …e poi, il gran finale, il tonfo molliccio di un corpo morto sul parquet viscido. Segue un’altra pausa e Brian avverte una scarica di brividi febbricitanti lungo la spina dorsale. Torna il silenzio. Con gli occhi ormai adattati all’oscurità, Brian vede il primo luccichio di denso sangue arterioso colare da sotto la porta: sembra quasi olio da motore. Allontana con delicatezza la nipote dalla pozza che si allarga, spingendola contro gli stivali e gli ombrelli appoggiati sul fondo. L’orlo del vestitino di jeans di Penny Blake tocca il sangue. La bambina scosta subito il tessuto e sfrega freneticamente la macchia, come se il semplice assorbimento del sangue possa in qualche modo infettarla. Brian si piega in due per un nuovo attacco; lo combatte, deglutisce e, per via della gola infiammata, ha la sensazione di ingoiare dei vetri rotti. Attira a sé la bambina e la stringe in un abbraccio. Non sa cosa fare o dire. Vorrebbe aiutarla, sussurrarle qualcosa di rassicurante, ma non riesce a pensare a niente di rassicurante da sussurrare. Il padre della bambina saprebbe cosa dire. Lui sa sempre cosa dire. Philip Blake è il tipo che dice sempre le cose che gli altri avrebbero voluto dire. Dice quanto va detto e fa quanto va fatto. Proprio come adesso. Philip è là fuori con Bobby e Nick, a fare quello che va fatto… mentre Brian se ne sta rannicchiato al buio come un coniglio impaurito, senza sapere cosa dire a sua nipote. E considerando che Brian Blake è il più grande dei due fratelli, è strano che proprio lui sia una mezza cartuccia. Alto appena un metro e settanta anche con gli stivali coi tacchi, Brian Blake è uno spaventapasseri ossuto che riempie a stento gli stretti jeans neri e la maglietta strappata dei Weezer. Un pizzetto scuro di colore indefinibile, braccialetti di macramè e un cespuglio di capelli neri alla Ichabod Crane completano l’immagine di un trentacinquenne bohémien intrappolato senza speranza in un limbo simile a quello di Peter Pan, e ora inginocchiato in quella oscurità che sa di naftalina. Brian respira a fatica e abbassa lo sguardo sugli occhi da cerbiatta spaventata di Penny, sul suo volto muto e terrorizzato che affiora spettrale nel buio dell’armadio. Penny è sempre stata una bambina tranquilla e con un colorito estremamente pallido, come quello di una bambola di porcellana, il che conferisce al suo viso un aspetto quasi etereo. Ma da quando è morta sua madre si è chiusa in se stessa, diventando sempre più pallida e distaccata, fino a sembrare quasi traslucida, con le ciocche di capelli corvini a coprirle gli occhi spalancati. Negli ultimi tre giorni, ha detto a malapena qualche parola. Naturalmente sono stati tre giorni straordinari… e i traumi colpiscono i bambini in modo diverso dagli adulti, ma Brian teme che Penny stia scivolando in una specie di stato di shock. “Andrà tutto bene, piccola” le sussurra con un piccolo e incerto colpo di tosse a punteggiare l’affermazione. Lei dice qualcosa senza guardarlo. Biascica con lo sguardo fisso sul pavimento, mentre una lacrima le riga la guancia sporca. “Cosa c’è, Pen?” Brian la culla tenendola stretta e le asciuga la lacrima. Lei dice ancora qualcosa, e ancora e ancora, ma non si rivolge davvero a Brian. Lo dice piuttosto come un mantra o una preghiera o un incantesimo: “Non andrà mai più bene, mai e poi mai-mai-mai-mai”. “Ssssshhhh.” Le tiene la testa, stringendola dolcemente contro le pieghe della T-shirt. Sente il calore umido della sua faccia contro le costole. Le copre di nuovo le orecchie mentre da fuori si ode il THWACK di un’altra ascia, che attraversa il cuoio capelluto, le ossa del cranio e gli strati di dura madre per conficcarsi nella gelatina grigia del lobo occipitale. Sembra il rumore di uno schiaffo, come una mazza da baseball che colpisce una palla morbida e bagnata; lo schizzo del sangue, invece, è come uno straccio per pavimenti, seguito da un orribile tonfo umido. Stranamente, per Brian quello è il momento peggiore: quel tonfo sordo e molliccio di un corpo che cade sulle costose piastrelle di ceramica. Le piastrelle sono state realizzate apposta per quella casa, con un motivo elaborato e decorazioni in stile azteco. È una casa deliziosa… o almeno lo era stata. I rumori cessano di nuovo. A seguirli è ancora l’orribile silenzio sgocciolante. Brian soffoca un colpo di tosse, trattenendolo come un petardo che sta per scoppiare: deve poter udire anche il minimo cambiamento nei respiri fuori dall’armadio, nei passi viscidi che strisciano sul sangue. Ma adesso regna un silenzio mortale. Brian sente la bambina irrigidirsi accanto a lui: la piccola Penny si prepara per un’altra sequenza di colpi d’ascia, ma il silenzio resiste. A pochi centimetri di distanza, lo scatto metallico della maniglia che comincia a girare fa accapponare la pelle di Brian. La porta si spalanca. “Okay, siamo a posto.” È la voce baritonale, arrochita dal fumo e dal whisky, di un uomo che guarda nei recessi dell’armadio sbattendo le palpebre per il buio. Con la faccia madida di sudore e rossa per la fatica di essersi occupato degli zombie, Philip Blake stringe un’ascia bagnata di sangue nella mano da operaio. “Sei sicuro?” chiede Brian. Philip ignora il fratello e abbassa lo sguardo su sua figlia. “Va tutto bene, pulcino, papà sta bene.” “Sei sicuro?” dice Brian tossendo. Philip lo guarda. “Ti dispiacerebbe coprirti la bocca, campione?” Brian ansima. “Sei sicuro che è tutto pulito?” “Pulcino?” Philip Blake si rivolge con tenerezza a sua figlia e il leggero accento del Sud nasconde l’infuocata, selvaggia brace di violenza che proprio ora si sta spegnendo nei suoi occhi. “Ho bisogno che tu rimanga qui per un minuto. Va bene? Resta qui finché papà non ti dice che puoi uscire. Hai capito?” Con un lieve cenno del capo, la bambina pallida gli fa segno di aver capito. “Forza, campione.” Philip sprona il fratello a uscire dall’ombra. “Mi serve anche il tuo aiuto per ripulire.” Brian armeggia per alzarsi in piedi e farsi largo tra i vestiti appesi. Emerge dall’armadio con gli occhi stretti per la forte luce del vestibolo. Guarda, tossisce e torna di nuovo a guardare. Per un attimo gli sembra che il lussuoso atrio della casa a due piani in stile coloniale, brillantemente illuminato dai sontuosi candelieri di rame, sia stato ritinteggiato da una squadra di operai affetti da paralisi. Grosse strisce color melanzana imbrattano l’intonaco verdeblu delle pareti, e macchie di Rorschach nere e scarlatte adornano i battiscopa e le modanature. Solo alla fine si notano le sagome sul pavimento. Sei corpi giacciono sui fianchi, ammucchiati in un cumulo insanguinato. Età e genere sono celati dal sangue ancora umido, dalla carnagione livida e dai crani ormai informi. Il più grosso giace in una pozza di bile che si allarga ai piedi della grande scalinata circolare. Un altro, forse quello della padrona di casa, forse colei che una volta era stata un’allegra signora nota per le sue crostate di pesche e l’ospitalità del Sud, è riverso in un ammasso contorto sul delizioso parquet bianco, mentre un filo di materia grigia cola lento dal cranio sfondato. Brian Blake ha la nausea e la gola gli si dilata involontariamente. “Okay, signori, questo è un lavoro per noi” dice Philip, rivolto ai due compagni, Nick e Bobby, e a suo fratello, ma Brian riesce a sentirlo a malapena sopra il battito sordo del suo stesso cuore. Vede i corpi rimanenti di quelli che, negli ultimi due giorni, Philip ha cominciato a chiamare “maiali in doppia cottura”, ammucchiati sul battiscopa scuro e lucido della soglia del soggiorno. Forse i figli adolescenti che un tempo vivevano lì, forse visitatori che hanno sperimentato l’inospitalità del Sud per colpa di un morso infetto: chiunque fossero, ora giacciono in mezzo a un’esplosione di sangue. Uno con la testa ammaccata e riversa a faccia in giù sul pavimento, come una pentola messa ad asciugare, continua a pompare fluidi scarlatti con la copiosità di un idrante aperto. Altri due hanno ancora le lame delle piccole accette conficcate nel cranio e affondate fino al manico, come le bandiere di esploratori trionfanti piantate su cime un tempo irraggiungibili. La mano di Brian scatta alla bocca per arginare la marea che sale dall’esofago. Ha la sensazione che qualcosa gli sfiori la testa, come se una falena gli battesse ritmicamente sul capo. Alza lo sguardo. Dal candeliere sopra la sua testa cola del sangue e una goccia gli cade sul naso. “Nick, perché non vai a prendere un po’ di quei teli che abbiamo visto nel…” Brian cade in ginocchio, si piega in avanti e vomita rumorosamente sul parquet. L’ammasso fumante di bile color cachi cola sulle piastrelle, mescolandosi alle secrezioni dei morti. Le lacrime gli bruciano negli occhi mentre rigurgita quattro giorni di angoscia. Philip Blake si lascia sfuggire un sospiro teso con l’adrenalina che ancora gli circola in corpo. Per un attimo non fa alcuno sforzo per avvicinarsi al fratello: si limita a restare dov’è, posando l’ascia insanguinata e alzando gli occhi al cielo. È un miracolo che non gli si sia scavato un solco sopra le palpebre, per tutte le volte che negli anni ha alzato gli occhi al cielo a causa di suo fratello. Ma cos’altro può fare? Quel povero figlio di puttana fa parte della sua famiglia, e la famiglia è la famiglia… specie in tempi eccezionali come questi. La somiglianza c’è di sicuro, Philip non può farci nulla. Philip Blake, alto, slanciato e coi muscoli possenti di un facchino, ha gli stessi lineamenti di suo fratello, gli stessi occhi scuri a mandorla e gli stessi capelli neri come il carbone, che hanno ereditato dalla madre messicana. Il nome da ragazza di mamma Rose era Garcia e i suoi lineamenti hanno dominato su quelli di Ed Blake, il padre dei ragazzi, un grosso e rozzo alcolizzato di origini scozzesi e irlandesi. Philip, di tre anni più giovane di Brian, ha preso da lui tutti i muscoli. Se ne sta lì in tutto il suo metro e ottanta abbondante, coi jeans sbiaditi, gli stivali da lavoro e una maglia di cotone, coi baffi alla Fu Manchu e i tatuaggi da galera di un motociclista; sta per muovere la figura imponente verso il fratello ancora in preda ai conati, con l’intenzione forse di dirgli qualcosa di sgradevole, quando si ferma: ha sentito qualcosa che non gli piace provenire da oltre il vestibolo. Bobby Marsh, un vecchio compagno di liceo di Philip, è ai piedi della scalinata, intento a pulirsi l’ascia sui jeans taglia XXL. Un corpulento disadattato di trentadue anni, coi lunghi e unti capelli castani raccolti in una coda di cavallo, Bobby non è obeso, ma decisamente sovrappeso, proprio il tipo che i compagni di classe alla Burke County High avrebbero chiamato “palla di lardo”. In questo momento ridacchia, una risatina nervosa che gli fa tremare la pancia, mentre osserva Brian Blake che vomita. La risatina è spenta e vuota, una sorta di tic che, a quanto pare, Bobby non riesce a controllare. È cominciata tre giorni fa, quando uno dei primi non morti è sbucato goffo dall’officina di una stazione di servizio vicino all’aeroporto di Augusta. Vestito di una tuta fradicia di sangue, lo scimmione sporco d’olio è uscito a passi strascicati, con un pezzo di carta igienica attaccato ai piedi e ha cercato di cibarsi del grasso collo di Bobby prima che Philip si facesse avanti e lo abbattesse con un piede di porco. La scoperta di quel giorno, ovvero che un violento colpo alla testa fosse perfetto per eliminare i mostri, aveva innescato la risatina nervosa di Bobby. È decisamente un meccanismo di difesa, accompagnato da un sacco di chiacchiere ansiose del tipo: “È qualcosa nell’acqua, amico, come la fottuta peste nera del cazzo”. Ma Philip non aveva avuto voglia di sentire le sue teorie sulle cause di quella tempesta di merda allora e di certo non vuole sentirle adesso. “Ehi!” Philip si rivolge all’uomo massiccio. “Pensi ancora che sia divertente?” La risata di Bobby si spegne. All’altro lato della stanza, vicino a una finestra affacciata sulla distesa buia del cortile sul retro, una quarta figura osserva a disagio. Nick Parsons, un altro amico proveniente dall’infanzia ribelle di Philip, è un uomo snello e compatto sulla trentina, con la cura della persona tipica delle scuole private e il taglio di capelli a spazzola dell’eterno spaccone. Nick è il religioso del gruppo e ha impiegato più tempo degli altri ad abituarsi all’idea di distruggere cose che un tempo erano state delle persone. Adesso i suoi pantaloni color cachi e le scarpe da ginnastica sono punteggiati di sangue, e gli occhi gli bruciano per il trauma, mentre guarda Philip avvicinarsi a Bobby. “Mi dispiace, amico” mormora Bobby. “Mia figlia è la dentro” dice Philip, ormai quasi naso a naso con Marsh. Basta un attimo perché l’instabilità derivante dalla rabbia, dal panico e dal dolore si infiammi in Philip Blake. Bobby guarda il pavimento lucido di sangue. “Scusa, scusa.” “Va’ a prendere i teli, Bobby.” Un paio di metri più in là, Brian Blake, ancora appoggiato su mani e ginocchia, espelle ciò che rimane del contenuto del suo stomaco e continua a spingere a vuoto… Philip cammina verso il fratello maggiore e si inginocchia accanto a lui. “Butta fuori tutto.” “Io… uh…” dice rauco Brian, tirando su col naso e sforzandosi di esprimere un pensiero sensato. Con gentilezza, Philip gli posa una mano grossa, sporca e callosa sulle spalle piegate. “Va tutto bene, fratellone… butta fuori tutto e basta.” “Mi… d-dispiace.” “Va tutto bene.” Brian riprende il controllo in qualche modo e si pulisce la bocca col dorso della mano. “P-pensi di averli presi tutti?” “Sì.” “Sei sicuro?” “Certo.” “Hai controllato… dappertutto? Nel seminterrato e cose del genere?” “Sissignore. Tutte le camere da letto… e anche il solaio. L’ultimo è sbucato dal suo nascondiglio quando ha sentito il tuo fottuto tossire: la tua tosse è forte abbastanza da risvegliare i fottuti morti. La ragazzina ha cercato di farsi il doppio mento di Bobby per pranzo.” Brian deglutisce, un gesto crudo e doloroso. “Questa gente… loro… vivevano qui.” Philip sospira. “Non più.” Brian osserva la stanza attorno a sé, poi alza lo sguardo verso il fratello con il viso bagnato di lacrime. “Ma erano… una famiglia.” Philip annuisce e non dice niente. Avrebbe voglia di scrollare le spalle, che cazzo me ne frega, ma si limita ad annuire. Non pensa alla famiglia zombificata che ha appena sterminato né alle implicazioni dell’enorme massacro che ha compiuto negli ultimi tre giorni, uccidendo individui che fino a poco prima erano madri, postini e benzinai. Ieri, Brian è partito per una qualche tangente intellettuale, sparando stronzate sulla differenza tra etica e morale di quella situazione: moralmente, non si dovrebbe mai uccidere, mai, ma eticamente c’è una sottile differenza: si dovrebbe uccidere solo per autodifesa. Ma per Philip quello che fanno non è uccidere. Non puoi uccidere qualcosa che è già stato ucciso; si tratta solo di schiacciarlo come uno scarafaggio e andare avanti, smettendola di pensarci tanto. Al momento, poi, Philip non pensa affatto alla prossima mossa che il suo piccolo gruppo scalcinato dovrà fare, decisione che probabilmente spetterà interamente a lui (è diventato il leader del gruppo e tanto vale che affronti la cosa). Al momento, Philip Blake è concentrato su un unico obiettivo: da quando quell’incubo è cominciato, meno di settantadue ore fa, e la gente ha cominciato a cambiare per ragioni che nessuno è riuscito a spiegare, la sola cosa a cui è stato in grado di pensare è proteggere Penny. È per quello che se l’è filata dalla sua città natale, Waynesboro, due giorni fa. La piccola comunità agricola sul lato orientale della Georgia è andata all’inferno in fretta quando la gente ha preso a morire e a tornare indietro. Ma è stata l’incolumità di Penny a convincere Philip ad abbandonare la città. È stato per proteggere Penny che si è assicurato l’aiuto dei suoi vecchi compagni di scuola; ed è stato per Penny che ha deciso di dirigersi ad Atlanta, dove, secondo i notiziari, sono stati allestiti i centri profughi. Tutto quello che ha fatto l’ha fatto per Penny. Penny è tutto ciò che gli resta, che gli permette di andare avanti; è l’unico balsamo che lenisce il dolore della sua anima ferita. Molto prima che quella inspiegabile epidemia scoppiasse, il vuoto nel cuore di Philip avrebbe potuto farsi sentire con una fitta acuta alle tre di una notte insonne. Quella era l’ora esatta in cui aveva perso sua moglie, difficile credere che fossero passati già quasi quattro anni!, su un’autostrada scivolosa a causa della pioggia a sud di Athens. Sarah era andata a trovare un’amica all’Università della Georgia, aveva bevuto e aveva perso il controllo dell’auto su una strada tortuosa nella contea di Wilkes. Dal momento in cui aveva identificato il corpo, Philip aveva capito che non sarebbe più stato lo stesso. Non ci aveva pensato due volte a fare la cosa giusta e accettare due lavori per nutrire, vestire e accudire Penny, ma non sarebbe più stato lo stesso. Forse era questo il motivo per cui stava accadendo tutto questo. Il solito, vecchio scherzo di Dio. Quando arrivano le cavallette e i fiumi scorrono rossi di sangue, il tizio che ha più da perdere si ritrova a guidare il branco. “Non importa chi erano” dice infine Philip al fratello. “O cosa erano.” “Già… immagino che tu abbia ragione.” A questo punto, Brian è ormai riuscito a mettersi seduto a gambe incrociate e respira profondamente. Guarda Bobby e Nick che, dall’altra parte della stanza, srotolano dei grossi teli e aprono dei sacchi per l’immondizia coi quali avvolgono i cadaveri ancora sgocciolanti. “L’unica cosa che adesso conta è che dobbiamo ripulire questo posto” dice Philip. “Stanotte resteremo qui e domani, se riusciamo a trovare un po’ di benzina, arriveremo ad Atlanta.” “Però non ha alcun senso” mormora Brian, spostando lo sguardo da un cadavere all’altro. “Di cosa parli?” “Guardali.” “Cosa?” Philip getta uno sguardo da sopra la spalla sui resti raccapriccianti della padrona di casa che vengono arrotolati in un telo. “Beh?” “Sono una famiglia.” “E allora?” Brian tossisce, coprendosi con la manica, poi si pulisce la bocca. “Voglio dire che… ci sono la madre, il padre, i quattro figli adolescenti… ed è tutto qui.” “Sì… e quindi?” Brian alza lo sguardo verso Philip. “Quindi come diavolo è successa una cosa del genere? Si sono… trasformati tutti insieme? Uno di loro è stato morso e gli altri lo hanno portato dentro?” Philip ci pensa per un attimo, dopotutto non ha ancora capito cosa stia davvero succedendo e come funzioni questa follia, ma alla fine si stanca di pensarci e dice: “Forza, alza il tuo culo pigro e dacci una mano”. Ci impiegano quasi un’ora a ripulire il posto. Penny resta nell’armadio per tutto il tempo. Philip le porta un animale di pezza che ha trovato nella stanza di uno dei bambini e le dice che non dovrà attendere molto prima di poter uscire. Brian lava via il sangue, tossendo di tanto in tanto, mentre gli altri tre trascinano fuori i cadaveri avvolti nei teli, due grandi e quattro più piccoli, attraverso le porte scorrevoli sul retro e il grande portico di cedro. Il cielo notturno di fine settembre sopra di loro è limpido e freddo come un oceano nero, un tripudio di stelle splendenti che li deridono con il loro impassibile e allegro brillare. Nel buio, si vede il fiato dei tre uomini che trascinano i fardelli sulle assi coperte di gelida rugiada. Portano dei picconi attaccati alla cintura e Philip ha una pistola dietro la schiena, infilata nella cinta. È una vecchia Ruger calibro .22 che ha comprato a un mercato delle pulci anni fa, ma in questo momento nessuno vuole risvegliare i morti col latrato di un’arma da fuoco. Il vento porta il brusio rivelatore dei morti che camminano, accompagnato dal suono di lamenti confusi e di passi strascicati, provenienti da alcuni cortili del vicinato immersi nelle tenebre. È stato un inizio di autunno insolitamente rigido in Georgia, e forse quella notte la colonnina di mercurio scenderà vicina allo zero, o addirittura anche sotto. Almeno questo è quanto la stazione radio locale ha affermato prima di trasformarsi in un fruscio di scariche di statica. A questo punto del loro viaggio, Philip e il suo gruppo controllano TV, radio e Internet sul BlackBerry di Brian. Nel mezzo del caos generale, i notiziari continuano ad assicurare alla popolazione che va tutto alla grande, che il fidato governo ha il controllo della situazione, che quel piccolo incidente sarà sistemato nello spazio di poche ore. Sulle frequenze della protezione civile, avvertimenti a cadenza regolare esortano la gente a rimanere chiusa in casa, a tenersi lontana dalle aree scarsamente popolate, a lavarsi le mani di frequente, a bere acqua imbottigliata e bla bla bla. Naturalmente nessuno ha risposte. E forse il segno più inquietante di tutti è il crescente numero di stazioni che scompaiono. Fortunatamente le pompe di benzina hanno ancora carburante, gli empori sono pieni di merce e la rete elettrica, quella dei semafori, le stazioni di polizia e tutte le diavolerie infrastrutturali della civilizzazione sembrano tenere duro. Ma Philip teme che una perdita di potenza farebbe crescere il livello di rischio oltre ogni immaginazione. “Buttiamoli nei cassonetti dietro il garage” dice piano, quasi sussurrando, trascinando due fardelli verso lo steccato di legno adiacente al garage con tre posti auto. Vuole fare le cose in fretta e in silenzio. Non vuole attirare zombie. Niente fuochi, niente rumori forti, niente colpi di pistola, se può farne a meno. Dietro lo steccato di cedro alto più di due metri c’è un vialetto coperto di ghiaia, che serve la fila di spaziosi garage allineati sul retro delle case. Nick trascina il suo carico oltre il cancello dello steccato, una solida lastra di tavole di cedro con un chiavistello di ferro battuto. Lascia cadere il fagotto e apre il cancello. Dall’altra parte, un cadavere in piedi lo sta aspettando. “STATE ATTENTI!” grida Bobby Marsh. “Sta’ zitto, cazzo!” sibila Philip, afferrando il piccone che porta alla cintura, già a metà strada verso il cancello. Nick indietreggia. Lo zombie barcolla verso di lui, cerca di morderlo e manca il pettorale sinistro di pochi millimetri: il rumore dei denti gialli che scattano a vuoto è come un ticchettio di nacchere e, alla luce della luna, Nick vede che si tratta di un uomo anziano con indosso un maglione della Izod fatto a brandelli, pantaloni costosi e scarpe da golf; la luce lunare si riflette sui suoi occhi bianchi e velati dalle cataratte: il nonno di qualcuno. Nick riesce a dargli una buona occhiata prima di inciampare all’indietro nei suoi stessi piedi e cadere a sedere sul rigoglioso tappeto di erba fienarola del Kentucky. Il golfista morto si muove goffo attraverso il varco e sul prato come un lampo d’acciaio arrugginito nell’aria. La punta del piccone di Philip gli colpisce in pieno la testa, spaccandogli il cranio come una noce di cocco, trapassando la fibrosa membrana della dura madre e penetrando nel gelatinoso lobo parietale. Produce un rumore simile allo spezzarsi di un gambo di sedano e spruzza un grumo di fluido scuro e salmastro nell’aria. La vivacità da insetto sulla faccia del nonno scompare all’istante, come un cartone animato il cui sistema di proiezione si sia inceppato. Lo zombie si accascia al suolo sgonfiandosi con l’ineleganza di un sacco da biancheria vuoto. Il piccone, ancora saldamente conficcato, tira Philip verso il basso. Lui lo strattona ma la punta è bloccata. “Chiudi subito quel fottuto cancello, chiudi il cancello e fallo in silenzio, dannazione” dice Philip, ancora nel suo tono di voce da suggeritore teatrale, mentre colpisce il cranio sfondato del cadavere col piede sinistro calzato nello stivale Chippewa dalla punta d’acciaio. Gli altri due uomini si muovono come in una specie di danza sincronizzata: Bobby lascia cadere il suo carico e corre verso il cancello, mentre Nick si rialza a fatica e indietreggia in preda a uno stupore terrorizzato. Bobby fa scorrere rapido il chiavistello di ferro battuto che emette uno stridore metallico così forte da echeggiare nei prati circostanti avvolti nelle tenebre. Alla fine, Philip estrae il piccone dalla tenace crepa nel cranio dello zombie con un suono umido e soffocato e si volta verso i resti della famiglia con la mente immersa nel panico: allora sente qualcosa di strano e di inaspettato provenire dalla casa. Alza lo sguardo e sul retro della casa coloniale vede la finestra illuminata dall’interno. Brian si staglia contro la porta scorrevole e picchietta sul vetro, facendo cenno a Philip e agli altri di tornare indietro, subito. La sua espressione brucia di urgenza. Non ha niente a che fare col golfista morto, Philip lo capisce, c’è qualcosa che non va. Oh, Dio, fa’ che non sia qualcosa che riguarda Penny. Philip lascia cadere il piccone e percorre il prato in pochi istanti. “Che ne facciamo dei cadaveri?” gli chiede Bobby Marsh. “Lasciateli lì!” urla Philip, salendo con un balzo i gradini del portico e correndo verso le porte scorrevoli. Brian lo aspetta sulla porta socchiusa. “Devo farti vedere una cosa, fratello” dice. “Cosa c’è? Si tratta di Penny? Sta bene?” Philip rientra in casa senza più fiato. Anche Bobby e Nick attraversano il portico e rientrano nel tepore della casa coloniale. “Penny sta bene” dice Brian. Tiene in una mano una foto incorniciata. “Sta bene. Dice che non le importa di rimanere ancora un po’ nell’armadio.” “Sangue di Giuda, Brian, ma che cazzo?!” Philip trattiene il fiato, le mani serrate in un pugno. “Devo farti vedere una cosa. Vuoi restare qui stanotte?” Brian si gira verso la porta a vetri scorrevole. “Guarda. La famiglia è morta qui tutta insieme, giusto? Tutti e sei? Sei?” Philip si asciuga la faccia. “Sputa il rospo, fratello.” “Guarda. In qualche modo si sono trasformati insieme. Come una famiglia, giusto?” Brian tossisce, poi indica i sei fagotti pallidi stesi vicino al garage. “Ce ne sono sei là fuori sull’erba. Guarda. Mamma, papà e quattro bambini.” “E allora, cazzo?” Brian ha in mano un ritratto incorniciato, la famiglia in un momento felice, tutti che sorridono imbarazzati, vestiti coi loro vestiti della domenica. “L’ho trovata sopra il pianoforte” dice. “E…?” Brian indica il bambino più piccolo nella foto, un ragazzo di undici o dodici anni, con un piccolo completo blu in stile marina militare, una frangetta bionda e un sorriso tirato. Brian guarda suo fratello e in tono solenne dice: “Nella foto sono in sette”. DUE La graziosa casa coloniale a due piani che Philip ha scelto per la loro sosta si trova su una strada ben curata in fondo a un dedalo di alberi di un residence protetto da una recinzione e conosciuto come Wiltshire Estates. Situato fuori dalla superstrada 278, a circa venti miglia a est di Atlanta, il quartiere grande duemilacinquecento ettari è stato ricavato in una foresta di pini dai lunghi aghi e di enormi, vecchie querce. Il confine meridionale si trova di fronte alle vaste e sinuose colline di un campo da golf da trentasei buche progettato da Fuzzy Zoeller. La prosa infiorettata della brochure gratuita, che Brian Blake ha trovato quella sera stessa sul pavimento di una guardiola abbandonata, descrive quel posto come il sogno bagnato di Martha Stewart: Wiltshire Estates ti regala uno stile di vita aristocratico con tutti gli agi della prima classe… GOLF Magazine Living lo ha definito il “Meglio del Meglio”… al suo interno c’è anche il Shady Oaks Plantation Resort & Spa, il classico complesso tripla A, cinque diamanti e cose del genere… vi operano pattuglie di vigilanza in servizio continuato… soluzioni abitative da 475,000 dollari fino a oltre un milione. A bordo della Chevy Suburban arrugginita di Philip, il gruppo dei Blake era capitato davanti alla recinzione esterna al tramonto di quello stesso giorno, mentre era sulla strada per il centro profughi di Atlanta. Alla luce dei fari, avevano visto l’elaborata recinzione di ferro battuto e il grande arco con la targa di metallo su cui era stato inciso il nome del Wiltshire e si erano fermati per investigare. Sulle prime, Philip aveva pensato che il posto potesse servire per una sosta breve, un luogo dove riposare e magari cercare un po’ di provviste prima di completare l’ultima parte del viaggio verso la città. Forse avrebbero trovato altri come loro, altri esseri viventi, magari qualche buon samaritano che li avrebbe aiutati. Ma quando i cinque viaggiatori stanchi, affamati, tesi e sconvolti avevano compiuto una prima ricognizione delle stradine sinuose del Wiltshire, con il buio che calava rapidamente, avevano compreso che il posto era, per lo più, morto. Non c’erano luci accese alle finestre e solo pochissime macchine erano rimaste nei vialetti o accanto ai marciapiedi. Un idrante antincendio zampillava trascurato in un angolo, spruzzando un getto d’acqua schiumosa su un prato. In un altro angolo, stava abbandonata una BMW col muso avvolto attorno a un palo del telefono e lo sportello del passeggero ritorto e spalancato. A quanto pareva, la gente se n’era andata di corsa. E la ragione per cui se n’era andata, per la maggior parte, era visibile in lontananza, nell’ombra del campo da golf, nei canali dietro il resort e anche qua e là nelle strade ben illuminate. Gli zombie gironzolavano barcollando senza meta come spettrali residui delle loro vecchie personalità; le bocche, spalancate come in un infinito sbadiglio, emettevano un lamento rugginoso che Philip riusciva a sentire fin troppo bene, anche attraverso i finestrini sigillati della Suburban, mentre percorreva il labirinto di strade larghe e asfaltate da poco. La pandemia o l’atto divino o qualsiasi cosa avesse dato inizio a tutta quella maledetta faccenda doveva aver colpito Wiltshire Estates duramente e in fretta. Il grosso dei non morti sembrava trovarsi sui terrapieni e sui sentieri del campo da golf. Laggiù doveva essere successo qualcosa che aveva accelerato il processo. Forse i giocatori erano per lo più vecchi e lenti. Forse i non morti gradivano di più il loro sapore. Chi diavolo poteva saperlo? Ma anche da centinaia di metri di distanza, tra gli alberi e al di sopra degli steccati delle abitazioni, si intravedevano decine, forse centinaia, di non morti radunati nel vasto complesso di club house, fairway, passerelle e bunker di sabbia. Nel buio della notte sembravano insetti che si muovevano pigri dentro un alveare. Era stata una visione sconcertante ma, in qualche modo, il fenomeno aveva lasciato la comunità adiacente, col suo circuito interminabile di cul-de-sac e strade ricurve, relativamente abbandonata. E più Philip e i suoi passeggeri dagli occhi sbarrati giravano attorno al quartiere, più cominciavano a desiderare almeno un pezzo di quello stile di vita aristocratico, solo un assaggio, quel tanto che bastava per rifocillarsi e riposarsi. Forse avrebbero potuto passare la notte lì e partire presto l’indomani mattina. Avevano scelto la grande casa in stile coloniale in fondo a Green Briar Lane perché era abbastanza lontana dal campo da golf da non attirare l’attenzione dello sciame. Inoltre disponeva di un giardino molto grande che consentiva un’ottima visibilità, e di uno steccato alto e robusto. E sembrava vuota. Ma quando erano entrati cauti in retromarcia, avevano attraversato il prato, parcheggiato la Suburban accanto a una porta sul lato della casa, lasciando il veicolo aperto con la chiave nell’accensione, e si erano intrufolati passando da una finestra, uno alla volta, la casa aveva cominciato quasi subito a reagire alla loro presenza. I primi crepitii erano arrivati dal secondo piano ed era stato allora che Philip aveva mandato Nick alla Suburban per prendere l’assortimento di asce contenuto nel bagagliaio. “Ti dico che li abbiamo stanati tutti” sta dicendo Philip per calmare suo fratello, che è seduto in cucina, nell’angolo per la colazione. Brian non dice niente, si limita a fissare la tazza colma di cereali. Vicino a sé ha una bottiglia di sciroppo per la tosse, di cui ha già ingoiato un buon quarto. Penny è seduta accanto a lui, anche lei con una tazza di cereali. Un piccolo pinguino di pezza delle dimensioni di una pera è posato accanto alla tazza della bambina e, di tanto in tanto, lei muove il cucchiaino verso la bocca del pupazzo, fingendo di condividere con lui i suoi cereali. “Abbiamo perlustrato ogni centimetro di questo posto” prosegue Philip mentre spalanca ogni pensile. La cucina è una cornucopia, piena fino all’orlo di cibo di prima qualità e oggetti di lusso: caffè da intenditori, frullatori a immersione, calici di cristallo, cestelli per il vino, pasta fatta a mano, deliziose confetture e gelatine, condimenti di ogni sorta, liquori costosi e attrezzi da cucina di ogni genere. Il gigantesco forno Viking Range è immacolato e l’imponente frigorifero Sub-Zero è stracolmo di carne di prima scelta, frutta, salse, latte, formaggi e piccoli contenitori di porcellana bianca con avanzi ancora freschi. “Forse è andato a trovare qualche parente o cose del genere” aggiunge Philip, prendendo nota di un ottimo Scotch di malto posato su un ripiano. “Magari è dai nonni, oppure a dormire a casa di un amico, che ne so.” “Gesù santo, guardate qua!” esclama Bobby Marsh dall’altra parte della stanza. È in piedi davanti alla dispensa e ispeziona bramoso le provviste al suo interno. “Sembra quasi quel cazzo di Willy Wonka e La Fabbrica di Cioccolato… focacce, biscotti e il pane è ancora fresco.” “Il posto è sicuro, Brian” dice Philip, posando la bottiglia di Scotch. “Sicuro?” Brian Blake fissa la superficie del tavolo. Tossisce e rabbrividisce. “È quello che ho detto. A dire il vero, credo che…” “Ne abbiamo appena persa un’altra!” dice una voce dall’altro lato della cucina. È Nick. Negli ultimi dieci minuti, si è dedicato a uno zapping nervoso tra i canali TV di un piccolo schermo al plasma montato sotto un mobiletto a sinistra del lavello, in cerca di aggiornamenti; ma adesso, a un quarto dalla mezzanotte, ora degli Stati Uniti Centrali, Fox 5 News che trasmette da Atlanta è appena diventata una serie di scariche statiche. Tutto ciò che il decoder riesce a captare, a parte i network nazionali che trasmettono repliche di documentari e vecchi film, è l’incrollabile CNN di Atlanta. E tutto ciò che loro stanno trasmettendo al momento sono gli annunci di emergenza automatici, le stesse schermate di avvertimento con gli stessi elenchi puntati che vanno in onda ormai da giorni. Anche il BlackBerry di Brian sta per tirare le cuoia, il segnale è sempre più evanescente. Quando funziona, l’apparecchio si riempie di e-mail vuote, tag di Facebook e tweet anonimi con messaggi criptici: …E IL REGNO CADRÀ NELL’OSCURITÀ… …SONO GLI UCCELLI CHE CADONO DAL CIELO, È DA LORO CHE TUTTO HA AVUTO INIZIO… …BRUCIATELI TUTTI BRUCIATELI TUTTI… …BESTEMMIE CONTRO DIO… …ASSAGGIA E MUORI… …LA CASA DEL SIGNORE È DIVENTATA LA DIMORA DEI DEMONI… …NON INCOLPATE ME PER QUESTO, IO SONO UN LIBERALE… …MANGIAMI… “Spegnila, Nick” dice triste Philip con la bottiglia in mano, gettandosi su una sedia che si trova nell’angolo dedicato alla colazione. Aggrotta la fronte e allunga la mano sul retro della cintura, dove la pistola gli si è conficcata nella schiena. Appoggia la Ruger sul tavolo e col pollice fa saltare il tappo dello Scotch, poi beve un sorso copioso. Brian e Penny fissano entrambi la pistola. Philip rimette il tappo alla bottiglia e la lancia attraverso la cucina in direzione di Nick, che la afferra con l’aplomb di un ottimo seconda base (come, in effetti, è stato un tempo). “Sintonizzala su un canale di televendite… hai bisogno di dormire un po’, smetti di guardare quello schermo.” Nick beve una sorsata e poi un’altra ancora; quindi richiude la bottiglia e la lancia a Bobby. Bobby quasi la manca. Ancora in piedi davanti alla dispensa, è occupato a divorare un’intera scatola di Oreo: agli angoli della bocca gli si è già formata una crosta di briciole. Manda giù i biscotti con un grosso sorso di whisky e rutta fragorosamente. Philip e i suoi due amici sono abituati a bere insieme e stanotte hanno bisogno di farlo più che mai. Avevano cominciato durante il loro primo anno alla Burke County, con crema di menta e vino di succo di cocomero nelle tende da campeggio piazzate nei cortili delle loro case. In seguito si erano diplomati bevitori professionisti dopo le partite di football. Nessuno regge l’alcool come Philip Blake, ma gli altri due sono ottimi rivali nelle gare di bevute. Ben presto, durante la sua vita da uomo sposato, Philip aveva cominciato a sbronzarsi regolarmente coi suoi compagni di liceo, più che altro per ricordare a se stesso com’era essere giovane, single e irresponsabile. Ma dopo la morte di Sarah, i tre si erano allontanati. Lo stress di ritrovarsi genitore single e di lavorare di giorno all’officina di marmitte e di notte alla guida di un camion, con Penny che dormiva nella cabina, lo aveva consumato. Le serate coi ragazzi erano diventate sempre meno frequenti. Di tanto in tanto, però, Philip trovava ancora il tempo per vedersi con Bobby e Nick giù al Tally Ho o al Wagon Wheel Inn, o in qualche altro locale di Waynesboro, per una serata di innocente dissolutezza (mentre mamma Rose badava a Penny). In anni più recenti, Philip aveva cominciato a chiedersi se continuava a frequentare Bobby e Nick meccanicamente, solo per ricordare a se stesso di essere vivo. Forse era per questo che la domenica precedente, quando quella merda aveva colpito il ventilatore a Waynesboro e lui aveva deciso di prendere Penny e tagliare la corda verso un posto più sicuro, aveva arruolato anche Nick e Bobby. Gli sembravano un pezzo del suo passato e in qualche modo quella cosa lo aveva aiutato. Ma non aveva mai avuto intenzione di portare con sé Brian. Imbattersi in lui era stato un incidente. Quel primo giorno sulla strada, poco meno di settanta chilometri a ovest di Waynesboro, Philip aveva compiuto una rapida deviazione verso Deering, per controllare sua madre e suo padre. L’anziana coppia viveva in una comunità per pensionati vicino alla base militare di Fort Gordon. Quando Philip era arrivato nella cittadina dove vivevano i suoi vecchi, aveva scoperto che l’intera popolazione di Deering era stata spostata nella base per motivi di sicurezza. Quella era la buona notizia. La cattiva era che c’era anche Brian. Se ne stava rintanato nella casa abbandonata, rannicchiato nel ristretto spazio del seminterrato, pietrificato dal crescente numero di morti viventi che si aggiravano in quella zona isolata. Philip aveva quasi dimenticato l’attuale condizione di suo fratello: Brian era tornato a vivere a casa dei suoi dopo che il matrimonio con quella pazza giamaicana di Gainesville aveva preso, letteralmente, il volo. La ragazza aveva tagliato la corda e se n’era tornata in Giamaica. Per questo, oltre al fatto che tutti gli strampalati piani di Brian per fare soldi erano andati all’aria uno dopo l’altro, la maggior parte dei quali finanziati dai loro genitori (come la sua ultima, geniale idea di aprire un negozio di musica ad Athens, dove ce n’era uno a ogni angolo), Philip rabbrividiva all’idea di doversi prendere cura di suo fratello troppo a lungo. Ma ormai era tardi e quel che era fatto era fatto. “Ehi, Philly” dice Bobby dall’altro lato della stanza, spazzando via gli ultimi biscotti, “pensi che quei centri profughi in città siano ancora operativi?” “Chi diavolo può saperlo?” Philip guarda sua figlia. “Come va, pulcino?” La bambina alza le spalle. “Bene.” La sua voce si sente a malapena, come un campanellino rotto scosso dal vento. Guarda il pinguino di stoffa. “Credo.” “Che ne pensi di questa casa? Ti piace?” Penny fa ancora spallucce. “Non lo so.” “Che ne diresti se ci fermassimo qui per un po’?” Quelle parole richiamano l’attenzione di tutti. Brian alza lo sguardo verso suo fratello. Adesso tutti gli occhi sono puntati su Philip. Alla fine Nick chiede: “Cosa intendi con ‘per un po’’?”. “Dammi quella schifezza” ordina Philip, indicando la bottiglia a Bobby, che gliela passa; Philip beve un lungo sorso, lasciandolo bruciare dolcemente. “Guardate questo posto” dice, dopo essersi asciugato la bocca. Brian è confuso. “Avevi detto che era solo per stanotte, giusto?” Philip prende un respiro profondo. “Sì, ma mi è appena venuta un’idea.” Bobby comincia a dire: “Sì, ma…”. “Senti. È solo un’idea, ma forse faremmo meglio a starcene al riparo per un po’.” “Sì, Philly, ma riguardo al…” “Potremmo starcene qui al riparo, Bobby, vedere cosa succede.” Nick ascolta lo scambio con grande attenzione. “Philip, dai, amico, al notiziario dicono che le grandi città sono più sicure…” “Il notiziario? Gesù Cristo, Nick, sciacquati la merda dal cervello. Il notiziario è andato giù per il cesso insieme al resto della popolazione. Guarda questo posto. Credi che le baracche del governo avranno queste provviste, letti per tutti, cibo a sufficienza per settimane, Scotch invecchiato vent’anni? Docce, acqua calda, lavatrice?” “Ma siamo così vicini” dice Bobby, dopo averci pensato per un attimo. Philip sospira. “Già, beh… vicini è un concetto relativo.” “Sono una trentina di chilometri, al massimo.” “Potrebbero anche essere trentamila chilometri, con tutti quei tamponamenti sull’autostrada: la 278 brulica di quelle cose.” “Questo non ci fermerà” dice Bobby. I suoi occhi brillano. Schiocca le dita. “Costruiremo un… come si chiama… sul davanti della Chevy… una specie di pala… come nel fottuto Mad Max…” “Attento alle parolacce, Bobby” lo interrompe Philip, indicando la bambina con un cenno. Nick prende la parola. “Amico, se restiamo qui, è solo questione di tempo prima che quelle cose là fuori…” Si ferma, guardando la bambina. Tutti sanno cosa intende. Penny studia i cereali inzuppati come se non ascoltasse. “Questi posti sono solidi, Nicky” ribatte Philip, posando la bottiglia e incrociando le braccia muscolose sul petto. Philip ha riflettuto parecchio sul problema delle cose che vagano nel campo da golf. Il segreto sta tutto nel mantenere il silenzio, coprire le luci di notte, non emettere rumori e odori, non fare chiasso. “Finché abbiamo energia elettrica e manteniamo la calma, siamo a cavallo.” “Con una pistola?” dice Nick. “Voglio dire, non possiamo nemmeno usarla senza attirarli.” “Controlleremo le altre case, cercheremo delle armi. Questi ricchi bastardi vanno pazzi per la caccia ai cervi, magari troviamo anche un silenziatore per la Ruger… diavolo, possiamo costruirne uno. Hai visto quel laboratorio di sotto?” “Dai, Philip. Cos’è, adesso siamo armaioli? Voglio dire… tutto ciò che abbiamo per difenderci al momento sono alcuni…” “Philip ha ragione.” La voce di Brian sorprende tutti per come arriva, con un tono rauco e ansimante, ma sicuro. Scansa i cereali e alza lo sguardo verso suo fratello. “Hai ragione.” Philip è forse quello più sorpreso dalla fermezza della voce nasale di Brian. Brian si alza, gira attorno al tavolo e rimane in piedi davanti alla porta che conduce al soggiorno spazioso e arredato con gusto, dove le luci sono spente e tutte le tende sono tirate. Indica il muro anteriore della casa. “Fondamentalmente, il problema è la facciata. I lati e il retro sono protetti abbastanza bene dallo steccato. I morti non sembrano in grado di, come dire, penetrare le barriere e cose del genere… e tutte le case di questo isolato hanno un cortile recintato.” Per un momento, sembra sul punto di tossire ma si trattiene e si mette la mano sulla bocca. La mano trema. Prosegue. “Se riusciamo a, come dire, prendere in prestito un po’ di materiale dagli altri cortili, dalle altre case, forse possiamo costruire un muro di sicurezza davanti alla facciata, forse anche davanti alle case vicine.” Bobby e Nick si guardano, nessuno reagisce, ma alla fine Philip con un lieve sorriso dice: “Dategli ascolto: lui è stato al college”. È passato molto tempo da quando i fratelli Blake si sono scambiati un sorriso, ma adesso Philip vede che il suo fratello buono a nulla vuole essere d’aiuto, vuole fare qualcosa per la causa, vuole essere un uomo. E Brian sembra aver guadagnato un po’ di fiducia dall’approvazione di Philip. Nick non è convinto. “Per quanto tempo? Qui dentro mi sento come un pesce in un barile.” “Non sappiamo cosa accadrà” dice Brian, la voce roca eppure in un certo modo frenetica. “Non sappiamo cos’è che ha causato questa cosa, quanto durerà… potrebbero, che so, capire come risolverla, trovare un antidoto o qualcosa del genere… potrebbero gettare delle sostanze chimiche dagli irrigatori, il Centro Controllo Malattie potrebbe arginare la cosa… non si sa mai. Io credo che Philip abbia ragione in pieno. Dovremmo fermarci e prendercela comoda per un po’.” “Dannatamente giusto” dice con un sorriso Philip Blake che, ancora seduto con le robuste braccia incrociate, strizza l’occhio al fratello. Brian ricambia l’occhiolino con un lieve cenno di soddisfazione, togliendosi un ciuffo di capelli sporchi e unti dagli occhi. Respira per un attimo col fiato corto e debole, poi si dirige trionfale verso la bottiglia di Scotch, che è sul tavolo accanto a Philip. La afferra con un vigore che non mostra da anni, la porta alle labbra e beve una gigantesca sorsata, con la spavalderia vittoriosa di un vichingo che festeggia una fruttuosa razzia. Ma sobbalza all’istante, piegato in due, e comincia a emettere una scarica di colpi di tosse. Spruzza per tutta la cucina metà del liquore che ha in bocca e continua a tossire e tossire e tossire e ad ansimare furiosamente: gli altri si limitano a guardarlo. La piccola Penny è sbalordita, lo guarda coi suoi occhioni stupiti e si strofina le goccioline di liquore dalla guancia. Philip guarda prima la sua patetica imitazione di fratello e poi i suoi amici. Bobby Marsh tenta di soffocare una risata e Nick reprime la sua torcendo la bocca. Philip cerca di dire qualcosa ma non può fare a meno di mettersi a ridere. Gli altri lo imitano. Ben presto, scoppiano tutti in una risata isterica, anche Brian, e per la prima volta da quando quell’incubo ha sconvolto le loro vite, è una risata genuina: la liberazione di qualcosa di oscuro e fragile che si annida in tutti loro. Quella notte, provano a dormire a turno. Si sono scelti una camera per uno al secondo piano; i resti dei precedenti abitanti sembrano inquietanti manufatti esposti in un museo: un mezzo bicchiere d’acqua posato sul comodino, un romanzo di John Grisham aperto a una pagina che nessuno leggerà mai più, un paio di pon pon appesi al letto a baldacchino di una ragazzina. Per gran parte della notte, Philip fa la guardia di sotto, in salotto, con la pistola posata accanto a lui su un tavolino da caffè e Penny accoccolata sotto le coperte su un divano ad angolo di fianco alla sua poltrona. La bambina tenta invano di prendere sonno e verso le tre del mattino Philip, assorto nel pensiero angoscioso dell’incidente di Sarah, si accorge, con la coda dell’occhio, che Penny continua a rigirarsi senza posa. Si china su di lei, le accarezza i capelli scuri e sussurra: “Non riesci a dormire?”. La bambina ha le coperte tirate fino al mento e lo guarda. Scuote la testa. Il suo viso cinereo è quasi angelico nella luce arancione della stufetta elettrica, che Philip ha sistemato accanto al divano. All’esterno, nel vento che si ode a malapena sopra il ronzio della stufa, il coro dissonante di lamenti è incessante, come un flusso di onde infernali che lambiscono una spiaggia. “Papà è qui, pulcino, non aver paura” dice con dolcezza Philip, sfiorandole la guancia. “Sarò sempre qui.” Lei annuisce. Philip le rivolge un sorriso tenero, si china su di lei e la bacia sul sopracciglio sinistro. “Non lascerò che ti succeda niente.” Lei annuisce di nuovo. Ha sistemato il piccolo pinguino nell’incavo del collo, lo guarda e aggrotta le sopracciglia. Si porta l’animale di pezza all’orecchio e si comporta come se le sussurrasse un segreto. Alza lo sguardo verso suo padre. “Papà?” “Sì, pulcino?” “Pinguino vuole sapere una cosa.” “Cosa?” “Pinguino vuole sapere se la gente è ammalata.” Philip prende un respiro profondo. “Di’ pure a Pinguino… che sì, sono molto malati. Sono più che malati. È per questo che abbiamo… messo fine alle loro sofferenze.” “Papà?” “Sì?” “Pinguino vuole sapere se anche noi ci ammaleremo.” Philip le accarezza la guancia. “No, signorina. Puoi dirgli che rimarremo sani come pesci.” La bambina sembra ora abbastanza soddisfatta: distoglie lo sguardo e fissa il vuoto ancora per un po’. Alle quattro di quello stesso mattino, un’altra anima insonne, in un’altra parte della casa, si pone domande imponderabili. Disteso in un groviglio di coperte, con la sagoma magra vestita soltanto di T-shirt e mutande, e con la febbre che esplode in una pellicola di sudore, Brian Blake fissa l’intonaco stuccato del soffitto della camera di una ragazzina morta e si chiede se è così che il mondo finirà. È stato Rudyard Kipling a dire che sarebbe finito “non già con uno schianto ma con un lamento”. No, aspetta un minuto… era stato Eliot. T. S. Eliot . Brian ricorda di aver studiato quel poema… era Gli uomini vuoti… nel corso di letteratura comparata del ventesimo secolo all’Università della Georgia. Gli era servita a molto quella laurea. Se ne sta lì e rimugina sui suoi fallimenti, come fa tutte le notti, ma stanotte le sue elucubrazioni sono inframezzate dalle immagini di massacri, come fotogrammi di un film snuff inseriti nel suo flusso di coscienza. I vecchi demoni si risvegliano, mischiandosi alle nuove paure e scavando un solco nei suoi pensieri: avrebbe potuto dire o fare qualcosa per impedire alla sua ex moglie, Jocelyn, di andarsene, di rifiutarsi di rispondere alle sue domande, di dire tutte quelle cose orribili prima di tornarsene a Montego Bay? E i mostri vanno uccisi con un semplice colpo al cranio o bisogna distruggere il tessuto cerebrale? C’era qualcosa che avrebbe potuto fare o qualcuno da implorare, qualcuno per farsi prestare il necessario per tenere aperto il negozio di musica ad Athens, l’unico del suo genere al Sud, la brillante, fottuta idea di un negozio rivolto agli artisti hip-hop con piatti rimessi a nuovo, amplificatori usati per i bassi e sfarzosi microfoni addobbati con bigiotteria alla Snoop Dogg? Quanto in fretta si moltiplicano le disgraziate vittime di fuori? Il contagio si diffonde per via aerea o si trasmette nell’acqua come l’Ebola? Il rimuginare della sua mente continua a riportarlo alle questioni più immediate: l’assillante sensazione che il settimo membro della famiglia che un tempo viveva lì sia ancora da qualche parte nella casa. Ora che Brian ha chiuso il discorso coi suoi compagni sul fatto che dovrebbero restare lì per un tempo indeterminato, non riesce a smettere di pensarci. Avverte ogni minimo crepitio, ogni debole rumore di assestamento, ogni ronzio soffocato della caldaia. Per una qualche ragione che non riesce a spiegare, è assolutamente sicuro che il ragazzino biondo sia ancora in casa, in attesa del momento opportuno per… cosa? Forse il bambino è l’unico della famiglia che non si è trasformato. Magari è terrorizzato e si sta nascondendo. Prima di mettersi giù a dormire, Brian ha insistito che controllassero un’ultima volta ogni angolo della casa. Philip lo ha accompagnato con un piccone e una torcia elettrica e insieme hanno controllato ogni anfratto del seminterrato, ogni mobiletto, ogni armadio e armadietto. Hanno guardato nel congelatore in cantina e persino dentro la lavatrice e l’asciugatrice in cerca di improbabili clandestini. Nick e Bobby hanno perlustrato il solaio, dietro le tubature, nelle scatole, nei guardaroba. Philip ha guardato sotto tutti i letti e dietro tutti i comò. Durante le ricerche non hanno trovato nulla, ma hanno fatto qualche scoperta interessante. Hanno trovato una ciotola per cibo per cani nello scantinato, ma nessun segno dell’animale. Hanno trovato anche un assortimento di utilissimi attrezzi nel laboratorio: seghe da traforo, trapani, fresatrici e anche una sparachiodi, particolarmente utile per costruire delle barricate in quanto molto più silenziosa di un martello che batte. Brian pensa anche ad altri usi per quella sparachiodi quando, d’un tratto, sente un rumore che in un istante paralizza il suo corpo seminudo e gli fa venire la pelle d’oca. Il rumore proviene da sopra di lui, dall’altra parte del soffitto. Viene dal solaio. TRE Dopo aver sentito il rumore e averlo identificato quasi inconsciamente come qualcosa di diverso dai normali rumori d’assestamento della casa, del vento negli abbaini o della caldaia, Brian si siede sul bordo del letto. Solleva la testa e ascolta con maggior attenzione. Sembra qualcuno che gratta qualcosa o il debole suono del tessuto che si strappa. Sulle prime, Brian sente il bisogno di andare a chiamare suo fratello. Philip sarebbe la scelta migliore per occuparsi della cosa. Potrebbe essere il ragazzo, santo cielo… o qualcosa di peggio. Poi però, quasi subito, Brian ci ripensa e si ferma. Ha intenzione di andare a nascondersi… come al solito? Vuole correre, come al solito, da suo fratello, suo fratello minore, Dio santo, lo stesso individuo a cui Brian teneva la mano quando attraversavano la strada per andare alla scuola elementare della Contea di Burke? No, dannazione. Non stavolta. Stavolta, Brian tirerà fuori le palle. Prende un respiro profondo, si gira e cerca la torcia elettrica che ha lasciato sul comodino. La trova e la accende. Il raggio sottile attraversa la stanza immersa nell’oscurità e crea una pozza di luce argentea sulla parete opposta… Solo tu e io, Justin, pensa Brian mentre si alza. La sua mente è lucida. I sensi crepitano. La verità è che si è sentito incredibilmente bene quella sera, quando ha convenuto coi piani di suo fratello, quando ha visto quello sguardo nei suoi occhi, come a dire che forse, dopotutto, lui non è un perdente e uno sfigato. È tempo di fargli vedere che quel momento in cucina non è stato un caso: Brian può occuparsi di quel lavoro tanto quanto Philip. Si muove in silenzio verso la porta. Prima di uscire, afferra la mazza da baseball di metallo che ha trovato nella camera di uno dei ragazzi. Nel corridoio i fruscii come di carta stropicciata sono più nitidi: Brian si ferma sotto l’ingresso del solaio, che è una botola pomposamente incassata nel soffitto del pianerottolo. Le altre camere da letto, da dove echeggia il profondo russare di Bobby Marsh e Nick Parsons, sono situate dall’altra parte, sul lato est della casa, fuori portata d’orecchio. Ecco perché Brian è stato il solo a sentirli. Una cinghia di cuoio pende dal soffitto, abbastanza in basso da consentirgli di saltare e afferrarla. Tira la chiusura a molla fino a spalancare la botola e la scala a fisarmonica si apre con un rumore metallico. Brian illumina il passaggio con la torcia. Granelli di polvere vagano nel raggio di luce. L’oscurità è impenetrabile, opaca. Il cuore di Brian fa un balzo. Fottuta femminuccia, dice a se stesso. Porta su il tuo culo da femminuccia. Sale le scale con la mazza da baseball sottobraccio e la torcia nella mano libera; quando raggiunge la cima della scala, si ferma. Punta la luce su un grosso baule da viaggio con attaccati sopra degli adesivi del Magnolia Springs State Park. Adesso sente gli odori gelidi e putridi della muffa e della naftalina. Il freddo autunnale si è già infiltrato nel solaio attraverso le scanalature del tetto. Avverte l’aria gelida sul volto. E dopo un istante, sente ancora il fruscio. Viene da un punto ancora più addentro nelle ombre del solaio. Brian varca la soglia e la sua gola è secca come farina di ossa. Il soffitto basso lo costringe a piegarsi. Vestito soltanto della sua biancheria, Brian rabbrividisce, vorrebbe tossire ma non osa. I grattamenti cessano per ricominciare subito forti e furiosi. Brian solleva la mazza e resta del tutto immobile, imparando da capo la meccanica della paura: quando si è davvero spaventati, non si trema come nei film. Si resta immobili, come un animale dal pelo ritto. Solo dopo si comincia a tremare. Il raggio della torcia controlla lento tutte le nicchie buie del solaio, tra il ciarpame dei ricchi: una cyclette coperta di ragnatele, un vogatore, bauli, bilancieri, tricicli, scatole da guardaroba, sci d’acqua, un flipper impolverato. I grattamenti cessano di nuovo. La luce rivela una bara. Brian diventa praticamente di pietra. Una bara? Philip è già a metà della scalinata quando nota, sul pianerottolo del secondo piano, che la scala del solaio pende giù, dischiusa. Sale sul pianerottolo in silenzio, coi piedi avvolti nei calzini. Tiene un’ascia in una mano e una torcia elettrica nell’altra. La pistola calibro .22 è infilata nel retro dei jeans. È senza maglietta e la muscolatura robusta brilla alla luce della luna che filtra da un lucernario. Gli ci vogliono pochi secondi per attraversare il pianerottolo e salire i gradini a fisarmonica: quando emerge nell’oscurità del solaio, vede una sagoma stagliarsi nello spazio ristretto. Prima che possa accendere la torcia e puntarla su suo fratello, la situazione si fa chiara. “È un lettino abbronzante” dice, facendo sobbalzare Brian. Nei pochi attimi precedenti, Brian Blake è rimasto paralizzato dal terrore, restando a qualche metro di distanza dal contenitore oblungo e polveroso appoggiato contro una parete. Il lato superiore è chiuso quasi fosse una gigantesca conchiglia e qualcosa gratta per uscire. Brian si volta di scatto e col raggio della torcia illumina il volto tetro e affilato di suo fratello. Philip è in piedi sull’ingresso del solaio con l’ascia nella mano destra. “Spostati da lì, Brian.” “Pensi che sia…” “Il ragazzino mancante?” sussurra Philip, avvicinandosi cauto all’oggetto. “Scopriamolo.” Il grattare, come stimolato dal suono delle voci, aumenta di frequenza e volume. Brian si volta verso il lettino abbronzante, si prepara e solleva la mazza da baseball. “Forse si era nascosto qui prima di trasformarsi.” Philip si avvicina con l’ascia. “Togliti di mezzo, campione.” “Me ne occupo io” dice secco Brian, muovendosi verso la serratura, con la mazza da baseball pronta. Philip si mette gentilmente tra suo fratello e il lettino abbronzante. “Non devi dimostrarmi niente, fratello. Dai, togliti di mezzo.” “No, dannazione, ci penso io” sibila Brian, allungando la mano verso la serratura arrugginita. Philip lo studia. “Okay, fa’ come vuoi. Pensaci tu, ma fallo alla svelta. Di qualsiasi cosa si tratti, non pensarci troppo.” “Lo so” dice Brian, afferrando il gancio con la mano libera. Philip è a pochi centimetri di distanza. Brian apre la serratura. I rumori frenetici cessano. Brian spalanca il coperchio e Philip solleva l’ascia. Due rapidi movimenti, come un paio di lampi nell’oscurità, attraversano il campo visivo di Philip: sono il frusciare di un manto peloso e l’arco della mazza di Brian. I sensi affinati di Philip impiegano un secondo o due a registrare l’animale: un topo, che scatta lontano dal raggio della torcia e fugge a rotta di collo sulla vetroresina verso un buco in un angolo. La mazza da baseball si abbatte pesante, mancando di molto il grasso roditore grigio e unto. Pezzi del pannello d’accensione del lettino e vecchi giocattoli si frantumano nell’impatto. Brian emette un rantolo e indietreggia alla vista del topo che scompare dentro il buco, arretrando verso i meccanismi interni della base del lettino. Philip si lascia sfuggire un sospiro di sollievo e abbassa l’ascia. Comincia a dire qualcosa quando sente una lieve melodia metallica risuonare nell’ombra accanto a lui. Brian guarda in basso, ansimando. Una piccola scatola, di quelle contenenti un pupazzo a molla, è caduta a causa dell’impatto della mazza e giace sul pavimento. L’impatto ha azionato la musica metallica, che suona ancora qualche nota di una melodia da circo. Poi il clown giocattolo sbuca di lato dal contenitore caduto. “Bù” dice Philip con un tono di voce stanco e ben poco divertito. Il loro umore migliora leggermente il mattino seguente, dopo un’abbondante colazione a base di uova strapazzate, fette di bacon, semolino, prosciutto, focacce, pesche fresche e tè. Il fragrante profumo del caffè, della cannella e della carne affumicata che sfrigola riempie tutta la casa. Nick prepara anche la sua speciale salsa Redeye1, mandando in estasi Bobby. Brian trova qualche medicina contro il raffreddore nell’armadietto dei medicinali della camera padronale e comincia a sentirsi un po’ meglio dopo aver mandato giù alcune capsule di DayQuil. Dopo colazione, esplorano le immediate vicinanze, senza spingersi oltre l’isolato conosciuto come Green Briar Lane, e ottengono ancora buone notizie. Trovano un tesoro di provviste e materiali da costruzione: cataste di legna per i camini, tavole di legno avanzate, altro cibo nei frigoriferi dei vicini, taniche di benzina nei garage, vestiti e stivali invernali, scatole di chiodi, liquori, fiamme ossidriche, acqua imbottigliata, una radio a onde corte, un computer portatile, un generatore, pile di DVD e, in uno degli scantinati, una rastrelliera zeppa di fucili da caccia e scatole di proiettili. Nessun silenziatore, ma a caval donato non si guarda in bocca. Hanno fortuna anche con i non morti. Le case dirimpetto a quella coloniale sono vuote: a quanto pare, i residenti hanno tagliato la corda prima che la merda si infittisse. A due case di distanza, sul lato ovest, Philip e Nick incontrano un’anziana coppia che si è trasformata, ma qualche colpo d’accetta ben piazzato basta a far fuori i vecchi senza difficoltà, in modo rapido e soprattutto silenzioso. Quel pomeriggio, Philip e i compagni cominciano a lavorare con cautela alla barricata che dovrà attraversare il viale alberato davanti alla casa coloniale e alle due case vicine, per un totale di quarantacinque metri per i tre lotti e un’altra ventina dall’altra parte: Nick e Bobby lo trovano uno spazio terribilmente vasto da coprire, ma con le tavole prefabbricate lunghe tre metri, che hanno trovato sotto il portico di una casa del vicinato, unite agli steccati che hanno razziato dalle altre case della via, il lavoro procede sorprendentemente rapido. Quella sera, al tramonto, Philip e Nick inchiodano già le ultime sezioni sul confine settentrionale della proprietà. “Li ho tenuti d’occhio tutto il giorno” dice Philip, mentre preme la punta biforcuta della sparachiodi contro il supporto di una sezione angolare. Si riferisce agli sciami vicini al golf club. Nick annuisce, intento a far combaciare gli incastri delle due sezioni. Philip preme il grilletto e la sparachiodi emette uno schiocco soffocato, come lo schianto di una frusta di metallo, conficcando un chiodo galvanizzato da quindici centimetri dritto tra le tavole. Per coprire il rumore la sparachiodi è stata avvolta con del nastro isolante in un piccolo pezzo di coperta. “Non ne ho visto nemmeno uno gironzolare da queste parti” dice Philip, asciugandosi il sudore dalla fronte e spostandosi verso l’altro supporto della sezione. Nick tiene ferme le tavole, sulle quali si abbassa la punta. FFFFFUMP! “Non saprei” dice Nick scettico, passando alla sezione successiva, col sudore che gli attacca il giubbetto alla schiena. “Continuo a pensare che non è questione di se… ma di quando.” FFFFFFFUMP! “Ti preoccupi troppo, figliolo” dice Philip, passando al gruppo di tavole successivo e tirando la prolunga della sparachiodi. L’estensione del cavo si allunga serpeggiando fino a una presa nell’angolo di una casa vicina. Philip ha dovuto collegare in tutto sei prolunghe da otto metri per far arrivare la corrente. Si ferma e si guarda dietro la spalla. A circa quindici metri di distanza, nel cortile posteriore della casa coloniale, Brian spinge Penny su un’altalena. Gli ci è voluto un po’ per abituarsi, per affidare al suo inetto fratello la cura della sua preziosa bambina, ma ora come ora Brian è la miglior baby-sitter a sua disposizione. Il campo da gioco, ovviamente, è lussuoso. La gente ricca adora rovinare i figli con merdate del genere. Quello, molto probabilmente, era uno dei posti preferiti del bambino scomparso; ha tutte le carte in regola per esserlo stato: scivolo, capanna, quattro altalene, una parete per arrampicarsi, una palestra e una sabbiera. “Fin qui ce l’abbiamo fatta” continua Philip, rimettendosi al lavoro. “Finché teniamo la testa a posto, non dovremmo avere problemi.” Mentre posizionano la tavola successiva, il fruscio dei loro stessi movimenti e il crepitio delle tavole coprono il rumore di passi strascicati. I passi provengono dall’altra parte della strada. Philip non li sente finché lo zombie errante non è abbastanza vicino da far sentire il suo odore. Nick è il primo a sentirlo: quella combinazione scura, densa e ammuffita di proteine che marciscono e di decomposizione, come escrementi umani cotti in grasso di maiale. Nick scatta in guardia. “Aspetta un attimo” dice, reggendo una tavola. “Puzzi…” “Sì, puzzi come…” Un braccio viscido irrompe attraverso un buco dello steccato e afferra un lembo della camicia di jeans di Philip. Una volta era una donna di mezza età in tuta da jogging; adesso è un’arpia emaciata con le maniche strappate, piena di lividi scuri, i denti scoperti e gli occhi fissi di un pesce preistorico. La sua mano ha uncinato la camicia di Philip con la forte morsa delle sue dita morte. Emette un lamento simile a quello della canna di un organo rotta mentre Philip si gira verso la sua ascia, appoggiata contro una carriola a qualche metro di distanza. Dannatamente troppo lontana. La signora morta cerca il collo di Philip con la fame automatica di una tartaruga alligatore; dall’altra parte, Nick annaspa in cerca di un’arma, ma succede tutto troppo in fretta. Philip indietreggia con un grugnito ma, alla fine, si ricorda che sta ancora stringendo la sparachiodi. Evita i denti che cercano di morderlo e istintivamente solleva la punta della sparachiodi. Con un movimento rapido, la appoggia sulla fronte della cosa. FFFFFFFFFFFUMP! La signora zombie si irrigidisce. Le dita gelide allentano la presa e Philip si libera, inspirando a fatica e osservando la cosa. Per un istante, il cadavere verticale barcolla, dondolando come se fosse ubriaco; trema nella sua tuta di cotone di Pierre Cardin, ma non vuole andare giù. La testa del chiodo galvanizzato, lungo ben quindici centimetri, è visibile sopra la cresta del naso, come una monetina attaccata alla fronte. La cosa rimane in piedi per alcuni interminabili istanti, con gli occhi da squalo rivoltati all’insù, finché non comincia a vacillare lenta, con la faccia rovinata che assume un’espressione strana, quasi sognante. Per un momento, sembra che stia ricordando qualcosa o che resti in ascolto di un qualche fischio acutissimo. Poi crolla sull’erba. “Credo che i chiodi possano abbatterli” dice Philip dopo cena, camminando avanti e indietro davanti alle finestre sbarrate del lussuoso soggiorno, la sparachiodi in mano come un promemoria. Gli altri stanno seduti intorno al lungo tavolo di quercia lucido con gli avanzi della cena disseminati davanti a loro. Brian ha cucinato per tutti, scongelando un arrosto nel forno a microonde e preparando una salsa con un cabernet di un’ottima annata e una spruzzata di crema. Penny è di là nel soggiorno a guardare un DVD di Dora l’esploratrice. “Sì, ma hai visto quanto ci ha messo a venire giù?” precisa Nick, spingendo un pezzo della carne che non ha finito sul piatto. “Dopo che gli hai sparato… per un secondo sembrava quasi che quella dannata cosa fosse drogata.” Philip continua a camminare pensoso, premendo il grilletto della sparachiodi. “Già, ma alla fine è andata giù.” “È più silenziosa di una pistola, te lo concedo.” “Ed è maledettamente più facile che spaccargli la testa con un’ascia.” Bobby ha appena cominciato a servirsi un secondo piatto di arrosto e di salsa. “Peccato che tu non abbia una prolunga di dieci chilometri” dice a bocca piena. Philip preme ancora il grilletto. “Magari possiamo attaccare questo affare a una batteria.” Nick alza lo sguardo. “Come la batteria di una macchina?” “No: qualcosa che potremmo portarci dietro più facilmente, come una di quelle grosse batterie per le lampade o come una falciatrice elettrica.” Nick scrolla le spalle. Bobby mangia. Philip cammina e riflette. Brian fissa il muro, rimuginando: “Dev’essere qualcosa che ha a che fare col cervello”. “Cosa?” Philip guarda suo fratello. “Di cosa stai parlando, Bri?” Brian lo guarda. “Quelle cose… i malati. Sostanzialmente si tratta del cervello, giusto? Dev’essere così.” Fa una pausa e guarda il suo piatto. “Sono ancora dell’idea che non sappiamo nemmeno se sono morti.” Nick lo guarda. “Vuoi dire dopo che li facciamo fuori? Dopo che… li distruggiamo?” “No, voglio dire prima” risponde Brian. “Intendo… sto parlando della condizione in cui sono.” Philip smette di camminare. “Cazzo, fratello… lunedì ne ho visto uno venire schiacciato dalla motrice di un tir e dopo dieci minuti trascinarsi lungo la strada con le budella di fuori. L’hanno detto su tutti i notiziari. Sono morti, campione. Sono decisamente morti.” “Sto solo dicendo che il sistema nervoso centrale dell’uomo è complicato, fratello. Tutta questa merda adesso è nell’ambiente, nuovi tipi di merda.” “Ehi, se vuoi portare una di quelle cose da un dottore per fargli fare un checkup, accomodati.” Brian sospira. “Voglio solo dire che non ne sappiamo ancora abbastanza. Non sappiamo un cazzo.” “Sappiamo tutto ciò che ci serve sapere” dice Philip, gettandogli un’occhiata. “Sappiamo che aumentano ogni giorno che passa e che sembrano solo intenzionati ad averci per pranzo. Che è il motivo per cui dobbiamo restare qui per un po’ e aspettare che le acque si calmino.” Brian emette un sospiro stanco e doloroso. Gli altri restano in silenzio. Durante quella pausa, sentono i flebili rumori che hanno sentito per tutta la notte, i rumori provenienti dall’oscurità di fuori: il battito soffocato e intermittente di figure insensibili che colpiscono la barricata improvvisata. Nonostante gli sforzi di Philip per erigere il baluardo in fretta e in silenzio, il fracasso del lavoro che hanno fatto quel giorno ha attirato altri cadaveri ambulanti. “Quanto a lungo pensi che riusciremo a restare qui?” chiede Brian piano. Philip si siede, posa la sparachiodi sul tavolo e beve un altro sorso di bourbon. Fa un cenno verso il soggiorno, da dove, in modo incongruo, provengono le voci bizzarre dei personaggi del cartone animato. “Ha bisogno di riposare” dice Philip. “È esausta.” “Adora tutti quei giochi nel cortile sul retro” dice Brian con un sorriso debole. Philip annuisce. “Qui può vivere una vita normale per un po’.” Tutti lo guardano e riflettono in silenzio su quel concetto. “Alla salute di tutti i ricchi bastardi del mondo” dice Philip, sollevando il bicchiere. Gli altri brindano senza sapere esattamente a cosa… o quanto a lungo durerà. QUATTRO Il giorno seguente, nel limpido sole autunnale, Penny gioca nel cortile sotto lo sguardo vigile di Brian. Gioca per tutta la mattina mentre gli altri fanno l’inventario e dividono le provviste. Nel pomeriggio, Philip e Nick mettono in sicurezza le lunghe e strette finestre dello scantinato con tavole supplementari e cercano invano di modificare la sparachiodi per collegarla alla corrente continua, mentre Bobby, Brian e Penny giocano a carte in soggiorno. La vicinanza dei non morti è una costante: sono squali che nuotano sotto la superficie di ogni decisione e attività. Ma per il momento, c’è solo qualche randagio occasionale, un vagabondo che sferra un colpo isolato contro lo steccato, per poi trascinarsi via. Per la maggior parte, l’attività dietro la barricata di tavole di cedro alte due metri su Green Briar Lane è passata inosservata allo sciame. Quella notte, dopo cena, con le tende tirate, guardano tutti insieme un film di Jim Carrey in soggiorno e si sentono di nuovo quasi normali. Stanno cominciando tutti ad abituarsi a quel posto. Ormai badano a malapena ai tonfi soffocati che di tanto in tanto si odono nell’oscurità. Brian ha praticamente dimenticato il dodicenne scomparso, e dopo che Penny è andata a letto, gli uomini fanno piani a lungo termine. Discutono delle implicazioni di restare nella casa coloniale finché durano le provviste, provviste sufficienti per settimane. Nick si domanda se dovrebbero mandare qualcuno in esplorazione, magari per verificare la situazione sulle strade verso Atlanta, ma Philip è irremovibile. “Lasciamo che quelli là fuori se la vedano tra loro” consiglia. Nick continua a tenere sotto controllo radio, TV e Internet… ma simili alle deboli funzioni corporee di un malato terminale, i media sembrano spegnersi un organo dopo l’altro. La maggior parte delle stazioni radio trasmette ormai solo programmi registrati o inutili informazioni d’emergenza. I canali televisivi via cavo sono ancora operativi e trasmettono ventiquattr’ore su ventiquattro annunci automatici della protezione civile o inspiegabili, incongrue repliche di pubblicità notturne. Giunti al terzo giorno, Nick comprende che la maggior parte delle frequenze radio si è ormai ridotta a semplici scariche statiche, la maggior parte dei canali via cavo è solo effetto neve e il Wi-Fi della casa è andato. Non funzionano nemmeno le connessioni via telefono, e le telefonate che Nick fa regolarmente ai numeri d’emergenza non ottengono altro che una risposta registrata, il classico “vaffanculo” delle compagnie telefoniche: il numero da lei chiamato non è al momento raggiungibile, la preghiamo di riprovare più tardi. Nella tarda mattinata di quello stesso giorno, il cielo si annuvola. Nel pomeriggio, una nebbia gelida e lugubre cala sulla comunità e tutti si accalcano all’interno, provando a ignorare la linea sottile che corre tra l’essere in salvo e l’essere prigionieri. A parte Nick, tutti gli altri sono stanchi di parlare di Atlanta. Atlanta appare molto più lontana ormai, come se più tempo passano a valutare la trentina di chilometri che la separano da Wiltshire, più quei chilometri sembrano diventare impraticabili. Quella notte, dopo che tutti si sono coricati, Philip resta seduto in soggiorno, a fare la sua veglia solitaria a Penny che dorme. La nebbia si è trasformata in un temporale con tanto di tuoni e fulmini. Philip infila il dito tra due stecche della veneziana e sbircia fuori nel buio. Attraverso la fessura, riesce a scorgere, al di sopra della barricata, le stradine sinuose e le imponenti ombre delle querce, coi loro rami piegati dal vento. Brilla un fulmine. A quasi duecento metri di distanza, una decina o più di sagome umanoidi si materializza nella luce stroboscopica, muovendosi senza meta nella pioggia. Dal suo punto di vista, Philip fa fatica a stabilirlo con sicurezza, ma si direbbe che le cose si muovano, col loro passo pesante da ritardati o da vittime di un i nfarto, nella sua direzione. Sentono l’odore di carne fresca? Sono i rumori delle attività umane ad attirarli? O semplicemente vagano in modo del tutto casuale, come orrendi pesci rossi in una boccia? Proprio allora, per la prima volta da quando sono arrivati a Wiltshire Estates, Philip Blake si ritrova a chiedersi se i loro giorni in quel grembo di moquette e divani esageratamente morbidi siano contati. Il quarto giorno l’alba è gelida e nuvolosa. Il cielo color peltro incombe sopra i giardini bagnati e le case abbandonate. In un certo senso il nuovo giorno segna una tappa importante, sebbene l’occasione passi sotto silenzio: è l’inizio della seconda settimana dell’epidemia. Adesso Philip è in soggiorno col suo caffè in mano e sbircia attraverso le tende verso la barricata di fortuna. Nella pallida luce mattutina, vede l’angolo nord-est dello steccato agitarsi e tremare. “Figlio di un cane” mormora sottovoce. “C’è qualche problema?” La voce di Brian risveglia Philip dal suo torpore. “Ce ne sono ancora di più.” “Merda. Quanti?” “Non saprei.” “Cosa vuoi fare?” “Bobby!” L’uomo grasso avanza pesantemente nei suoi pantaloni della tuta e a piedi nudi, mangiando una banana. Philip si volta verso il corpulento amico e dice: “Vestiti”. Bobby manda giù un grosso boccone di banana. “Che succede?” Philip ignora la domanda e guarda Brian. “Tieni Penny nel soggiorno.” “Va bene” dice Brian e si allontana di corsa. Philip si avvia verso le scale e, mentre se ne va, ordina: “Prendi la sparachiodi e tutte le prolunghe che riesci a portare… e anche le accette!”. FFFFFFFOOOMP! Il numero cinque va giù come una gigantesca bambola di pezza coi pantaloni di un completo sbrindellati; gli occhi morti e lattiginosi si rovesciano all’indietro mentre scivola a terra lungo l’altro lato dello steccato e il corpo putrido crolla sul viale. Philip fa un passo indietro, respirando a fatica per lo sforzo, bagnato di sudore nel giubbotto e nei pantaloni di jeans. I numeri da uno a quattro sono stati facili come sparare a un pesce in un barile, una donna e tre uomini, a ognuno dei quali Philip si è avvicinato di soppiatto con la sparachiodi mentre colpivano e artigliavano il punto debole dell’angolo dello steccato. Philip si è limitato a starsene sul montante più basso con una buona angolazione sulle loro teste. Li ha abbattuti rapido, uno dopo l’altro. FFFFOOOMP! FFFFOOOMP! FFFFOOOMP! FFFFOOOMP! Il numero cinque è stato il più sfuggente. Spostatosi inavvertitamente dalla linea di fuoco all’ultimo momento, ha fatto un piccolo passo da ubriaco, poi ha allungato il collo verso Philip, chiudendo i denti di scatto. Philip ha dovuto sprecare due chiodi, che sono rimbalzati lontani sul marciapiede, prima di riuscire a ficcarne uno nella corteccia cerebrale dello stronzo vestito di lusso. Adesso Philip riprende fiato, piegato in due dalla stanchezza, la sparachiodi ancora nella mano destra, ancora attaccata alla presa della casa con quattro prolunghe da otto metri. Si raddrizza e ascolta. Il viale è silenzioso. Lo steccato tiene. Si guarda dietro da sopra la spalla e vede Bobby Marsh nel cortile sul retro, a circa trenta metri di distanza. Il ciccione è seduto sul suo culo grasso e cerca di riprendere fiato, appoggiandosi contro una piccola cuccia abbandonata. La cuccia ha un tetto coperto di piccole tegole e le parole laddie boy sono state incise sopra l’apertura. Questa gente ricca e i loro fottuti cani, pensa mesto Philip, ancora un po’ depresso e nervoso. Probabilmente quella bestia mangiava meglio di molti bambini. Oltre lo steccato, a circa sei metri da Bobby, a ridosso della recinzione, ci sono i resti scomposti di una donna morta, con un’accetta ancora conficcata nel cranio dove Bobby Marsh l’ha colpita. Philip rivolge a Bobby un cenno e uno sguardo interrogativo. Tutto a posto? Bobby ricambia il gesto alzando il pollice. Poi… quasi senza preavviso… le cose cominciano ad accadere molto in fretta. Il primo segno che c’è qualcosa di decisamente non a posto si manifesta appena un secondo dopo che Bobby ha fatto al suo amico, capo e mentore il segno col pollice alzato. Fradicio di sudore, col cuore che ancora batte all’impazzata per la fatica di muovere il suo grosso corpo, mentre è appoggiato alla cuccia, Bobby riesce ad accompagnare il gesto con un sorriso… del tutto ignaro del rumore soffocato che proviene da dentro la cuccia. Da anni ormai, Bobby Marsh agogna segretamente di compiacere Philip Blake, e la prospettiva di rivolgergli il pollice alzato dopo un lavoro difficile ben fatto lo riempie di una strana sorta di soddisfazione. Figlio unico, a malapena capace di diplomarsi al liceo, Bobby si era attaccato a Philip negli anni precedenti alla morte di Sarah Blake e dopo, quando Philip si era allontanato dai suoi compagni di bevute, Bobby aveva disperatamente cercato di riallacciare i contatti. Aveva chiamato Philip fin troppe volte; quando erano insieme parlava troppo e spesso si era reso ridicolo nel tentativo di essere all’altezza del dinoccolato maschio alfa del gruppo. Ma ora, in uno strano modo, Bobby si sente come se quella bizzarra epidemia, tra le altre cose, gli abbia consentito di rinsaldare il suo legame con Philip. Ed è probabilmente per tutti questi motivi che, sulle prime, Bobby non sente il rumore che viene da dentro la cuccia. Quando il tonfo arriva, come se un cuore gigantesco battesse dentro la capanna in miniatura, il sorriso di Bobby gli si congela sulla faccia e il pollice alzato cade di lato. E quando la comprensione che dentro la cuccia c’è qualcosa che si muove riesce a farsi strada tra le sinapsi del cervello di Bobby e viene registrata abbastanza chiaramente da farlo muovere, è già troppo tardi. Qualcosa di piccolo e schiacciato sul terreno balza fuori dall’apertura ad arco della cuccia. Philip ha già attraversato metà cortile, correndo a tutta velocità, quando diventa chiaro che la cosa che si è appena fatta strada fuori dalla cuccia è un piccolo essere umano… o meglio un putrescente, bluastro, contorto facsimile di un piccolo essere umano, con foglie e merda di cane tra i capelli biondi e arruffati, e una catena avvolta intorno alla vita e alle gambe. “F-FAN-FANCULOOOOO!” geme Bobby e si agita per allontanarsi dal cadavere dodicenne mentre la cosa che un tempo era un bambino si lancia sulla sua gamba grossa come un prosciutto. Bobby rotola di lato e riesce a liberarsi appena in tempo: la piccola faccia contorta, simile a una zucca cava con dei buchi al posto degli occhi, ingoia l’erba dove fino a un attimo prima c’era stato l’arto di Bobby. Philip adesso è a quindici metri di distanza e corre verso la cuccia alla massima velocità, con la sparachiodi alta come una bacchetta da rabdomante puntata sul mostro in miniatura. Bobby si trascina come un granchio sull’erba umida, facendo patetica mostra del solco tra le natiche; i suoi rantoli sono acuti e striduli come quelli di una ragazzina. Il minuscolo demonio si muove con l’energia sgraziata di una tarantola, strisciando sull’erba verso Bobby, che cerca di rimettersi in piedi e scappare, ma le sue gambe si ingarbugliano facendolo cadere di nuovo, stavolta all’indietro. Philip è lontano sei metri, quando Bobby comincia a gridare in un tono ancora più acuto. Il bambino zombie gli stringe una mano simile a un artiglio intorno alla caviglia e prima che Bobby possa divincolarsi, gli affonda la bocca fitta di denti imputriditi nella gamba. “DANNAZIONE!” tuona Philip, mentre si avvicina con la sparachiodi. Trenta metri dietro di lui, la prolunga si stacca dalla presa elettrica. Philip sbatte la punta della sparachiodi sulla parte posteriore del cranio del mostro, che ha già afferrato il corpo grasso e tremante di Bobby. Il grilletto della sparachiodi fa clic. Non succede niente. Lo zombie scava a fondo nella coscia flaccida di Bobby, come un piranha, tranciandogli l’arteria femorale e portandosi via metà del suo scroto. Le grida di Bobby si riducono a un ululato di dolore mentre Philip istintivamente getta via la sparachiodi e si lancia incerto sulla bestia. La strappa via dal suo amico come se rimuovesse una sanguisuga enorme e la scaglia, a testa in giù, lontano sul il giardino prima che possa mordere ancora. Il bambino morto crolla a terra e rotola a cinque o sei metri di distanza sull’erba fangosa. Nick e Brian schizzano fuori di casa: Brian va ad afferrare la prolunga e Nick corre attraverso il prato con un piccone. Philip afferra Bobby e prova a farlo smettere di contorcersi e di urlare per impedirgli di dissanguarsi più in fretta: la ferita slabbrata spruzza geyser di sangue al ritmo del suo battito accelerato. Philip sbatte la sua mano sulla gamba di Bobby, tamponando lievemente il flusso: il sangue gli cola tra le dita unte, mentre altre figure si muovono nel suo campo visivo periferico. La cosa morta sta tornando: striscia sul terreno umido verso Philip e Bobby, ma Nick si avvicina di scatto, solleva il piccone con gli occhi spalancati di panico e di rabbia, e lo cala senza esitazioni: l’arma sibila nell’aria e la punta arrugginita si abbatte sulla parte posteriore del cranio dello zombie bambino, conficcandosi per otto centimetri nella cavità craniale. Il mostro si affl oscia. Philip grida a Nick qualcosa riguardo a una cintura, una CINTURA: Nick si agita, cercando a tentoni la sua cintura. Philip non ha alcun addestramento di primo soccorso, ma ne sa abbastanza da provare a fermare l’emorragia con un laccio di qualche tipo. Arrotola la cintura di Nick attorno alla gamba del ciccione tremante, che cerca di parlare, ma sembra tormentato da un freddo estremo: le sue labbra si muovono, tremando silenziose. Nel frattempo, Brian, a trenta metri di distanza, è impegnato a reinserire la prolunga nella presa elettrica, probabilmente perché non ha saputo pensare a nient’altro da fare. La sparachiodi giace nell’erba a quattro o cinque metri dietro Philip, che sta gridando a Nick: “VAI A PRENDERE UN PO’ DI FOTTUTE BENDE, DI ALCOL E QUALSIASI ALTRA COSA!!!”. Nick corre, senza mollare il piccone, mentre Brian si avvicina, fissando la cosa morta che giace a faccia in giù nell’erba, col cranio sfondato. Se ne tiene alla larga, afferra la sparachiodi, casomai ce ne sia bisogno, e controlla la collina dietro la staccionata mentre Philip tiene in braccio Bobby come un bambino gigante. Bobby piange e respira velocemente, respiri poco profondi e tremanti. Philip lo conforta, mormorando incoraggiamenti e assicurandolo che andrà tutto bene… ma è chiaro, mentre Brian si avvicina cauto, che le cose non andranno affatto bene. Alcuni istanti dopo, Nick torna con le braccia piene di grosse bende sterili, con una bottiglia di alcool in una delle tasche posteriori e un rotolo di nastro di cotone nell’altra. Ma qualcosa è cambiato. L’emergenza si è trasformata in qualcosa di più oscuro… una veglia al capezzale di un moribondo. “Dobbiamo portarlo dentro” annuncia Philip, ormai fradicio del sangue dell’amico. Ma non fa alcuno sforzo per sollevarlo. Bobby Marsh sta per morire. La cosa è chiara a tutti. È chiara specialmente a Bobby Marsh, che giace in stato di shock, fissando il cielo metallico nell’affannoso tentativo di parlare. Brian è lì accanto, tiene la sparachiodi al suo fianco, con lo sguardo rivolto in basso verso Bobby. Nick lascia cadere le bende ed emette un sospiro angosciato. Sembra quasi sul punto di piangere, ma si limita a crollare in ginocchio dall’altro lato e a prendersi la testa tra le mani. “Io… io… n-n-nn…” Bobby Marsh cerca disperatamente di far capire qualcosa a Philip. “Sssssshhh…” Philip gli accarezza la spalla, senza riuscire a pensare lucidamente. Si volta, afferra un rotolo di bende e comincia a fasciare la ferita. “Nnn-n-NO!” Bobby le spinge via. “Bobby, dannazione.” “NN-NO!” Philip si ferma, deglutisce a fondo, guarda gli occhi acquosi dell’uomo morente. “Andrà tutto bene” lo rassicura, e la sua voce cambia di tono. “N-no… non è vero” riesce a dire Bobby. Da qualche parte nel cielo, un corvo gracchia. Bobby sa cosa sta per accadere. Hanno visto un uomo in una fossa giù a Covington tornare indietro in meno di dieci minuti. “S-ss-smettila di parlare così, Philly.” “Bobby…” “È finita” sussurra flebile Bobby e i suoi occhi tornano lucidi per un momento. Poi vede la sparachiodi nella mano di Brian. Con le grosse dita a salsiccia, la afferra per la punta. Brian la lascia cadere con un sobbalzo. “Dannazione, dobbiamo portarlo dentro!” La voce di Philip è colma di disperazione mentre Bobby Marsh a tentoni riesce ad afferrare l’attrezzo. Posa le dita grassocce sulla canna e cerca di portarsela alla tempia. “Gesù Cristo” mormora Nick. “Levagli di mano quella cosa!” Philip fa cenno a Brian di allontanarsi dalla vittima. Le lacrime di Bobby scorrono sui lati della grossa testa, lavando il sangue e lasciando alcune striature pulite. “T-ti prego, Philly” mormora. “F-fallo… e basta.” Philip si alza. “Nick! Vieni qui!” Si volta e muove alcuni passi verso la casa. Nick si alza e raggiunge Philip. I due uomini sono a cinque metri di distanza da Bobby, fuori dalla sua portata d’udito, gli voltano la schiena, le loro voci sono basse e tese. “Dobbiamo tagliargliela” dice in fretta Philip. “Cosa?” “La gamba.” “Cosa?” “Prima che il contagio si diffonda.” “Ma come pensi di…” “Non sappiamo quanto velocemente si diffonda; dobbiamo provare, gli dobbiamo almeno questo.” “Ma…” “Ho bisogno che tu vada a prendere la sega per il ferro dal capanno e che la porti…” Una voce risuona dietro di loro, interrompendo la litania nervosa di Philip. “Ragazzi?” È Brian, e dal suono tetro della sua voce nasale le notizie sono probabilmente cattive. Philip e Nick si girano. Bobby Marsh è immobile. Brian si inginocchia accanto a lui e sui suoi occhi cala un velo. “È troppo tardi.” Philip e Nick si avvicinano al punto dove Bobby giace sull’erba, con gli occhi chiusi. Il petto enorme e flaccido non si muove. La bocca è spalancata. “Oh, no… Gesù Cristo Santo, no” dice Nick, fissando l’amico morto. Philip non dice niente per un lungo tempo. Nessuno di loro lo fa. Il grosso corpo dell’amico giace immobile sul terreno bagnato per minuti interminabili… finché qualcosa non si agita nelle estremità dell’uomo, nei tendini delle gambe massicce e nella punta delle dita grassocce. All’inizio, il fenomeno sembra quasi il tipico spasmo nervoso che i becchini vedono di tanto in tanto, il sussulto del motore diesel del sistema nervoso centrale di un cadavere. Nick e Brian osservano con gli occhi sempre più grandi, si alzano lenti e poi cominciano piano ad allontanarsi; Philip, invece, si avvicina ancora e si inginocchia, con un’espressione corrucciata e quasi professionale sul volto. Gli occhi di Bobby Marsh sono aperti. Le pupille sono bianche come pus. Philip afferra la sparachiodi e la preme sulla fronte dell’uomo corpulento, proprio sopra il sopracciglio sinistro. FFFFFFFFUMP! Ore dopo. Dentro la casa. Dopo il tramonto. Penny dorme. Nick è in cucina, ad annegare il suo dolore nel whisky… Brian è introvabile… il cadavere di Bobby si sta raffreddando nel cortile, avvolto in un telo accanto agli altri corpi… e Philip è in piedi davanti alla finestra del soggiorno e guarda, tra le stecche della tenda, il numero crescente di sagome scure sulla strada. Vagano come sonnambuli, muovendosi avanti e indietro al di là della barricata. Sono di più adesso. Trenta, forse. Magari addirittura quaranta. I lampioni brillano attraverso le fessure del recinto e le ombre deambulanti interrompono i raggi a intervalli irregolari, rendendo la luce stroboscopica e facendo impazzire Philip. L’uomo sente dentro la sua testa la stessa voce silenziosa che aveva sentito per la prima volta dopo che Sarah era morta: brucia questo posto, brucia tutto il mondo. Quello stesso giorno, dopo che Bobby è morto, la voce voleva che mutilasse il cadavere del dodicenne, che facesse a pezzi quella cosa morta. Ma Philip l’aveva ricacciata indietro e ora la combatte di nuovo. La miccia è accesa, fratello, l’orologio ticchetta… Philip distoglie lo sguardo dalla finestra e si strofina gli occhi stanchi. “Va bene lasciar sfogare i propri sentimenti” dice una voce diversa, proveniente dall’oscurità. Philip si gira e vede la sagoma di suo fratello attraverso il soggiorno, in piedi sotto l’arco che dà sulla cucina. Philip torna a girarsi verso la finestra senza rispondere. Brian si avvicina con una bottiglia di sciroppo per la tosse nelle mani tremanti. Nell’oscurità, i suoi occhi febbricitanti luccicano di lacrime. Rimane lì in piedi per un momento. Poi con un tono di voce basso e sommesso, attento a non svegliare Penny che dorme sul divano accanto a loro, dice: “Non vergognarti di dare sfogo ai tuoi sentimenti”. “Dare sfogo a cosa?” “Senti” dice Brian, “so che stai soffrendo.” Tira su col naso e si pulisce la bocca con la manica: la sua voce è rauca e infiammata. “Voglio dire che mi dispiace davvero per Bobby, so che voi ragazzi eravate…” “È andato.” “Philip, dai…” “Questo posto è andato, fottuto.” Brian lo guarda. “Cosa intendi dire?” “Ce ne andiamo.” “Ma pensavo…” “Da’ un’occhiata.” Philip indica il crescente numero di ombre su Green Briar Lane. “Li attiriamo come mosche sulla merda.” “Sì, ma la barricata tiene ancora…” “Più a lungo restiamo, Brian, più questa casa diventerà una prigione.” Philip guarda fuori dalla finestra. “Dobbiamo rimetterci in viaggio.” “Quando?” “Presto.” “Tipo domani?” “Cominceremo a fare i bagagli domattina, caricheremo nella Suburban tutto quello che possiamo.” Silenzio. Brian guarda suo fratello. “Stai bene?” “Sì.” Philip continua a guardare fuori. “Va’ a dormire.” A colazione Philip decide di dire a sua figlia che Bobby è dovuto partire e tornare a casa, per occuparsi dei suoi, e la spiegazione sembra soddisfare la bambina. Più tardi, quel mattino, Nick e Philip scavano la fossa nel cortile sul retro, scegliendo un punto morbido in fondo al giardino, mentre Brian tiene occupata Penny in casa. Brian pensa che dovrebbero trovare un modo per raccontarle quanto è successo, ma Philip gli dice di stare fuori da tutta quella maledetta faccenda e di tenere la bocca chiusa. Davanti al pergolato per le rose nel cortile, Philip e Nick sollevano ora il corpo enorme avvolto nel telo e lo calano nella buca appena scavata. Impiegano qualche tempo a ricoprire la fossa, gettando palate e palate di nera terra concimata della Georgia sull’amico. Mentre lavorano, il lamento atonale dei non morti vaga nel vento. È un altro giorno di pioggia e di cielo coperto, e i rumori dell’orda di zombie si diffondono nell’aria e sopra ai tetti delle case, mandando fuori di testa Philip che, madido di sudore nei suoi jeans, continua a spingere la terra nella fossa. L’odore sporco e nero della carne putrefatta è forte come sempre e fa rivoltare lo stomaco di Philip, impegnato a gettare le ultime palate di terra sulla tomba. Adesso Philip e Nick si fermano ai lati opposti del grosso cumulo, appoggiati alle pale e col sudore che cola giù per il collo. Per un lungo istante, non dicono niente, ciascuno perso nei propri pensieri. Alla fine, Nick alza lo sguardo e, molto dolcemente, in tono stanco e deferente, chiede: “Vuoi dire qualcosa?”. Philip lo guarda al di sopra della fossa. Il suono dei lamenti si fa sentire con forza da tutte le direzioni, come il ronzio di uno sciame di cavallette, e Philip riesce appena a pensare in modo lucido. Proprio allora, per qualche strana ragione, ricorda la notte in cui i tre amici si erano ubriacati, si erano intrufolati nello Starliter, il drive-in su Waverly Road, e si erano introdotti nella cabina di proiezione. Muovendo le dita grassocce davanti al proiettore, Bobby aveva fatto delle ombre cinesi sullo schermo lontano. Philip aveva riso così forte, che aveva temuto di essere sul punto di vomitare, mentre guardava le sagome di paperi e conigli saltellanti sopra le immagini di Chuck Norris che prendeva a calci dei nazisti. “Molti pensavano che Bobby Marsh fosse un sempliciotto” dice Philip con lo sguardo rivolto verso il basso, “ma non lo conoscevano. Era leale e divertente, ed era un amico dannatamente buono… ed è morto da uomo.” Anche Nick guarda verso il basso; le sue spalle tremano leggermente, la voce è rotta e le parole si odono appena sopra il clamore che continua a crescere intorno a loro. “Dio onnipotente, nella tua misericordia, volgi le tenebre della morte nell’alba di una nuova vita e la tristezza della separazione nella gioia del paradiso.” Philip sente le lacrime salirgli agli occhi e stringe i denti così forte da far stridere la mascella. “Si renda grazie al nostro Salvatore, Gesù Cristo” continua Nick con voce scossa, “che è morto, risorto e vive per sempre. Amen.” “Amen” riesce a dire Philip con una voce rauca e debole, che sembra quasi aliena alle sue stesse orecchie. L’incessante frastuono dei non morti si fa sempre più forte. “STATE ZITTI, CAZZO!” ruggisce Philip Blake agli zombie. I rumori giungono ormai da tutte le direzioni. “FOTTUTI FIGLI DI PUTTANA MORTI!” Philip si allontana dalla tomba, girandosi lento. “VI SFONDERÒ IL CRANIO UNO PER UNO, BASTARDI SUCCHIACAZZI CANNIBALI!!! VI STACCHERÒ QUELLA TESTA SCHIFOSA E CAGHERÒ NEI VOSTRI FOTTUTI COLLI MARCI!!!” A quelle parole, Nick comincia a singhiozzare, mentre Philip, ormai a corto di energie, cade in ginocchio. Nick piange e Philip si limita a fissare la terra smossa da poco come se questa contenesse chissà quali risposte. Se mai ci fosse stato qualche dubbio su chi fosse il leader del gruppo, non che ci sia mai stato, ormai è del tutto chiaro che Philip è l’alfa e l’omega. Passano il resto della giornata a fare i bagagli, con Philip che trasmette ordini a monosillabi, la voce bassa e roca per lo stress. “Prendete la cassetta degli attrezzi” grugnisce. “Batterie per le torce elettriche” borbotta. “E quella scatola di cartucce” mormora. “Anche altre coperte.” Nick pensa che forse dovrebbero valutare l’idea di prendere due macchine. Molti dei veicoli abbandonati nella comunità sono ultimi modelli di lusso, molti con le chiavi ancora inserite, pronti per essere presi, ma Brian ha paura di dividere il loro gruppo già piccolo e sparuto. O forse si è ormai aggrappato a suo fratello. Forse ha soltanto bisogno di stare vicino al suo centro di gravità. Decidono di prendere la Chevy Suburban. Quella macchina è praticamente un carro armato, proprio quello di cui hanno bisogno per raggiungere Atlanta. Ancora affl itto dal suo ostinato raffreddore che ormai è sceso nei polmoni, causandogli un sibilo perpetuo, forse il primo stadio di una polmonite, Brian Blake si concentra sul suo compito. Deve stipare in tre frigoriferi da campeggio i cibi che recano la data di scadenza più lontana: carne affumicata, formaggi duri, contenitori sigillati o succhi, yogurt, soda e maionese. Riempie una scatola di cartone con pane, carne di manzo, caffè istantaneo, acqua in bottiglia, barrette di proteine, vitamine, piatti di carta e posate di plastica. Decide di prendere tutto un assortimento di coltelli da cucina: mannaie, lame seghettate e coltelli per disossare, per qualsiasi incontro ravvicinato in cui gli capiti di imbattersi. In un’altra scatola ripone carta igienica, sapone, asciugamani e stracci. Rovista nell’armadietto dei medicinali e prende medicine per il raffreddore, sonniferi, antidolorifici; intanto gli viene un’idea, pensa a una cosa che dovrebbe fare prima di partire. Nel seminterrato prende un piccolo secchio pieno per metà di vernice rossa e un pennello di crine di cavallo da cinque centimetri. Trova un vecchio pezzo di compensato largo novanta centimetri per novanta e in fretta, ma con molta attenzione, scrive un messaggio: quattro semplici parole scritte in caratteri maiuscoli, grandi abbastanza da essere viste da un veicolo di passaggio. Poi inchioda un paio di gambe al lato inferiore del cartello. Lo porta di sopra e lo mostra al fratello. “Penso che dovremmo lasciarlo fuori dal cancello” dice a Philip. Philip si limita a scrollare le spalle e a dirgli che la decisione è sua, qualsiasi cosa voglia fare. Per uscire aspettano il buio. Alle sette in punto, mentre il sole scende freddo e metallico dietro i tetti, si affrettano a caricare la Suburban. Lavorano svelti tra le ombre che si allungano, coi mostri che sciamano contro la barricata e formano una specie di catena, passandosi velocemente valigie e contenitori dalla porta laterale della casa al bagagliaio aperto del SUV. Prendono le asce che si portano dietro dall’inizio e aggiungono un vasto assortimento di picconi, pale, accette, seghe e lame da taglio, provenienti dal capanno degli attrezzi sul retro. Portano corde, cavi, torce stradali, giacche, stivali da neve e cubetti accendifuoco. Caricano anche un tubo per travasare e tutte le taniche di benzina che riescono a infilare nel baule posteriore. Il serbatoio della Suburban al momento è pieno: quello stesso giorno, Philip, all’oscuro delle condizioni in cui versano le stazioni di servizio della zona, ci ha travasato una sessantina di litri di benzina da una berlina abbandonata nel garage di un vicino. Durante gli ultimi quattro giorni, Philip ha scoperto una gran varietà di fucili da caccia nelle case vicine. Da quelle parti i ricchi amano la stagione delle anatre. Adorano abbattere le teste verdi dal lusso dei loro capanni riscaldati, coi fucili potenti e i cani da caccia purosangue. Il vecchio di Philip lo faceva nel modo difficile, con nient’altro che un paio di stivaloni, un whisky fatto in casa e un pessimo carattere. Philip ha scelto tre fucili, che adesso ripone nelle sacche in vinile con la chiusura lampo nel compartimento sul retro: uno è un Winchester calibro .22 a percussione anulare e gli altri due sono fucili a pallettoni Marlin modello 55. I Marlin sono particolarmente utili. Sono conosciuti come fucili da oche. Rapidi, accurati e potenti, sono progettati per uccidere stormi di uccelli migratori ad altitudini elevate… o, in questo caso, colpire il centro di un cranio a un centinaio di metri di distanza. Sono quasi le otto quando finiscono di caricare la Suburban e fanno sedere Penny sul sedile posteriore. Infagottata in un piumino, con accanto il suo pinguino di pezza, la bambina sembra stranamente ottimista: il viso pallido è teso e spossato, come se dovesse andare a farsi visitare dal pediatra. Gli sportelli si aprono e si chiudono. Philip si mette al volante. Nick si siede sul sedile del passeggero e Brian si sistema accanto a Penny, in quello posteriore di mezzo. Il cartello resta sul pavimento dell’auto, appoggiato alle ginocchia di Brian. La macchina si mette in moto. Il ruggito del motore si diffonde nell’oscurità silenziosa, facendo irrigidire i non morti dall’altro lato della barricata. “Diamoci una mossa, gente” dice Philip sottovoce, inserendo la retromarcia. “Reggetevi forte.” Spinge il pedale a tavoletta e le quattro ruote motrici partono a tutta potenza. La forza di gravità spinge i passeggeri in avanti mentre la Suburban scatta all’indietro. Nello specchietto retrovisore, il punto debole della barricata di fortuna incombe sempre più vicino finché… BANG! Il veicolo schizza attraverso le tavole di cedro nella Green Briar Lane. Immediatamente, il paraurti posteriore sinistro colpisce un cadavere ambulante, mentre Philip preme sui freni e inserisce la marcia. Lo zombie viene scagliato a qualche metro di distanza dietro di loro, fa una piroetta sgraziata in una nuvola di sangue e un pezzo del suo braccio in decomposizione si stacca e carambola nella direzione opposta. La Suburban parte a razzo verso la strada principale, investendo e spedendo nell’oblio altri tre zombie. A ogni impatto, le vibrazioni sorde dei tonfi che si trasmettono attraverso il telaio e le macchie giallastre, simili a insetti, che rimangono sul parabrezza, costringono Penny a rannicchiarsi e a chiudere gli occhi. Alla fine della strada, Philip gira rapido il volante e sgomma attorno all’angolo, poi si dirige a nord verso l’entrata. Alcuni minuti dopo, abbaia un altro ordine: “Okay, fallo di corsa… e intendo proprio DI CORSA!”. Pesta sui freni e di nuovo tutti sobbalzano in avanti. Sono fermi davanti al grande cancello d’entrata, visibile nel cono di luce dei lampioni attraverso una breve distesa di ghiaia delineata da una siepe. “Ci metto un secondo” dice Brian, afferrando il cartello e facendo scattare la maniglia dello sportello. “Lascia il motore acceso.” “Basta che ti sbrighi.” Brian scivola fuori dall’auto con il cartello grosso novanta centimetri per novanta. Nella gelida aria notturna, corre sulla distesa di ghiaia, con le orecchie allerta e sensibili al lontano brusio dei gemiti fragorosi: vengono nella sua direzione. Sceglie un punto appena a destra del cancello d’entrata, dove il muro di mattoni non è ostruito dagli arbusti, e posiziona il cartello. Infila le gambe di legno nel terreno soffice per stabilizzarlo e poi si affretta a tornare alla macchina, soddisfatto di aver fatto la sua parte per l’umanità o per quanto ne è rimasta. Mentre la macchina si allontana, tutti quanti, anche Penny, guardano dal lunotto posteriore il piccolo cartello quadrato che scompare in lontananza. TUTTI MORTI NON ENTRARE CINQUE Nell’oscurità della campagna si dirigono a ovest, mantenendo una velocità di cinquanta chilometri all’ora. Le quattro corsie dell’Interstate 20 sono disseminate di macchine abbandonate e l’asfalto serpeggia verso il bagliore roseo dell’orizzonte, dove la città aspetta come un livido di luce nel cielo notturno. Sono costretti ad attraversare quel dedalo di rottami con lentezza agonizzante, ma riescono a percorrere otto chilometri prima che le cose si mettano male. Per gran parte di quegli otto chilometri, Philip continua a pensare a Bobby e a tutte le cose che avrebbero potuto fare per salvarlo. Il dolore e il rimorso gli scavano un solco profondo nelle viscere, un cancro con metastasi più cupe e molto più maligne del dolore. Per combattere le emozioni si costringe a pensare al vecchio detto dei camionisti: controlla la strada e non tenere lo sguardo fisso. Afferra il volante con la stretta esperta del camionista di lungo corso e si sposta più avanti sul sedile con lo sguardo vigile sui margini dell’autostrada. Per otto chilometri solo una manciata di morti sfiora lo spettrale fascio di luce dei fanali. Appena fuori da Conyers, superano un paio di morti rimasti indietro: barcollano lungo il fianco della carreggiata come disertori sporchi di sangue. Oltre il centro commerciale Stonecrest Mall vedono un gruppo di sagome scure accovacciate in un fosso: a quanto pare sono intente a cibarsi di una vittima della strada, ma nel buio tremolante è impossibile stabilire se si tratti di un animale o di un umano. Ma questo è tutto quello in cui si imbattono, per otto chilometri almeno, durante i quali Philip decide di non superare i costanti (e sicuri) cinquanta chilometri l’ora. Se andassero più lentamente rischierebbero di farsi agganciare da qualche mostro vagabondo; se fossero più veloci potrebbero colpire di striscio il numero crescente di veicoli distrutti e abbandonati che punteggiano le corsie. La radio è morta e il gruppo viaggia in silenzio con lo sguardo incollato sul paesaggio che scorre. Le circonvallazioni esterne dell’area urbana di Atlanta scorrono lente, una serie di foreste di pini interrotte da qualche dormitorio o centro commerciale. Oltrepassano rivendite di macchine buie come camere mortuarie: un oceano sconfinato di nuovi modelli, simili a bare, che riflettono la lattiginosa luce lunare. Superano varie Waffl e House abbandonate e con le finestre sfondate come ferite aperte, e parcheggi di uffici deserti come zone di guerra. E poi svariati Shoney’s, parcheggi di roulotte, Kmart e RV Center, ognuno più desolato e malridotto del precedente. Piccoli fuochi bruciano qua e là. I parcheggi sembrano la cupa stanza dei giochi di un bambino pazzo, con le macchine disseminate sul lastricato come giocattoli gettati rabbiosamente in un angolo. Vetri rotti scintillano dappertutto. A quanto pare, in meno di una settimana e mezzo, l’epidemia ha devastato la periferia di Atlanta. Qui, tra le riserve naturali e i palazzi degli uffici, dove le famiglie della classe media sono emigrate nel corso degli anni per sottrarsi ai lunghi viaggi per recarsi sul posto di lavoro, ai mutui massacranti e all’alto tasso di stress della vita cittadina, l’epidemia ha distrutto l’ordine sociale in pochissimi giorni. E per qualche motivo, è la vista di tutte le chiese devastate a infastidire maggiormente Philip. Ogni santuario che sorpassano versa in uno stato peggiore: il Centro Battista della Nuova Nascita Missionaria fuori da Harmon è ancora in fiamme dopo un recente incendio, e le rovine carbonizzate di una croce si stagliano contro il cielo. Un paio di chilometri dopo, lungo la strada, il portale del Seminario Luther Rice mostra scarabocchi frettolosi che avvisano i passanti della fine imminente e che l’estasi è qui e tutti i peccatori farebbero bene a dire addio al loro culo. La Cattedrale della Fede Cristiana Unita sembra saccheggiata, ripulita di tutto e, successivamente, che qualcuno ci abbia pisciato sopra. Il parcheggio del Palazzo Pentecostale di San Giovanni Apostolo sembra un campo di battaglia coperto di cadaveri, molti dei quali si muovono ancora col passo da sonnambuli dei non morti. Che razza di Dio lascerebbe accadere tutto questo? E visto che siamo in argomento: che razza di Dio permetterebbe che un bravo ragazzo, semplice e innocente, come Bobby Marsh muoia in quel modo? Che razza di… “Oh, merda!” La voce proviene dal sedile posteriore e scuote Philip dai suoi pensieri cupi. “Cosa c’è?” “Guarda” dice Brian, la voce debole per il raffreddore o per la paura, o forse per un po’ di entrambi. Philip guarda nello specchietto retrovisore e vede l’espressione ansiosa del fratello nel bagliore verde del cruscotto. Brian indica l’orizzonte a ovest. Philip torna a guardare dal parabrezza, premendo istintivamente i freni. “Cosa? Non vedo niente.” “Merda” dice Nick dal posto del passeggero. Guarda attraverso un varco nel bosco di pini lontano sulla destra, dove la luce brilla in mezzo agli alberi. A quasi centocinquanta metri davanti a loro, l’autostrada gira in direzione nord-est, passando attraverso una macchia di alberi, oltre i quali, attraverso il fogliame, sono visibili delle fiamme. L’autostrada è in fiamme. “Dannazione” dice Philip con un sospiro teso. Rallenta l’andatura fin quasi a fermarsi mentre l’auto affronta la curva. Dopo pochi istanti, il camion ribaltato entra nel loro campo visivo: giace ripiegato su se stesso, avvolto in un bozzolo di fiamme, come un dinosauro in perpendicolare. La sua carcassa blocca le due corsie più a ovest; la cabina è staccata e ridotta a pezzi, aggrovigliata ad altre tre macchine attraverso la linea mediana e le due corsie a est. I gusci bruciati di altre auto giacciono rovesciati dietro i rottami che bruciano. Oltre l’incidente, le corsie sembrano un parcheggio con decine di macchine, alcune in fiamme, avviluppate nel tamponamento a catena. Philip accosta la Suburban e la fa fermare a una cinquantina di metri dalle fiamme. “Fantastico” dice, senza rivolgersi a nessuno in particolare; muore dalla voglia di lanciarsi in una raffica di imprecazioni, ma si trattiene seppur a fatica (le orecchie di Penny sono a pochi centimetri di distanza). Da lì, pur in quella tremolante oscurità, molte cose diventano chiare. La prima, e più importante, è che o si mettono alla ricerca di una squadra di pompieri con tanto di carro attrezzi per continuare il percorso o trovano una fottuta deviazione. Seconda: qualsiasi cosa sia accaduta in quel posto, sembra avvenuta in un passato molto recente, forse quello stesso giorno, magari poche ore prima. Il manto stradale attorno al tamponamento è annerito e bruciato, come se una meteora ci avesse scavato un buco e anche gli alberi che costeggiano l’autostrada sono stati carbonizzati dalle onde d’urto. Nonostante i finestrini chiusi della Suburban, Philip sente il tanfo acre del gasolio che brucia e della gomma fusa. “E adesso?” chiede infine Brian. “Dobbiamo tornare indietro” risponde Nick, guardando da sopra la spalla. “Fatemi pensare un attimo” dice Philip, fissando la cabina del camion ribaltato con il tettuccio scoperchiato come una scatoletta d’alluminio. Nell’oscurità, corpi carbonizzati giacciono distesi sull’aiuola spartitraffico fangosa. Alcuni si contraggono con gli ondeggiamenti svogliati di un serpente che si alza. “Dai, Philip, non possiamo aggirarlo” dice Nick. Brian interviene. “Forse possiamo tagliare sulla 278.” “DANNAZIONE, STA’ ZITTO E LASCIAMI PENSARE!” L’improvviso scoppio di rabbia fa vibrare la testa di Philip con la potenza di un’emicrania lancinante, gli fa digrignare i denti, stringere i pugni e ricacciare indietro la voce che sente dentro di sé: spaccagli la testa, fallo, staccagliela, staccagliela subito, strappagli il cuore… “Scusa” dice Philip, asciugandosi la bocca e guardando la bambina spaventata che si rannicchia nel buio del sedile posteriore. “Scusami tanto, pulcino, papà ha perso il controllo per un secondo.” La bambina fissa il pavimento. “Cos’hai intenzione di fare?” chiede piano Brian e dal tono triste della sua voce si direbbe disposto a seguire il fratello tra le fiamme dell’inferno se Philip la giudicasse la scelta migliore. “L’ultima uscita era… a quanto? Un paio di chilometri più indietro?” Philip guarda da sopra la spalla. “Forse dovremmo…” Il rumore come di uno schiaffo giunge dal nulla, bloccando Philip a metà frase. Penny urla. “MERDA!” Nick si scansa dal finestrino del passeggero, dove un cadavere carbonizzato si è materializzato nel buio. “Abbassati, Nick. Subito.” La voce di Philip è fredda e piatta, come quella di uno speaker radiofonico, mentre si china rapido verso il cassetto del cruscotto, apre lo sportellino e rovista in cerca di qualcosa. La cosa fuori dal finestrino preme contro il vetro: è a malapena identificabile come un essere umano; la sua carne è coperta di vesciche tanto da essere quasi carbonizzato. “Brian, copri gli occhi di Penny.” “MERDA! MERDA!” Nick si china e si protegge la testa, come se si trattasse di un attacco aereo. “MERDA! MERDA! MERDA!” Philip trova la Ruger .22 dove l’ha lasciata, con il proiettile già in canna. Con un unico movimento fluido, solleva l’arma con la mano destra e simultaneamente preme il pulsante che abbassa il finestrino con la mano sinistra. Lo zombie si allunga nell’apertura col braccio ustionato ed emaciato, emettendo un lamento gutturale, ma prima che possa afferrare la camicia di Nick, Philip gli spara un unico colpo, a bruciapelo, nel cranio. Il latrato della Ruger risuona assordante nell’abitacolo della Suburban e li fa sobbalzare tutti, mentre il cadavere carbonizzato scatta all’indietro: il colpo diretto sopra la sua tempia sinistra manda schizzi di materia cerebrale contro il lato interno del parabrezza. La cosa scivola lungo lo sportello del passeggero e il suono ovattato del suo corpo che colpisce il manto stradale si ode appena al di sopra del ronzio nelle orecchie di Philip. Le semiautomatiche calibro ventidue come la Ruger producono un latrato unico. Lo sparo risuona come un sonoro schiaffo sferrato a mano aperta o una tavola di legno che colpisce il cemento, e invariabilmente la pistola scatta nella mano del tiratore. Quella notte, nonostante l’effetto smorzante dell’interno della Suburban, quel singolo sparo echeggia nel paesaggio buio e si riverbera sopra le cime degli alberi e dei parcheggi degli uffici, portato dal vento. Quel latrato si potrebbe sentire a più di un chilometro di distanza, potrebbe penetrare il silenzio del fitto bosco e farsi strada nei canali uditivi senza vita delle creature ombrose, risvegliando sistemi nervosi centrali morti. “State tutti bene?” Philip si guarda intorno nell’abitacolo buio, posando la pistola fumante sul poggiagomito che ha di fianco. “Tutto a posto?” In quel momento Nick si sta tirando su sul sedile con gli occhi spalancati e infiammati dai residui dello sparo rimasti all’interno del finestrino. Penny, raccolta nelle braccia di Brian, tiene gli occhi chiusi, e Brian guarda frenetico fuori da tutti i finestrini in cerca di altri eventuali intrusi. Philip inserisce la retromarcia, preme sull’acceleratore e fa risalire in fretta il finestrino. Tutti sono spinti in avanti mentre il veicolo sgomma all’indietro, trenta, cinquanta, cento metri, lontano dall’autocisterna fumante. Poi la Suburban sbanda e si ferma, e tutti restano seduti in silenzio per un attimo. Fuori, tra le ombre tremolanti non si muove niente. Nessuno dice nulla per molto tempo, ma Philip è convinto di non essere il solo, in quel momento, a chiedersi se quel viaggio di trenta chilometri verso la città non sarà molto più duro di quanto abbiano creduto all’inizio. Rimangono seduti nella Suburban ferma per un po’ di tempo, dibattendo sulla migliore linea di condotta e la cosa rende Philip molto nervoso. Non gli piace starsene seduto in un posto troppo a lungo, specie col motore acceso, a sprecare benzina e tempo, con tutte quelle ombre che si muovono dietro gli alberi in fiamme. Ma il gruppo sembra non riuscire a mettersi d’accordo e Philip fatica duro per comportarsi da dittatore benevolo in quella piccola repubblica delle banane. “Sentite, io continuo a pensare che dovremmo aggirarlo.” Philip fa un cenno del capo verso il buio a sud. Le corsie che vanno in direzione contraria sono disseminate di veicoli bruciati, ma tra il bordo della massicciata di ghiaia e il boschetto di pini che costeggia l’autostrada c’è una stretta fessura, forse della larghezza della Suburban, con giusto qualche centimetro in più. Le piogge recenti, insieme alla benzina uscita dall’autocisterna rovesciata, hanno reso il terreno viscido. Ma la Suburban è un veicolo grosso e pesante, con pneumatici larghi e Philip l’ha guidata in condizioni di gran lunga peggiori. “È troppo pericoloso, Philly” dice Nick, pulendo la materia grigia dall’interno del parabrezza con un asciugamano sporco. “Proprio così, amico, devo convenire” dice Brian dalle ombre del sedile posteriore, col braccio attorno a Penny e i lineamenti angosciati visibili nella luce tremolante dell’incendio. “Io voto per tornare verso l’ultima uscita.” “Ma non sappiamo cosa troveremo sulla 278, potrebbe essere peggio.” “Non possiamo saperlo” dice Nick. “Dobbiamo andare avanti.” “Ma che facciamo se nella città va peggio? La situazione sembra peggiorare via via che ci avviciniamo.” “Siamo ancora a venti, trenta chilometri di distanza… non sappiamo un cazzo di come stanno le cose ad Atlanta.” “Non lo so, Philly.” “Ti dico cosa faccio” dice Philip. “Vado a dare un’occhiata.” “Che intendi dire?” Philip prende la pistola. “Vado solo a dare un’occhiata.” “Aspetta!” grida Brian. “Dai, Philip. Dobbiamo restare uniti.” “Voglio solo vedere com’è messo il terreno, per capire se possiamo passare.” “Papà…” Penny comincia a dire qualcosa, ma ci ripensa. “Va tutto bene, pulcino, torno subito.” Brian guarda fuori dal finestrino, non del tutto convinto. “Eravamo d’accordo che saremmo rimasti insieme. A qualsiasi costo. Dai, fratello.” “Ci metto due minuti.” Philip apre lo sportello e si infila la Ruger nella cintura. L’aria fredda, il suono crepitante delle fiamme, l’odore di ozono e di gomma che brucia si diffondono dentro la Suburban come ospiti non invitati. “Voi, ragazzi, restate qui, io torno subito.” Philip esce dalla macchina. La portiera sbatte. Brian resta seduto nella Suburban silenziosa per un istante, in ascolto del battito del suo cuore. Nick guarda da tutti i finestrini e controlla le immediate vicinanze, che sono vive di ombre tremolanti. Penny è immobile. Brian la guarda. La bambina sembra essersi ritirata, come un piccolo fiore notturno, che si contrae, richiudendo i petali. “Torna subito, piccola” la rassicura Brian. Gli dispiace per lei. Non è giusto che una bambina sia costretta a sopportare tutto questo e, in un certo senso, Brian può capire come si sente. “È un duro, Philip. Può riempire di botte ogni mostro che incontra, credimi.” Dal sedile davanti Nick si volta e dice: “Da’ retta a tuo zio, tesoro. Ha ragione. Il tuo papà sa prendersi cura di se stesso e anche degli altri”. “Una volta l’ho visto catturare un cane rabbioso” dice Brian. “Avrà avuto diciannove anni e c’era questo pastore tedesco che terrorizzava i bambini del vicinato.” “Me lo ricordo” conferma Nick. “Tuo padre ha dato la caccia a quella bestia con la bocca schiumante e tutto il resto, inseguendola lungo il letto di un torrente asciutto, e ha chiuso quella dannata cosa in una pattumiera.” “Me lo ricordo benissimo” dice Nick. “L’ha preso a mani nude, l’ha fatto volare per metà del canale prima di coprirlo con la pattumiera come se fosse una mosca.” Brian si allunga e con tenerezza sposta una ciocca di capelli dal viso della bambina. “Starà bene, tesoro… credimi. È un muchacho duro.” All’esterno, un pezzo di rottame in fiamme cade a terra. Il clangore fa sobbalzare tutti. Nick guarda Brian. “Ehi, amico… ti dispiacerebbe prendere quella sacca là dietro, sopra il parafango?” Brian lo guarda. “Cosa ti serve?” “Uno di quei fucili a pallettoni.” Brian lo fissa per un istante, poi si volta e si china sopra il poggiatesta posteriore. Estrae la lunga borsa di tela incastrata in mezzo a un frigo da campeggio e a uno zaino. La apre e prende un Marlin 55. Porge il fucile attraverso il sedile posteriore a Nick, che è su quello davanti, e chiede: “Ti servono anche le cartucce?”. “Penso che sia già carico” risponde Nick, sbloccando la canna e guardando dentro la culatta. Nick è pratico del fucile, probabilmente prima andava a caccia, sebbene Brian non l’abbia mai visto. Brian non è mai stato tipo da partecipare ai divertimenti virili del fratello minore e dei suoi compari, per quanto segretamente lo agognasse. “Due cartucce in canna” constata Nick, richiudendo il fucile con uno scatto. “Sta’ attento con quell’affare” dice Brian. “Un tempo andavo a caccia di porci con uno di questi piccoli” dice Nick, sollevandolo e puntandolo. “Porci?” “Sì… cinghiali… nella riserva di Chattahoochee. Di solito ci andavo di notte con mio padre e mio zio Verne.” “E li chiami maiali?” dice Brian incredulo. “Già, in fondo un cinghiale non è altro che un grosso maiale. Forse sono più antichi. Non…” Un altro rumoroso schianto metallico risuona fuori dal finestrino di Nick, che punta la canna verso il rumore, con il dito sul grilletto e i denti digrignati per la tensione nervosa. Fuori non si muove nulla. Nella Suburban, i muscoli si rilassano e Nick si lascia sfuggire un lungo sospiro di sollievo. Brian comincia a dire: “Dobbiamo rimetterci in marcia prima che…”. Un altro rumore. Stavolta proviene dal lato del guidatore, uno strascicare di piedi… …e prima che Nick possa anche solo registrare l’identità della tenebrosa figura che si avvicina allo sportello del guidatore della Suburban, ruota la canna del Marlin verso il finestrino e prende la mira con l’intenzione di spedire un paio di biglietti d’auguri calibro ventidue, quando una voce familiare tuona da fuori. “GESÙ CRISTO!” Per un istante Philip è visibile fuori dal finestrino, prima che si chini per togliersi dalla linea di tiro. “Oddio, scusa, scusa” dice Nick, riconoscendo subito il suo errore. La voce di Philip è più bassa adesso, più controllata, ma ancora carica di rabbia. “Punteresti quell’affare lontano dal fottuto finestrino?” Nick abbassa la canna. “Scusami, Philly, colpa mia, scusa.” Lo sportello si apre e Philip rientra in macchina, col respiro pesante e la faccia lucida di sudore. Chiude lo sportello e fa un lungo respiro. “Nick…” “Philly, mi dispiace… sono un po’ nervoso.” Per un istante Philip sembra voler staccare la testa dell’amico con le sue stesse mani, poi la collera si spegne. “Siamo tutti un po’ nervosi… è vero.” “Mi dispiace da morire.” “Vedi solo di stare più attento.” “Lo farò, lo farò.” Brian interviene. “Cos’hai trovato là fuori?” Philip afferra la leva del cambio. “Una via d’uscita da questo dannato casino.” Inserisce la guida a quattro ruote motrici e abbassa la leva. “Reggetevi forte.” Gira il volante e passano piano sopra una distesa di vetri rotti. Le schegge si schiantano sotto le enormi ruote della Suburban e nessuno dice niente, ma Brian pensa al potenziale rischio per dei pneumatici lisci. Philip dirige il veicolo sopra lo spartitraffico centrale, un canale poco profondo fitto di vegetazione e di erbacce varie, e le ruote posteriori scavano nella terra già piena di solchi. Mentre si avvicinano all’altra carreggiata, Philip dà ancora un po’ di gas e la Suburban scatta in avanti e attraversa le corsie a est. Philip tiene le mani incollate al volante. “Tenetevi!” avverte, mentre cominciano improvvisamente a scendere giù per un pendio coperto di erbacce fangose. La Suburban si inclina di lato come una nave che affonda. Brian si aggrappa a Penny e Nick al bracciolo centrale. Philip gira il volante e schiaccia l’acceleratore. Il veicolo sbanda verso uno stretto passaggio in mezzo al tamponamento. I rami degli alberi graffiano le fiancate del SUV. Le ruote posteriori slittano, ma poi fanno presa nel fango. Philip lotta col volante. Tutti gli altri trattengono il respiro, mentre la Suburban attraversa il varco graffiandosi. Quando emerge dall’altro lato, risuona un “evviva” spontaneo. Nick dà una pacca sulla schiena a Philip, e Brian grida e ulula trionfante. Anche Penny sembra illuminarsi un po’ e l’accenno di un sorriso le piega gli angoli delle labbra a forma di fiore. Attraverso il parabrezza riescono a scorgere il groviglio di macchine nel buio davanti a loro, almeno venti macchine, SUV e camion nelle corsie a ovest, la maggior parte dei quali danneggiati nel tamponamento. Sono stati abbandonati tutti e molti sono ormai niente più che carcasse bruciate. La fila dei veicoli vuoti si allunga per almeno un centinaio di metri. Philip preme il pedale a tavoletta per dirigere il SUV verso la strada. Strattona il volante. La parte posteriore dell’auto sobbalza e gira a vuoto. Qualcosa non va. Brian percepisce la perdita di trazione sotto di loro come un ronzio nella spina dorsale; all’improvviso il motore va su di giri. L’entusiasmo muore. La macchina si blocca. Per un momento, Philip mantiene il pedale a tavoletta, spingendosi in avanti con le natiche, come se la sua sola forza di volontà, la rabbia incandescente e i muscoli dello sfintere serrati possano costringere quella dannata cosa a muoversi. Ma la Suburban continua a scivolare su un fianco. Ben presto spinge con tutte e quattro le ruote motrici, schizzando due getti di fango nell’oscurità illuminata dalla luna che hanno alle spalle. “CAZZO! CAZZO! CAZZO! CAZZO!” Philip colpisce il volante con un pugno, abbastanza forte da creparlo, e riceve in cambio una fitta di dolore su per il braccio. Spinge il piede fin quasi ad attraversare il pavimento e il motore ulula. “Dai meno gas, amico!” grida Nick sopra il rumore. “Così c’impantaniamo ancora di più!” “CAZZO!” Philip riduce il gas. Il motore rallenta, la Suburban si piega su un fianco, come una barca che affonda nell’acqua salmastra. “Dobbiamo spingerla per tirarla fuori” dice Brian, dopo un momento di silenzio teso. “Prendi il volante” dice Philip a Nick, aprendo il suo sportello e uscendo. “Dai gas quando te lo dico io. Vieni, Brian.” Brian apre lo sportello sul retro, esce e si unisce al fratello nel bagliore delle luci di coda. Le ruote posteriori hanno scavato almeno quindici centimetri nella melma oleosa ed entrambi i parafanghi posteriori sono sporchi di fango. Le ruote anteriori non sono in condizioni migliori. Philip piazza le mani grosse e nodose sul pannello di legno del portellone posteriore e Brian si piazza dall’altro lato, a gambe larghe per stare più in equilibrio. Nessuno dei due nota le sagome scure che caracollano fuori dagli alberi dall’altro lato dell’autostrada. “Okay, Nick, ora!” dice Philip e spinge con tutta la sua forza. Il motore ruggisce. Le ruote girano a vuoto, sputando fontane di fango, mentre i fratelli Blake continuano a spingere. Spingono con tutta la forza che hanno in corpo, ma ogni sforzo è vano; e intanto le figure dietro di loro si avvicinano barcollando lente. “Ancora!” grida Philip, spingendo con tutto il suo peso. Le ruote posteriori affondando ancora di più nel pantano, schizzando addosso a Brian un aerosol di fango. Dietro di lui, gli ospiti non invitati si muovono attraverso un banco di nebbia fatto di fumo e di ombre: sono ormai a meno di cinquanta metri e scricchiolano sui vetri rotti coi movimenti lenti, svogliati e impacciati di lucertole ferite. “Torna in macchina, Brian.” La voce di Philip è cambiata di colpo: si è fatta bassa e ferma. “Subito.” “Cosa c’è?” “Fallo e basta.” Philip apre il baule facendo cigolare i cardini e allunga la mano in cerca di qualcosa. “Non fare domande.” “Ma che ne…” Brian si interrompe con le parole che gli muoiono in gola mentre con la visione periferica intravede almeno una dozzina, o forse più, di tenebrose figure che si avvicinano da varie direzioni. SEI Le figure si avvicinano attraversando lo spartitraffico, da dietro i rottami fiammeggianti del tamponamento e dal bosco adiacente: sono di tutte le forme e di tutte le taglie; hanno le facce del colore dello stucco, e occhi che scintillano come biglie alla luce del fuoco. Alcuni sono ustionati. Alcuni col corpo a brandelli. Alcuni sono ben vestiti e sembrano appena usciti dalla chiesa. La maggior parte ha le labbra ricurve e gli incisivi scoperti, tipici di chi è tormentato da una fame insaziabile. “Merda.” Brian guarda suo fratello. “Cosa vorresti fare? Cosa pensi di fare?” “Porta il tuo culo in macchina, Brian.” “Merda… merda!” Brian corre verso lo sportello, lo spalanca e si getta dentro accanto a Penny, che si guarda intorno con un’espressione confusa. Brian sbatte la portiera e blocca la serratura abbassando il pulsante con un pugno. “Chiudi gli sportelli, Nick.” “Vado ad aiutarlo…” Nick prende il fucile a pallettoni e apre lo sportello, ma si ferma di colpo quando sente lo strano suono della voce fredda, piatta e metallica di Philip che giunge dal bagagliaio aperto. “Ci penso io. Fa’ quello che dice lui, Nick. Chiudi gli sportelli e resta giù.” “Ce ne sono troppi!” Nick tamburella coi pollici sul Marlin, con la gamba destra già fuori dall’abitacolo e lo stivale da lavoro posato sul manto stradale. “Resta in macchina, Nick.” Philip estrae un paio di accette per spaccare la legna. Le ha trovate alcuni giorni prima nel capanno in giardino di una villa di Wiltshire Estates, due attrezzi ben fatti, bilanciati e con le lame di acciaio al carbonio affilate; quando le ha viste si è chiesto cosa potesse mai farsene uno di quei ricconi (che probabilmente pagava un giardiniere per spaccargli la legna da ardere) di un paio di arnesi del genere. Sul sedile anteriore, Nick ritira la gamba dentro il SUV, sbatte lo sportello e chiude la serratura con un pugno. Si volta con gli occhi fiammeggianti e il fucile tra le braccia, appoggiato alla spalla. “Ma che diavolo? Che vuoi fare, Philly?” Il bagagliaio sbatte. All’interno cala il silenzio. Brian abbassa lo sguardo sulla bambina. “Forse è meglio se ti stendi giù, piccola.” Penny non dice niente mentre scivola giù dal sedile e si accuccia in posizione fetale. Qualcosa nella sua espressione, un qualche accenno di consapevolezza nei suoi occhi dolci, tocca Brian e gli fa stringere il cuore. Le dà una pacca sulla spalla. “Ce la caveremo.” Brian si volta e guarda fuori, oltre il sedile e i bagagli, attraverso il lunotto posteriore. Philip tiene un’accetta in ogni mano e cammina con passo calmo verso la massa di zombie che converge su di lui. “Gesù” mormora Brian piano. “Che vuole fare, Brian?” La voce di Nick è acuta e tesa, le sue mani accarezzano l’otturatore del Marlin. Brian non riesce a mettere insieme una risposta, rapito com’è dalla terribile vista di quello che accade fuori. Non è bello. Non è aggraziato o fico o eroico o virile o anche solo ben eseguito… ma gli sembra giusto. “Ci penso io” dice Philip a se stesso, sottovoce, mentre attacca il più vicino, un uomo grasso vestito di una salopette da contadino. L’accetta taglia un pezzo delle dimensioni di un pompelmo dalla testa del ciccione, schizzando un geyser di materia rosa nel cielo notturno. Lo zombie cade. Ma Philip non si ferma. Prima che quello seguente gli si possa avvicinare, Philip si mette al lavoro sul grosso corpo flaccido caduto a terra, mulinando il freddo acciaio che tiene in entrambe le mani sulla carne morta. “Mia è la vendetta e io ripagherò, dice il Signore.” Sangue e tessuti schizzano come getti di fontane. Scintille si sprigionano dal manto stradale a ogni colpo. “Ci penso io, ci penso io, ci penso io” mormora Philip senza rivolgersi a nessuno in particolare e sfogando tutta la rabbia repressa e il dolore in una furia di colpi imprecisi. “Ci penso io, ci penso io, ci penso io, ci penso io, ci penso io…” Gli altri sono ormai vicini, una giovane donna magra con un fluido nero che le cola dalle labbra, una donna grassa con una faccia morta e gonfia, un tizio in un completo insanguinato… e Philip si stacca dal cadavere straziato sul terreno per andarsi a occupare anche di loro. A ogni colpo grugnisce… CI PENSO IO! …e spacca crani… CI PENSO IO! …recide arterie carotidee… CI PENSO IO! …lascia che la rabbia guidi il gelido acciaio attraverso cartilagini, ossa e cavità nasali… CI PENSO IO! …il sangue e la materia cerebrale gli coprono il volto mentre si ricorda della bocca schiumante e piena di zanne rabbiose che era venuta verso di lui quando era ragazzo e pensa a Dio che aveva preso sua moglie Sarah e ai mostri che si erano presi il suo migliore amico, Bobby Marsh… CI PENSO IO! CI PENSO IO! CI PENSO IO! Dentro la Suburban, Brian distoglie gli occhi dalla scena, tossisce e sente lo stomaco salirgli in gola per via dei nauseabondi rumori che penetrano nell’abitacolo sigillato. Trattiene l’impulso di vomitare. Si abbassa e posa le mani gentili sulle orecchie di Penny, in un gesto che è ormai diventato una triste routine. Sul sedile davanti Nick non riesce a distogliere gli occhi dal massacro. Sulla sua faccia, Brian riesce a vedere uno strano misto di repulsione e ammirazione, un tipo di meraviglia del genere “grazie a Dio è dalla nostra parte”, ma la cosa serve solo a chiudere lo stomaco di Brian. Non vomiterà, dannazione, sarà forte per Penny. Brian scivola giù e stringe a sé la bambina, che è debole e umida. La mente di Brian turbina per la confusione. Suo fratello è tutto per lui. È la soluzione di tutti i problemi. Ma gli sta succedendo qualcosa di orribile e questo comincia a preoccupare Brian. Quali sono le regole? Quegli abomini ambulanti meritano ogni fottuta cosa che Philip gli fa… ma quali sono le regole del gioco? Brian cerca di scacciare quei pensieri dalla mente quando si accorge che i rumori delle uccisioni sono cessati. Poi sente il passo pesante degli stivali di una persona fuori dalla parte del guidatore. La portiera scatta. Philip Blake rientra nella Suburban, lasciando cadere le accette insanguinate sul pavimento davanti a Nick. “Ne verranno degli altri” dice ansimante, con il volto imperlato di sudore. “Lo sparo li ha risvegliati.” Nick continua a guardare dal lunotto il campo di battaglia lastricato di cadaveri e visibile grazie alla luce del fuoco sul pendio; la sua voce esce in tono monocorde, una combinazione di meraviglia e disgusto: “Fuoricampo, amico… un fuoricampo a basi occupate”. “Dobbiamo andarcene” dice Philip; si asciuga una perla di sudore dal naso, riprende fiato e alza lo sguardo verso lo specchietto retrovisore, a cercare Penny nelle ombre del sedile posteriore, come se non avesse nemmeno sentito le parole di Nick. Brian interviene. “Qual è il piano, Philip?” “Dobbiamo trovare un posto sicuro dove passare la notte.” Nick lo guarda. “Cosa vuoi dire di preciso? Intendi oltre alla Suburban?” “Là fuori è troppo pericoloso col buio.” “Sì, ma…” “La tireremo fuori dal fango domattina.” “Sì, ma che ne…” “Prendete tutto quello che vi serve per la notte” dice Philip, afferrando la Ruger. “Aspetta!” Nick lo afferra per un braccio. “Vuoi dire che abbandoniamo la macchina e lasciamo tutta la nostra roba qui?” “Solo per stanotte” dice Philip, che apre lo sportello ed esce. Brian si lascia sfuggire un sospiro e alza lo sguardo su Nick. “Sta’ zitto e aiutami a prendere gli zaini.” Quella notte si accampano a circa cinquecento metri dall’autocisterna rovesciata, dentro uno scuolabus giallo abbandonato in un’area di sosta ben illuminata dal bagliore freddo di una lampada al sodio. L’autobus è ancora bello caldo e asciutto, ed è abbastanza alto da fornire un’ottima visuale sui boschi ai due lati dell’autostrada. Dispone di due porte, una sul davanti e una sul retro, che facilitano la fuga. Inoltre i sedili sono imbottiti e lunghi quanto basta perché tutti possano stendersi e cercare una parvenza di riposo. Le chiavi sono ancora nell’accensione e la batteria è carica. L’interno dell’autobus sa di vecchio cestino per il pranzo: l’odore del corpo dei bambini sudati, chiassosi e con i loro guanti corti e umidi, è un fantasma che aleggia nell’aria stantia. Mangiano un po’ di carne in scatola, qualche sardina e costosi cracker messicani, probabilmente destinati ai vassoi delle feste del golf club. Usano le torce elettriche, attenti a non farle risplendere fuori dai finestrini e alla fine stendono i sacchi a pelo sui sedili allungati per schiacciare un pisolino o sperimentare almeno un facsimile di sonno. Tutti fanno il loro turno di guardia sul sedile del guidatore, con un Marlin, usando i grandi specchi retrovisori laterali per avere una visuale sgombra sulla parte posteriore dell’autobus. Nick fa il primo turno e per quasi un’ora cerca invano di captare qualche stazione sulla sua radio portatile d’emergenza. Il mondo si è spento, ma almeno questa parte dell’Interstate 20 è altrettanto tranquilla. Il limitare del bosco resta silenzioso. Quando arriva il suo turno, Brian è riuscito a dormire solo pochi minuti di sonno agitato sopra un sedile cigolante in fondo al veicolo e prende volentieri posto nella cabina con tutte le leve, dove c’è il deodorante al profumo di pino selvatico che penzola e la fotografia laminata del piccolo figlio di un autista che ormai se n’è andato da un pezzo. Non che Brian sia particolarmente entusiasta alla prospettiva di essere l’unico sveglio o magari di essere costretto a sparare col fucile a pallettoni. Eppure ha bisogno di un po’ di tempo per pensare. A un certo punto, proprio prima dell’alba, Brian sente che il respiro di Penny, a malapena udibile sopra il fischio del vento attraverso le file di finestrini scorrevoli, si fa più irregolare e affaticato. La bambina sta sonnecchiando a pochi sedili di distanza dal posto di guida, vicino a suo padre. Poi si mette a sedere con un rantolo silenzioso. “Oh… ci penso io… cioè…” La voce della bambina è un sussurro. “Ci penso io, credo.” “Ssshhh” dice Brian, alzandosi dal sedile e strisciando lungo la cabina verso la bambina; poi le mormora: “Va tutto bene, piccola… lo zio Brian è qui”. “Uhm.” “Va tutto bene… ssshhhh… non svegliamo il tuo papà.” Brian guarda verso Philip, che è avvolto in una coperta, con la faccia contorta da sogni tormentati. Ha bevuto un quarto di bottiglia di brandy prima di crollare sfinito. “Sto bene” borbotta Penny nella sua vocina da topolino, guardando il pinguino di pezza che tiene tra le mani e che stringe come un talismano. Il pupazzo è sporco e logoro e quella vista spezza il cuore di Brian. “Brutti sogni?” Penny annuisce. Brian la guarda e riflette. “Ho un’idea” sussurra. “Perché non vieni qui e non mi fai compagnia per un po’?” La bambina annuisce. La aiuta ad alzarsi, poi, avvolgendole una coperta sulle spalle e prendendole la mano, la guida in silenzio lungo la cabina per tornare al suo posto. Abbassa un piccolo sedile a scomparsa accanto al posto del guidatore e dice: “Eccoci qua”. Batte una mano sull’imbottitura consumata. “Puoi fare il mio copilota.” Penny si sistema sul sedile con la coperta stretta attorno a lei e al pinguino. “Vedi?” Brian le indica un piccolo monitor sporco sopra il cruscotto, delle dimensioni di un libro tascabile, su cui una granulosa immagine in bianco e nero mostra l’autostrada dietro di loro. Il vento fruscia tra gli alberi e le luci al sodio si riflettono sui tettucci delle macchine distrutte. “È una telecamera di sicurezza, per fare retromarcia, la vedi?” La bambina la vede. “Siamo al sicuro qui, piccola” dice Brian cercando di suonare più convincente possibile. Prima, durante il suo turno, ha trovato il modo di girare la chiave di avviamento in posizione accessori e il cruscotto si è acceso come un vecchio flipper. “È tutto sotto controllo.” La bambina annuisce. “Vuoi parlarne?” dice dolcemente Brian un attimo dopo. Penny sembra confusa. “Di cosa?” “Il brutto sogno. A volte aiuta… dirlo a qualcuno… sai? Li fa andare via… puff.” Penny gli rivolge una lieve scrollata di spalle. “Ho sognato di stare male.” “Male come… quelle persone là fuori?” “Sì.” Brian prende un respiro lungo, profondo e angosciato. “Ascoltami, piccola. Qualsiasi cosa abbiano quelle persone, tu non la prenderai. Hai capito? Tuo padre non lo permetterà, nemmeno fra un milione di anni. Io non lo permetterò.” Lei annuisce. “Tu sei molto importante per tuo padre. Sei molto importante per me.” Brian avverte un groppo inaspettato nel petto, un sussulto alle sue stesse parole e una sensazione bruciante agli occhi. Per la prima volta, da quando ha lasciato la casa dei suoi genitori una decina di giorni prima, ha realizzato quanto siano profondi i sentimenti che nutre per quella bambina. “Ho un’idea” dice lui dopo aver ripreso il controllo delle sue emozioni. “Sai cos’è una parola d’ordine?” Penny lo guarda. “Come un codice segreto?” “Esatto.” Brian si lecca il dito e le pulisce una macchia di sporco dalla guancia. “Tu e io avremo una parola d’ordine segreta.” “Okay.” “È un codice molto speciale. Okay? Da adesso in poi, ogni volta che dico la parola segreta, voglio che tu faccia una cosa per me. Puoi farlo? Puoi, per esempio, ricordarti di fare una cosa per me ogni volta che ti dico la parola d’ordine segreta?” “Sicuro… credo.” “Quando dico la parola d’ordine, voglio che tu chiuda gli occhi.” “Chiudere gli occhi?” “Sì. E copriti le orecchie. Finché non ti dico che puoi guardare. D’accordo? E c’è anche un’altra cosa.” “Okay.” “Ogni volta che ti dico la parola d’ordine segreta… voglio che ti ricordi qualcosa.” “Cosa?” “Voglio che ti ricordi che verrà un giorno che non dovrai più chiudere gli occhi. Verrà un giorno in cui tutto andrà meglio e non ci saranno più persone malate. Capito?” Lei annuisce. “Capito.” “Quindi quale sarà la parola?” “Devo sceglierla io?” “Puoi scommetterci… è il tuo codice segreto… devi sceglierlo tu.” Penny arriccia il naso mentre riflette sulla parola giusta. Alla vista della bambina tutta intenta a rimuginare come se calcolasse il teorema di Pitagora, Brian si sente schiacciare il cuore. Alla fine Penny alza lo sguardo su di lui e, per la prima volta da quando l’epidemia è cominciata, un bagliore di speranza si accende nei suoi occhi enormi. “Trovata.” Sussurra la parola al suo animale di pezza, poi alza lo sguardo. “A Pinguino piace.” “Grande… non tenermi sulle spine.” “Lontano” dice lei. “La parola d’ordine segreta sarà lontano.” L’alba grigia arriva per gradi. Prima, una calma inquietante cala sull’autostrada e il vento tra gli alberi si placa; poi una luminosità pallida brilla lungo i confini della foresta, svegliandoli tutti e mettendoli in movimento. Il senso di urgenza è quasi immediato. Si sentono nudi e indifesi senza il loro veicolo e si concentrano tutti sul compito che li attende: fare i bagagli, tornare alla Suburban ed estrarre quel dannato affare dal fango. Ripercorrono i cinquecento metri che li separano dal SUV in quindici minuti, portando sacchi a pelo e cibo negli zaini. Incontrano un unico zombie sulla strada, una ragazzina errante e Philip la fa fuori senza problemi, in modo rapido e silenzioso aprendole un solco nel cranio, mentre Brian sussurra la parola d’ordine segreta a Penny. Quando raggiungono la Suburban, si mettono al lavoro in silenzio, sempre consapevoli delle ombre presenti nel bosco adiacente. All’inizio, provano ad aumentare il peso sul retro: Nick e Philip si posizionano sul portellone posteriore e Brian dà il gas dal sedile del guidatore mentre spinge con una gamba fuori dallo sportello. Non funziona. Allora, perlustrano le vicinanze in cerca di qualcosa da mettere sotto le ruote perché facciano trazione. Gli ci vuole un’ora, ma alla fine dissotterrano un paio di materassi sfondati lungo un canale di scolo e li portano indietro, incuneandoli sotto le ruote. Anche questo tentativo fallisce. Il fango sotto il SUV è troppo impregnato di umidità, fuoriuscite di liquidi, benzina e Dio solo sa cos’altro e continua a risucchiare il veicolo sempre più a fondo, facendolo scivolare all’indietro lungo il pendio. Ma il gruppo rifiuta di arrendersi. A guidarli sono l’ansia incessante alimentata dai misteriosi rumori di rami che si spezzano e di esplosioni sorde in lontananza che giungono dalla pineta adiacente e, insieme, il terrore inespresso di perdere tutti i loro beni terreni e le loro provviste con la Suburban che affonda: di fronte a questa prospettiva non hanno nessuna voglia di affrontare l’incombente disperazione della situazione. A metà pomeriggio, dopo aver lavorato per ore, essersi fermati per mangiare e poi essersi rimessi al lavoro per un altro paio d’ore, non sono riusciti a ottenere altro se non di far scivolare il SUV di quasi altri due metri lungo il pendio fangoso. Intanto Penny resta seduta dentro il veicolo e passa il tempo a giocare con Pinguino o a premere il viso imbronciato contro il finestrino. A quel punto, Philip esce dalla pozza di fango e guarda l’orizzonte a ovest. Il cielo nuvoloso ha cominciato la sua corsa verso il tramonto e, d’un tratto, la prospettiva del crepuscolo gli procura una stretta allo stomaco. Infangato e fradicio di sudore, prende una bandana e si asciuga il collo. Comincia a dire qualcosa, quando un’altra serie di rumori proveniente dagli alberi vicini attira la sua attenzione a sud. Da ore ormai i rumori secchi e crepitanti, forse passi, forse no, hanno preso a farsi più vicini. Nick e Brian, che si stanno ripulendo le mani con degli stracci, si uniscono a Philip. Per un momento nessuno dice niente. L’espressione di tutti riflette la dura realtà e quando un altro schianto si ode dal bosco, forte come un colpo di pistola, Nick dice: “È comparsa la scritta sul muro, vero? 2”. Philip rimette il fazzoletto in tasca. “Presto si farà notte.” “Che ne pensi, Philly?” “È ora del piano B.” Brian deglutisce a fondo, guardandolo. “Non sapevo che ci fosse un piano B.” Philip lo guarda e, per un attimo, prova un bizzarro misto di rabbia, pietà, impazienza e affetto. Poi guarda la vecchia Suburban arrugginita e avverte una punta di malinconia, come se stesse per dire addio a un altro vecchio amico. “C’è adesso.” Travasano la benzina della Suburban dentro le taniche di plastica che hanno preso a Wiltshire. Poi, sono abbastanza fortunati da trovare una grossa Buick LeSabre, ultimo modello, con le chiavi ancora infilate. È abbandonata sul lato della strada, a circa duecento metri a ovest. Se ne impadroniscono e tornano in fretta al SUV impantanato. Riempiono la Buick di benzina e trasferiscono quante più scorte riescono nel grosso bagagliaio della macchina. Poi partono verso il sole che tramonta, tutti con lo sguardo rivolto al SUV arenato, ormai lontano come il relitto di una nave che affonda nell’oblio. Indicazioni dell’apocalisse imminente appaiono su entrambi i lati dall’autostrada con allarmante frequenza. Mentre si avvicinano alla città, zigzagando con crescente difficoltà tra i rottami abbandonati, le macchie di alberi si assottigliano e cedono il posto a un numero sempre maggiore di quartieri residenziali, centri commerciali e parcheggi di uffici: i segni rivelatori della tragedia sono ovunque. Oltrepassano un Walmart buio e abbandonato, con le finestre rotte, un mare di vestiti e ogni genere di bene di consumo disseminato su tutto il parcheggio. Notano sempre più zone prive di elettricità, interi quartieri bui e silenziosi come tombe. Superano centri commerciali devastati dai saccheggi e avvertimenti biblici scarabocchiati su camini spenti. Vedono anche un piccolo aereo a elica, ancora fumante, incastrato in un gigantesco traliccio dell’elettricità. Da qualche parte tra Lithonia e Panthersville, la parte posteriore della Buick comincia a vibrare come una dannata e Philip si accorge che due ruote sono a terra. Forse erano già sgonfie quando hanno preso la macchina. Chi può saperlo? Ma non c’è tempo per cercare di sistemare quegli attrezzi infernali e non c’è tempo per discutere l’argomento. La notte sta per calare e più si avvicinano ai confini di Atlanta, più le strade sono intasate dalle carcasse di veicoli distrutti e da macchine abbandonate. Nessuno lo dice a voce alta, ma tutti hanno cominciato a chiedersi se farebbero prima ad arrivare in città muovendosi a piedi. Anche le vicine strade a due corsie, come Hillandale e Fairington, sono bloccate dalle macchine vuote, allineate come tessere di domino cadute nel mezzo della strada. A questa velocità, potrebbero impiegarci una settimana per entrare in città. E così Philip decide di lasciare la Buick dove si trova, caricare tutto quanto riescono e continuare a piedi. Nessuno è entusiasta di quell’idea, ma tutti acconsentono. L’alternativa di cercare pneumatici di ricambio o un veicolo di rimpiazzo tra le macchine bloccate nel traffico congelato nella profonda oscurità in cui sono immersi non sembra un’opzione praticabile. Estraggono in fretta le loro cose dal bagagliaio della Buick e stipano i borsoni e gli zaini di provviste, coperte, cibo, armi e acqua. Stanno diventando sempre più bravi a comunicare con sussurri, gesti delle mani e cenni, consapevoli come sono del distante ronzio prodotto dalle persone morte e dei rumori che crescono e diminuiscono d’intensità nelle tenebre al di là dell’autostrada, filtrando tra gli alberi e dietro i palazzi. Philip ha la schiena più forte e prende il borsone di tela più grosso. Nick e Brian si caricano entrambi di uno zaino stracolmo. Anche Penny accetta di portare uno zainetto pieno di biancheria. Philip prende la Ruger, le due accette, infilate ognuna su un lato della cintura, e un lungo arnese per tagliare le sterpaglie simile a un machete, che infila lungo la spina dorsale tra il borsone e la maglia di cotone sporca. Brian e Nick stringono ognuno un fucile Marlin 55 in mano e un piccone legato al fianco dei rispettivi zaini. Cominciano a camminare verso ovest, e stavolta nessuno si gira per guardarsi indietro. Cinquecento metri più avanti, incontrano un cavalcavia bloccato da una roulotte Airstream ammaccata. La cabina è accartocciata intorno a un palo del telefono. I lampioni sono tutti spenti e nella completa oscurità è possibile sentire il suono soffocato di colpi che proviene da dentro le pareti della roulotte danneggiata. La cosa li fa bloccare di colpo sul margine della strada sotto il viadotto.“Gesù, forse è qualcuno…” Brian si ferma vedendo che il fratello alza una mano. “Sssssshhh!” “Ma cosa facciamo se…” “Zitto!” Philip solleva la testa e si mette in ascolto. La sua espressione è quella di un gelido monumento di pietra. “Da questa parte, venite!” Philip guida il gruppo lungo un pendio roccioso sul bordo nord dello svincolo, poi tutti scendono cauti, attenti a non scivolare sul terreno coperto di ghiaia bagnata. Brian chiude il gruppo, chiedendosi di nuovo quali sono le regole e se hanno appena abbandonato un altro essere umano. I suoi pensieri tornano in fretta a focalizzarsi su questioni più importanti, mentre si inoltra nella campagna buia. Seguono una stretta strada asfaltata a due corsie chiamata Miller Road, diretti a nord. Per quasi due chilometri, non incontrano niente più di qualche zona poco commerciale di desolati parcheggi industriali e fonderie, coi loro cartelli misteriosi come geroglifici sulle pareti di una caverna: Barloworld Handling, Atlas Tool and Die, Hughes Supply, Simcast Electronics, Peachtree Steel. L’andatura ritmica dei loro passi sull’asfalto freddo si mischia al suono monotono del loro respiro. Il silenzio comincia a lavorare sui nervi. Penny è stanca. Sentono dei fruscii provenire dal bosco alla loro destra. Alla fine, Philip solleva una mano e indica una fabbrica che si estende bassa e tentacolare in lontananza. “Ecco il posto che fa per noi” dice con un sussurro in tono piatto. “Fa per cosa?” chiede Nick, fermandosi accanto a Philip, col fiatone. “Per la notte” dice Philip. La sua voce non lascia trapelare emozioni. Conduce il gruppo oltre un cartello basso e non illuminato che reca la scritta Georgia Pacific Corporation. Philip entra dalla finestra dell’ufficio. Ha fatto accucciare tutti nell’ombra accanto all’entrata, mentre si fa strada tra i corridoi vuoti e disordinati, verso il magazzino al centro dell’edificio. Il posto è buio come una cripta. Il battito del suo cuore gli risuona nelle orecchie mentre avanza con le accette lungo i fianchi. Prova invano ad accendere un interruttore della luce. Nota appena l’aroma pungente della polpa di legno che permea l’aria, un odore appiccicoso e dolciastro; quando raggiunge le porte di sicurezza, le apre piano con la punta dello stivale. Il magazzino è delle dimensioni di un hangar per aerei, con le gigantesche incastellature che pendono dall’alto, le file di enormi riflettori spenti, l’odore di carta ammuffita denso come talco. La debole luce lunare scintilla attraverso i lucernari enormi. Il pavimento è diviso in sezioni da file di enormi rotoli di carta, grandi come tronchi di sequoie, così bianchi da brillare nell’oscurità. Qualcosa si muove non molto lontano. Philip si infila le accette ai fianchi della cintura e afferra l’impugnatura della Ruger. Estrae la pistola, tira indietro la porta e solleva la canna verso una figura scura che esce barcollando da dietro una catasta di pallet. L’operaio attraversa lento l’ombra che lo separa da Philip, il davanti dei suoi pantaloni da lavoro è scuro di bile e sangue secco, la faccia oblunga e magra è fitta di denti che riflettono i raggi della luna. Un colpo abbatte la cosa morta e lo sparo risuona come un timpano nel magazzino cavernoso. Philip perlustra la parte che resta del magazzino. Ne trova un altro paio, un uomo grasso e anziano, un ex guardiano notturno, a giudicare dalla sua uniforme sporca, e uno più giovane, tutti e due impegnati a trascinarsi fuori da dietro alcune scaffalature. Philip non prova niente mentre li colpisce a bruciapelo alla testa. Sulla via del ritorno, verso l’entrata principale, ne scopre un quarto nell’ombra, intrappolato in mezzo a due imponenti rotoli di carta. La parte inferiore dell’ex manovratore di carrelli elevatori è infilata in mezzo ai cilindri di un bianco accecante, schiacciata al di là di ogni possibile riconoscimento: tutti i fluidi del corpo sono colati e si sono seccati sul pavimento di cemento sottostante. La metà superiore della creatura si contorce e si dimena; gli occhi duri e lattiginosi stupidamente svegli. “Che c’è, bubba 3?” dice Philip, avvicinandosi col fucile appoggiato al fianco. “Un altro giorno, un altro dollaro… eh?” Lo zombie azzanna impotente l’aria che separa la sua faccia da quella di Philip. “Sei in ritardo per la pausa pranzo?” CHOMP. “Mangia questo.” Lo sparo del calibro .22 echeggia mentre il proiettile attraversa l’orbita del manovratore di carrelli, gli annerisce l’occhio lattiginoso e fa volare in aria un pezzo dell’emisfero parietale. Lo spruzzo, un misto di sangue, tessuto e fluido cerebrospinale, imbratta le file di carta immacolata e la metà superiore della cosa morta si affloscia come uno spaghetto bagnato. Per un bel po’, prima di tornare dagli altri, Philip resta ad ammirare la sua opera d’arte: tentacoli scarlatti su campo bianco paradisiaco. SETTE Passano la notte nell’ufficio in vetro di un caporeparto, un posto sospeso sopra il pavimento del magazzino della Georgia Pacific. Usano le loro lampade a batteria, spostano le scrivanie e le sedie di lato e stendono i sacchi a pelo sulle piastrelle di linoleum. Il precedente occupante doveva aver vissuto in quel piccolo nido di sessanta metri quadri, perché ci sono CD, uno stereo, un forno a microonde, un piccolo frigorifero (il cibo che contiene è quasi tutto scaduto), cassetti colmi di barrette di cioccolato, ordini di servizio, bottiglie di liquore semivuote, materiale di cancelleria, magliette pulite, sigarette, matrici di assegni e riviste porno. Per tutta la notte, Philip si limita a dire poche parole. Resta seduto accanto alla finestra che sovrasta il pavimento del magazzino, bevendo di tanto in tanto un sorso di whisky dalla bottiglia trovata nella scrivania, mentre Nick siede sul pavimento nell’angolo opposto e legge in silenzio una piccola Bibbia della Concordanza alla luce di una lanterna. Nick sostiene di portarsi quel libretto rilegato in pelle e pieno di orecchie ovunque vada; ma raramente gli altri lo avevano visto leggerlo… fino a ora. Brian si costringe a mandar giù un po’ di cracker salati e del tonno, e cerca di far mangiare qualcosa a Penny, che però non vuole farlo. Sembra essersi chiusa in se stessa ancora di più: i suoi occhi mostrano sempre uno sguardo che a Brian sembra vagamente catatonico. Più tardi, Brian dorme accanto a lei, mentre Philip sonnecchia sulla poltrona girevole accanto all’unta finestra di vetro rinforzato attraverso la quale i vecchi capireparto avevano tenuto d’occhio i fannulloni. È la prima volta che Brian vede suo fratello così consumato dai suoi stessi pensieri da non dormire accanto a sua figlia, e la cosa non lascia presagire niente di buono. Il mattino dopo, si svegliano al rumore di un cane che abbaia da qualche, parte fuori dal magazzino. La luce, scialba e pallida, si riversa dalle alte finestre e il gruppo si affretta a fare i bagagli. Nessuno ha appetito, così usano il bagno, si fasciano i piedi per prevenire le vesciche e si mettono dei calzini extra. I talloni di Brian sono già rovinati dai pochi chilometri che hanno percorso e non c’è modo di prevedere quanta strada faranno quel giorno. Tutti dispongono di un cambio d’abiti, ma nessuno ha l’energia di mettersi addosso qualcosa di pulito. Uscendo, tutti, tranne Philip, evitano di proposito di guardare i corpi distesi nelle pozze di sangue nel magazzino. Philip sembra galvanizzato dalla vista dei cadaveri illuminati dalla luce del giorno. Fuori scoprono la fonte dei latrati. A meno di cento metri a ovest del magazzino, un branco di cani randagi, per lo più bastardi, si contendono qualcosa di rosa e dilaniato sul terreno. Quando Philip e gli altri si avvicinano, i cani si sparpagliano, lasciando l’oggetto delle loro attenzioni nel fango. Brian lo identifica mentre passano e impartisce sottovoce a Penny la parola d’ordine segreta: lontano. La cosa è un braccio umano amputato, masticato con tale furia da sembrare l’arto di una bambola di pezza bagnata. “Non guardare, pulcino” mormora Philip a sua figlia e Brian tira Penny accanto a sé, coprendole gli occhi. Si incamminano a fatica verso ovest, muovendosi in silenzio, coi passi furtivi e cauti di un ladro sorpreso dal sole del mattino. Seguono una strada chiamata Snapfinger Drive, che corre parallela all’autostrada. Il nastro d’asfalto si stende lungo brulle riserve forestali, quartieri residenziali abbandonati e centri commerciali saccheggiati. Mentre attraversano aree sempre più popolate, il ciglio della strada mostra orrori che nessuna bambina dovrebbe vedere. Il campo da football di un liceo è disseminato di torsi senza testa. Un’impresa di pompe funebri è stata frettolosamente sbarrata dall’esterno con tavole e chiodi e lascia trapelare gli orribili rumori soffocati dei risorti che graffiano e artigliano le porte per uscire. Philip cerca con fervore un veicolo adatto di cui appropriarsi ma la maggior parte delle automobili lungo la strada giacciono nei fossi come se fossero delle bucce bruciate, o sul lato ghiaioso della carreggiata con due o tre ruote scoppiate. I semafori, la gran parte dei quali o lampeggia di giallo o è del tutto spenta, pendono sopra gli incroci intasati. L’autostrada, visibile da sopra un crinale a un centinaio di metri alla loro sinistra, brulica di morti. Ogni tanto i resti laceri di una persona attraversano i lontani e pallidi raggi del sole crescente e Philip segnala a tutti di buttarsi a terra e stare in silenzio. Eppure, malgrado la difficoltà di doversi nascondere dietro gli alberi o i rottami ogni volta che percepiscono un’altra presenza nelle vicinanze, riescono a percorrere una buona quantità di terreno quel giorno. Non incontrano altri sopravvissuti. Più tardi, quel pomeriggio, il tempo torna, ironia della sorte, a essere limpido e soleggiato, un bel pomeriggio di inizio autunno in qualsiasi altro contesto, con la temperatura intorno ai sedici gradi. Alle cinque, gli uomini sudano e Penny si è legata la felpa attorno alla vita. Philip calcola i progressi fatti e, sottraendo una pausa di trenta minuti per il pranzo, presume che abbiano percorso in media un paio di chilometri all’ora e abbiano attraversato quasi dodici chilometri di giungla suburbana. Ma nessuno riesce ancora a capire quanto siano vicini alla città finché non risalgono un dosso fangoso e si ritrovano fuori dai pini proprio a ovest di Glenwood, dove una chiesa battista svetta in cima a un crinale, bruciata da un incendio recente e con il campanile ormai ridotto a una rovina fumante. Esausti, sfiniti e affamati, risalgono la strada tortuosa verso la cima della collina e quando arrivano nel parcheggio della chiesa, si fermano per un momento, guardando l’orizzonte a ovest, paralizzati da una sorta di inaspettata meraviglia. Lo skyline, a soli cinque chilometri di distanza, sembra quasi brillare nella luce che langue. Per essere dei ragazzi cresciuti a trecento chilometri dalla grande capitale del Nuovo Sud, Philip e Brian Blake avevano trascorso ben poco tempo ad Atlanta. Per i due anni e mezzo in cui aveva guidato camion per la Harlo Electric, Philip ci era capitato occasionalmente per fare delle consegne. E Brian aveva visto la sua parte di concerti al Civic Center, al The Earl, al Georgia Dome e al Fox Theater. Ma nessuno dei due conosce bene la città. Mentre rimangono nel parcheggio della chiesa, con la puzza acre dell’apocalisse nelle narici, lo skyline si staglia lontano nella foschia con una sorta di bellezza irraggiungibile. In quella luce sognante scorgono la cima del Campidoglio con la sua cupola rivestita d’oro, i monoliti a specchio del Concourse Complex, le imponenti torri del Peachtree Plaza e il pinnacolo dell’Atlantic Building, ma tutto ha l’aria di un miraggio, di una specie di città perduta come Atlantide. Brian sta per dire qualcosa riguardo al posto, che è così vicino eppure così lontano, o forse intende commentare le imprevedibili condizioni delle strade sotto di loro, quando percepisce un movimento con la coda dell’occhio. “Guardate!” Penny scappa via, in maniera inaspettata e repentina, con la voce stridula per l’eccitazione. “PENNY!” Brian comincia a inseguire la bimba, diretta a rotta di collo verso il margine ovest del parcheggio. “PRENDILA!” grida Philip, scattando dopo Brian, che corre dietro alla bambina. “Guardate! Guardate!” Le piccole gambe di Penny si muovono frenetiche verso una strada laterale, che gira verso la parte più lontana della collina. “È un poliziotto!” Lo indica mentre corre. “Ci salverà!” “PENNY, FERMATI!” La bambina corre attorno alla sbarra del cancello e giù lungo la strada laterale. “Ci salverà!” Brian balza oltre il bordo del recinto a tutta velocità e vede un’autopattuglia a circa cinquanta metri di distanza, parcheggiata sul lato della strada sotto una quercia gigantesca. Penny si avvicina alla Crown Victoria blu, con la decalcomania della Polizia di Atlanta sulla portiera, la tipica striscia rossa e la barra delle sirene montata sul tetto. C’è una sagoma piegata davanti al volante. “Fermati, tesoro!” Brian vede che Penny, ansimante per la fatica, si ferma all’improvviso fuori dallo sportello del guidatore e fissa l’uomo al volante. A questo punto, Philip e Nick hanno raggiunto Brian, e Philip supera di corsa suo fratello. Corre verso la sua bambina, sollevandola dal terreno come se dovesse portarla via da un incendio. Brian raggiunge l’autopattuglia e guarda dentro il finestrino semiaperto. Una volta il poliziotto era un uomo bianco, tarchiato e con le basette lunghe. Nessuno dice niente. Dalle braccia di suo padre, attraverso il finestrino, Penny fissa a bocca aperta il morto in uniforme che si sforza per liberarsi dalla cintura di sicurezza. Dall’aspetto del suo distintivo e dei suoi vestiti, come pure dalla parola TRAFFICO che spicca sul paraurti anteriore del veicolo, si intuisce che era stato un agente di basso livello, probabilmente assegnato alla periferia della città per far rimuovere qualche macchina sporadica e per farla portare nei depositi giudiziari lungo Fayetteville Road. Adesso l’uomo si gira sul sedile, imprigionato da una cintura di sicurezza, che non riesce a comprendere, e sbava a bocca aperta verso la carne fresca fuori dal finestrino. I lineamenti sono deformati e gonfi, del colore della muffa, gli occhi come monete arrugginite. Ringhia agli umani, aprendo e chiudendo di scatto i denti anneriti con feroce appetito. “Ecco una cosa davvero patetica” dice Philip a nessuno in particolare. “La prendo io” dice Brian, avvicinandosi e allungando le mani verso Penny. Il poliziotto morto sente l’odore del cibo e fa scattare le mascelle verso Brian, tirando la cintura e facendo scricchiolare la striscia di tessuto. Brian sobbalza all’indietro. “Non può farti niente” dice Philip con un tono che suona basso e indifferente in modo allarmante. “Non riesce nemmeno a liberarsi da quella dannata cintura.” “Vuoi scherzare” dice Nick, guardando da sopra la spalla di Philip. “Povero stupido figlio di puttana.” Il poliziotto morto ringhia. Penny si accuccia tra le braccia di Brian che indietreggia, tenendola stretta. “Dai, Philip, lascia perdere.” “Calma, amico, aspetta un minuto.” Philip estrae la .22 da dietro la schiena. “Dai, amico” interviene Nick. “Il rumore ne attirerà degli altri… andiamocene.” Philip punta la pistola sul poliziotto, che si immobilizza alla vista della bocca dell’arma. Ma Philip non preme il grilletto. Si limita a sorridere e a imitare il rumore di uno sparo con la bocca, come farebbe un bambino: “Psssh-pssshpssssh”. “Philip, andiamo” dice Brian, spostando il peso di Penny tra le braccia. “Quella cosa non ha nemmeno…” Brian si ferma e guarda. Il poliziotto morto è come paralizzato dalla vista della Ruger puntata sulla sua faccia. Brian si chiede se il suo rudimentale sistema nervoso centrale stia in qualche modo inviando un segnale a un lontano muscolo della memoria sepolto tra le cellule cerebrali morte. La sua espressione cambia. La faccia mostruosa crolla come un souffl é marcio e il morto vivente sembra quasi triste. O forse spaventato. È difficile stabilirlo dietro quella bocca bestiale spalancata in un ringhio e dietro la maschera di tessuto necrotico; eppure qualcosa guizza in quegli occhi grossi come nichelini: una traccia di terrore? Un’improvvisa ondata di emozione cresce dentro Brian Blake cogliendolo di sorpresa. È una sensazione indefinibile: in parte repulsione, in parte pietà, in parte disgusto, pena e rabbia. All’improvviso posa Penny e con gentilezza la fa girare per guardare la chiesa. “È il momento di andare lontano, piccola” dice dolcemente Brian, che poi si volta per affrontare suo fratello. Philip si prende gioco dello zombie. “Rilassati e guarda la palla” dice alla creatura sbavante, muovendo piano la canna avanti e indietro. “Lo faccio io” dice Brian. Philip si blocca. Si volta e lo guarda. “Cosa?” “Dammi la pistola, lo finisco io.” Philip guarda Nick e Nick guarda Brian. “Ehi, amico, non vuoi farlo dav…” “Dammi la pistola!” Il sorriso che contrae gli angoli della bocca di Philip è complesso e per niente divertito. “Accomodati, campione.” Brian prende la pistola e senza esitazione fa un passo avanti, la infila nella macchina, appoggia la canna sulla testa del poliziotto morto e comincia a stringere il grilletto per sparare quell’unico colpo… ma il suo dito non risponde. Il dito sul grilletto non obbedisce al comando che riceve dal cervello. In quella pausa imbarazzante lo zombie sbava come se aspettasse qualcosa. “Ridammela, campione.” La voce di Philip risuona lontanissima. “No… è mia.” Brian digrigna i denti e cerca di premere il grilletto, ma il suo dito è un blocco di ghiaccio. Gli occhi gli bruciano. Lo stomaco si chiude. Il poliziotto morto ringhia. Brian comincia a tremare mentre Philip fa un passo avanti. “Ridammi la pistola.” “No.” “Dai, campione, ridammela.” “Ce l’ho io!” Brian si pulisce gli occhi con la manica. “Dannazione, ce l’ho io!” “Muoviti.” Philip allunga la mano verso la pistola. “Ne ho abbastanza.” “Dio lo maledica” dice Brian, abbassando la pistola, con gli occhi luccicanti di lacrime. Non ci riesce: è una cosa con cui deve fare i conti. Rende la pistola al fratello e indietreggia a testa bassa. Philip mette fine alle sofferenze del poliziotto con un unico colpo che manda uno spruzzo di nebbia sanguinolenta contro il parabrezza dell’autopattuglia. Il latrato echeggia alto sul paesaggio in rovina. Il poliziotto morto si accascia sul volante. Passa un lungo momento durante il quale Brian lotta con le lacrime e cerca di non dare a vedere che sta tremando. Guarda i resti del poliziotto attraverso il finestrino. Si sente come se dovesse scusarsi con l’agente morto, ma decide di non farlo. Si limita a fissare il corpo affl osciato e tenuto al suo posto dalla cintura di sicurezza. Il suono debole della voce di una bambina, come un battito di ali spezzate, proviene da dietro di loro. “Papà… zio Brian… zio Nick? Ehm… sta succedendo qualcosa di brutto.” I tre uomini si voltano quasi nello stesso istante. I loro sguardi risalgono il parcheggio della chiesa, verso il punto indicato da Penny. “Figli di puttana” dice Philip, vedendo la peggiore delle ipotesi realizzarsi davanti ai suoi occhi. “Oh, mio Dio” dice Nick. “Merda, merda… merda!” Brian sente un brivido gelido corrergli lungo la spina dorsale mentre osserva la facciata della chiesa. “Forza, pulcino, da questa parte.” Philip va verso la bambina e la spinge con gentilezza verso l’autopattuglia. “Dobbiamo prendere in prestito la macchina di questo bravo poliziotto.” Si piega all’interno della portiera del guidatore, la sblocca, la spalanca, slaccia la cintura di sicurezza e spinge il corpo esanime fuori dal veicolo; lo zombie si distende sull’asfalto con il tonfo solenne di una zucca troppo matura. “Tutti dentro, svelti! Buttate dietro la vostra roba! E poi salite!” Brian e Nick aggirano la macchina, spalancano gli sportelli, gettano dentro gli zaini e salgono a bordo. Philip fa scivolare Penny sopra il bracciolo centrale, la sistema sul sedile del passeggero e prende posto dietro il volante. Le chiavi sono nell’accensione. Philip gira la chiave. Il motore strappa. Il cruscotto si illumina appena con un pallido guizzo di energia. “Dannazione! DANNAZIONE!” Philip guarda fuori dal finestrino verso la chiesa. “Okay. Aspettate un minuto. Aspettate… aspettate.” Getta una rapida occhiata al di là del parabrezza e vede che la strada davanti a loro si inclina in una ripida discesa e conduce a una strada che passa sotto un ponte ferroviario. Guarda Brian e Nick. “Voi due uscite. Subito!” Brian e Nick si guardano sbalorditi. Quel che vedono emergere dalla chiesa, molto probabilmente risvegliato dal trambusto delle loro voci e dal colpo di pistola, rimarrà impresso a fuoco nella loro memoria per molto tempo a venire. Purtroppo rimarrà scolpito anche nell’immaginazione di Penny, forse in modo ancora più vivido: cose morte si materializzano dai buchi aperti nei portali di vetro colorato e dalle entrate semiaperte; alcuni indossano ancora le vesti clericali strappate e insanguinate, altri i completi e gli abiti di crêpe della domenica ormai inzuppati di sangue. Alcuni rosicchiano appendici umane mutilate, altri si trascinano parti di corpi, gli organi ancora sgocciolanti della raccapricciante orgia tenutasi nella cappella. Sono almeno cinquanta, forse di più, e si muovono fianco a fianco con passo incerto verso la macchina della polizia. Per un unico istante, prima di scagliarsi fuori dallo sportello e unirsi a Nick fuori dalla macchina, Brian si ritrova a indugiare su un pensiero bizzarro: si muovono come un’unica entità… anche nella morte sono una congregazione unita… come le marionette di un grande burattinaio. Ma quel pensiero fugge rapido dalla sua mente, quando sente l’urlo del fratello da dietro il volante della macchina. “SPINGETE QUESTA FIGLIA DI PUTTANA CON TUTTA LA FORZA CHE AVETE IN CORPO E POI SALTATE SU!” Brian si unisce a Nick dietro la macchina e, senza fermarsi a pensarci, comincia a spingere. A questo punto Philip ha già messo la macchina in folle, ha aperto lo sportello, messo fuori una gamba e con lo stivale spinge la macchina con tutta la sua potenza. Gli occorrono alcuni istanti per guadagnare velocità mentre la massa dei fedeli dietro di loro si avvicina senza tregua abbandonando i suoi orripilanti tesori per la promessa di carne fresca. Ben presto la macchina scende rapida lungo la collina, sempre più veloce e Brian e Nick sono costretti a balzare a bordo. Nick afferra l’antenna sottile per reggersi. Brian si getta per metà dentro lo sportello posteriore sventolante, ma non riesce a tirare dentro il resto del corpo senza cadere, quindi si tiene saldo all’intelaiatura dello sportello. La macchina ha ormai disceso metà della collina, mettendo una buona distanza tra sé e le decine di non morti che la inseguono barcollando. Il veicolo, grazie al suo peso, persiste nel suo moto rettilineo. Sembra un treno lanciato a tutta velocità e urta il manto stradale crepato verso l’incrocio alla fine della collina. Il vento scompiglia i capelli neri di Brian che si tiene disperatamente aggrappato. Nick grida qualcosa, ma il rumore del vento e i tonfi delle ruote coprono la sua voce. In fondo alla collina c’è un defunto scambio ferroviario della Conrail, col suo dedalo di antichi binari fossilizzati nella terra della Georgia, con le rimesse sul punto di crollare e gli stabili degli uffici neri e putrefatti come rovine preistoriche. Philip urla qualcosa che Brian non riesce a sentire. Arrivano in fondo alla collina e il volante si blocca. L’autopattuglia sbatte sui binari e va a infilarsi nello scambio ferroviario. Philip non riesce a girare il volante. La macchina slitta. Le ruote scavano solchi nella cenere e la parte inferiore della carrozzeria sprigiona scintille sul ferro. Brian e Nick si tengono stretti mentre la vettura sbanda fino a fermarsi in una nuvola di polvere nera. “Prendete la vostra roba! Tutti! Subito!” Philip ha già aperto la sua portiera ed estrae Penny. Brian e Nick saltano giù dal retro e si uniscono a Philip, che si carica il borsone su una spalla e la figlia sull’altra. “Da questa parte!” Indica con un cenno una strada stretta a ovest. Corrono verso il nodo di scambio. Una fila di vetrine sbarrate con delle tavole e di edifici bruciati si stende lungo una strada selciata perpendicolare a quella da cui sono giunti. Si muovono veloci, restando sotto una fila di tende sul lato meridionale della via, le spalle che sfregano contro porte decorate di graffiti e finestre sporche di antiruggine. Il tramonto è vicino e le ombre si allungano, seppellendoli nell’oscurità. La sensazione di essere circondati li schiaccia, sebbene non vedano ancora alcuna creatura, solo un lungo corridoio di merdose, obsolete attività commerciali che una volta servivano questa logora e dimenticata parte della periferia di Atlanta: banchi di pegno, cambiavalute, agenzie di garanti per le cauzioni, negozi di ricambi per auto, taverne e botteghe di rigattieri. Si muovono lungo le vetrine fatiscenti, ansimando per il peso dei loro carichi, senza osare parlare o fare rumori inutili; e intanto l’urgenza di entrare da qualche parte comincia a impadronirsi di loro. Sta di nuovo calando la notte e quel posto diventerà presto il lato oscuro della luna. Non hanno mappe, GPS, bussole, nessuna idea di dove si trovino se non l’incerto punto di riferimento dello skyline a qualche chilometro a ovest. Brian sente l’ansia sfiorargli la nuca come un dito gelido. Svoltano un angolo. Brian è il primo a vedere l’officina, ma Philip la vede appena un secondo dopo e si muove verso di essa con un cenno. “Lassù, all’angolo, la vedi?” Anche Nick la vede adesso. “Sì, sì… sembra a posto.” Sembra davvero a posto: all’angolo sud-ovest di un incrocio deserto a un isolato di distanza, la Donlevy’s Autobody and Repair sembra l’unico esercizio in quella zona dimenticata da Dio a dare ancora segni di vita, sebbene al momento sembri chiuso per la stagione. Si affrettano verso l’edificio. Mentre si avvicinano, vedono che i duecento metri quadrati del lotto sono stati asfaltati di recente. Le due pompe di benzina all’esterno, pulite e apparentemente funzionanti, sono situate sotto una gigantesca insegna della Chevron. L’edificio stesso, ornato da colonne di pneumatici nuovi, con una coppia di imponenti doppie porte da officina su un lato della facciata, è una lastra lucida di metallo argenteo e vetri rinforzati. C’è anche un secondo piano, che ospita un ufficio o un altro spazio espositivo. Philip li guida sul retro, anch’esso ben curato, coi cassonetti dell’immondizia verniciati di fresco e addossati al muro di mattoni. Cercano una porta o una finestra ma non ne trovano. “Che ne dici di provare dalla porta principale?” dice Brian, sussurrando senza fiato mentre si fermano accanto ai cassonetti. Riescono a sentire la congregazione che si avvicina lungo la strada: un corteo strascicante e lamentoso di più di cinquanta zombie. “Sono sicuro che è chiusa” dice Philip, con la faccia dura, scarna e lucida di sudore per la fatica di portare sua figlia e il borsone. Contro la sua spalla, Penny si succhia il pollice in modo nervoso e compulsivo. “Come fai a saperlo?” Philip scrolla le spalle. “Tanto vale provare.” Strisciano attorno all’edificio e restano nell’ombra sotto l’insegna della Chevron, mentre Philip posa Penny e il borsone e corre verso la porta d’entrata. Gira la maniglia. È aperta. OTTO Restano nascosti per un po’ dentro l’ufficio dell’officina, sotto il registratore di cassa, accanto a un espositore girevole di snack al cioccolato e patatine. Philip chiude la porta a chiave e si accuccia vicino agli altri nell’ombra: la parata di non morti passa sulla strada accanto al negozio e, ignara della posizione delle prede, cerca con gli occhi stupidamente fissi come una muta di cani attirati da un fischio a ultrasuoni. Dalla sua angolazione, Brian vede, attraverso le finestre di vetro rinforzato, i preti morti e i parrocchiani vestiti di stracci oltrepassare barcollando la stazione di servizio. Come aveva fatto quella chiesa piena di fedeli a trasformarsi in massa? Si erano riuniti come cristiani spaventati dopo che era scoppiata l’epidemia, attaccandosi gli uni agli altri in cerca di soccorso e conforto? Avevano ascoltato i loro predicatori lanciare sermoni di fuoco e zolfo riguardo all’Apocalisse di San Giovanni? I pastori avevano furiosamente cantilenato parabole d’ammonimento: “E il quinto angelo suonò la sua tromba e io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra; a esso fu data la chiave del pozzo dell’abisso senza fondo!”. E come si era trasformato il primo? Qualcuno seduto sulle panche in fondo aveva avuto un infarto? Era stato un suicidio rituale? Brian si figura una di quelle vecchie signore di colore, con l’apparato circolatorio intasato di colesterolo e le mani paffute infilate nei guanti che si muovono al ritmo dei canti, stringersi all’improvviso sul petto imponente alla prima fitta delle coronarie. E pochi minuti dopo, forse un’ora o anche meno, la donna si alza con la faccia porcina ormai divenuta simbolo di una nuova religione, una fede singolare e selvaggia. “Fottuti fanatici religiosi” borbotta Philip da dietro il registratore di cassa. Poi si gira verso Penny e dice contrito: “Scusa per il linguaggio, pulcino”. Esplorano l’officina. Il posto è immacolato e sicuro, freddo ma pulito, i pavimenti lavati, gli scaffali in ordine, l’aria fresca che profuma di gomma nuova e della vagamente piacevole fragranza chimica del carburante e dell’olio. Si rendono conto di poter restare lì per la notte e quando perlustrano a fondo la grossa officina fanno la scoperta più fortuita. “Porca puttana, è un carro armato” dice Brian che, in piedi sul cemento freddo, fa scorrere il raggio della torcia elettrica sulla bellezza nera parcheggiata in un angolo sotto un telone. Gli altri si radunano intorno al veicolo solitario abbandonato nell’oscurità. Philip tira via il telo. È una Cadillac Escalade ultimo modello in perfette condizioni: le sue finiture cromate brillano nella luce gialla. “Probabilmente apparteneva al proprietario” azzarda Nick. “Natale è arrivato in anticipo quest’anno” dice Philip, mentre colpisce con lo stivale da lavoro infangato uno degli imponenti pneumatici. Il lussuoso SUV è enorme, con grossi paraurti sagomati, giganteschi fanali verticali e grandi, lucenti ruote cromate. Sembra il tipo di veicolo che un’agenzia governativa segreta terrebbe nel suo parco macchine, coi finestrini oscurati che riflettono il bagliore della torcia elettrica. “Non c’è nessuno dentro, vero?” Brian fa passare il raggio della torcia attraverso i vetri opachi. Philip estrae la .22 dalla cintura, apre uno sportello e punta la canna verso l’interno vuoto e lindo, con le finiture in legno, i sedili di pelle e un cruscotto che sembra la cabina di controllo di un aereo di linea. Philip dice: “Scommetto un dollaro contro una ciambella che le chiavi sono in un cassetto da qualche parte”. L’incidente col poliziotto morto e la faccenda della chiesa sembrano aver spinto Penny in uno stato di stordimento ancora più profondo. Quella notte dorme raggomitolata in posizione fetale sul pavimento dell’officina, avvolta nelle coperte, col pollice in bocca. “Non lo faceva da un sacco di tempo” osserva Philip seduto accanto a lei sul suo sacco a pelo col whisky che gli è rimasto. Indossa una T-shirt senza maniche e jeans sudici, gli stivali posati di fianco. Beve un sorso e si asciuga la bocca. “Cosa?” Brian è seduto a gambe incrociate, infagottato nel suo cappotto sporco di sangue, all’altro lato della bambina e bada a non parlare troppo forte. Nick sonnecchia dentro al sacco a pelo vicino a un banco da lavoro. La temperatura è scesa a meno dieci. “Succhiarsi il pollice in quel modo” dice Philip. “Ne ha passate parecchie.” “Come tutti noi.” “Già.” Brian abbassa lo sguardo e si fissa il grembo. “Ma ci arriveremo.” “Dove?” Brian alza lo sguardo. “Il centro profughi. Dovunque sia… lo troveremo.” “Già, certo.” Philip scola il resto della bottiglia e si stende. “Troveremo il centro, il sole domani splenderà, tutti gli orfani troveranno delle buone famiglie e gli Atlanta Braves vinceranno il campionato.” “C’è qualcosa che non va?” Philip scuote la testa. “Gesù Cristo, Brian, apri gli occhi.” “Ce l’hai con me?” Philip si alza e allunga il collo dolorante. “E perché cazzo dovrei avercela con te, campione? È sempre la solita storia. Niente di eccezionale.” “Cosa significa?” “Niente… va’ a dormire un po’.” Philip cammina verso la Escalade, si inginocchia e guarda sotto il telaio in cerca di qualcosa. Brian si alza in piedi, col cuore che batte all’impazzata. Gli gira la testa. Il suo mal di gola va meglio e ha smesso di tossire dopo i pochi giorni di riposo nella casa a Wiltshire, ma ancora non si sente al cento per cento. Ma chi lo è? Prosegue e si ferma dietro suo fratello. “Cosa intendevi con ‘è sempre la solita storia’?” “Quello che ho detto” mormora Philip, controllando le viscere del SUV. “Sei incazzato per via del poliziotto” dice Brian. Philip si alza lento, si volta e si mette faccia a faccia con suo fratello. “Ho detto ‘va’ a dormire’.” “Forse ho avuto qualche problema a sparare a qualcosa che una volta era un uomo… fammi causa.” Philip afferra Brian per la collottola della T-shirt, lo fa girare e lo sbatte contro la fiancata della Escalade. L’impatto quasi mozza il fiato a Brian e, a causa del rumore, Penny si sveglia agitata. “Ascoltami bene” ringhia Philip con una voce roca e minacciosa, che è sobria e ubriaca allo stesso tempo. “La prossima volta che prendi una pistola da me, assicurati di essere pronto a usarla come si deve. Quel poliziotto era indifeso, ma la prossima volta chi lo sa? E non ti farò da baby-sitter con nient’altro che le mie gonadi in mano, hai capito? Mi capisci?” Brian annuisce con la gola secca per il terrore. “Sì.” Philip aumenta la pressione sulla maglietta di Brian. “Farai meglio a lasciar perdere la tua comoda vita da smidollato fatta solo di stronzate, a prenderti le tue responsabilità e a sfondare qualche testa, perché è sicuro come l’inferno che le cose andranno molto peggio prima di migliorare!” “Ho capito” dice Brian. Philip non ha ancora finito, i suoi occhi scintillano di rabbia. “Sopravvivremo a tutto questo e lo faremo diventando mostri peggiori di loro! Hai capito? Non ci sono più regole! Non c’è più filosofia, non c’è più delicatezza o pietà, ci siamo solo noi e loro, e tutto quello che loro vogliono è mangiarsi il nostro culo! Non abbiamo scelta: noi dobbiamo mangiarci loro, cazzo! Li mastichiamo, li sputiamo e sopravviviamo a questo casino. Farò saltare tutto questo mondo fottuto! Mi segui? MI SEGUI?” Brian annuisce come un pazzo. Philip lo lascia andare e si allontana. A questo punto Nick è ormai sveglio e li guarda a bocca aperta. Penny si succhia il pollice furiosamente con gli occhi spalancati e osserva suo padre che cammina furibondo sul pavimento dell’autorimessa. Cammina verso le imponenti porte rinforzate del garage, si ferma e fissa fuori nella notte attraverso le sbarre, con i grossi pugni nodosi serrati. Sul pavimento, ancora appoggiato contro la fiancata della Escalade, Brian Blake combatte una battaglia silenziosa per impedirsi di piangere come un bambino abituato a una comoda vita da smidollato fatta solo di stronzate. Il mattino dopo, lambiti dalla luce del giorno che filtra nel negozio, si affrettano a fare colazione con barrette di cereali e acqua imbottigliata, poi versano il contenuto di tre taniche da venti litri di benzina nel serbatoio della Escalade. Trovano le chiavi in un cassetto dell’ufficio e caricano tutti i loro averi nel bagagliaio. I vetri oscurati sono appannati di condensa per il freddo. Brian e Penny si sistemano sul sedile posteriore mentre Nick sta accanto alla porta del garage in attesa del segnale di Philip. La corrente non c’è, e del resto sembra mancare dappertutto ormai, perciò sono costretti ad azionare manualmente il chiavistello che apre la porta automatica. Philip si siede dietro il volante della Escalade e la accende. L’enorme motore V-8 da 6,2 litri romba. Il cruscotto si illumina. Philip inserisce la marcia e si dirige in avanti, dando il segnale a Nick. Nick spalanca la porta del garage più vicina, che scorre sul binario con un cigolio di rotelle. L’aria e la luce del giorno esplodono attraverso il parabrezza, mentre Nick si affretta ad aprire lo sportello del passeggero e a salire a bordo. Lo sportello sbatte. Philip si ferma per un istante, guardando il cruscotto. “Qualcosa non va?” chiede Nick con voce incerta, ancora un po’ nervoso all’idea di fare domande a Philip. “Non dovremmo metterci in movimento?” “Un secondo” dice Philip, allungando la mano verso un cassetto. Dentro una custodia dalla chiusura a molla trova una ventina di CD, organizzati con precisione dal precedente proprietario, un certo Calvin R. Donlevy residente al n. 601 di Greencove Lane S.E. (stando a quanto riportato sul libretto riposto nel cassetto del cruscotto). “Ecco qui” dice Philip, rovistando tra i dischi. A quanto pare Calvin R. Donlevy di Greencove Lane ama il rock classico, a giudicare dagli Zeppelin, Sabbath e Hendrix della sua collezione. “Qualcosa per aiutare la concentrazione.” Parte quindi un disco dei Cheap Trick e Philip preme il pedale con forza. La spinta gravitazionale dei quattrocentocinquanta cavalli li incolla ai sedili, mentre l’enorme sagoma della Escalade esplode fuori dalla porta, passando appena dall’apertura senza che le fiancate di metallo si graffino. La luce del giorno inonda l’abitacolo. La chitarra elettrica che apre la canzone Hello There risuona dalle casse Bose 5.1 surround, mentre la macchina esce sulla strada schizzando fuori dall’officina. Il cantante dei Cheap Trick chiede se le ragazze e i ragazzi sono pronti per il rock. Philip romba attorno all’angolo e si dirige verso nord su Maynard Terrace. La strada si allarga. Case popolari scorrono su entrambi i lati del veicolo. Uno zombie errante, con indosso un impermeabile strappato, si aggira sulla destra e Philip vira verso di lui. Il tonfo raccapricciante si ode a stento sopra il rumore del motore (e la batteria tuonante dei Cheap Trick). Dietro, Brian sprofonda nel sedile, con lo stomaco sottosopra e in ansia per Penny, che è affondata sul sedile accanto al suo con lo sguardo fisso davanti a sé. Brian si allunga verso di lei e le allaccia la cintura, poi cerca di rivolgerle un sorriso. “Dev’esserci una rampa d’entrata a nord di qui” dice Philip sopra il rumore, ma il suono della sua voce è quasi del tutto sopraffatto dal ruggito del motore e dalla musica. Altri due morti compaiono alla loro sinistra, un uomo e una donna coi vestiti a brandelli, forse dei senzatetto: camminano lungo il marciapiede e Philip scarta allegramente e li abbatte entrambi come flaccidi birilli da bowling. Un orecchio amputato si attacca al parabrezza e Philip aziona i tergicristalli. Raggiungono il limite nord di Maynard Terrace, la rampa d’entrata è dritta davanti a loro. Philip schiaccia i freni. La Escalade stride fino a fermarsi davanti a un tamponamento a catena che ha coinvolto sei macchine ai piedi della rampa: un gruppo di cadaveri in posizione eretta circonda i rottami come poiane svogliate. Philip inserisce la retromarcia. Il pedale si abbassa, la musica rock rimbomba. La forza di gravità spinge tutti in avanti. Brian blocca Penny contro il sedile. Una sterzata del volante e la Escalade gira di centottanta gradi, poi si infila lungo McPherson Avenue, che corre parallela all’autostrada. Percorrono quasi due chilometri di proprietà immobiliari in un paio di minuti, con la batteria e il basso che danno un ritmo sincopato agli orribili tonfi dei morti vaganti, che, troppo lenti per togliersi di mezzo, si schiantano sul massiccio paraurti e finiscono scagliati in aria come giganteschi uccelli sorpresi da un attacco convulsivo. Dalle ombre e da dietro gli alberi ne emergono degli altri, risvegliati dal ruggito selvaggio della muscle car. La mascella di Philip si serra con tetra soddisfazione mentre si avvicinano a un’altra rampa d’accesso. I freni si bloccano su Faith Avenue, dove un Burger Win brucia senza controllo e tutta l’area è immersa nel fumo denso. Questa rampa è bloccata in modo persino peggiore della precedente. Philip grida un’imprecazione rabbiosa, poi rimette la retromarcia e schizza veloce all’indietro. La Escalade sterza all’angolo di una strada adiacente. Un altro strattone al volante. Un’altra pressione sul pedale. Sgommano di nuovo, diretti a ovest; aggirano i blocchi sulla strada e si dirigono verso i grattacieli in lontananza, che incombono sempre più grandi, come apparizioni nella foschia. Il numero di strade bloccate, detriti, macchine in rovina e morti erranti sembra insormontabile, ma Philip Blake non si ferma. Siede aggrappato al volante, col respiro affannoso e gli occhi fissi sull’orizzonte. Oltrepassa un emporio Publix che sembra essere stato bombardato nel corso di una guerra lampo: il parcheggio è infestato di morti. Philip aumenta la velocità per passare in mezzo a una fila di zombie sulla strada. L’ondata di sangue che schizza sull’enorme cofano del SUV è spettacolare, una lurida parata di tessuto morbido che fiorisce sul parabrezza. I tergicristalli passano frusciando sui resti appiccicosi. Sul sedile posteriore Brian si volta verso la nipote. “Piccola?” Nessuna risposta. “Penny?” Lo sguardo vuoto della bambina è fisso sullo spettacolo in Technicolor che attraversa il parabrezza. Non sembra sentirlo sopra il frastuono del rock and roll e il rombo della macchina; forse sceglie di non sentirlo, o forse è troppo lontana per sentire qualsiasi cosa. Brian le dà un colpo gentile sulla spalla e lei sposta il suo sguardo su di lui. Allora Brian si allunga oltre la bambina e scrive con attenzione una singola parola sul finestrino appannato dalla parte di lei. LONTANO Brian ricorda di aver letto da qualche parte che l’area metropolitana di Atlanta conta quasi sei milioni di abitanti. Ricorda di essere stato sorpreso da quel numero. Atlanta gli era sempre sembrata una specie di metropoli in miniatura, una mera dimostrazione del progresso del Sud, isolata in un mare di piccoli borghi pieni di redneck. Le poche visite che aveva fatto alla periferia della città gli avevano dato l’impressione che fosse niente più di un gigantesco sobborgo. Certo, il centro aveva i suoi canyon formati dagli alti edifici – c’era il Turner, il Coke, il Delta, il Falcons e tutto il resto – ma per lo più sembrava la sorella minore delle grandi città del Nord. Brian era stato a New York una volta, a visitare la famiglia della sua ex moglie, e quel vasto, tetro, claustrofobico formicaio gli era sembrato una città vera. Atlanta sembrava il simulacro di una città. Forse dipendeva in parte dalla sua storia, che Brian ricordava di aver studiato in un corso al college: durante la Ricostruzione, dopo che Sherman aveva bruciato la città, gli urbanisti avevano deciso che i punti di riferimento storici avrebbero fatto la fine del dodo; e nel successivo secolo e mezzo Atlanta era andata incontro a una pacchiana ricostruzione fatta con acciaio e vetro. A differenza di Savannah e New Orleans, permeate dal fiero gusto del Vecchio Sud, Atlanta si era concessa all’insipida patina dell’espressionismo moderno. Guardate, sembrava dire, come siamo progressisti, cosmopoliti, fichi, non come quei bifolchi di Birmingham. Ma a Brian era sempre sembrata la vecchia Atlanta, la dama “che si sbilancia troppo a promettere”. Per lui, Atlanta era sempre stata una città per finta. Fino a ora. Nel corso dei seguenti, orribili venticinque minuti, mentre Philip serpeggia senza tregua lungo desolate strade secondarie e attraverso lotti di terreno infestati posizionati ai lati dell’autostrada, cercando di aprirsi una strada che li avvicini al cuore della città, Brian vede fuori dai finestrini oscurati del SUV sigillato ermeticamente la vera Atlanta come in una tremolante proiezione di diapositive di scene del crimine. Vede vicoli ciechi intasati di rottami, cumuli di immondizia in fiamme, case popolari saccheggiate e abbandonate, finestre rotte ovunque, lenzuola macchiate appese fuori dai palazzi e scarabocchiate con disperate richieste d’aiuto. Questa è senza dubbio una città, una necropoli primordiale, sovraffollata e maleodorante di morte. E la cosa peggiore è che non sono nemmeno arrivati al confine del centro città. Approssimativamente alle dieci e ventidue, ora degli Stati Uniti Centrali, Philip Blake riesce a imboccare Capital Avenue, un’arteria di attraversamento larga sei corsie che oltrepassa Turner Field e si dirige verso il centro. Spegne lo stereo. Il silenzio esplode nelle loro orecchie mentre svoltano sulla Capital e procedono lenti verso nord. La strada è disseminata di macchine abbandonate, abbastanza lontane tra loro da consentire alla Escalade di passarci in mezzo. Le cime dei grattacieli, sulla sinistra, sono ormai vicinissime e brillano nella foschia come le vele maestre di una nave da soccorso. Nessuno dice niente mentre oltrepassano oceani di cemento su entrambi i lati della strada. I parcheggi dello stadio sono semivuoti. Ci sono alcuni golf cart ribaltati qua e là. Negli angoli, i furgoni dei venditori sono tutti chiusi e sfigurati dai graffiti. Qualche morto vaga in lontananza nella grigia desolazione e nella fredda luce di quella giornata autunnale. Sembrano cani randagi sul punto di morire di fame. Philip abbassa il finestrino e ascolta. Il vento ulula. Ha uno strano odore, un misto di gomma bruciata, circuiti fusi e qualcosa di oleoso e difficile da identificare, come sego che marcisce; qualcosa scoppietta da lontano, vibrando nell’aria come un motore gigantesco. Una consapevolezza blocca lo stomaco di Brian. Se i centri profughi sono in funzione, da qualche parte a ovest nel cuore della città, non dovrebbero esserci dei veicoli d’emergenza là fuori? Cartelli? Posti di blocco? Agenti armati ovunque? Elicotteri della polizia? Non dovrebbero esserci delle indicazioni, ora che sono così vicini al centro, che i soccorsi sono in vista? Fino a lì, durante tutto il loro viaggio all’interno della città, hanno visto solo alcuni, potenziali segni di vita. Giù a Glenwood Avenue hanno creduto di vedere una motocicletta sfrecciare come un lampo, ma non ne sono sicuri. Poi, su Sydney Street, Nick ha detto di aver visto qualcuno scattare dentro un portone ma non ci metterebbe la mano sul fuoco. Brian scaccia quel pensiero quando vede il vasto nodo di autostrade che formano un quadrifoglio a circa quattrocento metri di distanza. Quello svincolo tentacolare di arterie principali segna il confine orientale dell’area urbana di Atlanta, il punto dove l’Interstate 20 si incontra con la 85, la 75 e la 403; adesso se ne sta a cuocere sotto il sole e il freddo come un campo di battaglia dimenticato, intasato di rottami e rimorchi ribaltati. Brian si accorge che la Escalade comincia a percorrere una salita ripida. Capital Avenue si solleva su enormi piloni sopra lo svincolo. Philip affronta la salita piano, serpeggiando attraverso un percorso a ostacoli di rottami abbandonati a una velocità di circa venticinque chilometri l’ora. Brian sente un colpetto sulla spalla sinistra e comprende che Penny cerca di attirare la sua attenzione. Si volta e la guarda. Lei si piega verso di lui e gli sussurra qualcosa tipo: “Devo andare lì”. Brian la guarda. “Devi andare lì?” Lei scuote la testa e sussurra di nuovo. Stavolta Brian capisce. “Puoi trattenerla per un minuto, piccola?” Philip sente quelle parole e li guarda dallo specchietto retrovisore. “Che c’è?” “Deve fare pipì.” “Oh, cielo” dice Philip. “Scusa, pulcino, dovrai tenere le gambe incrociate per qualche minuto.” Penny sussurra a Brian che deve davvero, davvero, davvero farla. “Deve farla, Philip.” Brian informa suo fratello. “Davvero.” “Trattieniti ancora un po’, pulcino, solo un po’.” Sono ormai vicini allo zenit della salita. Di notte, la vista di quella parte della città, per un automobilista che attraversava Capital Avenue, doveva essere stupenda. Bisogna aspettare ancora un po’, mancano solo un centinaio di metri ormai, prima che la Escalade esca dall’ombra di un alto edificio a ovest. Di notte, le luminose costellazioni delle luci della città sarebbero visibili e regalerebbero un panorama mozzafiato, con la cupola del Campidoglio in primo piano e la scintillante cattedrale di grattacieli sullo sfondo. Escono dall’ombra dell’edificio e vedono la città distendersi davanti a loro in tutta la sua gloria. Philip schiaccia i freni. La Escalade sbanda e si ferma. Restano lì per un istante interminabile, tutti colpiti e ammutoliti. La strada a sinistra corre verso la facciata di marmo del vecchio e venerabile edificio del Campidoglio. È un senso unico nel verso sbagliato, del tutto intasato di macchine abbandonate. Ma non è per quello che i passeggeri del SUV sono rimasti di colpo attoniti. La ragione per cui nessuno riesce a spiccicare una parola in un silenzio che dura un secondo e sembra andare avanti per un’eternità è quello che vedono arrivare da nord lungo Capital Avenue e proprio nella loro direzione. Penny se la fa addosso. Il comitato d’accoglienza, copioso come un esercito romano e precipitoso come uno sciame di ragni giganteschi, arriva da Martin Luther King Drive, a poco più di un isolato di distanza. Emergono dalle ombre gelide degli edifici governativi e sono così tanti che l’occhio umano impiega un attimo anche solo per registrare cosa sono. Di tutte le taglie e in ogni stato di decomposizione, escono dai portoni, dalle finestre, dai vicoli, dalle piazze alberate, dagli angoli e dalle crepe e riempiono la strada con la profusione di una banda che marcia in disordine, attirata dal rumore e dall’odore di una macchina piena di carne fresca. Vecchi e giovani, bianchi e neri, uomini e donne, manager, casalinghe, impiegati, truffatori, bambini, delinquenti, insegnanti, avvocati, infermiere, poliziotti, spazzini e prostitute: hanno tutti la faccia uniformemente pallida e decomposta, come un infinito frutteto di frutti avvizziti che marciscono al sole, un migliaio di paia di occhi grigi, metallici e senza vita tutti rivolti alla Escalade, un migliaio di feroci, primordiali dispositivi di puntamento fissi e affamati verso i nuovi arrivati. In quell’unico istante di silenzio terrorizzato, Philip realizza un certo numero di cose con la velocità di una sinapsi che esplode. Realizza che riesce a sentire l’odore dell’orda attraverso il finestrino aperto e forse anche dalle bocchette di ventilazione nel cruscotto: quel fetore nauseante di bacon andato a male e merda. Ma più di quello, realizza che lo strano ronzio che ha sentito poco prima, quando ha abbassato il finestrino, quel brusio vibrante nell’aria come il fruscio di un milione di cavi dell’alta tensione, è il suono di una città piena di morti. Il loro gemito collettivo, ora che agiscono come un unico, gigantesco organismo multisfaccettato diretto verso la Escalade, gli fa accapponare la pelle. E alla fine, Philip Blake arriva a una conclusione che lo colpisce in mezzo agli occhi con la forza di un martello. Di fronte a quella vista, che gli si para innanzi al rallentatore, in modo quasi sognante, realizza che la ricerca di un centro profughi in quella città, per non parlare di qualcuno ancora vivo, si sta rapidamente rivelando saggia quanto la ricerca di un ago in un pagliaio. In quell’attimo di terrore, in quel minuscolo frammento di inerte immobilità, Philip si rende conto che probabilmente il sole domani non splenderà, gli orfani resteranno orfani e i Braves non vinceranno mai più il fottuto campionato. Prima di muovere la leva del cambio, si gira verso gli altri e con voce intrisa di amarezza dice: “Alzi la mano chi di voi muore ancora dalla voglia di trovare quel centro profughi!”. PARTE SECONDA Atlanta “Colui che combatte a lungo contro i draghi diventa un drago egli stesso; e se guardi troppo a lungo nell’abisso, l’abisso guarderà te.” —Nietzsche NOVE Pochissime macchine, almeno quelle in produzione negli Stati Uniti, sono in grado di raggiungere grandi velocità in retromarcia. Prima di tutto c’è il problema del cambio. La maggior parte delle auto, monovolume, pick-up e SUV, che escono dalle fabbriche, hanno cinque o sei marce in avanti ma solo una all’indietro. In secondo luogo, quasi tutti i veicoli hanno le sospensioni frontali progettate per andare avanti e non indietro, il che impedisce ai guidatori di ottenere grandi slanci in retromarcia. Terza considerazione, di solito in retromarcia si manovra il volante guardando da sopra la spalla e spingere le macchine a grandi velocità in questa posizione si conclude molto spesso in spettacolari testacoda. D’altro canto il veicolo che Philip Blake guida al momento è una Cadillac Escalade 2011 Platinum a trazione integrale, dotata di barre di torsione adatte a qualsiasi utilizzo fuoristrada che l’asso della meccanica Calvin R. Donlevy di Greencove Lane avrebbe potuto tentare di affrontare nelle zone sperdute della Georgia Centrale (in tempi più felici). Il veicolo pesa quasi quattro tonnellate, è lungo più di cinque metri ed è equipaggiato con un sistema di controllo elettronico della stabilità chiamato StabiliTrak (standard su tutti i modelli Platinum). Ma la cosa migliore è che dispone di una retrocamera, che mostra le immagini su un generoso schermo di navigazione di sette pollici incassato nel cruscotto. Senza esitazione, il sistema nervoso di Philip impartisce un ordine alla mano destra e lui ingrana con violenza la retromarcia, tenendo gli occhi incollati sulla tremolante immagine gialla che si materializza sullo schermo di navigazione. L’immagine mostra il cielo parzialmente nuvoloso sopra l’orizzonte formato dalla linea del manto stradale dietro di loro: la cima del cavalcavia. Prima che il reggimento di zombie in avvicinamento arrivi a una distanza inferiore ai cinquanta metri, la Escalade parte a razzo all’indietro. La forza di gravità risucchia tutti in avanti; Brian e Nick si voltano entrambi per guardare, oltre il lunotto posteriore oscurato, il cavalcavia che scorre rapido sotto di loro, mentre la coda della Escalade vibra leggermente e il veicolo guadagna velocità. Philip spinge a tavoletta. Il motore grida. Philip non si volta. Tiene gli occhi fissi sullo schermo dove la cima del cavalcavia si fa sempre più grande nella piccola e tremolante immagine gialla. Un piccolo errore di calcolo, la minima pressione sul volante nella direzione opposta e la Escalade entrerebbe in testacoda. Ma Philip tiene saldamente il volante, il piede sull’acceleratore e gli occhi sullo schermo mentre il veicolo corre all’indietro e il motore sta ormai cantando l’opera, con un tono vicino al do diesis minore. Sul monitor Philip si accorge che qualcosa è cambiato. “Oh, merda… guarda!” La voce di Brian penetra il rumore del motore, ma Philip non ha bisogno di guardare. Nel piccolo quadrato giallo del monitor vede una serie di figure scure apparire a poco più di cinquanta metri di distanza, direttamente sulla loro traiettoria, in cima al cavalcavia, come i paletti di uno steccato. Si muovono lente, in una formazione casuale, le braccia aperte a ricevere il veicolo che adesso si precipita proprio su di loro. Philip si lascia sfuggire un grugnito rabbioso. Schiaccia il pedale del freno con tutti e due gli stivali e la Escalade sbanda e si ferma di colpo, fumante, sul manto stradale in pendenza. A questo punto Philip realizza, insieme a tutti gli altri, che hanno una sola possibilità e che la finestra di quella opportunità si sta chiudendo molto in fretta. Le cose morte che vengono verso di loro sono lontane ancora un centinaio di metri, ma le orde dietro, che camminano con passo dinoccolato in cima alla cresta del viadotto, provenienti dalle case popolari e dai terreni vuoti che circondano Turner Field, si avvicinano con allarmante velocità, considerando i loro movimenti pesanti e impacciati. In uno degli specchietti laterali Philip vede che una strada adiacente, chiamata Memorial Drive, è accessibile tra due rimorchi rovesciati, ma anche l’esercito di zombie, che incombe sempre più vicino nello schermo posteriore, raggiungerà l’incrocio molto presto. Prende una decisione repentina e schiaccia a fondo l’acceleratore. La Escalade indietreggia con un ruggito. Tutti si reggono forte. Philip la guida dritta verso la folla di cadaveri traballanti. Sul monitor l’immagine mostra le colonne di zombie eccitati che allungano le braccia, con le bocche spalancate, mentre lo schermo li mostra sempre più grandi. Memorial Drive compare nell’inquadratura della telecamera e Philip schiaccia il freno. Il retro della Escalade si scaglia sopra una fila di non morti con un rumore nauseante, simile a un tambureggiare soffocato; Philip riporta di scatto la leva del cambio in posizione di marcia mentre il suo stivale da lavoro schiaccia il pedale a tavoletta. Affondano tutti nella tappezzeria mentre il SUV balza in avanti e Philip gira bruscamente a sinistra, infilandosi di stretta misura tra due rimorchi in rovina. Il SUV striscia una fiancata, che sprigiona un guizzo di scintille nell’aria, attraversa il varco e corre lungo le corsie di Memorial Drive, che si rivelano abbastanza libere e, grazie al cielo, sgombre da zombie. Passa appena un minuto, prima che Brian senta il rumore di qualcosa che sfrega. È un suono umido, penetrante e sgraziato, e proviene da sotto il telaio. Anche gli altri lo sentono. Nick si gira a guardare da sopra la spalla. “Che diavolo è?” “Uno di quei mostri è rimasto bloccato sotto le ruote” dice Brian, cercando di vedere la fiancata dell’auto fuori dal finestrino. Non riesce a vedere niente. Philip è silenzioso, ha le mani strette sul volante, la mascella serrata e contratta. Nick guarda fuori dallo specchietto laterale. “Uno di quei mostri è incastrato sotto la ruota!” “ O h , fantastico” dice Brian, contorcendosi sul sedile. Nota un piccolo ventaglio di gocce di sangue sul lunotto posteriore. “Che cosa facc…” “Proseguiamo” dice Philip in tono piatto, senza distogliere gli occhi dalla strada. “In pochi minuti sarà ridotto a brandelli.” Percorrono circa sei isolati, sobbalzando sopra una serie di binari ferroviari, e si inoltrano nella città, prima di incontrare qualcosa di più di qualche rottame isolato e pochi morti randagi. La griglia di strade che si infilano tra i palazzi è intasata di macerie, resti di esplosioni, macchine bruciate stipate di scheletri carbonizzati, finestre sfondate e pile di rifiuti e detriti innalzati contro le vetrine dei negozi. Da qualche parte, lungo la strada, il rumore della cosa che sfrega cessa, ma nessuno riesce a vedere cos’è successo al parassita. Philip decide di prendere una strada che va in direzione nord-sud fino al cuore della città, ma quando volta a destra, girando attorno al camion di un corriere, distrutto e ribaltato sul fianco nel centro dell’incrocio, schiaccia il freno. La Escalade sbanda fino a fermarsi. Rimangono lì per un momento, col motore al minimo. Philip non si muove: stringe le mani sul volante così forte da avere le nocche bianche e tiene gli occhi fissi sulle ombre lontane degli alti edifici. Sulle prime, Brian non riesce a capire quale sia il problema. Allunga il collo per gettare un’occhiata sulla strada disseminata di rifiuti che si estende per molti isolati davanti a loro. Attraverso il vetro oscurato, vede palazzoni su entrambi i lati della strada a quattro corsie. L’immondizia svolazza nel vento settembrino. Anche Nick è sconcertato da quella sosta improvvisa. “Che c’è che non va, Philip?” Philip non risponde. Continua a guardare dritto davanti a sé con preoccupante immobilità, i denti serrati, le mascelle contratte. “Philip?” Nessuna risposta. Nick si volta verso il parabrezza e guarda la strada di fuori. La sua espressione si inasprisce. Adesso vede quello che vede Philip. Rimane immobile. “Qualcuno vuol dirmi cosa sta succedendo?” chiede Brian, chinandosi in avanti per vedere meglio. Per un momento, distingue solo il lontano canyon formato dai palazzoni e molti isolati di asfalto coperto di immondizia. Ma comprende abbastanza in fretta che quello che guarda è la natura morta di una città desolata che comincia rapidamente a cambiare, come un gigantesco organismo che reagisce all’intrusione di batteri estranei. Quello che vede attraverso il finestrino oscurato è orribile, e Brian muove la bocca senza riuscire a dire niente. In quel singolo istante di ottenebrante stupore, quando la follia del momento gli afferra la mente, Brian Blake torna con la memoria a un ridicolo ricordo della sua infanzia. Una volta, sua madre li aveva portati, lui e Philip, ad Athens, al circo Barnum & Bailey. I ragazzi avevano più o meno tredici e dieci anni e si erano goduti i numeri sul trapezio, le tigri che saltavano attraverso i cerchi di fuoco, gli uomini che si facevano sparare dai cannoni, gli acrobati, lo zucchero filato, gli elefanti, i baracconi, il mangiatore di spade, il bersaglio umano, i mangiafuoco, le donne barbute e l’incantatore di serpenti. Ma la cosa che a Brian era rimasta più impressa, quella a cui pensa in questo esatto momento, era la macchina dei clown. Quel giorno ad Athens, al culmine dello spettacolo, una macchina piccola e buffa era entrata nell’anello centrale. Era una macchina simile a quelle dei cartoni animati, coi finestrini dipinti, delle dimensioni di una station wagon: bassa sul terreno e colorata in un patchwork di colori fluorescenti. Brian la ricorda in maniera vivida: alla vista dei clown che uscivano dalla macchina, uno dopo l’altro, aveva riso a crepapelle: all’inizio la cosa era stata solo divertente, poi era diventata quasi sbalorditiva e, infine, del tutto bizzarra. Questo perché i clown continuavano a uscire: sei, otto, dieci, venti, grandi e piccoli, avevano continuato a uscire come se la macchina fosse un contenitore magico di clown liofilizzati. Anche se aveva tredici anni, Brian era rimasto ammaliato dal numero: sapeva bene che doveva esserci un trucco, forse una botola nascosta dalla segatura sparsa sotto la macchina, ma non importava perché la sola vista del loro numero era ipnotica. Lo stesso esatto fenomeno, o almeno un suo perverso facsimile, si svolge adesso proprio davanti ai suoi occhi, lungo una trafficata strada urbana nelle viscere del centro di Atlanta. Resta a bocca aperta in silenzio per un momento, impegnato a descrivere a parole quello spettacolo raccapricciante. “Gira, Philip.” La voce di Brian suona cupa e stridula alle sue stesse orecchie mentre fissa le innumerevoli folle di non morti che si svegliano in ogni angolo della città davanti a loro. Se l’orda che hanno incontrato solo alcuni istanti prima sulla loro strada verso la città era un reggimento dell’esercito romano, questa è l’impero al completo. Fino a dove gli occhi riuscivano a vedere, giù lungo lo stretto canale della strada a quattro corsie, i non morti emergono dai palazzi, da dietro le macchine, da sotto i rottami, dalle ombre dei vicoli, dalle vetrine sfondate, dai portici di marmo degli edifici governativi, dai vasi esili degli alberi decorativi e dai resti malmessi dei caffè all’aperto. Riescono a vederne anche a grande distanza, dove il punto di fuga della strada sfuma nelle ombre dei grattacieli; le loro sagome cenciose sembrano una miriade di lenti insetti usciti dall’oscurità di una pietra rivoltata. Il loro numero sfida la logica. “Dobbiamo andarcene” dice Nick col cigolio arrugginito che in questo momento è la sua voce. Philip, ancora stoico e silenzioso, muove le dita strette sul volante. Nick getta uno sguardo nervoso da sopra la spalla. “Dobbiamo tornare indietro.” “Ha ragione, Philip” dice Brian, posando con gentilezza una mano sulla spalla di Penny. “Qual è il problema, cosa vuoi fare?” Nick guarda Philip. “Perché non giri la macchina?” Brian guarda la nuca di suo fratello. “Ce ne sono troppi, Philip. Troppi. Sono troppi.” “Oh, mio Dio, siamo fottuti… fottuti” dice Nick, ammaliato dallo spettrale prodigio che si sta compiendo sul loro cammino. I più vicini sono forse a mezzo isolato di distanza e appaiono come la cresta di uno tsunami: sembrano impiegati d’ufficio di entrambi i generi, ancora vestiti nei loro completi da lavoro strappati, masticati e immersi nel grasso dei motori e barcollano nella loro direzione come sonnambuli ringhianti. Dietro, per isolati e isolati, innumerevoli altri incespicano lungo i marciapiedi e al centro della strada. Se c’è un’ora di punta all’inferno, di certo non può competere con questa. Dalle bocchette di areazione e dai finestrini della Escalade, la sinfonia stonata di centomila lamenti fa rizzare i peli sul collo di Brian, che si allunga in avanti e dà un colpetto sulla spalla di suo fratello. “La città è andata, Philip.” “Sì, sì, ha ragione, il posto è bruciato, dobbiamo fare il giro” farfuglia Nick. “Un secondo.” La voce di Philip è fredda come il ghiaccio. “Tenetevi.” “Dai, Philip” dice Brian. “Questo posto appartiene a loro, adesso.” “Ho detto tenetevi.” Brian guarda la nuca di suo fratello e una sensazione gelida gli corre lungo la spina dorsale. Comprende che quanto Philip intende con la parola tenetevi significa “tenetevi un secondo mentre rifletto” o “tenetevi un minuto mentre trovo una soluzione”. Quello che Philip Blake intende con tenetevi è… “Avete allacciato le cinture?” chiede con una domanda retorica che gela il sangue nelle vene di Brian. “Philip, non…” Philip spinge a fondo il pedale. La Escalade erutta in avanti, dritta sulla folla brulicante, scacciando i pensieri di Brian e spingendo tutti contro i sedili. “PHILLY, NO!” Il grido di panico di Nick si dissolve in una salva di tonfi soffocati, come il battito di un gigantesco tam tam, mentre la Escalade salta il marciapiede e falcia almeno tre dozzine di zombie. Tessuti e fluidi piovono su tutta la macchina. Brian si piega nervoso sul pavimento e si unisce a Penny nel posto chiamato lontano. I più piccoli vanno giù come le paperelle di un tirassegno, esplodendo sotto le ruote e lasciando una traccia di viscere putrescenti. I più grossi rimbalzano sui paraurti e carambolano in aria, sbattendo contro i muri dei palazzi e andando in pezzi come frutti troppo maturi. A quanto pare, i morti non hanno la capacità di imparare. Anche una falena svolazzerebbe via dopo essersi avvicinata troppo a una fiamma. E invece questa enorme società di cadaveri ambulanti di Atlanta non capisce perché non può mangiare lo scintillante oggetto nero che le ruggisce contro, lo stesso tuonante pezzo di metallo che solo un istante prima ha trasformato altri zombie in budini di sangue: così continua ad avanzare. Piegato sul volante, coi denti digrignati e le nocche bianche, Philip usa i tergicristalli con regolari spruzzate di soluzione pulente per vedere attraverso il parabrezza mentre mastica la strada verso nord, aprendosi un varco, con le quasi quattro tonnellate di acciaio di Detroit, in mezzo al mare semovente di zombie. Con una velocità oscillante tra i cinquanta e i gli ottanta chilometri orari, si ricava un sentiero verso il centro della città. A volte falcia la folla come se si aprisse un sentiero attraverso una fitta foresta colma di frutti di sangue: le braccia si agitano e le dita ricurve, simili ai rami di un albero, cercano di artigliare i finestrini laterali mentre la Escalade procede attraverso gli escrementi che camminano. Altre volte il SUV percorre brevi tratti di strada libera, dove solo pochi zombie barcollano lungo un marciapiede o sui bordi del manto stradale, il che consente a Philip di aumentare la velocità e di scartare a destra per abbatterne una manciata e poi a sinistra per farne fuori un altro po’ e colpire un altro tappeto di mostri, e quello è forse il momento più divertente, perché è allora che la merda comincia a volare davvero. È quasi come se le viscere piovessero dall’alto, dal cielo, anziché da sotto le ruote o lungo il telaio, oppure da sopra la grossa griglia frontale. La materia umidiccia si trascina sul vetro, ancora e ancora, col ritmo di una girandola enorme, un caleidoscopio di colori, la tavolozza simile a un arcobaleno di tessuto umano – rosso sangue, verde marcio, giallo bruciato e nero catrame – e tutto questo per Philip è quasi meraviglioso. Svolta a un angolo con un rombo e si tuffa su un’altra massa di zombie che arriva lungo la strada. La parte più strana sono i continui e ripetuti lampi di tessuti e di organi, solo alcuni dei quali sono riconoscibili. Le budella volano in tutte le direzioni, schizzando il parabrezza e scivolando sul cofano. Piccoli grappoli di denti si raccolgono sui tergicristalli e qualcos’altro, qualcosa di rosa, come piccole perle di uova di pesce, continua ad accumularsi nelle giunture del cofano. Philip scorge le facce morte una dopo l’altra, ognuna come un lampo sul parabrezza, che si vede per un attimo e sparisce in quello successivo, ma lui è altrove, è da qualche altra parte, non nel SUV, non dietro il volante, ma dentro la folla, dentro la città dei non morti, a masticare in mezzo alle loro fila, a divorare gli stronzi. Philip è il mostro peggiore di tutti e riuscirà ad attraversare questo oceano di merda anche se dovesse demolire l’intero universo. Brian capisce cosa succede prima ancora di guardare. Dieci atroci minuti dopo che hanno cominciato a farsi largo nel mare di zombie, dopo averlo fatto per quasi ventitré isolati della città, la Escalade finisce in testacoda. La forza centripeta attira Brian contro il pavimento; l’uomo solleva la testa e sbircia da sopra il sedile mentre il SUV sbanda di lato sul grasso di cinquantamila cadaveri. Non ha tempo per gridare o fare qualcosa. Può solo stringere se stesso e Penny contro lo schienale del sedile posteriore per l’inevitabile impatto. Con le ruote scivolose per il sangue, il SUV gira di trecentosessanta gradi, con la parte posteriore che turbina in mezzo agli ultimi cadaveri randagi. Fuori dai finestrini la città diventa una macchia indistinta e Philip lotta col volante per raddrizzarlo, ma gli pneumatici slittano su una coltre di intestini, sangue e secrezioni. Brian emette un verso strozzato, in parte avvertimento e in parte grido inarticolato, mentre il veicolo sbanda contro una fila di vetrine. Nei momenti frenetici prima dello schianto, Brian scorge una serie di vetrate in rovina: busti senza cappello di manichini calvi, espositori di gioielli vuoti, cavi spezzati che fuoriescono dalle tavole del pavimento mancanti, tutto confuso dietro le vetrine rinforzate. Ma è solo un’impressione indistinta poiché la vista di Brian è troppo distorta dal violento sbandare del SUV. Ed è allora che la fiancata destra della Escalade collide con la vetrina. Lo schianto procura a Brian una sensazione di tempo sospeso: la vetrina del negozio si trasforma in polvere di stelle e il rumore del vetro che va in frantumi è quello di un’onda che colpisce un frangiflutti mentre la Escalade sfonda le sbarre e irrompe di traverso nell’ombra buia della Goldberg Fine Jewelry Center di Atlanta. Casse e bacheche esplodono in tutte le direzioni in un nevischio argentato e scintillante di detriti, mentre la forza gravitazionale sbatte tutti i passeggeri verso destra. Gli airbag della Escalade si aprono con piccole esplosioni; i grossi palloni ansimanti di nylon bianco riempiono l’abitacolo prima che collassi e Nick viene scagliato di lato nel tessuto bianco. Philip finisce addosso a Nick mentre Penny viene sbalzata attraverso il pavimento e si ferma addosso a Brian. Il SUV sbanda per un’eternità attraverso il negozio vuoto prima di fermarsi duramente contro una colonna portante nel centro, spingendo tutti contro la fodera imbottita degli airbag; per un attimo nessuno si muove. Detriti bianchi e leggeri cadono come neve nell’aria polverosa e buia della gioielleria e dietro di loro i rumori di qualcosa che crolla crepitano nell’improvviso silenzio. Brian getta un’occhiata dal lunotto posteriore crepato e vede la facciata del negozio, dove una pila di travi cadute blocca il buco nella vetrina e una nuvola di polvere oscura la strada. Philip si contorce sul suo sedile con la faccia cinerea e fuori di sé per il panico. “Pulcino? Pulcino? Stai bene? Parlami, piccola! Stai bene?” Brian si volta verso la bambina, che è ancora sul pavimento: sembra intontita e forse è in preda a un qualche tipo di shock, ma per il resto è incolume. “Sta bene, Philip, sta bene” dice Brian, tastando la testa della bimba in cerca di tracce di sangue o di ferite di qualsiasi genere. La bambina sembra illesa. “Voialtri, state tutti bene?” Philip si guarda intorno tra i granelli di polvere dell’abitacolo buio. Un sottile raggio di luce che filtra attraverso il negozio è l’unica fonte di luce. Nelle tenebre, Brian riesce a vedere le facce degli altri uomini: sudate, impietrite dal terrore e con gli occhi lucidi. Nick alza un pollice. “Sto bene.” Brian dice lo stesso. Philip ha già aperto il suo sportello e si affanna a uscire da dietro l’airbag. “Prendete tutto quello che potete” dice loro, “e assicuratevi di prendere i fucili e tutte le munizioni. Mi avete sentito?” Sì, lo hanno sentito, e anche Brian e Nick escono dal SUV. In un solo minuto, Brian compie una serie di considerazioni, la maggior parte delle quali, a quanto pare, sono già state valutate da Philip, a cominciare dalla facciata del negozio. Dal coro di lamenti e dallo strascicare di migliaia di piedi, è chiaro che l’orda di zombie è ormai vicina alla scena dell’incidente. La Escalade è finita, la parte anteriore è quasi del tutto distrutta, le ruote sono scoppiate, tutta la sua lunghezza è sporca di sangue. Il retro del negozio conduce a un corridoio buio, stretto e con i muri a secco, che forse porta a un’uscita. Non c’è tempo per indagare. Hanno solo il tempo di prendere zaini, borsoni e armi. Storditi dalla collisione, con le vertigini per il panico, contusi, ammaccati e con le orecchie che fischiano, Brian e Nick prendono ognuno un fucile a pallettoni e Philip prende tutti gli attrezzi taglienti che può portarsi addosso, un’accetta su ogni lato della cintura, la Ruger e tre caricatori extra. “Forza, piccola, dobbiamo filarcela” dice Brian a Penny, che sembra intontita e confusa. Brian cerca di tirarla fuori dall’abitacolo dilaniato, ma lei si attacca al retro del sedile. “Prendila” dice Philip, aggirando il muso del SUV. “Vieni, tesoro, sali a cavalluccio” le dice Brian. Penny esce riluttante dall’auto e Brian se la carica sulla schiena. I quattro si infilano rapidi nel retrobottega della gioielleria. Sono fortunati. Appena oltrepassata la porta a vetri di un ufficio sul retro, trovano una porta di metallo senza indicazioni. Philip tira il catenaccio e la apre di pochi centimetri, sbirciando fuori. L’odore è incredibile, un fetore nero e unto, che ricorda a Brian quella volta che la sua classe di prima media aveva fatto una gita d’istruzione all’allevamento Turner alla periferia di Ashburn. Il puzzo del reparto del mattatoio era lo stesso. Philip alza una mano, facendo cenno a tutti di fermarsi. Sopra la sua spalla, Brian scorge un vicolo lungo, stretto e buio con una fila di cassonetti dell’immondizia traboccanti. Ma è il contenuto di quei ricettacoli a imprimersi a fuoco nella sua memoria: pallide braccia umane ciondolano oltre il bordo, gambe ulcerate e a brandelli, oltre a capelli arruffati, pendono verso il basso dove si sono raccolte pozze di sangue scuro e secco. Philip si muove verso gli altri. “Seguitemi tutti e fate esattamente quello che vi dico” ordina, facendo scattare il cane della Ruger coi suoi otto proiettili calibro .22 pronti a far festa; poi si mette in movimento. Gli altri lo seguono. Si fanno strada più silenziosi e veloci che possono in mezzo al fetore e alle ombre di quel mattatoio abbandonato che è ormai diventato il vicolo, diretti verso una strada laterale visibile sul fondo. Piegato sotto il peso del borsone su una spalla e della bambina che gli sta aggrappata alla schiena, Brian cammina barcollando tra Philip e Nick: i trenta chili di Penny non gli sono mai sembrati tanto pesanti. Nick, che fa da retroguardia, procede con il Marlin calibro 20 appoggiato alla spalla. Brian tiene il suo fucile infilato sotto lo zaino: non che abbia la minima idea di come usare quel dannato affare. Raggiungono la fine del vicolo e stanno quasi per scivolare fuori sulla traversa abbandonata quando Philip pesta accidentalmente una mano umana che fuoriesce da un cassonetto. La mano, attaccata a uno zombie con ancora un po’ di energia, si ritira subito sotto il container. Philip sobbalza all’indietro. “AMICO!” grida Nick e la mano scatta di nuovo fuori e afferra la caviglia di Philip. Philip si getta a terra e la Ruger rotola lungo la strada. L’uomo morto, un senzatetto barbuto dalla pelle cinerea e coi vestiti stracciati e sporchi di sangue, striscia verso Philip con la velocità di un ragno enorme. Philip cerca di afferrare la pistola. Gli altri si agitano per prendere le loro armi: Brian cerca il fucile mentre tenta di bilanciarsi la bambina sulla schiena. Nick tira i cani del Marlin. La cosa morta stringe la gamba di Philip e apre le mascelle col crepitio di cardini arrugginiti affetti da rigor mortis mentre Philip armeggia per prendere l’ascia. Lo zombie è ormai sul punto di addentare la parte inferiore del polpaccio di Philip quando la canna del fucile a pallettoni di Nick si appoggia sulla parte posteriore del suo cranio. Lo sparo gli squarcia la testa, spedendo metà della sua faccia in aria in un geyser di sangue e tessuto cerebrale mentre l’eco del fucile rimbomba nei canyon di vetro e acciaio. “Adesso siamo fottuti” dice Philip, alzandosi a fatica e raccogliendo la Ruger. “Qual è il problema?” chiede Brian, sistemandosi il peso della bambina sulla schiena. “Ascolta” dice Philip. In quel silenzio fragile, sentono che il lamento simile alle onde dell’oceano muta all’improvviso il suo corso come se il vento fosse cambiato: le masse di non morti sono state attratte dallo sparo del fucile. “Allora torniamo dentro” dice Nick con voce tesa e stridula. “Dentro la gioielleria, dev’esserci un secondo piano.” “Troppo tardi” dice Philip, controllando la Ruger e guardando dentro la culatta. Nel calcio rimangono quattro proiettili a punta cava e ha altri tre caricatori da otto colpi in ognuna delle tasche posteriori. “Scommetto che stanno già invadendo la facciata del negozio.” “Cosa suggerisci?” Philip guarda Nick e poi suo fratello. “Quanto veloce pensate di poter correre con tutto quel peso?” Si danno alla fuga a un passo moderato: Philip sta davanti, Brian si trascina dietro di lui e Nick chiude il gruppo. Oltrepassano vetrine sfondate e immobili pire funebri di corpi carbonizzati, bruciati da sopravvissuti audaci. Brian non ne è certo, ma ha la sensazione che Philip sia alla ricerca disperata di un modo sicuro per andarsene dalle strade, un portone sgombro, una scala anti ncendi o, qualcosa… ma è distratto dal numero crescente di cadaveri semoventi che si materializzano a ogni angolo. Philip spara al primo da cinquanta passi, infilandogli una pallottola nella tempia e lasciandoselo alle spalle come una cattiva abitudine. Il secondo lo sorprende più da vicino, sbucando fuori dall’ombra di un portone: Philip lo abbatte con il secondo colpo. Altri ancora emergono dai portici e dalle vetrine sfondate. Nick mette all’opera il fucile a pallettoni e due decine di pallottole per la caccia al cinghiale vanno a buon segno, abbattendone almeno una dozzina nello spazio di due isolati. Gli spari echeggiano sopra lo skyline come boom sonici nella stratosfera. Svoltano un angolo e corrono lungo una traversa più stretta, lastricata con un selciato a spina di pesce, forse prima della guerra era una strada importante, che un tempo risuonava di carretti e cavalli e adesso è circondata su entrambi i lati da condomini e palazzi di uffici. La buona notizia è che sembrano allontanarsi dall’area congestionata: a ogni isolato incontrano sempre meno morti che camminano. La cattiva notizia è che iniziano a sentirsi in trappola. La città si sta chiudendo intorno a loro, li ingoia in un solo boccone nelle sue fauci di vetro e acciaio. Il sole ha ormai cominciato la sua discesa pomeridiana e le ombre proiettate dall’imponente skyline si allungano. Philip vede qualcosa in lontananza, forse a un isolato e mezzo di distanza, e istintivamente si nasconde al riparo di una tenda strappata. Gli altri si accovacciano accanto a lui contro la vetrina sbarrata di un ex lavasecco e si rannicchiano nell’ombra per riprendere fiato. Brian è ansimante per lo sforzo: la piccola Penny è ancora attaccata alla sua schiena come una specie di scimmia traumatizzata e addormentata. “Che problema c’è?” chiede Brian, vedendo che Philip allunga il collo per guardare qualcosa in lontananza. “Dimmi che ho le traveggole” dice Philip. “Che c’è?” “Il palazzo grigio laggiù sulla destra” dice Philip, indicando a nord con un cenno. “Lo vedi? A circa due isolati da qui? Vedi l’ingresso?” In lontananza, un condominio di tre piani svetta su una fila di fatiscenti condomini a due piani. Un’imponente costruzione post bellica in mattoni color gesso e balconi sporgenti, è l’edificio più grosso dell’isolato: la sua cima si alza sopra le ombre e riflette la fredda e pallida luce del giorno col suo dispiegamento di antenne e canne fumarie. “Oh, mio Dio, lo vedo” mormora Brian, continuando a bilanciare il peso di Penny sulla schiena indolenzita. La bambina gli si aggrappa alle spalle con una stretta disperata. “Non è un miraggio, Philly” commenta Nick; una traccia di stupore colora la sua voce. Fissano tutti la figura umana in lontananza, troppo lontana per essere identificata come uomo o donna, adulto o bambino, ma è lì… e agita le mani verso di loro. DIECI Philip si avvicina cauto dall’altro lato della strada, il calibro .22 al suo fianco, carico e armato, ma non puntato. Gli altri lo seguono in fila indiana, coi peli del collo ritti, gli occhi spalancati e pronti a tutto. La giovane donna al di là della strada li chiama con un sussurro lieve e sibilante. “Presto, sbrigatevi!” Sembra essere sulla trentina, anno più anno meno, con lunghi capelli di un biondo slavato raccolti in una stretta coda di cavallo. Indossa un paio di jeans e un largo pullover fatto a maglia molto sporco: le macchie rosse e gli schizzi sono visibili anche a quella distanza mentre gli fa cenno con un revolver di piccolo calibro, forse una .38 della polizia, agitandolo come se fosse la paletta di un vigile urbano. Philip si asciuga la bocca: pensa, trattiene il respiro, cerca di tenere la donna inquadrata nel mirino. “Forza!” urla lei. “Prima che sentano il nostro odore!” È ovviamente impaziente che la seguano dentro ed è molto probabile che non intenda fargli niente di male; da come agita la pistola, Philip non sarebbe sorpreso di scoprire che non è nemmeno carica. Li avverte: “E non lasciate che qualcuno di quegli azzannatori vi veda entrare qua dentro!”. Philip si ferma guardingo sul marciapiede prima di attraversare la strada. “Quanti siete?” grida. Dall’altra parte della strada, la donna bionda si lascia sfuggire un sospiro esasperato. “Per l’amor di Dio, vi offriamo cibo e riparo, muovetevi!” “Quanti?” “Gesù, volete essere aiutati o no?” Philip rafforza la sua stretta sulla Ruger. “Prima devi rispondere alla mia domanda.” Un altro sospiro nervoso. “Tre! Okay? Siamo in tre. Sei contento adesso? Questa è la tua ultima occasione perché se non venite tutti e subito, me ne torno dentro e allora saranno cazzi vostri.” Parla con l’accento leggermente strascicato di chi è nato in Georgia, ma nella sua voce c’è anche qualcosa della metropoli. Forse anche un accenno del Nord. Philip e Nick si scambiano uno sguardo. Il coro lontano dei lamenti rugginosi si avvicina, portato dal vento come una tempesta in arrivo. Brian si bilancia nervoso il peso di Penny sulla schiena, poi, da sopra la spalla, getta uno sguardo inquieto verso la fine dell’isolato. Guarda Philip. “Che altra scelta abbiamo, Philip?” “Sono d’accordo con lui, Philly” sussurra piano Nick, deglutendo per la paura. Philip guarda la giovane donna di là dalla strada. “Quanti uomini, quante donne?” Lei gli risponde gridando: “Vuoi che compili un questionario? Io torno dentro. Buona fortuna per tutto… ne avrete bisogno!”. “Aspetta!” Philip fa un cenno agli altri e poi li guida cauto al di là della strada. “Avete sigarette?” chiede la ragazza, conducendoli nell’ingresso esterno dell’edificio e sbarrando la porta dietro di sé con un chiavistello improvvisato. “Ci stiamo fumando gli ultimi mozziconi.” La donna è piuttosto malconcia: ha il mento graffiato, dei lividi su un lato del volto e un occhio così iniettato di sangue che sembra quasi abbia avuto una lieve emorragia. A parte questo, Philip è colpito per quanto è bella: ha occhi blu fiordaliso e il tipo di pelle baciata dal sole che ci si aspetterebbe di vedere in una ragazza di campagna, una bellezza tranquilla e poco curata. Ma dalla piega insolente della sua testa e dalle forme prosperose celate sotto gli abiti pesanti, sembra quasi la personificazione della Madre Terra. E con la Madre Terra non si scherza. “Spiacente, non fumiamo” dice Philip, tenendo aperta la porta per Brian. “Sembra che vi abbiano conciato per le feste là fuori” dice la donna, guidandoli attraverso una stanza maleodorante e disordinata, su una parete della quale sono allineate diciotto coppie di cassette della posta e citofoni. Brian mette giù Penny con gentilezza. La bambina vacilla per un attimo, cercando di orientarsi. L’aria puzza di decomposizione e di zombie. L’edificio non sembra sicuro. La giovane donna si inginocchia accanto alla bambina. “Ma che carina.” Penny non dice niente, si limita a guardare in basso. La donna alza lo sguardo su Brian. “È tua?” “È mia” dice Philip. La donna sposta una ciocca di capelli arruffati dal viso di Penny. “Io mi chiamo April, tesoro, tu come ti chiami?” “Penny.” La voce che esce dalla bambina suona tenue ed esasperata, come il miagolio di un micino. La donna di nome April sorride e le batte un colpetto sulla spalla, poi si alza e guarda gli uomini. “Entriamo prima di attirarne altri.” Si avvia verso un citofono e preme il bottone. “Papà, facci entrare.” Attraverso uno scoppio di scarica statica, una voce replica: “Non così in fretta, ragazzina”. Philip le afferra il braccio. “Avete energia là dentro? Avete l’elettricità?” Lei scuote la testa. “Purtroppo no… il citofono ha una batteria.” Preme il bottone. “Dai, papà.” Un’altra scarica crepitante. “Come facciamo a sapere che possiamo fidarci di quei bifolchi?” Click: “Ci fai entrare o no?”. Scarica: “Fatti dare tutte le armi”. La donna si lascia sfuggire un sospiro angosciato e si gira verso Philip, che scuote la testa, con uno sguardo del tipo “non ci pensare nemmeno”. Click: “Hanno una bambina piccola, per l’amor di Dio. Garantisco io per loro”. Scarica: “E Hitler dipingeva le rose… non li conosciamo”. Click: “Papà, apri questa dannata porta!”. Scarica: “Hai visto cos’è successo a Druid Hills”. April sbatte la mano sul citofono. “Qui non siamo a Druid Hills! Adesso facci entrare, dannazione, prima che ci cresca il muschio sul culo!” Si ode un ronzio secco e metallico, seguito da un forte scatto: la serratura automatica della porta di sicurezza interna si apre. April li conduce attraverso l’ingresso e poi lungo un corridoio malmesso e dall’odore stantio, su cui si affacciano le porte di tre appartamenti su ogni lato. All’altra estremità si vede una porta metallica con la scritta SCALE, chiusa con due assi incrociate. April bussa all’ultima porta sulla destra, appartamento 1C, e nel giro di pochi istanti una versione di April più pesante, più anziana e più volgare la apre. “Oh, mio Dio, che bambina adorabile” dice la donna più anziana vedendo Penny, che tiene per mano Brian. “Venite, ragazzi… non sapete quanto sia bello vedere finalmente delle persone capaci di tenersi la bava in bocca.” La sorella di April, che si presenta come Tara, è paffuta e un po’ grossolana. Odora di fumo e shampoo, e indossa un camicione a stampe floreali per nascondere i chili di troppo. Il petto erompe dal vestito come un impasto lievitante e su un seno sfoggia un piccolo tatuaggio di Woody Woodpecker. Ha gli stessi impressionanti occhi blu della sorella minore, ma i suoi sono pesantemente truccati e sottolineati da un ombretto blu acciaio. Le lunghe unghie finte sembrano in grado di aprire una scatoletta. Philip entra nell’appartamento per primo, con la Ruger ancora nella mano lungo il fianco. Gli altri lo seguono. Sulle prime, nota appena il soggiorno in disordine, le sedie coperte di vestiti, le valigie malconce contro il muro e la forma bizzarra delle custodie di strumenti musicali appoggiate alla porta scorrevole sbarrata. Scorge a stento il cucinotto sulla sinistra, le casse di provviste e il lavandino pieno di piatti sporchi. La puzza del fumo di sigaretta, di tessuto stantio e di sudore aleggiano nell’aria, ma le sue narici li registrano a malapena. In questo momento, tutta la sua attenzione è concentrata sulla bocca di un fucile calibro 12 puntata dritta su di lui da una sedia a dondolo dall’altra parte della stanza. “Fermo dove sei” dice l’uomo anziano col fucile. È un vecchio consumato, uno stagionato spilungone allampanato con la faccia da contadino abbronzata come la statua di legno di un indiano che fa da insegna alle tabaccherie, i capelli a spazzola grigi e gli occhi blu ghiaccio. Sotto il naso a becco è attaccato il tubo sottile di una bombola d’ossigeno, posata accanto a lui come un cucciolo fedele. Riempie a malapena i jeans a sigaretta e la camicia di flanella; le caviglie bianche e pelose sbucano dagli anfibi. Philip solleva istintivamente la .22, creando all’istante una situazione di stallo messicano. La punta sul vecchio e dice: “Signore, abbiamo già abbastanza problemi là fuori, non ne abbiamo bisogno anche qui”. Gli altri restano immobili. April si intromette tra i due. “Per l’amor di Dio, papà, metti via quell’affare.” Il vecchio fa scansare la ragazza con la canna del fucile. “Fa’ silenzio, ragazzina.” April resta lì con le mani sui fianchi e un’espressione disgustata sul volto. Dall’altra parte della stanza, Tara dice: “Perché non ci diamo una calmata tutti quanti?”. “Da dove venite, gente?” chiede il vecchio a Philip, col fucile ancora puntato su di lui. “Waynesboro, Georgia.” “Mai sentita nominare.” “È nella Contea di Burke.” “Diavolo, è quasi in Sud Carolina.” “Sissignore.” “Vi drogate? Speed, crack… roba del genere?” “No, signore. Cosa diavolo glielo fa credere?” “Qualcosa nei tuoi occhi, sembrano quelli di un tossico che si fa di speed.” “Io non mi drogo.” “Come avete fatto a finire davanti a casa nostra?” “Avevamo sentito che c’era una specie di campo profughi qui da qualche parte, ma la voce non sembra essere poi così vera.” “Puoi dirlo forte” dice il vecchio. April interviene. “A quanto pare, abbiamo qualcosa in comune.” Philip tiene gli occhi fissi sul vecchio, ma ribatte alla ragazza: “Cosa?”. “È la stessa ragione per cui anche noi siamo finiti in questo posto dimenticato da Dio” dice. “Cercavamo quel dannato centro profughi di cui parlavano tutti.” Philip fissa il fucile. “I migliori piani4, immagino.” “Fottutamente vero” dice il vecchio, mentre il sibilo tenue dell’ossigeno filtra dalla bombola. “Credo che non vi rendiate conto di quello che avete fatto.” “Parli.” “Avete fatto incazzare tutti quegli azzannatori. Per il tramonto, quelle fottute cose si saranno date appuntamento fuori dalla nostra porta.” Philip tira su col naso. “Mi dispiace, ma non avevamo molta scelta.” Il vecchio sospira. “Beh… immagino che tu abbia ragione.” “Sua figlia ci ha tolto dalla strada… non avevamo cattive intenzioni. Diavolo, non avevamo intenzioni di nessun tipo… se non evitare di farci mordere.” “Già, beh… capisco il vostro punto di vista.” Segue un lungo attimo di silenzio. Tutti aspettano. Le due armi da fuoco cominciano ad abbassarsi. “Cosa contengono quelle custodie?” chiede Philip alla fine, indicando con un cenno la fila di custodie di strumenti in fondo al soggiorno. La pistola è ancora sollevata ma la tensione dello scontro è scomparsa. “Ci sono delle mitragliatrici dentro?” Il vecchio si lascia sfuggire una risata severa. Appoggia il fucile di traverso sul grembo, lasciando sollevati i cani dell’arma: tutta la tensione è defluita dal suo volto scarno. La bombola d’ossigeno sibila. “Amico, stai guardando quello che resta della World Famous Chalmers Family Band, stelle del palcoscenico, dello schermo e delle fiere di stato di tutto il Sud.” Il vecchio appoggia il fucile sul pavimento con un grugnito. Alza lo sguardo su Philip. “Mi scuso per la brusca accoglienza.” Si mette in piedi a fatica, ergendosi in tutta la sua altezza fino a sembrare un Abe Lincoln avvizzito. “Mi chiamo David Chalmers, mandolino, voce e padre di queste due monellacce.” Philip si infila la pistola nella cintura dietro la schiena. “Philip Blake. Questo è mio fratello, Brian. E quello che fa da tappezzeria laggiù è Nick Parsons… vi ringrazio di cuore per averci salvato il culo là fuori.” I due patriarchi si stringono la mano e la tensione esce dalla stanza con l’immediatezza di un interruttore che si spegne. Salta fuori che c’era un quarto membro della Chalmers Family Band, la signora Chalmers, una piccola e corpulenta matrona di Chattanooga, che cantava come alto soprano nei pezzi “bluegrass” e “old-timey”. Secondo April, era stata una benedizione che la matriarca della famiglia fosse morta di polmonite cinque anni prima. Se fosse vissuta per vedere quella merda orribile che affl iggeva la razza umana, ne sarebbe stata schiacciata; l’avrebbe vista come la fine dei tempi e probabilmente sarebbe saltata dritta dal molo di Clark’s Hill Lake. E così la Chalmers Family Band era diventata un trio, ma aveva continuato ad andare in scena, suonando nel circuito dei luna park che giravano tra Alabama, Georgia e Tennesse, con Tara al basso, April alla chitarra e David al mandolino. Come padre single, il sessantaseienne David aveva il suo bel da fare. Tara fumava hashish e April aveva il temperamento e la tenacia della madre. Quando era scoppiata l’epidemia, si trovavano a un festival di bluegrass in Tennessee e si erano diretti verso casa col camper della band. Erano arrivati solo al confine della Georgia prima che il camper si rompesse. Da lì, erano stati abbastanza fortunati da trovare un treno della Amtrak ancora in servizio tra Dalton e Atlanta. Sfortunatamente, il treno li aveva scaricati nella parte meridionale della città, alla King Memorial Station, ormai infestata di morti. In qualche modo erano riusciti a farsi strada verso nord senza essere attaccati, muovendosi di notte a bordo di macchine rubate, alla ricerca del mitico centro profughi. “E questa è la storia di come siamo finiti qui, nel nostro piccolo paradiso a buon mercato” dice piano April a Philip, più tardi quella notte. È seduta su un lato di un divano sbrindellato, mentre Penny sonnecchia agitata accanto a lei in un groviglio di coperte. Philip siede lì vicino. Sul tavolino da caffè le candele sono accese. Nick e Brian dormono sul pavimento dall’altra parte della stanza, mentre David e Tara russano, in diverse tonalità, nelle rispettive camere. “Abbiamo troppa paura per andare di sopra” aggiunge April con una traccia di rimpianto nella voce. “Anche se ci servirebbero tutte le provviste che forse sono rimaste. Batterie, cibo in scatola, qualsiasi cosa. Gesù, darei la tetta sinistra per un po’ di carta igienica.” “Non darla mai via solo per un po’ di carta igienica” dice Philip con un ghigno, seduto a piedi scalzi, in jeans e T-shirt sporca, dall’altra parte del divano, con la pancia piena di riso e fagioli. Le provviste dei Chalmers cominciano a scarseggiare, ma possono ancora contare sulla metà di un sacco da cinque chili di riso, che hanno sgraffignato dalla vetrina sfondata di un negozio una settimana prima e abbastanza fagioli da preparare la cena per tutti. April ha cucinato e il cibo non era male. Dopo cena, Tara ha rollato qualche sigaretta con l’ultimo tabacco Red Man che le resta e alcuni grammi di marijuana. Philip ha dato qualche tiro, anche se aveva giurato di smettere col fumo anni prima… di solito gli faceva sentire nella testa voci che non voleva sentire. Adesso, nella strana luce del tramonto, il suo cervello si sente confuso e intontito. April riesce a mettere insieme un sorriso triste. “Già, beh… così vicino eppure così lontano.” “Che intendi dire?” Philip la guarda, poi alza lo sguardo lento al soffitto. “Oh… capito.” Ricorda di averlo notato poco prima. Adesso si sono calmati, ma i rumori strascicati e penetranti, che provengono dai piani più alti, hanno continuato a percorrere il soffitto per tutta la sera, muovendosi con la presenza insidiosa e invisibile delle termiti. Philip se n’è quasi dimenticato, ormai insensibile com’è alla prospettiva di trovarsi tanto vicino ai non morti. “E gli altri appartamenti del pianterreno?” chiede. “Li abbiamo ripuliti; abbiamo preso tutto quello che c’era di utilizzabile.” “Cos’è successo a Druid Hills?” le chiede, dopo un attimo di silenzio. April sospira. “La gente ci aveva detto che c’era un centro profughi laggiù. Non c’era.” Philip la guarda. “E?” April scrolla le spalle. “Siamo andati lì e abbiamo trovato un sacco di gente che si nascondeva dietro i cancelli di quella grande discarica. Gente come noi. Spaventati, confusi. Abbiamo cercato di convincere qualcuno di loro a venire via con noi. La forza è nel numero, tutte quelle stronzate da fanatici.” “E quindi? Cos’è successo?” “Immagino che fossero troppo spaventati per andarsene e troppo spaventati per restare.” April abbassa lo sguardo e la sua faccia riflette la luce delle candele. “Tara, papà e io abbiamo trovato una macchina che funzionava, abbiamo preso un po’ di provviste e ce ne siamo andati. Ma, mentre ce ne andavamo, abbiamo sentito arrivare le motociclette.” “Motociclette?” Lei annuisce. Si strofina gli occhi. “Abbiamo fatto quattrocento metri di strada, forse anche meno, abbiamo svoltato dietro una collina e di colpo abbiamo sentito, lontane dietro di noi, delle grida. Ci siamo guardati indietro oltre la valle, dove si trovava quella vecchia discarica lercia ed è stato come… non saprei. Come in quel cazzo di Mad Max o qualcosa del genere.” “Cosa?” “Una gang di motociclisti stava facendo a pezzi il posto, catturava la gente, famiglie intere, Dio solo sa cos’altro. È stato bruttissimo. Ma la cosa strana è che non stavamo male all’idea di essere scampati per un pelo. Non era per le pallottole che avevamo scansato. Credo fosse il senso di colpa. Volevamo tornare indietro e aiutarli, fare i bravi cittadini modello e tutto il resto, ma non l’abbiamo fatto.” Lo guarda. “Perché non siamo bravi cittadini modello; non esistono più i cittadini modello.” Philip guarda Penny. “Adesso capisco perché tuo padre non era entusiasta all’idea di farci entrare.” “Da quella volta alla discarica, è diventato paranoico riguardo agli altri sopravvissuti, forse anche di più che riguardo agli azzannatori.” “Azzannatori… te l’ho sentito dire anche prima. A chi è venuto in mente quel nome?” “È il nome che gli ha dato mio padre; direi che è calzante.” “Mi piace.” Philip le sorride di nuovo. “E mi piace tuo padre. Si prende cura dei suoi e non lo biasimo per non essersi fidato di noi. Mi sembra un osso duro e lo rispetto. Ce ne servirebbero di più di tipi come lui.” Lei sospira. “Non è duro come una volta, lascia che te lo dica.” “Cos’ha? Cancro ai polmoni?” “Enfisema.” “Male” dice Philip, poi vede qualcosa che lo raggela. April Chalmers ha appoggiato la mano sulla spalla di Penny che dorme e la accarezza sovrappensiero. È un gesto tenero e inatteso, naturale, e colpisce Philip nel profondo risvegliando qualcosa che è rimasto assopito per troppo tempo dentro di lui. All’inizio è una sensazione che non riesce a comprendere e la sua confusione dev’essere evidente sul suo volto perché April lo fissa. “Stai bene?” “Sì, sto… sto bene.” Si tocca il cerotto sulla tempia, dove ha sbattuto durante la collisione di quel giorno. I Chalmers hanno tirato fuori il loro kit di pronto soccorso e hanno medicato tutti prima di cena. “Sai cosa ti dico” dice Philip. “Tu dormi e, domattina, i ragazzi e io andremo a ripulire un po’ di sopra.” Per un momento, lei lo guarda come se si chiedesse se fidarsi o no di lui. Il mattino dopo, finita la colazione, Philip mantiene la sua parola. Arruola Nick e afferra caricatori extra per la Ruger e una scatola di cartucce per i Marlin. Si infila le accette nella cintura una per fianco e consegna un piccolo piccone a Nick per gli incontri ravvicinati. Si ferma sulla porta e si china per stringere i lacci degli stivali da lavoro, ormai così sporchi di fango e sangue da sembrare ricamati di fili neri e viola. “Fate attenzione là fuori” dice il vecchio David Chalmers, in piedi sulla porta del cucinotto. Nella luce del mattino sembra grigio e slavato, mentre si tiene appoggiato al carrello metallico che contiene la bombola d’ossigeno. Il tubo sotto il naso sibila leggermente a ogni respiro. “Non sapete quello che troverete.” “Come sempre” dice Philip, infilandosi la camicia dentro i jeans e assicurandosi che le accette siano sistemate in modo da poter essere estratte con velocità. Nick lo controlla, mentre aspetta col fucile a pallettoni in spalla. C’è un’espressione tirata sulla sua faccia, un misto di tetra determinazione ed eccitazione. “La maggior parte saranno al secondo piano” aggiunge il vecchio. “Lo ripuliremo.” “Guardatevi le spalle.” “Certo” dice Philip, alzandosi e controllando di nuovo le accette. “Arrivo.” Philip si volta e vede Brian con indosso una T-shirt pulita col logo dei REM, l’orgoglio di Athens, e un’espressione cupa e risoluta sul viso. Tiene tra le braccia un fucile quasi si trattasse di un essere vivente. “Sei sicuro?” “Diavolo, sì.” “E Penny?” “Le ragazze baderanno a lei.” “Non lo so.” “Dai” dice Brian. “Vi serviranno un paio di occhi extra lassù. Ci penso io.” Philip riflette. Guarda l’altro lato del soggiorno dove sua figlia sta seduta alla maniera degli indiani sul pavimento, in mezzo alle due ragazze Chalmers. Giocano a Uno con un mazzo di carte malconcio e, di tanto in tanto, le donne riescono a farla sorridere mentre cala una carta. È passato molto tempo dall’ultima volta che la bambina ha sorriso. Philip si gira verso suo fratello e gli fa un sorrisetto. “È lo spirito giusto.” Salgono le scale in fondo al corridoio del primo piano: gli ascensori all’altro capo del corridoio sono morti come gli zombie; ma prima devono tirare via le assi di legno dalla porta. Il rumore dei colpi d’ascia e lo stridio dei chiodi che vengono fuori sembrano stimolare dei movimenti sopra di loro, nelle stanze buie dietro le porte degli appartamenti. A un certo punto, a causa dello sforzo, Philip si lascia sfuggire del gas, un ricordo della cena a base di fagioli cucinata da April la sera prima. “Quella scoreggia ammazzerà più zombie delle cartucce calibro ventidue” commenta Nick. “Ha-ha-ha” ride Philip e strappa via l’ultima tavola che sbarrava la porta. Mentre salgono la rampa di scale buia, Philip dice: “Ricordatevelo, tutti e due… siate veloci. Sono dei viscidi figli di puttana, ma sono lenti come lumache del cazzo e più stupidi di Nick”. “Ha-ha, chi lo dice lo è” ribatte Nick, infilando con fare esperto un paio di cartucce calibro 20 nel fucile a pallettoni. Arrivano sul pianerottolo e trovano la porta tagliafuoco che dà sul secondo piano saldamente chiusa. Si fermano. Brian trema. “Calmati, campione” gli dice Philip, notando che la canna del fucile oscilla un po’. Philip allontana con gentilezza la canna dal punto dove si trovano le sue costole. “E cerca di non ficcare accidentalmente una palla in corpo a uno di noi”. “Ho tutto sotto controllo” ribatte Brian con voce tesa e tremante, rivelando che ovviamente non ha un bel niente sotto controllo. “Allora andiamo” dice Philip. “E ricordate, colpiteli con forza e alla svelta.” Sferra un unico, poderoso calcio col tacco dello stivale e la porta si spalanca. UNDICI Per un millesimo di secondo, restano fermi, coi cuori che battono come martelli pneumatici. A parte alcune carte di caramelle qua e là, bottiglie vuote di bibite gassate e una gran quantità di polvere, il corridoio del secondo piano, identico a quello del piano terra, è vuoto. La fioca luce del giorno fa capolino dalle finestre lontane e ricama merletti con i granelli di polvere che svolazzano davanti alle porte chiuse: 2A, 2C e 2E da un lato, 2B, 2D e 2F dall’altro. Nick sussurra: “Sono tutti chiusi dentro casa”. Philip annuisce. “Sarà come sparare a dei pesci in un fottuto barile.” “Forza, facciamolo” dice Brian, che non suona affatto convincente. “Diamoci da fare.” Philip guarda lui e poi Nick. “Ecco a voi John Rambo.” Si avviano verso la prima porta sulla destra, la 2F sollevando le canne dei fucili. Philip tira indietro il cane della Ruger. Poi spalanca la porta con un calcio. Una gigantesca bolla di tanfo li colpisce dritti in faccia. È la prima cosa che registrano: un repellente fetore di degradazione umana, urina, feci e puzza di zombie, insieme agli odori più acidi del cibo rancido, dei bagni guasti e dei vestiti ammuffiti. È insopportabile e li travolge facendoli letteralmente indietreggiare di mezzo passo. “Gesù Cristo” dice Nick in un’esclamazione soffocata, distogliendo involontariamente la faccia, quasi che la puzza fosse un vento che soffia verso di lui. “Pensi ancora che la mia scoreggia puzzi?” dice Philip, avanzando cauto nell’ombra fetida dell’appartamento. Solleva la .22. Nick e Brian lo seguono coi fucili spianati e gli occhi spalancati e luccicanti per la tensione. Un attimo dopo, ne trovano quattro che riposano sul pavimento di un soggiorno messo a soqquadro: ognuno è riverso in un angolo, con lo sguardo catatonico e le mascelle spalancate; ringhiano languidi alla vista degli intrusi, ma sono troppo stupidi o dementi per muoversi, come se fossero ormai stanchi del loro diabolico destino e avessero dimenticato l’uso dei mobili. È difficile stabilirlo nella debole luce della stanza, specie con la carne straziata, gonfia e illividita delle loro facce, ma si direbbero una famiglia: madre, padre e due figli grandi. Le pareti mostrano strani segni di graffi, come a formare un gigantesco quadro astratto, prova evidente che quelle cose tentavano di obbedire a un vago istinto che le spingeva a scavarsi una via d’uscita. Philip si avvicina al primo: gli occhi da squalo della cosa scintillano alla vista della Ruger puntata. Lo sparo manda il cervello dello zombie contro il Jackson Pollock fatto di graffi sul muro dietro di lui. La cosa si accascia sul pavimento. Intanto, dall’altra parte della stanza, Nick pone fine alle sofferenze di un altro e il boato del Marlin risuona come lo scoppio di un gigantesco sacchetto di carta gonfio d’aria. Il tessuto cerebrale macchia le pareti. Philip abbatte il terzo che si alza lento e Nick si muove verso il quarto… BANG! Il suono dei fluidi che schizzano sulle varie superfici viene soffocato dal rimbombo nelle loro orecchie. Brian è fermo dieci passi dietro di loro, col fucile pronto, mentre il suo spirito annega sotto un’ondata di repulsione e nausea. “Questo… questo non è…” comincia a dire, ma il balenio di un movimento alla sua sinistra interrompe le sue parole. Lo zombie errante viene verso Brian dai recessi di un corridoio laterale, sbucando dalle ombre come un clown mostruoso, con uno spaventoso parrucchino nero e occhi come caramelle. Prima che Brian abbia anche solo la possibilità di capire se si tratti di una figlia o di una fidanzata, vestita di un abito strappato e con una tetta di fuori come una bandiera di carne masticata, la cosa balza su di lui con la forza di un difensore impegnato in un placcaggio. Brian cade all’indietro sul pavimento, e tutto accade così in fretta che Philip e Nick non hanno il tempo di intervenire. Sono troppo lontani. Il cadavere atterra sopra Brian e ringhia coi denti neri e viscidi; in quel terribile istante, prima che Brian ricordi di avere ancora in mano il fucile, lo zombie spalanca le fauci tanto che la sua testa sembra sul punto di aprirsi in due. Brian coglie l’orribile vista dei recessi della gola del mostro, un pozzo nero senza fondo che conduce dritto all’inferno; poi, d’istinto, alza il fucile. Quasi per caso, la canna si infila nella bocca aperta dello zombie e Brian scoppia in un grido confuso mentre preme il grilletto sparando un unico colpo. La nuca della cosa esplode, schizzando in aria sangue misto a tessuto cerebrale. Lo spruzzo sporca il soffitto di sangue arterioso viola scuro e Brian rimane attonito per un attimo, con la schiena ancora inchiodata al pavimento. La testa del cadavere è ancora infilzata alla canna del fucile. Sbatte le palpebre. Gli occhi argentei della fidanzata o figlia, o chiunque fosse, sono immobili e fissi su Brian. Lui tossisce e si gira, mentre la testa della ragazza scivola lenta di lato giù per la lunghezza della canna, come lo spiedo di un gigantesco kebab, con gli occhi morti ancora fissi su Brian. Qualcosa di viscido gli cola sulle mani dalla faccia di lei. Chiude gli occhi. Non riesce a muoversi. Con la mano destra incollata al grilletto e la sinistra salda sul calcio, fa una smorfia d’orrore. Una risata fredda lo scuote da quello stato di trance. “Guarda un po’ chi ha segnato il suo primo touchdown” dice Philip Blake, ergendosi sopra suo fratello in una nuvola di fumo di cordite, con un sorriso malinconico che va da un orecchio all’altro. È Nick a trovare l’uscita sul tetto e a Philip viene l’idea di depositarci tutte le carcasse putrescenti perché non contaminino ulteriormente il posto (o rendano la caccia al tesoro nei piani superiori ancora più sgradevole di quanto già non sia). Impiegano poco più di un’ora a trascinare tutti i resti inumani su per le scale del terzo piano e poi lungo una stretta scalinata verso la porta antincendio. Devono distruggere la serratura e lavorare come in una specie di catena di secchi improvvisata, trascinando i maleodoranti ammassi di carne per i corridoi e su per due rampe di scale fino al tetto, lasciando viscide tracce di sangue sulla moquette rosa. Riescono a trascinarli tutti fino all’ultimo: lungo il passaggio fino al tetto, ne hanno eliminati quattordici, utilizzando due caricatori interi di cartucce calibro .22, oltre a una scatola di proiettili. “Guardate che vista” si meraviglia Nick intento a sistemare l’ultima carcassa sul camminamento di carta catramata lungo il lato est del tetto, col vento che gli sferza i pantaloni e gli scompiglia i capelli. I cadaveri giacciono in fila come legna da ardere accatastata per l’inverno. Brian è fermo sul lato opposto della fila, lo sguardo basso sulle cose morte con un’espressione strana e implacabile sul volto. “Davvero stupenda” dice Philip, camminando fino all’orlo del tetto. Da quell’altezza, è possibile scorgere in lontananza i palazzi del quartiere esclusivo di Buckhead, Peachtree Plaza, e le cattedrali di vetro dei grattacieli a ovest: le guglie immobili della città che si ergono, stoiche e impassibili nella luce del giorno, incontaminate dall’apocalisse. In basso, Philip vede i morti muoversi in disordine dentro e fuori le ombre, come soldatini giocattolo che hanno preso vita. “Bel posto per andare a fare un giro” dice Philip, voltandosi e controllando il resto del tetto. Intorno a un gigantesco conglomerato di antenne, comignoli e motori per condizionatori d’aria, ormai freddi e inattivi, c’è un piazzale coperto di ghiaino che offre abbastanza spazio per giocare a touch football 5. Un ammasso di mobili da giardino dimenticati sta appoggiato contro un tubo dell’aria condizionata. “Prendetevi una sedia e riposatevi un po’.” Trascinano alcune chaise-longue sbrindellate verso il bordo del tetto. “Potrei abituarmi a questo posto” dice Nick, sistemandosi su una sdraio rivolta verso i palazzi. Philip si siede accanto a lui. “Vuoi dire questo piano o tutto il posto in generale?” “Tutto quanto.” “Sono d’accordo.” “Come riuscite a farlo?” dice Brian, in piedi dietro di loro, ancora sulle spine e nervoso. Rifiuta di mettersi a sedere, rifiuta di rilassarsi. È ancora teso per l’incontro con la testa impalata. “Fare cosa?” dice Philip. “Non saprei, per esempio uccidere quelle cose in quel modo e dopo un minuto essere già…” Brian si blocca, incapace mettere in parole il suo pensiero e Philip si gira a guardarlo. Vede che le sue mani tremano. “Siediti, Bri, ti sei comportato bene là dentro.” Brian tira a sé una sedia, si siede e comincia a torcersi le mani, rimuginando. “Voglio solo dire che…” Di nuovo, non riesce ad articolare quello che vuole dire e balbetta. “Quello non è uccidere, campione” dice Philip. “Quando te ne renderai conto, starai meglio.” “E allora cos’è?” Philip scrolla le spalle. “Nicky, tu come lo definiresti?” Nick guarda verso i palazzi. “Il lavoro di Dio?” Philip scoppia in una risata fragorosa e dice: “Ho avuto un’idea”. Si alza e si avvia verso il cadavere più vicino, uno dei più piccoli. “Guardate questo” dice trascinandolo fino al bordo del tetto. Gli altri due lo raggiungono sul cornicione. Il vento rancido agita i loro capelli mentre guardano verso la strada, che si trova dieci metri più sotto. Philip spinge il cadavere con la punta dello stivale fino a farlo scivolare oltre il bordo. Il corpo sembra cadere al rallentatore, le sue appendici senza vita penzolano come ali spezzate. Colpisce il parcheggio di cemento sottostante, davanti alla facciata del condominio, e va in pezzi col rumore, il colore e la consistenza di un cocomero troppo maturo che scoppia in una esplosione di tessuto rosa. Nella camera da letto padronale dell’appartamento al primo piano, David Chalmers se ne sta seduto in canottiera e boxer, ad aspirare da un inalatore, per far entrare nei suoi polmoni abbastanza Atrovent da placare gli ansimi, quando sente il trambusto fuori dalla porta a vetri scorrevole sbarrata che dà sul retro dell’appartamento. Il rumore gli fa rizzare i peli sul collo: si affretta a rimettersi i vestiti, tubo per respirare incluso, che si sistema a metà, con un lato che penzola sotto la narice pelosa. Attraversa furibondo la stanza sulle ginocchia scricchiolanti, strattonando la bombola dell’ossigeno come un bambino capriccioso trascinato da una tata impaziente. Percorre il soggiorno e, con la coda dell’occhio, intravede tre figure immobili, rapite e terrorizzate sulla soglia della cucina. April, Tara e la bambina cucinavano dei biscotti con le ultime riserve di zucchero e farina; adesso le tre femmine se ne stanno lì, a bocca aperta, a guardare in direzione del rumore. David arranca verso le porte scorrevoli di vetro rinforzato sbarrate. Attraverso un piccolo buco tra le tavole di compensato, in mezzo ai rami degli alberi scheletrici, riesce a malapena a scorgere l’altra estremità del cortile e, oltre quella, una sezione della strada che corre parallela alla facciata dell’edificio. Un altro corpo piove a terra come se fosse stato gettato giù da Dio in persona: colpisce il manto stradale con un suono sordo e umido, simile a quello di un gigantesco palloncino d’acqua che scoppia. Ma non è quello il rumore che David Chalmers sente adesso. Non è quello il rumore che penetra a ondate nell’appartamento come una potente, lontana, sinfonia disarmonica. “Gesù santo” mormora in un rantolo, girando su se stesso così in fretta che quasi rovescia la bombola dal suo carrello. Trascina l’armamentario verso la porta. Sul tetto, Philip e Nick fanno una pausa dopo aver spinto il quinto corpo giù dal cornicione. Ansimando per lo sforzo e per una specie di lieve vertigine, Philip commenta: “Esplodono davvero bene, eh?”. Nick cerca senza successo di non ridere. “Ci sono almeno una decina di ragioni per cui quello che stiamo facendo è sbagliato, ma devo ammettere che è divertente.” “Hai proprio ragione.” “Qual è il punto, ragazzi?” insiste Brian, ancora in piedi dietro di loro. “Il punto è che non c’è nessun punto” dice Philip senza guardarlo. “Cos’è, un proverbio Zen?” “È quello che è.” “Okay, mi sono perso. Voglio dire, non capisco a cosa serva gettarli dal tetto.” Philip si gira per guardarlo. “Rilassati, campione. Hai conquistato il tuo primo trofeo, oggi. Non è stato piacevole, ma hai fatto il tuo dovere. Ci stiamo solo sfogando un po’.” In lontananza, Nick vede qualcosa che fino a quel momento non aveva notato. “Ehi, guardate…” “Voglio solo dire…” lo interrompe Brian. “In tutta questa merda, dobbiamo riuscire a non perdere il controllo.” Tiene le mani in tasca e armeggia nervoso con gli spiccioli e il coltello a serramanico che sono all’interno. “April e la sua famiglia sono brava gente, Philip, dobbiamo comportarci bene.” “Sì, mamma” dice Philip con un sorriso freddo. “Ehi, ragazzi, date un’occhiata a quel palazzo laggiù nell’angolo.” Nick indica un tozzo e brutto edificio di mattoni all’angolo nord-est dell’incrocio più vicino. Le lettere sbiadite e annerite lungo i bordi dai fumi della città, dipinte sopra le finestre del primo piano, recitano Dillard’s Home Furnishings. Philip lo vede. “E allora?” “Guarda l’angolo davanti al palazzo: c’è una di quelle cose pedonali.” “Una cosa?” “Un passaggio pedonale o un passaggio coperto: non so di preciso come si chiama. Lo vedi?” In effetti, Philip vede un ponte di vetro fuligginoso che attraversa la strada adiacente e collega il palazzo di uffici in diagonale rispetto a loro al secondo piano di Dillard’s. Il cavalcavia di vetro è vuoto e sigillato a entrambe le estremità. “A cosa pensi, Nicky?” “Non lo so.” Nick fissa il cavalcavia, rimuginando. “Potrebbe…” “Signori!” Il tuono rauco della voce del vecchio lo interrompe. Brian si volta e vede David Chalmers caracollare verso di loro dalla porta che dà sulle scale. Gli occhi del vecchio bruciano di un senso d’urgenza mentre arranca verso di loro trascinandosi dietro la bombola d’ossigeno con fare esperto. Brian fa un passo verso di lui. “Signor Chalmers, è venuto fin quassù da solo?” Il vecchio si avvicina respirando a fatica e in un rantolo dice: “Sarò anche vecchio e malato, ma non sono impotente… e chiamami David. Ho visto che avete ripulito per bene tutti i piani e per questo vi ringrazio, vi ringrazio di cuore”. Philip e Nick si girano per guardarlo. “C’è qualche problema?” chiede Philip. “Diavolo, sì, certo che c’è un problema” risponde il vecchio, con gli occhi scintillanti di rabbia. “Che diavolo fate quassù: perché buttate i corpi dal tetto a quel modo? Vi date la zappa sui piedi da soli!” “Che intende dire?” Il vecchio grugnisce. “Siete tutti sordi o cosa? Non lo sentite?” “Sentire cosa?” Il vecchio si trascina verso il cornicione. “Provate a indovinare.” Punta un dito nodoso in direzione di due palazzi in lontananza. “Vedete cosa avete fatto?” Philip guarda a nord e di colpo si rende conto che è da almeno quindici minuti che sente quel rumore infernale di mille e uno lamenti. Legioni di zombie migrano verso il loro condominio, molto probabilmente attirati dal rumore e dallo spettacolo dei corpi che colpiscono la strada. Al momento sono a forse dieci o dodici isolati di distanza e si muovono col movimento strisciante e ondulatorio dei grumi di sangue nelle arterie. Per un attimo, Philip non riesce a distogliere lo sguardo da quella orripilante migrazione. Vengono da tutte le direzioni. Si infilano tra le ombre, sgocciolano fuori dai vicoli, intasano le vie principali, si incontrano e si moltiplicano agli incroci come una grande ameba che cresce di taglia e di potenza, inesorabilmente attratti dal catalizzatore degli umani in mezzo a loro. Alla fine, Philip distoglie lo sguardo e dà una pacca sulla spalla al vecchio. “Colpa nostra, David… colpa nostra.” Quella notte, cercano di cenare e fingere che si tratti di una normale cena tra amici, ma i rumori persistenti che giungono dall’esterno dell’edificio continuano a uccidere la conversazione. I suoni sono un costante promemoria del loro esilio, della minaccia mortale che si trova fuori dalla porta, del loro isolamento. Si raccontano la storia delle loro vite e cercano di fare del loro meglio, ma i rumori minacciosi sfibrano i nervi di tutti. Considerando che ci sono altri diciassette appartamenti nel palazzo, quel giorno si aspettavano di trovare una buona quantità di provviste. Ma hanno trovato solo alcuni cibi secchi nelle dispense, un po’ di cereali, della pasta, una mezza dozzina di scatole di zuppa, qualche pacchetto di cracker stantii e alcune bottiglie di vino a buon mercato. Il condominio era stato abbandonato ormai da settimane, restando senza elettricità e infestato dai morti: tutto il cibo era marcito. I vermi si erano introdotti nella maggior parte dei frigoriferi e anche la biancheria, i vestiti e i mobili si erano ammuffiti e impregnati del fetore degli zombie. Forse la gente aveva portato con sé l’essenziale quando era fuggita. Forse aveva preso tutta l’acqua in bottiglia, le batterie, le torce elettriche, i fiammiferi e le armi. Avevano però lasciato perdere gli armadietti dei medicinali e Tara era riuscita a riempire una scatola di scarpe di pillole: tranquillanti come Xanax e Valium, stimolanti come Adderall e Ritalin, farmaci per la pressione, pillole contro l’obesità, betabloccanti, antidepressivi e pillole per il colesterolo. Aveva trovato anche un paio di bottiglie di broncodilatatori, che sarebbero stati molto utili al vecchio. Philip è divertito dal comportamento di Tara che, con l’evidente pretesto di preoccuparsi per la salute degli altri, in realtà è interessata a trovare qualsiasi cosa possa fornirle un piacevole sballo. E chi diavolo può biasimarla? In quella situazione il sollievo donato dai farmaci è una fuga buona come un’altra. La verità è che, in quella seconda notte, nonostante il baccano costante dei non morti fuori dalle finestre, la famiglia Chalmers ha cominciato a piacere sempre di più a Philip. Gli piacciono. Gli piace il loro stile country-bohémien, gli piace il loro coraggio e semplicemente gli piace stare con altri sopravvissuti. Anche Nick sembra aver trovato nuove energie dall’unione delle due famiglie e Penny ha addirittura ripreso a parlare con gli occhi limpidi per la prima volta da settimane. Philip è convinto che la presenza di altre femmine sia proprio quel che ci vuole per sua figlia. Persino Brian, ormai del tutto guarito dal suo raffreddore, sembra più forte e sicuro di sé. Ha ancora molta strada da fare, ma appare galvanizzato dalla prospettiva di vivere in un qualche tipo di comunità, per quanto piccola e malconcia sia. Il giorno dopo, cominciano a stabilire una routine. Dal tetto Philip e Nick controllano il numero di zombie nelle strade, mentre Brian verifica i punti deboli del primo piano, le finestre, le uscite di sicurezza, il cortile e l’ingresso principale. Penny comincia a conoscere le sorelle Chalmers; David per lo più pensa ai fatti suoi. Il vecchio combatte contro la malattia ai polmoni meglio che può. Pisola, usa l’inalatore e parla il più possibile coi nuovi arrivati. Nel pomeriggio, Nick lavora su una passerella di fortuna che progetta di gettare tra il tetto del condominio e quello dell’edificio vicino. Si è convinto di poter arrivare al cavalcavia all’angolo senza mettere piede al suolo. Philip pensa che sia una follia, ma gli dice di andare avanti e di sprecare così il suo tempo se vuole farlo. Nick crede che quel tentativo rappresenti la loro unica possibilità di sopravvivere, specie da quando li ha assaliti la preoccupazione tacita, ma evidente sulla faccia di tutti quelli che entrano in cucina, che presto finiranno le provviste. Nel condominio non c’è più acqua corrente e portare secchi pieni di escrementi umani dal bagno alla finestra affacciata sul cortile (che usano come discarica) è l’ultimo dei loro problemi. Hanno una scorta d’acqua limitata e questo li affligge davvero. Quella notte, dopo cena, poco dopo le otto, quando una pausa imbarazzante nella conversazione rammenta a tutti i rumori che provengono incessanti dalle tenebre di fuori, Philip ha un’idea. “Perché non ci suonate qualcosa” dice. “Coprite il rumore di quei bastardi.” “Ehi” dice Brian, con gli occhi che gli si illuminano. “È un’idea fantastica.” “Siamo un po’ arrugginiti” dice il vecchio dalla sua sedia a dondolo. Sembra stanco e tirato: la malattia sta esigendo il suo tributo. “Se devo essere sincero, non abbiamo più suonato una nota da quando tutto questo è cominciato.” “Coniglio” osserva dal divano Tara, intenta ad arrotolarsi una sigaretta fatta di granelli di tabacco, semi e gambi sul fondo della sua piccola scatola di cerotti. Gli altri si siedono in cerchio nel soggiorno, rinvigoriti dalla prospettiva di ascoltare la World Famous Chalmers Family Band. “Dai, papà” interviene April. “Possiamo suonare The old rugged cross.” “Naa, non hanno voglia di sentire quei vaneggiamenti religiosi, non in momenti come questi.” Tara muove già la sua corpulenta figura attraverso la stanza in direzione della gigantesca custodia del suo contrabbasso, con la sigaretta improvvisata che le pende dalle labbra. “Scegli tu, papà, io ti vengo dietro col basso.” “Bah, che male può fare?” cede David Chalmers, mentre solleva il corpo scricchiolante dalla sedia a dondolo. I Chalmers estraggono gli strumenti dalle custodie e li accordano. Quando sono pronti, si posizionano in una formazione serrata, sincronizzati come un drappello dei marines in parata, con April davanti, alla chitarra e David e Tara di lato e un po’ arretrati, rispettivamente al mandolino e al contrabbasso. Philip può solo immaginarseli sul palco del Grand Ole Opry, e vede Brian, dall’altra parte della stanza, del tutto assorbito. Una cosa sola si può dire di Brian Blake: conosce la musica. Philip si è sempre meravigliato della sua profonda conoscenza di quell’argomento e adesso, di fronte a quel dono inatteso, Philip immagina che Brian sia al settimo cielo. Cominciano a suonare. Philip resta immobile. Ha la sensazione che il suo cuore sia stato improvvisamente riempito di elio. Non è solo l’inattesa e cruda bellezza della loro musica: il primo pezzo è una piacevole, vecchia danza vivace irlandese, con una triste, martellante linea di bassi e un vivace motivo di chitarra, che ricorda un vecchio organetto. Non è nemmeno il fatto che la piccola, dolce Penny, seduta sul pavimento con gli occhi sognanti, sembri di colpo trasportata dalla melodia. E neppure il fatto che una canzone semplice e delicata contro tutte quelle brutture spezza il cuore di Philip. È quando April comincia a cantare che l’anima di Philip si riempie di una dolcezza irrequieta. C’è un’ombra sulla mia parete, ma non mi spaventa affatto Sono felice per tutta la notte nei miei sogni Limpida e pungente come una campana di vetro, con una tonalità perfetta, la spettacolare voce da contralto di April risuona vellutata nella stanza. Accarezza le note con un accenno di chiesa e insieme una lieve ma profonda impertinenza che ricorda a Philip la cantante di un coro in una cappella di campagna. Nei miei sogni, nei miei sogni Sono felice per tutta la notte nei miei sogni Sono al sicuro qui nel mio letto, nella mia testa ci sono pensieri felici E sono felice per tutta la notte nei miei sogni Quella voce risveglia in Philip un desiderio doloroso, qualcosa che non aveva più provato da quando era morta Sarah. All’improvviso sembra dotato di una vista a raggi X. Scopre in April Chalmers, intenta a strimpellare le sei corde e gorgheggiare allegramente, alcuni particolari che non aveva ancora notato. Vede una catenella che le gira sottile intorno alla caviglia, una piccola rosa tatuata nell’incavo del braccio e le pallide mezze lune dei seni, bianchi come madreperla, tra i bottoni allacciati della camicetta. La canzone giunge al termine e tutti applaudono, Philip con più vigore degli altri. Il giorno seguente, dopo una misera colazione a base di cereali stantii e latte in polvere, Philip nota April, di spalle davanti alla porta d’ingresso, che si infila gli scarponi da trekking e avvolge le maniche della sua felpa con del nastro isolante. “Pensavo che una seconda tazza ti avrebbe fatto piacere” le dice Philip con innocenza, avvicinandosi a lei con una tazza di caffè in ciascuna mano. “È istantaneo ma non fa del tutto schifo.” Si accorge che April si sta avvolgendo le caviglie con del nastro isolante. “Che diavolo fai?” Lei guarda il caffè. “Hai usato quello che restava in quella brocca?” “Credo di sì.” “Ci rimangono solo cinque litri per tutti e sette fino all’anno del mai.” “Mi dici cosa ti passa per la testa?” “Non farne un affare di stato.” Tira su la zip della felpa e stringe l’elastico sulla coda di cavallo, infilandola nel cappuccio. “È un po’ che ci penso e voglio farlo da sola.” “Pensi a cosa?” La donna allunga una mano dentro il guardaroba ed estrae una mazza da baseball di metallo. “L’abbiamo trovata in un appartamento; sapevo che un giorno mi sarebbe servita.” “Cos’hai intenzione di fare, April?” “Hai presente quella scala antincendio sul lato sud del condominio?” “Non andrai là fuori da sola.” “Potrei scivolare fuori dal 3F, scendere le scale e attirare gli azzannatori fuori dal palazzo.” “No… no.” “Attirarli abbastanza a lungo per andare a prendere le provviste e poi tornare dentro.” Philip vede i suoi stivali da lavoro lerci accanto alla porta, dove li ha lasciati la sera prima. “Ti spiace passarmi quegli stivali?” dice. “Se proprio hai deciso di farlo, col cazzo che te lo lascio fare da sola.” DODICI Ancora una volta, mentre Philip si sporge dalla finestra a sud dell’appartamento 3F, la prima cosa che lo colpisce forte dritto in faccia, è l’odore: un gumbo6 ramato di escrementi umani cotti lentamente nel grasso di maiale, un odore orribile da farlo quasi indietreggiare. S’infila nell’apertura e gli occhi cominciano a lacrimargli. Non si abituerà mai a quella puzza. Esce su un pianerottolo traballante di ferro arrugginito. La piattaforma, collegata a una scala che serpeggia giù per tre piani fino a una strada laterale, vacilla sotto il suo peso. Il suo stomaco sobbalza per l’improvviso cambio di gravità e Philip si aggrappa alle sbarre. Il tempo si è fatto uggioso e umido, il cielo ha il colore dell’asfalto e il vento ulula da nord-est infilandosi tra i lontani canyon di cemento. Per fortuna, in basso ci sono solo pochi azzannatori erranti nella stretta strada laterale che costeggia il lato sud del condominio. Philip dà un’occhiata all’orologio. Tra meno di un minuto e quarantacinque secondi, April rischierà la vita sul davanti dell’edificio e quell’urgenza lo spinge a mettersi in movimento. Scende rapido la prima rampa e la scala pericolante geme sotto il suo peso, tremando a ogni passo. Mentre scende, sente gli occhi argentei delle cose morte fissarsi su di lui, attirati dai rumori metallici della scala: i loro sensi primitivi lo individuano, lo annusano, percepiscono le sue vibrazioni come i ragni sentono una mosca nella ragnatela. Sagome scure, ai margini della sua visione periferica, cominciano a trascinarsi pigre verso di lui, e altre, sempre più numerose, svoltano l’angolo che dà sulla facciata del palazzo per indagare. Non avete ancora visto niente, pensa saltando a terra e attraversando di corsa la strada. Sessantacinque secondi. Il piano è di entrare e uscire in fretta: Philip si muove lungo le vetrine sbarrate con la circospezione di un marine della Delta Force. Raggiunge l’estremità orientale dell’isolato e trova una Chevy Malibu con la targa di un altro stato abbandonata. Trentacinque secondi. Riesce a sentire i passi strascicati avvicinarsi mentre si accuccia dietro la Malibu e si toglie rapido lo zaino. Le sue mani non tremano mentre estrae la bottiglia da mezzo litro di Coca-Cola piena di benzina (April ha trovato una tanica di benzina di scorta nello stanzino degli attrezzi del condominio). Venticinque secondi. Svita il tappo, ci inserisce uno straccio imbevuto di benzina e infila l’estremità della bottiglia nel tubo di scappamento della Malibu, lasciando penzolare una trentina di centimetri dello straccio. Venti secondi. Prende un accendino Bic, lo fa scattare e dà fuoco allo straccio. Quindici secondi. Scappa via. Dieci secondi. Attraversa la strada, sfiorando un gruppo di azzannatori, e si nasconde in una nicchia buia; poi si accuccia dietro una fila di bidoni dell’immondizia, prima di sentire il WHOOMP della prima esplosione, la bottiglia infilata nel tubo di scappamento, seguita da un’esplosione molto più potente. Philip si china e si copre: il boom sonico scuote la strada e una palla di fuoco si alza verso il cielo illuminando le tenebre. Preciso come un orologio, pensa April accucciata nell’ombra dell’ingresso, mentre l’onda d’urto fa tremare la porta di vetro. La luce che erompe è come il flash di un fotografo invisibile. April sbircia fuori dalla parte inferiore della porta sbarrata e percepisce un cambiamento nelle onde dell’oceano di morti. Come una marea di facce livide e devastate che si sposta per l’effetto degli strattoni gravitazionali della luna, i non morti seguono il rumore e la luce, diretti come una massa disordinata verso il lato sud del palazzo. Un pezzo di latta che scintilla al sole non attirerebbe uno stormo di sparvieri come quell’esplosione ha fatto con gli azzannatori. In un minuto circa, la strada davanti al condominio è deserta. April si fa coraggio. Prende un respiro profondo. Stringe le cinghie dei borsoni. Chiude gli occhi. Mormora una preghiera veloce e silenziosa… e balza in avanti, tirando via il chiavistello improvvisato e spalancando la porta. Esce furtiva. Il vento le scompiglia i capelli e il fetore la soffoca. Si tiene bassa mentre attraversa la strada di scatto. Il sovraccarico sensoriale minaccia di distrarla: gli odori, l’orda a solo mezzo isolato di distanza, il battito tuonante del suo cuore: si muove frenetica davanti alle vetrine buie. Per fortuna, ha acquisito abbastanza familiarità con la zona e sa dove si trova l’emporio. Misurato con un cronometro, il tempo che le occorre per scivolare tra le fauci dentellate dei vetri rotti e perlustrare l’interno dell’emporio saccheggiato è di undici minuti e trentatré secondi. Solo undici minuti e mezzo per riempire una borsa di tela e metà di un’altra con cibo, acqua e altri viveri sufficienti a farli sopravvivere ancora un po’. Ma per April Chalmers, quegli undici minuti e mezzo sembrano sospesi nel tempo. Prende quasi quindici chili di roba dall’emporio, inclusa della carne in scatola tanto zeppa di conservanti da durare fino a Natale, una decina di litri di acqua distillata, tre stecche di Marlboro rosse, accendini, carne di manzo, vitamine, medicine per il raffreddore, una pomata antibatterica e sei rotoli extra di benedetta carta igienica; getta tutto nel suo borsone alla velocità del lampo. Mentre continua a darsi da fare con la consapevolezza costante del tempo che passa, avverte un formicolio alla nuca: se non torna indietro nel giro di pochi minuti, la strada tornerà a riempirsi e l’esercito degli azzannatori le bloccherà il percorso. Philip spara un altro mezzo caricatore di proiettili calibro .22, per farsi strada verso il retro del condominio. La maggior parte degli azzannatori è radunata intorno ai rottami in fiamme della Malibu: un ammasso di cadaveri semoventi simili a insetti attirati dalla luce. Philip si apre un varco verso il retro del cortile sparando due colpi. Uno fa saltare il cranio di un cadavere che, vestito con una tuta da footing, avanza sgraziato verso di lui: lo zombie cade come una marionetta a cui siano stati recisi i fili. Un altro sparo apre un buco nel cranio di quella che sembra essere stata una senzatetto: lo zombie cade e i suoi occhi incavati sono attraversati da un guizzo. Prima che altri azzannatori possano avvicinarglisi, Philip balza oltre lo steccato del cortile e corre sull’erba di un marrone malsano. Si arrampica sul muro posteriore dell’edificio, usando una tenda come punto d’appoggio. A metà del muro intonacato del primo piano c’è una seconda scala antincendio: Philip la afferra e inizia a salire. Ma di colpo si blocca, assalito da un ripensamento riguardo al piano. April è ormai giunta al punto critico della sua missione: sono passati dodici minuti da quando è uscita, ma si arrischia a passare in rassegna un altro negozio. Mezzo isolato più a sud, c’è un negozio Ace Hardware vuoto, con le vetrine sfondate: le inferriate sono abbastanza larghe perché una donna minuta possa passarci. Scivola attraverso una fessura ed entra nel negozio buio. Riempie lo spazio rimasto della seconda borsa di tela con filtri per l’acqua (per rendere potabile l’acqua immobile nei bagni), una scatola di chiodi (per rimpolpare la loro scorta, che hanno utilizzato per mettere in sicurezza le barricate), evidenziatori e rotoli di carta di grande formato (per realizzare cartelli di avvertimento destinati ad altri sopravvissuti), lampadine, batterie, lattine di gelatina infiammabile Sterno e tre piccole torce elettriche. Sulla via del ritorno verso l’uscita del negozio, carica di quasi venti chili di roba in due borse stracolme, oltrepassa una figura curva alla fine di una corsia laterale piena di isolanti in vetroresina. April si ferma. Alla ragazza morta e appoggiata alla parete più lontana, manca una gamba. Dalle tracce insanguinate di unghie sul pavimento, è chiaro che si è trascinata fin lì. Non è molto più grande di Penny. April resta a bocca aperta per un attimo. Sa che deve andarsene, ma non riesce a distogliere lo sguardo dal cadavere patetico e malconcio che giace nei suoi stessi umori corporei, ovviamente colati dal moncherino annerito della gamba destra. “Oh, Dio, non ce la faccio” dice April sottovoce, senza sapere nemmeno lei cosa davvero non riesca a fare: porre fine alle sofferenze della cosa o lasciarla soffrire per l’eternità in quella ferramenta deserta. April prende la mazza di metallo dalla cintura e posa a terra le borse. Si avvicina cauta. La cosa morta sul pavimento si muove a stento e alza appena lo sguardo col tremolante stupore di un pesce che muore sul ponte di una barca. “Mi dispiace” sussurra April, poi affonda la mazza nel cranio della ragazza. Il colpo produce il suono umido e schioccante della legna verde che si spezza. La cosa si piega silenziosa sul pavimento. Ma April resta lì e chiude gli occhi per un istante per cancellare quell’immagine dalla sua mente, un’immagine che probabilmente la perseguiterà per il resto della vita. La vista del fusto della mazza che spacca quella testa è già abbastanza brutta, ma nel breve e terribile istante in cui ha tirato indietro e sollevato la mazza prima di calarla, April ha visto dell’altro: se per un insignificante riflesso dei nervi senza vita o per una qualche comprensione più profonda, la ragazza morta ha girato la testa proprio un attimo prima che la mazza calasse su di lei. Un rumore proveniente dal davanti del negozio attira la sua attenzione: April si affretta a riprendere i borsoni e infila i manici sulle spalle diretta verso l’uscita. Ma non va molto lontano. Si blocca all’istante alla vista di una seconda ragazza che le blocca la strada. È a quasi cinque metri di distanza, appena dentro le saracinesche contorte, nello stesso identico vestito infangato della ragazza che ha appena eliminato. Sulle prime, April pensa che i suoi occhi le stiano facendo un brutto scherzo. Oppure si tratta del fantasma della ragazza che ha appena ucciso. O forse sta perdendo il senno. Ma quando la seconda ragazza morta comincia a trascinarsi lungo la corsia, diretta verso di lei con entrambe le gambe al loro posto e la bava nera che le cola dalle labbra spaccate, April capisce: erano gemelle. È la gemella identica dell’altra ragazza. “Ci siamo” dice April, tirando indietro la mazza, caricando il peso e preparandosi a combattere per aprirsi la strada. Fa un passo verso il minuscolo mostro e solleva la mazza, quando uno schiocco secco risuona da dietro la gemella e April sbatte le palpebre. La pallottola schianta un angolo della vetrina e fa esplodere la parte superiore della testa della gemella. April si ritira per evitare lo spruzzo di sangue, mentre la ragazza si accascia in un ammasso informe. April si lascia sfuggire un doloroso sospiro di sollievo. Philip Blake è fuori dal negozio, in mezzo alla strada deserta, intento a inserire un nuovo caricatore nella Ruger calibro .22. “Sei lì dentro?” chiama. “Sì! Sto bene!” “So che non è educato mettere fretta a una signora, ma stanno tornando!” April afferra i suoi tesori, salta sopra i resti insanguinati che bloccano la corsia ed emerge sulla strada scivolando tra le sbarre della saracinesca. Capisce il problema all’istante: la schiera di zombie sta tornando, pronta ad aggirare l’angolo col fervore collettivo di un gruppo di ballerini di fila dementi che si muovono in una formazione casuale. Philip afferra una delle borse e tutti e due cominciano a correre verso il palazzo. Attraversano la strada in pochissimi secondi, con almeno cinquanta azzannatori su ogni lato. Brian e Nick sbirciano fuori dai vetri rinforzati dell’altra porta dell’ingresso quando si accorgono che nella strada la situazione sta cambiando in fretta. Vedono branchi di zombie venire lungo la strada da entrambe le direzioni, di ritorno dal fottuto posto in cui erano appena andati. In mezzo a tutto questo, due esseri umani, un maschio e una femmina, come i possessori di palla di uno sport misterioso e surreale, corrono verso il condominio con due borsoni a tracolla che gli rimbalzano sulla schiena. Nick si rallegra. “Eccoli!” “Grazie a Dio” dice Brian, abbassando il fucile Marlin fin quando il calcio non tocca il pavimento. Trema. Si ficca in tasca la mano sinistra e cerca di controllarsi. Non vuole che suo fratello lo veda tremare. “Apriamo la porta” dice Nick, appoggiando il fucile in un angolo. Apre la porta proprio mentre Philip e April corrono lungo il vialetto, con una moltitudine di azzannatori alle calcagna. April si getta dentro la porta per prima, tremante e in iperventilazione per l’adrenalina. Philip la segue con gli occhi neri brillanti per la carica di testosterone. “Questa sì che è vita!” Nick sbatte la porta giusto in tempo. Tre azzannatori vanno a sbattere contro il vetro: sbatacchiano la porta rinforzata d’acciaio e lasciano strisce di bava con la bocca. Numerose paia di occhi bianco latte scrutano le persone nell’ingresso attraverso le vetrate sporche. Dita morte provano ad artigliare la porta. Altri azzannatori barcollano su per il vialetto. Brian punta il fucile verso le figure fuori dalla porta e poi indietreggia. “Che diavolo succede, fratello? Dove eravate andati?” Nick li accompagna verso la porta interna e da lì nell’ingresso. April lascia cadere il borsone stracolmo. “Ci siamo andati… molto… Gesù, molto vicino!” Philip posa a terra il suo zaino. “Ragazza, hai davvero i cojones, te lo concedo.” Nick si fa avanti. “Qual era l’idea, Philly? Quella di sparire e basta, senza dire niente a nessuno?” “Parla con lei” dice Philip con un sorriso, infilandosi la Ruger nella cintura. “Stavamo per impazzire!” inveisce Nick. “Tra un secondo saremmo venuti fuori a cercarvi!” “Calmati, Nicky.” “Cal marmi ? Calmarmi! Abbiamo rivoltato questo posto da capo a piedi per cercarvi! A Tara stava per venire un cazzo di infarto!” “È colpa mia” dice April, sfregandosi la sporcizia dal collo. “Guarda il nostro bottino, amico!” Philip indica il bottino stipato nelle borse. Nick ha i pugni stretti. “Poi abbiamo sentito una fottuta esplosione! Cosa dovevamo pensare? Siete stati voi, ragazzi? Avete qualcosa a che fare anche con quella?” Philip e April si scambiano uno sguardo e Philip risponde: “È stata un’idea di tutti e due, più o meno”. April non riesce a soffocare il suo sorriso vittorioso, mentre Philip fa un passo verso di lei, sollevando la mano. “Che ne dici di un cinque, tesoro?” Si scambiano un cinque, mentre Nick e Brian li guardano increduli. Nick è sul punto di dire qualcos’altro quando una figura compare all’altro lato dell’ingresso, attraversando la porta interna. “Oh, mio Dio!” Tara si precipita nella stanza verso sua sorella. Attira April in un forte abbraccio. “Oh, mio Dio, ero così spaventata! Grazie a Dio stai bene! Grazie a Dio! Grazie a Dio!” April le dà una pacca sulle spalle. “Scusa, Tara, ma dovevo farlo.” Tara la lascia, con la faccia rossa di rabbia. “Dovrei picchiarti a sangue. Sul serio! Ho detto a quella bambina che eri andata di sopra, ma è spaventata quanto me! Cosa avrei dovuto fare? È stata una cosa maledettamente stupida e irresponsabile! Una cosa da te, April!” “E questo che diavolo significa?” April si avvicina naso a naso alla faccia di sua sorella. “Perché non dici quello che pensi, per una volta?” “Troia del cazzo.” Tara solleva una mano intenzionata a schiaffeggiare la donna più giovane, quando all’improvviso Philip si intromette. “Buona lì, bellezza!” Philip le dà una pacca rassicurante. “Aspetta un secondo. Fa’ un respiro profondo, sorella.” Philip indica con un cenno i due borsoni. “Voglio farti vedere una cosa. Okay? Calma i bollenti spiriti per un secondo.” Si inginocchia e apre le borse, mostrandone il contenuto. Gli altri osservano le provviste in silenzio. Philip si raddrizza e guarda Tara negli occhi. “Quella ‘troia del cazzo’ ci ha salvato il culo oggi: ci sono cibo e acqua là dentro. Quella ‘troia del cazzo’ ha rischiato il suo culo senza sapere se sarebbe riuscita a cavarsela e senza lasciare che qualcun altro si facesse male. Dovresti baciarle i piedi, a quella ‘troia del cazzo’.” Tara distoglie lo sguardo dai borsoni e lo abbassa sul pavimento. “Eravamo preoccupati, ecco tutto” dice con voce bassa e flebile. Nick e Brian si inginocchiano accanto ai borsoni, esaminando i tesori. “Philly” dice Nick. “Devo ammetterlo: voi ragazzi siete davvero forti.” “Voi ragazzi spaccate” mormora sottovoce Brian, meravigliato e intento a rovistare tra la carta igienica, la carne di manzo e i filtri per l’acqua. L’atmosfera emotiva della stanza cambia con la lenta certezza delle nuvole che si aprono e un sorriso si allarga sulla faccia di tutti. Presto anche Tara rivolge uno sguardo riluttante da sopra la spalla al contenuto dei borsoni. “C’è qualche sigaretta là dentro?” “Ecco tre stecche di rosse” dice April, chinandosi per estrarre le sigarette. “Goditele, troia del cazzo.” Con un sorriso innocente, lancia le stecche alla sorella. Tutti ridono. Nessuno vede la piccola figura dall’altra parte della stanza, nell’ingresso interno, finché Brian non alza lo sguardo. “Penny? Stai bene, piccola?” La bambina apre la porta ed entra. È ancora in pigiama e sul suo viso di crema e pesche è cesellato uno sguardo serioso. “Quell’uomo là dentro, il signor Chahmerz? È caduto a terra.” Trovano David Chalmers sul pavimento della camera da letto padronale, in mezzo a un gran numero di fazzoletti di carta e medicinali. Frammenti di vetro di una bottiglia di dopobarba rotta scintillano come un’aureola attorno alla sua testa tremante. “Gesù! Papà!” Tara si inginocchia accanto all’uomo caduto, togliendogli il tubo dell’ossigeno. La faccia raggrinzita di David ha il colore della nicotina mentre ansima involontariamente in cerca di aria, come un pesce fuor d’acqua che cerca di respirare l’atmosfera velenosa. “Sta soffocando!” April accorre all’altro lato del letto, per controllare la bombola d’ossigeno, che giace sul pavimento avvolta nel tubo. Il vecchio deve esserselo tirato via quando è caduto. “Papà? Mi senti?” Tara dà una serie di schiaffi leggeri e veloci alla faccia cinerea dell’uomo. “Controllagli la lingua!” “Papà? Papà?” “Controllagli la lingua, Tara!” April corre intorno al letto, con la bombola d’ossigeno e un tubo arrotolato nelle mani. Intanto gli altri, Philip, Nick, Brian e Penny, osservano dalla porta. Philip si sente impotente. Non sa se intromettersi o restare a guardare. Le ragazze sembrano sapere quello che fanno. Tara apre con gentilezza la bocca del vecchio, osservando la gola. “È vuota.” “Papà?” April si inginocchia accanto all’altro fianco del padre, piazzando il sottile apparato respiratorio sotto il suo naso a becco. “Papà, riesci a sentirmi?” David Chalmers continua ad ansimare in silenzio e il fondo della sua gola schiocca dolorosamente come un disco incantato. Le palpebre, antiche e traslucide come ali di un’efemera, tremano. Tara tasta freneticamente la parte posteriore della testa in cerca di ferite. “Non vedo sangue” dice. “Papà?” April gli sente la fronte. “È gelato.” “L’ossigeno è aperto?” “Al massimo.” “Papà?” April riposiziona delicatamente il vecchio in modo che giaccia supino, col tubo dell’ossigeno sopra il labbro superiore. Gli danno di nuovo degli schiaffi leggeri. “Papà? Papà? Papà, puoi sentirci? Papà?” Il vecchio tossisce, sbattendo le palpebre. Cerca di prendere una buona boccata d’aria, ma i respiri convulsi continuano a occludergli la gola. Gli occhi sono rovesciati all’indietro e sembra cosciente solo a metà. “Papà, guardami” dice April, voltandogli con un movimento gentile della mano la faccia verso la sua. “Puoi vedermi?” “Mettiamolo sul letto” suggerisce Tara. “Ragazzi, vi dispiacerebbe darci una mano?” Philip, Nick e Brian entrano nella stanza. Philip e Nick afferrano il vecchio da un lato, Tara e Brian dall’altro e al tre lo sollevano con attenzione dal pavimento e lo posano sul letto, facendo cigolare le molle. Nel posarlo, il tubo si attorciglia su un lato del corpo. Alcuni istanti dopo, districano il tubo e posano delle coperte sopra il vecchio. Solo il suo viso pallido e scavato emerge dalle lenzuola: gli occhi sono chiusi, la bocca è fiaccamente aperta e respira a singhiozzo. Sembra un motore a scoppio che rifiuta di accendersi. Di tanto in tanto le palpebre sbattono e qualcosa guizza dietro di esse, mentre le labbra si stringono in una smorfia; ma poi il volto torna a distendersi. Respira ancora… a malapena. Tara e April sono sedute ai lati del letto e accarezzano la sagoma magra sotto le coperte. Per un lungo istante, nessuno dice niente. Ma probabilmente tutti pensano la stessa cosa. “Pensi sia un infarto?” chiede piano Brian, qualche minuto più tardi, seduto fuori dalle porte a vetri scorrevoli. “Non lo so, non lo so.” April cammina avanti e indietro nel soggiorno e si morde le unghie, mentre gli altri sono seduti nella stanza, a guardarla. Tara è nella camera da letto, al capezzale del padre. “Senza cure mediche, che possibilità ha?” “È già successo prima?” “Gli è già capitato di avere qualche problema a respirare, ma mai niente del genere.” April smette di camminare. “Dio, sapevo che questo giorno sarebbe arrivato.” Si asciuga gli occhi, umidi di lacrime. “Siamo arrivati all’ultima bombola di ossigeno.” Philip chiede delle medicine. “Abbiamo le sue medicine, certo, ma adesso non gli serviranno a molto. Ha bisogno di un medico. Quel vecchio bacucco testardo ha saltato il suo ultimo appuntamento il mese scorso.” “Cosa abbiamo tra le scorte di medicinali?” chiede Philip. “Non lo so, abbiamo preso un po’ di merda di sopra, antistaminici e robaccia del genere.” April riprende a camminare. “Abbiamo dei kit di pronto soccorso. Capirai. Questa è una cosa seria. Non so cosa possiamo fare.” “Stiamo calmi e cerchiamo di trovare una soluzione.” Philip si strofina la bocca. “Adesso riposa tranquillamente, giusto? Le vie respiratorie sono libere. Non si sa mai, forse… si riprende.” “E se non lo fa?” April smette di camminare e lo fissa. “E se non si riprende?” Philip si alza e va verso di lei. “Ascolta. Dobbiamo essere lucidi.” Le dà una pacca sulla spalla. “Lo controlleremo a vista, troveremo una soluzione. È un tipo tosto.” “È un tipo tosto che sta morendo” dice April, mentre un’unica lacrima le scende lungo il volto. “Non puoi saperlo” dice Philip, asciugandole la lacrima dalla guancia. Lei lo guarda. “Bel tentativo, Philip.” “Coraggio.” “Bel tentativo.” Distoglie lo sguardo e la sua espressione avvilita è desolata come quella di una maschera funeraria. “Bel tentativo.” Quella notte, le sorelle Chalmers vegliano al capezzale del padre, con le sedie accostate ai due lati del letto e una lanterna a batteria a illuminare la pallida faccia del vecchio. L’appartamento è freddo come una cella frigorifera. April riesce a vedere il respiro di Tara dall’altra parte della stanza. Per gran parte della nottata il vecchio giace in un sonno di pietra; le sue guance scavate si contraggono a intervalli regolari mentre respira a fatica. Le rughe avvizzite sul mento sembrano limatura di ferro che si sposta dentro un campo magnetico, scosse come sono dai movimenti casuali del suo sistema nervoso danneggiato. Ogni tanto le labbra secche e spaccate si muovono impotenti, come nel tentativo di formare una parola. Ma a parte alcuni sbuffi secchi, l’uomo non riesce a pronunciare niente. A un certo punto, nel cuore della notte, April si accorge che Tara si è appisolata, con la testa appoggiata sul letto. April prende un’altra coperta e l’appoggia delicatamente sopra sua sorella. Sente una voce. “Lil?” Viene dal vecchio. I suoi occhi sono ancora chiusi, ma la bocca lavora alacremente e l’espressione del viso è corrugata dalla rabbia. Lil è il diminutivo di Lillian, la moglie defunta di David. April non sentiva quel soprannome da anni. “Papà, sono April” sussurra, accarezzandogli la guancia. Lui si ritrae, con gli occhi ancora chiusi. La bocca è contorta, la voce suona farfugliante e ubriaca a causa della paresi di un lato del volto. “Lil, porta dentro il cane! Sta arrivando una tempesta, una di quelle grosse, da nord-est!” “Papà, svegliati” sussurra dolce April. L’emozione cresce dentro di lei. “Lil, dove sei?” “Papà?” Silenzio. “Papà?” A quel punto, Tara si mette a sedere, sbattendo le palpebre, stupita dal suono strozzato della voce di suo padre. “Che succede?” dice, sfregandosi gli occhi. “Papà?” Il silenzio continua e il respiro del vecchio si fa più rapido e affannoso. “Pa…” La parola rimane nella gola di April mentre vede qualcosa di terribile attraversare la faccia del vecchio. Apre le palpebre tremanti a mezz’asta, mostrando il bianco degli occhi, e comincia a parlare con voce limpida in maniera allarmante: “Il diavolo ha un piano per noi”. Nella luce fioca e pallida della lanterna, le due sorelle si scambiano uno sguardo scoraggiato. La voce che proviene da David Chalmers è bassa e roca, come un motore diesel. “Il giorno della resa dei conti si avvicina… l’Ingannatore cammina in mezzo a noi.” Poi ripiomba nel silenzio, con la testa a ciondoloni su un lato del cuscino come se i cavi del cervello fossero stati recisi di netto. Tara controlla il polso. Guarda sua sorella. April guarda il viso di suo padre, che ha ormai assunto l’espressione distesa e rilassata di un sonno profondo e senza fine. Allo spuntare della luce del giorno, Philip si sveglia nel suo sacco a pelo sul pavimento del soggiorno. Si mette a sedere e si massaggia il collo indolenzito, con le articolazioni irrigidite dal freddo. Per un attimo, lascia che i suoi occhi si adattino alla luce fioca mentre si orienta nella stanza. Penny è sul divano, avvolta nelle coperte, e sembra dormire. Nick e Brian sono dall’altra parte della stanza, anche loro avvolti nelle coperte, e anche loro dormono. Il ricordo della veglia della sera prima ritorna per gradi nella mente di Philip insieme alla lotta agonizzante e disperata per aiutare il vecchio e attenuare le paure di April. Lancia un’occhiata all’altro lato della stanza. Nell’ombra del corridoio adiacente, la porta della camera da letto padronale, visibile nel buio, è ancora chiusa. Philip esce dal sacco a pelo e si veste in fretta e in silenzio. Si tira su i pantaloni e si infila gli stivali. Si passa le dita tra i capelli e va in cucina per sciacquarsi la bocca. Sente il mormorio delle voci al di là delle pareti. Si avvicina alla porta della camera da letto e si mette in ascolto. Sente la voce di Tara. Sta pregando. Philip bussa delicatamente. Un attimo dopo, la porta si apre e April appare sull’ingresso. Lo guarda come se qualcuno le avesse gettato dell’acido negli occhi. Sono umidi e iniettati di sangue come se fossero stati torturati. “’Giorno” dice con un filo di voce. “Come sta?” Le sue labbra tremano. “Non sta più.” “Cosa?” “È andato, Philip.” Philip la fissa. “Oh, Dio…” Deglutisce a fondo. “Mi dispiace davvero, April.” “Già, beh…” Comincia a piangere. Dopo un momento d’imbarazzo, un’ondata di emozioni contrastanti irrompe nelle viscere di Philip, che l’attira a sé in un abbraccio. La stringe e le accarezza la testa. Lei trema tra le sue braccia come una bimba smarrita. Philip non sa cosa dire. Da sopra la spalla di April, scorge l’interno della stanza. Tara Chalmers è inginocchiata sul letto di morte e prega in silenzio con la testa china sul lenzuolo aggrovigliato. Una delle mani è posata sulla mano fredda e nodosa del defunto padre. Per un’oscura ragione, che non riesce a spiegarsi, Philip trova difficile distogliere gli occhi dalla vista della mano della ragazza che accarezza le dita esangui del morto. “Non riesco a farla uscire da quella camera.” April è seduta al tavolo della cucina e beve una tazza di tè tiepido e mediocre, preparato col fuoco di una lattina di Sterno. I suoi occhi sono puliti per la prima volta da quando quella mattina è uscita dalla camera mortuaria. “Poverina… credo che voglia provare a riportarlo in vita pregando.” “Non ha niente di cui vergognarsi” dice Philip. Sta seduto dall’altra parte, con un piatto di riso mangiato a metà davanti a sé. Non ha appetito. “Hai pensato a quello che volete fare a riguardo?” chiede Brian dall’altra parte della cucina. È accanto al lavandino e versa l’acqua, raccolta da qualche bagno dei piani superiori, dentro una serie di barattoli filtrati. Dall’altra stanza giunge il rumore di Nick e Penny che giocano a carte. April alza lo sguardo verso Brian. “A riguardo di cosa?” “Tuo padre… sai… tipo, seppellirlo?” April sospira. “Tu ci sei già passato, vero?” chiede a Philip. Philip guarda il riso che ha lasciato sul piatto. Non ha idea se stia parlando di Bobby Marsh o di Sarah Blake: l’altra notte le ha raccontato di entrambe le morti. “Sissignora, proprio così.” La guarda. “Qualsiasi cosa tu intenda fare, noi ti aiuteremo.” “Lo seppelliremo, naturalmente.” La sua voce si rompe. Abbassa lo sguardo. “Anche se non avrei mai immaginato di farlo in un posto come questo.” “Lo faremo insieme” dice Philip. “Lo faremo come si deve, nel modo giusto.” April continua a guardare in basso e una lacrima cade nel suo tè. “Odio tutto questo.” “Dobbiamo restare uniti” dice Philip senza troppa convinzione. Lo dice perché non sa cos’altro dire. April si asciuga gli occhi. “C’è un pezzo di terra fuori, sotto il…” Un rumore brusco, proveniente dal corridoio, la interrompe e tutte le teste si girano. È un tonfo ovattato, seguito da uno schianto e dal rumore di mobili ribaltati. Philip è già in piedi, prima che gli altri abbiano il tempo di realizzare che il rumore arriva da dietro la porta chiusa della camera da letto padronale. TREDICI Philip spalanca la porta con un calcio. Ci sono candele dell’avvento sul pavimento e il tappeto brucia in più punti. L’aria fumosa vibra di grida. Nell’oscurità, Philip coglie un movimento indistinto e resta senza fiato per alcuni istanti, necessari a comprendere quanto sta vedendo nel buio tremolante. Il comodino ribaltato, la fonte dello schianto che hanno udito poco prima, è caduto a pochi centimetri da Tara, e la donna, stesa sul pavimento, striscia con istinto animalesco, nel disperato tentativo di liberarsi dalla potente stretta che delle dita morte stanno operando sulle sue gambe. Dita morte? Sulle prime, solo per un istante, Philip pensa che qualcosa sia entrato da una finestra, ma poi vede sul pavimento la forma avvizzita di David Chalmers. Adesso del tutto girato verso di lui, il vecchio è sopra le gambe di Tara e conficca le unghie ingiallite nella carne di lei. La faccia scavata del vecchio è livida, del colore della terra, e gli occhi sono bianchi e vitrei per le cataratte. Il suo ringhio è un lamento gutturale e famelico. Tara riesce a districarsi e a rimettersi faticosamente in piedi, poi si getta di lato verso il muro. Proprio allora, molte cose accadono contemporaneamente: Philip comprende quanto sta succedendo, si ricorda di aver lasciato la pistola in cucina e si rende conto di avere davvero pochissimo tempo per eliminare quella minaccia. Il punto cruciale sta tutto lì: il vecchio e gentile suonatore di mandolino è andato e quella cosa, quel famelico ammasso di tessuti morti risorto che sbava ringhiando in maniera confusa, è una minaccia. Più delle fiamme che lambiscono il tappeto, più del fumo, che crea una coltre infernale nella stanza, la cosa che si è materializzata dentro il loro rifugio costituisce una minaccia. Una minaccia per tutti loro. Nello stesso momento, prima che Philip abbia anche solo la possibilità di muoversi, arrivano gli altri e riempiono il vano della porta aperta. April esplode in un gemito d’angoscia, non un vero grido, piuttosto un verso di dolore, come un animale colpito al ventre. Cerca di farsi largo all’interno della stanza, ma Brian l’afferra e la tira indietro. April si divincola tra le sue braccia. Accade tutto nello spazio di un istante, durante il quale Philip vede la mazza. Con tutta l’agitazione della notte precedente, April ha lasciato la sua mazza da baseball di metallo autografata da Hank Aaron nell’angolo accanto alla finestra sbarrata, dove adesso riflette la luce tremolante delle fiamme. È a circa quattro metri da Philip. Non c’è tempo per considerare la distanza o anche solo per pianificare la manovra. Ha solo il tempo di fare un balzo attraverso la stanza. Intanto Nick si è girato e corre per l’appartamento in cerca del suo fucile. Brian prova a portare April fuori dalla stanza, ma lei è forte, è fuori di sé e urla. A Philip occorrono pochi secondi per coprire la distanza tra la porta e la mazza. Ma in quel breve lasso di tempo, la cosa che un tempo era David Chalmers si avvicina a Tara. Prima che la donna corpulenta possa riprendersi e fuggire, l’uomo morto è su di lei. Dita gelide e grigie si chiudono goffe sulla sua gola. Lei sbatte di nuovo contro la parete, dimenandosi e cercando di spingerlo via. Le mascelle putrescenti si aprono e le esalano l’alito rancido dritto in faccia. La bocca piena di denti anneriti si spalanca. La cosa punta alla curva pallida e carnosa della sua giugulare. Tara grida, ma prima che i denti la tocchino, la mazza si abbatte. Fino a quel momento, per Philip in particolare, l’atto di annientare un cadavere semovente era diventato un’azione quasi superficiale, un gesto meccanico e necessario come stordire un maiale prima di macellarlo. Ma stavolta è diverso. Gli occorrono solo tre colpi potenti. Il primo, un duro schianto sulla parte posteriore della regione temporale del cranio, immobilizza lo zombie e arresta il suo avvicinamento al collo di Tara. Lei scivola sul pavimento in un parossismo di lacrime e muco. Il secondo colpo centra la testa su un lato: la cosa si gira involontariamente verso il suo aggressore e l’acciaio temperato della mazza sfonda l’osso parietale e parte della cavità nasale, schizzando fili di materia rosa nell’aria. Il terzo e ultimo colpo sfonda l’emisfero sinistro del cranio: la cosa cade e il rumore che produce sembra quello di un cavolo infilato in un trapano industriale. Il mostro, che era stato David Chalmers, atterra in un cumulo umido su una delle candele rovesciate; i fili di bava, sangue e materia grigia appiccicosa colpiscono le fiamme e sfrigolano sul pavimento. Philip resta in piedi accanto al corpo, senza fiato, le mani ancora strette sulla mazza. Quasi a puntualizzare quell’orrore, un bip acuto prende a risuonare nella stanza. Allarmi antincendio alimentati a batteria cominciano a trillare in tutto il primo piano, e Philip impiega un secondo per identificare il segnale che gli vibra nelle orecchie. Lascia cadere la mazza. Ed è allora che nota la differenza. Questa volta, dopo questa eliminazione, nessuno si muove. April osserva dalla porta. Brian allenta la presa su di lei e anche lui resta a bocca aperta. Anche Tara, seduta contro la parete dall’altra parte della stanza, in preda a lacrime di repulsione e agonia, ha uno sguardo quasi catatonico. La cosa più strana è che anziché fissare il cumulo sanguinante sul pavimento, tutti fissano Philip. Spengono le fiamme e ripuliscono il posto. Avvolgono il corpo e lo spostano nel corridoio, dove sarà al sicuro fino alla sepoltura. Per fortuna Penny ha assistito a molto poco dello scontro nella stanza. Ha sentito abbastanza, però, e si è ritirata di nuovo nel suo guscio muto e invisibile. In effetti, per un bel po’ di tempo, nessuno ha molto da dire e il silenzio teso continua per tutto l’arco della giornata. Le sorelle sembrano piombate in una sorta di stupore scioccato: si limitano a compiere i movimenti necessari per pulire e non parlano nemmeno l’una con l’altra. Entrambe hanno pianto fino ad avere gli occhi asciutti. Ma continuano a fissare Philip, che percepisce i loro sguardi come dita gelide sulla nuca. Che diavolo si aspettavano? Cosa volevano che facesse? Doveva lasciare che il mostro divorasse Tara? Volevano che negoziasse con quella cosa? A mezzogiorno del giorno seguente, officiano un funerale improvvisato in una sezione del cortile circondata da un recinto di sicurezza. Philip insiste per scavare la fossa lui stesso, rifiutando anche l’aiuto di Nick. Ci vogliono ore. L’argilla della Georgia è tenace. Ma a metà pomeriggio, Philip, fradicio di sudore, ha finito. Le sorelle cantano la canzone preferita di David, Will the circle be unbroken, accanto alla sua tomba, facendo scoppiare in lacrime sia Nick che Brian. La melodia è straziante, specie quando si innalza nel cielo blu e si mischia con l’onnipresente coro di lamenti che giunge dall’altro lato del recinto. Più tardi, siedono tutti nel soggiorno e si dividono il liquore che hanno recuperato in uno degli appartamenti (e che tenevano in serbo per Dio solo sa cosa). Le sorelle Chalmers raccontano dell’infanzia del padre, dei suoi primi giorni nella Barstow Bluegrass Boys Band e del suo periodo come deejay alla WBLR alla periferia di Macon. Parlano del suo temperamento e della sua generosità, del suo essere un donnaiolo e della sua devozione a Gesù. Philip le lascia parlare e si limita ad ascoltare. È bello tornare a sentire le loro voci finalmente e la tensione del giorno precedente sembra allentarsi almeno un po’. Forse faceva tutto parte del processo necessario alle sorelle per lasciar andare il padre o forse avevano solo bisogno di rendersene conto. Più tardi, quella notte, Philip è solo in cucina e si riempie il bicchiere con le ultime due dita di whisky di malto, quando entra April. “Senti… volevo parlarti… a proposito di quello che è successo e tutto il resto.” “Lascia perdere” dice Philip, guardando il liquido color caramello nel suo bicchiere. “No, avrei dovuto… avrei dovuto dire qualcosa, ma immagino di essere stata sotto shock.” Lui la guarda. “Mi dispiace di averlo dovuto abbattere in quel modo, mi dispiace davvero. Mi spiace che tu abbia dovuto vederlo.” “Hai fatto quello che andava fatto.” “Ti ringrazio per averlo detto.” Philip le dà una pacca sulla spalla. “Tuo padre mi è piaciuto subito, era un gran bel soggetto. Ha vissuto una vita buona e lunga.” Lei si morde l’interno della guancia e Philip capisce che lotta contro l’impulso di piangere. “Pensavo di essere preparata a perderlo.” “Nessuno lo è mai.” “Già, ma in questo modo… sto ancora provando a capirci qualcosa.” Philip annuisce. “Un vero schifo!” “Voglio dire… una persona non… non abbiamo punti di riferimento per affrontare questo genere di stronzate.” “Capisco cosa intendi.” Lei si guarda le mani, che tremano. Forse il ricordo di Philip che sfonda il cranio di suo padre aleggia ancora. “Volevo solo dirti che… non ti biasimo per quello che hai fatto.” “Lo apprezzo.” Lei guarda il bicchiere di lui. “È rimasto un po’ di quel vino da poco?” Lui ne trova un po’ in una bottiglia e glielo versa. Bevono in silenzio, a lungo. Alla fine Philip dice: “E tua sorella?”. “Cosa?” “Non sembra…” La sua voce si spegne in mancanza delle parole giuste. April annuisce. “Dell’umore di perdonare?” “Qualcosa del genere.” April gli rivolge un sorriso amaro. “Ancora ce l’ha con me perché le ho rubato i soldi della merenda quando andavamo alla scuola elementare di Clark’s Hill.” Durante i giorni successivi, la nuova famiglia si unisce e le sorelle Chalmers affrontano il lutto come possono: a volte litigano per niente, a volte evitano di rivolgersi la parola, a volte si chiudono nelle loro camere per lunghi periodi a piangere e a rimuginare. April sembra gestire il cambiamento meglio di sua sorella. Toglie le cose di suo padre e si sposta nella camera da letto padronale, lasciando a Philip la sua stanza. Philip allestisce una parte per Penny con degli scaffali e qualche libro da colorare che ha trovato di sopra. La bambina si sta affezionando ad April. Passano molte ore insieme, a esplorare i piani superiori, a giocare e a sperimentare nuovi modi per far durare più a lungo le scarse provviste a loro disposizione: cucinano cene simboliche ma creative sulle fiamme dello Sterno, cose come manzo sbriciolato rifritto, pesche e uvetta in casseruola e verdura in scatola a sorpresa (dove, purtroppo, la sorpresa sono solo altri pezzi di carne di manzo). A poco a poco, le orde di non morti si allontanano dalle immediate vicinanze, lasciandosi dietro solo pochi ritardatari: i due fratelli Blake e Nick hanno così la possibilità di stabilire i confini delle loro missioni di ricognizione nei palazzi vicini. Brian diventa sempre più audace e desideroso di avventurarsi fuori dall’edificio per brevi tragitti. Ma, a quanto pare, è Nick Parsons quello che sembra adattarsi meglio a quel posto. Si è allestito una camera nello studio di un appartamento del secondo piano, il numero 2F, all’estremità est del corridoio. Ha trovato libri e riviste negli altri appartamenti e vi ha trascinato altri mobili. Passa il tempo nel balcone, a disegnare le strade del vicinato, a realizzare una mappa della zona più vicina, a leggere la Bibbia, a coltivare un orto per le verdure invernali e a riflettere a lungo su quanto è successo alla razza umana. Completa anche la sgangherata passerella che collega i due edifici adiacenti. Lo stretto camminamento è fatto di compensato e scale da imbianchino, tenuti insieme con corde e nastro isolante (e ben più di una preghiera). Il ponte di fortuna parte dal retro del tetto, attraversa un varco di quasi otto metri sopra un vicolo e si collega al bordo superiore di una scala antincendio sul tetto adiacente. Il completamento della passerella segna un punto di svolta per Nick. Un giorno, prendendo il coraggio a due mani, si avventura sulla struttura traballante e, proprio come aveva previsto, compie tutto il tragitto fino all’angolo sud-est dell’isolato senza mettere piede a terra. Da lì, trova il modo di infilarsi nel cavalcavia e poi nel supermercato. Quella notte, quando torna con le braccia cariche di roba presa da Dillard’s, viene accolto come un eroe di guerra di ritorno a casa. Porta sofisticati dolci da gourmet e noccioline; abiti caldi; scarpe nuove e materiale da cancelleria; penne di lusso; una stufa da campo pieghevole; lenzuola di seta e lussuose lenzuola a trecento fili e anche animali di pezza per Penny. Persino Tara si rilassa alla vista delle sigarette europee con le loro confezioni color pastello. Ma durante le sue uscite solitarie, Nick fa anche qualcos’altro, qualcosa che all’inizio tiene per sé. A una settimana dalla morte di David Chalmers, Nick convince Philip ad accompagnarlo in una piccola missione di ricognizione per rivelargli quello che fa. Philip non è entusiasta all’idea di attraversare il ponte di scale; finge di essere preoccupato che si spezzi sotto il suo peso, ma a preoccuparlo davvero è la sua segreta paura delle altezze. Nick lo persuade stuzzicando la sua curiosità. “Devi vederlo, Philly” dice sul tetto. “È una miniera d’oro, amico. Ti dico che è perfetta.” Con grande riluttanza, Philip va avanti e si costringe a salire sulla passerella, strisciando sulle mani e le ginocchia dietro Nick e brontolando per tutto il percorso. Segretamente pietrificato, Philip non osa guardare in basso. Raggiungono l’altro lato, saltano giù, scendono la scala antincendio e si introducono nel palazzo adiacente attraverso una finestra aperta. Nick guida Philip lungo i corridoi deserti dello studio di un commercialista: i pavimenti sono disseminati di moduli e documenti dimenticati, simili a foglie cadute. “Non manca molto ormai” dice, facendo strada a Philip giù per una rampa di scale e attraverso un atrio desolato e occupato da mobili rovesciati. Philip è ben consapevole dell’eco dei loro passi, che scricchiolano sopra le ceneri e i detriti. Percepisce fin nel suo plesso solare i punti ciechi e gli spazi vuoti, sente ogni scatto e ogni ticchettio, tutto quanto come qualcosa che potrebbe balzare su di loro in qualsiasi momento. Tiene le mani sul calcio della .22 infilata nei jeans. “Per di qua, proprio oltre il garage” dice Nick, indicando un’alcova alla fine dell’atrio. Girano un angolo. Oltrepassano un distributore automatico rovesciato. Salgono una breve rampa di scale. Attraversano una porta di metallo senza contrassegni e d’un tratto, quasi senza preavviso, davanti agli occhi di Philip si spalanca il mondo intero. “Madonna santa.” Meravigliato Philip segue Nick sul cavalcavia. Il marciapiede protetto è lercio di immondizia e puzza di urina: le spesse pareti di plexiglas sono coperte da uno strato di sporcizia così denso da distorcere la vista della città che li circonda. Ma quella visione è spettacolare. Il passaggio è inondato di luce e lo sguardo può spaziare per chilometri. Nick fa una pausa. “Troppo forte, eh?” “Straordinario, cazzo.” A quasi dieci metri sopra la strada, il vento fa vibrare la struttura e Philip può guardare giù e vedere gli zombie sparsi che vagabondano sotto di loro come in una battuta di pesca esotica a bordo di una barca col fondo di vetro. “Se non fosse per quegli orrendi figli di puttana, lo farei vedere a Penny.” “Ecco cosa volevo farti vedere.” Nick cammina fino al lato sud del passaggio. “Vedi quell’autobus? A circa mezzo isolato da quella parte?” Philip lo vede, un enorme autobus MARTA color argento, fermo accanto al marciapiede. Nick dice: “Guarda sopra la porta anteriore dell’autobus, vicino allo specchietto, sulla fiancata destra: lo vedi quel simbolo?”. In effetti, Philip vede un simbolo disegnato a mano sopra l’ingresso dei passeggeri, una stella a cinque punte scarabocchiata in tutta fretta con vernice rossa spray. “Cos’è?” “È una zona sicura.” “Cosa?” “Sono riuscito a scendere giù per quella strada e a risalire da quell’altra” gli dice Nick con l’orgoglio innocente di un bambino che mostra al padre la macchinina di legno che ha costruito. “C’è la bottega di un barbiere laggiù, linda come uno specchio, sicura come una banca e con la porta aperta.” Indica un punto più in alto lungo la strada. “Laggiù c’è un semirimorchio vuoto e in buone condizioni, che aspetta lì, con un’ottima, robusta… come si chiama… porta a soffietto? Sul fondo.” “Qual è il punto, Nicky?” “Zone sicure. Posti dove nascondersi quando si esce in missione in cerca di provviste e ci si trova nei guai o qualcosa del genere. Ne individuo sempre di più lontane lungo la strada. E le segno per non perderle. Ci sono nascondigli di tutti i tipi là fuori, da non crederci.” Philip lo fissa. “Ti sei spinto così lontano da solo?” “Sì, sai…” “Dannazione, Nick. Non dovresti andartene là fuori senza nessun tipo di rinforzo.” “Philly…” “No, no… niente ‘Philly’, amico. Sono serio. Voglio che tu faccia più attenzione. Capito? Sono serio.” “Okay, okay. Hai ragione.” Nick colpisce il braccio di Philip con un pugno bonario. “Ho capito.” “Bene.” “Devi ammetterlo però, questo posto è una forza. Considerata la situazione in cui ci troviamo, intendo.” Philip scrolla le spalle, guarda in basso attraverso il vetro sporco e osserva i pesci cannibali che girano in tondo. “Sì, immagino di sì.” “Potrebbe essere molto peggio, Philly. Non siamo in uno di quei palazzi alti; qui intorno è abbastanza pianeggiante da potersi guardare bene attorno. Abbiamo un sacco di spazio dove sistemarci nel condominio e ci sono negozi forniti di provviste e raggiungibili a piedi. Potremmo anche trovare un generatore da qualche parte; magari potremmo rubare una macchina per portarlo via. Credo che potremmo stare qui, Philly… non so… per molto tempo.” Ci pensa ancora un po’. “Per un tempo indefinito… eh?” Attraverso il vetro sudicio, Philip guarda la necropoli di edifici vuoti e i mostri cenciosi che vagano dentro e fuori dal suo campo visivo. “Oggigiorno è tutto indefinito, Nicky.” Quella notte, la tosse di Brian ritorna. Il tempo si è fatto più freddo e umido, ed esige il suo tributo dal sistema immunitario di Brian. Al calare della notte, l’appartamento è gelido e al mattino è una ghiacciaia: il pavimento è come una pista di pattinaggio per i piedi di Brian che sono protetti solo dai calzini. Ha cominciato a indossare tre strati di maglie e una sciarpa che Nick gli ha procurato da Dillard’s. Coi guanti senza dita, l’ammasso di ribelli capelli neri e gli occhi incavati alla Edgar Allan Poe, somiglia a un mendicante uscito da un romanzo di Charles Dickens. “Penso che questo posto sia ottimo per Penny” dice quella notte Brian a Philip, su un terrazzo del secondo piano. I fratelli Blake si fanno una bevuta dopo cena, altro vino a poco prezzo, e guardano i palazzi desolati. L’aria fredda della sera gli scompiglia i capelli e la puzza degli zombie aleggia appena al di sotto dell’odore della pioggia. Brian guarda le sagome lontane degli edifici scuri come in uno stato di trance. Per un americano del ventunesimo secolo, è quasi inconcepibile vedere una grande metropoli completamente al buio. Ma è proprio questo che i Blake guardano: uno skyline così nero e morto da sembrare la cresta di un monte in una notte senza luna. Ogni tanto, Brian crede di vedere il bagliore tenue di un fuoco o di una luce scintillante nel vuoto delle tenebre. Ma potrebbe benissimo trattarsi della sua immaginazione. “Penso che quella ragazza, April, sia la cosa migliore per Penny” dice Philip. “Sì, è davvero molto brava con lei.” Anche Brian si sta affezionando ad April e ha notato che forse Philip si è preso una piccola cotta per lei. Niente lo renderebbe più felice di sapere che Philip ha trovato un po’ di pace e di stabilità con una ragazza. “L’altra è un bel soggetto però, eh?” dice Philip. “Tara? Già. Di certo non è una simpaticona.” Negli ultimi giorni, Brian ha evitato Tara Chalmers, che è come un’ulcera ambulante: irritabile, paranoica, ancora alle prese col dolore per la morte del padre. Ma Brian immagina che alla fine ne verrà fuori. Sembra una brava persona. “Non ha ancora capito che ho salvato la sua vita del cazzo” dice Philip. Brian emette una serie di secchi colpi di tosse. Poi dice: “Volevo parlarti proprio di questo”. Philip lo guarda. “Cosa?” “Il vecchio che si è trasformato in quel modo.” Brian misura le parole. Sa di non essere l’unico a preoccuparsene. Da quando David Chalmers è tornato dalla morte e ha cercato di divorare la figlia maggiore, Brian ha rimuginato sul fenomeno, sulle implicazioni di quello che è successo, sulle regole di quel nuovo, selvaggio mondo e forse anche sulla prognosi per l’intera razza umana. “Riflettici, Philip. Non è stato morso. Giusto?” “No, non è stato morso.” “E allora perché si è trasformato?” Per un momento, Philip si limita a fissare Brian e l’oscurità sembra inghiottirli. La città pare allargarsi all’infinito come il paesaggio di un sogno. Le braccia di Brian rabbrividiscono, come se l’atto stesso di mettere in parole quei pensieri, di pronunciarli ad alta voce, abbia liberato un genio malvagio dalla sua bottiglia, un genio che non saranno mai in grado di rimettere al suo posto. Philip beve il suo vino. Nell’oscurità, la sua faccia è cupa e risoluta. “Diavolo, ci sono un sacco di cose che non sappiamo. Forse è stato infettato da qualcosa molto prima, forse è venuto in contatto con quel qualcosa abbastanza perché facesse effetto sul suo sistema. Il vecchio aveva un piede nella fossa, in ogni caso.” “Se è vero, allora dobbiamo…” “Ehi, professore. Datti una calmata. Siamo tutti in ottima forma e rimarremo così.” “Lo so. Voglio solo dire… forse dovremmo pensare a prendere più precauzioni.” “Quali? Le mie precauzioni sono queste.” Philip tocca il calcio della Ruger calibro .22 infilata dentro la cintura. “Voglio dire che dovremmo lavarci meglio e sterilizzare le cose.” “Con cosa?” Brian si lascia sfuggire un sospiro e guarda in alto verso il cielo notturno e coperto, una bassa volta di nuvole scure come lana nera. Le piogge autunnali sono vicine. “Abbiamo l’acqua dei bagni di sopra” dice. “Abbiamo i filtri e il propano e abbiamo accesso ai prodotti igienici giù in strada: saponi, detersivi e tutta quella merda lì.” “Stiamo già filtrando l’acqua, campione.” “Sì, ma…” “E ci laviamo con quell’aggeggio che ha trovato Nicky.” Il cosiddetto “aggeggio” è una doccia da campo che Nick ha trovato nel reparto sportivo di Dillard’s. Delle dimensioni di un piccolo condizionatore, dispone di un serbatoio pieghevole da venti litri e di un tubo da doccia che funziona con una pompa a batteria. Da cinque giorni ormai, si concedono il lusso periodico di una breve doccia, riciclando quanta più acqua possibile. “Lo so, lo so… dico solo che, forse, sarebbe meglio cominciare subito a darci dentro con l’igiene. Tutto qui. Finché non ne sappiamo di più.” Philip gli rivolge un’occhiata dura. “E se non c’è più niente da imparare?” Brian non ha risposte per quella domanda. L’unica risposta giunge dalla città nella forma di un ronzio cupo, di una raffica di vento nauseabondo e di un gigantesco, silenzioso vaffanculo. Forse è l’allarmante conglomerato di ingredienti poco appetitosi che April e Penny hanno preparato quella sera per cena, un misto di asparagi in scatola, carne in scatola Spam e patatine sbriciolate cotti sopra una fiamma al propano, che a Philip si piazza come un’ancora nel fondo dello stomaco. O forse è l’effetto di tutto lo stress, la rabbia e l’insonnia accumulati. O magari è la conversazione che ha avuto col fratello sul balcone. Ma a prescindere dalla causa, dopo essersi messo a dormire ed essersi girato e rigirato in un sonno agitato, Philip Blake sperimenta un sogno complesso e violento. È in quella che era la camera da letto di April e che è diventata il suo nuovo alloggio (a quanto pare, prima era l’ufficio casalingo di qualcuno: mentre ripulivano la stanza dalle cose del proprietario, Philip e April avevano trovato mucchi di moduli per ordini della Mary Kay Cosmetics e vari campioni di trucchi). Steso sul gigantesco letto appoggiato alla parete, Philip si contorce in uno stato di parziale incoscienza, fuori e dentro uno spettacolo orrendo e delirante. È un sogno che non ha forma: senza inizio, svolgimento e conclusione. Si limita a ripercorrere il suo solco circolare di terrore. Philip si ritrova nella casa della sua infanzia a Waynesboro, un piccolo e squallido bungalow su Farrel Street, precisamente nella camera da letto sul retro che divideva con Brian. Nel sogno Philip non è un bambino ma un adulto, e in qualche modo l’epidemia ha viaggiato indietro nel tempo fino agli anni 70. Il sogno ha una vividezza quasi tridimensionale. Ci sono la carta da parati decorata coi mughetti, i poster degli Iron Maiden, la scrivania coperta di incisioni. Brian è da qualche parte, invisibile, e urla; e c’è anche Penny, in una delle stanza vicine, che piange chiamando il suo papà. Philip corre lungo i corridoi che formano un labirinto senza fine. L’intonaco è crepato. L’orda degli zombie è all’esterno e rumoreggia per entrare. Le finestre sbarrate tremano. Philip ha un martello e cerca di mettere in sicurezza le finestre con dei chiodi, ma la testa del martello cade. Rumori di schianti. Philip vede una porta aprirsi di botto e corre verso di essa, ma la maniglia gli resta in mano. Fruga nei cassetti e nei mobili in cerca di armi, gli sportelli cadono dai mobili, l’intonaco si stacca dal soffitto e il suo stivale finisce in un buco nel pavimento. I muri crollano, il linoleum si deforma, le finestre cadono dalle intelaiature e Philip continua a sentire la voce acuta e disperata di Penny che lo chiama. “PAPÀ!” Braccia scheletriche sfondano le finestre che crollano dalle pareti; dita annerite e ricurve provano a tentoni ad afferrare qualcosa. “PAPÀ?” Teschi sbiancati erompono dal pavimento come raccapriccianti periscopi. “PAPÀ!” Philip scoppia in un grido silenzioso mentre il sogno si frantuma come lana di vetro. QUATTORDICI Philip si sveglia di colpo, ansimante. Si piega sul letto, sbattendo le palpebre e strizzando gli occhi nella pallida luce del mattino. C’è qualcuno in piedi accanto al letto. No. Sono due persone. Adesso le vede, una alta e una più bassa. “Buongiorno, splendore” dice April con la mano sulla spalla di Penny. “Gesù.” Philip si siede contro la testata del letto in canottiera e calzoni della tuta. “Che diavolo di ora è?” “È quasi mezzogiorno.” “Cristo santo” mormora Philip, ritrovando l’orientamento. Il suo corpo muscoloso è del tutto coperto da una pellicola di sudore freddo. Il collo gli duole e la bocca ha il sapore di una pattumiera. “Non ci credo.” “Dobbiamo farti vedere una cosa, papà” gli dice la bambina, con gli occhi lucidi per l’emozione. La vista di sua figlia felice lo colpisce con una rassicurante ondata di sollievo, spazzando via gli ultimi residui del sogno dalla sua mente febbricitante. Si alza e si veste, chiedendo alle due signore di calmarsi. “Datemi un secondo per sistemarmi” dice con un grugnito rauco per via del whisky, passandosi le dita tra i capelli unti. Lo portano sul tetto. Quando escono dalla porta antincendio ed emergono nell’aria fredda, Philip tentenna davanti alla luce. Benché il giorno sia nuvoloso e scuro, Philip è reduce dai postumi della sbornia e la luce gli fa pulsare le pupille. Strizza gli occhi al cielo, dove le nuvole annunciano un temporale e si rimescolano verso nord. “Sembra che stia per piovere” dice. “È una buona notizia” dice April, strizzando l’occhio a Penny. “Fagli vedere perché, tesoro.” La bambina afferra il padre per la mano e lo trascina sul tetto. “Guarda, papà, io e April abbiamo preparato un giardino dove piantare le cose.” Gli mostra un piccolo vaso improvvisato al centro del tetto. Philip impiega un po’ per capire che il giardino è stato realizzato con quattro carriole, alle quali sono state rimosse le ruote e i cui vani sono stati attaccati insieme. Uno strato di quindici centimetri di terreno riempie ognuna delle quattro cavità e alcuni germogli non identificati sono già stati trapiantati nei carretti. “È un’idea fantastica” dice, stringendo la spalla della bambina. Guarda April. “Davvero fantastica.” “È stata un’idea di Penny” dice April con un piccolo lampo d’orgoglio negli occhi. Indica una fila di secchi. “Raccoglieremo anche la pioggia.” Philip si abbevera dello stupendo, anche se leggermente ammaccato, viso di April Chalmers, dei suoi occhi blu come il mare, dei suoi capelli biondo cenere sciolti sopra il collo del maglione fatto all’uncinetto che ha trovato chissà dove. Non riesce a toglierle gli occhi di dosso. E anche se Penny comincia a chiacchierare tutta felice, parlando delle cose che vuole far crescere, piante di zucchero filato e cespugli di gomma da masticare, Philip non può fare a meno di arrivare a una conclusione: il modo in cui April si inginocchia accanto a Penny e la ascolta attentamente con la mano sulla schiena della bambina, lo sguardo affettuoso sul suo viso, il disinvolto legame tra le due, il senso di unità, tutto suggerisce qualcosa di più profondo della mera sopravvivenza. Philip si concede appena il lusso di pensare alla parola, che gli si presenta di colpo proprio in quel momento, su quel baratro esposto al vento: famiglia. “Scusate!” La voce scontrosa proviene dalla porta antincendio dietro di loro, dall’altra parte del tetto. Philip si gira. Tara, in uno dei suoi camicioni sporchi e in preda a uno dei suoi tipici malumori, sta davanti alla porta aperta. Tiene in mano un secchio. Il volto dalle guance cadenti e gli occhi pesantemente truccati sembrano persino più tirati e scontrosi del solito. “Sarebbe chiedere troppo avere un po’ d’aiuto?” April si alza e si volta. “Ti avevo detto che ti avrei aiutata tra un minuto.” Tara ha raccolto l’acqua dai bacini dei bagni. Philip prende in considerazione l’idea di intromettersi ma decide di non farlo. “È stato mezz’ora fa” dice Tara. “Nel frattempo, mi sono ammazzata di fatica per prendere l’acqua mentre tu te ne stavi qui a trastullarti nel teatrino di Mr. Rogers 7.” “Tara, ti prego… calmati” sospira April. “Dammi un secondo, arrivo subito.” “Va bene… fa’ come ti pare!” Tara si gira di scatto e si precipita con rabbia giù per la scala interna, lasciando dietro di sé un’acida scia di disprezzo. April abbassa lo sguardo. “Mi dispiace per questo spettacolo, ma è ancora alle prese coi suoi… lo sai… problemi.” Dall’espressione avvilita sulla faccia di April, è chiaro che le servirebbe troppa energia per spiegare la litania di quello che tormenta sua sorella. Philip non è uno stupido. Sa che è complicato e che ha a che fare con la gelosia e la rivalità tra sorelle, e forse anche col fatto che April affronta il lutto con qualcuno diverso da Tara. “Non hai bisogno di scusarti” le dice Philip. “Ma c’è una cosa che vorrei che sapessi.” “Di che si tratta?” “Volevo solo che sapessi quanto ti sono grato per quello che fai per mia figlia.” April sorride. “È una bambina fantastica.” “Sissignora… lo è… e anche tu non sei male.” “Beh… grazie.” Si piega verso di lui e gli dà un bacetto sulla guancia. Niente di speciale, solo un bacio veloce. Ma fa il suo effetto. “Adesso è meglio che vada, prima che mia sorella mi spari.” April se ne va, lasciando Philip sbalordito a riprendersi nel vento. Come bacio, non è niente di speciale. La defunta moglie di Philip, Sarah, era stata una baciatrice da primo premio. Diavolo, negli anni dopo la morte di Sarah, Philip aveva incontrato prostitute che ci sapevano fare meglio coi baci. Anche le puttane hanno dei sentimenti e Philip, all’inizio dell’incontro, chiedeva loro se avevano qualche problema a cominciare con qualche bacio, giusto per far finta che stessero insieme. Ma quel piccolo bacetto di April è piuttosto un antipasto, un assaggio delle cose a venire. Philip non lo definirebbe un bacio provocatore. Ma nemmeno un bacio platonico, del tipo che una sorella darebbe a un fratello. Quel bacio si colloca nel limbo irresistibile tra due estremi. È, dalla prospettiva di Philip, il gesto di chi bussa alla porta per vedere se c’è qualcuno in casa. Quel pomeriggio, la pioggia, che sembrava imminente, non arriva. È già metà ottobre ma Philip non ha idea di che giorno sia, e tutti continuano ad aspettarsi l’arrivo dei temporali che tradizionalmente spazzano la Georgia centrale in quel periodo dell’anno. Eppure qualcosa li tiene alla larga. La temperatura precipita e l’aria ronza di umidità latente, ma la pioggia seguita a non arrivare. Forse la siccità ha qualcosa a che fare con l’epidemia. Qualunque sia il motivo, il cielo instabile, col suo scuro bassoventre di nuvole tempestose, sembra riflettere la strana, inesplicabile tensione che cresce dentro Philip. Quello stesso giorno, più tardi, chiede ad April di accompagnarlo in una veloce sortita in strada. Ci mette un po’ a convincerla, sebbene il numero degli zombie sia drasticamente calato dall’ultima volta che sono usciti. Philip le dice che ha bisogno d’aiuto per esplorare le vicinanze in cerca di un negozio di materiali per la costruzione e la manutenzione della casa, un Home Depot o un Lowe’s, dove trovare dei generatori. Fa sempre più freddo, specie di notte, e presto avranno bisogno di energia per sopravvivere. Gli serve qualcuno che conosce la zona. Vuole anche mostrarle i percorsi sicuri che Nick ha individuato. Nick si offre di andare con loro ma Philip gli suggerisce che farebbe meglio a restare nei paraggi per fare la guardia al condominio insieme a Brian. April è all’altezza del compito ed è disposta ad andare, ma ha qualche dubbio sulla traballante passerella improvvisata. E se comincia a piovere quando sono sulle scale? Philip le assicura che è un gioco da ragazzi, specie per una piccoletta come lei. Si infilano i cappotti e prendono le armi tenendole pronte: stavolta April porta con sé un Marlin e si preparano a partire. Tara ribolle di rabbia, disgustata da quella che considera “una stupida, pericolosa, immatura, imbecille perdita di tempo”. Philip e April la ignorano educatamente. “Non guardare in basso!” Philip è a metà del ponte improvvisato che passa sopra il vicolo sul retro. April è tre metri dietro di lui, disperatamente aggrappata alla passerella. La guarda da sopra la spalla e sorride tra sé. Quella ragazza ha cojones da vendere. “Va tutto bene” dice lei, aggrappandosi con le nocche bianche e la mascella contratta. Il vento le arruffa i capelli. Dieci metri sotto di lei, un paio di cadaveri ambulanti guardano con aria stupida verso la fonte delle voci. “Ci siamo quasi” la sprona Philip, ormai approdato dall’altra parte. Lei striscia per i rimanenti cinque metri. Lui l’aiuta a scendere sul pianerottolo della scala antincendio. La grata di ghisa scricchiola sotto il loro peso. Trovano la finestra aperta e scivolano dentro l’ex sede della Stevenson and Sons Accounting and Estate Planning. I corridoi dell’ufficio sono più bui e freddi dell’ultima volta che Philip li ha attraversati. Quella notte, il fronte della tempesta ha portato il tramonto prima del solito. Attraversano i corridoi vuoti. “Non ti preoccupare” la rassicura Philip, mentre camminano con passo scricchiolante su detriti e moduli per rimborsi di tasse spiegazzati. “Questo posto è il massimo della sicurezza che puoi avere al giorno d’oggi.” “Non è molto rassicurante” dice lei, stringendo il fucile e appoggiando nervosamente il pollice sul cane. Vestita con un pile sbrindellato e un paio di jeans, April ha le gambe e la parte inferiore delle braccia avvolte di nastro adesivo. Nessun altro lo fa. Quando Philip le ha chiesto perché lo facesse, lei gli ha risposto che l’ha visto fare a un addestratore di animali alla TV, un’ultima difesa contro i morsi che lacerano la pelle. Attraversano l’atrio e poco dopo trovano la scala d’accesso proprio dietro il distributore automatico rovesciato. “Osserva bene” dice Philip, guidandola verso la rampa di scale che conduce alla porta senza contrassegni. Fa una pausa prima di aprire la porta. “Ti ricordi il Capitano Nemo?” “Chi?” “Quel vecchio film, Ventimila leghe sotto i mari. Quel vecchio capitano strambo che suona l’organo in un sottomarino, mentre una piovra gigante nuota fuori dagli oblò panoramici.” “Non l’ho mai visto.” Philip le sorride. “Beh, stai per farlo.” L’ultima cosa che April Chalmers si aspetta è che a toglierle il fiato sia qualcosa di diverso dall’orrore e dalla violenza, ma è più o meno quello che succede quando segue Philip attraverso la porta senza contrassegni sul cavalcavia. Si ferma sulla soglia e rimane a guardare. È già stata in questi passaggi coperti prima, forse persino in quello stesso ponte, ma in qualche modo, quella sera, la luce trasparente e lo spazio della struttura, che si allunga attraverso l’incrocio, una decina di metri sopra la strada, collegandosi col secondo piano di Dillard’s, sembrano un miracolo. Attraverso le pareti di vetro, le venature dei fulmini tremolano e si fanno strada in mezzo alle nuvole tempestose. Attraverso le pareti trasparenti, le ombre sempre più scure della città brulicano di zombie erranti. Atlanta sembra la plancia di un enorme gioco da tavolo in preda al caos. “Capisco cosa intendevi” dice. La sua voce è un mormorio, mentre assapora tutto insieme, provando uno strano misto di emozioni, vertigine, paura, eccitazione. Philip si avvicina al centro del ponte, fermandosi accanto a una parete, e si libera delle cinghie del borsone. Indica verso sud con un cenno. “Voglio farti vedere una cosa” dice. “Vieni qui.” Lei lo raggiunge, appoggiando il fucile e lo zaino alla parete di vetro. Philip indica i segni lasciati da Nick Parsons sui veicoli abbandonati e sui portoni. Le spiega la teoria delle zone sicure e le parla di quanto Nick sia diventato furbo. “Credo che faccia qualcosa di veramente buono qui” conclude. April concorda. “Potremmo usare quei nascondigli quando andiamo a cercare quel generatore di cui tutti parlano.” “Hai capito al volo, sorella.” “Nick è un bravo ragazzo.” “Già.” L’oscurità cala su tutta la città, e nelle ombre bluastre del ponte, il volto segnato di Philip sembra ad April ancora più ruvido del solito. Coi baffoni neri alla Fu Manchu e gli occhi scuri infossati tra le rughe, lui le ricorda un incrocio tra un giovane Clint Eastwood e… chi? Suo padre da giovane? È per questo che avverte quelle fitte di attrazione verso quel grosso e allampanato redneck? April è forse così stupida da sentirsi attratta da un uomo solo perché è il doppelgänger di suo padre? O quella patetica cotta ha qualcosa a che fare con lo stress della lotta per la sopravvivenza in un mondo improvvisamente minacciato dall’estinzione? È il tizio che ha sfondato il cranio di suo padre, per l’amor di Dio. Ma questo è ingiusto. Quello non era più David Chalmers. Lo spirito di suo padre, come diceva la canzone, era volato via. La sua anima se n’era andata molto prima che il suo corpo uscisse dal letto e tentasse di divorare la sua figlia maggiore. “Devo proprio dirtelo” dice Philip, mentre osserva le figure vestite di stracci che vagano nelle strade come cani randagi in cerca di avanzi. “Dobbiamo sistemare ancora alcune cose e poi potremo restare in quel condominio per un bel po’ di tempo.” “Credo che tu abbia ragione. Dobbiamo solo trovare il modo di infilare un po’ di Valium nel cibo di Tara.” Philip scoppia in una risata pulita e allegra, mostrandole un lato di sé che non aveva ancora visto. La guarda. “Forse possiamo farlo funzionare. Possiamo fare molto più che limitarci a sopravvivere. E non parlo solo di prendere un generatore.” April lo guarda negli occhi. “Che intendi dire?” Lui si volta verso di lei. “Ho conosciuto un sacco di ragazze ai miei tempi, ma non mi sono mai imbattuto in una come te. Dura come il ferro… ma la tenerezza che hai mostrato verso mia figlia? Non ho mai visto Penny avvicinarsi a qualcuno come ha fatto con te. Diavolo, ci hai salvato il culo, quando ci hai tirato fuori dalla strada. Sei una signora davvero speciale, lo sai?” D’un tratto, la pelle di April avvampa di brividi e il petto s’indebolisce mentre capisce che Philip la guarda in un modo nuovo. I suoi occhi scintillano di emozione. Adesso sa che lui pensa alla stessa cosa a cui pensava lei. Abbassa lo sguardo, imbarazzata. “I tuoi standard devono essere bassi” sussurra. Lui si avvicina e le posa con gentilezza una delle grosse mani callose da lavoratore sulla curva della mascella. “Ho gli standard più elevati di tutti quelli che conosco.” Lo scoppio di un tuono echeggia oltre il vetro, facendo tremare il ponte e sobbalzare April. Philip la bacia sulle labbra. Lei si tira indietro. “Non lo so, Philip… voglio dire… non so se… capisci.” Nello spazio di un istante la mente di April è attraversata dai ripensamenti e dai ripensamenti sui ripensamenti. Se lascia che questa cosa arrivi al livello successivo, cosa succederà con Tara? Quanto manderà a puttane le dinamiche dell’appartamento? Quanto complicherà le cose? Quanto inciderà sulla loro sicurezza, sulle loro possibilità di sopravvivenza, sul loro futuro (se ancora ne hanno uno)? L’espressione di Philip la riporta indietro, per il modo in cui la fissa con lo sguardo quasi vitreo per l’emozione e la bocca rilassata dal desiderio. Lui si china e la bacia di nuovo; e stavolta lei si ritrova ad avvolgergli le braccia al collo e a ricambiare il bacio, senza nemmeno accorgersi delle gocce di pioggia che ticchettano sul vetro sopra le loro teste. Il suo corpo quasi si affl oscia nell’abbraccio energico di Philip. Le loro labbra si staccano e l’elettricità la percorre mentre si esplorano con le lingue: il sapore del caffè e della gomma da masticare alla menta insieme all’odore muschiato di Philip le sovraccaricano i sensi. I suoi capezzoli si induriscono sotto il maglione. Con una brillante luce argentata, una saetta blu illumina a giorno il tramonto. April perde la cognizione di se stessa. Perde la cognizione di tutto. Le gira la testa. Non si accorge che la pioggia sbatte contro il tetto di vetro. Non si accorge nemmeno che Philip sta delicatamente adagiando entrambi sul pavimento del passaggio. Mentre le loro labbra sono incollate e continuano a scambiarsi baci appassionati, Philip le accarezza il seno con le sue grandi mani e la appoggia con attenzione contro la parete di vetro; e prima che April se ne renda conto, è sopra di lei. Il temporale scatena la sua furia. La pioggia scroscia contro il tetto. I tuoni rimbombano, i fulmini crepitano e mandano scariche di elettricità statica nell’aria irrequieta mentre Philip solleva a tentoni la maglia di April sopra la vita, esponendo il suo reggiseno alla luce bluastra. Dita nodose aprono le fibbie delle cinture. I tuoni rimbombano. April sente la spinta incalzante dei lombi di Philip farsi strada tra le sue gambe. I lampi sfarfallano. I suoi jeans sono a metà gamba e il suo seno è libero. Un’unghia le graffia il ventre e di colpo, come se dentro di lei fosse scattato un interruttore, accompagnato da un’unica raffica di tuoni, April pensa: ASPETTA. BOOOOOOOM! ASPETTA! Un’ondata irrefrenabile di desiderio trascina via Philip Blake sulle sue correnti impetuose. Riesce appena a sentire la voce di April da un luogo molto lontano; gli dice: “Fermati, aspetta, basta, ascolta, ascolta, è troppo, non sono pronta, ti prego, ti prego, fermati subito, basta”. Il cervello di Philip non registra nessuna di quelle parole mentre annega nella lussuria, nella passione, nel dolore, nella solitudine e nel disperato bisogno di sentire qualcosa, perché adesso tutto il suo essere è concentrato sul suo inguine e tutte le emozioni che aveva represso lo travolgono. “Dio, ti prego, fermati!” La voce lontana lo supplica, il corpo di April si irrigidisce. Philip monta la donna, che si contorce sotto di lui, quasi come se facesse surf all’interno di un’onda di rumore bianco, convinto che segretamente lei voglia lui, che lo ami, malgrado quello che dice. Così, continua a spingersi dentro di lei, ancora e ancora, in mezzo ai lampi al magnesio e alla cruda energia dei fulmini: la riempie, la prende, la nutre, la trasforma, finché non resta sfibrata sotto di lui, sfibrata e silenziosa. La morbida esplosione bianca di piacere erutta come un razzo che si stacca dal suolo dentro Philip. Scivola via da lei e si sdraia sul pavimento al suo fianco, a guardare la pioggia sopra di lui, momentaneamente dimentico delle ombrose anime profanate dieci metri sotto di loro, catturate dallo sfarfallio dei lampi come le figure mostruose di un film muto. Philip prende il silenzio di April come un segno che forse, solo forse, tutto andrà per il meglio. Mentre il temporale si assesta in un costante diluvio e il suo ruggito simile a quello di un jet soffocato satura il passaggio, i due si rimettono i vestiti e restano lì, fianco a fianco, a lungo, senza dire una parola, a fissare le raffiche di pioggia che si schiantano sul tetto di vetro. Philip è in stato di shock, il suo cuore batte all’impazzata, la pelle è viscida e gelida. Si sente come uno specchio infranto, come se una scheggia della sua stessa anima si fosse staccata e gli rimandasse il riflesso della faccia di un mostro. Cosa ha fatto? Sa di aver fatto qualcosa di sbagliato. Ma ha come la sensazione che sia stato qualcun altro a farlo. “Mi sono lasciato trasportare un po’” dice alla fine, dopo molti minuti di terribile silenzio. Lei non dice una parola. Le lancia uno sguardo e nell’oscurità vede riflesse sul suo volto le ombre liquide della pioggia che scorre lungo i lati del passaggio di vetro. Sembra cosciente solo in parte. Come se sognasse a occhi aperti. “Mi dispiace” le dice, con parole che suonano false e vuote anche alle sue stesse orecchie. Le getta un altro sguardo, per cercare di intuire il suo stato d’animo. “Stai bene?” “Sì.” “Sei sicura?” “Sì.” La sua voce ha un timbro meccanico e del tutto incolore, a malapena udibile sopra il rumore della pioggia. Philip sta per dire qualcos’altro quando una raffica di tuoni interrompe il suo pensiero. Il rimbombo si riverbera attraverso l’intelaiatura metallica del passaggio e provoca una vibrazione che lo fa rabbrividire. “April?” “Sì.” “Dobbiamo tornare indietro.” Il viaggio di ritorno è avvolto dal silenzio. Philip cammina qualche passo dietro April attraverso l’atrio deserto, su per una rampa di scale e lungo i corridori vuoti e sporchi di immondizia. Di tanto in tanto, prende in considerazione l’idea di dire qualcosa, ma non lo fa. Immagina che forse è meglio lasciarla in pace. Lasciare che affronti la cosa. In quel momento qualsiasi parola potrebbe peggiorare le cose. April cammina davanti a lui col fucile sulla spalla, come un soldato stanco che ritorna da una ronda pericolosa. Raggiungono il piano superiore dello studio commerciale e trovano la finestra aperta: la pioggia entra passando in mezzo ai denti di vetro rotto. Pronunciano solo poche parole: “Va’ prima tu” e “Attenta a dove metti i piedi”, mentre Philip la aiuta ad arrampicarsi fuori e a salire la scala antincendio spazzata dalla pioggia. Il vento incessante e la pioggia che li sferzano mentre traballano sull’insidiosa passerella di fortuna procurano a Philip una sensazione quasi piacevole. Una sensazione che lo conforta, lo risveglia e alimenta in lui la speranza di poter forse riparare al male che le ha fatto. Nel tempo che impiegano a tornare all’appartamento, entrambi fradici fino al midollo, esausti e inebetiti, Philip è ormai convinto di poter sistemare le cose. Brian è nell’ufficio camera da letto con Penny, intento a metterla a dormire nel suo lettino. Nick è in soggiorno e lavora sulla sua mappa delle zone sicure. “Ehi, com’è andata?” chiede, alzando gli occhi dalle sue carte. “Ragazzi, sembrate dei pulcini bagnati; avete trovato qualche Home Depot là fuori?” “Non oggi” replica Philip, dirigendosi verso la camera da letto, senza fermarsi, nemmeno per togliersi gli stivali. April non dice niente, non alza nemmeno gli occhi per incontrare lo sguardo di Nick, mentre si incammina lungo il corridoio. “Guardatevi” dice Tara, uscendo dalla cucina con un’espressione scontrosa e una sigaretta accesa che le penzola da un angolo della bocca. “Proprio come pensavo… una stupida perdita di tempo del cazzo!” Se ne sta lì con le mani sui fianchi, mentre sua sorella svanisce senza dire una parola nella sua stanza alla fine del corridoio. Tara osserva Philip e poi esce furibonda, seguendola. “Vado a dormire” dice Philip a Nick in tono piatto e poi si avvia verso la sua stanza. Il mattino dopo, Philip si sveglia appena prima dell’alba. La pioggia continua a martellare le strade all’esterno. La sente tambureggiare fuori dalla finestra. La stanza è fredda, buia, umida e odora di muffa. Si siede sull’orlo del letto e rimane a lungo così, a guardare Penny, che dorme nel suo lettino dall’altra parte della stanza, col corpicino raccolto in posizione fetale. Il ricordo incompleto di un sogno si aggrappa al cervello intontito di Philip, insieme alla nauseante sensazione di non sapere dove finisce l’incubo e dove comincia l’episodio con April della sera prima. Se solo lo avesse sognato invece di averlo fatto davvero. Ma, nel buio della stanza, la realtà gli attraversa la mente coi suoi contorni duri e affilati: sono come dei lampi, come se guardasse un altro perpetrare quel crimine. Philip si stringe la testa, provando a scacciare dalla mente i sensi di colpa e il terrore. Si passa le dita tra i capelli, cerca di convincersi a sperare. Può affrontarlo insieme ad April, trovare un modo per andare avanti, lasciarsi tutto alle spalle, scusarsi con lei, farsi perdonare. Osserva Penny che dorme. Nelle due settimane e mezzo da quando il piccolo gruppo di Philip si è unito ai Chalmers, sua figlia ha iniziato a uscire dal suo guscio. Sulle prime sono state solo piccole cose: Penny ha cominciato a non vedere l’ora di preparare le loro cene disgustose e a illuminarsi ogni volta che April entrava in una stanza. Col passare dei giorni poi, la bambina è diventata sempre più loquace e ha preso a ricordare com’erano le cose prima del cambiamento, a fare commenti sulle strane condizioni climatiche e domande sulla malattia. Si ammalavano anche gli animali? Sarebbe finita? Dio ce l’aveva con loro? Il petto di Philip freme per l’emozione mentre osserva la bambina che dorme. Dev’esserci un modo per costruire una vita per sua figlia, costruire una famiglia, trovare una casa, anche nel mezzo di quell’incubo a occhi aperti, dev’esserci un modo. Per un breve istante, immagina un’isola deserta e un piccolo cottage annidato tra le palme. L’epidemia è a milioni di anni luce di distanza. Immagina April e Penny su un’altalena che giocano insieme in un orto. Immagina se stesso seduto su una veranda, in forma, con la pelle cotta dal sole, intento a osservare felice le due donne della sua vita che condividono quel momento gioioso. Immagina tutto questo mentre osserva sua figlia che dorme. Si alza e le si avvicina senza fare rumore; si inginocchia e le accarezza dolcemente i capelli morbidi. Deve fare un bagno. I suoi capelli sono unti e arruffati e il suo corpo manda un tenue odore di sudore. Quell’odore lo tocca e gli stringe lo stomaco. I suoi occhi si spalancano. Non ha mai amato nessuno come ama sua figlia. Persino Sarah, che aveva adorato, veniva per seconda. Il suo amore per Sarah era, come quello di tutte le coppie sposate, complicato, condizionato e fluido. Ma quando, sette anni e mezzo prima, aveva posato gli occhi per la prima volta su sua figlia, quella piccola neonata coperta di chiazze, aveva imparato cosa davvero significava amare. Significa essere spaventato e vulnerabile per il resto della vita. Qualcosa, dall’altra parte della stanza, attira la sua attenzione. La porta è socchiusa. Si ricorda di averla chiusa prima di mettersi a dormire. Lo ricorda molto bene. Adesso è aperta di circa quindici centimetri. Sulle prime, la cosa non lo preoccupa granché. Forse ha accidentalmente chiuso male la porta, che si è riaperta per conto suo. O forse durante la notte si è alzato per andare a pisciare e si è dimenticato di chiuderla. O magari è stata Penny ad andare a fare pipì e a lasciarla aperta. Diavolo, magari è sonnambulo e non sa nemmeno di esserlo. Ma poi, proprio mentre si gira per tornare a guardare sua figlia, nota dell’altro. Dalla stanza mancano delle cose. Il cuore di Philip comincia a martellare. Ha lasciato il suo zaino, quello che portava quando è arrivato due settimane prima, appoggiato contro il muro, nell’angolo, ma adesso è sparito. Manca anche la sua pistola. Ha lasciato la calibro .22 in cima al comodino con l’ultimo caricatore infilato. Anche le munizioni sono sparite. Philip balza in piedi. Si guarda attorno. Proprio in quel momento, l’alba tetra comincia a illuminare la stanza e la tenda della finestra proietta lacrime di pioggia, come riflessi spettrali d’acqua, che colano lungo la parte esterna del vetro. I suoi stivali non sono dove li ha lasciati. Erano sul pavimento sotto la finestra, ma adesso sono spariti. Chi diavolo prenderebbe i suoi stivali? Dice a se stesso di calmarsi. Dev’esserci una spiegazione semplice. Non c’è ragione di lasciarsi prendere dal panico. Ma ciò che lo turba di più è l’assenza della pistola. Decide di fare un passo alla volta. Attraversa la stanza in silenzio, facendo attenzione a non svegliare Penny, e scivola fuori dalla porta aperta. L’appartamento è silenzioso e immobile. Brian sonnecchia in soggiorno sul divano letto. Philip entra scalzo in cucina, accende il fornello a propano e si prepara una tazza di caffè istantaneo con dell’acqua piovana rimasta in un secchio. Si spruzza un po’ d’acqua fredda sul viso. Dice a se stesso di restare calmo e prende alcuni respiri profondi. Quando il caffè è caldo, prende la tazza e si incammina lungo il corridoio verso la stanza di April. Anche la sua porta è socchiusa. Guarda dentro e vede che la stanza è vuota. Il suo battito accelera. Una voce dice: “Non è qui”. Si gira e si ritrova faccia a faccia con Tara Chalmers, che tiene in mano la Ruger, col cane armato e la canna puntata dritta su di lui. QUINDICI “Okay… vacci piano, sorella.” Philip non si muove. Rimane fermo e immobile nel corridoio, con la mano libera alzata e il caffè nell’altra, che tiene protesa da un lato come se valutasse se offrirlo alla donna. “Di qualsiasi cosa si tratti, possiamo risolverla.” “Davvero… ?” gli chiede Tara Chalmers, guardandolo torva coi fiammeggianti occhi truccati. “Credi?” “Senti… non so cosa sta succedendo…” “Succede” dice lei senza traccia di nervosismo o di paura, “che la formazione cambia.” “Tara, qualsiasi cosa tu stia pensando…” “Vediamo di mettere le cose in chiaro.” La sua voce è ferma, piatta e senza emozioni. “Voglio che chiudi quella cazzo di bocca e fai quello che ti dico, altrimenti ti faccio saltare quella testa del cazzo; non credere che non ne abbia voglia.” “Questo non…” “Metti giù la tazza.” Philip obbedisce, posando piano la tazza sul pavimento. “Okay, sorella. Come vuoi.” “Smettila di chiamarmi così.” “Sissignora.” “Adesso andiamo a prendere tuo fratello, il tuo amico e tua figlia.” Philip freme di adrenalina. Non crede che Tara abbia le palle per fargli davvero del male e prende in considerazione l’idea di provare ad afferrare l’arma, lontana solo un paio di metri, ma resiste alla tentazione. A questo punto è meglio abbozzare e cercare di farla parlare. “Posso parlare?” “MUOVITI!” Il suo grido improvviso frantuma la tranquillità e sveglia Penny e Brian; probabilmente giunge anche al secondo piano dove Nick, un tipo mattiniero, è già operativo. Philip fa un passo verso di lei. “Se solo mi dessi la possibilità di…” La Ruger ruggisce. Lo sparo lo manca, forse di proposito, forse no, e scava un solco nel muro a mezzo metro dalla spalla sinistra di Philip. Il ruggito della pistola è assordante nello spazio chiuso del corridoio e le orecchie di Philip rimbombano mentre l’uomo realizza che una scheggia dell’intonaco del muro gli si è conficcata nella guancia. Riesce a malapena a vedere Tara attraverso il fumo blu della cordite. Sul suo volto c’è un sorriso o forse una smorfia: è difficile capirlo ormai. “Il prossimo te lo becchi in faccia” gli dice. “Adesso farai il bravo bambino, vero?” Nick Parsons sente lo sparo subito dopo aver aperto la Bibbia della Concordanza per la sua lettura mattutina. Seduto sul letto, con la schiena appoggiata alla testata, sobbalza per il rumore, mentre la Bibbia gli cade di mano. Era aperta sull’Apocalisse di Giovanni, capitolo 1 versetto 9, la parte in cui Giovanni dice alla chiesa: “Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù”. Salta giù dal letto e va verso l’armadio, accanto al quale dovrebbe essere il suo fucile Marlin, appoggiato nell’angolo, ma il fucile non c’è. Il panico gli vibra lungo la spina dorsale: Nick comincia a girare su se stesso, si guarda intorno e nota tutte le cose che sono sparite dalla stanza. Lo zaino… sparito. Le scatole di cartucce… sparite. Gli attrezzi, il piccone, gli stivali, le mappe… tutto sparito. Almeno i jeans ci sono ancora, piegati con cura sullo schienale di una sedia. Li infila di corsa e si precipita fuori dalla stanza. Attraverso lo studio dell’appartamento. Fuori dalla porta. Lungo il corridoio. Giù per una rampa di scale e sul primo piano. Crede di sentire il suono di una voce acuta di rabbia, ma non ne è sicuro. Corre verso l’appartamento dei Chalmers. La porta non è chiusa a chiave e piomba all’interno. “Che succede? Che succede?” continua a ripetere Nick mentre si ferma di colpo nel soggiorno. Vede qualcosa che non ha senso. Tara Chalmers tiene la Ruger puntata contro Philip, Philip ha una strana espressione sul volto e Brian se ne sta a pochi passi di distanza e tiene stretta Penny, con le braccia che la avvolgono in un gesto protettivo. E cosa ancora più strana: tutte le loro cose sono ammucchiate sul pavimento davanti al divano. “Va’ da quella parte” ordina Tara, che brandisce l’arma per indicare a Nick di andare verso Philip, Brian e Penny. “Che problema c’è?” “Non ti preoccupare, basta che fai quello che ti dico.” Nick obbedisce lentamente, ma la sua mente è in preda alla confusione. In nome di Dio, cos’è successo lì dentro? Quasi involontariamente, Nick guarda Philip, guarda il grand’uomo negli occhi in cerca di risposte, ma per la prima volta da quando lo conosce, il grande uomo pare quasi sottomesso, assente, indeciso e frustrato. Nick guarda Tara. “Dov’è April? Cos’è successo?” “Non ti preoccupare.” “Cosa vuoi fare? Perché hai messo tutta la nostra roba nel…” “Nicky” interviene Philip. “Lascia perdere. Tara ti dirà ciò che vuole che facciamo. Noi lo facciamo e tutto si sistema.” Philip dice queste cose a Nick ma mentre le dice guarda Tara. “Da’ retta al tuo amico, Nick” dice Tara; anche lei parla con Nick ma non toglie gli occhi di dosso da Philip. I suoi occhi ardono di rabbia, disprezzo, vendetta e anche qualcos’altro, qualcosa di incomprensibile per Nick, qualcosa che percepisce come intimo, di un’intimità inquietante. Adesso è il turno di Brian di parlare. “Cosa vuoi che facciamo di preciso?” Tara, che continua a non distogliere lo sguardo da Philip, risponde: “Ve ne andate”. Sulle prime, a Nick Parsons quelle parole semplici e imperative sembrano un’affermazione retorica. Alle sue orecchie sbalordite, sembra quasi che non gli stia dicendo di fare qualcosa, bensì che stia esprimendo un’opinione. Ma quella reazione iniziale e tutto il suo ragionamento speranzoso vengono subito mandati in corto circuito dall’espressione sulla faccia di Tara Chalmers. “Ripartite.” Philip continua a fissarla. “Da dove vengo io, questo si chiama omicidio.” “Chiamalo come ti pare. Prendete la vostra roba di merda e andatevene.” “Vuoi farci uscire senza armi?” “Farò molto di più” dice. “Salirò sul tetto con uno di quei potenti fucili per ammazzare i piccioni e mi assicurerò che ve ne andiate.” Dopo un lungo, terribile momento di silenzio, Nick guarda Philip. E alla fine, Philip distoglie lo sguardo dalla robusta e pettoruta ragazza con la pistola. “Prendi la tua roba” ordina a Nick; e poi, rivolto a Brian: “C’è un poncho impermeabile nel mio zaino, mettilo a Penny”. Il tempo che impiegano a vestirsi e a prepararsi è molto breve, solo pochi minuti, durante i quali Tara Chalmers sta di guardia come una sentinella di pietra; eppure quel tempo è sufficiente a Brian Blake per rimuginare freneticamente su quanto potrebbe essere successo. Mentre allaccia gli stivali e mette l’impermeabile a Penny, comprende che tutti gli indizi puntano verso un qualche genere di perverso triangolo. L’assenza di April dice molto. Così come la furia legittima e assoluta di Tara. Ma cosa l’ha causata? Non può essere qualcosa che Philip ha detto o fatto. Cosa avrebbe potuto offendere le ragazze così nel profondo? Per un folle istante, la mente di Brian torna alla sua ex moglie pazza. Patologica, volatile, fragile, Jocelyn aveva fatto cose del genere. Era svanita senza lasciare tracce per settimane. Una volta, mentre Brian era alla scuola serale, aveva preso tutta la sua roba e l’aveva lasciata sulle scale del condominio, quasi che volesse cancellare una macchia dalla sua vita. Ma questo... questo è diverso. Le ragazze Chalmers non hanno dato segno di essere irrazionali o pazze. La cosa che lo irrita di più è il comportamento di suo fratello. Sotto la superficie di rabbia che ribolle e di frustrazione, Philip Blake sembra quasi rassegnato, forse persino disperato. Quello è un indizio importante. Ma il problema resta, non c’è tempo per trovare una soluzione. “Forza, datevi una mossa” dice Philip con lo zaino gettato sopra la spalla. Indossa il suo giubbotto di jeans, su cui sono ancora evidenti lo sporco, il grasso e il sangue del loro viaggio precedente, e si avvia verso la porta. “Aspetta!” dice Brian. Si gira verso Tara. “Almeno lasciaci prendere un po’ di cibo. Per il bene di Penny.” Lei sposta il suo sguardo su di lui e ribatte: “Vi lascerò uscire di qui vivi”. “Dai, Brian.” Philip si ferma sulla porta. “È finita.” Brian lo guarda. In quella faccia profondamente segnata e vissuta c’è qualcosa di galvanizzante per Brian. Philip è la sua famiglia, sangue del suo sangue. E hanno fatto così tanta strada. Sono sopravvissuti a troppi casini per morire adesso come cuccioli abbandonati sul lato della strada. Brian avverte una strana sensazione montargli alla base della spina dorsale e colmarlo di una forza inaspettata. “Va bene” dice. “Se è così che deve…” Non finisce la frase, non c’è nient’altro da dire, si limita a mettere un braccio intorno alle spalle di Penny e a condurla fuori dietro suo padre. La pioggia è una benedizione e una tortura. Gli frusta la faccia quando emergono dal portone principale del palazzo; ma quando si accucciano sotto gli alberi brulli lungo il marciapiede per prendere le loro cose, si accorgono che il temporale ha allontanato gli azzannatori dalle strade. Le fogne traboccano, le strade sono allagate dall’alluvione e il cielo grigio incombe. Nick strizza gli occhi guardando in lontananza verso sud, dove le strade sono relativamente sgombre. “Questa è la strada migliore! La maggior parte delle zone sicure è da quella parte!” “Okay, dirigiamoci a sud, allora” dice Philip e si volta verso Brian. “Puoi prenderla di nuovo a cavalcioni? Conto su di te, campione. Proteggila.” Brian si asciuga l’acqua dalla faccia e alza il pollice rivolto a suo fratello. Si gira verso la bambina e fa per posarsela gentilmente sulla schiena, ma lei si ferma di colpo. Per un brevissimo istante, lui si limita a fissarla meravigliato. Anche lei fa lo stesso gesto del pollice alzato. Brian guarda suo fratello e i due si comunicano qualcosa che va oltre le parole. Penny Blake rimane lì, ad aspettare, col mento spinto in avanti in un gesto di sfida. Sbatte i dolci occhioni per cacciare via la pioggia e l’espressione sulla sua faccia ricorda quella che la sua defunta madre mostrava quando aveva a che fare con le assurdità degli uomini. Alla fine, la piccola dice: “Non sono più una bambina… possiamo andare adesso?”. Si fanno strada fino all’angolo, tenendosi bassi e scivolando sul marciapiede viscido, con la pioggia che li ostacola. Gli sbatte in faccia e quasi subito gli entra nei vestiti e nelle articolazioni. È una pioggia autunnale gelida e pungente e non dà segno di volersi calmare. Più avanti, alcuni zombie cadaverici e malandati si sono raggruppati vicino a una fermata degli autobus abbandonata: le teste coi capelli unti sembrano coperte di muschio. Sembrano in attesa di un autobus che non arriverà mai. Philip guida il gruppo verso un angolo e sotto un tendone. Nick indica la via verso la prima zona sicura: l’autobus in disarmo a mezzo isolato a sud del cavalcavia. Un rapido gesto della mano di Philip e si affrettano lungo le vetrine verso l’autobus. “Io dico che dobbiamo tornare indietro” si lamenta Nick Parsons, mentre si accuccia sul pavimento dell’autobus e fruga nello zaino. La pioggia colpisce il tetto con il rumore di una raffica di mitragliatrice soffocata. Nick trova una Tshirt, la tira fuori e si asciuga la faccia. “È una donna sola: possiamo riprenderci quel posto. Io dico di tornare lì e cacciarla fuori a calci nel culo.” “Pensi che possiamo riprenderci il posto, eh?” Philip è vicino al sedile del guidatore e fruga nei compartimenti in cerca delle cosa lasciate dall’autista. “Hai un giubbotto antiproiettile in quello zaino?” L’autobus, lungo nove metri e coi sedili sagomati rivolti verso l’interno su entrambi i lati, puzza delle spettrali secrezioni di passeggeri ormai spariti, un odore simile a quello del pelo di un cane bagnato. In fondo, a riposare sul penultimo sedile, con Penny nel sedile accanto al suo, Brian rabbrividisce nella felpa bagnata e nei jeans. Ha una pessima sensazione e non solo per via della loro esposizione alla burrascosa giungla urbana di Atlanta. La sensazione di catastrofe che avverte ha a che fare piuttosto col mistero di quanto è successo nel condominio la notte prima. Non riesce a smettere di chiedersi cos’è successo di preciso tra le cinque del pomeriggio (quando Philip e April hanno intrapreso la loro missione) e le cinque del mattino del giorno dopo (quando tutto gli è esploso in faccia). Dalla tensione nella voce roca di suo fratello e dalla fredda determinazione sulla sua faccia, a Brian è ormai chiaro che la questione potrebbe diventare insignificante. La loro priorità immediata è sopravvivere. Ma Brian non può smettere di pensarci. Il mistero indica qualcosa di più profondo, qualcosa che lo rode dall’interno e che non riesce a mettere in parole. I fulmini lampeggiano all’esterno dell’autobus, brillanti come le luci di un fotografo. “Ce la cavavamo bene in quel posto” prosegue Nick con voce lamentosa e instabile. Si alza, afferrandosi a una maniglia. “Quelle sono le nostre armi, amico. E tutto il lavoro che abbiamo fatto? Quella roba è nostra quanto loro!” “Sta’ giù, Nick” dice Philip in tono piatto. “Non voglio che qualche sacco di pus ci veda.” Nick si abbassa. Philip si siede sul sedile dell’autista, le molle cigolano. Controlla il cassettino delle mappe sul cruscotto, ma non trova niente di utile. Le chiavi sono nell’accensione. Philip le gira ma ne esce niente più di un ticchettio. “Non te lo dirò di nuovo. Quel posto è andato.” “Perché? Perché non possiamo riprendercelo, Philly? Possiamo sopraffare quella troia cicciona. Tutti e tre!” “Lascia perdere, Nick” dice Philip, e persino Brian, in fondo all’autobus, sente il gelido tono d’avvertimento nella voce di Philip. “È solo che non capisco” si lamenta Nick piano. “Com’è potuta succedere una cosa del genere…” “Bingo!” Alla fine, Philip ha trovato qualcosa di utile. Una sbarra d’acciaio lunga un metro e mezzo, all’incirca della lunghezza e del peso dei cilindri di ferro usati nel cemento armato, è attaccata a dei ganci sotto il finestrino dell’autista. L’attrezzo termina con un uncino e molto probabilmente serviva ad arrivare alla porta a soffietto (per chiuderla manualmente) attraverso la cabina. Adesso, mentre Philip la brandisce nella luce fievole, sembra un’eccellente arma di fortuna. “Questa può andare” mormora. “Com’è potuto succedere, Philly?” insiste Nick, accucciandosi nella luce intermittente dei lampi. “DANNAZIONE!” All’improvviso Philip sbatte la sbarra di metallo sul cruscotto, spedendo schegge di plastica dappertutto e facendoli sobbalzare. La sbatte di nuovo, distruggendo la radio. Colpisce ancora e ancora, con tutta la sua forza, sfondando i controlli e schiantando la macchinetta dei biglietti, da cui le monetine escono volando. Continua a colpire la console finché il cruscotto non è distrutto. Alla fine, con le vene del collo gonfie e la faccia livida di furore, si volta e fissa i suoi occhi brucianti in quelli di Nick Parsons. “Chiudi quella cazzo di bocca!” Nick lo fissa. Sul fondo, seduta accanto a Brian, Penny Blake si gira e guarda fuori dal finestrino, dove la pioggia sporca continua a colare in rivoli. La sua espressione si indurisce come provasse a risolvere un problema matematico troppo complicato per le sue conoscenze scolastiche. Nel frattempo, sul davanti, Nick è paralizzato dallo shock. “Calmati, Philly… sto solo… chiacchierando. Vedi? Non significa niente. È solo che ormai quel posto mi piaceva.” Philip si lecca le labbra. Il fuoco nei suoi occhi si placa. Fa un respiro profondo ed espira dolorosamente. Appoggia la sbarra sul sedile dell’autista. “Senti… mi dispiace… capisco come ti senti. Ma è meglio così. Senza elettricità, quel posto sarà una cella frigorifera da metà novembre.” Nick continua a tenere lo sguardo basso. “Già… capisco il tuo punto di vista.” “È meglio così, Nicky.” “Certo.” A questo punto, Brian dice a Penny che tornerà subito e si alza dal sedile. Si muove lungo la corsia, restando basso sotto il livello dei finestrini, finché non raggiunge Nick e suo fratello. “Qual è il piano, Philip?” “Troveremo qualche posto dove accendere un fuoco. Non possiamo accendere fuochi in un condominio.” “Nick, quante altre zone sicure hai mappato finora?” “Abbastanza per uscire da questa zona della città, se facciamo una pausa o due.” “Presto o tardi, dovremo trovare una macchina” dice Brian. Philip grugnisce. “Ma davvero.” “Pensi che ci sia benzina in questo autobus?” “Diesel, probabilmente.” “Immagino che non abbia importanza cosa ci sia. Non abbiamo modo di tirarla fuori.” “E non abbiamo modo di mettercela dentro” gli ricorda Philip. “Né di muoverlo” aggiunge Nick. “Quell’affare di metallo che hai trovato?” Brian indica l’asta di metallo sul sedile dell’autista. “Pensi che sia abbastanza appuntito da perforare il serbatoio della benzina?” “Dell’autobus?” Philip guarda la sbarra d’acciaio. “Penso di sì. A cosa potrebbe servire?” Brian deglutisce a fondo. Ha un’idea. Uno alla volta, scivolano attraverso la porta a soffietto ed escono nella pioggia, che è ormai diventata una pioggerella gelida. La luce del giorno è torbida. Philip impugna la sbarra d’acciaio e Nick tiene le tre bottiglie marroni di Miller Light che Brian ha trovato incastrate sotto i sedili sul fondo. Brian tiene Penny vicino a sé: sagome scure si vedono in tutte le direzioni, le più vicine sono a forse un isolato di distanza, e il tempo passa in fretta. Nell’intervallo di pochi istanti, la luce dei fulmini rischiara la città con lampi al magnesio, illuminando i morti che arrivano dalla cima e dal fondo della strada. Alcuni zombie hanno notato gli umani che si affrettano sul fondo dell’autobus e adesso si avvicinano con andatura caracollante e con uno scopo più preciso. Philip era un camionista e sa dove si trova il serbatoio. Si accuccia a terra vicino all’enorme pneumatico e si infila rapido sotto il telaio per raggiungere l’estremità del serbatoio, mentre la pioggia gli sgocciola dalla faccia. Quell’autobus ha due serbatoi separati, ognuno dei quali contiene cinquecento litri di carburante. “Svelto, amico, stanno arrivando!” Nick si inginocchia dietro Philip con le bottiglie. Philip sbatte la parte appuntita della sbarra sul fondo del serbatoio più vicino, ma riesce solo a scheggiare l’involucro di ferro. Lancia un grido rabbioso e dirige di nuovo la punta contro il serbatoio. Questa volta, la punta perfora l’esterno della tanica e, all’improvviso, un flusso sottile di liquido giallo e oleoso gli cola sulle mani e sulle braccia. Nick si infila sotto e si affretta a riempire la prima bottiglia da trentatré centilitri. I tuoni martellano il cielo, seguiti da un’altra salva di fulmini. Brian guarda da sopra la spalla e vede un intero reggimento di cadaveri semoventi, illuminati a giorno dai lampi, a solo una ventina di metri di distanza: molte delle loro facce sono chiaramente riconoscibili nell’effetto stroboscopico delle saette. A uno manca la mascella; un altro cammina con un festone di intestini che penzola da uno squarcio nello stomaco. “Dai, Nick! Muoviti!” Brian tiene alcuni pezzi di una maglietta in una mano e un accendino nell’altra. Si agita irrequieto accanto a Penny, che fa del suo meglio per essere coraggiosa: stringe i piccoli pugni e si morde il labbro mentre sorveglia l’armata di cadaveri che avanzano. “Eccone una, vai, VAI!” Nick passa la prima bottiglia di carburante a Brian. Brian ci ficca dentro lo straccio e rovescia in fretta la bottiglia fino a farlo inzuppare. Gli occorrono solo pochi secondi, ma Brian avverte il tempo che si esaurisce e la presenza di centinaia di azzannatori che si avvicinano. Lo scatto dell’accendino produce una fiamma, che viene subito spenta dal vento. “Forza, campione… forza, forza!” Philip si gira verso l’orda in arrivo e solleva il suo attrezzo d’acciaio. Dietro di lui, Brian protegge la fiamma con le mani e riesce finalmente ad accendere la miccia. Lo straccio prende fuoco e le fiamme si accartocciano lungo il lato della bottiglia, tra il fumo e le gocce del liquido. Brian scaglia la bottiglia Molotov verso l’avanguardia della massa. La bottiglia si schianta a un metro e mezzo di distanza dagli zombie più vicini e fiorisce in un’esplosione di fuoco giallo, producendo un crepitio nella nebbia. Numerosi cadaveri barcollano all’indietro a causa della luce e del calore inattesi; alcuni urtano contro i loro simili, facendoli cadere come tessere del domino. In altre occasioni la vista di quei mostri che cadono sarebbe quasi divertente, ma non ora. Intanto Philip afferra la seconda bottiglia piena e ci ficca dentro lo straccio. “Dammi l’accendino!” Brian gli passa il Bic. “Adesso muovetevi!” ordina Philip, accendendo lo straccio e gettando la bottiglia in fiamme contro l’armata di mostri che giunge dalla direzione opposta. Stavolta la bottiglia si schianta in mezzo agli zombie: erutta tra le loro file e manda a fuoco almeno una dozzina di azzannatori con la ferocia del napalm. Brian non si guarda indietro mentre prende in braccio Penny e segue Nick nella fuga disperata verso la bottega del barbiere. Brian, Penny e Nick sono già a metà strada verso la prossima zona sicura quando si accorgono che Philip è rimasto indietro. “Che diavolo fa?” La voce di Nick è stridula e disperata, mentre si nasconde nell’androne di un altro negozio sbarrato. “Che diavolo ne so!” risponde Brian, infilandosi nell’androne con Penny e guardando indietro verso suo fratello. A un centinaio di metri di distanza, Philip grida verso i mostri qualcosa di osceno e inarticolato, roteando la sua arma di ferro contro un aggressore. Lo zombie in fiamme gli si avvicina avvolto in una voluta di fumo e scintille. “Oh, mio Dio!” Brian copre il viso di Penny. “Stai giù… STAI GIÙ!” In lontananza, Philip Blake si allontana dalla folla con l’accendino in una mano e la sbarra insanguinata nell’altra, come se fosse sotto l’effetto di una specie di frenesia vichinga, con tutta la rabbia repressa che emerge in una serie di plateali gesti sprezzanti. Si ferma e appicca il fuoco a una pozza di carburante che cola da sotto l’autobus; poi si volta e scappa con lo slancio e la velocità di un possessore di palla in un campo libero dagli avversari. Dietro di lui, la pozza di carburante prende fuoco e le fiamme blu si diffondono verso l’imponente sagoma d’acciaio dell’autobus. Philip percorre quasi cinquanta metri di asfalto bagnato e sfonda la testa di una mezza dozzina di azzannatori lungo la strada, mentre il fuoco risale sulla fiancata dell’autobus. Un tonfo basso e sordo si leva sopra la pioggia e i lamenti. Philip non riesce a vedere Brian e gli altri nella nebbia che si trova davanti. “PHILIP! DI QUA!” L’urlo di Brian è come un faro e Philip gira verso di lui mentre l’esplosione squassa il terreno e trasforma un pomeriggio grigio e scuro nella superficie del sole. Nessuno lo degna di un’occhiata. Sono tutti schiacciati contro una porta dentro l’alcova sbarrata, a proteggersi il volto dai frammenti in fiamme, dai pezzi dell’autobus, dalle schegge appuntite di carrozzeria metallica e dalle fontane di vetro, che volano oltre il portone. Brian intravede un riflesso su una vetrina dall’altra parte della strada: l’esplosione, a mezzo isolato di distanza, ha scagliato venti tonnellate di autobus dritte nel cielo: una nuvola a fungo di fuoco abbagliante e terribile. La potenza dello scoppio ha squarciato la cabina e l’onda d’urto rovente ha abbattuto moltitudini di morti con la luminosa violenza di una supernova. Innumerevoli corpi sono spazzati via dall’ondata, inceneriti nella fornace; alcuni vengono fatti a pezzi dai rottami scagliati in aria e i brandelli volano nel cielo in tempesta come uno stormo di uccelli in fuga. Un pezzo di parafango in fiamme si schianta a cinque metri dal portone. Tutti sobbalzano al clangore metallico dell’impatto, con gli occhi spalancati per lo shock. “Cazzo! CAZZO!” esclama Nick, proteggendosi il volto con le mani. Brian stringe Penny in un abbraccio serrato, senza parlare, momentaneamente paralizzato. Philip si pulisce la faccia col dorso della mano e si guarda intorno nell’androne con lo stupore di un sonnambulo che si è appena risvegliato. “Okay, allora.” Si guarda dietro da sopra la spalla, poi si volta di nuovo verso Nick. “Dov’è questa bottega di barbiere?” SEDICI Mezzo isolato più a sud, nel buio di una stanza piastrellata putrida e senza aria, tra i numeri sparpagliati di True Detective, pettini di plastica, piccoli ammassi di polvere e capelli e tubi di Brylcreem, si asciugano la faccia con asciugamani e grembiuli da barbiere e trovano altri ingredienti per le loro bottiglie Molotov fatte in casa. Le bottiglie di lozioni per capelli vengono svuotate, riempite di alcool e tappate con batuffoli di cotone. Sotto il registratore di cassa trovano nascosta una Louisville Slugger vecchia e ammaccata. Probabilmente, una volta, quella mazza da baseball teneva alla larga i clienti importuni o i criminali della zona intenzionati a rubare l’incasso della giornata. Philip passa la nuova arma a Nick e gli dice di usarla con giudizio. Recuperano tutto quanto giudicano utile. Da un vecchio distributore automatico sul retro prendono una manciata di barrette di cioccolato, un paio di Twinkie8 e un vecchio spiedino di salsiccia. Mentre riempiono gli zaini, Philip dice loro di non rilassarsi troppo. Sente dei rumori all’esterno: sempre più morti si stanno raggruppando nella zona, attirati dall’esplosione. La pioggia cala. I rumori si diffondono. Devono continuare a muoversi, se vogliono uscire dalla città prima che faccia notte. “Forza, forza” dice Philip. “Muoviamo il culo e andiamo verso la prossima zona… Nicky, facci strada.” Riluttante, Nick li guida fuori dalla bottega del barbiere, sotto la pioggia e giù lungo un’altra fila di vetrine. Philip fa da retroguardia, con la sbarra di ferro pronta a colpire e un occhio fisso su Penny, che si aggrappa alla schiena di Brian con l’istinto di una scimmia. A metà del percorso verso la successiva zona sicura, un cadavere randagio sbuca da dietro un tamponamento, barcollando minaccioso verso Brian e Penny. Philip lo centra sul retro del cranio con la parte appuntita della sbarra di ferro, colpendolo proprio sopra la sesta vertebra cervicale: il cranio si stacca e penzola sul petto mentre il corpo crolla sul selciato bagnato. Penny distoglie lo sguardo. Altri cadaveri si materializzano dalle imboccature dei vicoli e dalle ombre dei portoni. Nick trova il simbolo dipinto all’angolo dell’incrocio tra due strade. La stella è scarabocchiata sopra la porta di vetro di un negozietto. La facciata del negozio è avvolta in una saracinesca di ferro; ci sono anche cavi consunti, tubi al neon infranti e ammassi di nastro adesivo; gli scaffali delle vetrine sono vuoti. La porta è chiusa, ma non a chiave (proprio come Nick l’aveva lasciata tre giorni prima). Nick la spalanca e fa un cenno: tutti entrano di corsa. In effetti, si infilano dentro così in fretta che nessuno nota l’insegna del negozio sopra l’architrave della porta, dove le lettere al neon fredde e spente recitano “tom thumb’s tiny toy shoppe”. La facciata del negozio, appena centocinquanta metri quadrati, è disseminata di frammenti dai colori brillanti. Gli scaffali ribaltati hanno rovesciato sulle piastrelle infangate il loro inventario di bambole, macchinine da corsa e trenini. Un tornado di distruzione ha imperversato nel negozio. Dove un tempo stavano i mobili pendono ora mucchi di cavi; i resti in frantumi delle scatole di LEGO e degli aeroplanini sono accatastati qua e là. Le imbottiture di piuma dei giocattoli di peluche squarciati si muovono come foglie morte nella scia dei visitatori che entrano sbattendo le porte. Per un momento, restano nel vestibolo, gocciolanti di sudore, intenti a riprendere fiato e a bocca aperta davanti al sorprendente cumulo di rottami ammassato davanti a loro. Per parecchio tempo nessuno si muove. Qualcosa in quella rovina li ipnotizza e li tiene incollati alla soglia. “State tutti fermi” dice infine Philip, prendendo un fazzoletto e pulendosi la sporcizia dal collo. Cammina di lato, accanto a un orso di peluche dilaniato, poi si inoltra con cautela sul fondo del negozio. Vede una porta posteriore senza contrassegni, forse un magazzino, forse una via d’uscita. Brian mette giù Penny con gentilezza e controlla che non abbia ferite di nessun tipo. Penny guarda il triste mucchio di Barbie decapitate e animali di pezza sventrati. “Quando mi sono imbattuto in questo posto” dice Nick dall’altra parte della stanza, in cerca di qualcosa, “pensavo che forse ci avremmo trovato qualcosa di utile: gadget, walkie-talkie, torce elettriche… roba del genere.” Gira attorno alla cassa, fa alcuni passi e si sistema dietro il registratore di cassa. “Un posto come questo, in questa parte della città… diavolo, poteva esserci anche una pistola.” “Cosa c’è là dietro, Nicky?” Philip indica col pollice un passaggio, coperto da una tenda, sul retro del negozio. La tenda nera arriva fino al pavimento. “Hai avuto modo di darci un’occhiata?” “Un magazzino credo. Fa’ attenzione, Philly. È buio là dentro.” Philip si ferma vicino alla tenda, si toglie lo zaino e ci fruga dentro in cerca della piccola torcia elettrica delle dimensioni di una penna che tiene nella tasca laterale. La accende e si fa strada dietro la tenda… sparendo nell’oscurità. Dall’altra parte del negozio, Penny è ammaliata dalle bambole rotte e dagli orsacchiotti sventrati. Brian la controlla da vicino. Muore dalla voglia di aiutarla, di rimettere tutti in carreggiata, ma adesso non può far altro che inginocchiarsi accanto alla bambina e cercare di distrarla. “Vuoi una barretta di cioccolato?” “No.” La parola suona come pronunciata da una bambola parlante; gli occhi sono fissi su tutti i giocattoli distrutti. “Sei sicura?” “Sì.” “Abbiamo i Twinkie” dice Brian, per colmare il silenzio, per farla parlare, per tenerla occupata. Ma in quel momento, Brian non riesce a pensare a nient’altro che all’espressione sulla faccia di Philip, alla violenza nei suoi occhi e al fatto che tutto il mondo, il loro mondo, sta crollando a pezzi. “No, sto bene” dice Penny. Si avvicina a uno zainetto di Hello Kitty posato su una pila di immondizia. Lo raccoglie e lo controlla. “Pensi che qualcuno si arrabbierà se prendo un po’ di queste cose?” “Quali cose, piccola?” Brian la guarda. “Vuoi dire i giocattoli?” Lei annuisce. Una fitta di pena e vergogna squarcia il petto di Brian. “Prendili pure” dice. Lei comincia a raccogliere pezzi di bambole calpestate e animali di pezza sbrindellati. A Brian sembra quasi un rituale, come un rito di passaggio per la bambina, intenta a selezionare Barbie a cui manca qualche arto e orsetti con le cuciture strappate. Fa scivolare i giocattoli rovinati nello zaino con la cura di chi effettua il triage in una clinica. Brian sospira. Proprio in quell’istante, la voce di Philip li chiama da un luogo perso nei meandri del retrobottega e interrompe i pensieri di Brian, che stava per offrire irresponsabilmente a Penny la salsiccia allo spiedo. Adesso, però, Brian scatta in piedi. “Cos’ha detto?” Dall’altra parte del negozio, da dietro il registratore di cassa, Nick si rianima. “Non lo so… non ho sentito.” “Philip!” Brian comincia a muoversi verso la tenda che dà sul retro, con la pelle che freme per la tensione. “Stai bene?” Passi frettolosi risuonano da dietro la tenda che copre il passaggio poi, d’un tratto, la tenda si spalanca e Philip li guarda con la faccia contorta da un’espressione selvaggia, qualcosa a metà tra l’eccitazione e l’ossessione. “Prendete la vostra roba, abbiamo appena vinto alla fottuta lotteria!” Philip li conduce lungo un corridoio stretto e buio, oltre scaffali di giocattoli ancora nelle scatole, girato un angolo e attraverso una porta di sicurezza apparentemente chiusa, ma non a chiave, durante l’esodo precipitoso dei precedenti occupanti. Giù per un altro stretto corridoio, guidati dal sottile raggio di luce della torcia di Philip, giungono a una porta antincendio. La porta metallica è socchiusa e dall’altra parte sono visibili le ombre di un altro corridoio. “Date un’occhiata a quello che c’è dall’altra parte del nostro negozietto di giocattoli.” Philip apre la porta antincendio col piede. “Il nostro biglietto per uscire da questo inferno.” La porta metallica si spalanca e Brian si ritrova a guardare, attraverso un altro stretto corridoio, l’immagine speculare della prima porta antincendio. Anche la porta metallica che dà sulla sala è socchiusa, e dall’apertura Brian vede, celate dall’ombra, file di lucenti raggi di ruote. “Oh, mio Dio” mormora. “È quello che penso?” Lo spazio è enorme: comprende l’intero angolo del primo piano dell’edificio adiacente; su tre lati si dispongono vetrine di vetro rinforzato, attraverso le quali è possibile vedere l’angolo della strada all’esterno, dove sagome ombrose vagano senza meta, alla deriva nella pioggia come anime dannate. Ma dentro, nel lucente mondo felice del Champion Cycle Center, il principale venditore di motociclette di Atlanta, tutto è caldo, ordinato e lucidato a dovere. Il salone non sembra essere stato toccato dall’epidemia. Nella luce pallida e smorta che filtra dalle imponenti vetrine, motociclette di tutte le marche e modelli sono allineate in quattro file ordinate, che si estendono da un estremo all’altro della rivendita. L’aria odora di gomma nuova, di pelle oliata e di acciaio finemente lavorato. I lati del salone sono rivestiti da tappeti ricamati con il logo, nuovi e lussuosi come quelli della hall di un albergo elegante. Insegne al neon spente pendono dal soffitto coi nomi delle marche delle moto: Kawasaki, Ducati, Yamaha, Honda, Triumph, Harley-Davidson e Suzuki. “Pensi che ci sia della benzina nelle moto?” Brian compie un lento giro su se stesso, ammirando l’intero salone. “Non abbiamo che da scegliere, campione.” Philip indica con un cenno il fondo della stanza, oltre il bancone della cassa, le scrivanie e gli scaffali traboccanti di pezzi di ricambio. “Sul retro c’è un’officina… possiamo travasare la benzina in tutte le moto che vogliamo abbastanza in fretta.” Penny guarda senza emozioni il tripudio di cromo e gomma. Tiene lo zainetto di Hello Kitty stretto saldamente alle spalle sottili. La testa di Brian gira. Emozioni contrastanti si schiantano una contro l’altra come onde impetuose: eccitazione, ansia, speranza, paura. “C’è solo un problema” mormora piano, sentendo sulle spalle il peso dell’angoscia e dell’incertezza. Philip lo guarda. “Che diavolo di problema hai adesso?” Brian si pulisce la bocca. “Non ho la minima idea di come funzionano questi affari.” Si fanno tutti una necessaria risata, una risata nervosa, fragile forse, ma nonostante tutto una risata, alle spese di Brian. Philip gli assicura che non fa nessuna differenza se non ha mai guidato una motocicletta: qualsiasi idiota imparerebbe a farlo in due minuti. Cosa più importante, Philip e Nick hanno avuto delle moto nel corso degli anni e l’ultima volta che Philip ha controllato erano solo in quattro: i due che non guidano possono viaggiare sul sellino posteriore. “Prima ce ne andiamo da Atlanta, più possibilità abbiamo di sopravvivere senza armi” dice Philip alcuni minuti dopo, rovistando in uno scaffale di vestiti di pelle nell’angolo posteriore del negozio, tra giubbotti, pantaloni, magliette e accessori. Si sceglie un giubbotto marrone della Harley e un paio di robusti stivali da lavoro neri. “Voglio che vi cambiate i vestiti bagnati e vi prepariate a partire entro cinque minuti… Brian, tu aiuta Penny.” Si cambiano, mentre la pioggia fuori dai vetri comincia a placarsi. L’angolo della strada pullula di figure traballanti, decine di sagome logore e cenciose, alcune delle quali bruciate dall’esplosione, altre in stato di decomposizione avanzata. Le facce sono incavate, alcune brulicano di parassiti e altre si illividiscono in maschere ammuffite di carne putrefatta. Nessuno, però, si accorge del movimento all’interno del salone buio. “Vedi quegli azzannatori che si radunano qui fuori?” dice sottovoce Nick a Philip. Nick si è già messo un cambio di vestiti asciutti e si sta allacciando un giubbotto di pelle nero. Fa un lieve cenno verso la luce grigia della vetrina. “Alcuni sono quasi andati del tutto.” “E allora?” “Alcuni hanno… quanto?… tre, quattro settimane?” “Come minimo.” Philip ci pensa per un momento, mentre si toglie i vestiti di jeans bagnati. La biancheria gli si è incollata alla pelle e deve praticamente sbucciarsela di dosso. Si gira in modo che Penny non lo veda nudo. “Tutta questa cosa è scoppiata da più di un mese ormai… beh?” “Si stanno decomponendo.” “Eh?” Nick abbassa la voce per non farsi sentire da Penny; la bambina è dall’altra parte del salone, impegnata a infilarsi un giubbotto invernale di taglia small, con Brian che cerca di allacciarglielo. “Pensaci, Philly. Secondo il naturale corso degli eventi, un cadavere diventa polvere in un anno, più o meno.” Abbassa ancora di più il tono della voce. “Specie quelli esposti agli elementi.” “Cosa vuoi dire, Nick? Che non dobbiamo far altro che aspettare? Lasciare che i vermi facciano tutto il lavoro?” Nick scrolla le spalle. “Beh, sì, pensavo che…” “Ascolta.” Philip gli punta un dito in faccia. “Tieni per te le tue teorie.” “Non intendevo…” “Quei mostri non se ne andranno, Nicky. Ficcatelo per bene in quella testaccia dura. Non voglio che mia figlia senta queste stronzate. Mangiano i vivi e nel farlo si riproducono; e quando si saranno decomposti, ce ne saranno molti altri a prendere il loro posto. A giudicare dal fatto che il vecchio Chalmers si è trasformato senza essere stato morso, i giorni di tutto il fottuto mondo sono contati, perciò bevici su, bubba, è troppo tardi, più tardi di quanto tutti pensiate.” Nick abbassa lo sguardo. “D’accordo, amico, ho capito… calmati, Philly.” A questo punto, Brian ha finito di infagottare Penny e i due si avvicinano. “Siamo pronti, più pronti di così…” “Che ore sono?” chiede Philip a Brian, che sembra quasi ridicolo nel giubbotto di pelle della Harley di una taglia e mezzo troppo grande. Lui guarda l’orologio. “Quasi mezzogiorno.” “Bene… abbiamo almeno sei, sette ore buone di luce per lasciare la città.” “Avete scelto le vostre moto, ragazzi?” chiede Brian. Philip gli rivolge un sorriso freddo. Scelgono due dei più grossi capolavori di metallo del negozio, un paio di Harley-Davidson Electra Glide, una blu perla e l’altra tutta nera. Le scelgono per le dimensioni dei motori, la spaziosità dei sedili, i centimetri cubici di spazio dei bagagliai e anche perché, ehi, sono delle fottute Harley. Philip decide che Penny viaggerà con lui e Brian viaggerà con Nick. I serbatoi sono vuoti ma nell’officina sul retro ci sono parecchie moto fornite di carburante: ne travasano il più possibile dentro le Harley. Nei quindici minuti che occorrono per preparare le moto, trovare i caschi della misura giusta e trasferire tutti i loro averi nelle borse portabagagli, la strada davanti al negozio brulica di morti. Adesso centinaia di azzannatori affollano l’incrocio, vagano senza meta nella pioggerella grigia, si sfregano contro il vetro, lanciano i loro gemiti intorpiditi, sbavano la loro bile nera, fissano i loro occhi di peltro sulle ombre che si muovono dentro le vetrine del Champion Cycle Center. “È affollato là fuori” borbotta Nick, senza rivolgersi a nessuno in particolare, mentre trascina la massiccia due ruote verso l’uscita, dove una porticina verticale dà sul parcheggio che costeggia la rivendita. Si allaccia il casco. “Abbiamo l’elemento sorpresa” dice Philip, spingendo la Harley nera verso la porta. Indossa il casco e il suo stomaco brontola per la fame e il nervosismo. Non mangia da quasi ventiquattr’ore. Nessuno di loro ha mangiato. Infila la sbarra di ferro che ha preso sull’autobus in una cucitura tra il manubrio e il parabrezza (per poterla afferrare agevolmente e alla svelta). “Forza, pulcino, salta su” dice a Penny, che se ne sta impacciata lì vicino con in testa un casco per bambini. “Andiamo via, ci facciamo un giretto.” Brian aiuta la bambina a salire sul sellino posteriore, un trespolo imbottito sopra il comparto per i bagagli laccato di nero. C’è una cintura di sicurezza in uno dei comparti laterali e Brian la allaccia attorno alla vita della bambina. “Non preoccuparti, piccola” le dice sottovoce. “Ci dirigeremo a sud e poi a ovest, capito?” dice Philip, montando in sella alla bestia di ferro. “Nicky, tu seguimi.” “Ricevuto.” “Siete pronti?” Brian si avvia verso la porta e annuisce nervoso. “Pronto.” Philip accende la Harley, il motore ulula e riempie il salone buio di rumore e fumo. Nick accende la sua moto. Il secondo motore suona una melodia di rumore all’unisono dissonante con l’altro. Philip dà gas e fa il segnale a Brian. Brian aziona la serratura manuale della porta e la spalanca nel vento bagnato. Philip dà gas e parte. Brian balza sul sellino posteriore della moto di Nick, che parte a razzo dietro Philip. “OH, MERDA! OH, DIO! PHILIP! PHILIP! GUARDA IN BASSO! GUARDA IN BASSO, AMICO! PHILIP, GUARDA IN BASSO!” L’urlo disperato di Brian è soffocato dal casco e sommerso dal rumore delle motociclette. È successo appena pochi istanti dopo che sono sfrecciati attraverso la massa di azzannatori che ingolfava l’incrocio, coi corpi a brandelli che rimbalzavano sui parafanghi. Dopo aver compiuto una brusca svolta a sinistra ed essere schizzati a sud su Water Street, lasciando le schiere di non morti a mangiare la polvere e il fumo, Brian ha visto il cadavere straziato trascinarsi sull’asfalto dietro la moto di Philip. La parte inferiore del corpo è stata strappata, gli intestini sono come cavi elettrici che sbandierano al vento, ma nel torace è rimasta ancora abbastanza energia e la testa putrefatta è intatta. Si è aggrappato al parafango posteriore con le braccia morte e comincia a issarsi lungo il fianco della Harley. Ma la cosa peggiore è che né Philip né Penny sembrano essersene accorti. “AFFIANCATI A LUI! NICK, AFFIANCATI!” urla Brian, con le braccia strette attorno al torace di Nick. “CI STO PROVANDO!” A quel punto, mentre ruggisce lungo la strada laterale deserta e bagnata, la moto sbanda sull’asfalto viscido; Penny nota la creatura attaccata alla moto che si arrampica verso di lei e comincia a urlare. Da dove si trova Brian, una decina di metri più indietro, il grido della bambina non si sente e appare come il gesto esagerato di un’attrice del cinema muto. Nick dà gas. La sua Harley riduce la distanza. “PRENDI LA MAZZA!” grida sopra il frastuono e Brian cerca di estrarre la mazza da baseball da sotto il portabagagli. Più avanti, quasi senza preavviso, Philip Blake si avvede della cosa attaccata dietro la sua moto. Il casco di Philip si guarda rapidamente intorno mentre lui annaspa per prendere la sua arma. Nel frattempo, Nick è arrivato a quasi due metri dal fanalino di coda della Harley nera; ma prima che Brian possa intervenire con la mazza, Philip estrae la sbarra di ferro dal suo fodero di fortuna sul davanti della moto. Con un movimento rapido e violento, che fa deviare leggermente la Harley nera dal suo percorso, si gira sul sedile, tenendo il manubrio con una sola mano, e conficca la punta della sbarra di metallo nella bocca dello zombie. La testa infilzata del mostro resta bloccata pochi centimetri sotto Penny, con la sbarra incastrata tra i tubi di scappamento cromati. Philip solleva la gamba destra e, con la potenza di un ariete, scalcia il cadavere (con la sbarra e tutto) giù dalla moto. Il mostro cade e rotola e Nick deve scartare bruscamente per evitarlo. Philip aumenta la velocità, mantenendo la rotta, diretto a sud, senza prendersi il disturbo di guardarsi indietro. Proseguono, zigzagando attraverso la zona sud della città ed evitando le aree congestionate. Dopo un paio di chilometri, Philip trova un’altra arteria principale piuttosto libera da tamponamenti e morti vaganti e li guida lungo quella strada. Sono già a cinque chilometri dai confini di Atlanta. La linea dell’orizzonte è netta e il cielo si sta lentamente schiarendo a ovest. La benzina che hanno è sufficiente a percorrere seicentocinquanta chilometri senza doversi fermare per fare rifornimento. Qualsiasi cosa li aspetti là fuori, nel grigio paesaggio rurale, è meglio di quello che hanno passato ad Atlanta. Deve esserlo. PARTE TERZA La teoria del caos “Nessun uomo sceglie il male perché è il male; lo scambia solo per la felicità, per il bene che cerca.” —Mary Wollstonecraft DICIASSETTE Arrivati vicini all’aeroporto di Hartsfield, la pioggia cessa e lascia il posto a un cielo metallico lugubre e freddo, solcato da nuvole basse. Eppure, è una sensazione fantastica essere arrivati così lontano in meno di un’ora. Le corsie della superstrada 85 sono intasate da un numero molto inferiore di tamponamenti rispetto alla Interstate 20 e la popolazione di morti è considerevolmente diminuita. La maggior parte degli edifici ai margini della strada sono ancora intatti: le porte e le finestre sono state sbarrate e messe in sicurezza. I morti che vagano qua e là sembrano ormai parte del paesaggio: si fondono con gli alberi scheletrici come un fungo spettrale che infesta i boschi. Anche la terra sembra cambiata. Le città stesse sono morte. Viaggiare attraverso quella zona lascia un’impressione di desolazione più che di fine del mondo. L’unico problema immediato è che tutte le stazioni di servizio abbandonate e le aree di sosta per camion sono infestate di azzannatori e Brian comincia a essere molto preoccupato per Penny. A ogni fermata, che sia per fare i propri bisogni o per cercare un po’ di cibo e di acqua, la sua faccia sembra più tirata, la boccuccia di tulipano sempre più screpolata. Brian teme che possa disidratarsi. Diavolo, teme che tutti loro possano disidratarsi. Lo stomaco vuoto è una cosa: possono tirare avanti senza cibo per lunghi periodi di tempo, ma la mancanza d’acqua sta diventando un problema serio. A quindici chilometri a sud-ovest di Hartsfield, mentre il paesaggio diventa un patchwork di foreste di pini e piantagioni di germogli di soia, Brian si chiede se possono bere l’acqua dei radiatori delle motociclette, quando vede incombere dall’alto un cartello direzionale verde con un messaggio provvidenziale: AREA DI SOSTA – 1 MIGLIO. Philip fa segno di fermarsi e infilano la rampa d’uscita successiva. Mentre rombano su per la rampa e si infilano nel parcheggio, circondato da una piccola area attrezzata per turisti, il sollievo pervade Brian come un balsamo: per fortuna il posto è deserto, sgombro da qualsiasi segno di vita o di morte. “Cos’è successo davvero laggiù, Philip?” Brian è seduto a un tavolo da picnic su un piccolo promontorio d’erba dietro lo stabile dell’area di sosta. Philip cammina avanti e indietro e scola una bottiglia di Evian che ha strappato a un distributore automatico rotto. Nick e Penny sono a una cinquantina di metri di distanza, ancora a portata di vista. Nick la spinge delicatamente su una vecchia giostra sgangherata sotto una quercia malata. La bambina si limita a starsene seduta sul gioco, malinconica, come una gargoyle, con lo sguardo fisso davanti a sé mentre gira, gira e gira. “Ti ho già detto una volta di lasciar perdere” brontola Philip. “Credo che tu mi debba una risposta.” “Non ti devo un cazzo.” “È successo qualcosa quella notte” insiste Brian. Non ha più paura di suo fratello. Sa che Philip potrebbe pestarlo a sangue in qualsiasi momento, il potenziale per uno scoppio di violenza tra i Blake sembra adesso più imminente che mai, ma a Brian non importa. Nel suo profondo qualcosa si è spostato come una placca tettonica che cambia col paesaggio. Se Philip vuole saltargli alla gola, lo faccia pure. “Qualcosa tra te e April.” Philip resta immobile e abbassa lo sguardo. “Che cazzo di differenza fa?” “Fa una grande differenza… la fa per me. Ci sono le nostre vite in ballo qui. In quel posto avevamo una buona probabilità di sopravvivere e poi, di punto in bianco… puff?” Philip alza lo sguardo. I suoi occhi si fissano su quelli del fratello e tra i due uomini passa qualcosa di molto oscuro. “Lascia perdere, Brian.” “Dimmi solo una cosa. Sembravi così deciso ad andartene da Atlanta… hai un piano?” “Cosa vuoi dire?” “Hai, che so, una strategia? Un’idea di dove diavolo siamo diretti?” “Cosa sei, una fottuta guida turistica?” “E se gli azzannatori si infoltiscono? In fin dei conti, abbiamo solo un pezzo di legno per combatterli.” “Troveremo qualcos’altro.” “Dove andiamo, Philip?” Philip si gira e si tira su il colletto del giubbotto di pelle, fissando il nastro d’asfalto che serpeggia verso l’orizzonte a occidente. “Tempo un mese e arriverà l’inverno. Pensavo di continuare a muoverci, di dirigerci a sud-ovest… verso il Mississippi.” “E poi?” “È il modo più semplice per andare a sud.” “E?” Philip si volta e lo guarda: un misto di determinazione e angoscia gli attraversa la faccia segnata, come se non credesse davvero a quello che sta per dire. “Troveremo un posto dove vivere, a lungo, al sole. Un posto tipo Mobile o Biloxi. New Orleans, magari… non lo so. Un posto caldo. E vivremo lì.” Brian si lascia sfuggire un sospiro esausto. “Sembra così facile. Basta andare a sud.” “Se hai un piano migliore, sono tutto orecchi.” “I piani a lungo termine sono un lusso a cui non ho ancora pensato.” “Ce la faremo.” “Dobbiamo trovare un po’ di cibo, Philip. Sono molto preoccupato per l’alimentazione di Penny.” “Ci penso io a preoccuparmi per mia figlia.” “Non vuole mangiare nemmeno un Twinkie. Ci credi? Una bambina che non vuole mangiare un Twinkie.” “Cibo da scarafaggi” grugnisce Philip. “Non la biasimo. Troveremo qualcosa. Starà bene. È una piccola dura… come sua madre.” A questo Brian non ha niente da obiettare. Di recente, la bambina ha mostrato uno spirito straordinario. In effetti, Brian ha cominciato a chiedersi se Penny sia la colla che li tiene tutti insieme, impedendo loro di autodistruggersi. Getta una sguardo dall’altra parte dell’area di sosta e vede Penny Blake girare con aria sognante sulla giostra arrugginita nel piccolo, lugubre campo giochi. Nick ha perso l’entusiasmo di spingerla e si limita a darle qualche spinta con lo stivale. Oltre il campo giochi, il terreno si solleva in una collinetta invasa dalla vegetazione, dove si trova un piccolo cimitero spazzato dal vento nel sole pallido. Penny parla con Nick e gli fa il terzo grado riguardo a chissà quale argomento. Brian si chiede di cosa i due stiano parlando: la bambina sembra molto preoccupata. “Zio Nick?” Il faccino di Penny è teso per l’apprensione mentre gira piano sulla giostra. Lo chiama zio da anni, anche se sa bene che non è davvero suo zio. Quella finzione ha sempre alimentato in Nick una segreta punta di desiderio, il desiderio di essere davvero lo zio di qualcuno. “Sì, tesoro?” Un opprimente senso di catastrofe si abbatte su Nick Parsons mentre spinge Penny distratto. Con la coda dell’occhio vede i fratelli Blake che litigano per qualcosa. “Il mio papà ce l’ha con me?” chiede la bambina. Nick reagisce a scoppio ritardato. Penny abbassa lo sguardo, continuando a girare lentamente. Nick misura le parole. “Certo che no. Non è arrabbiato con te. Cosa vuoi dire? Perché mai dovresti anche solo pensare una cosa del genere?” “Non parla mai con me come faceva prima.” Nick ferma con gentilezza la giostra. La bambina oscilla in avanti contro la sbarra di sicurezza. Nick le dà una tenera pacca sulla spalla. “Ascolta. Te lo giuro. Tuo padre ti ama più di ogni altra cosa al mondo.” “Lo so.” “È solo che ha un sacco di cose per la testa. Tutto qui.” “Credi che ce l’abbia con me?” “Non esiste. Ti ama in maniera quasi feroce, Penny. Credimi. Ha solo… un sacco di cose per la testa.” “Già… immagino di sì.” “Come tutti.” “Già.” “Nessuno di noi ha parlato molto negli ultimi tempi.” “Zio Nick?” “Sì, tesoro?” “Credi che lo zio Brian ce l’abbia con me?” “Dio, no. Perché lo zio Brian dovrebbe avercela con te?” “Forse perché deve portarmi tutto il tempo?” Nick sorride triste. Studia l’espressione sul volto della bambina, la piccola fronte corrugata e seria. Le accarezza la guancia. “Ascoltami. Sei la bambina più coraggiosa che io abbia mai incontrato. Dico davvero. Sei una Blake… ed è una cosa di cui essere orgogliosi.” Lei ci pensa e sorride. “Sai cosa voglio fare?” “No, tesoro. Dimmelo.” “Aggiusterò quelle bambole rotte. Vedrai. Le aggiusterò tutte.” Nick le sorride. “Mi sembra un’ottima idea.” Il sorriso della bambina è una cosa che Nick Parsons non era sicuro di vedere ancora. Un istante dopo, dall’altra parte dell’area di sosta, tra i tavoli da picnic, Brian Blake vede qualcosa con la coda dell’occhio. A un centinaio di metri di distanza, oltre il campo giochi, in mezzo alle lapidi ribaltate, con le iscrizioni sbiadite dal tempo e i fiori di plastica malconci, qualcosa si muove. Brian fissa il suo sguardo su tre figure che emergono lontane dall’ombra degli alberi. Si trascinano in formazione casuale e si avvicinano come segugi pigri che hanno fiutato la preda. È difficile dirlo da quella distanza ma i loro vestiti sembrano passati sotto una mietitrice: le bocche sono spalancate in un perpetuo tormento. “È ora di rimetterci in movimento” dice Philip senza nessuna fretta, diretto verso il campo giochi con passo pesante e meccanico. Mentre si affretta a seguirlo, Brian pensa, solo per un istante, che per il modo di camminare, per le braccia muscolose rilassate lungo i fianchi, per il peso del mondo sulle sue spalle, da lontano, anche suo fratello potrebbe facilmente essere scambiato per uno zombie. Percorrono altri chilometri. Girano intorno a cittadine vuote e immobili come diorami in un enorme museo. La luce blu del tramonto comincia a gettare la sua ombra sul cielo coperto e il vento soffia pungente contro le visiere dei caschi mentre aggirano tamponamenti e rimorchi abbandonati, facendosi strada verso ovest sulla 85. Brian pensa che devono trovare un posto dove passare la notte. Appollaiato sul sellino dietro Nick, con gli occhi che gli lacrimano e le orecchie assordate dal vento e dal ruggito del motore a due alberi della Harley, ha fin troppo tempo per figurarsi il posto perfetto per il viaggiatore sfinito nella terra dei morti. Immagina un’enorme, tentacolare fortezza con giardini, passaggi, fossati impenetrabili, recinzioni di sicurezza e torrette di guardia. Darebbe la palla sinistra per una bistecca e delle patatine fritte. O una bottiglia di Coca-Cola. O anche solo per un po’ della misteriosa carne dei Chalmers… Un riflesso all’interno della visiera del casco interrompe il flusso dei suoi pensieri. Si guarda alle spalle. Strano. Per un brevissimo istante, nel preciso momento in cui ha visto una macchia scura attraverso la visiera del casco, ha creduto di sentire qualcosa alla nuca, una sensazione vaga, come un bacio schioccato da labbra gelide. Forse è stata la sua immaginazione, ma forse qualcosa è apparso nello specchietto retrovisore. Solo per un istante. Proprio prima che deviassero verso sud. Si guarda alle spalle e non vede niente, se non le corsie vuote che si srotolano dietro di loro, indietreggiando in lontananza per svanire dietro la curva. Scrolla le spalle e torna ai suoi pensieri sconclusionati e caotici. Si avventurano più a fondo nella periferia rurale, finché non vedono nient’altro se non chilometri e chilometri di fattorie in rovina e campagna incolta. Le sinuose colline di campi di fagioli affondano in scoscese morene su entrambi i lati dell’autostrada. È una terra vecchia, preistorica, stanca, lavorata fino alla morte per generazioni. Carcasse di vecchi macchinari giacciono dormienti ovunque, seppelliti dai rampicanti e dal fango. Il crepuscolo si fa notte e il cielo scolora dal grigio pallido in un indaco profondo. Ormai sono le sette passate e Brian ha dimenticato del tutto il lampo di movimento che si era riflesso sulla sua visiera. Hanno bisogno di trovare un riparo. Il fanale di Philip si accende, gettando un raggio di luce argentata sulle ombre che calano. Brian sta per urlare qualcosa riguardo alla necessità di trovare un nascondiglio quando vede Philip che fa un cenno con un gesto rigido; poi un dito inguantato indica verso destra. Brian guarda a nord e vede quello che suo fratello sta indicando. Molto lontano, tra le distese sinuose dei campi coltivati, sopra una macchia di alberi, è visibile il profilo di una casa, lontana tanto da sembrare quasi una sagoma ritagliata nel cartoncino nero. Se Philip non l’avesse indicata, Brian non l’avrebbe mai notata. Ma adesso capisce perché ha attirato l’attenzione di Philip: sembra una grande reliquia del diciannovesimo secolo, forse addirittura del diciottesimo; probabilmente un tempo era la villa del padrone di una qualche piantagione. Brian scorge un altro guizzo di movimento nello specchietto retrovisore, qualcosa dietro di loro, che è passato per appena una frazione di secondo ai margini del suo campo visivo. Poi, quando si gira sul sedile per guardarsi alle spalle, quel qualcosa è andato, sparito. Imboccano rombando l’uscita successiva e si mettono su una vecchia strada polverosa. Mentre si avvicinano alla casa, che si staglia tutta sola sulla cima di una vasta collina a quasi un chilometro dall’autostrada, Brian trema dal freddo. Di colpo, benché più si avvicinino alla fattoria, più invitante essa si riveli, lo assale una sensazione terribile. Quella zona della Georgia è nota per i suoi frutteti, pesche, fichi e susine, e mentre percorrono il tortuoso vialetto che conduce alla casa, vedono che si tratta di una bellezza in declino. Circondato da alberi di pesche, che si stendono in lontananza come i raggi di una ruota, l’edificio centrale è un’imponente pila di mattoni alta due piani con solai decorati e abbaini sul tetto. Ha il gusto di una vecchia, decrepita villa italiana. La veranda è un portico lungo quindici metri con colonne, balaustre e finestre ad archi soffocate da tralci di edera marrone e bouganville. Nella luce del tramonto, sembra quasi una nave fantasma di una flotta risalente a prima della Guerra Civile. Il rumore e il fumo delle Harley turbinano nell’aria polverosa mentre Philip li conduce nello spiazzo davanti alla casa, una zona in cui troneggia una grandiosa fontana decorativa di marmo e muratura. Apparentemente in rovina, la fontana ha il bacino coperto da una pellicola di melma. Sulla destra ci sono numerosi altri edifici annessi, stalle forse. C’è anche un trattore semisepolto dalle erbacce. A sinistra della facciata c’è una gigantesca rimessa per carrozze, grande abbastanza da ospitare sei automobili. Brian non registra nulla di quell’antica opulenza, mentre si avvicinano cauti a una porta laterale tra il garage e l’edificio principale. Philip ferma la sua Harley in una nuvola di fumo e polvere, facendo rombare il motore per un istante. Poi la spegne e rimane lì, a fissare quella mostruosità dai muri color salmone. Nick si ferma accanto a lui e abbassa il cavalletto. Per un lungo lasso di tempo non dicono una parola. Alla fine, Philip abbassa il cavalletto, smonta e dice a Penny: “Aspetta qui un secondo, pulcino”. Nick e Brian scendono. “Avete quella mazza da baseball a portata di mano?” dice Philip, senza nemmeno guardarli. “Pensi che ci sia qualcuno là dentro?” chiede Nick. “C’è solo un modo per scoprirlo.” Philip aspetta che Nick giri intorno alla sua Electra Glide e afferri la mazza, infilata lungo il fianco del portabagagli. Lui la prende e gliela porge. “Voi due restate con Penny” dice Philip, e si avvia verso il portico. Brian lo ferma, afferrandolo per il braccio. “Philip…” Brian sta per dire qualcosa sulle sagome scure che ha intravisto nello specchietto retrovisore quando erano ancora sull’autostrada, ma si blocca. Non è sicuro di volere che Penny senta quanto ha da dire. “Si può sapere che diavolo di problema hai?” dice Philip. Brian deglutisce a vuoto. “Credo che qualcuno ci segua.” I precedenti occupanti della villa sono spariti da tempo. In effetti, l’interno della casa sembra vuoto da molto prima dell’inizio dell’epidemia. Lenzuola ingiallite ricoprono i mobili antichi. Le numerose stanze sono polverose camere congelate nel tempo. Un orologio a pendola continua a ticchettare testardo in un salotto. Finezze di un’era passata addobbano la casa: modanature elaborate, portefinestre, scalinate circolari e due massicci camini delle dimensioni di una cabina armadio. Coperti dalle lenzuola ci sono un grande pianoforte, un grammofono Victrola e una stufa a legna. Philip e Nick perlustrano i piani superiori in cerca di azzannatori ma trovano solo altre reliquie impolverate del Vecchio Sud: una biblioteca, un corridoio di dipinti a olio dei generali Confederati su cornici dorate, una stanza dei bambini con una vecchia culla impolverata dei tempi delle Colonie. La cucina è sorprendentemente piccola, un altro retaggio del diciannovesimo secolo quando solo i servi si sporcavano le mani per cucinare; la dispensa invece è enorme e gli scaffali traboccano di cibo in scatola impolverato. Il riso e i cereali secchi sono farinosi e infestati di vermi, ma l’assortimento di frutta e verdura è incredibile. “Hai le traveggole, campione” dice Philip piano, più tardi quella notte, davanti a un fuoco crepitante acceso nel salotto. Dopo aver trovato pile di legna da ardere nel cortile vicino al granaio, sono riusciti a scaldarsi le ossa per la prima volta da quando hanno lasciato Atlanta. Il calore, la sicurezza della villa e la cena a base di pesche in scatola e gombo hanno fatto addormentare Penny all’istante. Dorme tranquilla sotto una lussuosa trapunta nella stanza dei bambini al secondo piano. Nick dorme nella stanza accanto alla sua. Ma i due fratelli sono insonni. “E comunque chi diavolo si prenderebbe il disturbo di segui re noi?” aggiunge Philip, bevendo un altro sorso del costoso sherry da cucina che ha trovato nella dispensa. “Ti dico quello che ho visto” dice Brian, agitandosi nervoso su una sedia a dondolo dall’altra parte del fuoco. Si è messo una maglietta asciutta e un paio di pantaloni della tuta e si sente di nuovo quasi umano. Guarda suo fratello che fissa il fuoco con uno sguardo intenso, come in cerca di un messaggio in codice segreto. Per qualche ragione, la vista della faccia scarna e preoccupata di Philip, che riflette il tremolio del fuoco, spezza il cuore di Brian. Gli tornano in mente gli epici viaggi nei boschi della sua infanzia e le notti passate nelle tende e nei capanni. Ricorda di essersi bevuto la sua prima birra insieme a suo fratello, quando Philip aveva solo dieci anni e Brian ne aveva tredici: Philip lo aveva fatto finire sotto il tavolo a furia di bevute già quella volta. “Potrebbe essere stata una macchina” prosegue Brian. “O forse un furgone, non ne sono sicuro. Ma te lo giuro, l’ho vista solo per un secondo… e sembrava proprio che ci seguisse, cazzo.” “E se anche ci fosse qualcuno che ci segue, chi se ne frega?” Brian ci pensa per un secondo. “L’unica cosa è… se hanno intenzioni amichevoli… non dovrebbero, tipo, raggiungerci? Farci dei segnali?” “Che ne so…” Philip fissa il fuoco con la mente rivolta altrove. “Chiunque siano… se sono là fuori, sono messi male quanto noi.” “Anche questo è vero, immagino.” Brian ci pensa ancora un po’. “Magari sono solo… spaventati. Forse ci… controllano.” “Nessuno ci scoverà quassù, te lo posso garantire.” “Già… immagino di sì.” Brian sa esattamente di cosa sta parlando suo fratello. La locazione e la posizione della villa sono ideali. Situata in cima a una salita che sovrasta chilometri di alberi diradati, la casa gode di una visuale che darebbe loro un ampio preavviso. Anche in una notte senza luna, i frutteti sono immobili e silenziosi e nessuno potrebbe avvicinarsi di nascosto senza essere visto o sentito. Philip, poi, parla già di sistemare delle trappole e dei fili lungo il perimetro per avvertirli in caso di intrusioni. Inoltre, quel posto offre loro tutta una serie di vantaggi, che potrebbero sostenerli per un bel po’ di tempo, forse anche per tutto l’inverno. Ci sono un pozzo sul retro, benzina nel trattore, un posto per nascondere le Harley, chilometri di alberi carichi di frutta ancora commestibile sebbene congelata e abbastanza legna da tenere le stufe e i camini accesi per mesi. L’unico problema è la mancanza di armi. Hanno frugato la villa da cima a fondo e hanno trovato solo alcuni attrezzi nel granaio, una vecchia falce arrugginita e un forcone, ma niente armi da fuoco. “Stai bene?” chiede Brian, dopo un lungo momento di silenzio. “Sono sano come un fottuto pesce.” “Sei sicuro?” “Sì, nonna.” Philip fissa il fuoco. “Lo saremo tutti, dopo qualche giorno di riposo in questo posto.” “Philip?” “Che c’è adesso?” “Posso dire una cosa?” “Ci siamo.” Philip non distoglie gli occhi dal fuoco. Indossa la canottiera e un paio di jeans asciutti. I calzini sono bucati e da un buco esce l’alluce. La visione, alla luce del fuoco, dell’unghia contorta dell’alluce di Philip che sbuca dal calzino è straziante per Brian. Lo fa sembrare, forse per la prima volta nella sua vita, quasi vulnerabile. È altamente probabile che, se non fosse stato per Philip, nessuno di loro sarebbe ancora vivo. Brian deglutisce, ricacciando indietro l’emozione. “Sono tuo fratello, Philip.” “Lo so bene, Brian.” “No, quello che voglio dire è… che non ti giudico, non l’ho mai fatto.” “Dove vuoi arrivare?” “Voglio arrivare a… apprezzo quello che stai facendo… rischiare il culo per proteggerci. Voglio che tu lo sappia. Lo apprezzo.” Philip non dice niente, ma il modo in cui fissa il fuoco comincia a cambiare. Guarda oltre le fiamme, mentre il fuoco fa scintillare di emozione i suoi occhi. “So che sei una brava persona” prosegue Brian. “Lo so.” Fa una breve pausa. “Ma sento che qualcosa ti rode.” “Brian…” “Aspetta un minuto, stammi solo a sentire.” La conversazione ha ormai passato il Rubicone, ha superato il punto di non ritorno. “Se non vuoi dirmi cos’è successo tra te e April, mi sta bene. Non te lo chiederò di nuovo.” Segue una lunga pausa. “Ma puoi dirmelo, Philip. Puoi dirmelo perché sono tuo fratello.” Philip si gira e lo guarda: un’unica lacrima gli scorre lungo il volto scavato e legnoso. La cosa fa stringere lo stomaco a Brian. Non ricorda di averlo mai visto piangere, nemmeno da bambino. Una volta, quando Philip aveva dodici anni, il padre lo aveva preso a frustate senza pietà, con un ramo di noce americano, lasciandogli così tanti segni sul sedere da costringerlo a dormire molte notti sulla pancia, ma anche allora non aveva pianto. Per dispetto, aveva rifiutato di piangere. Adesso, quando i suoi occhi incontrano quelli di Brian nell’ombra tremolante, con voce sfinita, Philip dice: “Ho mandato tutto a puttane, campione”. Brian annuisce senza dire niente, si limita ad aspettare. Il fuoco crepita e sfrigola. Philip guarda verso il basso. “Credo di essermi preso una specie di cotta per lei.” La lacrima continua a scendere. Ma la sua voce non si spezza, resta piatta e flebile. “Non voglio dire che fosse amore, ma del resto chi cazzo lo sa cos’è l’amore? L’amore è una fottuta malattia.” Rabbrividisce per colpa di un qualche demone che si agita dentro di lui. “Ho mandato tutto a puttane, Brian. Avrei potuto costruire qualcosa con lei. Avrei potuto costruire qualcosa di solido per Penny, qualcosa di buono.” Fa una smorfia, come per ricacciare indietro un’ondata di dolore, con le lacrime che gli salgono agli occhi ogni volta che sbatte le palpebre, per poi scorrergli lungo il viso. “Non sono riuscito a fermarmi. Lei mi ha chiesto di farlo, ma io non ci sono riuscito. Non mi sono fermato. Vedi… il fatto è che… era così dannatamente bello.” Le lacrime scorrono. “Anche quando mi spingeva via, era bello.” Silenzio. “Che cazzo c’è che non va in me?” Altro silenzio. “So di non avere scuse per quello che ho fatto.” Pausa. “Non sono stupido… è solo che non avrei mai creduto di poter… non pensavo di poter… non pensavo…” La sua voce si sgretola, finché rimangono solo il crepitio del fuoco e lo smisurato silenzio buio fuori dalla villa. Alla fine, dopo un interminabile intervallo di tempo, Philip alza lo sguardo verso suo fratello. Nella luce tremolante, Brian vede che le lacrime sono finite. Sulla faccia di Philip Blake c’è solo una sterile angoscia. Brian non dice una parola. Si limita ad annuire. Arrivano così a novembre e decidono di restare nascosti per vedere come si comporta il tempo. Un mattino, un nevischio gelido spazza i frutteti. Un altro giorno, una gelata assassina colpisce i campi e abbatte gran parte della frutta. Ma nonostante tutti i segni dell’inverno incombente, non hanno ancora voglia di andarsene. La villa potrebbe essere la loro migliore scommessa per aspettare con calma i giorni difficili che si profilano all’orizzonte. Hanno cibo in scatola e frutta a sufficienza per mesi, se fanno attenzione. E legna per scaldarsi. I frutteti sembrano relativamente liberi dagli azzannatori, almeno nelle immediate vicinanze. Per certi versi, Philip sembra stare meglio ora che si è liberato del fardello della sua colpa. Brian tiene per sé il segreto, ci pensa spesso, ma non torna ad affrontarlo. I due fratelli sono meno rudi l’uno con l’altro e persino Penny sembra essersi piacevolmente adattata alla nuova routine che si sono creati. Trova un’antica casa delle bambole in un salotto del primo piano e ne ricava un piccolo rifugio per se stessa (e tutti i suoi giocattoli rotti e malmessi) alla fine del corridoio del secondo piano. Un giorno Brian sale lassù e trova tutte le bambole stese in file ordinate sul pavimento, con le appendici recise sistemate accanto ai corpi corrispondenti. Rimane a osservare per un bel po’ quello strano obitorio in miniatura, prima che Penny lo scuota dal suo torpore. “Dai, zio Brian” dice. “Tu fai il dottore… aiutami ad aggiustarle.” “Sì, è una buona idea” dice con un cenno del capo. “Aggiustiamole.” In un’altra occasione, di prima mattina, Brian sente un suono provenire dal piano terra. Scende in cucina e trova Penny in piedi su una sedia, coperta di farina e di una qualche sostanza appiccicosa, intenta a trafficare con pentole e padelle, coi capelli sporchi di impasto di pancake improvvisato. La cucina è un’area disastrata. Gli altri arrivano e i tre uomini restano lì, sulla porta della cucina, a guardare. “Non ti arrabbiare” dice Penny, guardandolo da sopra la spalla. “Pulisco tutto, lo prometto.” Gli uomini si guardano. Philip sorride per la prima volta dopo settimane e dice: “Chi è arrabbiato? Noi non siamo arrabbiati. Siamo solo affamati. Quand’è che è pronta la colazione?”. Col passare dei giorni, prendono delle precauzioni. Decidono di bruciare la legna solo di notte, quando il fumo non può essere visto dall’autostrada. Philip e Nick costruiscono un perimetro di filo di ferro teso tra piccoli paletti di legno in ogni angolo della proprietà e piazzano dei barattoli di latta nei punti chiave, per metterli in allarme contro possibili intrusi, sia azzannatori che umani. Trovano anche un’antica doppietta calibro 12 nell’attico della villa. Il fucile è coperto di polvere e inciso di cherubini, e dà l’impressione di potergli esplodere in faccia quando cercano di farlo sparare. Non hanno nemmeno una cartuccia da infilarci. Sembra il tipo di fucile che qualcuno appenderebbe alla parete del suo studio, accanto alle vecchie fotografie di Ernest Hemingway, ma Philip trova vantaggioso averlo a portata di mano. Fa abbastanza paura... “sul dorso di un cavallo al galoppo”, come diceva sempre suo padre. “Non si sa mai” dice Philip una notte, appoggiando il fucile al camino e mettendosi comodo per stordirsi con altro sherry da cucina. I giorni continuano a scivolare via con informe regolarità. Riguadagnano il sonno perduto, esplorano i frutteti e raccolgono la frutta. Sistemano trappole a forma di scatola per gli animali randagi e un giorno riescono persino a catturare una lepre scheletrica. Nick si offre volontario per pulirla e quella sera finisce a cucinare un coniglio brasato quasi decente sulla stufa a legna. Durante quel periodo incontrano solo pochi azzannatori. Un giorno, mentre Nick si arrampica su un albero per raccogliere delle susine rinsecchite, vede un cadavere con una salopette da contadino sbucare fuori dall’ombra di un boschetto vicino. Scende con calma e si avvicina furtivo alla cosa col forcone, trafiggendogli la parte posteriore della testa come per far scoppiare un palloncino. In un’altra occasione, Philip sta travasando della benzina da un trattore quando nota un cadavere malconcio in un vicino canale d’irrigazione. Con le gambe schiacciate e contorte, la cosa, che un tempo era una donna, sembra essersi trascinata fin lì per chilometri. Philip le taglia la testa con la falce e brucia i resti con uno schizzo di benzina e una scintilla del Bic. Un gioco da ragazzi. Per tutto quel tempo, la villa sembra averli adottati proprio come loro hanno adottato lei. Dopo che hanno rimosso le lenzuola dal vecchio mobilio opulento, sembra quasi un posto che potrebbero chiamare casa. Hanno ognuno la propria stanza. E sebbene continuino a essere perseguitati dagli incubi, non c’è niente di più rassicurante che scendere in una vecchia cucina elegante, col sole di novembre che filtra attraverso le portefinestre e la fragranza di una caffettiera rimasta tutta la notte sul fuoco. Infatti, se non fosse per la periodica sensazione di essere osservati, le cose sarebbero pressoché perfette. La sensazione di Brian si intensifica già dopo la seconda notte. Brian si è appena trasferito nella sua camera da letto al secondo piano, un’austera stanza da cucito con un pittoresco e piccolo letto a baldacchino e un armadio del diciottesimo secolo, quando si sveglia di scatto nel bel mezzo della notte. Stava sognando di essere un naufrago su una zattera di fortuna alla deriva in un mare di sangue, quando aveva visto un lampo di luce. Nel sogno, ha pensato che fosse un faro lontano su una spiaggia lontana, che lo richiamava, salvandolo da quell’infinita epidemia di sangue, ma quando si è svegliato, ha realizzato di aver visto una vera luce nel mondo della veglia, solo per un secondo, un raggio di luce rettangolare che è scivolato sul soffitto. In un attimo era sparito. Non è nemmeno sicuro di averlo visto davvero, ma ogni fibra del suo essere gli aveva detto di alzarsi e andare alla finestra. L’aveva fatto e aveva guardato fuori, nel nero vuoto della notte: avrebbe giurato di aver intravisto una macchina, a circa quattrocento metri di distanza, svoltare nel punto dove l’autostrada incrocia la strada della fattoria. Poi la cosa è svanita, scivolando nel nulla. Brian ha trovato estremamente difficile riprendere sonno quella notte. Quando il mattino dopo lo racconta a Philip e a Nick, loro lo liquidano come un sogno. Chi diavolo sarebbe uscito dall’autostrada per girare e ripartire? Ma il sospetto continua a crescere dentro Brian durante la settimana e mezzo successiva. Di notte, continua a scorgere lampi di luci che si muovono lenti sull’autostrada al confine esterno del frutteto. Alcune volte, nel cuore della notte, avrebbe giurato di aver sentito lo scricchiolio degli pneumatici sulla ghiaia. Il tono furtivo e fugace di quei rumori è la cosa peggiore. Dà a Brian la sensazione che in qualche modo la villa sia circondata. Ma si è stancato di vedere gli altri liquidare i suoi sospetti definendoli paranoici, perciò ha semplicemente smesso di riferirli. Forse si sta davvero immaginando tutto. Non aggiunge nemmeno un’altra parola sull’argomento fino all’anniversario della seconda settimana della loro permanenza nella villa, quando, a un certo punto proprio prima dell’alba, il suono delle lattine che sferragliano lo risveglia da un sonno profondo. DICIOTTO “Ma che diavolo…?” Brian si sveglia di scatto nell’oscurità della sua stanza. Cerca a tentoni una lanterna a cherosene sopra il comodino, sbattendo contro il vetro e facendo cadere il fluido. Si alza e va alla finestra; sente il pavimento gelato sotto la pianta dei piedi nudi. La luce della luna splende nel cielo di quell’autunno gelido e cristallino, avvolgendo ogni sagoma all’esterno di un luminoso alone argentato. Brian può ancora sentire le scatole di latta appese ai cavi che sferragliano fuori da qualche parte. Sente che anche gli altri si svegliano nelle loro stanze, lungo il corridoio. Sono tutti in piedi ora, svegliati dal tintinnio delle lattine. La cosa più strana è che il tintinnio arriva da tutte le direzioni: Brian si chiede se sia frutto della sua immaginazione. Le scatolette risuonano dai boschetti dietro la villa come da quelli sul davanti. Allunga il collo per vedere di che si tratta quando la porta della sua camera da letto si spalanca. “Campione! Sei sveglio?” Philip è senza maglia, indossa solo jeans e stivali, che non ha ancora avuto il tempo di allacciare. In una mano tiene il vecchio fucile con gli occhi sbarrati e allarmati. “Ho bisogno che tu vada a prendere quel forcone nell’ingresso sul retro, subito!” “Ci sono degli azzannatori?” “Muoviti e basta!” Brian fa un cenno d’assenso e si precipita fuori dalla stanza, col cervello in preda al panico. Si infila i pantaloni della tuta e una T-shirt senza maniche. Mentre cammina con passo felpato nella casa immersa nell’oscurità, giù per le scale, attraverso il salotto e nell’ingresso posteriore, percepisce dei movimenti fuori dalle finestre: qualcuno si avvicina dall’esterno. Afferra il forcone, appoggiato alla porta sul retro, si gira e torna di scatto verso la porta principale. Ormai Philip, Nick e persino Penny sono arrivati in fondo alle scale. Si avviano verso il balcone verandato, che offre un’ampia visuale sull’esterno della casa, sul sentiero digradante che porta alla strada adiacente e anche sul bordo del frutteto più vicino. Vedono subito delle sagome scure, basse sul terreno, scivolare verso la proprietà da tre diverse direzioni. “Sono macchine quelle?” mormora Nick con un filo di voce. Mentre i loro occhi si adattano alla luce della luna, tutti comprendono che sì, quelle sono senza dubbio macchine che si muovono lente per la proprietà in direzione della villa. Una arriva dal vialetto tortuoso, un’altra dal confine nord del frutteto e una terza è appena visibile a sud e scricchiola sul sentiero di ghiaia che conduce fuori dagli alberi. Con un tempismo quasi perfettamente sincronizzato, ogni veicolo si ferma di colpo alla stessa distanza dalla casa. Rimangono fermi per un secondo, ognuno a una quindicina di metri di distanza: i finestrini sono troppo scuri per rivelarne gli occupanti. “Questo non è un comitato di benvenuto” mormora Philip, pronunciando l’eufemismo della serata. Di nuovo, quasi in perfetta sincronia, ogni paio di fari si accende all’improvviso. L’effetto è piuttosto drammatico, quasi teatrale, in effetti, e i raggi colpiscono le finestre della villa, riempiendo gli interni bui di fredda luce cromata. Philip sta per uscire e opporre resistenza col fucile inutilizzabile, quando ode uno schianto provenire dal retro della villa. “Pulcino, tu resta qui con Brian” dice a Penny. Poi scocca un’occhiata a Nick. “Nicky, prova a scivolare fuori da una finestra laterale, prendi il machete e cerca di prenderli alle spalle. Mi segui?” Nick capisce alla perfezione quello che vuole dire e si allontana lungo il corridoio laterale. “Resta dietro di me, ma stammi vicino.” Philip solleva il fucile, appoggiando il calcio alla spalla. Cauto, con la concentrazione e la calma di un cobra, striscia come un commando verso il suono che proviene dalla cucina: il rumore di passi che calpestano i vetri rotti. “Calma e sangue freddo, amico” dice l’invasore in un allegro accento del Tennessee, sollevando la canna di una Glock nove millimetri quando Philip entra in cucina col fucile ugualmente puntato. Prima di essere così bruscamente interrotto, l’intruso si guardava in giro in tutta tranquillità, come se si fosse appena alzato dal letto per uno spuntino di mezzanotte. La luce dei fari, proveniente dall’esterno, trafigge la stanza con violenza. Il pannello di vetro sopra la porta alle spalle dell’uomo è stato sfondato e la debole luce dell’alba comincia a brillare proprio in quel momento. Alto oltre un metro e ottanta, vestito di pantaloni mimetici sbiaditi, stivali infangati e di un giubbetto di kevlar sporco di sangue, l’invasore è completamente calvo, ha una testa a punta sfregiata e occhi come crateri scavati da minuscole meteore. A un esame più ravvicinato, sembra malato, come se fosse stato esposto alle radiazioni: la pelle giallastra è butterata dalle infiammazioni. Philip punta l’inutile fucile da antiquariato verso la testa dell’uomo calvo: circa due metri e mezzo separano i due uomini, e Philip si concentra per fingere, forse persino per convincersi, che il fucile sia carico. “Vi concedo il beneficio del dubbio” dice. “E partirò dal presupposto che pensavate che il posto fosse vuoto.” “Proprio così, amico” dice l’uomo calvo; la sua voce suona calma, forse per effetto di qualche droga, come quella di un disc jockey trasognato. I denti incapsulati in oro scintillano fiocamente mentre si profonde in un sorriso da rettile. “Allora vi preghiamo di andarvene… nessun danno, nessun problema.” L’uomo con la Glock simula un’espressione ferita. “Non è molto ospitale da parte vostra.” L’uomo ha un leggero tremore, un tic, che lascia trapelare una violenza latente. “A quanto pare, vi siete trovati un bel posticino qui.” “Non sono fatti tuoi.” Philip non molla. Sente il cigolio della porta principale e i passi che attraversano il salotto. La sua mente è preda di impulsi contrastanti, panico e sete di sangue. Sa che i prossimi secondi saranno critici, forse persino fatali. Ma non riesce a fare altro che temporeggiare. “Non vogliamo spargimenti di sangue e, fratello, te lo garantisco, non importa quello che succede: il tuo sarà il primo sangue che scorrerà.” “Hai la lingua sciolta.” All’improvviso l’uomo calvo chiama uno dei compari rimasti nell’oscurità. “Shorty?” Una voce risponde da fuori della porta sul retro. “L’ho preso, Tommy!” Quasi all’instante, Nick compare fuori dalla finestra infranta della porta sul retro, con un grosso coltello Bowie puntato contro la trachea. Quello che l’ha catturato, un ragazzino magro, brufoloso e con un taglio di capelli a spazzola da marine, spalanca la porta e spinge Nick dentro la cucina. “Mi dispiace, Philly” dice Nick, mentre viene spinto contro i mobili, abbastanza forte da perdere il fiato. Il giovanotto magro e coi capelli a spazzola gli tiene il coltello contro il pomo d’Adamo e ha un machete infilato nella cintura. Ossuto e nervoso, con guanti senza dita Carnaby sulle mani, sembra quasi l’evaso di un carcere militare. Al suo giubbotto militare sono state strappate le maniche e le lunghe braccia nude sono coperte di tatuaggi da prigione. “Aspetta un minuto” dice Philip all’uomo calvo. “Non c’è ragione per…” “Sonny!” L’uomo calvo chiama un altro complice nel preciso istante in cui Philip sente i passi, che crepitano sul pavimento di legno massiccio, vecchio almeno un secolo, del salotto principale. Philip continua a tenere il fucile sollevato e puntato, ma getta un rapido sguardo dietro la sua spalla. Brian e Penny sono rannicchiati nell’ombra proprio dietro di lui, a forse un metro e mezzo di distanza. Altre due figure sono apparse dietro di loro, facendo sobbalzare la bambina. “Ce li ho, Tommy!” dice una delle figure e tutti possono vedere la canna d’acciaio di un revolver di grosso calibro, forse una .357 Magnum o una Army .45, premuta contro la testa di Brian Blake. Brian si irrigidisce come un animale stretto in un angolo. “Aspetta un minuto” dice Philip. Con la sua visione periferica, si rende conto che le due figure con le pistole puntate contro Brian e Penny sono un uomo e una donna… sebbene donna non sia proprio la parola giusta. La ragazza, che stringe il colletto di Penny, è una marionetta androgina pelle e ossa, indossa pantaloni di pelle e vari strati di maglie, sfoggia un eyeliner nero, capelli da punk e il pallore verdognolo di un tossico. Si batte nervosa la canna di una .38 police special contro il fianco della coscia smunta. Anche l’uomo accanto a lei, che a quanto pare si chiama Sonny, non sembra estraneo all’ago. I suoi occhi infossati sporgono da una maschera butterata di ignoranza e cattiveria e il corpo emaciato è vestito di stracci che un tempo erano un surplus dell’esercito. “Voglio ringraziarti, fratello” dice l’uomo calvo, infilando la nove millimetri nella fondina attaccata alla cintura, come se lo scontro fosse ufficialmente terminato. “Vi siete trovati proprio un bel posticino. Ve lo riconosco.” Si avvicina al lavandino e si serve con calma dalla brocca di acqua di pozzo posata sul ripiano, tracannandone un bicchiere intero. “Sarà un’ottima casa base.” “Sono completamente d’accordo” dice Philip, senza dare segno di voler abbassare la sua arma finta. “L’unico problema è che non possiamo ospitare altra gente.” “Va tutto bene, fratello.” “Allora cosa pensi di fare di preciso per…? Quali sono le vostre intenzioni?” “Le nostre intenzioni?” L’uomo calvo pronuncia la parola con finta profondità. “Le nostre intenzioni sono di prenderci questo posto.” Qualcuno, che Philip non riesce a vedere, scoppia in una risata divertita. La mente di Philip è come una scacchiera spezzata dove i pezzi si muovono in modo spasmodico. Probabilmente quei delinquenti incalliti intendono uccidere lui e tutti gli altri abitanti della casa. Sono parassiti e molto probabilmente giravano intorno alla casa come avvoltoi da settimane: Brian non aveva le allucinazioni. Philip sente altre persone all’esterno, voci basse, rami che si spezzano, e compie un rapido calcolo mentale: sono almeno sei, forse di più, e dispongono di almeno quattro veicoli; ognuno sembra pesantemente armato, con munizioni in abbondanza. Philip vede cartucce e caricatori rapidi attaccati ad alcune delle cinture, ma l’unica cosa che sembra mancargli e di cui Philip può approfittare è forse, solo forse, l’intelligenza. Anche il grosso tizio pelato, il grande capo, ha lo sguardo spento del tossico. Non ci saranno appelli alla clemenza, o ai migliori angeli 9 stavolta. Philip ha solo una possibilità per sopravvivere. “Ti spiace se dico una cosa?” chiede. “Prima che tu faccia qualcosa di avventato.” L’uomo calvo solleva il bicchiere come in un brindisi. “A te la parola, amico.” “Abbiamo due modi per risolvere questa faccenda.” Quelle parole sembrano destare la curiosità dell’uomo calvo. Posa il bicchiere e si volta verso Philip. “Solo due modi?” “Il primo è che cominciamo a sparare e posso dirti come andranno le cose.” “Va’ avanti.” “I tuoi scagnozzi avranno la meglio su di noi e questo è quanto, ma c’è un unico problema: ti prometto solo una cosa e, sarò onesto con te, non sono mai stato altrettanto sicuro di niente nella mia vita.” “E sarebbe?” “Non importa cosa succede, so che sarò in grado di sparare solo un colpo ma, e te lo dico senza mancanza di rispetto, mi assicurerò che la stragrande maggioranza di questi pallini di piombo finisca nella tua carcassa. Adesso, signore, vuole sentire l’opzione numero due?” L’uomo calvo ha perso il suo senso dell’umorismo. “Continua.” “L’opzione due è che ci lasciate andare via da qui vivi e vi prendete la casa con i nostri complimenti, così nessuno dovrà ripulire il casino e tu continuerai a tenerti la metà superiore del corpo.” Per un lungo istante, le cose procedono in maniera molto ordinata (agli ordini dell’uomo calvo). La coppia di tossici, ai quali Philip, nella sua mente stravolta, comincia a pensare come Sonny e Cher, si limitano ad allontanarsi lentamente da Brian e Penny e consentono a Brian di prendere in braccio la bambina e di portarla verso la porta attraverso il salotto. L’accordo, se così si può chiamare, è che Philip e il suo gruppo se ne vadano dalla villa, lasciando tutte le loro cose; e questo è tutto. Brian osserva Philip uscire dalla casa col fucile ancora puntato. Grazie a Dio per quel ferro vecchio. Nick lo segue. I due si uniscono a Brian e Penny nell’ingresso e Brian apre la porta continuando a tenere in braccio Penny. Scivolano fuori, col fucile ancora puntato sugli intrusi all’interno. Una gran quantità di cose travolge i sensi di Brian: il vento gelido, la luce pallida dell’alba che sorge dietro i frutteti, le sagome di altri due uomini armati su entrambi i lati della casa, le macchine parcheggiate con gli abbaglianti ancora accesi come riflettori teatrali che annunciano l’atto successivo di una commedia da incubo. Dall’interno, la voce dell’uomo calvo dice: “Ragazzi! Fateli passare!”. I due complici all’esterno, vestiti di divise militari logore e armati di fucili a pompa, li osservano col minaccioso interesse di uccelli predatori, mentre Brian si mette Penny a cavalcioni sulle spalle. Philip sussurra piano: “Statemi vicini e seguitemi. Hanno ancora voglia di ammazzarci. Fate tutto quello che vi dico”. Brian segue Philip, che è ancora a petto nudo e seguita a tenere quel ridicolo fucile puntato come un commando, attraverso il cortile, oltre gli uomini armati di guardia e verso il vicino boschetto di peschi. A Philip occorre un atroce lasso di tempo per portarli tutti oltre il cortile e tra le ombre del frutteto più vicino, pochi secondi di orologio, ma un’eternità per Brian Blake, perché ora il regolare svolgimento del passaggio di proprietà comincia ad andare in pezzi. Sente i rumori confusi dietro di sé, mentre si affretta a portare Penny verso il limitare degli alberi. È ancora scalzo e la pianta dei suoi piedi è sferzata dai rovi e dai sassi. Dalla villa giungono voci che gridano di rabbia e rumori di passi e movimenti sulla veranda. Il primo sparo risuona proprio nel momento in cui Philip e il suo gruppo si tuffano tra gli alberi. Lo sparo risuona nell’aria e scava un solco in un ramo, a quindici centimetri dalla spalla destra di Brian, schizzandogli pezzi di corteccia su un lato del volto e facendo gridare Penny. Philip spinge Brian, che porta ancora Penny sulla schiena, verso l’ombra più fitta. “CORRI!” gli ordina. “CORRI, BRIAN! SVELTO!” Per Brian Blake, i cinque minuti successivi si svolgono con la confusione caotica di un sogno. Sente altri spari dietro di sé: le pallottole sibilano attraverso il fogliame mentre si precipita dentro il bosco, dove la luce acquosa dell’alba non ha ancora scacciato le ombre fitte della notte. I suoi piedi nudi, sempre più piagati a ogni secondo che passa, scavano nel morbido tappeto di foglie e frutta marcia; il panico gli illumina la mente come le scintille di un fuoco d’artificio. Penny gli rimbalza sulla schiena, in iperventilazione per il terrore. Brian non ha idea di quanto debba allontanarsi, di dove andare o quando fermarsi. Si inoltra sempre più a fondo nelle ombre del frutteto. Percorre circa duecento metri di bosco ombroso, prima di raggiungere un enorme albero caduto, ormai marcio, dietro cui si nasconde. Ansimando per riempire d’aria i polmoni, col fiato visibile nell’atmosfera gelata e il cuore che batte all’impazzata alle sue stesse orecchie, si fa scendere delicatamente Penny dalla schiena. La mette a sedere accanto a sé in mezzo alle erbacce. “Sta’ giù, piccola” sussurra. “E fa’ molto, molto, molto silenzio… devi stare zitta come un topolino.” Il frutteto vibra di movimento in tutte le direzioni; la sparatoria è momentaneamente cessata e Brian si arrischia a sbirciare da sopra la cima dell’albero caduto per avere una visuale migliore. Attraverso il fitto colonnato di peschi, vede una figura, a meno di cento metri di distanza, dirigersi verso di lui. Gli occhi di Brian, ormai adattati alle ombre pallide, riconoscono uno dei tizi che erano all’esterno della casa, col fucile dall’impugnatura da pistola sollevato e pronto a sparare. Ne arrivano anche altri dagli alberi dietro e una sagoma scura si dirige perpendicolarmente verso di lui. Brian torna a nascondersi dietro l’albero marcio e valuta disperatamente le sue alternative. Se scappa lo sentiranno. Se resta nascosto lo troveranno di sicuro. Dove diavolo è Philip? Dov’è Nick? Proprio in quel momento, sente che il ritmo dei rami che si spezzano dall’altra parte del boschetto accelera: qualcuno si muove veloce verso l’uomo armato. Brian sbircia da sopra la cima dell’albero caduto e vede la sagoma di suo fratello, a una cinquantina di metri di distanza, strisciare attraverso il sottobosco e avvicinarsi al tiratore. La spina dorsale di Brian si gela per il terrore; il suo stomaco si chiude. Nick Parsons esce dall’ombra, dall’altra parte dell’uomo, con una pietra in mano. Si ferma e scaglia la pietra, delle dimensioni di un pompelmo, a una trentina di metri di distanza nel frutteto. La pietra sbatte contro un albero e risuona con un forte rumore secco, che fa sobbalzare l’uomo armato. Il tizio si gira e spara un colpo verso il rumore: lo sparo risveglia il frutteto e fa sobbalzare Penny. Brian si china a terra, ma non prima di aver scorto, quasi nello stesso istante, un movimento lampeggiare verso l’uomo armato, che non ha nemmeno il tempo di inserire un’altra cartuccia in canna. Philip Blake balza dal fogliame con la vecchia doppietta già a metà movimento. Il calcio di legno pietrificato si schianta di piatto sulla parte posteriore del cranio dell’uomo, colpendolo così forte da farlo quasi volare fuori dagli stivali. Il fucile a pompa cade lontano. L’uomo barcolla e piomba sul terreno muschioso. Brian distoglie lo sguardo e copre le orecchie di Penny, mentre Philip finisce il lavoro con furia rapida e selvaggia, assestando altri quattro colpi sul cranio dell’uomo caduto. Adesso l’equilibrio di potere è leggermente mutato. Philip trova una pistola di riserva, una .38 a canna corta, infilata nella cintura dell’uomo. Una tasca colma di proiettili e un caricatore rapido migliorano l’umore e concedono a Philip e Nick altra potenza di fuoco. Brian osserva tutto questo da dietro l’albero caduto a cinquanta metri di distanza. Un’ondata di sollievo lo travolge come un bagliore di speranza. Adesso possono andarsene. Possono ricominciare. Possono sopravvivere un altro giorno. Ma quando fa un cenno a suo fratello da dietro l’albero caduto e Philip e Nick giungono al nascondiglio, la luce pallida che illumina l’espressione di Philip si conficca come un pugnale affilato di panico nello stomaco di Brian. “Dobbiamo far fuori quei figli di puttana” dice. “Dal primo all’ultimo.” “Ma, Philip, e se ci limitassimo…” “Dobbiamo riprenderci quel posto, è nostro e il loro numero è diminuito.” “Ma…” “Ascoltami.” Qualcosa nel modo in cui Philip fissa gli occhi nei suoi gli fa accapponare la pelle. “Voglio che tu tenga mia figlia al sicuro, non importa come. Capisci quello che ti chiedo?” “Sì, ma…” “È tutto quello che devi fare.” “Okay.” “Basta che la tieni al sicuro. Guardami. Puoi fare questa cosa per me?” Brian annuisce. “Sì. Certo, Philip. Lo farò. Ma tu non farti ammazzare.” Philip non dice niente, non reagisce, si limita a fissarlo mentre fa scattare una cartuccia nella canna del fucile a pompa calibro 20. Poi rivolge uno sguardo a Nick. In pochi istanti, i due uomini sono scattati di nuovo in azione, svanendo tra gli alberi e lasciando Brian seduto tra le erbacce, disarmato, pietrificato dalla paura, agitato per l’incertezza, coi piedi nudi che sanguinano. Philip vuole che resti nascosto? Qual è il piano? Echeggia uno sparo. Brian sobbalza. Un altro sparo risponde e l’eco rimbalza nel cielo gelido sopra la cima degli alberi. Brian stringe i pugni così forte da sanguinare. Deve restare lì? Tira Penny più vicino a sé, mentre un altro sparo risuona più vicino; poi, a riverberarsi nell’aria è il suono soffocato del gorgogliante rantolo della morte. I pensieri di Brian riprendono a scalpitare e i tremori lo sconquassano. Dei passi scricchiolano verso il nascondiglio. Brian azzarda un’altra sbirciatina sopra la cima dell’albero e vede lo spaventoso tizio pelato con la Glock nove millimetri camminare rapido in mezzo agli alberi, nella sua direzione, con la faccia che arde di furia omicida. Il corpo contorto del ragazzo magro di nome Shorty giace nel fango a una trentina di metri verso nord: metà della testa è stata distrutta dallo sparo. Un altro sparo fa accucciare Brian, col cuore in gola. Non è sicuro se l’uomo calvo sia a terra o se lo sparo sia partito dalla sua arma. “Forza, piccola” dice Brian a Penny, che quasi catatonica si è raggomitolata nel sottobosco, coprendole la testa. “Dobbiamo muoverci da qui.” La porta fuori dalle erbacce e le prende la mano: è troppo pericoloso portarla di nuovo sulle spalle. La trascina via dalla sparatoria. Strisciano all’ombra dei peschi, restando sotto la copertura del bosco ed evitando le impronte che si irradiano in mezzo ai frutteti. Con le piante dei piedi ormai quasi insensibili per il dolore e il freddo, Brian sente ancora le voci dietro di sé, spari occasionali e poi più niente. Per un lungo periodo di tempo, non sente altro che il vento tra i rami e forse una serie di passi frenetici di tanto in tanto, ma non ne è sicuro: il cuore gli batte troppo forte nelle orecchie. Continua ad andare avanti. Percorre un altro centinaio di metri, prima di accucciarsi dietro un vecchio e malmesso carro per il fieno. Riprende fiato e stringe Penny a sé. “Stai bene, piccola?” Penny riesce a sollevare il pollice, ma la sua espressione è sul punto di crollare per il terrore. Le controlla i vestiti, la faccia, il corpo: fisicamente sembra indenne. Le dà una pacca sulla spalla e prova a confortarla, ma l’adrenalina e la stanchezza lo fanno tremare con violenza e riesce a malapena nel suo intento. Ode un rumore e si blocca. Si piega verso il basso e guarda attraverso le stecche del carro malmesso. A meno di cinquanta metri da lui, una figura si muove furtiva nell’ombra di un canalone. La figura è alta e slanciata e ha un fucile a pompa, ma è troppo lontana per essere identificata. “Papà…?” La voce di Penny mette in allarme Brian. È un sussurro, ma basta a segnalare la loro presenza. Brian afferra la bambina. Le mette una mano sulla bocca. Poi allunga il collo per vedere oltre il carro. Intravede la figura che risale il pendio del canalone. Sfortunatamente, la figura che viene verso di loro non è il papà della bambina. Lo sparo vaporizza metà del carro e Brian finisce scagliato a terra in un turbine di polvere e detriti. Ingoia la polvere, agita la mano in cerca di Penny, riesce ad afferrare l’orlo della sua maglietta e la trascina ancora più a fondo nel bosco. Percorre parecchi metri strisciando insieme a Penny, poi riesce finalmente a rimettersi in piedi e continua a trascinare Penny verso le ombre più fitte, ma qualcosa non va. La bambina è inerte nella sua stretta, come se fosse svenuta. Brian sente scricchiolare i passi degli stivali dietro di sé, lo scatto della pompa, mentre l’uomo armato si avvicina per dare loro il colpo di grazia. Brian solleva disperatamente Penny sulla spalla e cammina carponi più in fretta che può verso la copertura degli alberi, ma non arriva molto lontano prima di accorgersi di essere coperto di sangue. Il sangue gli cola sul davanti della maglia, infradiciandolo: scorre copioso. “Oh, Dio, no, Dio, no, Dio, no no no…” Brian posa Penny sul terreno morbido, appoggiandola sulla schiena. Il suo faccino esangue è bianco come un lenzuolo. Gli occhi sono vitrei e fissi al cielo e dalla bocca escono suoni come di singhiozzi. Un sottile rivolo di sangue le cola dall’angolo della bocca. Brian non sente più l’uomo armato, che si avvicina con passo pesante, né lo scatto della pompa che inserisce un’altra cartuccia. La maglietta di Penny, una T-shirt di cotone, è fradicia di sangue scarlatto; il foro d’uscita irregolare ha un diametro di almeno quindici centimetri. I pallini per la caccia ai cervi, sparati da una cartuccia calibro 20, hanno una potenza sufficiente a penetrare l’acciaio e, a quanto pare, la bambina è stata colpita alla schiena da almeno la metà della rosa in espansione dello sparo, che poi è uscita da un lato del pancino. L’uomo armato si avvicina. Brian solleva la maglietta della bambina e prorompe in un lamento d’angoscia quasi primordiale. La sua mano non può tamponare la copiosa perdita di sangue che esce dalla ferita a forma di mezzaluna. Preme la mano sulla ferita. Il sangue ribolle. Si strappa un pezzo della camicia e cerca di tappare il buco frastagliato nel torace della piccola, ma il sangue è ovunque. Balbetta, piange e cerca di parlarle mentre il sangue viscido gli scorre tra le dita e l’uomo armato si avvicina. “Va tutto bene, starai bene, ti cureremo, andrà tutto bene, starai meglio…” Le braccia e la vita di Brian vengono battezzate dal calore della forza vitale che sta abbandonando la bambina. Penny pronuncia un’unica flebile parola: “…Lontano…”. “No, Penny, no, no, non farlo… non andare lontano, non ancora… non adesso…!” In quel momento, Brian sente un rametto spezzarsi proprio dietro di lui. Un’ombra cala sul corpo di Penny. “Davvero un peccato” mormora una voce roca alle spalle di Brian, mentre la punta gelida della canna del fucile gli preme sulla nuca. “Guardala bene.” Brian si gira e alza lo sguardo sull’uomo armato, un uomo tatuato, barbuto e con la pancia da bevitore, che gli punta il fucile dritto in faccia. Quasi sovrappensiero, l’uomo grugnisce: “Guardala… perché è l’ultima cosa che vedrai”. Brian non toglie la mano dalla ferita di Penny, ma sa che è troppo tardi. Non ce la farà. Brian è pronto ormai… pronto a morire. Lo sparo ha un che di onirico, come se Brian fosse d’un tratto uscito dal suo corpo e aleggiasse sopra il frutteto, guardando agli eventi dalla prospettiva di uno spirito incorporeo. Ma quasi subito, Brian, che d’istinto si era gettato in avanti contro lo sparo, scatta di nuovo all’indietro per lo shock. Il sangue ricopre le sue braccia e il corpo di Penny. Forse l’impatto dello sparo a bruciapelo è stato così catastrofico da essere indolore? Forse Brian è già morto senza ancora rendersene conto? L’ombra dell’uomo armato comincia a cadere, quasi al rallentatore, come una vecchia sequoia che rende l’anima a Dio. Brian si gira di scatto, in tempo per vedere che l’uomo barbuto è stato colpito alle spalle: la cima del suo cranio è un ammasso di polpa rossa e la barba è macchiata di sangue. I suoi occhi si rovesciano all’indietro, poi l’uomo crolla a terra. Brian lo fissa. Come un sipario che cala, l’uomo, cadendo, rivela due figure, che corrono verso Brian e Penny. “DANNAZIONE, NO!” Philip scaglia il fucile a pompa, ancora fumante, sul terreno e corre verso gli alberi. Nick lo segue da vicino. Philip si precipita gridando verso Brian e lo spinge da parte. “NO! NO!” Cade in ginocchio accanto alla bambina morente, che sta soffocando, annegata dal suo stesso sangue. La solleva e tocca con tenerezza la ferita aperta come se fosse un errore, un graffio, una semplice botta. La attira in un abbraccio e il sangue della bambina lo inzuppa. Brian giace sul terreno a pochi passi di distanza e respira la terra ammuffita, mentre un velo di sbigottimento gli cala sugli occhi. Nick è a poca distanza. “Possiamo fermare l’emorragia, vero? Possiamo curarla, giusto?” Philip coccola la bambina insanguinata. Penny spira tra le sue braccia con un lieve ma sonoro rantolo di morte, che lascia il suo viso bianco e freddo come porcellana. Philip la scuote. “Forza, pulcino… resta con noi… resta con noi. Forza… resta con noi… ti prego, resta con noi… Pulcino? Pulcino? Pulcino?” Il silenzio aleggia terribile nell’aria. “Gesù Santo” mormora Nick tra sé, con gli occhi fissi sul terreno. Philip continua a stringere la bambina a lungo, mentre Nick continua a fissare la terra, pregando in silenzio. Per la maggior parte di quel tempo, Brian giace prono sul terreno, a un metro e mezzo di distanza, e piange sulla terra umida, balbettando a bassa voce, a se stesso più che a chiunque altro: “Ho cercato… è successo tutto così in fretta… non ho potuto… è stato… non riesco a crederci… non posso… Penny era…”. D’un tratto, una mano grande e nodosa lo agguanta per il retro della camicia. “Cosa ti avevo detto?” ruggisce Philip con un ringhio gutturale, mentre solleva suo fratello e lo sbatte contro il tronco di un albero vicino. Brian è privo di energie. Vede le stelle. “Philly, no!” Nick cerca di intromettersi, ma Philip lo spinge via con forza facendolo finire disteso per terra. Philip seguita a tenere la mano destra serrata intorno alla gola di suo fratello. “Cosa ti avevo detto?” Lo sbatte contro il tronco. La testa di Brian rimbalza sulla corteccia dell’albero, producendogli lampi di luce e di dolore, ma l’uomo non fa alcuno sforzo per reagire o scappare. Vuole morire. Vuole morire per mano di suo fratello. “COSA TI AVEVO DETTO?” Philip scaglia il fratello lontano dall’albero. Il suolo si getta verso Brian come un ariete, colpendogli una spalla e un lato del volto, poi una scarica di calci si abbatte su di lui, che rotola involontariamente sul terreno. Un calcio dello stivale da lavoro dalla punta d’acciaio lo colpisce alla mascella e gli spacca la mandibola. Un altro gli frattura tre costole, inviandogli fitte di dolore incandescente in tutto il fianco. Un altro colpo ancora lo raggiunge alla schiena, dislocando le vertebre e quasi perforandogli un rene. Un dolore acuto e abbagliante gli frantuma il coccige. Dopo un po’, Brian può a malapena sentire altro dolore, può solo osservarlo dispiegarsi per tutto il suo corpo massacrato, mentre si sottomette al pestaggio come un supplicante si sottomette a un sacerdote. DICIANNOVE Il giorno dopo, Philip passa un’ora nel capanno degli attrezzi dietro la villa, a esaminare la collezione di armi prese agli intrusi, gli utensili dotati di lame e gli attrezzi lasciati dai precedenti abitanti. Sa quello che deve fare, ma scegliere la modalità dell’esecuzione è un’agonia. Sulle prime, decide di usare la nove millimetri semiautomatica. Sarebbe il modo più veloce e pulito. Ma poi è assalito dai dubbi. In un certo senso, gli sembra ingiusto. La pistola è troppo fredda e impersonale. E nemmeno può costringersi a usare un’ascia o un machete. Troppo difficile e incerto. Se sbagliasse la mira di un centimetro e mandasse all’aria il lavoro? Alla fine, decide di usare la Glock nove millimetri: infila un caricatore nuovo nel manico e fa scattare un colpo in canna. Fa un respiro profondo e si avvia verso la porta del capanno. Si ferma e si fa forza. Dalle pareti esterne del capanno giungono sporadici rumori di graffi. Il terreno della villa ronza per le attività degli azzannatori: la sparatoria del giorno prima ha attirato decine di non morti. Philip spalanca la porta con un calcio. La porta sbatte contro uno zombie donna di mezza età vestita di un grembiule sporco e intenta ad annusare l’aria intorno al capanno. La forza dell’impatto la fa capitombolare all’indietro con le braccia mulinanti, mentre un lamento spettrale si leva dalla sua faccia decomposta. Philip la oltrepassa, sollevando la Glock quasi per caso e rallentando appena il passo, mentre preme rapido il grilletto e le spara un unico colpo su un lato della testa. Il boato della Glock echeggia e il cadavere schizza di lato in una nuvola di sangue scarlatto, per poi piegarsi sul terreno. Philip marcia verso il retro della villa e lungo il percorso elimina un altro paio di azzannatori erranti. Uno è un vecchio, vestito solo di biancheria ingiallita: forse proviene da una casa di riposo. Un altro è, molto probabilmente, un ex coltivatore di frutta: il suo corpo gonfio e livido indossa ancora la vecchia salopette. Philip li abbatte con il minimo di rumore, un unico colpo ciascuno, e si prende l’appunto mentale di ripulire i resti più tardi, con uno spalaneve attaccato alla falciatrice. È passato quasi un giorno intero da quando Penny è morta tra le sue braccia e ora la nuova alba sorge limpida e blu, diffondendo un cielo terso sopra gli ettari di peschi. A Philip ci sono volute quasi ventiquattro ore per trovare il coraggio di fare quello che deve fare. Adesso, con la mano sudata e stretta intorno alla pistola, entra nel frutteto. Nel caricatore rimangono cinque colpi. All’ombra degli alberi, una figura si contorce lamentosa contro il tronco di un vecchio albero. Legata con corde e nastro isolante, la prigioniera tenta di scappare con futile disperazione. Philip si avvicina e alza la pistola. Punta la canna verso gli occhi della figura e, solo per un istante, dice a se stesso di farla finita alla svelta. Incidi la ferita, rimuovi il tumore, falla finita. La canna trema, il dito è paralizzato sul grilletto e Philip si lascia sfuggire un sospiro tormentato. “Non ci riesco” dice piano. Abbassa la pistola e fissa sua figlia. A meno di due metri da lui, legata all’albero, Penny ringhia con la fame feroce di un cane rabbioso. Il suo viso da bambolina si è ristretto e infossato fino a sembrare una zucca marcia, gli occhi dolci si sono induriti fino a diventare monetine d’argento. Le labbra da tulipano, un tempo innocenti, sono livide e arricciate sui denti viscidi. Non riconosce suo padre. Ecco cosa ha scavato il buco più grande nell’anima di Philip. Non può smettere di ricordare lo sguardo negli occhi di Penny ogni volta che andava a prenderla al centro giochi o a casa di sua zia Nina al termine di una lunga giornata di duro lavoro. La scintilla di riconoscimento, di entusiasmo e, diavolo, sì, di amore puro, in quegli occhioni marroni da cerbiatta ogni volta che il padre tornava erano tutto quello per cui Philip teneva duro, a tutti i costi. Adesso quella scintilla è sparita per sempre, cementata sotto la grigia patina dei non morti. Philip sa cosa deve fare. Penny ringhia. Gli occhi di Philip bruciano di agonia. “Non ci riesco” mormora di nuovo, guardando in basso, senza rivolgersi né a Penny né a se stesso. Vederla così gli provoca una scarica di furore elettrico in tutto il sistema nervoso, lo fa inarcare come il cannello di una fiamma ossidrica, scatena la fiamma segreta che nasconde nel profondo di se stesso. Sente la voce. Fa’ a pezzi il mondo, fallo a pezzi, squarciagli il suo fottuto cuore… fallo subito. Si ritrae dall’orrore nel frutteto, con la mente che ribolle di furia. Il terreno della villa, che al momento si riscalda nell’aria tiepida di quel mattino d’autunno, è un appezzamento a forma di mezzaluna, con la casa principale al centro. Numerosi edifici secondari sorgono lungo la morbida curva dietro la casa: la rimessa per le carrozze, un piccolo capanno per la falciatrice e il trattore, un secondo capanno per gli attrezzi, una dependance rialzata per gli ospiti e un grosso granaio di legno con un’enorme banderuola e una cupola sulla cima. Quest’ultima struttura, col legno tarlato del rivestimento così sbiadito dal sole da diventare rosa, è la meta verso cui Philip è diretto. Ha bisogno di scaricare la corrente che scorre velenosa dentro di lui; ha bisogno di sfogarsi. L’entrata principale del granaio è una porta doppia, chiusa da una gigantesca tavola che la attraversa nel mezzo. Philip si avvicina e rimuove la tavola: le porte si aprono con uno scricchiolio e granelli di polvere fluttuano nelle ombre all’interno. Philip entra, chiudendosi la doppia porta alle spalle. L’aria puzza di piscio di cavallo e fieno ammuffito. Altre due figure si contorcono e si dimenano in un angolo, avvinte nella loro personale versione di tormento infernale, legate e imbavagliate con del nastro isolante: Sonny e Cher. Tremano l’uno contro l’altra sul pavimento del granaio, le bocche avvolte dal nastro isolante, le schiene che premono contro la porta della stalla di un cavallo vuota: i loro corpi stanno affrontando un qualche tipo di crisi d’astinenza. Che si tratti di eroina, crack o altro, a Philip non importa. L’unica cosa che gli interessa, al momento, è che quei due non hanno idea di quanto la loro vita stia per peggiorare. Cammina verso il dinamico duo. La ragazza magra trema per gli spasmi con gli occhi truccati incrostati di lacrime secche. L’uomo respira a fatica dalle narici. In piedi, in uno stretto raggio di luce che brulica di polvere e frammenti di fieno, Philip li guarda dall’alto come un dio furente. “Tu” dice a Sonny. “Devo farti una domanda… so che è difficile annuire con la testa legata in quel modo e tutto il resto, quindi sbatti le palpebre una volta per dire sì, due per dire no.” L’uomo lo guarda con occhi irritati, acquosi e infossati. Un battito. Philip lo guarda. “Ti piacerebbe guardare?” Due battiti. Philip prende la fibbia della cintura e comincia a slacciarla. “Peccato, perché sto per regalarvi un accidenti di spettacolo.” Due battiti. Di nuovo… due battiti. Due battiti. Due battiti. Due battiti. “Piano, Brian, non così in fretta” dice Nick a Brian la notte seguente, nella stanza da cucito al secondo piano. Alla luce delle lanterne al cherosene, Nick lo aiuta a bere dell’acqua da una cannuccia. Con la bocca ancora gonfia e intorpidita, Brian si sbava addosso. Nick ha fatto di tutto per aiutarlo a riprendersi e farlo mangiare: è stato il suo obiettivo prioritario. “Cerca di mangiare altro minestrone” suggerisce. Brian ne mangia qualche cucchiaio. “Grazie, Nick.” La voce di Brian è soffocata, rauca per il dolore. “Grazie di tutto.” Biascica le parole per via del palato ancora infiammato. Parla con esitazione, a scatti. Sdraiato sul letto, ha degli stracci legati stretti intorno alle costole spezzate, cerotti sul volto e sul collo e l’occhio sinistro è gonfio per un livido violaceo. Ci potrebbe essere qualcosa che non va nell’anca; nessuno dei due può dirlo per certo. “Starai bene, amico” dice Nick. “Tuo fratello è un’altra storia.” “Che intendi dire?” “È perduto, amico.” “Ne ha passate tante, Nick.” “Come puoi dire una cosa del genere?” Nick torna a sedersi, lasciandosi sfuggire un sospiro di dolore. “Guarda cosa ti ha fatto. E non dire che è perché ha perso Penny… tutti abbiamo perso delle persone che amiamo. Per poco non ti ha ammazzato.” Brian si guarda il piede straziato che sbuca da sotto le coperte. Con grande sforzo, dice: “Mi merito tutto quello che mi è capitato”. “Non dire così! Quanto è successo non è stata colpa tua. Tuo fratello ha oltrepassato il limite. Sono davvero preoccupato per lui.” “Starà bene.” Brian lo guarda. “Cosa c’è che non va? Cos’altro ti preoccupa?” Nick fa un respiro profondo e si chiede se può fidarsi di Brian. I fratelli Blake hanno sempre avuto una relazione complessa e, nel corso degli anni, Nick Parsons ha spesso sentito di essere per Philip Blake un fratello più del suo stesso fratello biologico. Ma c’è sempre stato un fattore X tra i fratelli Blake, un profondo legame di sangue. Alla fine, dice: “So che non sei esattamente quel che si dice una persona religiosa. E che pensi che io sia un fanatico religioso”. “Non è vero, Nick.” Nick fa un gesto noncurante. “Non importa… la mia fede è forte e io non giudico un uomo dalla sua religione.” “Dove vuoi arrivare?” Nick lo guarda. “Continua a tenerla in vita, Brian… ma forse vita non è la parola giusta.” “Penny?” “È là fuori con lei, adesso.” “Dove?” Nick spiega quanto è accaduto nei due giorni successivi alla sparatoria. Mentre Brian si riprendeva dal pestaggio, Philip si è tenuto occupato. Ha chiuso nel granaio due degli intrusi, gli unici sopravvissuti alla sparatoria. Sostiene che vuole interrogarli su eventuali insediamenti umani. Nick teme che li stia torturando. Ma quella è l’ultima delle loro preoccupazioni. A rodere Nick è il destino di Penny Blake. “La tiene incatenata a un albero come un cucciolo” dice Nick. Brian aggrotta la fronte. “Dove?” “Fuori nel frutteto. Ci va di notte. Passa del tempo con lei.” “Oh, Dio.” “Ascolta, so che pensi che siano stronzate, ma secondo quello che mi hanno insegnato nell’universo c’è una forza chiamata Bene e una forza chiamata Male.” “Nick, non penso che sia…” “Aspetta. Lasciami finire. Io credo che tutto questo, l’epidemia o comunque tu voglia chiamarla, sia opera di quello che tu definiresti Diavolo o Satana.” “Nick…” “Lasciami finire. Ci ho pensato parecchio.” “Va’ avanti. Ti ascolto.” “Qual è la cosa che Satana odia di più? Il potere dell’amore? Forse. Qualcuno che rinasce? Sì, probabilmente. Ma io credo che sia il momento in cui una persona muore e la sua anima vola in Paradiso.” “Non ti seguo.” Nick guarda gli occhi incavati di Brian. “È quello che sta succedendo qui, Brian. Il Diavolo ha trovato un modo per tenere le anime delle persone intrappolate sulla terra.” Brian impiega un attimo per interiorizzare quell’affermazione. Nick non si aspetta che gli creda, ma forse, solo forse, può riuscire a comprendere. In quel breve silenzio, il vento del nord sibila tra le persiane. Il tempo sta cambiando. La villa cigola e si lamenta. Nick si tira su il colletto della felpa che sa di naftalina, e che ha trovato alcuni giorni prima insieme ad altri vestiti pesanti nel solaio della villa, e rabbrividisce nell’aria gelida del secondo piano. “Quello che tuo fratello sta facendo è sbagliato, è contro Dio” dice, e quella sentenza resta ad aleggiare nel buio. In quel momento, fuori nell’oscurità del frutteto, un piccolo fuoco da campo crepita e tremola sul terreno. Philip è seduto sulla terra fredda davanti al fuoco, col fucile appoggiato accanto a sé e un libretto ammuffito che ha trovato nella stanza dei bambini posato sul grembo. “Lasciami entrare, lasciami entrare, porcellino” legge con voce forte, cantilenante e affaticata. “O comincerò a soffiare e butterò giù la casa!” A un metro da lui, legata al tronco dell’albero, Penny Blake ringhia e sbava a ogni parola, mentre le sue piccole mascelle scattano invano. “No, no, neanche per sogno” seguita a leggere Philip, voltando una pagina di carta semitrasparente. Fa una pausa e guarda la cosa che un tempo era sua figlia. Nella luce tremolante del fuoco, il faccino di Penny si contorce di una fame insaziabile, gonfio e rugoso come una zucca di Halloween. Il torace, ferito dal filo di ferro, si tende contro l’albero. Allunga le mani con le dite curve come artigli e stringe l’aria, cercando disperatamente di liberarsi per cibarsi di suo padre. “Ma ovviamente” continua Philip con voce rotta, “il lupo buttò giù la casa.” Segue una pausa agonizzante, prima che Philip dica con voce spezzata, piena in parti uguali di tormento e follia: “E si mangiò il porcellino”. Per il resto della settimana, il sonno non giunge facilmente per Philip Blake. Prova a concedersi alcune ore ogni notte, ma l’energia nervosa che lo sostiene continua a farlo girare e rigirare nel letto finché non è costretto ad alzarsi e fare qualcosa. La maggior parte delle notti, va nel granaio e sfoga la sua rabbia su Sonny e Cher. I due sono la ragione evidente per cui Penny è diventata quello che è, e tocca a Philip assicurarsi che soffrano come nessun uomo o donna abbia mai fatto. Il delicato processo di mantenerli da questa parte del confine tra vita e morte non è semplice. Di tanto in tanto, Philip deve dar loro dell’acqua, per essere sicuro che non gli muoiano tra le mani. Deve anche impedire che si uccidano per sfuggire al loro tormento. Come un buon carceriere, tiene le corde strette e tutti gli oggetti affilati lontani dalla loro portata. Quella notte, Philip crede che sia un venerdì, aspetta che Nick e Brian si addormentino, prima di sgusciare fuori dalla sua stanza, mettersi il giubbotto di jeans e gli stivali, uscire dalla porta sul retro e attraversare il terreno illuminato dalla luna in direzione del granaio danneggiato dalle intemperie sull’angolo nord-est della proprietà. Gli piace annunciarsi quando arriva. “Papà è a casa” mormora in tono conviviale, e dalla sua bocca escono sbuffi di vapore, mentre apre il chiavistello e spalanca la doppia porta. Accende una lampada a batteria. Sonny e Cher sono curvi nell’ombra dove li ha lasciati, due creature malconce legate fianco a fianco come maialini da latte, e giacciono in una pozza del loro stesso sangue, piscio e merda. Sonny è appena cosciente: la testa è riversa su un fianco, gli occhi iniettati di sangue sono cerchiati di rosso. Cher è priva di sensi. Giace accanto a lui, coi pantaloni di pelle arrotolati intorno alle caviglie. Entrambi recano i segni suppuranti degli strumenti punitivi di Philip: pinze tagliacavi, filo spinato, tavole di legno con chiodi arrugginiti e vari oggetti non appuntiti che ha usato nella foga del momento. “Sveglia, sorella!” Philip si piega e gira la donna sulla schiena: i legacci le stanno segando i polsi e la corda intorno al collo le impedisce di agitarsi troppo. Philip la schiaffeggia. I suoi occhi vacillano. La schiaffeggia di nuovo. La donna riprende i sensi, ma le sue grida scoraggiate sono soffocate dalla matassa di nastro isolante che le copre la bocca. A un certo punto nella notte, è riuscita a rimettersi le mutandine insanguinate e a coprirsi le parti intime. “Lasciate che ve lo ricordi ancora una volta” dice Philip, riabbassandole le mutande fino al ginocchio. Si erge su di lei e le allarga le gambe con gli stivali come per aprirsi una strada. Lei si agita e si dimena, come se potesse contorcersi fino a uscire dalla sua stessa pelle. “Voi siete quelli che mi hanno portato via mia figlia… perciò andremo all’inferno tutti insieme.” Si slaccia la cintura e si cala i pantaloni; poi non gli serve troppa immaginazione per produrre rapidamente un’erezione: la rabbia e l’odio bruciano in lui con tanto di quel calore da farlo sentire un ariete. Si inginocchia tra le gambe tremanti della donna. La prima spinta è sempre l’innesco: allora la voce nella sua testa comincia a intromettersi, lo deride, lo esorta coi frammenti delle vecchie assurdità bibliche che suo padre era solito borbottare quando era ubriaco. La vendetta è mia, disse il Signore! Ma quella notte, dopo la terza o quarta spinta dentro la donna inerte, Philip si ferma. Una combinazione di fattori interrompe la sua concentrazione e attira la sua attenzione. Sente dei passi, che scricchiolano sul retro del terreno e vede, tra le tavole del rivestimento esterno, l’ombra sfuocata di una figura che oltrepassa il granaio. Ma ciò che lo spinge a ritirarsi, ad alzarsi e rimettersi frettolosamente i pantaloni, è che quella figura si muove verso il frutteto. Verso il posto dove si trova Penny. Philip esce dal granaio e vede una figura inoltrarsi nelle ombre del frutteto. La figura è quella di un uomo basso ma robusto, sulla trentina, vestito con una felpa e dei jeans: porta una grossa pala arrugginita sulla spalla. “Nick!” Il grido di Philip viene ignorato. Nick è già svanito tra gli alberi. Philip estrae la nove millimetri da dietro la cintura e corre verso il frutteto. Infila un proiettile nella camera di scoppio mentre si inoltra nel bosco. L’oscurità cede al raggio di una torcia elettrica. Quindici metri più avanti, Nick Parsons illumina il volto livido della cosaPenny. “NICK!” Nick si gira di scatto con la pala sollevata; la torcia elettrica gli cade di mano. “Sei andato troppo oltre, Philly, sei andato troppo oltre.” “Metti giù la pala” dice Philip, mentre si avvicina con la pistola puntata. Il raggio della torcia elettrica risplende sulle foglie e proietta un bagliore pallido e inquietante come un film in bianco e nero sgranato. “Non puoi fare questo a tua figlia, non capisci quello che stai facendo.” “Mettila giù.” “Impedisci alla sua anima di entrare in Paradiso, Philly.” “Sta’ zitto!” Nell’ombra, a cinque o sei metri di distanza, la cosa-Penny strattona i suoi legacci. Il raggio storto della torcia elettrica evidenzia i suoi mostruosi lineamenti. Gli occhi riflettono la fredda luce argentata. “Philly, ascoltami.” Nick abbassa la pala con la voce tremante per l’emozione. “Devi lasciarla morire… è una figlia di Dio. Ti prego… ti imploro da cristiano… ti prego, lasciala andare.” Philip punta la Glock dritta sulla fronte di Nick. “Se lei muore… tu muori subito dopo.” Per un momento, Nick Parsons pare avvilito, sconfitto. Poi getta a terra la pala, si prende la testa tra le mani e si avvia di nuovo verso la villa. Per tutto quel tempo, la cosa-Penny tiene il suo sguardo da squalo fisso sull’uomo che una volta chiamava padre. Brian continua a guarire. Sei giorni dopo il pestaggio, si sente abbastanza forte da alzarsi dal letto e girare per casa. L’anca gli manda lancinanti fitte di dolore a ogni passo e le vertigini lo assalgono a ondate ogni volta che sale o scende le scale, ma nel complesso se la cava abbastanza bene. I lividi stanno svanendo, il gonfiore si è ridotto e gli sta tornando l’appetito. Riesce anche ad avere una conversazione con Philip. “Mi manca in modo atroce” gli dice Brian una sera a tarda notte in cucina: entrambi soffrono di una grave insonnia. “Cambierei il mio posto col suo in un baleno, se servisse a portarla indietro.” Philip guarda verso il basso. Ha sviluppato una serie di lievi tic, che emergono quand’è sotto pressione: tira su col naso, contrae le labbra, si schiarisce la gola. “Lo so, campione. Non è stata colpa tua… quello che è successo là fuori. Non avrei mai dovuto farti del male.” Gli occhi di Brian si inumidiscono. “Probabilmente avrei fatto la stessa cosa.” “Mettiamoci una pietra sopra.” “Sicuro.” Brian si sfrega gli occhi. Guarda Philip. “Allora, com’è la faccenda con la gente nel granaio?” Philip solleva lo sguardo. “Qual è il problema?” “Tutta questa storia sta facendo andare fuori di testa Nick… e si sentono delle cose là fuori… di notte, intendo. Nick crede che tu gli stia, che so… strappando le unghie.” Un sorriso freddo piega gli angoli della bocca di Philip. “Questo sì che è nauseante.” Brian non sorride. “Philip, qualsiasi cosa tu faccia là fuori non porterà indietro Penny.” Philip abbassa lo sguardo di nuovo. “Lo so… credi che non lo sappia?” “Allora ti imploro di smetterla. Qualsiasi cosa tu faccia… smettila.” Brian lo guarda. “Non serve a niente.” Philip alza lo sguardo con occhi che bruciano per l’emozione. “Quelle merde nel granaio mi hanno rubato l’unica cosa che aveva importanza per me… quel figlio di puttana pelato e i suoi scagnozzi… quei due drogati… hanno distrutto la vita di una meravigliosa bambina innocente e l’hanno fatto solo per cattiveria e avidità. Niente di quello che potrei fargli sarebbe sufficiente.” Brian sospira. Protestare ancora sarebbe inutile; si limita a fissare il suo caffè. “E ti sbagli quando dici che non serve a niente” conclude Philip, dopo averci riflettuto per un attimo. “Serve a farmi stare meglio.” La notte seguente, dopo che le lanterne si sono spente, che i fuochi nei tre diversi camini sono diventati cenere e che il vento da nord-est ha preso a giocare con gli abbaini e le tegole allentate, Brian giace sul letto nella stanza del cucito e prova a sprofondare in un sonno agitato, quando sente aprirsi la porta e vede la sagoma di Nick Parsons scivolare nella sua stanza. Si mette a sedere. “Che succede?” “Sssssshhh” sussurra Nick, attraversando la stanza e inginocchiandosi accanto al letto. Nick si è messo il giubbotto e i guanti, e sul fianco si vede un rigonfiamento che sembra il calcio di una pistola automatica. “Fa’ silenzio.” “Che c’è?” “Tuo fratello dorme… finalmente.” “E allora?” “Allora dobbiamo… come dire… intervenire.” “Di cosa parli? Penny? Vuoi provare ad ammazzarla di nuovo?” “No! Il granaio, amico! Il granaio!” Brian si sposta verso il bordo del letto e si strofina gli occhi, si stira gli arti doloranti e cerca di darsi una svegliata. “Non so se sono pronto.” Scivolano fuori dal retro, ognuno armato di una pistola automatica. Nick ha il revolver .357 dell’uomo calvo, Brian una pistola a canna corta che apparteneva a uno degli altri delinquenti. Si muovono furtivi nel cortile, diretti verso il granaio; Brian illumina il chiavistello con una torcia elettrica. Trovano un pezzo di legno in una catasta e lo usano per aprire le porte marce, cercando di fare meno rumore possibile. Il cuore di Brian batte all’impazzata mentre scivolano dentro il granaio buio. Il tanfo di muffa e urina gli riempie le narici mentre si fanno strada verso le fetide ombre sul fondo del granaio, dove due mucchi scuri giacciono sul pavimento in pozze di sangue nero come petrolio. Sulle prime, non sembrano nemmeno forme umane, ma quando il raggio della torcia elettrica si posa su una faccia pallida, Brian si lascia sfuggire un rantolo. “Porca merda fottuta.” L’uomo e la donna sono ancora vivi, a malapena, le loro facce sono sfigurate e gonfie, il torace esposto come carne cruda. Un sottile filo di vapore sale dalle ferite piene di pus e non ancora cicatrizzate. Entrambi i prigionieri sono solo parzialmente coscienti, i loro occhi sbucciati sono fissi sulle travi del tetto. La donna è stata violentata, una bambola rotta con le gambe spalancate e disegni di sangue sulla carne viscida e tatuata. Brian comincia a tremare. “Porca merda… cos’abbiamo…? Porca merda fottuta…” Nick si inginocchia accanto alla donna. “Brian, prendi un po’ d’acqua.” “Ma che…” “Prendila dal pozzo! Svelto!” Brian prende la torcia elettrica, la accende e si affretta nella direzione da cui è venuto. Nick fa scorrere la luce sulla costellazione di ferite e piaghe, alcune vecchie e infettate, altre fresche, su tutta la superficie dei corpi straziati. Il petto dell’uomo si alza e si abbassa in fretta, con respiri brevi e convulsi. La donna si affanna per mettere a fuoco il suo sguardo umido su Nick. Sbatte le palpebre freneticamente. Le sue labbra si muovono sotto il nastro isolante. Nick le rimuove con cautela il bavaglio dalla bocca. “Ti p-p-pre… ucchhh…” Si sforza di dire qualcosa di importante, ma Nick non capisce. “Va tutto bene, vi tireremo fuori da qui, va tutto bene, ce la farete.” “U-ucchhh…” “Freddo?” Nick cerca di rimetterle i pantaloni. “Cerca di respirare, cerca di…” “U-Ucchdhicih.” “Cosa? Non…” La donna deglutisce e dice di nuovo: “U-uccidici… ti p-prego…” Nick li guarda. Gli si gela il sangue. Sente qualcosa che lo sfiora delicatamente sul fianco, guarda in basso e vede che la mano incrostata della donna tenta di afferrare il calcio della pistola, che sbuca dalla sua cintura. Nick sente tutta la sua energia defluirgli di dosso. Il suo cuore sprofonda ben oltre il livello del pavimento. Estrae la .357 dalla cintura, si alza e resta a guardare gli abomini sul pavimento del granaio molto, molto a lungo. Recita una preghiera: il Salmo ventitreesimo. Brian è sulla via del ritorno con un secchio di plastica colmo di acqua del pozzo, quando sente due spari soffocati provenire dal granaio. Come petardi che esplodono dentro una lattina, gli spari sono brevi e intensi. Il rumore lo fa bloccare di colpo, mentre l’acqua cola oltre il bordo del secchio. Deglutisce spaventato. Poi, con la coda dell’occhio, vede una debole luce accendersi in una finestra del secondo piano della villa: la stanza di Philip. Il raggio di una torcia elettrica illumina la finestra, poi svanisce. Segue una serie di passi, che risuonano lungo le scale e attraverso la casa, pesanti e veloci; Brian si rimette in movimento. Lascia cadere il secchio e comincia a correre nel cortile diretto al granaio. Si fionda attraverso il portone e si tuffa nell’oscurità. Sfreccia nell’ombra, verso il raggio di luce argentata che brilla sul pavimento. Nick è in piedi sopra i prigionieri. Un filo di fumo di cordite si leva dalla bocca della .357 stretta nella mano destra di Nick, che guarda i corpi distesi a terra. Brian lo raggiunge e comincia a dire qualcosa quando, d’un tratto, guarda giù e vede le ferite alla testa: germogli di sangue fioriscono sulla porta della stalla, scintillando nel raggio di luce orizzontale. L’uomo e la donna sono morti e freddi come il marmo; giacciono supini nei loro fluidi che si seccano, con la faccia tranquilla, ormai liberi dal tormento delle loro sofferenze. Di nuovo, Brian cerca di dire qualcosa. Ma non riesce a dire neanche una parola. Un attimo dopo, nel buio del granaio, la doppia porta si spalanca e Philip piomba all’interno. Con i pugni stretti sui fianchi, la faccia contorta dalla rabbia, gli occhi lampeggianti di follia, marcia verso la luce. Sembra sul punto di divorare qualcuno. Ha una pistola infilata nella cintura e un machete gli rimbalza sul fianco. Arriva quasi fino a metà del granaio, prima di rallentare. Nick si è allontanato dai corpi ed è pronto a difendere la sua posizione con Philip che si avvicina. Brian fa un passo indietro: un’ondata di vergogna lo travolge. Ha la sensazione che la sua anima sia stata strappata in due. Fissa il pavimento mentre suo fratello cammina lento, guardingo e sposta lo sguardo nervoso dai corpi morti a Nick a Brian e di nuovo ai corpi morti. Per lungo tempo, nessuno riesce a pensare a qualcosa da dire. Philip continua a guardare Brian, e Brian continua a cercare di nascondere la vergogna che lo paralizza e lo travolge, ma più ci prova più questa lo trascina a fondo. Se solo ne avesse il fegato, si ficcherebbe la pistola a canna corta in bocca e porrebbe fine alle sue sofferenze da solo in quello stesso momento. In qualche strano modo, si sente responsabile per quanto è successo, tutto quanto, ma è troppo codardo per uccidersi da uomo. Può solo restare lì e guardare altrove, pieno di vergogna e umiliazione. E come in un’invisibile reazione a catena, la vista patetica e raccapricciante dei corpi profanati, combinata con l’ostinato silenzio di suo fratello e del suo amico comincia a incrinare Philip. Ricaccia indietro le lacrime che gli affiorano negli occhi, e sporge il mento tremante in un misto di sconfitta e di disgusto per se stesso. Muove la bocca come se avesse qualcosa di importante da dire e gli occorre uno sforzo enorme per riuscire a parlare. Alla fine riesce a mormorare una sola parola soffocata: “Pazienza”. Nick sembra mortificato e fissa Philip incredulo. “Pazienza?” Philip si gira e se ne va; mentre si allontana estrae la Glock dalla cintura. Tira indietro il carrello e spara sulla parete del granaio… BOOOOMMMMMM! Il rinculo scalcia nella sua mano e il latrato sordo fa sobbalzare Brian. BOOOOOMMMM! Un altro sparo lampeggia nell’oscurità, distruggendo un pezzo della porta. BOOOOOMMMM! Il terzo sparo apre un buco in una trave e scatena una pioggia di schegge sul pavimento. Philip spalanca la porta con un calcio furioso ed esce fuori. Nel silenzio, che si lascia alle spalle, guizzano per un momento le immagini residue della sua rabbia feroce. In tutto quel tempo, Brian non ha distolto lo sguardo dal pavimento e continua a tenersi la testa tra le mani e a fissare miseramente il fieno ammuffito. Nick rivolge un’ultima occhiata ai corpi; poi esala un sospiro lungo, irregolare e affl itto. Guarda Brian e scuote la testa. “Ecco come stanno le cose” dice. Ma qualcosa dietro le sue parole, nel sottile tono di terrore della sua voce, dice a Brian che le cose sono ormai irrimediabilmente cambiate nella loro piccola famiglia disfunzionale. VENTI “Che cazzo fa?” Nick è alla finestra sul davanti della villa e guarda il mattino coperto. Davanti alla facciata della casa, in cima al vialetto, Philip ha messo a Penny un guinzaglio per cani modificato, che ha fabbricato con pezzi presi nel capanno degli attrezzi: è un lungo tubo di rame, a un’estremità del quale ha infilato un collare appuntito. La trascina verso un pick-up Ford S-10 parcheggiato sull’erba, uno dei veicoli della banda del pelato. Philip ha riempito il cassone posteriore di cibo in scatola, armi, provviste, coperte e lenzuola. Penny ringhia e sputa mentre viene trascinata via; afferra il tubo che ha attaccato al collo e morde l’aria. Nella luce acquosa e opaca, la sua faccia morta sembra una maschera di Halloween vivente, scolpita con argilla grigio verme. “È quello che cercavo di dirti” dice Brian, in piedi accanto a Nick, mentre guarda la bizzarra scena che si sta svolgendo nel cortile. “Stamattina si è alzato con la convinzione che non possiamo più restare qui.” “E perché?” Brian scrolla le spalle. “Non lo so… dopo tutto quello che è successo… immagino che questo posto sia come un veleno per lui, pieno di fantasmi… non lo so.” Brian e Nick sono stati in piedi tutta la notte a tracannare caffè e a discutere della situazione. Nick ritiene che Philip sia andato fuori di testa, sopraffatto dallo stress della perdita di Penny e dalla pressione di proteggerli. Sebbene abbia smesso di dirlo a parole, ha alluso alla possibilità che il Diavolo abbia posato i suoi artigli su Philip. Brian è troppo esausto per discutere di metafisica con Nick, ma non può negare che le cose siano diventate terribili. “Lascialo andare” dice Nick alla fine, allontanandosi dalla finestra. Brian lo guarda. “Che intendi dire? Vuoi rimanere qui?” “Già, rimango. E dovresti farlo anche tu.” “Dai, Nick.” “Come possiamo continuare a seguirlo… dopo tutta questa merda… dopo tutto quello che è successo?” Brian si sfrega la bocca e ci pensa. “Senti. Te lo ripeto. Quanto ha fatto a quella gente va ben oltre l’atroce. Ha perso la testa. E non sono sicuro che riuscirò a guardarlo ancora alla stessa maniera… ma adesso si tratta di sopravvivere. Non possiamo separarci. Abbiamo buone possibilità se restiamo insieme, a ogni costo.” Nick guarda fuori dalla finestra. “Pensi davvero che riusciremo ad arrivare alla Costa del Golfo? Sono più di seicento chilometri.” “Abbiamo buone possibilità se ci proviamo insieme.” Nick fissa il suo sguardo su Brian. “Ha messo un fottuto guinzaglio a sua figlia morta. Ti ha quasi picchiato a morte. È una mina vagante, Brian, e ci scoppierà in faccia.” “Quella mina vagante ci ha portati tutti interi fin qui per tutta la Georgia da Waynesboro” dice Brian, con una vampa di rabbia che gli brucia nelle viscere. “Perciò, è pazzo, è imprevedibile, è posseduto dai demoni, è il fottuto principe delle tenebre… ma è ancora mio fratello ed è la nostra migliore possibilità di sopravvivenza.” Nick lo guarda. “È così che la chiami adesso? Sopravvivenza?” “Se vuoi restare qui, fa’ pure.” “Grazie, lo farò.” Nick si allontana, lasciando Brian a voltarsi di nuovo verso la finestra e a osservare nervoso suo fratello. Utilizzando il manicotto di un radiatore come sifone, accumulano tutto il carburante che hanno preso dai trattori, dai veicoli, persino dalle Harley, sul Ford S-10. Alla fine, riempiono il serbatoio da ottanta litri e gli avanza ancora qualcosa. Philip rimedia un posto per Penny sul cassone posteriore, spostando delle scatole di provviste a semicerchio e sistemando delle coperte sul fondo. La incatena a una staffa a U in modo che non possa combinare niente o cadere dal pick-up. Nick osserva tutto dalla sua finestra al secondo piano, camminando per la stanza come un animale in gabbia. La realtà della situazione si sta concretizzando. Resterà solo in quella vecchia villa piena di spifferi. Passerà le notti da solo. Passerà tutto l’inverno da solo. Sentirà il vento del nord ululare nelle grondaie e i lamenti lontani degli azzannatori che vagano nei frutteti… tutto il tempo da solo in attesa del momento giusto. Si sveglierà da solo, mangerà da solo, cercherà il cibo da solo, sognerà giorni migliori e pregherà Dio per la liberazione… tutto da solo. Mentre osserva Philip e Brian terminare gli ultimi preparativi per la partenza, una fitta di rimpianto gli serra il petto: il rimorso del venditore. Attraversa la stanza e si avvicina all’armadio. Gli bastano pochi secondi per riempire un borsone con le cose essenziali. Corre fuori dalla stanza e fa le scale due alla volta. Brian si sistema sul sedile del passeggero e Philip sta mettendo in moto il motore, per allontanarsi dalla villa, quando il rumore del portone che si spalanca giunge alle loro orecchie. Brian guarda da sopra la spalla e vede Nick con un borsone sulle spalle, che corre sul viale, facendo loro cenno di tornare indietro. È difficile credere che Philip abbia trascurato di guardare sotto il cofano del pick-up. Gli ci sarebbero voluti meno di tre minuti per trovare il manicotto perforato. Ma Philip Blake non è esattamente al pieno della sua forma in questi giorni. Adesso la sua mente è una radio a onde corte sintonizzata su stazioni diverse. E comunque, a prescindere che si tratti di un taglio fatto di proposito dagli intrusi dopo lo scoppio dello scontro a fuoco (per assicurarsi che nessuno scappasse), di un buco aperto da un proiettile, che ha perforato la griglia anteriore del furgone, o semplicemente di un’avaria fortuita, il pick-up comincia a emettere fumo e a scoppiettare a meno di dieci chilometri dalla villa. In un punto a circa ottanta chilometri a sud-ovest di Atlanta, in un posto che molti degli abitanti della zona definiscono il bel mezzo del nulla, il pick-up arranca fuori dall’autostrada e sulla banchina di ghiaia, dove sputacchia fino a fermarsi, con tutte le spie del cruscotto accese. Da sotto il cofano esce un vapore bianco e l’accensione non funziona. Philip prorompe in un’allarmante sequela di bestemmie e per poco non sfonda il pavimento a furia di calci coi suoi stivali da lavoro. Gli altri due uomini guardano in basso, aspettando silenziosi che la sfuriata finisca. Brian si chiede se è così che si sente una moglie maltrattata: troppo impaurita per scappare, troppo impaurita per restare. Alla fine, la collera di Philip si placa. Scende e apre il cofano. Brian si unisce a lui. “Qual è il verdetto?” “Fottuti per bene.” “Non c’è speranza di aggiustarlo?” “Hai per caso un manicotto per il radiatore?” Brian guarda da sopra la spalla. Il fianco della strada scende in un crepaccio pieno di vecchi pneumatici, erbacce e spazzatura. Un movimento attira il suo sguardo verso l’estremità del crepaccio, a circa quattrocento metri di distanza, dove un gruppetto di azzannatori rovista nella spazzatura. Barcollano in cerca di carne tra le rocce, come maiali in cerca di tartufi. Non si sono ancora accorti del veicolo in panne che manda fumo sul lato della carreggiata a trecento metri da loro. Sul retro del pick-up, Penny strattona la catena, che passa intorno al suo collare da cane ed è imbullonata al pianale ondulato. La vicinanza di altri cadaveri che camminano sembra stimolarla, eccitarla, disturbarla. “Che ne pensi?” chiede infine Brian a suo fratello, che ha abbassato il cofano e lo ha chiuso, attento a non fare il minimo di rumore. Nick esce dalla cabina e si unisce a loro. “Qual è il piano?” Brian lo guarda. “Il piano è… che siamo fottuti.” Nick si mangia un’unghia, guardando da sopra la spalla il conclave di zombie che avanzano lenti lungo il crepaccio, avvicinandosi sempre più di minuto in minuto. “Philip, non possiamo restare qui. Forse possiamo trovare un’altra macchina.” Philip esala un sospiro affl itto. “D’accordo, ragazzi, sapete cosa fare… prendete la vostra roba, io prendo Penny.” Se la filano con Penny al guinzaglio e la schiena carica di provviste. Marciano sulla banchina, seguendo l’autostrada. Brian cammina zoppicando senza lamentarsi, nonostante lo straziante dolore all’anca. Dalle parti di Greenville, devono prendere una deviazione per via di un inspiegabile ammasso di veicoli distrutti e bruciati, che si estende per tutte le corsie, a nord come a sud: l’intera area brulica di zombie. Da lontano, sembra quasi che la terra stessa si sia spaccata e abbia vomitato centinaia di cadaveri ambulanti. Decidono di prendere una strada a due corsie, la Rural Route 100, che si dirige a sud, attraversa Greenville e gira intorno al tamponamento. Percorrono forse tre o quattro chilometri prima che Philip alzi la mano e si fermi. “Aspettate un secondo” dice, accigliandosi. Solleva la testa. “Cos’è?” “Cosa?” “Questo rumore.” “Quale rumore?” Philip si mette in ascolto. Gli altri lo imitano. Philip gira piano su se stesso, per individuare la direzione da cui proviene il rumore. “È un motore?” Anche Brian lo sente. “Sembra un fottuto carro armato.” “O forse un bulldozer” azzarda Nick. “Ma che cazzo.” Philip strizza gli occhi mentre ascolta. “Non può essere troppo lontano.” Riprendono a camminare. Dopo meno di un chilometro e mezzo, si imbattono in un cartello ammaccato. woodbury – 1 miglio Continuano lungo la strada con gli occhi puntati sul cielo coperto di fumo a occidente. “Chiunque siano, hanno del carburante” dice Nick. Brian vede una nuvola di polvere all’orizzonte. “Pensi che abbiano intenzioni amichevoli?” “Non voglio correre rischi” dice Philip. “Forza… troviamo una strada alternativa, facciamo un passo alla volta.” Philip li conduce dall’altra parte della banchina, poi giù per una discesa erbosa. Attraversano veloci il campo di una fattoria vicina, una valle incolta di morbida terra. I loro stivali affondano nella melma. Il vento freddo li sferza e impiegano un interminabile lasso di tempo per aggirare la periferia, prima che i resti di una città abbandonata si materializzino davanti a loro. L’insegna di un Walmart sorge sopra una macchia di querce antiche. Le arcate dorate di un McDonald’s sono visibili non molto lontano. L’immondizia rotola nelle strade deserte, davanti a edifici di mattoni costruiti nel dopoguerra e condomini fatti con lo stampino. Ma sul lato nord della città, dall’interno di un labirinto di barriere anticiclone, il suono di motori, martellamenti e di voci sporadiche rivelano la presenza di umani. “Sembra quasi che costruiscano un muro o qualcosa del genere” dice Nick, mentre fanno una pausa sotto la copertura degli alberi. In lontananza, a circa duecento metri di distanza, una manciata di figure lavorano a un alto baluardo di legno che racchiude il confine nord della città. La barricata circonda già quasi due isolati. “Il resto del posto sembra morto” commenta Philip. “Non possono esserci molti sopravvissuti.” “Che diavolo è quello?” Brian indica un semicerchio di alti piloni, ad alcuni isolati a ovest della barricata. Grappoli di lampade ad arco sono puntate verso il basso su un grande spazio aperto, oscurato dai palazzi e dalle recinzioni. “Il campo da football di un liceo, forse?” Philip prende la sua Glock. La estrae e controlla i proiettili che restano nel caricatore. Ha ancora sei proiettili a punta cava. “A cosa pensi, Philip?” Nick sembra ansioso, agitato. Brian si chiede se sia preoccupato di finire in un’altra trappola. O forse è solo nervoso per la vicinanza di Philip. La verità è che nemmeno lui è troppo entusiasta di presentarsi senza invito a quella piccola comunità di straccioni, specie considerando che hanno uno zombie in decomposizione a rimorchio e che il padre di quello zombie è così profondamente affl itto da sembrare capace di fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Ma quale alternativa hanno? Le nuvole scure si radunano all’orizzonte verso ovest e la temperatura è in picchiata. “Cos’hai lì, campione?” Philip indica con un cenno la pistola che sporge dalla cintura di Brian. “La .38?” “Già.” “E tu hai la .357?” chiede a Nick, che annuisce nervoso. “Okay… ecco cosa faremo.” Entrano dall’angolo nord-est della città, dagli alberi che fiancheggiano i binari della ferrovia. Arrivano lenti, con le mani alzate in un gesto non intimidatorio. Sulle prime, sono sorpresi da quanto riescono ad avanzare, sotto gli occhi di almeno una dozzina di esseri umani, prima che qualcuno si accorga che stanno entrando in città. “Ehi!” Un uomo massiccio di mezz’età con un dolcevita nero salta giù da un bulldozer, indicando i nuovi arrivati. “Bruce! Guarda! Abbiamo compagnia!” Un altro lavoratore, un nero alto con una giacca da marinaio e la testa rasata e lucida, smette di martellare. Alza lo sguardo e spalanca gli occhi. Si avvicina a un fucile appoggiato a un frigo da campeggio. “State calmi, amici!” Philip avanza lento attraverso un parcheggio per camion polveroso, con le mani alzate. La sua espressione è calma, mostra tutta la mitezza e la bonarietà che è riuscito a chiamare a raccolta. “Passavamo da queste parti… non siamo in cerca di guai.” Brian e Nick lo seguono da vicino, entrambi con le mani alzate. I due uomini si avvicinano coi fucili. “Avete armi, ragazzi?” si informa il nero. “C’è la sicura inserita” dice Philip, fermandosi per estrarre cauto la Glock. “Ve la faccio vedere, con molta calma.” Mostra loro la nove millimetri. “E voi due?” L’uomo col dolcevita si rivolge a Brian e Nick. Entrambi mostrano le loro pistole. “Ci siete solo voi tre?” L’uomo che indossa il dolcevita ha un accento del nord. I capelli biondi e rasati sono screziati di grigio; ha un collo da lottatore e un torace da scaricatore di porto. La grossa pancia da maiale pende sopra la cintura. “Solo noi tre” dice Philip, e in fondo è la verità. Ha lasciato Penny legata a un albero nelle ombre del boschetto di noci americani a un centinaio di metri dalla barricata. L’ha legata con della corda extra e le ha messo una bandana intorno alla bocca per impedirle di fare rumore. Imbavagliarla a quel modo è stato uno strazio, ma fin quando non sa con chi ha a che fare, immagina che sia meglio tenerla al riparo da occhi indiscreti. “Cosa vi è successo?” chiede il tizio col maglione a collo alto a Brian, accennando alle sue ferite. “Se l’è vista brutta lottando contro alcuni azzannatori” spiega Philip. L’uomo col maglione a collo altro abbassa il fucile. “Voi ragazzi venite da Atlanta?” “No, signore. Da una piccola città chiamata Waynesboro.” “Avete visto la Guardia Nazionale là fuori?” “No, signore.” “Viaggiavate da soli?” “Più o meno.” Philip mette via la pistola. “Abbiamo solo bisogno di riposare un po’ e poi ci rimettiamo in viaggio.” “Hai del cibo?” “No.” “Sigarette?” “No, signore.” Philip indica i suoi compagni. “Se potessimo avere soltanto un tetto sulla testa per un po’, non disturberemmo nessuno. A voi ragazzi sta bene?” Per un momento, i due operai si guardano come se si scambiassero una battuta. Poi il nero scoppia a ridere. “Ragazzi, questo è il fottuto selvaggio West… a nessuno frega un cazzo di quello che fate.” In realtà l’uomo di colore ha minimizzato la situazione a Woodbury. Durante le restanti ore del giorno, Philip, Brian e Nick si fanno un’idea del posto e non è esattamente Mayberry RFD 10. Circa sessanta abitanti resistono nel settore sicuro a nord della città: intenti per lo più a proteggere se stessi, si accontentano di vivere di avanzi e sono tutti così paranoici e diffidenti che escono dalle loro tane solo di rado. Vivono in condomini deserti e negozi vuoti, e non si sono organizzati intorno a una leadership di nessun genere. È straordinario che alcuni abbiano preso l’iniziativa di costruire un muro. A Woodbury ogni uomo, ogni donna, ogni bambino è per se stesso. E questo a Philip, Brian e Nick va più che bene. Dopo aver perlustrato i confini della città, decidono di sistemarsi in un palazzo abbandonato composto da due appartamenti, sul confine meridionale della zona sicura, vicino al distretto commerciale disabitato. Qualcuno ha posizionato scuolabus e semirimorchi vuoti in file che circondano la periferia, costruendo un bastione di fortuna per tenere fuori gli azzannatori. Per adesso, il posto sembra relativamente sicuro. Quella notte, Brian non riesce a dormire e decide di sgusciare fuori e di esplorare la città. Camminare non è facile: le costole lo tormentano ancora e il suo respiro è affaticato e ansimante, ma è bello uscire e chiarirsi le idee. Nella luce della luna fredda come un diamante, i marciapiedi giacciono desolati e aridi, attraverso quella che un tempo era una tipica cittadina di operai. L’immondizia ricopre disordinatamente le piazze e i campi da gioco abbandonati. Le vetrine dei negozi necessari a servire una piccola città, il dentista locale, il DeForest’s Feed and Seed, un Dairy Queen, il Piggly Wiggly, sono tutte chiuse e sbarrate. I segni della “svolta” sono ovunque: nelle fosse di calce viva del Kirney’s Salvage Yard, dove i corpi sono stati depositati e bruciati, e nel gazebo pubblico in piazza Robert E. Lee, dove le macchie di sangue di qualche raccapricciante battaglia scintillano ancora come catrame nero. Brian non è sorpreso di scoprire che il campo aperto nel centro della città, che aveva scorto per la prima volta dalla fattoria, è una vecchia e polverosa pista per delle gare di dirt track11. A quanto pare, i residenti hanno abbastanza carburante per far andare i generatori tutto il giorno; e come Brian scopre presto, ogni tanto, nel buio della notte, le grandi lampade ad arco della pista si accendono senza ragione apparente. Sul lato opposto della pista, Brian oltrepassa un semirimorchio che pulsa come un grande cuore d’acciaio per le vibrazioni soffocate dei motori a scoppio: i cavi serpeggiano dal retro e si collegano ai palazzi vicini. Quando l’alba comincia a brillare a est sull’orizzonte, Brian decide che è meglio tornare all’appartamento. Attraversa un parcheggio deserto e prende una scorciatoia passando in un vicolo lastricato di immondizia. Arriva nella strada adiacente e oltrepassa un gruppo di vecchi stretti intorno a un bidone colmo di immondizia e in fiamme, intenti a scaldarsi le mani contro il freddo e far girare una bottiglia di Thunderbird. “Guardati le spalle, ragazzo” dice uno a Brian, e gli altri due ridacchiano senza l’aria di divertirsi davvero. Sono tre vecchietti decrepiti e coi capelli grigi, avvolti nei loro cappotti tarmati dell’Esercito della Salvezza. Sembra quasi che siano accosciati intorno a quel bidone per l’eternità. Brian si ferma. Ha la .38 a canna corta infilata dietro la cintura, sotto il giubbotto, ma non sente alcun bisogno di estrarla. “Ci sono azzannatori nella zona?” “Azzannatori?” chiede un altro, che ha una lunga barba bianca e strizza confuso gli occhi cerchiati di rughe. “Intende dire le cose morte” dice il terzo derelitto, il più grasso dei tre. “Già, Charlie” dice il primo. “Ti ricordi… quei sacchi di pus ambulanti che si sono mangiati Yellow Mike… la ragione per cui siamo bloccati in questa città di merda.” “Lo so di cosa parla!” sbotta il vecchietto con la barba. “Solo che non avevo mai sentito chiamarli così prima d’ora.” “Sei nuovo in città, figliolo?” Quello grasso squadra Brian da cima a fondo. “A dire il vero, sì… sono nuovo.” Il vecchio grasso gli mostra un sorriso pieno di denti verdi e marci. “Benvenuto nella sala d’aspetto dell’inferno.” “Non ascoltarlo, figliolo” dice il primo, posandogli un braccio scheletrico e artritico intorno alle spalle. Poi, con voce roca e raffreddata, il vecchio dice in tono confidenziale: “Non è alle cose morte che devi fare attenzione da queste parti… ma ai vivi”. Il giorno dopo, Philip dice a Brian e a Nick di tenere le bocche chiuse finché rimangono a Woodbury, di non attirare attenzione, di evitare ogni contatto con gli altri residenti, di guardarsi perfino dal dire alla gente i loro nomi. Per fortuna, l’appartamento si rivela un rifugio temporaneo eccellente. Costruito negli anni 50, contiene mobili altrettanto vecchi, uno specchio scheggiato appeso a un muro, un divano letto tarmato in soggiorno, un enorme acquario rettangolare accanto al televisore, pieno di sporco stagnante e dei piccoli cadaveri galleggianti dei pesci rossi abbandonati. Ci sono tre camere da letto e persino acqua corrente. Puzza di merda di gatto rancida e pesce marcio, ma com’era solito dire il padre di Brian: “A caval donato non si guarda in bocca”. Trovano cibo in scatola nelle dispense di entrambi gli appartamenti e decidono di fermarsi per un po’. Con grande stupore di Brian, gli abitanti della città li ignorano, come se fossero dei fantasmi. Brian sa che la voce della loro presenza si è sparsa tra gli abitanti, eppure è come se i Blake e Nick fossero spettri che infestano l’appartamento fatiscente. Il che non è troppo lontano dal vero. Nick pensa agli affari suoi, legge la sua Bibbia e non parla molto. Philip e Brian, ancora irritabili l’uno con l’altro, si fanno anche loro gli affari propri e si parlano il meno possibile. L’idea di cercare un altro veicolo e di continuare il loro viaggio verso sud non li sfiora nemmeno. Brian crede che abbiano rinunciato… ad arrivare al mare, al futuro, forse anche gli uni agli altri. Continua a guarire e Philip coltiva la sua ossessione per Penny, recandosi di nascosto nella macchia di noci americani ogni volta che può. Una sera, a tarda notte, Brian sente la porta dell’appartamento aprirsi e chiudersi. Rimane steso sul letto, in ascolto, per quasi un’ora, quando finalmente sente Philip ritornare in un turbinio di passi felpati e gorgoglii. È la terza notte di fila che scivola fuori dall’appartamento in silenzio, presumibilmente per andare a controllare Penny, mentre gli abitanti della città dormono; ma fino ad allora il suo ritorno è stato silenzioso e discreto come la sua partenza. Adesso, invece, Brian lo sente muoversi nel soggiorno: Philip respira pesantemente e mormora qualcosa, che viene soffocato da rumori acquosi e dal clangore metallico di una catena. Brian scende dal letto e va in soggiorno. Rimane di ghiaccio quando vede Philip che tira Penny col suo guinzaglio, trascinandola sul pavimento come un cane recalcitrante. Per un breve istante, Brian resta ammutolito. Riesce solo a fissare il piccolo cadavere semovente coi suoi codini, il vestitino infangato e i piedi che lasciano tracce di sporcizia sul pavimento. Spera solo che sia in visita temporanea e, Dio non voglia, che non sia una nuova compagna di casa. VENTUNO “Che diavolo vuoi fare?” chiede Brian al fratello mentre la bambina morta artiglia l’aria con la sua famelica stupidità e posa gli occhi lattei su di lui. “Andrà tutto bene” dice Philip, trascinando la figlia morta verso la stanza sul retro. “Non vorrai…” “Pensa agli affari tuoi.” “Ma se qualcuno…” “Non mi ha visto nessuno” ribatte, spalancando con un calcio la porta del locale adibito a lavanderia. È una stanza piccola e claustrofobica, col pavimento in linoleum, le pareti di sughero, una lavatrice e un’asciugatrice fuori uso; la segatura di una vecchia lettiera per gatti riempie le fessure del pavimento. Philip trascina la cosa sbavante e ringhiosa in un angolo e attacca il guinzaglio alle tubature dell’acqua che corrono lungo la parete. Lo fa con la mano gentile ma ferma dell’addestratore di animali. Brian osserva dal corridoio, sconvolto da quella visione. Philip ha steso delle coperte sul pavimento e ha rivestito di nastro isolante gli angoli taglienti della lavatrice, per impedire alla cosa-Penny di fare rumore o di ferirsi. È ovvio che si preparava ormai da tempo. Deve averci pensato parecchio. Le infila intorno alla testa una cavezza di cuoio improvvisata, fatta con una cintura e pezzi del guinzaglio, e la attacca ai tubi. Sbriga quelle faccende col rigore gentile di un infermiere che mette in sicurezza la sedia a rotelle di un bambino disabile. Con una sbarra d’acciaio tiene il piccolo mostro alla distanza di un braccio, mentre assicura cauto i legacci al muro. Per tutto il tempo, la cosa che un tempo era una bambina ringhia, sbava e strattona le cinghie. Brian osserva. Non riesce a decidere se andarsene, piangere o urlare. Ha la sensazione di essere incappato in qualcosa di intimo, intimo in maniera disturbante, e per un breve istante la sua mente torna frenetica a quella volta in cui aveva diciotto anni ed era andato alla casa di riposo di Waynesboro per dire addio alla nonna morente. Non avrebbe mai dimenticato l’espressione sulla faccia dell’infermiere. Quasi ogni ora l’infermiere doveva pulire la merda dal sedere dell’anziana e l’espressione sulla sua faccia mentre lo faceva, coi parenti nella stanza, era orribile: un misto di disgusto, stoica professionalità, compassione e disprezzo. La stessa bizzarra espressione deforma ora i lineamenti di Philip Blake, intento ad allacciare le cinghie intorno alla testa del piccolo mostro e a evitare con cura la zona pericolosa intorno alle mascelle pronte a scattare. Le canta qualcosa con dolcezza mentre le infila le manette, una specie di ninna nanna stonata che Brian non riesce a identificare. Alla fine, Philip è soddisfatto. Accarezza teneramente la testa della cosaPenny e le bacia la fronte. Le mascelle della bambina scattano verso di lui, mancandogli la giugulare di pochi centimetri. “Ti lascio la luce accesa, pulcino” le dice Philip, parlando ad alta voce, come se si rivolgesse a uno straniero, prima di girarsi in tutta tranquillità e uscire dalla lavanderia, chiudendo bene a chiave la porta dietro di sé. Brian è nel corridoio, col sangue che gli scorre gelido nelle vene. “Ne vuoi parlare?” “Andrà tutto bene” ripete Philip, evitando di guardarlo negli occhi mentre si allontana, diretto verso la sua stanza. La parte peggiore è che il locale lavanderia è accanto alla camera da letto di Brian e così lui, da quel momento in poi, tutte le notti sente la cosa-Penny gemere, grattare, strattonare le catene. È un promemoria costante di… cosa? L’Armageddon? La follia? Brian non conosce nemmeno le parole per descriverlo. Inoltre la puzza è mille volte peggiore di quella dell’urina di gatto. E Philip passa un sacco di tempo chiuso dentro quella lavanderia con la bambina morta, facendo Dio solo sa cosa, il che scava un solco profondo fra i tre uomini. Ancora alle prese col dolore e con lo shock, Brian è dilaniato tra la compassione e la repulsione. Vuole ancora bene a suo fratello, ma questo è troppo. Nick non ha niente da dire sull’argomento, ma Brian capisce che lo spirito dell’amico è ormai spezzato. I silenzi si fanno più lunghi e Brian e Nick cominciano a trascorrere più tempo fuori dall’appartamento: si aggirano nella zona sicura, cominciando a conoscere meglio le dinamiche degli abitanti. Mantenendo un basso profilo, a zonzo per la periferia della piccola enclave di frontiera, Brian scopre che la città è praticamente divisa in due caste sociali. Il primo gruppo, quello col potere maggiore, include tutti coloro che svolgono un’attività o una professione utile. Quel primo gruppo comprende due muratori, un tornitore, un dottore, il proprietario di un’armeria, un veterinario, un idraulico, un barbiere, un meccanico di automobili, un contadino, un cuoco di cibi fritti e un elettricista. Il secondo gruppo, Brian pensa a loro come ai Dipendenti, raggruppa i malati, i giovani e tutti gli impiegati con un oscuro passato nell’amministrazione. Sono gli ex middle manager, i burocrati, i passacarte e i dirigenti d’azienda che un tempo incassavano stipendi a sei cifre, dirigendo divisioni di grandi multinazionali, e che ora occupano solo spazio, obsoleti come le musicassette. Con l’eco dei vecchi corsi di sociologia che gli risuona in fondo al cervello, Brian si chiede se quel debole, sgangherato assembramento di anime disperate si svilupperà mai in qualcosa di simile a una comunità. Il problema maggiore sembra costituito da tre membri della Guardia Nazionale che, giunti a Woodbury da una caserma vicina un paio di settimane prima, hanno preso a comandare la gente a bacchetta. Quella piccola cricca di delinquenti, i Bulli, come li soprannomina Brian, è guidata da un fanatico ex marine coi capelli a spazzola e gli occhi blu ghiaccio, che risponde al nome di Gavin (o “Il Maggiore”, come lo chiamano i suoi tirapiedi). Brian impiega solo un paio di giorni per inquadrare Gavin come un sociopatico affl itto da manie di potere e saccheggio. Forse l’epidemia lo ha fatto andare fuori di testa; nel corso della sua prima settimana a Woodbury, Brian vede Gavin e i suoi guerrieri della domenica strappare provviste dalle mani di famiglie impotenti e approfittare di parecchie donne, sotto la minaccia delle armi da fuoco e con la complicità della notte, dietro la pista. Brian si tiene alla larga a testa bassa. Durante quelle osservazioni silenziose sull’ordine gerarchico di Woodbury, continua a sentire il nome Stevens. Da quanto riesce a dedurre dalle conversazioni occasionali con gli abitanti della città, questo tale Stevens un tempo era un otorinolaringoiatra, che aveva uno studio nei sobborghi di Atlanta. Dopo la svolta, era andato alla ricerca di pascoli più sicuri; apparentemente era solo, forse in seguito a un divorzio. Il buon dottore si era presto imbattuto nell’eterogeneo gruppo di sopravvissuti di Woodbury. Alla vista dei malconci abitanti stretti nella morsa delle malattie, della malnutrizione e di ferite non curate, Stevens aveva deciso di offrire i suoi servizi. Da allora aveva sempre avuto il suo bel da fare: esercitava nell’ex Meriwether County Medical Center, a tre isolati dalla pista. Nel pomeriggio del suo settimo giorno a Woodbury, Brian che, a ogni respiro sibilante avverte come una pugnalata di dolore nel fianco, trova finalmente il coraggio per recarsi nel tozzo edificio di mattoni grigi sul confine sud della zona sicura. “Sei fortunato” dice Stevens, attaccando una lastra a una pinza sul pannello illuminato. Indica un’immagine lattiginosa delle costole di Brian. “Nessuna rottura seria… solo tre fratture minori alla seconda, quarta e quinta costola.” “Fortunato, eh?” mormora Brian, seduto senza camicia sul lettino imbottito. La stanza è una deprimente cripta piastrellata nel seminterrato del centro medico: una volta era il laboratorio di anatomia patologica e adesso Stevens la utilizza come ambulatorio. L’aria puzza di disinfettante e muffa. “È una parola che non ho usato molto spesso negli ultimi tempi, lo ammetto” dice Stevens, girandosi verso un immacolato armadietto d’acciaio accanto al pannello luminoso. È un uomo alto, snello, ben curato, più vicino ai cinquanta che ai quaranta, con occhiali dalla montatura d’acciaio che tiene bassi sul naso. Indossa un camice da laboratorio sopra una camicia Oxford spiegazzata e mostra una sorta di intelligenza stanca e autorevole negli occhi. “E il sibilo?” chiede Brian. Il dottore rovista in un ripiano di fiale di plastica. “Il primo stadio di una pleurite causata dal danno alle costole” borbotta, mentre cerca tra i medicinali. “Ti incoraggio a tossire il più possibile… farà male, ma impedirà alle secrezioni di raccogliersi nei polmoni.” “E l’occhio?” Negli ultimi giorni il dolore lancinante all’occhio sinistro, che si irradia verso l’alto dalla mascella ammaccata, è peggiorato. Ogni volta che Brian si guarda allo specchio, lo vede sempre più iniettato di sangue. “Mi sembra che vada bene” risponde il dottore, prendendo una bottiglietta di pillole dal ripiano. “La mandibola, invece, ha una brutta contusione, ma dovrebbe guarire entro breve. Ti darò un po’ di Naprossene per il dolore.” Stevens gli passa la fiala e poi resta lì, con le braccia incrociate sul petto. Brian allunga quasi involontariamente la mano verso il portafogli. “Non sono sicuro di avere…” “I servizi resi qui non si pagano” dice il dottore inarcando un sopracciglio, in un certo senso confuso dal gesto istintivo di Brian. “Non ci sono staff, infrastrutture, assistenza supplementare e, per quello che conta, non c’è nemmeno una tazza di espresso decente o uno stupido quotidiano da leggere.” “Oh… bene.” Brian si mette le pillole in tasca. “E riguardo all’anca?” “Ammaccata ma intatta” dice, spegnendo il panello luminoso e chiudendo l’armadietto. “Io non mi preoccuperei. Puoi rimetterti la maglia, adesso.” “Bene… grazie.” “Non sei un gran chiacchierone, vero?” Il dottore si lava le mani in un lavandino a muro, asciugandole su un asciugamano sporco. “Immagino di no.” “Forse è meglio così” dice il dottore, appallottolando l’asciugamano e gettandolo nel lavandino. “Probabilmente non vorrai nemmeno dirmi il tuo nome.” “Beh…” “Non c’è problema. Lascia perdere. Sarai registrato come il Tizio Bohémien con le costole rotte. Vuoi dirmi cosa ti è successo?” Brian scrolla le spalle, mentre si allaccia la camicia. “Sono caduto.” “Combattendo contro gli esemplari?” Brian lo guarda. “Esemplari?” “Scusa… clinicamente parlando. Azzannatori, zombie, sacchi di pus, o come li chiamano al momento. È così che ti sei ferito?” “Sì… una cosa del genere.” “Vuoi un parere professionale? Una prognosi?” “Certo.” “Vattene, finché puoi.” “E perché mai?” “La teoria del caos.” “Scusi?” “L’entropia… gli imperi cadono, le stelle si spengono… i cubetti di ghiaccio del tuo drink si sciolgono.” “Scusi, non la seguo.” Il dottore si spinge gli occhiali sul naso. “C’è un crematorio nei sotterranei di questo edificio… abbiamo distrutto altri due uomini oggi, uno era il padre di due bambini. Sono stati attaccati ieri mattina nella zona nord. Si sono rianimati la scorsa notte. E continuano a passare altri azzannatori… la barricata è un colabrodo. La teoria del caos sostiene l’impossibilità per un sistema chiuso di rimanere stabile. Questa città è condannata. Non c’è nessuno al comando… Gavin e i suoi amichetti diventano sempre più sfrontati… e tu, amico mio, sei solo un altro pezzo di carne da cannone.” Per un lungo momento, Brian non dice niente, limitandosi a guardare oltre. Alla fine, si costringe a scendere giù dal lettino e allunga la mano. “Lo terrò a mente.” Quella notte, intontito dagli antidolorifici, Brian Blake sente bussare alla porta della sua camera da letto. Prima ancora che abbia la possibilità di orientarsi e accendere la luce, la porta si apre e Nick caccia dentro la testa. “Brian, sei sveglio?” “Sempre” grugnisce Brian, mentre esce da sotto le coperte e si siede sul bordo del letto. Solo alcune prese dell’appartamento sono collegate alla corrente elettrica. La stanza di Brian ha un circuito morto. Accende una lanterna a batteria e vede Nick che si infila dentro la stanza, tutto vestito, con un’espressione tesa per la paura. “Devi vedere una cosa” dice Nick, che va alla finestra e sbircia dalla veneziana. “L’ho visto anche ieri notte, ma non ci ho fatto troppo caso.” Ancora intontito, Brian raggiunge Nick alla finestra. “Cosa?” Attraverso le stecche, nel buio di un terreno incolto, vedono la sagoma di Philip emergere dagli alberi lontani. Nell’oscurità sembra quasi una figura stilizzata. Dalla morte di Penny, ha perso peso, continua a non dormire e mangia appena. Sembra malato, a pezzi, come se i jeans sbiaditi fossero l’unica cosa che tiene insieme il suo corpo lungo e allampanato. Ha con sé un secchio e cammina con una strana rigidità, come un sonnambulo o un automa. “Cosa c’è nel secchio?” chiede piano Brian, quasi retoricamente. “Hai fatto centro.” Nick si gratta nervoso. “Ce l’aveva anche ieri notte.” “Non ti agitare, Nick. Resta qui.” Brian spegne la lanterna. “Stiamo a vedere cosa succede.” Pochi istanti dopo, il rumore della porta d’ingresso che si apre risuona nell’appartamento buio. Sentono il passo strascicato di Philip attraversare il soggiorno e percorrere il corridoio. Lo scatto della porta della lavanderia è seguito dagli strepiti di Penny, che comincia ad agitarsi e a far sferragliare la catena, coi grugniti ai quali Brian e Nick si sono ormai quasi abituati. Poi qualcosa raggiunge le loro orecchie, qualcosa che non avevano mai sentito prima: il rumore umido di qualcosa che cade sul pavimento… seguito dagli strani, animaleschi versi di uno zombie che mangia. “Che cazzo fa?” Nella luce incerta, la faccia di Nick è una pallida, gibbosa luna di terrore. “Cristo Santo” sussurra Brian. “Non può essere…” Brian non riesce nemmeno a terminare la frase, perché Nick si è già incamminato verso la porta a tutto spiano, diretto verso il corridoio. Brian lo insegue. “Nick, non…” “Non è possibile.” Nick sfreccia lungo il corridoio, verso la lavanderia. Bussa alla porta. “Philip, cosa succede?” “Va’ via!” Il suono ovattato della voce di Philip è soffocato dall’emozione. “Nick…” Brian cerca di mettersi in mezzo tra Nick e la porta, ma è troppo tardi. Nick gira la maniglia. La porta non è chiusa a chiave. Nick entra nella lavanderia. “Oh, Dio.” La reazione scoraggiata di Nick giunge alle orecchie di Brian, appena un attimo prima che possa dare un’approfondita occhiata a quello che succede nella lavanderia. Brian si fa largo nella stretta apertura e vede la bambina morta che mangia una mano umana. La reazione iniziale di Brian non è di repulsione, disgusto oppure oltraggio (che è, invece, l’esatta combinazione di emozioni che contorcono i lineamenti di Nick di fronte a quella vista). Brian è sopraffatto da un’ondata di tristezza. Non dice niente, si limita a guardare suo fratello accovacciato davanti al piccolo cadavere che si muove. Ignorando la presenza degli altri uomini, in tutta calma, Philip prende dal secchio un orecchio umano reciso e aspetta pazientemente che la cosa-Penny finisca di consumare la mano. Si ingozza delle dita di un uomo di mezz’età con gusto sfrenato e mastica le nocche senza peli come fossero prelibatezze, con fili di saliva rosa e schiumosa che le pendono dalle labbra. Si ferma appena per inghiottire, prima che Philip piazzi l’orecchio a portata dei suoi denti anneriti, offrendole il boccone con l’attenzione e la cura con cui un sacerdote porge l’ostia a un fedele. La cosa-Penny divora cartilagine e rotoli di pelle umana con incurante abbandono. “Io me ne vado” dice Nick Parsons alla fine, girando su se stesso e precipitandosi fuori dalla stanza. Brian entra e si accovaccia accanto al fratello. Non alza la voce. Non lo accusa di niente. In questo momento, Brian è sommerso dal dolore e l’unica cosa che riesce a dire è: “Che succede, fratello?”. Philip si prende la testa tra le mani. “Era già morto… volevano bruciarlo… ho trovato il suo corpo in una sacca dietro la clinica… è morto di qualcos’altro… ho preso solo qualche pezzo… non se ne accorgerà nessuno…” La cosa-Penny finisce l’orecchio ed emette versi per avere altro cibo. Philip le porge un piede amputato e gocciolante: l’osso spezzato fuoriesce dalla caviglia come una viscida zanna d’avorio. “Pensi che sia…?” Brian cerca le parole. “Pensi che sia una buona idea?” Philip abbassa lo sguardo sul pavimento, mentre i rumori viscidi del pasto riempiono frenetici la lavanderia. La cosa-bambina rosicchia l’osso, mentre la voce di Philip si abbassa di un’ottava, spezzata dall’emozione. “Pensa a lui come a un donatore di organi…” “Philip…” “Non posso lasciarla andare, Brian… non ci riesco… è tutto quello che mi resta.” Brian fa un respiro profondo e lotta contro le sue stesse lacrime. “Il fatto è che quella cosa… non è più Penny.” “Lo so.” “Allora perché…” “La vedo e cerco di ricordare… ma non ci riesco… non riesco a ricordare… non riesco a ricordare nient’altro che la tempesta di merda in cui viviamo… e quei bastardi che le hanno sparato… lei è tutto quello che mi resta…” Il dolore e la pena gli strozzano la voce, la rendono più rauca, la induriscono in qualcosa di più tenebroso. “Me l’hanno portata via… tutto il mio universo… ci sono nuove regole ora… nuove regole…” Brian non riesce a respirare. Osserva la cosa-Penny rosicchiare l’appetitoso piede amputato. Distoglie lo sguardo. Non riesce a sopportare oltre. Ha lo stomaco serrato dalla nausea, la bocca piena di saliva. Sente qualcosa risalirgli in gola e si affretta a rimettersi in piedi. “Io devo… non posso restare qui, Philip… devo andare.” Si gira di scatto, esce incespicando e arriva a metà del corridoio prima di cadere in ginocchio e vomitare. Il suo stomaco è relativamente vuoto. Quanto ne esce è perlopiù bile. Ma esce tra spasmi d’agonia. I conati si susseguono e l’acido schizza su quasi due metri di tappeto tra il corridoio e il soggiorno. Vomita anche l’anima, madido di sudore freddo in tutto il corpo; poi lo coglie un attacco di tosse parossistica. L’attacco prosegue per minuti che sembrano eterni: ogni colpo di tosse risuona doloroso nelle sue costole. Continua a tossire fin quando, finalmente, non si accascia sul pavimento. A cinque metri da lui, alla luce della lanterna a batteria, Nick Parsons prepara il suo zaino. Ficca dentro un cambio d’abiti, un paio di scatole di fagioli, coperte, una torcia elettrica, un po’ d’acqua imbottigliata. Cerca qualcosa sul tavolino da caffè in disordine. Brian riesce a mettersi a sedere e si pulisce la bocca col dorso della mano. “Non puoi andartene, amico… non adesso.” “Col cavolo che non posso” dice Nick, trovando la sua Bibbia sotto un mucchio di involucri di caramelle. La mette nello zaino. I rumori soffocati del pasto si diffondono lungo il corridoio, alimentando l’agitazione di Nick. “Ti imploro, Nick.” Nick chiude le cerniere dello zaino. Evita di guardare Brian, mentre dice: “Non hai bisogno di me…”. “Non è vero.” Brian deglutisce il sapore amaro della bile. “Adesso ho bisogno di te più che mai… mi serve il tuo aiuto… per tenere le cose insieme.” “Insieme?” Nick alza lo sguardo. Si infila lo zaino sulle spalle e oltrepassa il punto del pavimento dove Brian è piegato. “Qui le cose non sono più insieme da un sacco di tempo.” “Nick… Ascoltami…” “Si è spinto troppo oltre, Brian.” “Ascolta. Capisco quello che intendi dire. Dagli un’ultima possibilità. Forse non lo farà più. Forse… non lo so… è il dolore. Un’ultima possibilità, Nick. Abbiamo più probabilità di sopravvivere se restiamo insieme.” Per un lungo, agonizzante momento, Nick considera tutto quanto. Poi, con un sospiro esasperato e stanco, che sembra avvilire il suo stesso spirito, lascia cadere lo zaino. Il giorno dopo, Philip scompare. Brian e Nick non si preoccupano nemmeno di andarlo a cercare. Restano dentro per gran parte della giornata, si parlano appena, si sentono zombie loro stessi, si muovono in silenzio dal bagno alla cucina, al soggiorno, dove siedono per guardare fuori dalla finestra sbarrata il cielo tempestoso, in cerca di una risposta, un modo per uscire da quella spirale discendente. Verso le cinque del pomeriggio, sentono uno strano ronzio provenire dall’esterno, un misto tra una sega elettrica e un fuoribordo. Brian teme che possa avere a che fare con Philip; va alla porta sul retro, ascolta, poi esce e fa qualche passo sul cemento crepato del portico posteriore. Il rumore è più forte. In lontananza, sulla parte nord della città, un nuvolone di polvere si alza nel cielo grigio come l’acciaio. Si sentono i motori sputacchiare il loro ululato, che si alza e si abbassa nella brezza. Con un’ondata di sollievo, Brian comprende che si tratta di qualcuno che guida un’auto da corsa nella vecchia pista polverosa. Di tanto in tanto, il suono delle acclamazioni risuona ed echeggia nel vento. Per un momento, Brian è assalito dal panico. Quegli idioti non sanno che quel frastuono attirerà tutti gli azzannatori nel raggio di ottanta chilometri? Nello stesso tempo, però, è ammaliato da quel ronzio da sega elettrica, che aleggia nella brezza. Come un segnale radio vagante nell’etere, tocca qualcosa di doloroso dentro di lui, un rimpianto per i tempi pre-epidemia, il ricordo penoso di pigri pomeriggi domenicali, di una buona notte di sonno, del semplice gesto di entrare in una dannata drogheria e comprare una fottuta confezione di latte. Torna dentro, si infila il giubbotto e dice a Nick che va a fare una passeggiata. L’entrata della pista confina con la strada principale, un’alta barriera anticiclone tesa fra due pile di mattoni. Brian si avvicina e vede cumuli di immondizia e vecchi pneumatici gettati davanti a un botteghino malconcio, sbarrato da tavole coperte di graffiti. Il rumore spacca i timpani: sono le urla acute dei motori e i miagolii della folla, contaminati dagli odori della benzina e della gomma bruciata. Il cielo è coperto da un alone di fumo e polvere. Brian si dirige verso un buco nella recinzione, quando sente una voce. “Ehi!” Si ferma, si volta e vede tre uomini, vestiti di logore tute mimetiche, che vengono verso di lui. Due sono sulla ventina; hanno i capelli lunghi e unti, e fucili d’assalto alti contro le spalle, come se fossero di pattuglia. Il più anziano, un duro coi capelli a spazzola, un giubbotto verde militare abbottonato e una cartucciera che gli attraversa il petto, cammina davanti agli altri, ovviamente è lui a comandare. “L’ingresso costa quaranta dollari o l’equivalente in natura” dice il comandante. “Ingresso?” replica Brian, sorpreso. Sul taschino dell’uomo più anziano vede una targhetta con un nome: MAGG. GAVIN. Finora, Brian ha visto l’ufficiale della Guardia Nazionale solo di sfuggita, ma adesso, a quella distanza, scorge un riflesso di follia nei suoi occhi blu. Il suo alito sa di Jim Beam. “Quaranta dollari per un adulto, figliolo… tu sei un adulto?” Gli altri uomini ridacchiano. “I bambini entrano gratis, naturalmente, ma mi sembra che tu abbia passato i diciott’anni. Appena appena.” “Prendete soldi alla gente?” Brian è confuso. “Di questi tempi?” “Sei libero di pagare in natura, amico. Hai un pollo? Qualche numero di Penthouse su cui ti sei fatto una sega?” Altre risatine. Le viscere di Brian diventano gelide di rabbia. “Non ho quaranta dollari.” Il sorriso sparisce dalla faccia del Maggiore come se si fosse spento un interruttore. “Allora buona giornata.” “A chi vanno i soldi?” Quella domanda attira l’attenzione degli altri due uomini della Guardia. Si avvicinano. Gavin si mette naso a naso con Brian e con un grugnito basso e minaccioso dice: “Sono per la comunità”. “Cosa?” “La comunità… la collettività… il progresso della cittadinanza e così via.” Brian sente una scarica di furia bruciargli dentro. “Sei sicuro che non sia per la collettività di voi tre?” “Mi dispiace” dice il Maggiore in un tono piatto e gelido. “Devo aver perso il promemoria che diceva che sei il nuovo ufficiale di stato civile. Voi ragazzi avete ricevuto il promemoria che diceva che questo saltapicchio è il nuovo ufficiale di stato civile di Woodbury?” “No, signore” risponde uno dei tirapiedi dai capelli unti. “Mai ricevuto.” Gavin estrae una .45 semiautomatica dalla fondina, toglie la sicura e appoggia la canna sulla tempia di Brian. “Hai bisogno di ripassare le dinamiche di gruppo, figliolo. Hai saltato le lezioni di educazione civica al liceo?” Brian non dice niente. Guarda il Maggiore negli occhi e una lente rossa gli cala sulla vista. Tutto diventa rosso. Le sue mani cominciano a formicolare, la testa pulsa. “Fai ‘ahh’” dice il Maggiore. “Cosa?” “HO DETTO: APRI LA TUA DANNATA BOCCA!” ruggisce Gavin e gli altri due soldati della Guardia si mettono in posizione coi fucili d’assalto e le canne puntate alla testa di Brian. Brian apre la bocca e Gavin gli infila la canna gelata della .45 tra i denti come un dentista a caccia di carie. Dentro Brian qualcosa si spezza. La canna d’acciaio sa di monetine vecchie e olio amaro. Il mondo intero diventa di un intenso colore scarlatto. “Torna da dove sei venuto” dice il Maggiore. “Prima di farti male.” Brian riesce a fare un cenno d’assenso. La canna gli scivola fuori dalla bocca. Come in un sogno, Brian si allontana lento dai soldati della Guardia, indietreggia, si gira e si incammina rigido sulla strada da cui è venuto, muovendosi in mezzo a una invisibile nebbia scarlatta. Quella sera, verso le sette, è nell’appartamento, da solo, ancora infagottato nel suo giubbotto, in piedi davanti alla finestra sbarrata sul retro del soggiorno, e guarda la luce del giorno affievolirsi, mentre nella sua testa i pensieri impazzano come onde contrarie che si schiantano contro un frangiflutti. Si copre le orecchie. Il rumore soffocato e martellante dello zombie in miniatura nella stanza accanto alimenta il suo stato confusionale, come la puntina che si incanta su un disco: Brian affonda sempre più dentro se stesso. Sulle prime, registra appena il suono di Nick di ritorno da chissà dove, i passi strascicati e lo scatto dell’anta dell’armadio. Ma quando sente un brontolio smorzato provenire dal corridoio, esce di colpo dal suo stato di trance e va a indagare. Nick fruga nell’armadio in cerca di qualcosa. Il suo logoro giubbotto di nylon è bagnato, le scarpe da ginnastica sono infangate e borbotta piano: “‘Alzo gli occhi verso i monti… Da dove arriverà l’aiuto…? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra’”. Brian vede Nick prendere il fucile a pompa dall’armadio. “Nick, cosa vuoi fare?” Nick non risponde. Apre di scatto il meccanismo a pompa del fucile e controlla la culatta. È vuota. Cerca convulsamente sul fondo dell’armadio e trova l’unica scatola di cartucce, che sono riusciti a nascondere per tutto il viaggio dalla villa a Woodbury. Continua a borbottare: “‘Il Signore ci preserverà da ogni male… proteggerà le anime nostre…’”. Brian fa un passo verso di lui. “Nick, che diavolo succede?” Ancora nessuna risposta. Nick prova a inserire una cartuccia con le mani tremanti, ma la cartuccia cade e rotola sul pavimento. A tentoni, ne infila un’altra nella culatta e poi mette la pompa in posizione con uno scatto. “‘Colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà…’” “Nick!” Brian afferra la spalla dell’uomo e lo costringe a voltarsi. “Che cazzo c’è che non va?” Per un momento, sembra quasi che Nick stia per girare il fucile e far saltare la testa di Brian, mentre un’espressione di puro furore gli deforma il volto. Poi riprende il controllo, deglutisce, guarda Brian e dice: “Non può andare avanti così”. Senza aggiungere altro, si volta ed esce a passo di marcia dalla stanza e dalla porta principale. Brian afferra la .38, la infila nella cintura e corre dietro a Nick. VENTIDUE La luce viola del tramonto si diffonde sul paesaggio. Venti gelidi scuotono gli alberi lungo i margini del bosco ai limiti di Woodbury. Nell’aria turbinano gli odori del fumo della legna e del monossido di carbonio, come pure i sibili incessanti delle macchine da corsa che provengono dal centro della città. Le strade sul retro sono quasi deserte, la maggior parte degli abitanti è alla corsa… ma anche così, è un miracolo che nessuno veda Brian e Nick correre sul terreno incolto al confine della zona sicura. Nick prega furiosamente mentre si dirige verso il bosco, con il fucile a pompa appoggiato sulla spalla come una specie di randello sacro. Brian continua ad afferrarlo per rallentarlo, per farlo smettere, almeno per un secondo, con quella dannata preghiera e farlo parlare come una persona normale, ma Nick è guidato da una qualche febbrile intenzione. Alla fine, quando sono ormai vicini al margine del bosco, Brian strattona il giubbotto di Nick con forza e per poco non lo fa cadere. “Che cazzo fai?” Nick si gira e rivolge a Brian uno sguardo duro. “L’ho visto prendere una ragazza là fuori.” La voce di Nick è incerta e sull’orlo delle lacrime. “Philip?” “Non può andare avanti così, Brian…” “Quale ragazza?” “Una della città, l’ha presa con la forza. Qualsiasi cosa faccia deve finire.” Brian studia il mento tremante di Nick, che ha gli occhi pieni di lacrime. Fa un respiro profondo. “Okay, calmati un secondo, calmati.” “Ha le tenebre dentro di sé, Brian. Lasciami andare. Questa cosa deve finire.” “Lo hai visto prendere una ragazza, ma non hai…” “Lasciami stare, Brian.” Per un momento, Brian si limita a restare lì, con le mani ancora strette intorno alla manica di Nick. La pelle d’oca gli increspa la schiena, il suo petto si raffredda. Rifiuta di accettarlo. Dev’esserci un modo per rimettere le cose in carreggiata, per riportarle sotto controllo. Alla fine, dopo una pausa straziante, Brian guarda Nick e dice: “Mostramelo”. Nick lo conduce lungo un sentiero stretto e trascurato, che serpeggia attraverso un bosco ceduo di alberi di noce. Invaso dalla cicuta e dalla veronica glauca, il sentiero è già ammantato di ombre. Il tramonto è vicino, la temperatura è in picchiata. I rovi e le spine strappano i loro giubbotti, mentre si affrettano verso un varco nel fogliame. Sulla destra, attraverso un traliccio di foglie, vedono il margine meridionale del cantiere, dove è in costruzione una nuova sezione della barricata di legno. Nelle vicinanze ci sono pile di legname. Il bulldozer riposa nel buio. Nick indica la radura più avanti. “È qui” sussurra, mentre si avvicinano a un albero caduto sul confine della radura. Nick si lascia scivolare a terra dietro il tronco, con l’aria di un bambino isterico che gioca a fare il soldato. Brian si accuccia accanto a lui e sbircia oltre l’albero marcio. A circa venti metri di distanza, in un affossamento naturale del terreno coperto di muschio, sormontato da una tettoia di vecchie querce e pini dai lunghi aghi, scorgono Philip Blake. Il terreno è rivestito da una gran quantità di aghi di pino, funghi, erbacce e un debole bagliore di metano aleggia nel sottobosco, come una spettrale foschia color magenta che conferisce alla radura un aspetto quasi mistico. Nick solleva il fucile. “Mio Signore” borbotta piano “ti prego: purificaci da tutte queste ingiustizie…” “Nick, fermati” sussurra Brian. “Rinuncio a tutti i peccati” continua a cantilenare Nick, a bocca aperta davanti all’orrore nella radura. “Ti offendono, oh Signore…” “Sta’ zitto, sta’ solo zitto!” Brian cerca di dare un senso a tutto. Nell’ombra è difficile capire cosa stanno guardando. A prima vista, sembra che Philip sia inginocchiato tra i rovi, intento a incaprettare un maiale. Il suo giubbotto di jeans è fradicio di sudore e con vari rami di piante dotate di spine attaccati: l’uomo avvolge una corda intorno ai polsi e alle caviglie di una figura che si dimena sotto di lui. Una gelida esplosione di orrore travolge Brian quando realizza che quella sul terreno è indubbiamente una giovane donna, con la camicetta strappata e la bocca imbavagliata con una corda di nylon. “Gesù Cristo, ma che diavolo sta…” Nick continua a farfugliare sottovoce: “Perdonami, Signore, per quanto sto per fare e, con l’aiuto della Tua grazia, servirò la Tua volontà…” “Sta’ zitto, cazzo!” La mente di Brian è sul punto di scoppiare. Stretto nella morsa del panico, azzarda le ipotesi più disperate: Philip vuole stuprare quella povera donna oppure ucciderla e darla in pasto a Penny? Bisogna fare qualcosa e bisogna agire alla svelta. Nick ha ragione. Ha sempre avuto ragione. Dev’esserci un modo per fermare tutto questo prima che… Accanto a Brian qualcosa si muove. Nick salta oltre l’albero caduto e si fa largo tra i rampicanti, diretto verso la radura. “Nick, aspetta!” Brian è in mezzo ai rovi, quando vede il quadro mortale che si dispiega nella radura tenebrosa, come uno schieramento di giocatori che si mettono in posizione al rallentatore su una scacchiera surreale, come in un sogno. Nick barcolla col fucile puntato su Philip, che sorpreso dall’improvviso grido d’allarme di Brian scatta in piedi. Disarmato, sposta nervoso lo sguardo dalla donna che si contorce al borsone posato sui funghi velenosi accanto a lei e alza le mani. “Metti giù quel dannato affare, Nicky.” Nick alza il fucile finché non inquadra Philip nel mirino. “Il Diavolo ha messo i suoi artigli su di te, Philip. Hai peccato contro Dio… hai profanato il Suo nome. È tutto nelle mani del Signore ormai.” Brian entra vacillando nella radura, armeggia per prendere la sua .38, in iperventilazione per l’adrenalina. “Nick, no! NON FARLO!” Con la mente in preda al panico, si ferma tre metri dietro Nick. Nel frattempo, la ragazza stesa al suolo è riuscita a girarsi, ancora legata e imbavagliata, e piange sul terreno umido, come se sperasse che la terra si spalanchi per farla sprofondare e morire. Intanto, Nick e Philip sono a sei metri l’uno dall’altro, ognuno con lo sguardo fisso negli occhi dell’altro. “Cosa sei, l’angelo vendicatore?” chiede Philip al suo vecchio amico. “Forse sì.” “Questa cosa non ti riguarda, Nicky.” Nick trema per l’emozione, i suoi occhi respingono le lacrime. “C’è un posto migliore per te e tua figlia, Philly.” Philip resta immobile come una statua di pietra: la sua faccia rigida e segnata sembra grottesca nella debole luce. “E immagino che sarai tu a mandare me e Penny verso la Gloria!” “Qualcuno deve fermare tutto questo, Philly. Tanto vale che lo faccia io.” Nick avvicina il mirino all’occhio e mormora: “Signore, ti prego, perdonami…”. “Nick, aspetta! Ti prego, ti prego! Ascoltami!” Brian gli gira attorno con la .38 puntata in alto come uno starter. Arriva a pochi centimetri da Nick, che continua a tenere gli occhi fissi su Philip. Brian balbetta: “Tutti gli anni a cazzeggiare per tutta Waynesboro, tutte le risate che vi siete fatti, tutta la strada che avete fatto… non conta niente? Philip ci ha salvato la vita! Le cose gli sono sfuggite di mano, è vero. Ma possiamo aggiustarle. Metti giù il fucile, Nick. Ti scongiuro.” Nick trema. Continua a tenere lo sguardo fisso. La sua fronte si imperla di sudore. Philip si avvicina di un passo. “Non ti preoccupare, Brian. Nicky è sempre stato un chiacchierone. Non ha il fegato di sparare a qualcuno che è ancora vivo.” Nick trema furioso. Brian osserva, paralizzato dall’incertezza. Con calma, Philip si allunga verso la ragazza, la afferra per il colletto e la solleva in piedi come se fosse un bagaglio qualunque. Si volta e comincia a trascinarla verso il lato opposto della radura. La voce di Nick si abbassa di un’ottava. “Abbi pietà di tutti noi.” Il cane del fucile scatta all’improvviso. E la bocca ruggisce. Un fucile calibro .12 è uno strumento impreciso. La rosa dei letali pallettoni calibro .33 può diffondersi per circa trenta centimetri di larghezza a breve distanza, lacerando il bersaglio con forza sufficiente a penetrare in un mattone di cemento. Lo sparo che colpisce Philip alla schiena perfora la carne delle scapole e i tendini del collo: metà del cervello fuoriesce dalla gola. I pallettoni fanno saltare anche un lato della testa della ragazza, uccidendola all’istante. I due corpi sono scagliati in aria in una nuvola di nebbia rosa. Rotolano aggrovigliati l’uno all’altra, prima di finire stesi, fianco a fianco, nel sottobosco, con braccia e gambe spalancate. La ragazza è già morta e immobile, ma Philip si contorce negli spasmi dell’agonia per parecchi secondi. La sua faccia è rivolta verso l’alto, congelata in una maschera di assoluta sorpresa. Cerca di respirare, ma il danno al cervello sta spegnendo tutte le sue funzioni. Per lo shock di quanto è appena successo, Nick Parsons cade in ginocchio, con le dita ancora paralizzate sul grilletto e il fucile che sfrigola di calore. Il suo campo visivo si restringe, mentre resta a bocca aperta davanti al danno inflitto ai due corpi umani sulla traiettoria dello sparo. Lascia cadere il fucile sull’erba e muove la bocca senza emettere suono. Cos’ha fatto? Si sente contrarre come un seme nel baccello, freddo e desolato, col fragore metallico dell’Armageddon che gli risuona nelle orecchie e le roventi lacrime di vergogna che gli colano a fiotti lungo la faccia: cos’ha fatto? Cos’ha fatto? Cos’ha fatto? Brian Blake diventa di ghiaccio. Le sue pupille si dilatano. La vista di suo fratello, che giace a terra in un ammasso insanguinato accanto alla ragazza morta, si stampa per sempre nel suo cervello. Tutti gli altri pensieri escono dalla sua mente. Solo il rumore dei gemiti acuti di Nick penetra il suo torpore. Nick, che adesso singhiozza e ulula, è ancora in ginocchio accanto a Brian. La razionalità e la sanità mentale sono scomparse dalla sua faccia, mentre miagola alla vista del massacro. Scoppia in raffiche di borbottii che escono insieme a fili di muco e suonano a tratti come preghiere e a tratti come folli suppliche; il suo respiro è visibile nel gelido crepuscolo. Alza gli occhi al cielo. Brian solleva la .38 senza pensare, guidato da una scarica di rabbia psicotica, e spara un unico colpo, a bruciapelo, su un lato del cranio di Nick Parsons. La spinta scaglia Nick in uno schizzo di fluido rosso: la pallottola gli squarcia il cervello, uscendo dall’altro lato e conficcandosi in un albero. Nick si incurva con gli occhi rovesciati all’indietro: è già morto. Cade a terra, come un bambino che va a dormire arrendendosi al sonno. Il passare del tempo perde ogni significato. Brian non scorge le sagome scure che si avvicinano tra gli alberi lontani, attirate dal rumore. E nemmeno è consapevole del movimento che compie attraverso la radura per raggiungere i corpi straziati. Ma in qualche modo, finisce sul terreno accanto a Philip, a cullare in grembo la sagoma insanguinata di suo fratello. Abbassa lo sguardo sulla faccia grigia di Philip, pallida come alabastro e sporca di sangue. Una scintilla di vita brilla ancora nel suo sguardo, mentre gli occhi dei due fratelli si incontrano. Per un breve istante, Brian si ritrae davanti alla gelida scheggia di tormento che lo trafigge: la connessione tra i due fratelli, densa come il sangue, profonda come la terra, gli squarcia l’anima con la potenza delle placche tettoniche che si spostano. Il peso della loro storia, il tedio infinito delle lezioni di grammatica, le benedette vacanze estive, le chiacchiere sussurrate nel letto a castello a tarda notte, le prime birre durante quello sfortunato campeggio sugli Appalachi, i segreti, le lotte, i sogni da provinciali vanificati dalle crudeli macchinazioni della vita: tutto taglia a pezzi la sua anima. Brian piange. Le sue grida, stridule e acute come quelle di un animale in trappola, risuonano nel cielo che si oscura e si mischiano ai sibili lontani delle macchine da corsa. Singhiozza forte e non si accorge nemmeno dell’attimo in cui Philip muore. Quando torna ad abbassare lo sguardo su suo fratello, la faccia di Philip si è indurita fino a diventare una scultura di marmo bianco. A cinque o sei metri di distanza il fogliame trema. Almeno una dozzina di azzannatori di tutte le forme e le taglie si fanno strada attraverso il fitto del bosco. Il primo, un maschio adulto in logori abiti da lavoro, sbuca tra i rami con le braccia tese verso il nulla e gli occhi a bottone che scandagliano la radura. La cosa fissa il suo sguardo sul pasto più vicino: il cadavere di Philip che si raffredda. Brian Blake si alza e se ne va. Non può restare a guardare. Sa che è la scelta migliore. L’unica. Lasciare che gli zombie ripuliscano il casino. Infila di nuovo la .38 nella cintura e si dirige verso il cantiere. Trova posto in cima alla cabina di un camion, dove aspetta con calma che la frenesia alimentare finisca. La sua mente è una televisione sintonizzata su troppe stazioni insieme. Estrae la pistola e la stringe come la coperta di Linus. La cacofonia di voci, i frammenti di immagini formate a metà, tutto crepita e tremola dentro la sua testa. Il crepuscolo è diventato buio pesto: le luci più vicine sono a centinaia di metri di distanza. Ma adesso Brian vede il mondo che lo circonda con la nitidezza del negativo di una foto e la sua paura è affilata come la lama di un coltello. È solo adesso… solo com’è sempre stato… e ciò lo dilania più a fondo di quanto qualsiasi zombie potrebbe mai fare. I risucchi umidi e gorgoglianti che giungono dalla radura si odono appena sopra il ronzio costante delle macchine da corsa. Da qualche parte, tra i pensieri febbrili della sua mente, Brian capisce che il frastuono della pista copre i rumori della radura e che probabilmente questo faceva parte del piano di Philip: il rapimento della ragazza sarebbe passato inosservato. In mezzo ai merletti dei rovi e del fogliame, scorge le sagome dei mostri che fanno a pezzi i resti umani lasciati nella radura. Sciami di zombie chini sulla preda, come scimmie, si ingozzano di pezzi di carne, ossa gocciolanti sangue, brandelli di pelle, scalpi strappati, appendici non identificate e organi ancora caldi che mandano vapore nell’aria fredda. Ne arrivano degli altri e spingono goffi quelli che già c’erano, grugnendo alla ricerca di un boccone. Brian chiude gli occhi. Per un momento, si chiede se dovrebbe pregare. Si chiede se recitare un elogio silenzioso per suo fratello, Nick, la donna, Penny, Bobby Marsh, David Chalmers, per i morti, i vivi e per tutto quel mondo guasto, fottuto e dimenticato da Dio. Ma non lo fa. Si limita a stare seduto, mentre gli zombie mangiano. Qualche tempo dopo, Dio solo sa quando, gli azzannatori si allontanano dai resti scorticati e ripuliti, che ora giacciono sparsi per tutta la radura. Brian scivola giù dal tetto della cabina del camion e al buio riprende la strada per tornare all’appartamento. Quella notte siede nell’appartamento vuoto, in soggiorno, davanti all’acquario sporco. È la fine delle trasmissioni della giornata, nella testa di Brian. L’inno nazionale è stato cantato, i programmi sono cessati e solo una bufera di scariche statiche risuona nei suoi pensieri. Con ancora il giubbotto lurido indosso, resta seduto a fissare il vetro rettangolare dell’acquario, coperto da una patina di fango verde e sporco di cibo per pesci, come se guardasse una monotona natura morta trasmessa dall’inferno. Rimane seduto così, a fissare il cuore vuoto dell’acquario come in uno stato di trance, per interminabili minuti. I minuti diventano ore. La sua mente è uno schermo bianco, un tubo catodico vuoto che ribolle di neve elettronica. Si accorge appena del sorgere del giorno. Non sente il trambusto fuori dall’appartamento, le voci preoccupate, i rumori dei veicoli. Il giorno si trascina, il tempo ormai non ha più significato, finché la sera seguente non stende il suo sipario di tenebra sopra l’appartamento. Brian siede al buio, ignaro del tempo che passa, e continua a fissare con interesse catatonico la trasmissione invisibile che ha luogo nel guscio vuoto dell’acquario. Il mattino successivo arriva e se ne va. In un momento del giorno dopo, Brian sbatte le palpebre. Lo sfarfallio di un messaggio scintilla e tremola nello schermo bianco della sua mente. All’inizio, è flebile e disturbato, come un segnale trasmesso da una sorgente troppo debole, ma a ogni secondo che passa si fa più forte, chiaro, rumoroso: ADDIO. Come una bomba di profondità piazzata nel centro della sua anima, la parola implode in una convulsione di energia incandescente, lo fa scattare sulla poltrona sciupata, dove resta a sedere dritto come un fuso, e lo costringe ad aprire gli occhi. � ADDIO � È disidratato e indolenzito, ha lo stomaco vuoto e i pantaloni fradici della sua stessa urina. È rimasto seduto su quella sedia per quasi trentasei ore, in stato comatoso, immobile come una bacchetta da rabdomante e sulle prime muoversi non è facile, ma si sente purificato, castigato, lucido com’è sempre stato. Barcolla fino alla cucina e nella credenza non trova altro che un paio di scatolette di pesche. Ne apre una e la divora tutta, col succo che gli cola sul mento. Le pesche non sono mai state tanto buone. A dire il vero, gli viene in mente che forse non le aveva mai assaggiate fino a quel momento. Va nella camera da letto e si toglie i vestiti disgustosi… indossa il suo solo altro paio di jeans e la sua sola altra T-shirt (una maglietta con una serigrafia degli AC/DC). Trova gli scarponi Dr. Martens di ricambio e li infila. Sul retro della porta c’è uno specchio a figura intera attraversato da una crepa. Un uomo snello, malmesso, compatto, simile a un furetto ricambia il suo sguardo. La crepa nello specchio divide il suo viso stretto e il cespuglio di capelli neri, lunghi e ribelli. La sua faccia è delineata da basette arruffate, gli occhi sono infossati e circondati da occhiaie scure. Stenta a riconoscersi. “Pazienza” dice allo specchio ed esce dalla stanza. Trova la sua .38 nel soggiorno, insieme a un ultimo caricatore rapido, gli ultimi sei colpi in suo possesso; infila la pistola nella cintura, dietro la schiena, e il caricatore rapido in tasca. Poi va a trovare Penny. “Ciao, piccola” dice con tenerezza quando entra nella lavanderia. Lo stretto stanzino di linoleum puzza di morte. Brian si accorge appena dell’odore. Si avvicina alla piccola creatura, che ringhia, sputa e si dimena contro le catene. Ha il colore del cemento e gli occhi sono come pietre lisce. Brian si china davanti a lei e guarda nel secchio. È vuoto. Alza lo sguardo. “Lo sai che ti adoro, vero?” La cosa-Penny ringhia. Brian le accarezza un lato della piccola e delicata caviglia. “Vado a fare un po’ di provviste, tesoro. Non ti preoccupare, tornerò prima che tu ti accorga che me ne sono andato.” La piccola cosa morta solleva la testa e prorompe in un grugnito, che suona come uno sbuffo d’aria in un tubo arrugginito. Brian le dà una pacca sulla gamba, lontano dalla portata dei suoi incisivi in putrefazione, poi si alza. “A presto, tesoro.” Nell’attimo in cui esce inosservato dalla porta laterale dell’appartamento diretto a nord, camminando nel vento pomeridiano freddo e umido, a testa bassa e con le mani nelle tasche del giubbotto, capisce che sta succedendo qualcosa. La pista è silenziosa. Un paio di abitanti della città lo oltrepassano di corsa, con gli occhi accesi per l’agitazione. L’aria puzza di morte. A sinistra, dietro la barricata di autobus e rimorchi, decine di cadaveri ambulanti vagano lungo la barriera, annusando in cerca di un modo per entrare. Più avanti, un fumo nero esce dall’inceneritore della clinica. Brian accelera il passo. Mentre si avvicina alla piazza della città, scorge in lontananza, sul margine nord della zona sicura, dove la recinzione è ancora in costruzione, uomini di guardia sui parapetti di legno con fucili e binocoli. Non paiono allegri. Brian si affretta. Tutto il suo dolore, la rigidità delle giunture, il pulsare delle costole, tutto quanto, sparisce in mezzo alla scarica ad alto voltaggio dell’adrenalina. Woodbury tiene le sue razioni di cibo in un magazzino di mattoni di fronte al vecchio tribunale. Brian si ferma davanti al magazzino, quando vede i vecchi bevitori derelitti che bighellonano dall’altra parte della strada, dinnanzi all’edificio governativo di pietra con le sue colonne romaniche scheggiate. Altra gente sta sui gradini di pietra e fuma nervosamente; altri ancora affollano l’entrata. Brian attraversa l’incrocio e si avvicina all’assemblea. “Cosa succede?” chiede al vecchio grasso col cappotto dell’Esercito della Salvezza. “Grossi guai a River City 12, figliolo” risponde il vecchietto, indicando il tribunale col pollice unto. “Mezza città è là dentro a tenere un pow-wow13.” “Cos’è successo?” “Ieri hanno trovato altri tre cittadini nel bosco, ripuliti come ossi di pollo… tutta la zona brulica di vaganti adesso, molto probabilmente attirati dal rumore della pista. Dannati idioti, fare tutto quel rumore.” Per un momento, Brian considera le sue alternative. Potrebbe tranquillamente evitare tutto quel casino, fare i bagagli e andarsene. Potrebbe rubare una macchina, caricare Penny dietro e sparire in un lampo. Non deve niente a quella gente. La scelta più sicura sarebbe di non farsi coinvolgere e limitarsi a tagliare la corda. Sarebbe il modo migliore di giocarsela. Ma qualcosa nel suo profondo lo spinge a riconsiderare la situazione. Cosa avrebbe fatto Philip? Brian fissa la folla degli abitanti della città assiepati davanti all’entrata del tribunale. VENTITRE “Qualcuno sa almeno come si chiamavano?” Una donna, ben oltre i sessanta, con un’aureola di capelli grigi dritti sul capo, si alza dal fondo della sala comunale al primo piano del palazzo del tribunale: le vene del suo collo a bargigli pulsano di tensione. Una trentina di assediati residenti di Woodbury si raccoglie intorno a lei: sono gli anziani della città, i capofamiglia, gli ex commercianti e i passanti capitati lì quasi per sbaglio. Si agitano nervosi sulle sedie pieghevoli, vestiti di cappotti malconci e stivali infangati, con le facce rivolte alla prima fila della stretta sala conferenze. La stanza sa di fine del mondo, con l’intonaco che cade a pezzi, le macchinette del caffè rovesciate, l’impianto elettrico scoperto e rifiuti sparsi sul pavimento di parquet. “Che cazzo di differenza fa?” abbaia il Maggiore Gene Gavin: i suoi scagnozzi sono dietro di lui e tengono i fucili d’assalto M4 appoggiati sui fianchi come se fossero i membri di una gang. Al Maggiore, in piedi accanto alle aste che sostengono la bandiera dell’America e quella dello Stato della Georgia, sembra giusto e appropriato reggere le redini di quella piccola assemblea cittadina. Come aveva fatto MacArthur occupando il Giappone o Stonewall Jackson a Bull Run, il Maggiore assapora finalmente il gusto di imporsi come leader pro tempore di quella miserabile città piena di cagasotto e sfigati. Teso e rigido nella sua mimetica verde e nel suo taglio a spazzola, ha atteso il momento giusto per settimane. Sa come rendere i fighetti degli uomini usando un buon numero di frustate; sa che ha bisogno di essere rispettato per avere il comando; e sa che per essere rispettato, deve essere temuto. È esattamente così che era abituato a trattare i guerrieri della domenica sotto il suo comando a Camp Ellenwood. Gavin era un istruttore di sopravvivenza del 221° Battaglione dell’Intelligence dell’esercito ed era abituato a tormentare quei codardi rammolliti durante i bivacchi notturni a Scull Shoals, cagando nei loro zaini e riservando loro il trattamento del tubo di gomma a ogni minima infrazione. Ma poteva essere accaduto un milione di anni prima. Il nome in codice di questa situazione è Fottuti e Gavin si aggrapperà a qualunque cosa per rimanere al comando. “Erano solo un paio di tizi nuovi” aggiunge Gavin, come se ci avesse ripensato. “E una troia di Atlanta.” Un signore anziano, seduto davanti, si alza; le sue ginocchia ossute tremano: “Con tutto il dovuto rispetto… era la figlia di Jim Bridges e non era una troia. Ora, credo di parlare a nome di tutti quando dico che ci serve protezione, magari un coprifuoco… dovremmo tenere la gente al chiuso quando è buio. Forse dovremmo metterlo ai voti.” “Siediti, vecchio… prima di farti male da solo.” Gavin rivolge all’anziano il suo miglior sguardo intimidatorio. “Abbiamo problemi più grossi da affrontare adesso… abbiamo una dannata convention di azzannatori alle costole.” Il vecchio si mette a sedere, lagnandosi tra sé. “Tutto quel casino con quelle dannate corse… è per quello che gli azzannatori ci hanno circondato.” Gavin apre di scatto la fondina, che porta al fianco, mette in mostra il calcio della sua .45 e fa un passo minaccioso verso il vecchio. “Scusa, non ricordo di aver dato il via ai commenti dell’ospizio.” Punta un dito sul petto del vecchio. “Ti consiglio di chiudere quella cazzo di bocca prima di metterti nei guai.” Un uomo più giovane scatta in piedi a due sedie di distanza dal vecchio. “Calmati, Gavin” dice. Alto, con la carnagione olivastra e i capelli raccolti sotto una bandana, indossa una maglia senza maniche, che rivela braccia robuste e muscolose. I suoi occhi scuri scintillano di astuzia da strada. “Non siamo in un film di John Wayne, datti una calmata.” Gavin si volta verso l’uomo con la bandana, sventolando la .45 con aria minacciosa. “Chiudi il becco, Martinez, e rimetti quel tuo culo latino sulla sedia.” Dietro Gavin, i due soldati della Guardia si irrigidiscono, ruotano le canne dei loro M4 e si mettono in posizione di tiro, mentre i loro occhi perlustrano la stanza. L’uomo chiamato Martinez si limita a scuotere la testa e si rimette a sedere. Gavin si lascia sfuggire un sospiro frustrato. “Voi gente sembrate non afferrare la gravità della situazione” dice, infilando la .45 nella fondina, mentre torna in cima alla stanza e parla con il tono di un istruttore durante un’esercitazione. “Se non facciamo qualcosa a proposito di quelle barricate, qui saremo come pesci in un barile. Ci sono un sacco di scansafatiche che non fanno altro che occupare spazio. Si aspettano che siano gli altri a fare tutto il lavoro. Senza disciplina! Ho una notizia per voi: la vostra piccola vacanza è finita. D’ora in poi ci sono nuove regole, a cui vi atterrete tutti: farete quello che vi viene detto e terrete chiuse quelle vostre bocche del cazzo! Sono stato chiaro?” Gavin fa una pausa, sfidando chiunque a obiettare. Gli abitanti della città siedono in silenzio, come bambini mandati nell’ufficio del preside. In un angolo Stevens, il medico, siede accanto a una ragazza sulla ventina, che indossa un camice sporco e ha uno stetoscopio intorno al collo. Stevens sembra un uomo che ha sentito la puzza di qualcosa che marcisce da tempo. Alza la mano. Il Maggiore leva gli occhi al cielo ed emette un sospiro esasperato. “Che c’è adesso, Stevens?” “Correggimi se sbaglio” dice il medico “ma ci stiamo già dando parecchio da fare. Facciamo del nostro meglio.” “E allora, cosa vorresti dire?” Il dottore gli rivolge una scrollata di spalle. “Cos’altro vuoi da noi?” “VOGLIO LA VOSTRA DANNATA OBBEDIENZA!” I lineamenti sottili e acuti di Stevens registrano appena la roboante risposta di Gavin, che fa respiri lunghi e regolari per riprendere il controllo di se stesso. Stevens si spinge gli occhiali sul naso e distoglie lo sguardo, scuotendo la testa. Gavin guarda i suoi uomini. I soldati della Guardia annuiscono all’unisono, le dita pronte sui grilletti. Non sarà facile come Gavin aveva pensato. Brian Blake resta in fondo alla stanza, all’ombra di un polveroso distributore automatico fuori servizio, con le mani in tasca, e ascolta con attenzione ogni cosa. Il suo cuore martella. Si odia per questo. Si sente un topo da laboratorio in un labirinto. La paura paralizzante, la sua vecchia nemesi, è tornata per vendicarsi. Sente il caricatore come un tumore nella sua tasca; il rigonfiamento è freddo contro la sua coscia. La sua gola è secca e asciutta, la lingua è due taglie troppo grossa per la sua bocca. Che cazzo c’è che non va in lui? In cima alla stanza, Gavin continua a camminare davanti alla galleria dei fondatori della città ritratti in una serie di quadri sbiaditi appesi sulla parete principale. “Ora, non mi frega niente di come chiamate questo fottuto casino in cui ci troviamo, io lo chiamo guerra… e da questo istante, questa piccola città del cazzo è ufficialmente sotto la fottuta legge marziale.” Mormorii di tensione si diffondono nel gruppo. Il vecchio è il solo abbastanza audace da prendere la parola. “E questo cosa significa di preciso?” Gavin gli si avvicina. “Significa che tutti voi eseguirete gli ordini, come bravi bambini e brave bambine.” Dà una serie di colpetti alla testa pelata del vecchietto, come se accarezzasse un coniglio. “Comportatevi bene, fate quello che vi viene detto e forse riusciremo a sopravvivere a questa tempesta di merda.” Il vecchio deglutisce impaurito. Molti dei suoi concittadini abbassano lo sguardo sul pavimento. A Brian, che li osserva dal fondo della stanza, appare chiaro che gli abitanti di Woodbury sono in trappola. L’odio nella stanza è abbastanza denso da poterci dipingere le pareti. Ma la paura è ancora più densa. Trasuda dai pori di tutti i presenti, Brian incluso, che si sforza di combatterla. Ricaccia il suo terrore giù per la gola. Qualcuno mormora qualcosa: è quasi in cima alla stanza, vicino alla finestra. Brian è troppo lontano per capire le parole e guarda sopra la testa degli altri per vedere di chi si tratta. “Vuoi dire qualcosa, Detroit?” Accanto alla finestra, un uomo di colore, di mezz’età, con la barba grigia e con indosso una salopette unta, se ne sta seduto sulla sua sedia con un’espressione stizzita e guarda cupo fuori dalla finestra. Le dita lunghe e marroni sono sporche di grasso per motori. Il meccanico della città, un trapiantato dal Nord, borbotta qualcosa tra sé, senza guardare il Maggiore. “Parla, amico mio.” Il Maggiore si avvicina al nero. Torreggia sopra di lui e dice: “Hai qualche reclamo da fare? Non ti piace il programma?”. Quasi impercettibilmente, il nero dice: “Me ne vado”. Si alza per andarsene, quando all’improvviso il Maggiore prende la pistola. Con un istinto quasi involontario, il nero allunga una mano grossa e callosa per afferrare il revolver che porta infilato nella cintura. Ma prima che possa estrarre l’arma o anche solo ripensarci, Gavin gli si avvicina. “Forza, Detroit, prendi la pistola” ringhia, puntando la .45 sull’uomo. “Così ti faccio saltare quella testa di cazzo.” Gli altri soldati si spostano dietro il Maggiore e puntano i loro fucili d’assalto, con lo sguardo fisso sul nero. Con la mano ancora sul calcio della pistola e gli occhi fissi su quelli di Gavin, il nero di nome Detroit mormora: “È già abbastanza brutto dover combattere con quelle cose morte… adesso dobbiamo anche sopportare te che ci comandi a bacchetta?”. “Mettiti. A. Sedere. Subito. Cazzo!” Gavin appoggia la canna della pistola sulla fronte di Detroit. “O ti ammazzo. Ed è una promessa.” Con un sospiro esasperato, Detroit si affloscia all’indietro. “E vale anche per tutti voi altri!” Il Maggiore si gira verso la gente nella sala. “Pensate che lo faccia per il mio benessere? Pensate che voglia candidarmi a fare l’accalappiacani? Questa non è una democrazia. È una questione di vita o di morte, cazzo!” Cammina in cima alla stanza. “Se volete che vi impedisca di diventare cibo per cani, dovete fare quello che vi dico. Lasciate che i professionisti si occupino di tutto e tenete cucite le vostre bocche del cazzo!” Il silenzio incombe sulla stanza come un gas venefico. In fondo, Brian sente la pelle della nuca formicolargli. Il cuore sta per sfondargli lo sterno per come gli martella duramente il petto. Non riesce a respirare. Vorrebbe staccare la testa dal collo a quel soldatino di latta, ma il suo corpo è alle prese con una specie di dilemma paralizzante: battersi o battersela. Nella mente gli crepitano i frammenti confusi dei ricordi, le visioni e i suoni di una vita vissuta all’insegna della paura: aveva sempre evitato i bulli nel cortile della scuola elementare della Contea di Burke, aggirato il parcheggio dello Stop-and-Go per non imbattersi in un gruppo di teppisti vestiti di giubbotti di pelle, era scappato da una banda di duri a un concerto di Kid Rock, mentre si chiede dov’è Philip… dove diavolo è Philip quando c’è bisogno di lui… Un rumore proviene dal fondo della stanza e scuote Brian dalle sue elucubrazioni. Detroit si sta alzando. Ne ha avuto abbastanza. La sua sedia scricchiola mentre l’uomo si erge in tutta la sua altezza, ben più di un metro e ottanta, e si volta per andarsene. “Dove cazzo stai andando?” Gavin guarda il nero che si muove lungo il corridoio diretto verso l’uscita principale. “EHI! TI HO FATTO UNA DOMANDA, DETROIT! DOVE CAZZO CREDI DI ANDARE?” Detroit non si degna nemmeno di girarsi per guardarlo, fa solo un cenno sdegnoso con la mano e borbotta: “Me ne vado… buona fortuna a tutti… ne avrete bisogno con questi figli di puttana”. “O TI METTI SUBITO A SEDERE SUL TUO CULO NERO O TI FACCIO SALTARE IL CERVELLO!” Detroit continua a camminare. Gavin estrae l’arma. Gli abitanti della città trattengono percettibilmente il respiro mentre Gavin prende di mira la parte posteriore della testa di Detroit. Lo sparo risucchia l’aria dalla stanza ed echeggia con forza sulle pareti, accompagnato dal grido di una donna anziana, mentre un singolo proiettile perfora la parte posteriore del cranio del nero. Detroit viene scagliato verso il distributore automatico accanto a Brian, che si scansa di colpo. Il nero rimbalza sul pannello d’acciaio e si ripiega sul pavimento: lo spruzzo del suo sangue sporca il marchio della Coca-Cola, il muro sopra la macchina e anche parte del soffitto. Molte cose accadono come conseguenza di quello sparo, ancora prima che l’eco delle grida possa placarsi. Quasi subito, tre abitanti della città, due uomini di mezz’età e una donna sulla trentina, si affrettano verso l’uscita e Brian li osserva come in un sogno, con le orecchie che gli fischiano e gli occhi abbagliati. Riesce appena a sentire la voce stranamente calma del Maggiore Gavin, che senza cenni di rimpianto e di altre emozioni, ordina ai suoi due soldati, Barker e Manning, di prendere gli abitanti in fuga e, già che ci sono, di radunare tutti gli altri che sono “ancora fuori a nascondersi come dannati scarafaggi”. Gavin vuole che ogni persona che ha ancora un battito cardiaco senta quello che ha da dire. I due soldati si affrettano a uscire dalla stanza e si lasciano alle spalle uno sbalordito e pietrificato gruppo di venticinque abitanti, il Maggiore… e Brian. Brian vede la stanza girare su se stessa, mentre Gavin rinfodera la pistola e abbassa lo sguardo sul corpo del nero disteso in maniera scomposta sul pavimento come se fosse un trofeo di caccia. Gavin si volta e torna disinvolto verso le prime file della stanza. Ha catturato l’attenzione di tutti adesso, come mai era successo fino a quel momento, e sembra gustarsi ogni minuto. Brian lo sente appena blaterare a proposito di come quello debba essere d’esempio per tutti i succhiacazzi che pensano di poter mettere in pericolo la vita dei residenti di Woodbury facendo i lupi solitari, andando contro il sistema, facendo i furbi; e per tutti i saputelli che credono di potercela fare da soli e pensano solo ai propri fottuti affari. Questi tempi, dice Gavin, sono tempi speciali. Previsti dalla Bibbia. Profetizzati. In fin dei conti, forse, solo forse, sono la fine dei tempi. D’ora in poi, ogni figlio di puttana di quella città deve abituarsi all’idea che potrebbe benissimo essere l’ultima battaglia tra l’uomo e Satana, e che per quello che riguarda la brava gente di Woodbury, Georgia, il qui presente Gavin è stato designato come fottuto Messia. Quel discorso maniacale dura forse un minuto, due al massimo ma, in quel breve lasso di tempo, Brian Blake subisce una metamorfosi. Bloccato contro il fianco del distributore automatico, col sangue dell’uomo morto che gli cola sotto le suole degli scarponi, comprende che non avrà nessuna possibilità in quel mondo se si lascerà trascinare a fondo dalle sue inclinazioni naturali. Il suo istinto di allontanarsi dalla violenza, di schivare i pericoli, di evitare il confronto lo riempie di vergogna e si ritrova a tornare col pensiero alla primissima volta che aveva incontrato i morti che camminano, giù a Deering, a casa dei suoi genitori, a un milione di anni luce di distanza. Erano usciti dal capanno degli attrezzi sul retro e Brian aveva cercato di parlare con loro, di ragionarci: li aveva avvisati di stare alla larga, gli aveva tirato dei sassi; poi era tornato a casa di corsa, aveva sbarrato le finestre, si era pisciato nei pantaloni, comportandosi come il rammollito che era sempre stato e sempre sarebbe stato. Ma nello spazio di quell’unico, terribile istante, mentre Gavin pontifica davanti agli abitanti della città, Brian è assalito da una confusa serie di visioni della codardia e dell’indecisione che ha mostrato lungo la strada verso la Georgia occidentale, come se non avesse imparato nulla durante il cammino: si rivede nascosto nell’armadio a Wiltshire Estates, far fuori il suo primo zombie quasi per caso nel palazzo dei Chalmers, lagnarsi col fratello di ogni cosa; è sempre stato debole, spaventato e inutile. All’improvviso comprende, col dolore convulso di un embolo che gli esplode nel cuore, che non ha modo di sopravvivere da solo. Escluso. E ora, mentre il Maggiore Gavin comincia ad abbaiare ordini ai cittadini traumatizzati in cima alla sala del consiglio e impartisce doveri, regole e procedure, Brian sente la sua coscienza disconnettersi e staccarsi dal suo corpo come una farfalla che esce dal bozzolo. Vorrebbe che Philip fosse ancora lì a proteggerlo, come ha fatto fin dall’inizio di quell’ordalia. Come si comporterebbe Philip con Gavin? Cosa farebbe? Presto, quel semplice desiderio si trasforma in un dolore agonizzante e in un senso di perdita per la morte di Philip, una tortura simile a una ferita aperta: la lama affilata del tormento lo trafigge e lo lacera. Appoggiato al distributore automatico sporco di sangue, Brian sente che il suo centro di gravità si risolleva e il suo spirito si separa dal corpo, come un pezzo di terra primordiale che si stacca per formare la luna. Le vertigini minacciano di gettarlo sul pavimento, ma le combatte e prima ancora che possa registrare quanto sta accadendo, si solleva fuori dal suo corpo. La sua coscienza fluttua al di sopra del corpo come un testimone spettrale che osserva se stesso in quella puzzolente, soffocante, affollata sala comunale nel vecchio tribunale di Woodbury. Brian vede se stesso farsi sempre più calmo. Brian vede il bersaglio in cima alla stanza, a sette, otto metri di distanza. Brian vede se stesso allontanarsi di un unico passo dal distributore automatico, allungare la mano alla cintura dietro la schiena, stringere il calcio zigrinato della pistola calibro .38, mentre Gavin continua ad abbaiare ordini, inconsapevole, e a camminare tra gli stoici ritratti dei padri fondatori di Woodbury. Brian vede se stesso fare altri tre passi più tattici lungo il corridoio centrale ed estrarre la .38 dalla cintura con un movimento sciolto e istintivo. Tiene la pistola sul fianco mentre completa il quarto passo: ormai a meno di cinque metri da Gavin, attira finalmente l’attenzione del Maggiore, che fa una pausa e solleva lo sguardo. E allora Brian alza la pistola e svuota l’intero caricatore di letali proiettili a punta cava Glaser Safety Slug sulla faccia di Gavin. Stavolta, gli abitanti della città sobbalzano sulle sedie ma, stranamente, nessuno urla. Nessuno è sconvolto dalle azioni di Brian più di quanto non lo sia lui stesso che, per un atroce momento, resta paralizzato nel corridoio centrale, con la .38 ancora sollevata e scarica, il braccio bloccato nella posizione di tiro, davanti allo spettacolo del Maggiore Gavin piegato sul pavimento contro la parete principale. La parte superiore del corpo di Gavin è crivellata di colpi, la faccia e il collo pompano dense bollicine di rosso sangue arterioso. Il suono delle sedie che cigolano e il trambusto della gente che si alza spezzano l’incantesimo. Brian abbassa la pistola sul fianco. Si guarda intorno. Alcuni abitanti della città si stanno spostando in avanti. Gli altri lo fissano. Un uomo si inginocchia accanto al corpo di Gavin, ma non si disturba a sentirgli il polso o a guardare troppo da vicino. Quello di nome Martinez si dirige verso Brian. “Non prenderla sul personale, fratello” dice; la sua voce è un mormorio grave e rauco. “Ma faresti meglio a portare il tuo culo fuori da qui.” “No.” Brian si sente come se il suo centro di gravità fosse tornato al suo posto, come se la sua stessa anima si fosse riavviata come un computer. Martinez lo fissa. “Si metterà molto male quando quei teppisti torneranno.” “Andrà tutto bene” dice Brian, infilando la mano in tasca per prendere il caricatore rapido. Getta via i bossoli vuoti e armeggia un po’ per infilare il nuovo caricatore nella pistola. Non è esperto, ma le sue mani sono salde come la roccia. Ha smesso di tremare. “Li superiamo di dieci a uno.” Alcuni abitanti della città stanno riuniti vicino al distributore automatico intorno al corpo di Detroit. Il dottor Stevens sta cercando il polso, mentre il suono di qualcuno che piange sommessamente raggiunge le orecchie di Brian. Si gira verso il gruppo radunato lì. “Qualcuno è armato?” chiede. Alcune mani si alzano. “Statemi vicini” dice Brian; poi si fa largo in mezzo agli abitanti della città sbalorditi e assiepati, diretto verso l’uscita. Resta all’interno della porta, a guardare attraverso le lastre di vetro di sicurezza il cielo coperto e tempestoso di quella giornata autunnale. Persino da lì è possibile sentire l’inconfondibile brusio degli zombie che ronza in lontananza, sotto il fischio del vento. Adesso però quel suono ha qualcosa di diverso alle orecchie di Brian. Segregata dietro le barricate di fortuna, separata dalla piccola e ostinata enclave di sopravvissuti dalle sottili membrane di legno e metallo, la roca, onnipresente sinfonia di gemiti e lamenti, disgustosa e dissonante come sarebbe quella prodotta da un acchiappasogni fatto di ossa umane, non è più un sussurro di condanna. Adesso suona alle orecchie di Brian come un’opportunità, l’invito a un nuovo modo di vivere, a un nuovo paradigma che si forma dentro di lui in quello stesso momento, come la nascita di una nuova religione. Una voce lo scuote dal suo stato di trance. Si gira e vede Martinez, che gli rivolge uno sguardo incuriosito. “Scusa” dice Brian. “Cos’hai detto?” “Il tuo nome… prima non l’ho afferrato.” “Il mio nome?” Martinez annuisce. “Io mi chiamo Martinez… e tu sei…?” Brian esita per un istante brevissimo prima di rispondere: “Philip… sono Philip Blake”. Martinez allunga la mano e afferra quella di Brian. “Piacere di conoscerti, Philip.” Con una presa salda, i due uomini si stringono la mano e quel singolo gesto suggella l’avvento di un nuovo ordine. NOTA Il romanzo di The Walking Dead è collegato alla serie a fumetti creata da Robert Kirkman e pubblicata negli Stati Uniti da Image Comics. L’edizione italiana è curata da Saldapress. NOTE 1 Salsa tipica della cucina degli stati del Sud. N.d.T. 2 Riferimento biblico al libro di Daniele. Nei paesi anglosassoni il modo di dire è diventato proverbiale per indicare una situazione di destino incombente o la fine di qualcosa. N.d.T. 3 Termine che indica un uomo bianco della classe operaia degli Stati del Sud. N.d.T. 4 Riferimento al poema di Robert Burns, Ad un topo. N.d.T. 5 Variante del football americano giocata dai bambini, e da adulti nel tempo libero, dove per bloccare l’avversario basta toccarlo con tutte e due le mani. N.d.T. 6 Piatto degli stati del Sud, una specie di stufato. N.d.T. 7 Mr. Rogers’s neighborhood è stato un noto programma televisivo per bambini degli anni 60 e 70. Realizzato anche con l’uso di marionette, è stato replicato fino ai giorni nostri. N.d.T. 8 Una merendina col ripieno di vaniglia (ma disponibile anche in altri gusti). N.d.T. 9 Riferimento a una frase del discorso di insediamento di Abraham Lincoln, diventata di uso comune. N.d.T. 10 Riferimento a una popolare serie televisiva andata in onda dal 1968 al 1971, inedita in Italia, ambientata in una cittadina di campagna. N.d.T. 11 Un tipo di corsa automobilistica che si tiene su piste di terra di forma ovale. N.d.T. 12 Riferimento a una canzone del popolare musical The Music Man. N.d.T. 13 Il nome usato dagli indiani d’America per indicare una riunione importante. N.d.T. AUTORI ROBERT KIRKMAN è famoso per le sue serie a fumetti The Walking Dead e Invincible per la Image Comics sotto l’etichetta Skybound. È uno dei cinque soci della Image Comics ed è un produttore esecutivo e uno degli sceneggiatori della serie televisiva di successo tratta da The Walking Dead, trasmessa in Italia da Sky. JAY BONANSINGA è uno scrittore di romanzi horror acclamato dalla critica. Tra i suoi lavori Perfect Victim, Shattered, Twisted e Frozen. Il suo romanzo d’esordio, The Black Mariah, è stato uno dei finalisti per il Bram Stoker Award.
Scaricare