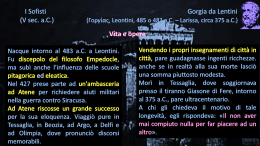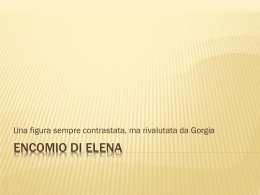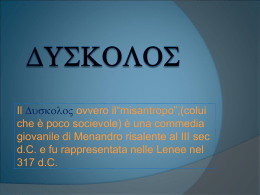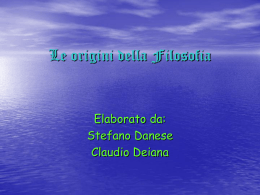L’ANONIMO TRATTATO DE GORGIA (DE MELISSO XENOPHANE GORGIA 979a 11 – 980b 21) Soggetto 1 Il Trecento ci ha lasciato due manoscritti contenenti un testo greco antico intitolato alla latina De Melisso Xenophane Gorgia (d’ora in poi De MXG) e fondamentali per la costituzione del testo critico dell’opera. I due manoscritti sono il “Lipsiensis 16” (L) ed il “Vaticanus graecus 1302” (R); storicamente il testo fa parte del corpus aristotelico almeno a partire dall’edizione fondamentale dell’Accademia di Berlino2 (da qui la collocazione 974a1 - 980b 21 del De MXG e 979a 11 – 980b 21 del De Gorgia) pur essendo la paternità aristotelica totalmente inammissibile. Oggi3 si ritiene infatti che l’Anonimo autore di questa dossografia sia un appartenente alla scuola megarica (scuola socratica attiva nel IV – III secolo a. C.). Nella presente sede verrà presa in considerazione solo la terza parte del trattato, quella relativa a Gorgia4 (pur mai nominato dall’Anonimo) e 1 I contenuti del presente paragrafo sono basati su B. CASSIN, Le traité anonyme De Melisso Xenophane Gorgia, Edition critique et commentaire, (« Cahiers de Philologie Publiès par le Centre de Recherche Philologique de Lille III, Directeur Jean Bollack, Volume 4 » ), PUL, Lille, 1980. 2 Aristotelis Opera edidit Academia regia Borussica, G. Reimer, Berolini, 1831-1870; v. I-II Aristoteles Graece a cura di I. Bekker; v. III Aristoteles Latine; v. IV Scholia in Aristotelem; v. V Aristotelis Fragmenta e Index aristotelicus. 3 M. MIGLIORI, La filosofia di Gorgia, Milano, Celuc, 1973; il Migliori su questo punto segue M. UNTERSTEINER, I sofisti, Torino 1949; seconda ed. , Milano, 1967, voll, 2 ; n. ed., Milano, Bruno Mondadori, 1996. 4 Suid. s.v. “Gorgia figlio di Carmantida, da Leontini, oratore, scolaro di Empedocle, maestro di Polo d’Agrigento, di Pericle, di Isocrate, di Alcidamante nativo di Elea il quale ne ereditò anche la scuola. Fu fratello del medico Erodico. Porfirio lo pone 1 tematicamente corrispondente ad un perduto scritto gorgiano che il neoscettico Sesto Empirico (II – III sec. d.C.), nel suo Contro i matematici, chiama, riassumendone e presumibilmente manipolandone il contenuto, Sul non essere o Sulla natura 5. L’ultima e più dettagliata edizione critica del De Gorgia (all’interno del De MXG) è quella di Barbara Cassin (1980), qui adottata. Edizione che, comunque sia, non si discosta sensibilmente da quella classica del Diels (1900)6. Il soggetto del mio lavoro non è dunque “Gorgia” o “il pensiero di Gorgia” o “la storia di Gorgia”, ma il contenuto di uno scritto greco antico (che non si sa né da chi né quando né perché è stato composto) tramandatoci per via manoscritta, dove il nome di Gorgia nemmeno compare. Ogni altra illazione che si discosti dalla interpretazione concettuale e a sé stante di quest’unico e solo testo, deve in questa sede essere considerata fuorviante e non pertinente7. Ciò basti in via nell’80.a olimpiade [460-57], ma è da supporre che fosse più vecchio [Willamowitz: 500/497-391/388]. Egli fu il primo a dare efficacia espressiva ed elaborazione tecnica all’aspetto oratorio della cultura; e indusse l’uso di tropi, metafore, allegorie, ipallagi, iperbati, e anadiplosi e epanalessi e apostrofi e parisosi; faceva pagare a ogni scolaro cento mine; visse 109 anni e compose molti scritti”. DIELS-KRANZ, Die fragmente der Vorsokratiker, VII ed., Berlin, 1954, 82, A, 2; ed. it. a cura di G. GIANNANTONI, I Presocratici, Testimonianze e frammenti, quinta ed., Roma-Bari, BUL, 1993, pp. 905906, II. 5 Degli 11 libri “Contro i matematici” i primi 6 polemizzano contro i grammatici, i retori e gli studiosi di geometria, aritmetica, astronomia e musica; gli ultimi 5, contrassegnati con il titolo alternativo “Contro i dogmatici”, confutano i sostenitori di un fondamento obiettivo della logica, della fisica e dell’etica: è lampante che allo scettico Sesto, Gorgia (la cui trattazione è collocata nel VII libro) serve solo in funzione anti-dogmatica. Per il “Sul non essere o Sulla natura” (quindi per l’opera di Sesto limitatamente a questa pertinenza) si veda D.K. B, 3 in I Presocratici, cit. pp. 916-920, II. Per l’ intera opera di Sesto Empirico con il testo dell’ed. Bekker si veda: SEXTUS EMPIRICUS, reprinted., R. G. Bury (a cura di), Lodon-Harvard, Heinemann, 1967; per lo specifico su Gorgia ivi II, Against the logicians pp. 34-45; numerazione Bekker: SEXT. EMP. Adv. Math. VII 65-87 6 L’edizione del Diels è consultabile nei volumi ed edizioni già citate, con la collocazione 82 B 3a. Nell’ed. it. del DK la traduzione è la medesima di TIMPANARO CARDINI, I sofisti, testimonianze e frammenti, Bari, 1923, 1954 (2) 7 Per questi motivi ho creduta opportuna la coniazione di un nuovo termine: “degorgiano”. Lo userò secondo il seguente criterio: ogni volta che mi riferirò a 2 preventiva a giustificare l’assenza di tanti contributi forse aspettati ma la cui mancanza non è da ritenersi una deficienza bensì una scelta. Né di filologia né di storia della filosofia né di storia ci si sta occupando, ma solo di ermeneutica. Spero opportunamente e senza allo stesso tempo contraddire subito quanto appena detto, quando sarà necessario e direttamente proficuo, filologia e storia e storia della filosofia soprattutto costituiranno il mezzo comunque ineliminabile del fine ermeneutico. Sempre sulla medesima via preventiva, basti ciò ad autorizzare momentanee fughe al di là dello stretto contenuto del testo; fughe che però dovrebbero servire solo ad un ritorno al medesimo, in grado di spingersi più a fondo. Testo e traduzione del De Gorgia8 contributi altrui adopererò il consueto aggettivo “gorgiano” (in quanto gli studiosi considerano il De Gorgia all’interno dell’analisi della figura di Gorgia in generale), ogni volta che sarò “io” a parlare userò “degorigano”, in quanto di questo e solo di questo intendo occuparmi. 8 Per il testo (integralmente e anastaticamente riprodotto) mi sono basato su B. CASSIN, cit., pp. 637-643; per la traduzione (laddove, è ovvio, rispondeva a questa medesima lettura) fondamentalmente su TIMPANARO CARDINI, pp. 920-924 v. II, dell’ed. cit. del DK a cura di Giannantoni; ma anche su UNTERSTEINER, cit., pp. 215276; C. MORESCHINI, Gorgia, Frammenti, Torino, 1959; A. LEVI, Storia della sofistica, Morano, Napoli 1966, pp. 215-241; A. CAPIZZI, I Sofisti, Firenze, La Nuova Italia, 1976 3 4 [979a 11] Non esiste, dice egli, niente; se anche esiste è inconoscibile; se poi esiste ed è conoscibile, tuttavia non è mostrabile ad altri. E che invero niente esiste, combinando le dottrine degli altri autori, i quali ragionando sugli enti [15] a quanto pare esprimono reciprocamente opinioni contrarie, gli uni dicendo che l’ente è uno e non molteplice, gli altri che è molteplice e non uno, e alcuni mostrando che gli enti sono ingenerati, altri che sono generati, lo deduce contro ambo le parti. Ne segue logicamente, dice egli, che se esiste alcunché, non sia né uno, né molteplice, né ingenerato [20], né generato: nulla esisterà; infatti se alcunché esistesse, corrisponderebbe a una di queste alternative. Che non esiste cosa né una, né molteplice, né ingenerata, né generata, egli si assume di dimostrarlo, parte seguendo le teorie di Melisso, parte seguendo le teorie di Zenone, dopo la precedente dimostrazione sua propria, nella quale afferma che non esiste né essere né non essere. [25] E infatti se esiste, il non essere come non essere, in niente sarà da meno il non essere dell’essere. Perché il non essere esiste come non essere e l’essere esiste come essere, sicché le cose che sono non hanno alcuna superiorità su quelle che non sono. Se poi esiste il non essere, l’essere, la sua antitesi, dice egli, non esiste. Se infatti è il non essere ad esistere, [30] è giocoforza che non esista l’essere. Niente pertanto potrà esistere, dice egli, se essere e non essere non sono la stessa cosa. Ma anche se fossero la stessa cosa, pur in questo caso nulla esisterebbe; infatti il non essere non esiste e così l’essere, dal momento che esso è identico all’essere. Tale dunque è il ragionamento proprio di costui. [35] Ma in nessun modo risulta dagli argomenti che ha portato che non esista nulla. Perché quale che sia la sua dimostrazione egli argomenta così: se il non essere esiste, o esiste assolutamente o è indifferente non esistere. Ma questo né sembra così né è una necessità; anzi è come se si 5 trattasse di due enti, di cui l’uno esiste e l’altro sembra; il primo esiste, [979b] ma l’altro non è vero che esista, qualificandosi come non essere. Perché dunque non esiste né l’essere né il non essere? Chi ha ambedue non è né l’uno né l’altro. Infatti egli afferma che il non essere non sarebbe da meno dell’essere, ammesso che il non essere esista come qualcosa, dato che nessuno sostiene che il non essere non esista in alcun modo. Se anche poi [5] il non essere in quanto non essere esistesse, neppure così il non essere esisterebbe in modo simile all’essere, perché l’uno esiste come non essere, l’altro, oltre ad esistere, è. Se poi ciò fosse vero in senso assoluto, suonerebbe strano e come che il non essere esista; ma se è così, in un primo tempo è vero che tutte le cose non siano piuttosto che siano. Effettivamente sembra [10] accadere proprio il contrario; infatti se il non essere è esistente e se l’essere è esistente, tutto esiste; poiché sia gli enti sia i non enti esistono; non è necessario infatti, se il non essere esiste, che l’essere di colpo non esista. E se anche uno concludesse così, che il non essere esista e l’essere non esista, ugualmente non ci sarebbe nulla di meno. Infatti i non enti esisterebbero, secondo il ragionamento di costui. [15] E se poi sono la stessa cosa l’essere e il non essere nemmeno così accadrebbe che qualcosa non esista piuttosto che esista. Come infatti egli dice, che se sono la stessa cosa il non essere e l’essere, e l’essere non esiste allo stesso modo del non essere, sicché nulla esiste, capovolgendo è ugualmente lecito dire che tutto esiste, poiché esiste tanto il non essere che l’essere, così tutto esiste. [20] Dopo questo ragionamento, egli dice che, ammesso esista qualcosa, deve essere ingenerata o generata. E se è ingenerata, la suppone infinita per gli assiomi di Melisso. Ma l’infinito non potrebbe esistere mai; infatti non potrebbe stare né in sé stesso né in altro; perché ci sarebbero così due infiniti, [25] il primo e quello in cui questo è; ma se non è in nessun luogo, non è nulla secondo l’argomento di Zenone sullo spazio. 6 Per queste ragioni dunque, se qualcosa esiste, non è ingenerato; ma di sicuro nemmeno generato. Nulla certo potrebbe generarsi né dall’ente né dal non ente. Infatti se l’ente si trasformasse non sarebbe più l’ente e così anche il non ente se diventasse qualcosa non sarebbe più non ente. [30] Neppure dall’essere sarebbe possibile la genesi; se infatti il non essere non esiste, non può esserci sviluppo a partire dal non essere. Se dunque, posto che qualcosa esista, essa deve essere necessariamente o ingenerata o generata e questo è impossibile, è impossibile che qualcosa esista. [35] E ancora: se qualcosa esiste, dice egli, è o uno o più. Ma se non è né uno né più, nulla può esistere. (Se l’ente è uno solo, Melisso afferma che questo è incorporeo. Ma se non ha un corpo non ha parti, e dunque non è niente, secondo il ragionamento di Zenone. D’altra parte se non c’è l’uno, la pluralità che è una somma di unità non c’è nemmeno essa). [980a] Di modo che se l’ente non è né uno né molteplice non è niente. Neppure, dice egli, alcunché potrebbe muoversi; infatti se qualche cosa si movesse, non si troverebbe più nella stessa condizione, ma l’essere diverrebbe non essere, e il non essere sarebbe generato. Se poi si muove e muta lo stato di unità, l’ente, non essendo più continuo, si divide e ivi non è più; [5] cosicché se si muove in ogni parte in ogni parte si divide; e, se così, in ogni parte non esiste. Poiché, dice egli, è privo dell’ente in questo senso, in quanto è diviso, parlando dell’essere diviso al posto del vuoto, come è invece scritto nei ragionamenti pronunciati da Leucippo. Se dunque niente esiste, le dimostrazioni dicono tutte bene senza eccezioni. [10] Poiché tutte le cose pensate devono esistere, e il non essere, se non esiste, neppure deve pensarsi. Ma se fosse così, nessuno potrebbe dire il falso, dichiara egli, neanche se dicesse che nel mare gareggiano dei cocchi; infatti tutte le cose così esisterebbero; poiché anche le cose che si vedono e si sentono esisteranno per questo motivo, e cioè che ciascuna di esse è pensata. E se non è questo [15] il motivo, tuttavia, come nulla esiste più realmente di 7 quel che vediamo, così nulla esiste più realmente di quel che pensiamo; e come nel primo caso molti vedrebbero le stesse cose, anche nel secondo molti penserebbero le stesse cose. Ma quali siano le vere è oscuro. Sicché se anche esistono, le cose per noi sarebbero inconoscibili. Anche se le cose fossero conoscibili, in che modo, dice egli, [20] uno potrebbe manifestarle ad un altro? Come potrebbe uno, dice, esprimere almeno quello che vede col discorso? O come ciò [980b] potrebbe riuscire palese a chi ha udito ma non ha visto? Infatti come la vista non riconosce i suoni, così nemmeno l’udito ascolta i colori, ma i suoni: e colui che parla, parla, ma non dice un colore o una cosa. Dunque, ciò che alcuno non considera col pensiero, come lo potrà conoscere ricevendolo da altri per mezzo di un discorso o di un altro [5] segno diverso dalla cosa e non invece, se è un colore perché lo ha visto, se è un rumore perché lo ha ascoltato? Poiché prima di tutto chi parla non pronuncia un rumore o un colore, bensì un discorso; poiché non è nemmeno possibile pensare un colore, ma soltanto vederlo, né un suono, ma solamente udirlo. Anche se è possibile conoscere ed esprimere parlando ciò che si conosce, come chi ascolta [10] potrà pensare la stessa cosa che è pensata da chi parla? Infatti non è possibile che la stessa cosa sia insieme in più esistenti separatamente; poiché l’uno sarebbe due. E se anche, dice, fosse vero che il medesimo oggetto di pensiero si trovi in più persone, nulla impedisce che non appaia uguale ad essi, in quanto quelli non sono completamente uguali e nella stessa posizione, infatti se lo fossero sarebbero uno, ma non due. È chiaro anche che nemmeno la stessa persona [15] prova nello stesso tempo le stesse cose, ma prova cose diverse con l’udito e con la vista e prova differentemente ora e nel passato, sicché difficilmente alcuno potrebbe sentire la stessa cosa come un altro. Così niente esiste; e anche se qualche cosa esistesse, niente sarebbe conoscibile; e anche se qualche cosa fosse conoscibile, nessuno 8 potrebbe manifestarla ad altri, e perché le cose non sono discorsi e perché nessuno pensa la stessa cosa come un altro. [20] Tutte queste aporie sono anche d’altri antichi filosofi, sicché nello studio intorno ad essi, anche su queste bisogna esercitare l’indagine. Formalizzazione dei contenuti 9 Ontologia ( 979a 11 - 980a 8) . I. Presentazione da parte dell’Anonimo dell’argomento dell’intero opuscolo di Gorgia che da Sesto Empirico ricaviamo essersi intitolato Sul non essere. Questo, continua l’Anonimo che riporta il discorso di Gorgia (mai nominato) sempre in forma indiretta, si articolava in tre affermazioni base: a) nulla esiste; b) se qualcosa esiste non è conoscibile; c) anche se è conoscibile non è comunicabile agli altri (979a 11–13). II. Che nulla esista, Gorgia lo prova combinando le dottrine antitetiche dei filosofi, i quali sostengono gli uni che l’ente è uno, gli altri che è molteplice; gli uni che è eterno, gli altri che è generato (979a 13-18). III. Conseguenza: se qualcosa esiste, non è né uno né molteplice, né eterno né generato; quindi nulla esiste. Questo Gorgia lo prova in parte seguendo Melisso di Samo (parmenideo del VIV sec. a.C.: per le sue teorie si veda sotto), in parte Zenone di Elea (parmenideo del VI-V sec. a.C.: per le sue teorie si veda sotto), dopo aver sviluppato una dimostrazione del tutto sua (979a 18-24). 9 Il presente paragrafo è ampiamente debitore di MIGLIORI, La filosofia di Gorgia, cit., pp. 24-47 e pp. 63-69 9 IV. Nella sua argomentazione (979a 24-33) Gorgia afferma che tanto l’essere quanto il non essere sono impossibili. Infatti: a) premessa: 1° il non essere è (esiste come) non essere; 2° quindi il non essere non è inferiore all’essere; infatti come l’essere è essere (esiste) così il non essere è (esiste) non essere; 3° così il fatto che le cose siano, non vale più del fatto che non siano (esistono comunque); b) prima ipotesi: ente e non ente sono opposti; ora il non ente è (esiste), quindi l’ente non è (non esiste); c) seconda ipotesi: ente e non ente sono identici. Il non ente non è (non esiste) quindi l’ente non è (non esiste)10. V. Analisi critica fatta dall’Anonimo (979a 34 - b 1). Non è vero che nulla sia (che non esista nulla). a) confutazione di fondo. Si afferma che, se il non essere è (esiste), o è (esiste) assolutamente o è ugualmente non essere (come se non esistesse). Ma questo non è giusto: essere e non essere si contraddicono del tutto (979a 34- b 10 “ Qui,come si vede, Gorgia argomenta partendo esattamente dalle premesse poste da Parmenide, ossia che l'essere è essere, che il non essere è non essere, e che essere e non essere sono tra loro opposti. Il suo argomento consiste nel rilevare che la semplice identità con se stesso non conferisce all'essere nessun primato rispetto al non essere, perché essa vale anche per quest'ultimo, e dunque consente in definitiva l'identificazione tra i due opposti, ossia proprio ciò che Parmenide voleva evitare. E' singolare la coincidenza tra questa argomentazione e quella messa in atto da Hegel all'inizio della sua Logica, dove l'essere e il non essere vengono ugualmente identificati. Hegel tuttavia indica anche la ragione di questa identificazione, cioè l'assoluta indeterminatezza del concetto di essere, che equivale all'assoluta indistinzione dei suoi significati” (ENRICO BERTI, Il problema dell’essere e le ragioni dell’essere, http://www.rcs.re.it/banfi/olimpo/essere.htm) 10 1): il non essere non può essere, né la non esistenza esistere11. b) confutazione dell’introduzione al IV argomento: se l’essere e il non essere non esistono, perché non sono entrambi insieme? Gorgia stesso infatti afferma (IV a) 2°) che il non essere non è da meno dell’essere; il non essere infatti sarebbe (esisterebbe), poiché nessuno sostiene che non sia (esista) in nessun modo (b 1-4). c) confutazione di IV a). Nemmeno se il non ente è (esiste come) non ente, è uguale all’ente, poiché quest’ultimo in più è (b, 4-6). d) confutazione di IV b). Concediamo anche che il non essere è12 (per quanto sia strano). Crolla però così il principio di contraddizione, e quindi non c’è nessuna necessità di concludere che, se il non ente è, l’ente non è, ma tutto sarà (b 6-12). e) seconda confutazione di IV b). Se anche si concedesse il ragionamento di Gorgia, cioè che il non ente è e l’ente non 11 Si senta in questa alzata dell’Anonimo un tipico sapore eleatico: l’argomento di Gorgia è stretto tra le “due vie” di Parmenide, qui morse logiche: “ciò che è e che non può non essere” , “ciò che non è e che è necessario che non sia”. Due domande: nell’argomento gorgiano, se vi si trova, in quanto è quantificabile la componente esistenziale? E, ammesso che Gorgia fosse stato conscio di aver scoperto un sostrato comune all’essere e al non essere (l’esistere, la sussistenza, ma anche la sostanza aristotelica in cui l’essere o il non essere apparirebbero come modi o categorie: si veda comunque sotto), quanto di ciò era consapevole l’Anonimo nella sua critica? Anonimo che sembra ancora confinato in una concezione “pre-esistenzialistica”, ovverosia quella tipicamente parmenidea della contrapposizione essere/non-essere, risolventesi monisticamente nell’annullamento del primo a vantaggio del secondo e debitrice, a livello di principio o forma mentis, del “classico” dualismo presocratico di Anassimandro, Pitagora ed Eraclito. 12 Inevitabile ritornare, con una ulteriore, alle domande della precedente nota: la lingua greca non ha un verbo “esistenziale” distinguibile dal copulativo (almeno fino all’uso tecnico di “uparkein” negli stoici): ora, anche concettualmente un greco era inevitabilmente escluso dal concepire una tale distinzione (come, in una che sembra essere confusione solo per noi di oggi, pare accadere con l’Anonimo) oppure (e se vi fosse arrivato Gorgia a questo oppure?: in tal caso la critica dell’Anonimo non sarebbe cogente) no? Identificare (tradurre), infine “essere” con “esistere” e “non-essere” con “non-esistere” non cambia nulla all’interno del problema degorgiano che sembra richiedere un terzo termine: l’ “esserci”. 11 è, non si conclude che nulla è, ma proprio per tale ragionamento i non enti sono (b 12-14). f) confutazione di IV c). Anche nel caso dell’identità, si può rovesciare il discorso gorgiano e dire che tutto è (b 14-19). VI. Se l’ente è (esiste), o è ingenerato o generato (979b 20-34). a) non può essere ingenerato: infatti (b 20-26): x) se è ingenerato è infinito (Melisso13); y) se è infinito non è in alcun luogo, cioè: 1° non è in se stesso; 2° non è in altro, perché altrimenti si avrebbero due infiniti; z) ciò che non si trova in alcun luogo non esiste (Zenone14); b) non può essere generato: infatti nulla può generarsi né dall’ente né dal non ente (979b 26-33): x) dall’ente no (b 26-29): 1° l’ente non sarebbe più ente; 2° il non ente non può essere generato, senza non essere più non ente; y) dal non ente no (b 30-33): 13 L’eleate Melisso dichiara apertamente contro Parmenide (per il quale l’essere è senza fine ma non infinito: ai Greci l’ “àpeiron” suggeriva un senso di imperfezione) che l’ “essere” è infinito: Dal momento dunque che non è nato ed è e sempre era e sempre sarà così anche non ha principio né fine, ma è infinito. Perché se l’essere fosse nato avrebbe un principio (a un certo punto infatti avrebbe cominciato a nascere) e un termine (a un certo punto di fatti avrebbe terminato di nascere); ma dal momento che non ha né cominciato né terminato e sempre era e sempre sarà, non ha né principio né termine. Non è infatti possibile che sempre sia ciò che non esiste tutt’intero (DK 30 B 2; trad. di P. Albertelli in I Presocratici, cit. p. 316). 14 Ad oggi non abbiamo frammenti in merito del discepolo prediletto di Parmenide, nonché continuatore della sua scuola campana; tuttavia è possibile rimandare a DK 29 B 2: qualora l’essere non avesse grandezza neppure sarebbe; ed è legittimo implicare il concetto di spazio in quello di grandezza o viceversa; ivi: se esiste, è necessario che ciascuna cosa abbia una certa grandezza e spessore e che in essa una parte disti dall’altra. Quel che in Zenone era un semplice strumento di passaggio, in Gorgia serve a concludere un argomento. E questo dà il senso dei rapporti di Gorgia con i dialettici eleati di una generazione a lui anteriori: rapporti di confronto teoretico, non di semplice imitazione o plagio (ovviamente ammesso che Zenone avesse intenti costruttivi, cosa che una importante corrente critica nega). 12 1° se non è, dal nulla non si genera nulla; 2° se è, valgono i motivi addotti in VI bx, contro la generazione dall’ente15. b) conclusioni. Se dunque è necessario che, se qualcosa esiste, deve essere o eterna o generata, e ambedue i casi sono impossibili, è impossibile che esista qualche cosa (b 33-34). VII. Se esiste qualche cosa, dev’essere uno o molti; se non è né l’uno né l’altro, non vi è nulla. a) l’uno non è, perché dovrebbe essere incorporeo. Ma quest’ uno è distrutto dall’ argomentazione zenoniana16; b) se non esiste l’uno non c’è neppure il molteplice. VIII. Né alcunché potrebbe muoversi; infatti (980a 1-8): a) se si muove: 1° l’ente perde la sua essenza; 15 Se l’Anonimo è fedele nel riportarci la posizione di Gorgia, qui siamo ad un punto cruciale: o è errata la mia interpretazione (che poi espliciterò) dell’argomento gorgiano come scoperta di un terzo elemento (l’esistere) da cui si originerebbero sia l’essere sia il non essere, ovvero da cui non si originerebbe nulla, dato che l’essere ed il non essere verrebbero essenzialmente ad identificarsi nell’esistenza; o Gorgia s’inerpica in una dimostrazione fuorviante che attribuisce, anche se solo in via d’ipotesi, la capacità generativa all’essere ed al non essere, quando dovrebbero loro essere generati, vertendo appunto la questione su se qualcosa esiste o meno. Una terza via potrebbe però essere la seguente: forti del margine d’indeterminatezza ed oscillazione tra il verbo essere come copula e lo stesso verbo come attestante esistenza, Gorgia potrebbe qui riferirsi all’impossibilità generativa o sostanzializzante dell’essere e del non essere, epifenomeni a partire dall’unico ed inevitabile sostrato costituito dalla esistenza, esserci o sussistere. Ancora: potrebbero costituire la dimensione originaria anche l’essere ed il non essere a partire dai quali qualcosa esiste o meno: sarebbe il contrario di quanto appena detto, ma solo formale e non effettivo: il terzo termine verrebbe conservato ed evitata l’identificazione tra essere ed esistenza e non essere e non esistenza: identificazione che, ammesso non fosse riuscito ad evitarla Gorgia, quasi certi che non vi sia riuscito l’Anonimo, porta ad insanabili non-sensi tutta l’argomentazione e davvero alla ingiustificabile ed incomprensibile contraddizione del non essere che è, col venir meno del principio di identità quando in 979 a, 26 viene ribadito esplicitamente: Perché il non essere esiste come non essere e l’essere esiste come essere, sicché le cose che sono non hanno alcuna superiorità su quelle che non sono. . 16 DK, 29, B, 1-2: argomentazioni contro l’esistenza della molteplicità, a favore del monismo parmenideo a) l’uno dev’essere incorporeo, altrimenti sarebbe divisibile e non più uno; b) l’essere incorporeo non esiste; c) se manca l’uno non ci può essere la molteplicità (il concetto che la molteplicità è composta di unità in Zenone è continuamente ripetuto) 13 2° il non ente si genera; b) se si muove, l’ente si divide e non si trova più in questo luogo. Gnoseologia ( 980a 8 – 980b 21). IX. Introduzione (980a 8-10): a) se nulla è17, Gorgia afferma che le proposizioni ingannano b) tutte le cose pensate devono essere c) il non ente, se non è, non può venir pensato. X. Ammesso questo, non vi potrebbe essere il falso, nemmeno nel caso del pensiero di cocchi sul mare. Tutte le rappresentazioni infatti avrebbero lo stesso valore (a 10-12). XI. Infatti, gli oggetti del vedere e del sentire per questo esistono, in quanto ciascuno di essi viene pensato (a 12-14) XII. Se invece non è così (a 14-19): a) come non hanno sicura esistenza gli oggetti del nostro vedere, così non l’hanno i nostri pensieri b) come nel primo caso molti potrebbero vedere le stesse cose, così nel secondo molti potrebbero pensare lo stesso c) ma quali cose siano vere non è chiaro; quindi, anche se esistono, non sono conoscibili. XIII. Ammessa la conoscibilità delle cose, come potrebbero essere comunicate? (a 19 – b 3) a) quel che uno vede, come può esprimerlo con la parola? b) quel che uno ode, come può diventare chiaro, se non l’ha veduto? c) infatti: né la vista conosce i suoni, né l’udito ode i colori; chi dice, dice qualcosa, ma non un colore o una cosa. 17 “è” = “esiste”, “ha identità”, “è conoscibile”, “è comunicabile”: ma per una più adeguata esposizione sul significato di “eimì”, talora includente talora escludente tutti quelli appena elencati si veda sotto 14 XIV. Ciò che uno conosce, come può conoscerlo per l’intervento di un altro? Per mezzo della parola o di un segno diverso dalla cosa. Ma nel caso di un colore bisogna vederlo, nel caso di un rumore bisogna sentirlo: invece chi parla dice parole; né si può pensare un suono, ma udirlo, né un colore, ma vederlo (b 3 – 8). XV. Ammesso che sia possibile conoscere e comunicare tutto, come chi ode potrà rappresentarsi la stessa cosa? Se fosse così, l’uno sarebbe due (b 8 – 11). XVI. Ammesso anche che la medesima realtà si trovi in due, perché dovrebbe apparire loro simile? (b 11-14) a) essi infatti non sono uguali né si trovano nella stessa condizione, perché altrimenti sarebbero uno e non due b) neppure il medesimo soggetto esperimenta percezioni uguali (b 14-16), 1° per la differenza di senso (vista e udito) 2° per le differenze temporali c) a maggior ragione uno non può avere percezioni identiche a quelle di un altro (b 16-17). XVII. Quindi nulla esiste, se esiste non è conoscibile, se è conoscibile, non è comunicabile: a) perché le cose non sono parole; b) perché nessuno riesce a farsi una rappresentazione identica a quella di un altro (17-19)18. 18 “Come si vede, qui Gorgia ignora, o deliberatamente trascura, il carattere semantico delle parole, cioè la loro capacità di significare cose diverse da se stesse. Questo lo induce a fare del linguaggio, anzi del discorso (logos), una realtà per così dire chiusa in se stessa, che non allude ad altro, ed ha pertanto un valore assoluto, come si desume dalla famosa affermazione contenuta nell'Encomio di Elena, secondo la quale Elena di Troia non fu colpevole dell'abbandono del marito, perché fu sedotta dal discorso di Paride, e «il discorso è un grande signore (dynastes mega), che con un corpo piccolissimo e invisibilissimo riesce a compiere cose divinissime» (fr. 11, Diels-Kranz, § 8). Questa dottrina giustifica la grande importanza attribuita da Gorgia alla retorica, che è appunto l'arte di produrre discorsi, i quali non comunicano l'essere, ma per così dire lo creano, e quindi ne prendono il posto. Se Parmenide, insomma, ha creato 15 XVII. Queste aporie sono proprie anche di altri filosofi cosicché nello studio di questi bisogna anche esaminare queste argomentazioni (b 19-21). Problemi di traduzione come problemi ermeneutici Lo stile ed il lessico del De Gorgia sono quelli formali ed aridi propri di qualsiasi trattato dossografico: una sequela di “ipse dixit” talora diluiti con commenti del dossografo, la presenza dei quali autorizza parimenti a credere che i contenuti gorgiani siano correttamente e fedelmente riportati (per la metodica distinzione tra ciò che è di Gorgia e ciò che è dell’Anonimo) quanto che lo siano scorrettamente ed infedelmente (l’Anonimo, non limitandosi al riportare ma spingendosi nel commentare, potrebbe talora adeguare la prima pratica alla seconda; salvo ovviamente far parte del caso di coloro che, peggio, pur dando la parvenza di riportare fedelmente testi altrui corrompono questi dall’interno, proprio nell’atto di tramandarli, e spesso alterandoli per sempre). Senza dire alcunché circa la generalità di pratiche e significati del tradurre, e dando questi, quali che siano, per impliciti, vado subito al caso specifico in questione asserendo che il nodo focale e forse non scioglibile della traduzione del De Gorgia sta nella resa del verbo “eimì”. Difficilmente poteva accadere qualcosa di diverso in un tema dedicato al “Non essere”. Tale verbo compare mediamente una volta a rigo (dunque è una proporzione altissima): ed i righi sono oltre 150. Con una facile deduzione dalla divisione della precedente sezione sulla Formalizzazione dei contenuti, è naturale e giusto ritenere che la problematica circa la l'ontologia, Gorgia vi sostituisce, come è stato detto, la «logologia» (B. CASSIN, L'effet sophistique, Paris, Gallimard, 1995)” (E. BERTI, Il problema dell’essere e le ragioni dell’essere, cit.). 16 traduzione del verbo in questione riguardi eminentemente la prima parte del trattato, quella che si occupa dell’ ontologia gorgiana, del non essere in quanto tale (979a 11 – 980a 8); la seconda (980a 8 – 980b 21) e conseguenza (logica) della prima, con per soggetto la gnoseologia gorgiana, o dà per acquisiti i significati del verbo “eimì” o si avvale di questo nei limiti della sola costruzione copulativa. Il verbo “eimì” è il verbo “essere”, “etre”, “to be”: ora, lasciando fuori la questione delle lingue che hanno un verbo “essere” ed un verbo “esistere” e di quelle che hanno solo il primo, la cosa tanto evidente quanto importante da sottolineare è che nei tre esempi di traduzione in altrettante lingue del verbo “eimì” appena riportati, a partire da un onnipresente uso del verbo in funzione copulativa e, almeno in prima battuta, sterile di significato, vi sono ulteriori e più “intransitive” valenze facenti perno fondamentalmente nell’uso di “essere” come significante “esserci” e quindi “esistere”. Al di fuori della dimensione filosofica, confusione tra “essere” nel senso di copula ed “essere” nel senso di “esistere” non è avvertita. Ho usato “essere” perché ciò è valevole tanto per l’italiano che ha un verbo “essere” ed un verbo “esistere” quanto per le lingue come il greco antico che invece non hanno il secondo. Ma anche per i greci antichi, sia pure con tutte le precisazioni filosofiche del caso, le cose, in quanto cose, dovevano esistere, esserci. L’unico verbo “eimì” doveva comprendere anche questo ambito. Se per un qualche eccessivo condizionamento culturale potrebbe sembrarlo, il verbo “esistere” tuttavia non esiste (appunto) a partire dall’esistenzialismo del XX secolo; ma, come le cose ed il pensiero su di esse, era di pari rilevanza 2500 anni prima19. Solo che si chiamava 19 Si tenga comunque presente che c’è anche chi sostiene quanto segue: “Any linguistic study of the Greek verb be is essentially conditioned, and perhaps ultimately motivated, by the philosophic career of this word. We know what an extraordinary career it has been. It seems fair to say, with Benveniste, that the systematic development of a concept of Being in Greek philosophy from Parmenides to Aristotle, and then in a more mechanical way from the Stoics to Plotinus, relies upon the pre-existing disposition of 17 “eimì”, allo stesso modo del verbo usato nel sistema copulativo; e proprio come, ad esempio, in italiano accade con il verbo “essere”. La questione ora è: questo chiamarsi allo stesso modo si deve a due verbi diversi che hanno un’unica forma o ad un unico verbo con due significati? E se invece fosse un inutile polverone di distinzioni ed avesse ragione la pratica comune che senza distinzioni ritorce questa presunta confusione a quella effettiva di chi abusa di distinzioni, e copula od esistere fossero non solo lo stesso verbo ma lo stesso significato usato “intensivamente” in modo diverso: per cui nella copula vi sarebbe un esistere debole, transitivo, attributo; nel verbo isolato uno forte, intransitivo, sostanziale? Nei vari apparati critici da me consultati riguardo al De Gorgia non si trova cenno a tale problematica. Banalmente (e aggiungerei acriticamente o, per quanto in modo involontario, capziosamente) lo studioso parte con una propria traduzione che poi commenta senza dare alcun peso a ciò che sembrerebbe estremamente scontato: questo “eimì”, ora essere, ora esistere. Semplice sarebbe se si trattasse di una fisima the language to make a very general and diversified use of the verb einai. Furthermore, insofar as the notions expressed by on, einai, and ousia in Greek underlie the doctrines of Being, substance, essence, and existence in Latin, in Arabic, and in modern philosophy from Descartes to Heidegger and perhaps to Quine, we may say that the usage of the Greek verb be studied here forms the historical basis for the ontological tradition of the West, as the very term "ontology" suggests. At the same time it is generally recognized that this wide range of uses for the single verb eimi in Greek reflects a state of affairs which is "peculiar to Indo-European languages, and by no means a universal situation or a necessary condition." 1 The present monograph series on "the verb 'be' and its synonyms" shows just how far the languages of the earth may differ from one another in their expression for existence, for predication with nouns or with adjectives, for locative predication, and so forth. The topic of be can itself scarcely be defined except by reference to Indo-European verbs representing the root *es-. The question naturally arises whether an historical peculiarity of this kind can be of any fundamental importance for general linguistics and, even more pressing, whether a concept reflecting the Indo-European use of *es- can be of any general significance in philosophy.” 1 Émile Benveniste - "Catégories de pensée et catégories de langue" - in: Problèmes de linguistique générale - (Paris , 1966) p. 73 C. H. KAHN, The verb “Be” in ancient Greek, Dordrecht, Reidel, 1973, p. 1. Rimando alla sezione Che cos’altro dire? Per una più estesa disamina delle tesi di Kahn. 18 dell’inopportunatamente troppo ricco italiano col suo “essere” ed “esistere”; o di un nostalgico della temperie esistenzialistica desideroso di mostrare la validità delle di questo categorie ogni dove. Spero di dimostrare che non è così. Il metodo che seguirò vuole l’analisi dei punti del De Gorgia dove è di capitale importanza la resa in un senso o in un altro di “eimì”, quindi ed in forza di ciò la notifica che una certa traduzione od una altra di questo verbo e solo di questo, porta a rilevanti cambiamenti interpretativi del trattato e delle idee di chi lo ha ispirato. Ouk eìnai, phesìn, oudèn: “Gorgia afferma che nulla esiste” (Timpanaro Cardini, 1923; Untersteiner, 1949); “ “Il n’est, dit-il, rien” (Cassin, 1980). La traduzione/interpretazione di questa celebre asserzione sembra univoca; e tutti i traduttori italiani (di cui si sono riportati i battistrada) si trovano concordi. Già il francese, in pratica orfano del verbo “esistere” ed in questo speculare del greco, il francese con il suo calco esatto della frase da tradurre, quando a sua volta deve essere reso, potrebbe far sentire autorizzati ad un “nulla è”. Ipotesi naturalmente subito scartabile se la si considera una gratuita forzatura formale per un senso concreto che è quello già ribadito del “non esiste nulla”; “Non esiste nulla” che è già più proprio e chiarificatore di “nulla esiste” quando questo, viste come poi si vedranno anche le successive dinamiche del testo, potrebbe sempre intendersi come “esiste solo il nulla”, “non esiste che nulla”, e questo, se non è qualcosa, è almeno nulla, mentre nel “non esiste nulla”, non è, non si dà, nemmeno questo. Così come la storia intelligente si fa con tanti “se”, ne propongo uno ermeneutico che aspira quantomeno a giustificare la presenza del processo a questa frase e ai suoi traduttori che se inevitabilmente interpreti in un caso del genere rischiano di esserlo più del normale. Infatti: A) se Gorgia dice che nulla esiste, significa quello che significa tranne che possa darsi la possibilità dell’inquadramento di un qualcosa come esistente (ma non è logicamente esclusa la possibilità di un 19 qualcosa come non-esistente); inoltre il “significa quello che significa” porta alla già prospettata distinzione in a) esiste solo il nulla, e b) non esiste tout court; ovvero l’esistenza è impossibile per il nulla come per altro; l’eventuale e discutibile equivalenza ontologica tra l’esserci del nulla od il non esserci (nemmeno il) nulla, non riguarda lo stretto procedere logico-dimostrativo. B) Se Gorgia dice che nulla è, si avvicina ad una copula, ad un transitivo, ad un’accezione debole ed attributiva non inficiante l’essenza ultima o sostanziale della sussistenza della cosa o di un qualcosa; e cioè dice che nessuna cosa è questo o quello o quell’altro; ma, sempre logicamente, nessuna cosa, senza attributi, potrebbe conservare a qualsiasi livello voglia intendersi, un’esistenza; il discorso si fa più gnoseologico ed antropologico anziché ontologico ed universale; dato che il nulla è implica già in sé l’inconoscibilità di alcunché con il suo non poter conoscere e non poter essere conosciuto; implica un relativismo del punto di vista che nel suo non poter uscire da questa gabbia trova sostentamento e limite; nulla è perché nulla è in assoluto, una volta per tutte; ancora: ogni cosa è a vari livelli, la moltiplicazione tendente all’indeterminato se non infinito dei quali la porta a non farla essere o associarsi ad uno piuttosto che ad un altro; ogni cosa non è solo per me o per te o per lui, ma anche per la storia, l’arte, la fisica, la giustizia, la religione. In ogni modo una cosa non è conoscibile né se non esiste (non c’è traccia di lei) né se non è (non c’è traccia sufficientemente stabile: approssimarsi inadeguatamente alla conoscenza o non approssimarvisi affatto è negli effetti lo stesso). Così per la partecipazione, tramite noi, degli altri alla cosa: impossibile, quando (non essendo, non esistendo essa) non vi partecipiamo neanche noi. Di già da queste prime battute si vede come possa essere più che risolto aggirato il problema di traduzione: in italiano (ed in francese ancor più) come in greco, il verbo “essere” ha quella duplice valenza: ogni volta che 20 ci si imbatte in esso va rilevata questa duplicità; siamo di fronte ad un caso di ciò che generalmente accade nelle traduzione: l’inadeguatezza della resa è motivata dalla ricchezza semantica di una parola spesso non altrettanto determinabile con un suo corrispondente in un’altra lingua. Perché alcune lingue hanno alcune parole più ricche ed evocative (pur avendo tutte ed in quanto tali un campo semantico) di altre che ne hanno altre. Il verbo “eimì” greco deve essere più fecondo di “essere” italiano, italiano che in sede formale come in un trattato avrebbe usato (così difatti accade nelle traduzioni), laddove ve ne fosse bisogno, “esistere”. Ciò detto, la questione ermeneutica rimane, ed è grave che non sia stata sufficientemente presa in considerazione dagli interpreti: se infatti quella appena suggerita è una risaputa e naturale soluzione di compromesso, a prendere sul serio e minuziosamente la cosa e con questa intendo il testo ed il suo scritto in sé, lungi da Gorgia e dal suo pensiero e figura storica, a prendere sul serio la cosa, dico, si giunge a speculazioni forse non del tutto inutili. Tre sono i possibili modi di tradurre “eimì” in italiano: “è”, “esiste”, “c’è”. Si provi a scambiarli ed a fare un De Gorgia che “è”, uno che “esiste” ed uno che “c’è”. Impossibile non avvertire un notevole senso di diversità contenutistica e quindi concettuale. Altrettanto impossibile o quantomeno arbitrario negare una traduzione a vantaggio di un'altra. L’interpretazione che ne scaturirà, per quanto sia forzata comunque dovrà accogliere la singola resa. Vi è tuttavia una complicazione, anzi alcune complicanze; notazioni che farebbero supporre un senso ed un modo specifici, all’interno della concezione dell’autore, con i quali intendere “eimì”. Passi cioè dove tale interscambiabilità appare eccessivamente forzata, non solo dal punto di vista della correttezza della traduzione ma anche e soprattutto da quello della plausibilità ermeneutica. Da 979a 11 a 979a 24 il lavoro di sostituzione e confronto dei tre sensi di “eimì” può essere fatto, andrebbe fatto, ed è cosa stimolante e proficua. 21 Poi ci si imbatte in 979a 25 - 979a 28: e infatti se X1 il non X2 come non X2, in niente sarà da meno il non X3 dell’ X3a. Perché il non X3 X1 come non X3 e l’ X3 X1 come X3, sicché le cose che X2 non hanno alcuna superiorità su quelle che non X2. Per precisione ho segnato non solo con una X i luoghi dove comparivano le forme dello stesso verbo “eimì”, ma secondo l’ordine di comparsa e con lo stesso numero per il reiterarsi di una stessa forma, le varie forme del verbo. Queste le corrispondenze: X1 = ésti; X2 = eìnai; X3 = òn; X3a = òntos. Ecco la classica traduzione della Timpanaro Cardini20: e infatti se il non essere consiste nel non esistere, il non essere per nulla sarà meno dell’essere; perché il non essere è non essere, e l’essere è essere, sicché il fatto che le cose non siano non vale meno del fatto che esse siano. La stessa traduttrice riporta in nota: “si noti come qui e anche in altri punti del frammento il predicato essere oscilli tra il valore copulativo e quello esistenziale”. A parte l’aver fatto divenire l’ “eimì” di X1 un “consiste” (laddove il greco dice “ei mèn gàr tò mè eìnai ésti mè eìnai”), con un arbitrio insufficientemente autorizzato da una nota altrettanto arbitraria (nel caso non si voglia dare ad essa della tautologia: è ovvio che il verbo essere abbia tale duplice funzione), questa traduzione ci riporta la prima apparizione di X2 come “(non) essere”, la seconda come “(non) esistere”. Doppio allontanamento dal testo dunque: non solo per quanto riguarda il fatto che il greco usa lo stesso verbo “eìmi” ma anche e soprattutto (il greco non ha altri verbi si potrebbe difatti obiettare) laddove il testo usando anche la stessa forma sembra proprio voler ancora di più insistere sull’identità o identica funzione delle due ricorrenze. a) “Se il non essere consiste nel non esistere”; b) “Se il non essere consiste nel non essere”; c) “Se il non esistere consiste nel non esistere”; d) “Se il non esistere consiste nel non essere”. La lettera del testo (X2) vorrebbe una scelta tra b) o c), a cui potrebbe aggiungersi: e) “se il non esserci consiste nel non esserci”; tuttavia, ed ecco motivato l’intervento ”20. 20 p. 921 v. II, dell’ed. cit. del DK a cura di Giannantoni. 22 della Timpanaro nonché la ragione per la quale a questa altezza della traduzione incespica quel sistema di triplice sostituzione di significati del verbo “eimì” suesposto, tuttavia se nel (in questo caso) pluri-forme italiano interpretiamo il (in questo caso) mono-forme greco facendo soggiacere la polifonia del primo (tanto di forme quanto di significati) con il monolitismo formale del secondo che in realtà occulta (ma era sentito dai contemporanei parlanti) un plurimo significato, finiamo per non rendere adeguatamente la corrispondenza greco antico–italiano; finiamo per non tradurre. Tutto sta nel vedere se, all’interno di un un’unica forma (“eimì”) era lecito aspettarsi più significati (per quanto in relazione comunque almeno sfumata: essere, esistere) e quindi se è lecito intendere in italiano, dove, avendo esso una forma verbale per l’ “esistenza” ed una per la “copula” l’uso della seconda con valore sostitutivo della prima è meno ovvio o indistinguibile, qui “essere”, là “esistere”. La libertà o dovere di tale intendimento pare venirci data dal seguente fatto: b) e c), per quanto, parallelamente, rispondenti all’impronta del testo greco, sono tautologie e dunque improprie in una dimostrazione che vorrebbe essere informativa: non solo, logicamente la frase non avrebbe validità, non dimostrerebbe, sarebbe da meno di una tautologia (almeno che non si assuma come ipotetica ed improbabile premessa che l’essere consiste nel non essere): “se il non essere consiste nel non essere, il non essere, per nulla, sarà meno dell’essere”21. Questa la traduzione (ed è possibile farla anche nella versione “esistenziale”) rispettosa del ricorrere dello stesso verbo “eimì”. Tuttavia, sempre questa traduzione, che poi non è altra da quella della Timpanaro con la sola sostituzione del secondo “eìnai” con “essere” al posto di “esistere”, ignora la diversità di forme dello stesso verbo. Ad X2 succede infatti X3: “ei mèn gàr tò mè eìnai ésti mè eìnai, oudèn àv ètton tò mè òn tou òntos 21 A considerare a fondo la cosa un modo per intendere questa frase ci sarebbe; ed è poi il medesimo con il quale sotto si intenderà la traduzione pseudo-esistenziale della Timpanaro: il non-essere che consiste nel non-essere non sarà da meno dell’essere che consiste nell’essere perché entrambi hanno una, anche se loro propria, identità 23 eìe”. Se si tenesse conto di ciò, potremmo avere qualcosa del genere: “se il non essere (o esserci o esistere) consiste nel non essere (o esserci o esistere), il non ente (o esserci o esistere o essere, basta sia diverso dalla traduzione di “eìnai”) per nulla sarà meno dell’ente (“o esserci o esistere o essere, basta sia diverso dalla traduzione di “eìnai”)”. Tutto questo per dire che l’autorizzare l’apparentemente innocua traduzione “se il non essere consiste nel non esistere” dovrebbe portare se non altro a considerare in linea di principio o per gli stessi motivi, anche possibilità come “Se il non essere consiste nel non essere, il non esistere per nulla sarà meno dell’esistere”; “Se il non esistere consiste nel non essere, il non essere per nulla sarà da meno dell’esistere” ecc. Se è chiaro che certe interpretazioni sono improponibili, dovrebbe esserlo ancor di più che né quella della Timpanaro né quella di nessun altro sono le sole. Buon senso più o meno filosofico fa preferire quest’ultime agli esempi con qualche provocazione avanzati. Per tutti questi motivi la Timpanaro ha ragione nel dire e infatti se il non essere consiste nel non esistere, il non essere per nulla sarà meno dell’essere; perché il non essere è non essere, e l’essere è essere, sicché il fatto che le cose non siano non vale meno del fatto che esse siano; ma credo di averne qualcuna anch’io nel proporre: e infatti se esiste, il non essere come non essere, in niente sarà da meno il non essere dell’essere. Perché il non essere esiste come non essere e l’essere esiste come essere, sicché le cose che sono non hanno alcuna superiorità su quelle che non sono. Come al solito e come necessario alla speculazione il punto non è chi ha ragione o meno, ma le giustificazione che si dà del proprio postulare e le conseguenze di questo. Ogni traduzione implicitamente offre l’una e le altre. La medesima esegesi andrebbe fatta per almeno le 5-6 traduzioni fondamentali del passo, ma prendendo quella della Timpanaro come paradigmatica mi limito a questa. Ad uno che non ha mai letto il testo greco (ed ogni traduzione questo deve supporre) apparrà che l’Anonimo 24 voglia dirci di Gorgia quanto segue: “le cose che non sono hanno il medesimo valore di quelle che sono perché il non essere pur consistendo nel non esistere, consiste (è, ha identità); ed in questo si identifica con l’essere (che specularmente dovrebbe esistere, ma non si evince di necessità) che pure lui consiste”. E cioè: il mondo è fatto sia di cose che sono sia di cose che non sono; quelle che non sono non esistono, ma consistono (“sono”, hanno identità); anche quelle che sono consistono (“sono”, hanno identità): limitatamente al consistere dunque le cose che sono come quelle che non sono hanno il medesimo valore. Vediamo cosa succede nella mia alternativa: esistono cose che sono e cose che non sono (dice l’Anonimo riferendosi alla concezione di Gorgia); circoscritte a questo esistere le une non possono avere superiorità sulle altre; semplicemente il non essere esiste come non essere, l’essere come essere; il reale si basa su una diversità qualitativa di fenomeni (essere, non-essere) a partire da una medesima ed imprescindibile “sub-stantia” (l’esistere)22. Sperando di aver dato ragione di una scelta e una interpretazione, come di averne mostrate almeno non scontate altre, ritorno al perché su questo punto non sia possibile quella sostituzione salva veritate da cui è partita la mia proposta di manipolazione ermeneutica del testo. Mentre sin qui, come ho suggerito, “è”, “c’è”, “esiste”, possono essere coerentemente ed in prima battuta a-criticamente e meccanicamente applicate al testo da tradurre, adesso, per la prima volta, come ampiamente illustrato, è d’obbligo una scelta prima di tutto ermeneutica. Ed è una scelta pesante: da essa dipende infatti non solo il seguito ma la complessiva comprensione del testo stesso: infatti qui non si può, causa quegli “eimì” accostati che devono essere comunque interpretati ora in un modo ora in un altro, pena cadere nella tautologia o nel non senso; qui non si può, dicevo, separare la traduzione dall’interpretazione e nemmeno separarne i 22 Nella parte più programmaticamente ermeneutica amplierò e giustificherò, nel contesto del messaggio filosofico generale del trattato, il discorso 25 momenti. Mentre in precedenza era possibile e quasi divertente farlo, adesso, seriamente, va presa una decisione ed una decisione prima di tutto ermeneutica: altrimenti è impossibile procedere. La mia decisione l’ho presa e proseguo interessandomi di quegli altri punti dove è inevitabile prendere altre decisioni di pari entità e passando tra quelli dove invece è possibile adottare quel sistema dell’interscambiabilità dei significati già sperimentato. Dubbi ed ostacoli le pone subito il passo successivo: 979a 29 – 979a 34. Al solito la traduzione della Timpanaro e la mia: Se tuttavia il non essere esiste, allora, egli afferma, l’essere, che è il suo contrapposto, non esiste; perché se il non essere è, è logico che l’essere non sia. Nulla pertanto, egli afferma, può esistere, se essere e non essere non sono la stessa cosa. Che se poi fossero la stessa, neppur così alcunché esisterebbe; poiché il non ente non è, e così anche l’ente, dal momento che è la stessa cosa del non ente. Se poi esiste il non essere, l’essere, la sua antitesi, dice egli, non esiste. Se infatti è il non essere ad esistere, è giocoforza che non esista l’essere. Niente pertanto potrà esistere, dice egli, se essere e non essere non sono la stessa cosa. Ma anche se fossero la stessa cosa, pur in questo caso nulla esisterebbe; infatti il non essere non esiste e così l’essere, dal momento che esso è identico al non essere. Si ricordi che Gorgia vuole dimostrare che nulla esiste (o che non esiste nulla); qualificandosi l’essere ed il non essere come qualcosa (si veda il “consistere” - autoidentità della Timpanaro), Gorgia deve dimostrare che non esiste né l’uno né l’altro (oppure che tutto si riduce a non essere e che questo si identifica col non esistere). Secondo la Timpanaro lo fa così: se essere e non essere non sono la stessa cosa e se (ammettiamo; ma secondo la traduzione della Timpanaro questo non è il pensiero di Gorgia, giacché, come detto sopra, il non essere per il suo Gorgia non 26 esiste) esiste il non essere, l’essere, suo opposto, non esisterà e quindi esistendo solo il non essere nulla esisterà; se non essere ed essere sono la stessa cosa, non esistendo il primo (implicito - checché ne dica poi l’Anonimo - il fatto che a partire da un’ipotetica identità tra essere e non essere è più forte il negativo della non esistenza del non essere di quella dell’essere da dimostrare) nemmeno il secondo esisterà e quindi nulla esisterà. L’esistenza del non-essere equivale all’esistenza del nulla: questa la premessa (implicita) fondante. La traduzione che ho scelto è nella sostanza uguale a quella della Timpanaro, pur discostandosene quando pecca di imprecisione, soprattutto in quei passaggi decisivi in cui dimostra che la problematica semantica essere-esistere è dalla traduttrice in gran parte ignorata: Se tuttavia il non essere esiste, allora, egli afferma, l’essere, che è il suo contrapposto, non esiste; perché se il non essere è [esiste, avrebbe dovuto dire, e non è una pedanteria; tanto più che lei stessa qui sopra così si esprime], è logico che l’essere non sia [non esista: fingendo di non comprendere le intenzioni della traduttrice potremmo sempre obiettarle: come fa l’essere a non essere, se quest’ultimo atto non avesse un senso esistenziale?]. Nulla pertanto, egli afferma, può esistere, se essere e non essere non sono la stessa cosa. Che se poi fossero la stessa, neppur così alcunché esisterebbe; poiché il non ente non è [non esiste: altrimenti o si incorre in una tautologia o si dà un valore diverso, esistenziale?, ad “ente” ed un valore copulativo e comunque meno forte ad “è”, il contrario di quello che si vuole], e così anche l’ente, dal momento che è la stessa cosa del non ente. Il rimando alla nota n.12 serva da introduzione per quanto segue, cioè per il vero problema che presenta questo passo. In 979a 25 - 979a 28 Gorgia ci ha appena detto che “le cose che non sono hanno lo stesso valore di quelle che sono” e ce lo hanno perché entrambe “esistono” o, come dice la Timpanaro, “consistono”; completando l’analisi di quel passo dico che era impossibile tradurre “le 27 cose che esistono hanno lo stesso valore di quelle che non esistono”; che cosa potrebbe essere difatti, al di fuori dell’esistenza, a dare alle cose un medesimo valore? L’essere (o l’identità), si potrebbe dire, ribaltando però tutta l’argomentazione, e comunque la si voglia chiamare, mantenendo una distinzione di piani e livelli. Sulla scia di questa distinzione, e fin dall’inizio, abbiamo scelto (ma non è mai da considerarsi una scelta inappellabile, si badi), come anche la Timpanaro (che però, come vedremo, non condivide quella impossibilità), di tradurre “le cose che non sono hanno lo stesso valore di quelle che sono”. Dopo ciò si trova l’argomentazione centrale per dimostrare che nulla esiste sorretta (è quello che emerge dalla traduzione della Timpanaro come dalla mia) dall’equivalenza o contiguità tra “non-essere” e “non-esistere”. Ora, il punto focale dove sia la mia traduzione sia quella della Timpanaro, ognuna a suo modo, si contraddicono. Che una contraddizione insanabile non sia proprio nella materia da tradurre? Nella mia traduzione c’è una contraddizione perché prima (979a 25 979a 28) si dice che “le cose che non sono hanno lo stesso valore di quelle che sono” e ce lo hanno perché entrambe “esistono”; poi (979a 29 – 979a 34) che nulla esiste perché non-essere è come non esistere, e: se si dà il non essere, l’essere od esistere, in quanto suo opposto, non potrà darsi e così nulla esistere; se si dà il non essere e l’essere gli è uguale, non esistendo il primo non esisterà nemmeno il secondo e con esso nulla. L’altra traduzione dice prima che il non essere, pur non esistendo, è sé stesso, così come l’essere che invece esiste (in quanto sé stesse, le cose che sono non varranno meno di quelle che non sono); poi che, a partire dalla duplice identità “non-essere” = “non esistere”, “non essere” = “non essere o nulla”, se esistesse il non essere non potrebbe esistere l’essere, suo opposto, e quindi non esisterebbe nulla (non essendo il non essere niente); se l’essere si identificasse con il non essere non esisterebbe nulla lo stesso, il non essere non esistendo. Prima il non-essere, che pur non esiste, è di pari valore dell’essere in quanto entrambi, in qualche modo, 28 “sono” (hanno identità); poi nulla esiste perché se esiste il non essere non può esistere l’essere (e l’esistenza del non essere equivale a quella del nulla, essendo qualcosa solo l’essere); infine se essere e non essere fossero la stessa cosa non esisterebbe nulla ugualmente, perché il non ente non è (con contraddizione rispetto ai passi in cui si trovava il medesimo valore dell’essere e del non essere nell’ “è”, nel “consiste”, nell’identità). Insomma: nella versione della Timpanaro si dà per scontato che il non essere non esista, dimostrando poi non che nulla esiste ma che nulla è, ovvero che il non essere si identifica col non essere. E questa è una tautologia, non una dimostrazione. Per quanto invece riguarda la dimostrazione che nulla è (ma qui non c’entra niente la traduttrice), ritengo valida l’obiezione dell’Anonimo per cui si può rovesciare il discorso gorgiano e dire che tutto è (979b 14-19). Ciò che invece ho voluto rendere nella mia traduzione tutta “esistenzialistica” è questo: la grande scoperta di Gorgia è stata la base comune, la cosa in sé (con tutti i caratteri della non cosa, essendo non qualificabile in quanto non riducibile al principio, tutto umano, di identità e contraddizione): l’esistere. Fenomeni quali le nostre categorie di essere e non essere vengono, dopo vedersi ridotti ad epifenomeni, relativisticamente e convenzionalmente dedotti da questo humus inevitabile od onnipresente; humus che in verità o, se si potesse, a prescindere dalla nostra necessariamente limitata prospettiva, si ritrova negli alti e complessi livelli come negli infimi, dato che esso non distingue. Questo suo non-distinguere, questa realtà amorfa, senza principi di identità e di contraddizione, con tutto quello che segue (inconoscibilità, incomunicabilità: della verità, del reale su cui l’uomo si basa e che è al di là delle sue costruzioni) sono il nulla o il nulla che esiste degorgiano. È la scoperta dell’universo (nulla in quanto nonumano); l’uomo vi fa parte non in quanto uomo (l’unico “qualcosa” per 29 lui che invece è “nulla” per l’universo), ma in quanto non-uomo o materia amorfa (unico “qualcosa” nell’universo, “nulla” per l’uomo). Lasciando da parte l’intervento dell’Anonimo (sul quale rimando per una breve considerazione alla nota 8) arrivo, per completezza, all’ultimo punto chiave per una traduzione ermeneutica in quanto altra non rimandabile scelta del significato del verbo “eimì”: 979b 26-33. Il De Gorgia, nel dimostrare che nulla esiste, tratta il fatto che un ente non può essere né ingenerato né generato. La questione riguarda quest’ultima prova. Con il rinviare nuovamente alla nota 12, posso concludere. La gnoseologia del De Gorgia negli interpreti novecenteschi del De Gorgia Introduzione Dopo avere, se non altro implicitamente, ricondotto il problema ontologico del De Gorgia ad un problema prima di traduzione, poi di ermeneutica, per cui se non esiste nulla od esiste qualcosa o come questo qualcosa casomai esiste, dipende solo da come si definisce (traducendo “eimì”) il termine “esistere” e soprattutto dal fatto che il termine “essere” sia preso come sinonimo di “esistere” o invece come stato di un altro livello del reale, rimane da occuparsi della parte gnoseologica del trattato. Questa è oggigiorno l’aspetto più interessante e significativo della filosofia che, per i motivi espressi nel primo paragrafo (Soggetto), mi sia concesso chiamare “degorgiana”: ed è l’aspetto più interessante non solo perché l’asserzione capitale “nulla esiste” non viene, di fatto, dimostrata, ma più che altro perché viene asserita, tanto che la sua ragione potrebbe concludersi nel classico ed arcinoto rigo iniziale “nulla esiste, se qualcosa esistesse non sarebbe conoscibile, se fosse conoscibile non sarebbe comunicabile ad altri”, dove, non a caso, anche la forma è chiarificatrice: 30 un’asserzione, poi due ipotesi (anche se “dell’irrealtà”); come si volesse preannunciare che al primo punto non c’è un seguito di “perché?”, oltre l’evidenza, mentre al secondo e al terzo sì; ancora: come dire: concedetemi la tesi che nulla esiste (primo principio indimostrabile e come al solito perché siamo all’interno di esso che altrimenti non sarebbe primo) e vi dimostrerò tutto quello che volete. Il fatto, almeno storicamente, determinate per l’importanza della gnoseologia degorgiana sta tutto nella possibile definizione della nostra presente età filosofica come “post-kantiana”; nel fatto che alla filosofia (conoscenza) non può pertenere che l’indagine del suo unico, stretto, campo: il conoscere; nel fatto che esso, ancor oggi, viene tutto sommato inteso relativisticamente, fenomenisticamente direbbe Kant. L’irraggiungibilità, mediante le categorie umane e proprio in quanto umane, della cosa in sé (qualora abbia fondamento parlare in quest’ultimi termini) è appunto il tema forte della gnoseologia degorgiana. Termine “gnoseologia” che dagli antichi nel suo significato contemporaneo è reso ed usato con la semplice radice: “logos”. Quando si parla di “logos”, si parla di quella che oggi si chiama “gnoseologia”. Dopo la parte negativa (“nulla esiste”) ecco la parte positiva (“nulla è conoscibile”) del discorso; quanto appena detto non è un non-sense perché definisco parte negativa quella che procede senza dimostrazioni, positiva con queste. Altro elemento di positività e negatività: nella trattazione del “nulla esiste”, l’ipotesi che qualcosa esista viene taciuta (se non per essere confutata), mentre in quella che nulla è conoscibile e comunicabile, rimane, pur a livello di ipotesi irreale, sempre e fissa sullo sfondo di cui costituisce la base. In breve il punto della situazione23. Dalla impossibilità di affermare l’ “essere” in forma univoca (nessun ragionamento è così forte da negare il suo opposto), Gorgia arriva a dire che nulla è (prima tesi). Tra l’essere e 23 Con l’aiuto di S. MORAVIA, Filosofia. Dall’Antichità al Medioevo. Firenze, Le Monnier, 1990, I, pp. 139-141 31 il conoscere non vi è alcuna corrispondenza (seconda tesi), si possono pensare infatti cose che non esistono. Ora, le difficoltà che noi incontriamo nel cogliere razionalmente la realtà derivano o dalla realtà stessa (prima tesi: la realtà non si distingue dal nulla), oppure sono dovute all’impossibilità di mettere in rapporto la realtà con i nostri strumenti conoscitivi (seconda tesi: la realtà non è conoscibile). In tal modo viene negata l’identità di essere e pensiero che stava alla base dell’eleatismo e viene superata quella mescolanza fra strutture della realtà e strutture del pensiero che aveva caratterizzato tutta la filosofia presocratica o della physis. Infine (terza tesi) pretendere che le parole esprimano le cose, sarebbe come pretendere di poter vedere con l’udito o ascoltare con la vista. Le funzioni verbali-comunicative del soggetto si distaccano dal mondo; o l’oggetto esterno dall’uomo. Il linguaggio è semplicemente il modo con cui l’uomo esprime il suo contatto con le cose esterne; è qualcosa di nostro, di puramente umano, e non un ponte che ci conduce in presenza delle cose, dicendo come sono24. Untersteiner (Rovereto 1899 – Milano 1981) Nell’oramai lontano 1949, il filologo trentino Mario Untersteiner fu con I Sofisti25 e Sofisti. Testimonianze e frammenti26 protagonista, non solo a livello nazionale, di una riscoperta (soprattutto a mezzo interpretativo e metodologico) tanto urgente quanto tutte le altre e di tali entità fatte in quegli anni. Dal secondo dopo guerra in poi c’è stato l’ingresso in quella che è la “modernità” d’oggi e, in campo culturale, eminentemente in quello critico (dove, superati gli “eccessi” ottocenteschi, si raggiunge una “scientificità” ed “onestà intellettuale” mai viste prima), il modo 24 Per apprezzare la vastità applicativa e la profondità filosofica della scoperta gorgiana, si pensi a tutte le volte che nel linguaggio quotidiano pronunciamo espressioni forse troppo frettolosamente considerate come formulari, del tipo: “è indescrivibile”; “non trovo le parole”, “se non si prova non si può capire”. 25 M. UNTERSTEINER, I Sofisti, cit. 26 M. UNTERSTEINER, I Sofisti. Testimonianze e frammenti, Firenze, La Nuova Italia, 1949-1962, voll. IV 32 rivoluzionario (in entrambi i significati del termine) del guardare all’antico in funzione del presente, rese possibile o fu reso possibile da opere come quelle di Untersteiner, il metodo ed i principi fondanti delle quali sono stati perfezionati, precisati, corretti, ma non cambiati. Untersteiner ha dedicato gran parte della sua vita intellettuale a dimostrare (controcorrente27) che i sofisti non erano semplici retori bensì filosofi teoretici. Ne I Sofisti il capitolo quinto La gnoseologia di Gorgia. Dal trascendete all’immanente per concludere al tragico del conoscere28 è dedicato alle due declamazioni apologetiche di Gorgia rimasteci (L’encomio di Elena e L’apologia di Palamede) da Untersteiner ritenute la base della gnoseologia gorgiana e per questo strenuamente difese da una maggioranza che tende a considerarle solo esercizi retorici. Il capitolo sesto, Gnoseologia e ontologia tragiche secondo Gorgia29, è dedicato al trattato Sul non essere; quindi a Sesto Empirico; ma quindi, anche, all’Aninimo del De M.X.G. e cioè al De Gorgia30. Per Untersteiner Gorgia non fu uno scettico (ed in questo senso se ne era invece servito Sesto Empirico), ma un tragico; e tragiche furono la sua ontologia e la sua gnoseologia, in quanto travagliate da “nullificatrici antinomie” che lo portano non ad una sospensione di giudizio ma all’irrazionalità. “Conosco gli inconoscibili dissidi e tuttavia agisco”; ecco che anche l’azione diventa tragica (in quanto inevitabile). Cito da p. 237: “Non scettico, non relativista è Gorgia, ma un tragico e un irrazionalista. La conoscenza della forza propria dell’irrazionalità 27 Sia rispetto a chi temporalmente lo ha preceduto (come H. GOMPERZ, Sophistik und Rhetorik, Leipzig, 1912) sia rispetto a chi lo ha seguito (come W.K.C. GUTHRIE, The Sophists, Cabridge, 1971 o A. CAPIZZI, I Sofisti, cit.). Nel mezzo sta l’opinione comune che, tra un estremo (sofisti solo retori) e l’altro (sofisti solo filosofi) è, lentissima, passata dal primo al secondo dove ora, nell’epoca del “giustificazionismo” e dell’apolidia nei confronti della storia delle culture e dei personaggi storici e culturali, reazione estrema alla faziosità, sebbene tutta storicistica, di stampo ottocentesco, cerca di trovare una conveniente e sempre buona all’uso “aurea mediocritas”. 28 UNTERSTEINER, I Sofisti, cit. pp. 159-212 29 Ivi. pp. 215-262 30 Untersteiner è stato tra i primi a preferire, per una corretta ricostruzione del pensiero di Gorgia, l’Anonimo a Sesto, anche se, ovviamente, non poteva farlo con la sistematicità, di 25 anni dopo, di MIGLIORI, La filosofa di Gorgia, cit. 33 costituisce il superamento del tragico. L’uomo non può evitare le antitesi. Il suo pensiero non scopre se non opposti polari in tutte le proposizioni, che vogliono interpretare filosoficamente la realtà. La realtà dialettizzata non esprime altro che aporie […] in cui si risolve ogni tentativo di fissare la mobilità della physis […] La ragione non può più decidere nulla, e perciò finisce col negare ogni rapporto, su base razionale, fra uomo e uomo, e perfino ogni coerenza entro lo stesso individuo singolo”. Untertsteiner dimostra che i risultati gorgiani in campo ontologico sono importanti nella misura in cui si ripercuotono su quello gnoseologico; che è come dire: la costituzione dell’universo ci interessa in tanto in quanto spiega il “noi stessi”. Gorgia, per Untersteiner, trova prima che né l’ente né il non ente possono essere attributi delle esperienze: dall’osservazione dell’infinità fenomenica risulta che le cose in nessun modo debbano essere più che non essere “perché è pensabile di esse tanto l’attributo del non essere, quanto quello dell’essere, quanto, infine, quello dell’essere del loro non essere” (p. 221). È proprio il metodo dialettico parmenideo (e le sue tripartizioni logiche), quello che doveva rappresentare la via dell’essere, a non lasciare scampo nemmeno a quella del non essere. Ergo: né il non ente né l’ente esistono. Come si vede quando, col trattare l’ontologia, Untersteiner va a gettare le basi sostanziali e giustificative della gnoseologia degorgiana, anch’egli non vede o non vuole vedere quel problema di traduzione/ermeneutica che a mio giudizio è invece il focus di tutto il trattato: essere od esistere, questo è il problema. Il trattato si riferisce tutto all’essere, tutto all’esistere o non distingue tra le due componenti? Quand’è poi che fa tale distinzione, ed in che cosa questa consiste; qual è, infine, la definizione, non data (ed in ogni caso perché, verrebbe da chiedere), dell’uno e dell’altro termine? Risposta a tutte queste domande si trova nella sola traduzione di “eimì”; traduzione che se non esplicita come un saggio i risultati dello studioso, tuttavia ne denuncia l’ermeneutica. Con o 34 senza volontà da parte di chi si è occupato di queste cose, abbiamo tante risposte a quelle stesse domande, tante ermeneutiche, quante sono le traduzioni del De Gorgia. Untersteiner rileva che la sezione ontologica del trattato ha comunque sia un tono gnoseologico. Anzi: l’inganno (“apàte”) è il punto capitale che si vuole evidenziato nella conclusione; non la nullificazione dell’ente (per la quale, aggiungo io, si sembra piuttosto propendere per un agnosticismo da bipolarismo fenomeno/cosa in sé). “Se nulla è, le dimostrazioni ingannano” (980a 9): “significa che l’inganno, in quanto districa le antitesi contraddittorie, celate nell’essenza delle cose, e ne impone una per mezzo della persuasione, finisce col rilevare l’ambivalenza del logos e, quindi, l’impossibilità di una dimostrazione univoca. […]. Se le dimostrazioni ingannano, ne segue che il conoscere è contraddittorio. Se il conoscere è contraddittorio, ne segue che ogni conoscibilità risulta esclusa” (p. 227). Oltre alla condizione, di base ontologica, ma negli effetti tangibili soprattutto gnoseologica, “tragica”, che per Untersteiner è il timbro fondamentale ed estremo di una corretta interpretazione gorgiana, in questo passo compare una parola non presente nel De Gorgia e nemmeno giustificata da Untersteiner stesso. Nel contesto succitato, intendo la parola “persuasione” così: la natura umana, non potendo “sostenere” il tragico insito nelle cose che ad essa si rapportano (ovvero la contraddizione per cui ad una cosa presumibilmente in sé si contrappone da parte nostra un’esperienza della stessa inevitabilmente e connaturatamente relativa e fenomenica), non potendo “sostenere” il non essere da una parte (del presunto in sé, come tale inqualificabile, inidentificabile) e dall’altra (l’uomo fenomeno, apparenza nel senso del mero relativismo), cerca un porto sicuro nella “convenzione” (attribuisce arbitrariamente o crea artificiosamente, “soggetti” ed “oggetti”), nella epifenomenica sostantizzazione del fenomeno, nella credenza della realtà del “suo”, proprio, umano, vero; ossia della assolutezza e oggettività di 35 questo: nella persuasione, che è innanzitutto “auto-persuasione” come specie e persuasione degli individui all’interno della stessa (tramite l’educazione e la società).31 L’ultima citazione. “Se i sensi dell’udito, della vista e del pensiero sono esperienze che non escono dalla loro autonomia, e di conseguenza, la realtà che a ciascuno di essi è peculiare deve essere giudicata dalla sensazione che le è peculiare, non da un’altra -, risulterà che ciascuna sensazione non presenta alcun criterio per poter essere trasformata in giudizio, perché, in questo caso, si passerebbe da un dominio a un altro eterogeneo […] Se il senso-pensiero sente che cocchi corrono sul mare, poiché il senso vista non può intervenire a determinare un giudizio provocato da una sensazione in contrasto con quella del senso-pensiero, 31 Per un’originale interpretazione del contrasto “apparenza” - “cosa in sé”, storicamente definibile come l’essenza del filosofare (valga la domanda generale dinanzi al comprendere ogni filosofia, il cui succo può dirsi esaurito anche in questa: “qual è per essa il fenomeno?”, “quale la cosa in sé?” ) e quindi rintracciabile a vari livelli, primo fra tutti per clamore e spessore quello “ideale” platonico, in ogni filosofo, mi piace ricordare C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica, VIIa ed., Milano, Adelphi, 1996, forse considerato anche da Untersteiner. Se di già qui abbiamo rispetto a Gorgia uno slittamento d’interresse più sulle conseguenze sociali (gnoseologiche nel senso lato di antropologiche, vista la caratterizzazione delle prime sulle seconde) dell’antitesi o dualismo fenomeno - cosa in sé (e tanto conseguentemente quanto soprattutto della “persuasione”), in Hume si era subito giunti alla considerazione di questo dualismo in termini di un convenzionalismo (ecco la “persuasione” di Untersteiner), interessante principalmente come base del costituirsi civile e non tanto operante nell’intrinsecità della natura umana. Rimando per questo ad HUME, Opere filosofiche, I, Trattato sulla natura umana, Va ed., Roma-Bari, Laterza, 1999, Terzo libro, Sulla morale, Parte seconda, La giustizia e l’ingiustizia, pp. 504-606; pur considerando Hume come la fonte principale d’ispirazione del dualismo gnoseologico kantiano fenomeno – cosa in sé e, quindi, anche delle basi più propriamente ontologiche e meno “antropocentriche” dello stesso. Infine, ritenendo di poter usare sotto una luce ermeneutica il “contrattualismo” di Hobbes, potrei ascrivere ad esso una base soprattutto “convenzionale” e traslitterarlo, con un passaggio dal politico al conoscitivo nella “persuasione” untersteineriana di Gorgia, per cui sembra, in definitiva, che quello che “vediamo” è quello che “crediamo” o siamo costretti (ci costringiamo) a credere. Il richiamo ad Hume mi sembra poi opportuno anche per un certo scetticismo (tuttavia troppo riduttivamente sentito da Sesto Empirico in Gorgia), nonché per quella sua gnoseologia che lo porta rivoluzionariamente, ed in anticipo (oltre che su Kant) di più di due secoli sui “filosofi della mente”, a negare l’identità dell’ “io” e a considerare questo come una costruzione a posteriori del nostro stato di esseri pensanti (vedasi Trattato, cit., Primo libro, Sull’intelletto, Parte quarta, Lo scetticismo ed altri sistemi filosofici, Sezione sesta, L’identità personale, pp. 263-275). Potremmo intendere il De Gorgia anche come la dissoluzione del concetto di “oggetto” a partire da quella del “soggetto” o io; ed attribuire a tale risultato il significato dell’ “ouk eìnai oudén”. 36 si avranno due sensazioni contrastanti, nessuna delle quali può pretendere alla verità” (p. 233). Il logos, conclude Untersteiner, si identifica con la percezione (di cui fa parte anche il pensiero); uscendo fuori di sé, ben lungi dal ritornarvi dialetticamente evoluto, cessa di essere logos; indipendentemente dalla nostra espressione il rapporto con l’oggetto potrà avvenire solo irrazionalmente. Da qui l’inesprimibilità. Levi (Modena 1878 – Roma 1948) Una quindicina di anni dopo l’opera fondamentale di Untersteiner, uscì quella (postuma) di Adolfo Levi: Storia della sofistica, a cura di D. Pesce, Napoli 196632. Si tratta, questa, di una raccolta di interventi fatti dallo studioso almeno una ventina di anni prima, fra cui Studi su Gorgia, “Logos”, 24, 1941. È Untersteiner, in quanto scrive qualche anno dopo, a tenere conto di Levi, e non viceversa (come risulta anche dalla bibliografia del primo). Così schematizzo il contributo di Levi: Calogero33 ha torto nel ritenere che la motivazione precipua della filosofia gorgiana sia una critica all’eleatismo. Gorgia si è valso delle argomentazioni di Parmenide e Zenone non soltanto per ridurre all’assurdo, con le armi che essi stessi gli fornivano, la metafisica che così volevano giustificare e difendere, bensì per colpire, con tali armi, anche le altre filosofie. “Gorgia vuole provare che niente (“oudén”) è. Ora “oudén” non significa il non essere (“tò mè òn”), contro il quale aveva sempre polemizzato l’eleatismo, tanto è vero che il sofista si sforza di dimostrare che esso non ente non è; la sua critica, quindi, non è esclusivamente anti-eleatica, perché altrimenti avrebbe dovuto mirare invece a mettere in evidenza appunto che il non ente esiste. “Niente” ha il significato più generico e indeterminato 32 33 La parte su Gorgia e la sua scuola è alle pp. 193 - 241 G. CALOGERO, Studi sull’eleatismo, Roma, 1932 37 possibile, e così può includere nella negazione l’essere, il non essere e gli enti particolari” (p. 209)34. Il se qualcosa fosse conoscibile non sarebbe comunicabile agli altri significa “che diversamente da coloro la stessa parola viene interpretata che l’adoperano perché riceve il suo significato dai rapporti che ciò che essa deve disegnare forma con gli altri contenuti del pensiero di ciascuno, sicché chi l’adopera sottintende necessariamente molte cose, che variano da uomo a uomo35. La proposizione che due soggetti non possono percepire ugualmente col senso la stessa cosa è stata recentemente ripresa da chi, senza essere consapevole di essere stato preceduto da Gorgia, ha mostrato che, salvo in casi eccezionali, non si può mai essere sicuri che più persone, quando designano con la stessa parola (rosso, verde ecc.) una qualità sensibile, provino effettivamente la stessa impressione” (pp. 235-236)36. 34 Una più distesa esposizione del concentrato pensiero di Levi, potrebbe essere la seguente. Gorgia non aveva di mira solamente o particolarmente l’eleatismo, bensì il dogmatismo filosofico in quanto tale, o, il che è lo stesso, l’umana presunzione di poter approdare a conoscenze definitive e non relative, quali esse siano; e ciò perché non v’è “epistème”che non sia inevitabilmente riconducibile a “doxa”. Da qui l’ontologia di Gorgia. Se egli si fosse voluto contrapporre a Parmenide avrebbe concentrato le sue forze nel dimostrare che non è solo l’ “essere” ad esistere, ma solo il “non-essere” (concetto da rendere con “tò mè òn”). Invece la caratteristica precipua della speculazione gorgiana sta nel voler dimostrare la non-esistenza di alcunché, essere o non-essere che sia. “Oudèn” significa, più generalmente possibile, “niente”. Il concetto stesso di esistenza diventa assurdo e contraddittorio o insensato. Ecco come, secondo Levi, Gorgia intendesse dire non che esiste solo il nulla, bensì che non esiste nemmeno questo: non “nulla esiste”, ma “non esiste nulla”. 35 È come, per esprimerci con Frege (altro esempio d’applicazione del dualismo fenomeno-cosa in sé), se, nei rispetti di una presunta “cosa” o “denotazione”, vi fossero tanti “sensi”, e di intenderla e di considerala e di comunicarla, quanti sono gli esseri umani che ne fanno esperienza nonché i vari stati situazionali di questi. 36 Levi non dice a chi si riferisce con quel “chi” e con quel “recentemente”; applicando tuttavia la frase ai nostri giorni mi è possibile riportare un esempio che evidentemente quel “chi” di Levi lo aveva invece ben presente: “Block e Fodor in Che cosa gli stati psicologici non sono (1972) escogitano contro Putnam e la teoria causale della mente di Lewis e Armstrong (da Block considerata una forma di funzionalismo) un esperimento di pensiero noto come i “qualia invertiti”. Tu e io “diciamo” (comportamento verbale osservabile) che i tramonti sono rossi e i prati verdi. Se le nostre percezioni dei colori sono definite, in conformità con l’ipotesi avanzata dai funzionalisti sulla natura degli stati mentali, come le cause di tale comportamento verbale, allora si deve ammettere per coerenza con quella definizione che noi abbiamo le stesse percezioni dei colori. Ma un 38 La conoscenza di cui Gorgia cerca di mostrare l’impossibilità è quella scientifica, la quale è totalmente distinta dall’opinione (“dòxa”) che è il mezzo di cui si avvale la retorica per persuadere37: la nostra ignoranza e tragedia deve considerarsi rispetto alla “realtà razionale dell’essere”; non ai “fatti concreti della vita pratica” per l’organizzazione dei quali c’è appunto la convenzione che ne crea e risolve problemi e dinamiche38. giorno un neuroscienziato inventa uno strumento che collega il mio cervello al tuo e mi consente di vedere il mondo con i tuoi occhi. Che sorpresa! Tu vedi verdi i tramonti e rossi i prati! Tu hai imparato a chiamare verde ciò che io chiamerei rosso e viceversa. Se tu guardi un tramonto dici come me che è rosso ma di fatto lo vedi diversamente da me. I nostri comportamenti sono indistinguibili e pertanto anche gli stati funzionali che li provocano sono, per definizione, identici; ma le nostre esperienze soggettive sono molto diverse; dunque esse non sono stati funzionali. La concepibilità stessa di questo esperimento immaginario prova che la riduzione degli stati mentali a stati funzionali è sbagliata” (S. NANNINI, L’anima e il corpo. Un’introduzione storica alla filosofia della mente, Roma-Bari, Laterza, 2002). 37 Impossibile, e non solo per una questione di formulario, non sentire l’eco di Michelstaedter che ben conosceva il mondo pre-socratico a cui, tra l’altro, si richiamava: “Si son fatti una forza della loro debolezza, poiché su questa comune debolezza speculando hanno creato una sicurezza fatta di reciproca convenzione. – È il regno della rettorica”. (cit. p. 144). 38 Ecco (aggiungo io) come la critica, condotta da Platone per bocca dell’ “ospite di Elea” nel suo Sofista non è cogente; almeno nel caso di Gorgia: il maestro di retorica non dà ai discepoli l’ episteme e la vera conoscenza, ma solo la doxa, la semplice apparenza del conoscere, utile forse per scopi pratici, ma lontana dagli interessi del vero filosofo? Ebbene è proprio quello che il sofista vuole fare, perché è giusto o necessario farlo. Platone, come ogni metafisico, è un dogmatico: crede di insegnare la verità; ma è solo un’illusione e tanto più grave quanto più incoraggiata (con l’amore della saggezza); ogni verità è relativa ed in definitiva convenzionale; non ha nulla a che fare con il reale. Le metafisiche sono come quelle religioni o superstizioni che a-criticamente richiedono un atto di fede per offrire la spiegazione di un tutto che, proprio in quanto tale, non si spiega. L’agnosticismo è la posizione corretta, anche moralmente: perché è la posizione più onesta dinanzi ad uno stato di cose che coloro che si definiscono “moralisti” o “credenti” deformano a loro piacimento e comodo, sortendo un effetto nebuloso e feticistico in grado solo di rendere l’uomo ridicolamente infante e senza il coraggio di “guardare la morte ad occhi aperti” o, il che è lo stesso, la sua condizione, per quel modo in cui può guardarla, con presa di coscienza. Il tragico è sapere, constatare, di trovarsi in una condizione in cui, dato che vi siamo dall’interno, non è dato sapersi fino in fondo, anzi affatto. In questo senso non può esservi frase più sofistica del “so di non sapere” socratico. Preso atto delle tre tesi gorgiane non rimane che, a livello della vita di tutti i giorni, comportarsi nel modo più tradizionale e conformista possibile (la noncuranza e l’indifferenza essendo l’unica reazione dignitosa e veramente filosofica alla legge che regola la gnoseologia umana o l’umanità tout court: la convenzione, in pratica la coordinata o modo di essere, di stare umano nell’universo; modo intrinseco alla natura umana in quanto razionale; come il bianco e nero alla visione dei felini). All’umano non è data altra conoscenza che la doxa, che l’umano in quanto umano o convenzione. Ecco perché “Gorgia non si è allontanato dalle opinioni etiche dominanti 39 Più che il mondo concreto che ci sta innanzi Gorgia intende con il suo paradosso negare la pensabilità logica ed ontologica dell’essere in generale e, in particolare, di quella struttura metafisica di cui i vari pensatori presofisti erano andati alla ricerca; se uno degli obiettivi della critica gorgiana è l’eleatismo, lo è in tanto in quanto questo più delle altre scuole aveva ritenuto di poter provare con dimostrazioni razionali inconfutabili l’esistenza di una realtà perfettamente razionale, unico oggetto del pensiero puro e della formulazione verbale corrispondente. Come si vede, anche per Levi, la filosofia di Gorgia è eminentemente gnoseologia, cioè “un incitamento alla ragione, perché assuma di nuovo la più gravosa di tutte le incombenze, ossia quella della conoscenza di sé, e perché istituisca un tribunale, che la garantisca nelle sue giuste pretese, ma possa per contro sbrigarsi nel suo tempo fra il suo popolo. In questo campo il pensiero di Gorgia ci appare banale e superficiale, privo di originalità e di profondità, ben lontano dalle audacie rivoluzionarie e distruttici che nell’opinione comune, caratterizzano la interpretazione sofistica dei problemi etico-sociali” (Levi, p. 203). Quanto precede valga anche come confutazione della teoria oltranzista di Capizzi (I Sofisti cit.) per il quale “Come Protagora aveva imparato la filosofia da Democrito, Gorgia l’aveva appresa da Empedocle; ma se ne servì solo per dimostrare tesi assurde ed evidenetemente non serie come quelle contenute nello scritto Sulla natura o su ciò che non è” (p. X); e “La filosofia morirà o vivrà, ma se vivrà , vivrà in Socrate e non in Gorgia”. Probabilmente Capizzi (che rinfaccia tanto a Platone e con lui a tutta la tradizione successiva di aver definito i sofisti come “cattivi filosofi”, quanto alla critica contemporanea di averli definiti dei “buoni filosofi” mentre erano da ritenersi dei “nonfilosofi”) è un platonico che identifica la filosofia con la scalata verso il mondo delle certezze iperuraniche; oppure con la metafisica. Nell’ultimo caso dimostra lampantemente di non essere a conoscenza degli sviluppi nel campo del pensiero analitico da un secolo a questa parte. Per la precisione aggiungo che la considerazione di Capizzi dei sofisti come non-filosofi è da me caldamente condivisa; però solo per la sofistica nel suo insieme e non per singoli come Gorgia. Dopo aver citato il Sofista cito anche il Gorgia dove la rappresentazione del sofista come un fantoccio privo di vero spessore intellettuale e della questione intorno alla sofistica come tutta conclusa intorno alla definizione di retorica, dimostrano quanto Platone “filosofo per vocazione e aristocratico per nascita, trasformasse un conflitto di interessi in una disputa ideale, una lotta tra due classi (borghesi e aristocratici) in una lotta tra due filosofie” (Capizzi, cit., p. XXIII). 40 di tutte le pretensioni senza fondamento non mediante sentenze d’autorità, bensì in base alle sue eterne ed immutabili leggi”39. Kerferd George Kerferd ha insegnato Letteratura greca nell’Università di Manchester. Al 1955 risale il suo saggio Gorgias on Nature or that 39 I. KANT, Critica della ragion pura, a cura di G. Colli, Milano, Adelphi, 1999 (Ia ed. 1957), Prefazione, pp. 9-10. Adesso stempero per ritorsione, storicizzandola e contestualizzandola, la mia interpretazione dell’interpretazione del Levi con una antitetica a quest’ultima: “Filosofia e sofistica, unitesi momentaneamente in Protagora e addirittura saltuariamente in Zenone, si scissero nuovamente assai presto per non più ricongiungersi: la filosofia, discendendo da Anassagora a Socrate attraverso Archelao, nell’epoca in cui un’Atene ormai vinta e umiliata si ripiegava nella meditazione interiore, i sommi metafisici Platone e Aristotele; la sofistica dopo il momento magico vissuto attorno alla pace di Nicia (421 a.C.), sboccò nella grande oratoria attica, creando Lisia, Isocrate e Demostene. Le cerchie culturali del V secolo vanno viste alla luce delle cerchie politico-pedagogiche del secolo successivo; e vanno viste come inseparabili dalle classi sociali che dominarono l’Atene post-periclea e dagli strumenti di dominio peculiari a ciascuna di essa […]. Se il fenomeno della sofistica è spiegabile solo in relazione alle esigenze della borghesia, anche l’aristocrazia ha la sua parte preponderante nella spiegazione del socratismo come evento culturale. […] Se la sofistica non fu, come tale, filosofia, perché studiarla ancora in sede filosofica? Perché il concetto di filosofia nacque in energica contrapposizione ai concetti di sofistica e di retorica” (CAPIZZI, I Sofisti, cit., pp. XIV-XXV). Da un’altra prospettiva ma sempre all’interno della medesima chiave, può essere utile anche quanto segue: “I sofisti sono i veri scopritori del principio della soggettività. Sono i primi a collocare l’individuo puramente su se stesso, i primi a portargli a piena coscienza il contenuto e l’ambito di quanto lo spirito è in grado di trarre da sé. Ma questa liberazione dello spirito, questo scioglierlo da tutti i legami della tradizione e dell’autorità che si contrappongono al singolo come forze presunte oggettive, nei sofisti non è tanto rivolta a un fine teoretico quanto a un fine pratico. La dottrina sofistica della sapienza non mira a un ideale logico del sapere, ma fin dall’inizio coglie ogni sapere come mezzo, come strumento tecnico che deve servire a sottomettere l’effettualità oggettiva, sociale e politica, al volere e al potere dell’individuo. In questo senso i sofisti sono divenuti i primi tecnici, i grandi virtuosi della soggettività. Ma a tale virtuosismo pratico non corrisponde alcun concetto pienamente valido, teoricamente fondato, della soggettività stessa. Quando i sofisti si provano non solo a mettere in pratica, ma a porre in forma concettuale il loro principio, allora, non possedendo nessuno di loro una spinta filosofica veramente autonoma, si vedono rinviati agli strumenti speculativi ausiliari che sistemi precedenti o contemporanei offrono loro (Eraclito, Eleati, Empedocle)” E. CASSIRER, Die Geschichte der antiken Philosophie, Berlin, 1925; trad. it. Da Talete a Platone, a cura di G. A. de Toni, Laterza, Bari, 1984, pp. 89-90 41 which is not40. Lo studioso ha raccolto i risultati significativi di trent’anni di vita intellettuale dedicati allo studio della sofistica in The Sophistic Movement, Cambridge, Cambridge University Press, 198141. Ivi a Gorgia è dedicato un capitolo dal titolo La dottrina del “logos” nella letteratura e nella retorica (pp. 103-141). Kerferd considera anzitutto il De Gorgia come “la più completa esposizione tecnica di un’articolata discussione sofistica del V secolo” giuntaci (p. 120): è una testimonianza indiretta, in forma dossografica e posteriore di oltre un secolo, ma va ricordato che non possediamo le opere di nessuno dei sofisti. Il De Gorgia, continua lo studioso, è più tecnico e organico dei Dissoi logoi42, cui d’altronde va accostato. Tre gli approcci critico-interpretativi principali in merito alla considerazione alla terza parte del De MXG: a) Il De Gorgia non ha un proposito serio, ma è stato composto solo come parodia o scherzo contro i filosofi; al massimo può trattarsi di un’esercitazione retorica sul tema 43. b) Il De Gorgia, che ha un effettivo valore filosofico, è un attacco prima di tutto contro gli eleati e poi anche contro certi fisici presocratici. L’ “essere” del trattato va inteso con “esistere”. Che nulla esiste si prova dimostrando che non esiste né l’essere né il 40 Noto che, come sta (oltre ad essere sempre accaduto) sempre più accadendo per i presocratici in genere, anche per i sofisti, sembra valga la constatazione per la quale sono studiosi di formazione filologica ad occuparsene precipuamente e a doversene occupare. La causa è fisiologica: laddove il primo, quando non unico, problema è stabilire l’autenticità e il contenuto scrittorio di un testo, la fase ermeneutico-teoretica di intervento sullo stesso (specie quando molto corrotto) pare fuori luogo o velleitaria. D’altro canto, sperando d’aver dimostrato come, e si prenda il solo esempio del De Gorgia col suo “eimì”, davanti a tali documenti l’aspetto interpretativo ed “interventista” della ricostruzione testuale come della traduzione sia così profondamente ed ossimoricamente ad alto grado connaturato alle stesse; se il teoretico deve aspettare una traduzione già “theory-laden” è inutile che faccia il teoretico, quando al suo posto ci sono già i filologi. 41 In italiano G.B.KERFERD, I Sofisti, Bologna, Il Mulino, 1988. Breve testo tramandatoci senza autore e senza titolo nei Mss. di Sesto. Appare come la trascrizione di esercitazioni scolastiche tenute intorno al 400 a.C. da un sofista seguace di Protagora. Si veda DK 90, in I Presocratici, cit., pp. 1044-1056. 43 GUTHRIE, The Sophists, cit. p. 197. 42 42 non essere. Il bersaglio è l’idea di Parmenide che solo l’essere esiste e Gorgia con il suo ragionamento arriva ad una posizione di nichilismo filosofico. Parmenide aveva distrutto il multiforme mondo delle apparenze, conservando il mondo unitario del vero essere: Gorgia si sbarazza di tutto quanto, restando semplicemente con il Nulla. Prima di riportare la propria posizione, Kerferd si sofferma, seppur brevemente, su quel problema di come intendere il verbo “eimì” che tanto ho voluto far presente nelle mie considerazioni a proposito del De Gorgia: “Nell’ambito di una più estesa indagine iniziante da Omero, Charles Kahn ha notato come sia difficile tracciare una netta distinzione sintattica tra l’uso assoluto del verbo (cioè senza ulteriore predicato come in x è) ed i suoi costrutti predicativi (come in x è y), negando che il primo impiego – quello assoluto – possa essere considerato esistenziale. Egli sostanzialmente propende a trattare entrambi gli usi come autentici segni di affermazione, riconducendo sia l’uso esistenziale che quello predicativo ad un valore più fondamentale che è molto più vicino al secondo che al primo 44 . Quindi Owen 45 ha sostenuto che nel Sofista di Platone il discorso non comporta né determina nessun isolamento di un verbo esistenziale: si rivela essere in primo luogo un saggio sui problemi della referenza e della predicazione. Infine questa nuova prospettiva è stata applicata direttamente a Parmenide, soprattutto da Mourelatos 46 , con la conclusione che Parmenide non si occupò essenzialmente dell’esistenza e della non esistenza, ma piuttosto della distinzione tra due vie, una positiva per cui diciamo x è F ed una negativa per cui diciamo x è non F. È la seconda quella che Parmenide condanna a favore della prima, la sola possibile” (pp. 121-122). Da ciò Kerferd, ricordiamo 44 C. H. KAHN, The Verb “be” in Ancient Greek, cit. G. E. L. OWEN, Plato on Not-being in G. VLASTOS (a cura di) A collection of Critical Essays, I, cap. XII, New York, 1971 46 A. P. D. MOURELATOS, The Route of Parmenides. A Study of Word, Image and Argument in the Fragments, New Haven, 1970 45 43 proveniente dall’ambiente anglosassone che è condizionato dalla filosofia analitica, deduce e auspica, come introduzione alla propria ermeneutica, un cambiamento di approccio al mondo filosofico greco, specie quello presocratico: gran parte della filosofia greca non si occupò essenzialmente dei problemi dell’esistenza, ma di quelli della predicazione, visti come problemi dell’inerenza di qualità e caratteristiche agli oggetti del mondo reale che ci circonda. Finalmente Kerferd può esporre la sua interpretazione del De Gorgia alla luce dei problemi della interpretazione. È il terzo ed ultimo dei tre modi considerati di intendere il trattato (ovvero, a partire dalle due posizioni classiche: prendere sul serio lo scritto o no, una interpretazione della seconda): c) Il De Gorgia si occupa fondamentalmente dell’uso predicativo del verbo essere e delle contraddizioni che ne risultano. Non c’è modo in cui si possa riferire il verbo essere ad un soggetto senza che sorgano contraddizioni; queste contraddizioni gli eleati avevano potuto riconoscerle nel caso di proposizioni negative; ora valgono anche per le proposizioni affermative. Dà ragione al titolo del capitolo di Kerferd dedicato a Gorgia (nonché al presente paragrafo dedicato ai suoi esegeti contemporanei), quanto segue47. 47 Noto che l’esposizione di Kerferd relativa alla gnoseologia degorgiana è interamente incentrata sul termine e concetto di logos, che ne costituisce un sinonimo. Se da una parte ciò è interessante, soprattutto considerando che questo termine così capitale in altri contesti qui è solo una parola usata poco e laddove e nel senso in cui anche il linguaggio comune l’avrebbe usata, dall’altra, per questa stessa esiguità e banalità di ricorrenza per la quale la parola non è stata considerata dalla maggior parte degli interpreti, una evidenziazione eccessiva può risultare forzante indebitamente il testo. Il tutto è tuttavia coerente e collegato con l’ermeneutica logico-analitica di Kerferd. Quest’ultima, a sua volta, trova valido appoggio più nell’intendere non-esistenzialmente ma predicativamente il termine “eimì” che insistere sul quello di logos. Sarebbe stato meglio attribuire il valore di questo a quello; o esplicitare maggiormente il riferimento di questo a quello. Non c’è insomma, ritengo, nella lettura di Kerferd un essere ed un logos; ma è il primo a venire inteso con il secondo; od il secondo che spiega il senso del primo. Siamo arrivati paradossalmente ad un Gorgia “parmenideo” (essere=logos)? Niente affatto: anzi; Gorgia è proprio anti-parmenideo (mi immedesimo in Kerferd) perché si mette sullo stesso piano filosofico di costui (il logos) e lo intende 44 Il De Gorgia dice che se anche qualcosa fosse e fosse pure conoscibile, non sarebbe comunque, tra conoscenti, comunicabile. La “parola” (logos) è il metodo comunicativo eminentemente umano. Il logos viene trasmesso da una persona ad un’altra tramite suoni udibili ma invisibili. Così se abbiamo a che fare con una comunicazione riguardante cose visibili come colori, tali cose non possono essere trasmesse per mezzo di cose invisibili prive di colore (sembra che Gorgia creda: perché sia possibile conoscere o pensare qualcosa, questo deve avere, ripetere, riprodurre, possedere in sé, i caratteri propri degli oggetti di cui si ha cognizione)48. Tra il logos e le cose (pragmata) che ci giungono dall’esterno c’è uno iato sostanziale, che non può considerarsi superato contrariamente (non è il nulla ad essere tutto ma il tutto ad essere nulla). E come sappiamo, l’opposizione, lo scontro e la filosofia esigono questo terreno comune; una condivisa forma dove far scontrare due mentes. 48 Sento qui la mancanza di una precisazione, senza la quale il discorso di Gorgia potrebbe sembrare non essere esauriente. Il punto non è che la “parola” sia incapace di comunicare il significato, ad esempio di un colore, perché è “invisibile”. Infatti, quello stesso logos funzionale alla comunicazione può essere benissimo scritto; essere cioè visibile: che è il contrario di quanto appena sostenuto circa la sua invisibilità. Evidentemente, deve dedurre il lettore, il messaggio degorgiano è un altro e squisitamente “di principio”, al di là dei vari esempi: tra la “parola” e le “cose” vi è un dislivello ontologico che porta anche ad uno gnoseologico: da qui la incomunicabilità. Dislivello che con tutte le sfumature e precisazioni del caso varrà anche tra senso e senso; fino ad essere presente tra cosa e cosa. Questa mancanza di rapporti, di complicità, di organicità, se non totale comunque profonda ed in ogni caso “tragica” (essendo, del termine, principali sinonimi esplicativi “incompletezza” e “imperfezione”), esacerba il principio di identità così tanto da non richiederlo neanche più: se ogni cosa è se stessa, a se stante, auto-sufficiente, finisce per non essere: venendo la qualificazione e quindi l’essere e quindi il modo dell’identità, dal rapporto, dalla relazione con l’altro. E si badi bene: qui non mi riferisco semplicemente a quel rapporto di comparazione per cui il grande è tale solo in rapporto ad un altro ecc.; mi riferisco soprattutto alla mancanza del rapporto con un eventuale “conoscitore”, a sua volta chiuso nel suo “a se stante” e quindi nemmeno più conoscitore, se non, ed inevitabilmente, miope. Ancora: l’ “a se stante” di ogni uomo, allargando il discorso, può essere l’umanità: l’inevitabile (paradigma, sostanza o altro) da dove non poter uscire per andare alla scoperta, ad esempio, di quelli da noi “convenzionalmente” ed “umanamente” chiamati “fiori” o “cieli”; di ciò da noi chiamato. Chiamato che non risponde e non risponde perché non può uscire dalle proprie categorie per finire nelle nostre. L’ “altro”, la “cosa”, è , al più, un postulato al quale ci ha condotto il tragico del nostro intelletto. Ma come, di fatto (data la sua essenziale incomprensibilità ed irriducibilità), questo altro per noi non è nulla, così noi per esso nulla siamo. Da qui il: solo il nulla esiste. Conoscerlo, poi, sarà comprendere che la dimensione umana è convenzionale e non assoluta. Assoluto, ripeto, è solo quel nulla di cui sopra; nulla che non è, eppure, inevitabilemte, “sta”. 45 per il fatto che il logos (in quanto suono) rientra anch’esso nella medesima categoria dei pragmata. In un certo senso è vero che il logos ci perviene dalle cose da noi esterne. Il logos è costruito a partire da esse quando le percepiamo. Dal nostro incontro col “sapore” risulta il logos espressione di questa qualità; così per il “colore” ecc. Tuttavia il logos non ha la funzione di rivelare l’oggetto esterno, ma è l’ “oggetto esterno” che ci informa sul significato del logos 49. Si trovano qui le origini di due differenti valori di “logos”: 1) qualcosa che si genera nella mente come risultato delle nostre percezioni; 2) un suono fonetico udibile, una parola parlata. Il fatto che un individuo non possa comunicare ad un altro qualcosa che lui stesso non possegga nel proprio pensiero, indica una triplice analisi: a) l’oggetto in sé con le sue qualità; b) ciò che noi acquisiamo da tale oggetto; c) le parole parlate con cui tentiamo di trasmettere la conoscenza di tale oggetto a qualcun altro. Gorgia ha separato le tre cose identificate da Parmenide: l’essere, il pensare e il dire50. Gorgia solleva l’intero problema del significato e della referenza (quello che, a partire da Frege e Russell, ha segnato la strada per la maggior parte filosofia contemporanea). Se le parole vengono usate per riferirsi alle cose, come mai una parola viene accettata come riferita alle cose cui diciamo che si riferisce e non ad altre cui diciamo che non si riferisce? Non c’è qualcosa nella parola che rispecchia o riproduce all’interno di essa i caratteri distintivi delle cose a cui si riferisce. Alle parole viene attribuito un significato in virtù del quale le intendiamo riferite alle cose cui riteniamo che si riferiscano. Questo significato dovrà essere qualcosa 49 Da quanto detto alla precedente nota, cadono (in forza di un essenziale nulla indistinto, sordo, muto, cieco, insensibile e stupido: più materiale che vitale) tutte le concezioni di “esterno” ed “interno”, “soggetto” ed “oggetto”; altrimenti “qualcosa” sarebbe. 50 “Il pensiero ed il pensare che esso sia sono la stessa, unica cosa. Giacché non si troverà il pensare senza l’essere in cui si esprime” (framm. 8, 34-36). Ricordiamo che Parmenide era più vecchio di Gorgia di circa due generazioni. 46 di diverso dai semplici suoni delle parole in questione. Una questione simile si presenta per gli atti conoscitivi (i pensieri e le percezioni) che traduciamo in parole. Parole, pensieri, cose: qual è la relazione che li lega? Il logos sembra avere un fondamento fissato ad ognuna di queste tre aree. Il logos di una cosa è: 1) il principio o natura o segno distintivo o elemento costitutivo della cosa stessa; 2) ciò che noi comprendiamo che essa sia; 3) la corretta descrizione verbale, esposizione o definizione della cosa stessa. Tutti e tre gli aspetti sollevano la questione dell’essere. Infatti il logos di una cosa è: secondo il punto 1) ciò che la cosa è, secondo il 2) ciò che noi comprendiamo che essa sia, secondo il 3) ciò che noi diciamo che essa sia. Che cos’altro dire ? Le tre interpretazioni del precedente capitoletto danno ineluttabilmente tre Gorgia: quello tragico di Untersteiner, quello realista-scettico51 di Levi e quello analitico di Kerferd. La sciapita dialettica della “via di mezzo” suggerirebbe di accogliere in una interpretazione globale e “virtualmente o momentaneamente definitiva” i tre contributi in un Gorgia da vedere come: per un tot di percentuale tragico per un altro realista, per un altro analitico. Quantomeno, ponendo l’accento o ammettendo l’ “esistenzialismo” gorgiano possiamo, nel bene nel male, arricchire con un po’ di sapore questa pietanza che altrimenti appare tanto necessaria da mangiare quanto inevitabilmente insipida. Per “esistenzialismo gorgiano” intendo nient’altro che questo: ogni volta che nel De Gorgia ci troviamo di fronte al verbo “eimì”, questo va tradotto con “esistere”; ad eccezione di quando ha valore copulativo; ma 51 Trovo questo termine il più appropriato o il meno inappropriato per rendere quella che è la notazione distintiva del contributo del Levi per il quale più che il mondo concreto che ci sta innanzi Gorgia intende con il suo paradosso negare la pensabilità logica ed ontologica dell’essere in generale e, in particolare, di quella struttura metafisica di cui i vari pensatori presofisti erano andati alla ricerca. 47 non è un’eccezione in grado di minare questa regola: dato che tale valore risulta, nel contesto, di forza ovvio52. Rimane da dire o da palesare, dato che gran parte di quello che avevo da notare in merito si trova nel capitoletto intitolato Problemi di traduzione come problemi ermeneutici, quali sono le principali conseguenze di tale resa. Che poi, è come dire, all’inverso, quale ermeneutica sta dietro a questa traduzione. Per Untersteiner, Levi e Kerferd lo abbiamo visto. Al primo, non interessato tanto al Gorgia gnoseologico-analitico ma a quello ontologico-esistenziale (meglio: intendendo quello nei limiti di questo) basta, per portare avanti tale ermeneutica, una traduzione di “eimì” ora con “essere” ora con “esistere”, la cosa non ha troppa importanza, importante è che emerga il conflitto del vivere. Per il Levi, anch’egli non metodicamente preso dalla traduzione di “eimì”, è sostanzialmente indifferente l’una o l’altra resa del termine, l’importante è la comprensione generale di una figura filosofica, quella di Gorgia, che se ha il grado “esistenzialista” (di analisi dell’esistenza, dell’interesse verso il rapporto uomo-mondo) tanto quanto gli attribuisce Untersteiner, tuttavia il termometro di questo grado non è offerto eminentemente dal “tragico”, bensì dalla dimensione filosofica stessa. Gorgia, per il Levi, più che un filosofo dell’esistenza è un’esistenza filosofica. Con Kerferd le cose cambiano. Sembra imporsi la traduzione di “eimì” con “essere”. Fosse possibile andrebbe dato ad “eimì” sempre il valore copulativo, essendo il più vicino a quello “logico”. È un notevole cambiamento di prospettiva. Traumatico, nei suoi rispetti, quanto il 52 Ho presente e non condivido, almeno sul lato “degorgiano”della questione, quanto dice (rifacendosi manifestamente a Khan) Enrico Berti (Il problema dell’essere e le ragioni dell’essere, cit.) “In Parmenide infatti, come in Gorgia, non esiste alcuna distinzione tra i diversi significati che possono appartenere all'essere e al non essere: ciò consente a Gorgia di confondere il significato copulativo con quello esistenziale, cioè di concludere che, se il non essere è non essere, esso è qualcosa, dunque esiste. Tale confusione sarà smascherata solo da Aristotele, grazie proprio alla sua teoria della distinzione tra i significati dell'essere. Questi infatti osserverà, con probabile allusione a Gorgia: «l'essere qualcosa (to einai ti) e l'essere [puro e semplice] non sono lo stesso, poiché non è vero che, se il non essere è qualcosa, esso sia anche semplicemente (kai estin haplôs)» (Soph. el. 25, 180 a 36-38)”. 48 passaggio dalla “vecchia filosofia” (l’esistenzialista appunto: qual è la filosofia che non si interroghi eminentemente sul rapporto uomomondo?) a quella “nuova e moderna”, l’analitica: ecco la prima filosofia, nella storia, che vuole circoscrivere il suo ambito alla dimensione logicolinguistica e lasciare l’altra metà, l’esistenziale (ovvero “ontologia”) alle scienze fisiche. Kerferd, ed è cosa molto interessante, nonché almeno in una qualche percentuale di forza vera, vuole il De Gorgia o (per lui è lo stesso) il Gorgia storico, un primo, forse miracoloso, ma comunque consapevole, precursore, “protomartire”, di questa corrente filosofica 53. Ma, allo stesso modo in cui è possibile dire che la filosofia analitica nasce virtualmente con Kant, essendo egli il primo (e non si porti, per ribattere più o meno ironicamente, l’esempio di Aristotele e delle sue divisioni metodologiche da “enciclopedia del sapere” o “campi del sapere”) a denunciare la necessità (tutta pratica nelle conseguenze, pur 53 Sulla stessa linea d’onda, ma con un approccio più storiografico, mi piace riportare il contenuto di un’ intervista rilasciata qualche anno fa da Vittorio Hoesle e adesso consultabile in http://www.emsf.rai.it/interviste : “ora è chiaro che l’importanza della parola cresce quando non si crede più in un essere assoluto. Per Parmenide l’essere assoluto è qualcosa che bisogna capire basandosi su una chiara intuizione logica. Siccome per i Sofisti non esiste una verità assoluta al di là delle nostre opinioni, la cosa più importante per avere potere è influenzare le nostre opinioni. E per ciò la sofistica dà una tale importanza alla retorica in quanto attraverso la retorica noi manipoliamo, formiamo le opinioni di altre persone e siamo in grado di usarle per il nostro interesse. Famosa la frase di Protagora che dice che lui era in grado di rendere il logos, l’argomento, più debole più forte, e cioè di farlo apparire migliore. Con ciò non è inteso che Protagora diceva io faccio apparire vero quello che è falso, perché Protagora negherebbe che esiste una verità al di là dell’apparire. Ma direbbe che il grande retore è quello che sa far apparire ciò che vuole e in questa maniera fa la verità. Per quanto riguarda l’analisi del linguaggio questo è sicuramente un grande merito della sofistica che proprio a causa di questi momenti di diffidenza verso la conoscenza umana si mette a criticare il linguaggio. Vari Sofisti, come Prodico ad esempio, analizzano omonimi. Analizzano il fatto che ci sono delle parole che significano cose diverse e che un filosofo deve essere conscio di questo fatto per non essere sedotto dal linguaggio a commettere errori logici. Protagora sviluppa il tema della “orthòtes” cioè se le parole sono giuste. Lui scopre per esempio che alcuni sostantivi della lingua greca con un significato maschile hanno un genere grammatico femminile e viceversa; l’analisi di omonimie, sinonimie, di metonimie, come la troviamo in Democrito, è sicuramente un contributo importante per una fondazione più rigorosa e più critica della filosofia. Quello che dicevo prima di Gorgia e la scissione dell’unità di essere, pensiero e parola che noi troviamo ancora in Parmenide, deve portare ad una critica del linguaggio. Bisogna scoprire che il linguaggio, la parola e il pensiero non sono identiche, ma che ci sono distinzioni fra di esse come per esempio nel caso dell’omonimia”. 49 proveniente da insanabili “limiti” epistemici) di una scissione in filosofia (che storicamente si caratterizza per la più o meno presunta forza dell’unione delle due) tra ontologia e gnoseologia; così Kerferd (filosofia analitica) prende le sue idee dal vecchio “marburghiano” Cassirer (filosofia kantiana). Se la prima parte della equazione può apparire od ovvia o gratuita, la seconda è tangibile. Basta andare alle pagine 85-89 di Da Talete a Platone 54 . Si tratta di un qualcosa della massima evidenza: Cassirer, senza forse troppa fantasia intenzionale, ma negli effetti precursore ermeneutico (siamo nel 1925) di svariate decadi, non fa altro che, aprioristicamente, applicare il suo scolastico concetto di oggettività pensabile anche a Gorgia. Facendo questo però innesca un’eterogenesi dei fini (pomposo termine per “fa tutto senza potersi accorgere di niente”) in grado di renderlo il profeta della più moderna interpretazione analitica. Cassirer, come Kerferd (e chi altri?), mette ben in evidenza il termine logos (a lui serve per richiamare la “oggettività pensabile”); e senza concepire Gorgia tragico, esistenzialista, ecc., gli attribuisce (oltre alla classica svalutazione di sofista-tecnico-non-filosofo55) quello studio della predicabilità, della logica, e comunque solo della dimensione umana gnoseologica, tenuto presente anche da Levi, Levi che aggiunge il Gorgia ontologo-esistenzialista senza togliere questo analitico. Eccolo il particolare senso in cui Cassirer intende la conoscenza un qualcosa di assolutamente altro ed incomparabile rispetto all’oggetto: instaurando un parallelo tra la “cosa” o l’ “in sé” o l’ “essere” degorgiano e l’ “essere” parmenideo egli può dire (interpretando così anche l’essenza complessiva delle “tre tesi”): “quanto poco all’essere unico spetta un qualche connotato sensibile qual che sia, altrettanto poco gli spettano predicati logici, quali che siano, poiché è proprio la predicabilità come tale a contraddire la sua natura di essere assoluto. E così la verità di 54 55 E. CASSIRER, Da Talete a Platone, cit. Si veda nota 35 50 Parmenide si annienta in se stessa e da se stessa: infatti che cosa significa verità senza predicabilità?” (p. 86). Cassirer conclude facendo vedere come in pratica la sua interpretazione gnoseologica di Gorgia porti direttamente al relativismo protagoreo: sia Protagora che Gorgia avrebbero trasferito56 il principio eracliteo del divenire dal campo dell’essere oggettivo in quello dell’essere soggettivo, dal cosmologico nello psicologico, dall’ontologia alla gnoseologia, volatizzando la verità assoluta eleatica; la verità è solo soggettiva, solo umana, solo “doxa” o “episteme” in quanto “doxa”. La verità non può sussistere al di là del mondo dei fenomeni, è un problema nostro, la verità è una nostra categoria: i fenomeni quindi non possono cogliersi come veri o essenti se non all’interno della condizionatezza e mutevolezza temporali. “Il logos dunque non esiste altrimenti che nel suo individualizzarsi e concretizzarsi 57 ; non esiste nessun metro assoluto della verità tout court, ma solo l’uomo, che imprime la particolarità della propria natura su tutto ciò che è per lui vale a dire su tutto quanto gli è dato come fenomeno”58 (p. 89; la citazione è da Cassirer, anche se sembra di sentire Husserl). 56 Ma perché, chiedo io? Il disinteresse verso l’ontologia è dato da una presa di coscienza dell’impossibilità di chiarirne le dinamiche, dal nostro conoscere per forza “prospettico” e “soggettivo” e che quindi non può colmare l’abisso per giungere all’ “oggettivo”; oppure dalla consapevolezza che la dimensione del relativo e del mutevole è insita nella realtà e si aggiunge (per una duplice irriducibilità) a quella del conoscere? 57 Da un punto di vista storico un sostegno a tali affermazioni ermeneutiche viene dal seguente commento alla terza ipotesi degorgiana e alla scoperta gorgiana in genere circa l’assurdità dell’identificazione tra il pensiero dell’oggetto e l’esistenza di questo e l’arbitrarietà della connessione tra lo stesso e il nome che vorrebbe identificarlo: “Ciò non implica però che la parola non abbia alcun valore: anche se essa non può definire la verità intesa come certezza dell’esistente, assolve pur sempre l’insostituibile funzione di descrivere situazioni particolari e di esprimere giudizi che valgono hic et nunc, cioè che possono mutare col variare della situazione stessa. Liberato da qualunque presupposto metafisico e da ogni riferimento a valori assoluti, il logos acquista così una sua piena autonomia ontologica, divenendo essenzialmente portatore di persuasione: in quanto arte del persuadere, la retorica è quella che più di ogni altra mette in condizione di sfruttare pienamente questa capacità psicagogica della parola” (MONACO, CASERTANO, NUZZO, L’attività letteraria nell’antica Grecia, Palermo, Palumbo, 1997). 58 In questo senso, secondo Cassirer, Protagora dirà la sua frase-manifesto “di tutte le cose è misura l’uomo”. 51 Prima di procedere è giunto il momento di occuparci di un contributo che deve avere valore generale. Khan, in The greek verb “to be” and the concept of being 59 , non si occupa infatti di Gorgia o del De Gorgia, bensì, e con pochi precedenti, della storia, del valore e del significato di quel termine che è al centro del nostro trattato: “eimì”. Di seguito i risultati di Khan. Ogni pensiero e concetto è condizionato dalla struttura del linguaggio nel quale è espresso. Un linguaggio può essere filosoficamente più adeguato di un altro. Il greco antico è una delle lingue più adeguate per esprimere contenuti filosofici; ciò ha avuto non piccola parte nella diffusione del pensiero greco. Nella filosofia inglese ed americana il concetto di “Essere” (Being) è visto con grande sospetto, come pseudo-concetto o mera confusione d’idee. “Essere” filosoficamente e più particolarmente logicamente non spiega nulla perché quando diciamo “è”, dobbiamo precisare se intendiamo: 1) un quantificatore esistenziale; 2) il membro di una classe; 3) un’identità. Oggigiorno è chiara la distinzione tra l’ “è” di “esistenza” e l’ “è” di “predicazione”. Tradizionalmente tuttavia è stata teoreticamente svantaggiosa la dicotomia tra l’uso esistenziale e l’uso predicativo del verbo “essere”. Essa infatti ha confuso una genuina distinzione sintattica (tra la costruzione assoluta e quella predicativa del verbo) con un contrasto semantico tra il significato di “esistere” e qualche altro significato o assenza di significato. Questa fusione di un criterio sintattico e di uno semantico in una singola antitesi 59 C. H. KAHN, The greek verb “to be” and the concept of being, in Foundation of Language, 2, 1966, pp. 245-265; del medesimo si veda anche The verb “be” in ancient greek, cit. 52 si poteva giustificare solo se ci fosse stata una diretta correlazione tra i due; solo se: 1) l’uso assoluto del verbo fosse sempre esistenziale nel significato; 2) il verbo essere nella costruzione predicativa fosse sempre privo di significato, fungendo come mera forma grammaticale per collegare il predicato con il soggetto. Ma queste assunzione sono false per il geco antico. Aristotele distingue quattro sensi-base di “eimì”: 1) accidentale, 2) sostanziale, 3) veritativo, 4) potenziale/attuale. Come si vede non v’è nessun senso che implichi necessariamente il valore “esistenziale” di “eimì”. Per un filosofo greco l’uso assoluto di “eimì” non è necessariamente “esistenziale”. Anzi, il fondamentale valore del verbo quando è usato da solo non è “esistere”, ma “essere così”, “essere vero”. Entrambi gli usi, esistenziale e predicativo, del verbo sono casi speciali di un più generale uso “veritativo”, di giudizio affermativo o negativo circa un determinato stato di cose. La verità o falsità riguarda propriamente la dimensione logica (le parole); lo stato di cose in un modo od in un altro la realtà. Ecco come “eimì” assolve precipuamente un compito rafforzativo: “ciò è proprio vero”, “ciò è veramente reale”. La struttura della realtà è quella che esprime il discorso vero (tale proprio in virtù di questa espressione): dire (alla Parmenide) delle cose che (ci) sono che esse (ci) sono e delle cose che non (ci) sono che esse non (ci) sono. Dire che cosa una cosa “è”, significa dire che cosa essa veramente (essenzialmente) “è” (si tratta della socratico-platonica “definizione”). Il verbo “eimì” è uno di quei pochi verbi a non avere né l’aoristo né il perfetto. “Eimì” ha più che “tempi”, “forme”: presente imperfetto, futuro. Si veda ciò come causa ed effetto di quanto 53 segue: 1) la concezione greca di eternità è quella di uno stabile presente (per Omero “eimì” vale “vivere”, “sopravvivere”; è con i primi filosofi che il “divenire” scaturisce da un principio “indiveniente”); 2) l’essere è antitetico al divenire; 3) la categoria di “esistenza” è estranea al mondo classico e propria di quello moderno-medievale (etimologicamente “exsistere” evoca un emergere dalle tenebre alla luce del giorno; e, a partire dalla nozione biblica di “Creazione” si differenzia da “essenza”60). Il valore fondamentale del verbo essere non è né esistenziale né predicativo, ma “locativo” (si veda il “veritativo” di poco sopra): l’espressione per dire “esiste”, in molte lingue non-indoeuropee era “c’è”, “ci sono” (corrispondente al francese “il y a” e al tedesco “dasein”). Sarebbe più opportuno parlare di un senso locativo-esistenziale di “essere”. Il valore “locativo”, che si accompagna a quello “durativo” e “veritativo” di “eimì” (i tre termini costituiscono l’ interpretazione di Kahn dell’analisi aristotelica), suggerisce una concretezza spaziale e “corporea”, significativa del predominate materialismo o comunque “materialità” di tutto il pensiero se non greco almeno presocratico. Per i presocratici è vero il seguente assioma (di origine zenoniana 61 ): ciò che è è da qualche parte, ciò che non è non è da nessuna parte. Chiarisco di aver preso in considerazione lo studio di Kahn principalmente per l’opportunità che offre esso di contestualizzare diacronicamente (nel senso saussuriano del termine) e concettualmente il vocabolo “eimì”. Con quanto segue quindi non vorrò mettere in discussione le tesi di Kahn (cosa che non pertiene al presente lavoro) ma tentare di far vedere come, a partire dal ritenere quelle vere, il De Gorgia 60 Per la precisione è la filosofia ellenistica che chiarisce sistematicamente la distinzione tra essenza (“ousìa”) ed esistenza (“ùparxis”). Es. Noi possiamo conoscere l’esistenza di Dio ma non la sua essenza. 61 Si veda D.K. 29 A 24 cit. in I Presocratici cit. 54 costituisca un’eccezione ed una rivoluzione del contesto storicolinguistico-concettuale che Kahn ci rappresenta. Ripeto, non voglio trovare una falla nel sistema ricostruito da Kahn, né avanzare a questo obiezioni o smascherarne le contraddizioni. La mia interpretazione degorgiana vuole essere l’eccezione che conferma le regole di Kahn; eccezione che Kahn, presumibilmente, non sarebbe pronto ad ammettere. È incontestabile che il De Gorgia neghi la capacità, ad un qualsiasi discorso, di esprimere la realtà. Questo, e tutto quello che ne segue (impossibilità di comprendere concettualmente la realtà, impossibilità di esprimere questa eventuale comprensione, ecc.) per quanto riguarda il senso gnoseologico dell’ “ouk eìnai oudén”. Per quanto riguarda l’aspetto ontologico il discorso si complica, e può ridursi alla domanda amletica circa il che cos’è a non essere. Potrebbe trattarsi della nostra conoscenza, a non “essere”, ovvero a non saper rendere conto della realtà (o a non saper “raggiungere”, “afferrare” questa). In tal caso la gnoseologia sarebbe il centro del trattato e di ontologia se ne parlerebbe solo in funzione e nei limiti di questa; come cioè una sorta di incognita da presupporre ma da non considerare troppo, dato che in una inevitabile visione o dimensione antropocentrica il problema conoscitivo (umano cioè) è il solo che interessa e ciò perché, soprattutto, è l’unico di cui ci si può effettivamente occupare (che possiamo in qualche modo “afferrare”). Se il discorso degorgiano si riducesse a ciò potremmo plausibilmente ipotizzare un procedimento concettuale che poi ha portato alla stesura del trattato, simile al seguente: vista la “relatività” e (soprattutto) la “convenzionalità” del nostro conoscere, possiamo dedurre che nulla è in quanto per noi (e non c’è altro al di fuori del noi o, il che è lo stesso, al di fuori della nostra conoscenza) è impossibile il raggiungimento dell’oggettività, della stabilità, della non-convenzionalità, dell’esistenza. Data per acquisita la parte “gnoseologica” della sua speculazione all’autore non sarebbe restato che estendere questo non-essere alla realtà globale, e lo avrebbe potuto fare per la stessa ragione per cui ha negato 55 l’essere a quella umana: perché altra realtà non c’è, e se questa che c’è è tale (relativa, convenzionale) è come se non vi fosse. E quindi nulla è. Infine, al momento di tradurre per scritto queste conclusioni la parte “ontologica” avrebbe benissimo potuto precedere quella gnoseologica che tuttavia, nel processo speculativo, viene prima (è la causa di un effetto che se non si identifica con essa stessa viene considerato come pura ipotesi o punto da tenere presente solo per completezza). Vediamo che uso si può fare di Kahn circa questa prima ipotesi di lettura del De Gorgia. Se “eimì” usato in senso assoluto avesse, nel De Gorgia, il valore di “ciò che è proprio vero”, “ciò che è veramente reale”, ecco come suonerebbe uno dei passi principali del trattato (979a 25): “Se è veramente reale, il non veramente reale come non veramente reale, in niente sarà da meno il non veramente reale dal veramente reale. Perché il non veramente reale è veramente reale come non veramente reale e il veramente reale è veramente reale come veramente reale”. Se la prima parte della frase (fino al punto) è incomprensibile, la seconda è illogica. È vero che ho costruito questa frase ad hoc ma è anche vero che tutte le varie difese che potrebbe assumere Kahn con questi medesimi argomenti sono smontabili come segue: 1) se egli o chi per lui pensasse di poter tradurre “eimì” ora con “è” ora con “è veramente reale” si contraddirebbe con le proprie tesi: infatti nel passo in questione, palesemente, non compare alcun uso copulativo del verbo, ma solo valori “assoluti”; 2) e se si riconoscono due valori assoluti ad “eimì” più uno che è la negazione di uno dei due, non si fa altro che condividere la mia posizione; principalmente difatti io sostengo solo questo: il procedimento logico degorigano è quello di mettere in relazione tre termini di cui due contrari e far vedere come i due contrari siano comprensibili o comunque “trattabili” solo a partire da un sostrato “essenziale” comune; per la correttezza di questo schema logico potevano usarsi anche i verbi “fare bene”, “correre” e “non-correre”; 3) infine chi traduce “eimì” sempre allo stesso modo, quale esso sia, ricade nelle contraddizioni di cui ho dato 56 esempio in merito al caso della Timpanaro-Cardini in Problemi di traduzione come problemi ermeneutici. Quest’ultimo punto serve anche a tutelarmi contro chi mi accusasse di aver mal interpretato Kahn. Ammesso infatti pure questo qualunque valore si dia ad “eimì” se non gliene si daranno due diversi sarà fatale ricadere nella contraddizione del punto 2); mentre con altri valori avremo solo un De Gorgia diverso, che nega cose diverse, ma che pur mantiene quello schema logico da me considerato il suo centro focale. Vediamo ora come reagiscono le categorie di Kahn nell’altra macroscopica interpretazione del De Gorgia. Essa è la seguente. “Ouk eìnai oudèn” è un’asserzione e significa che non esiste nulla. Agli altri l’onere di dimostrare il contrario (si pensi alla Prima Meditazione di Cartesio). Per parte sua il De Gorgia offre tutta una serie di motivazioni per cui non si debba considerare plausibile nemmeno l’esistenza del nulla. Dando ad “eimì” un valore “locativo”, “veritativo” o “durativo” le dimostrazioni degorgiane possono assumere interessantissime sfumature concettuali. Tuttavia, e non tanto per una questione di buon senso, quanto anche solo di calcolo di probabilità, è più plausibile che nel V secolo a.C. Gorgia o chi per lui si sia messo a scrivere un trattato, sul tema “non esiste nulla”, oppure su temi del tipo “non c’è nulla”, “non è veramente reale nulla”, intesi, si badi bene, come non-sinonimi del primo? E ciò considerando che lo stesso Kahn ci sottolinea la “concretezza materialistica” di tutto il pensiero presocratico: data quest’ultima, un sofista intenzionato a negare il tutto, avrà mirato ad un qualcosa di eclatante come l’esistenza oppure a cose che veramente rasentano lo pseudo-concetto come “l’essere veramente reale”? Tali considerazioni possono forse apparire ingenue e grossolane ma servono solo come ritorsione contro chi (forse troppo dentro la dimensione “teoretica”) ritenesse che 400 anni prima di Cristo non urgesse tutta la tangibilità delle cose e, se pur chiamato diversamente e diversamente compreso, non fosse onnipresente quel concetto che noi oggi chiamiamo in modo neutro 57 “esistenza”. In ogni caso le contraddizioni di una traduzione “univoca” di “eimì” presenti sul lato gnoseologico valgono parimenti su quello ontologico, essendo queste categorie che emergono solo in sede ermeneutica e non (pur con tutte le precisazioni del caso) in quella ontologica. Il cos’altro I chiarimenti sarebbe sempre meglio farli strada facendo; in caso contrario, tuttavia, ci si accontenti pure del detto per cui tardi è meglio che mai. In questa conclusione per metà chiarirò o cercherò di; per metà no. Il mio primo dovere è saldare il conto con un termine di cui ho forse abusato; abuso che a sua volta devo, almeno dal capitoletto precedente, svolgere nelle conseguenze. Ovviamente il termine sotto giudizio è “esistenza” o, peggio ancora, “esistenzialismo”. Se una certa neutralità può dare ragione per il primo, al secondo, così tanto inevitabilmente carico di malizia storico-filosofica, pare non potersi offrire scampo. Dico subito che l’ho usato come Gorgia ha usato “eimì”: non aveva altri termini. Sarebbe stato meglio se avessi usato omni tempore la perifrasi “la filosofia incentrata sulla speculazione circa l’esistenza umana del De Gorgia”, anziché, come ho fatto, “l’esistenzialismo degorgiano” 62? Basti questo (ma nelle prime battute di 62 Pur avendo ben presente il fatto che il De Gorgia si riferisca ad una dimensione “universale” e, nel dimostrare che nulla esiste, questo voglia dire, e cioè non che non esista nulla “per noi” ma tout court, ho creduto bene avvalermi dell’espressione “esistenza umana” come perno centrale del trattato per due motivi collegati: 1) la seconda parte del De Gorgia è gnoseologica, quindi, di necessità, antropologica: e, se la prima parte vuole offrirsi come premessa fondante della seconda sarà anch’essa da ricollegare alla dimensione “umana”, salvo il lecito passaggio dal “generale” (ontologia: non esiste nulla) al “particolare (gnoseologia: a noi umani, che non esistiamo, non è dato conoscere le cose, che non esistono); 2) una notevole dimensione “relativistica” è innegabile all’opera; quindi, essendo già impossibile parlare da una “mia” prospettiva in quanto ognuno di noi è in continuo mutamento da attimo ad attimo e da stato a stato, fino a non esservi o dissolversi la dimensione dell’ “identità”, dell’ “io” , come sarà possibile che parli non solo al di là della mia soggettività, ma, andando anche oltre la prospettiva umana (seconda soggettività), riconduca (anche se “negativamente” o per negarne la comprensione e comunicatività) il presunto o ipotetico stato “oggettivo” 58 trattazione già l’avevo detto) a fugare ogni accusa contro eventuali mie decisamente fuori luogo - simpatie verso Heidegger e compagnia 63. Certo, ora che siamo entrati in argomento, qualche ipotesi ermeneutica in proposito potrebbe anche farsi; per un parallelo poi nemmeno troppo fantasticato: nel 1943 Sartre (come risposta “a distanza” al De Gorgia?) ha scritto un saggio dal titolo L’essere e il nulla! Prima di procedere ho il desiderio di fare una precisazione di altra natura e forse doverosa. Questo lavoro è, fin dalle prime battute, consacrato al metodo ermeneutico ed all’interno di tale dimensione vorrebbe universale al logos? Questo secondo punto serva anche come confutazione del filosofare degorgiano; ossia serva a dimostrare che l’autore del De Gorgia per provare coerentemente quanto sostiene avrebbe dovuto stare zitto, non lo avrebbe potuto “dimostrare”; anzi, non avrebbe potuto pensarlo, oltre che scriverlo. Preciso che ritengo l’ultima osservazione, riportata per completezza ermeneutica, irrilevante alla cogenza del trattato in quanto il presupposto di esso è che, al di là del “non esiste nulla” sia possibile solo “convenzione” (unico “essere” che continua a fare da “nulla”): e quindi, scrivere, pensare, dimostrare, sono tutti atti “convenzionali”, ovvero “nulli”. La coerenza stessa non conta perché non esiste nulla in quanto tutto quello che esiste è convenzionale, e quindi non conta. 63 Heidegger di cui, in ogni caso, tengo presenti i passi più eclatanti: “La comprensione dell'essere, definita così, in pochi tratti, si mantiene sul piano senza scosse e senza pericoli della più pura evidenza. E tuttavia, se la comprensione dell'essere non avesse luogo, l'uomo non sarebbe mai in grado di essere l'ente che è, anche qualora fosse dotato delle più straordinarie facoltà. L'uomo è un ente che si trova in mezzo all'ente, e vi si trova in modo tale, per cui l'ente che egli non è e l'ente che egli stesso è gli sono sempre già manifestati. A questo modo d'essere dell'uomo diamo il nome di esistenza. L'esistenza è possibile solo sul fondamento della comprensione dell'essere. Nel rapportarsi all'ente che egli non è, l'uomo si trova già davanti l'ente come ciò che lo sostiene, ciò cui si trova assegnato, ciò che, con tutta la sua cultura e la sua tecnica, egli non potrà mai, in fondo, signoreggiare. Assegnato all'ente diverso da lui, l'uomo non è in fondo, padrone nemmeno dell'ente che egli stesso è”. (M. Heidegger, Kant e il problema della metafisica, introduzione di V. Verra, Laterza, Bari-Roma, 1989, pp. 195-196); “Quello di essere è un concetto ovvio. In ogni conoscere, in ogni asserzione, in ogni comportamento [che ci pone in rapporto] con l’ente, in ogni comportamento che ci pone in rapporto con noi stessi si fa uso di "essere", e l’espressione è "senz’altro comprensibile". Tutti comprendono cosa significhi: "Il cielo è azzurro", "Sono contento", e così via. Ma questa comprensione media non dimostra che un’incomprensione. Essa sta a denunciare che in ogni comportamento e in ogni modo di essere che ci ponga in relazione con l’ente in quanto ente si nasconde a priori un enigma. Il fatto che già sempre viviamo in una comprensione dell’essere e che, nel contempo, il senso dell’essere continua a restare avvolto nell’oscurità, attesta la necessità fondamentale di una ripetizione del problema del senso dell’"essere".(M. Heidegger, Essere e tempo, a cura di P. Chiodi, U.T.E.T., Torino, 1994, p. 56). 59 conchiudersi. Tuttavia ciò è da me ritenuto valido solo se per “ermeneutica” si intende un termine del linguaggio comune (un tempo indicante in teologia l’interpretazione della Bibbia, ed in giurisprudenza quella delle leggi) che sta per “arte dell’interpretazione” e quindi “arte di saper ascoltare”; dopodiché si può chiarire, criticare, analizzare. Spero mi sia possibile non avere nulla a che fare con lo “storicismo” o la “fenomenologia heideggeriana” pur condividendone i risultati laddove si esauriscono nel ricercare le correlazione processuali intercorrenti tra la totalità delle manifestazioni umane, le sue parti e viceversa. In particolare ritengo sia oggi ancora possibile un’ermeneutica (cioè dire “civilmente” la nostra) senza incappare in quella figura che da mezzo secolo a questa parte è diventata l’antonomasia del termine: e cioè Gadamer. Stilando le conseguenze della mia traduzione di “eimì” con “esiste” è come se dicessi le ragioni ermeneutiche di ciò e giustificassi, palesandola, la mia interpretazione del De Gorgia. 1) Un insieme finito S di proposizioni implica una proposizione A se e solo se l’insieme S1 ottenuto aggiungendo non-A a S è inverificabile. L’essere è; il non essere è (che è come dire l’essere non è); quindi l’essere (non essendo inverificabile il non-essere) non è: l’insieme dell’essere non implica la proposizione di essere, né l’insieme delle cose che sono lo stato di essere. Non solo è il non essere a non essere, ma anche l’essere. Questo è ciò che ha in mano chi traduce “eimì” sempre con essere e tra l’essere ed il non-essere non ammette un terzo “sub-stantiale” termine come l’esistenza o l’esserci. È vero, può darlo per implicito o lasciarlo dedurlo al lettore, il “senso esistenziale”, ma dato che esso è esplicitabilissimo in italiano, perché non farlo? Ne guadagneremmo in chiarezza ed onestà; anche se, come al solito, queste due posizioni implicano quella spinosa di responsabilità. Spiego. Ogni volta che ci troviamo di fronte a passi (già esaminati nel capitoletto Problemi di traduzione come problemi 60 ermeneutici) tipo 979a 25, a dire “il non essere è essere e l’essere è essere, sicché le cose che sono non hanno alcuna superiorità su quelle che non sono” se non diamo, diluendone la concentrazione, un qualche valore diverso dal letterale a quell’ “è” oppure qualcosa del genere non facciamo con l’ “essere” e con il “nonessere”, sortiamo un effetto di insensatezza ed inintelligibilità. Senza considerare l’evidente violazione del principio di identità (“il non-essere è essere”, “Camillo è non-Camillo”). All’interno di questa presa di coscienza si sostenga pure la posizione (raffinata) di Kerferd e si continui a tradurre “eimì” solo con “è” in forza di una programmatica ed interessante non- ontologizzazione del discorso; ma, almeno in fase di critica, va esplicitato a chiare note essenzialmente questo: comunque si interpreti il De Gorgia ci è inevitabilmente richiesta una distinzione di tre termini categoriali, risultando due “indialettizzabili”. A partire dall’essere e dal non essere che il terreno comune sia costituito dall’ontologia (“esiste”) o dalla gnoseologia (“è”) non è metodologicamente scorretto: anzi, l’interesse aumenta quanto quello verso un qualcosa analizzato prima dal punto di vista fisico e poi da quello logico. Rimane la domanda (a cui Kerferd e gli altri hanno risposto) circa quale di questi aspetti premesse più a Gorgia; ma a noi qui, in quanto ermeneutici sempre alla ricerca di eterogenesi dei fini, non interessa 64. 64 Riassumo così il contributo di Adorno espresso in vari luoghi (La filosofia antica, voll. 2, Milano, 1961-1964; I Sofisti e Socrate, Torino, 1961): l' intuizione gorgiana consiste nel fatto che il mondo degli uomini è costruito con le parole e che quindi il lògos ha una funzione poietica. Il rapporto con gli uomini infatti non viene creato una volta per tutte, ma deve essere sempre rinnovato. Il pensiero ionico influenzò i sofisti, che adottarono come parola d'ordine “non uscire dal fenomeno” e quindi dai rapporti umani, che sono fatti di parole. Il termine essere in Aristotele ha soltanto un valore verbale, mentre il tò òn, il "ciò che è in quanto è quello che è" non indica l'essere come sostantivo e oggetto metafisico, ma la ragione logica o essenza di una cosa. 61 2) Compresa la necessità di un terzo termine oltre l’essere ed il non essere, rimane l’arduo compito di dare un’identità a quest’ultimo. Il mio scopo primario tuttavia, qualora venga ammesso tale terzo temine l’ho già ottenuto. Il punto capitale infatti non è tanto fare di Gorgia un’esistenzialista nel senso di interessato al fenomeno tangibile da noi chiamato esistenza, quanto di vederne lo spessore filosofico nella discoperta “basica” oltre sia l’essere sia il non essere, categorie inadeguate ad una resa complessiva del reale. Ancora: Gorgia sembra non proporsi come il solito “riempitore di caselle concettuali vuote”, bensì, kantianamente, come un analizzatore e formalista di metodo. Egli non si presenta asserendo che alla base dell’universo c’è questo e questo, poi una causa, infine un effetto (come i filosofi prima e dopo di lui hanno invece quasi sempre fatto); egli non si presenta né con dèi né con sostanze prime: bensì col nulla. Con una tabula rasa. Per farci capire la convenzionalità del nostro porci dinanzi alla realtà, che è essa stessa convenzionalità un porre la realtà. Ecco come “riempire la terza casella” non rientra negli interessi del De Gorgia; in questo senso al sofista non interessa la verità. Ma, a partire da un reale inconoscibile ed impercepibile se non relativisticamente e convenzionalmente (prima come specie, la umana; poi come individuo, il soggetto; poi come stati all’interno di un presunto stesso individuo), palesare le categorie (le convenzionali appunto) all’interno delle quali stiamo. La “terza casella” è, il riempirla, una contraddizione in termini proprio perché, costituendo essa la “base oggettiva” dello stato universale, il punto a partire dal quale essere e non essere si dicono, il punto a partire dal quale “si dice”, umanizzarla, soggettivizzarla, relativisticamente, convenzionalmente (e non ci è dato altro tipo di operazione) è, al contempo, farcela sfuggire, vederla svanire, renderla più lontana. E questo è il messaggio 62 ultimo a tutti i filosofi-fisici che pretendono di stringere effettivamente la realtà con i loro concetti, di potersi sintonizzare sulla sua frequenza. Con questa premessa la posizione di Kerferd acquista la fisionomia che mi interressa e condivido. La logica non si occupa di che cosa di fatto è vero o falso. Col “nulla” (ontologico e gnoseologico insieme) degorgiano, questa logica diventa la filosofia tout court. La coscienza della convenzionalità; ed oltre non c’è niente proprio perché non-convenzionale ed in quanto tale, in quanto non-umano o disumano, inesistente. Umanamente. E noi siamo di necessità umani: ed universali in tanto in quanto non usciamo da questa necessità (che equivale ad ubbidire alle leggi naturali). Si altererebbero gli equilibri universali se noi uscissimo dalla nostra “parte”; uscita che proprio la comprensione di questi tuttavia richiederebbe. Sennonché, forse, l’universo non ha che “prospettive” o “punti”, per cui è impossibile da questi peculiari uscirne proprio perché inutile. L’unica oggettività sembra divenire la soggettività; ma questo non ne scusa né impreziosisce il limite 65. 3) Il mondo è andato in un certo modo, ma sarebbe potuto andare in molti altri modi. È il classico e forse unico “credo” della logica. Ma anche del De Gorgia. Un testo che sembra fuori dal tempo e dallo spazio (e, effettivamente, lo è, almeno in parte: non ne 65 Una qualche completezza potrà risultare dal contenuto del già citato volume della Cassin, L’effet sophistique, che così sintetizzo: la sofistica è un fatto di struttura e nasce dalla struttura stessa della filosofia: Gorgia nel Trattato del non essere mostra che all'interno del poema di Parmenide, al contrario di quanto è in esso sostenuto, l'essere è un effetto del dire: ciò che viene prima è il linguaggio, il discorso e non l'essere. La sofistica è insopportabile per la filosofia, mostra i limiti e le conseguenze di ciò che afferma, per questo il sofista è allontanato e considerato un impostore. Nella rilettura contemporanea la sofistica è considerata eminentemente politica, è una retorica politica che consente la costruzione della città intesa come l'insieme dei discorsi che la compongono. I sofisti furono i primi a sfruttare i “performativi”, vale a dire quelle asserzioni che non comunicano qualcosa, ma producono effetto nel mondo, e mostrare il nesso tra città, parola e “omologia”, accordo tra discorsi. Tracce di questo accordo si ritrovano in Aristotele per cui, il consenso (l'omologia) è il risultato del contributo che ciascuno è chiamato a portare a partire dalla propria prospettiva singola. 63 sappiamo né l’autore, né la periodizzazione, né il contesto, né gli scopi); destoricizzarlo lo rende “eterno” e quindi “logico”. È la forza dell’ermeneutica che vive solo di concetti e questi di atemporalità, questi che sono tali proprio a partire da quest’ultima66. 4) “Sul non essere ovvero sulla natura”. Concentriamoci sulla seconda parte del titolo tramandatoci da Sesto Empirico. Va detto subito che potrebbe essere un’ingenuità, un fare di tutta l’erba un fascio, da parte di Sesto o delle fonti da cui egli ha attinto: dato che gran parte delle opere presocratiche venivano intitolate “Sulla natura”, potrebbero aver ragionato costoro, anche quella di Gorgia avrà avuto un similare riferimento. Non solo non è necessario un simile titolo ma (come dimostrano anche tutti questi “Sulla natura”) non è nemmeno necessario che un’opera dell’epoca del sofista o a maggior ragione di epoca precedente, 66 È interessante l'attenzione che alcuni autori hanno prestato alle procedure logicoargomentative utilizzate nel De Gorgia. WESOLY [Le tecniche argomentative di Gorgia intorno alla tesi che nulla esiste, “Siculorum Gymnasium”, 38, 1985, pp. 311341] riferendosi alla sezione dell'opera gorgiana relativa alla confutazione dell'essere come generato, ingenerato, uno o molteplice, rileva una tecnica logica che consiste nella prova indiretta o dimostrazione per assurdo che, sebbene debba molto a Zenone, è pur sempre originale al punto di fornire nuove prospettive al discorso retorico e confutatorio. PEPE [Su di un passo del Sul non essere (D.K. 82 B 3), “Siculorum Gymnasium”, 38, 1985, pp. 501-10] riscontra in Gorgia i primi rudimenti del principio di non contraddizione, presente anche nell' Apologia di Palamede, e mette in evidenza l' uso causale-esplicativo della particella “oti”, la quale sarebbe una prima anticipazione del nesso aristotelico ~. CASERTANO [Natura e istituzioni umane nelle dottrine dei sofisti, Napoli-Firenze, 1971, pp. 137-176.] e COSENZA [Gorgia e le origini della logica, “Siculorum Gymnasium”, 38, 1985, pp. 145-155], infine, rilevano la presenza di formule logiche paragonabili a due sillogismi di prima figura aristotelici (precisamente il sillogismo in Celarent e il sillogismo in Cesare) e al secondo anapodittico della logica stoica (chiamato “modus tollendo tollens”) avvicinabile al sillogismo che Aristotele definisce “ex hypotheseos”. Naturalmente con questo non si vuole dire che tali strutture logiche siano nate con Gorgia, ma ciò autorizza a ritenere che le due grandi logiche antiche, cioè quella aristotelica e quella stoica, derivino dall'elaborazione di materiali dell'epoca della maturità del Sofista e forse anche precedenti. 64 avesse un titolo che potrebbe invece essergli stato attribuito successivamente (ed in questo i filologi alessandrini potrebbero aver avuto un ruolo non marginale). Perché dire tutto questo, tanto più che il De Gorgia non ha, oltre all’autore, nemmeno un titolo? Perché se quei contenuti, e nel succo sono i medesimi quelli di Sesto e quelli dell’Anonimo, potevano venire sentiti già dagli antichi come riferentisi “alla natura”, cioè alla costituzione del (più o meno “nostro”) mondo, allora è doveroso riconsiderare lo spessore e l’interesse “ontologico” degorgiano. E, sempre allora, quando vi si dice che “nulla esiste” o “nulla è” non si intende per noi, per voi o sotto qualsiasi altro rispetto (gnoseologicamente, ad esempio), bensì tout court. Questa è la premessa per introdurre più giustificatamente quanto segue. Cassirer e Kerferd sono stati coloro che, nell’interpretazione della gnoseologia gorgiana, hanno dato il contributo più intelligente e significativo; il loro Gorgia-analitico, non sarà distante dalle dimostrazioni, tastabili con mano, dell’Anonimo. Ma questa è solo la metà di un’esegesi, quella del De Gorgia, che è speculare a quella della realtà nel suo complesso. La parte ontologica sarà ineliminabile. Ed ecco che ritorna attuale in particolare il contributo di Levi, mentre quello di Untersteiner sarà messo un po’ da parte in sede ermeneutica, nonostante i suoi notevolissimi meriti storiografico-metodologici, causa quell’unilaterale intesa “tragica” sia del fronte ontologico sia dello gnoseologico. Voglio dire: il De Gorgia (da qui la divisione del capitoletto sulla Formalizzazione dei contenuti) andrà recepito come interessantesi sia dell’aspetto ontologico sia di quello gnoseologico, con tuttavia la seguente complicazione (che ne costituisce l’acume filosofico): ontologia e gnoseologia non formano due paralleli, non richiedono due approcci diversi e non sono distinte, bensì, circolarmente, reciprocamente e indefinitivamente, si rincorrono: 65 nulla è conoscibile perché nulla esiste, ma anche (e di pari ragione) nulla esiste perché nulla è conoscibile. Qualora qualcosa esistesse, diverrebbe subito conoscibile; qualora fosse conoscibile, esisterebbe. Insistendo ancora sulla equivalenza di entrambi gli aspetti del processo, si intensifichino le due componenti basilari (esistere e conoscere) per comprenderne il senso. Ne risulterà questo: non esiste nulla perché di nulla possiamo avere una conoscenza o visione completa, esauriente, definitiva; e non c’è bisogno di aggiungere un “per noi”; tocca infatti a coloro che sostengono che qualcosa di oggettivo e sussistente vi sia e che si tratti solo di banale, umana, deficienza, dimostrare il contrario. “Il realista metafisico che crede in un mondo esterno indipendente dal nostro percepirlo, non può escludere in linea di principio di essere un cervello in una vasca, mente il realista interno, per il quale il mondo non esiste indipendentemente dalla cornice teorica entro la quale ne parliamo, riesce invece a dimostrare che quell’ipotesi è contraddittoria: se fossimo tutti cervelli in una vasca non ci sarebbe nessuno che standone fuori potrebbe constatarlo” 67 … ed infatti non c’è nessuno, conclude il De Gorgia, al quale, la cosa, risulta del tutto indifferente, o meglio non risulta: le cose cessano di risultare e rimangono, se per la convenienza socialeconvenzionale si vogliono far rimanere, soltanto ipotesi più o meno meglio congeniate, dei focus la tensione verso i quali ce la diamo, arbitrariamente, noi stessi. Da qui la “retorica” come l’unico atteggiamento che onestamente denuncia la presa di coscienza di tale stato di fatto. “Uno degli aspetti più fastidiosi della vita intellettuale del nostro tempo è il così ampio consenso concesso all’irrazionalismo e il fatto che le 67 PUTNAM H., 1981, trad. it., Ragione, verità e storia, Milano, Il Saggiatore, 1985, riassunto in NANNINI, L’anima e il corpo, cit. 66 dottrine irrazionalistiche siano date per scontate. Una delle componenti del moderno irrazionalismo è il relativismo (la dottrina secondo cui la verità è relativa al nostro ambiente intellettuale, ambiente che si suppone determini in qualche modo la cornice all’interno della quale siamo in grado di pensare: che la verità possa cambiare da una cornice all’altra), e, in particolare, la dottrina che sostiene l’impossibilità della reciproca comprensione tra differenti culture, generazioni o periodi storici – anche all’interno della scienza, e persino della fisica”68. Per il De Gorgia la “verità”(costrutto umano) è separata dalla “realtà” (cosa in sé inidentificabile finanche da sé stessa): la prima, con questa sua separazione, finisce per non essere o esistere; dovrebbe esistere solo ciò che è reale ma non essendo questo per nessuno in quanto nessuno può diventare qualcuno uscendo dalla realtà e comprendendola dal di fuori, anche quest’ultima finisce per non essere. Razionalità ed irrazionalità sono cose identicamente indifferenti, qualificandosi, come ogni categoria, come ogni presunto essere, umanamente; indifferenti alla cosa in sé che è l’indifferente e l’ignorante per eccellenza. Fisica e metafisica finiscono per coincidere nel loro non uscire da sé stesse, non uscire dall’umano, quando la realtà autentica non è al di sopra ma nel diverso dall’umano. Diverso irraggiungibile perché, ammessa una comunque impossibile uscita dall’umano ci ritroveremmo sempre di fronte delle categorie, dei paradigmi o dei punti più o meno di vista. Cioè la cosa che più di tutte era da fuggire. Questo dal lato gnoseologico della questione sull’ “ouk eìnai oudén”. Per quanto riguarda il lato ontologico è lo stesso, dato che l’umano ha un solo lato, quello alla sua fenomenicità relativa, e per il quale ontologia e gnoseologia si danno al massimo come aspetti o approcci diversi (con una seconda illusione-interpretazione dopo quella che allontana dalla cosa in sé). Per quanto la scienza progredisca lo farà sempre umanamente, e quindi nullamente. La materia inerte sembra K. R. POPPER, Il mito della cornice. Difesa della razionalità e della scienza. Bologna, Il Mulino, 1994, p. 57 68 67 presentarsi come il corrispettivo più prossimo “all’in sé” o “aprospettico”. Per onestà la fisica può al più denunciare questo suo limite e farlo nel ritenerlo connaturato alla sua stessa dimensione di “cosaumana”. È quello che, oramai fino all’abuso o alla banalizzazione, ha fatto nel corso del XX secolo: “Nella fisica classica la ricerca si proponeva di studiare fenomeni obiettivi che si verificano nello spazio e nel tempo, e le leggi che ne determinano lo svolgimento in base alle condizioni iniziali. Un problema era considerato risolto, se si era riusciti a collocare oggettivamente un dato avvenimento nello spazio e nel tempo e a dimostrare che obbediva a leggi generali della fisica classica formulate in equazioni differenziali. […] Nella teoria quantistica troviamo invece una situazione del tutto differente. La circostanza che il formalismo della meccanica quantistica non possa essere considerato come una descrizione intuitiva d'un avvenimento che si svolga nello spazio e nel tempo, mostra che la stessa non si occupa affatto della determinazione oggettiva di avvenimenti spazio-temporali. […] Questa relazione d'indeterminatezza per i risultati della misurazione di variabili classiche formano la condizione necessaria affinché il risultato d'una misurazione possa essere espresso con il formalismo della teoria quantistica” 69. 69 W. HEISENBERG, Lo sviluppo della meccanica quantistica (1933), in Mutamenti nelle basi della scienza, Torino, Boringhieri, 1978, pp. 29-32 68 69
Scaricare