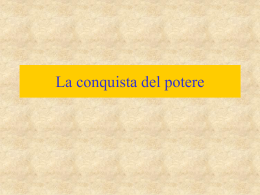L’occhio del regime sulla Grande guerra: l’Istituto Luce tra informazione, memoria e propaganda di Antonia Liguori Considerazioni preliminari È ormai un’acquisizione condivisa dalla migliore storiografia contemporanea la necessità di individuare nella Prima guerra mondiale le premesse che hanno consentito l’affermazione del movimento fascista in Italia. Tale consapevolezza è palese sia in quegli storici che interpretano l’evento bellico come momento catalizzatore delle trasformazioni già in atto dal punto di vista sociale, economico e politico, sia in quegli studiosi che hanno focalizzato la loro ricerca su una tematica specifica – carica di notevoli implicazioni di natura antropologica e sociologica – come quella della connessione tra la mobilitazione del popolo per la guerra e il contemporaneo avvio di quel processo definito come «nazionalizzazione delle masse». Una prospettiva di questo tipo rende indispensabile una maggior attenzione a tutto ciò che ruota attorno al concetto di “partecipazione”, inteso non soltanto come effettiva integrazione del popolo nella vita dello Stato durante e soprattutto dopo l’evento bellico, ma anche come una sorta di atto di accusa mosso prima – e cioè alla vigilia dell’intervento – dagli intellettuali al ceto dirigente e, successivamente, dai gerarchi del regime fascista all’élite culturale. Si tratta, in realtà, di una tematica che consente numerosi riferimenti a quel dibattito che si protrasse per l’intero arco del Ventennio e che culminò con la pubblicazione del veemente articolo di Bottai sull’«interventismo della cultura». L’immagine che del popolo avevano fornito gli intellettuali negli anni compresi tra il «piccolo dopoguerra libico» e l’intervento italiano del maggio del era in un certo senso sintomatica del fallimento di un approccio che, comunque, rimase di natura elitaria e che, perciò, rese evidente la scarsa percezione – da parte di quella cultura che «se ne stava alla finestra» – delle implicazioni connesse all’avvento della società di massa. E l’insuccesso dell’élite intellettuale, che, alla vigilia della Grande guerra, si arrogava il diritto di presentarsi Dimensioni e problemi della ricerca storica, n. / ANTONIA LIGUORI come «voce della coscienza nazionale», sarebbe divenuto ancor più palese – a posteriori – a confronto con la straordinaria efficacia dell’organizzazione del consenso attuata in pieno regime. Quanti si proponessero di individuare i moventi ideologici che hanno indotto il «fascismo-movimento» a cercare nella Grande guerra – e, più in particolare, nel perdurare del suo mito – la legittimazione storica e la propria ragion d’essere, troverebbero nel patrimonio filmico conservato presso l’Archivio storico dell’Istituto Luce una fonte indispensabile per l’individuazione di quelle componenti emotive che possono sfuggire alla consultazione dei documenti e delle memorie. È opportuno, infatti, verificare la possibilità e la relativa validità dell’uso delle immagini come fonte storica, in un ambito nel quale non si ha come scopo la ricerca di una presunta oggettività – come vorrebbe uno scolastico neopositivismo – quanto piuttosto il tentativo di ribadire la necessaria priorità della norma storiografica della contestualizzazione. Per valutare a tutto tondo il panorama nel quale ha preso forza il mito della Grande guerra, così come il fascismo-regime lo ha poi consegnato al popolo italiano, è tuttavia necessario ampliare il concetto di produzione culturale, sia per considerare la sua effettiva incidenza sulle masse – cosa che non sarebbe possibile qualora si prendesse in considerazione soltanto il dibattito culturale qual è stato vissuto dagli addetti ai lavori – sia per verificare l’impatto che la “favola” della «quarta guerra d’indipendenza» ha avuto negli ambienti più disparati, dalle aule scolastiche alle piazze, dalle sale di proiezione cinematografica alle terre d’oltremare. Proprio dopo la recente pubblicazione del testo di Norberto Bobbio sulla cultura a Torino tra le due guerre, si è nuovamente ravvivato un dibattito storiografico che sembrava ormai sopito. Si tratta della “vecchia” querelle relativa all’esistenza di una “cultura fascista”, questione preliminare per chi si accinge a verificare proprio nell’organizzazione del consenso le tracce della cultura di massa. Il filosofo torinese ripropone quella coincidenza tra fascismo e incultura che fu fornita come chiave interpretativa di base dalla storiografia di sinistra, che, sul finire degli anni Sessanta, partendo da presupposti crociani, salveminiani o gramsciani, dava sostegno alla fortunata definizione coniata da Venturi. In una delle sue lezioni, infatti, egli condannava il fascismo delle origini – e con maggiore acredine il regime – senza alcuna possibilità di replica, stigmatizzando con il marchio della “retorica” la produzione culturale del Ventennio, alla quale affiancava la definizione onnicomprensiva di «regno della parola che si muove in un mondo di fenomeni che finisce per credere reali». Una concezione, quella di Venturi, che lascia poco spazio al momento creativo e perciò ratifica l’inesistenza stessa di una cultura propriamente detta. L’ISTITUTO LUCE TRA INFORMAZIONE, MEMORIA E PROPAGANDA Già prima della pubblicazione del più recente volume di Bobbio – che in realtà è stato concepito dall’autore alla fine degli anni Settanta – Angelo D’Orsi, dalle colonne de “Il Foglio”, aveva dato il “la” a una polemica, che, sia per le dimensioni che per la durata, in alcuni casi è apparsa fine a se stessa e priva di quei riferimenti a una più ampia interpretazione del fenomeno fascista che imporrebbero al dibattito una diversa sede e un maggiore sostegno scientifico. Proprio i tempi e i modi del rapido ravvivarsi e diffondersi del vecchio “dilemma” – in un certo senso già risolto dallo stesso Bobbio nel suo volume diffuso in sordina all’inizio degli anni Novanta – impongono una rapida riflessione sulle implicazioni relative all’uso pubblico della storia. Con la chiusura del Novecento si sono moltiplicati i tentativi di sintesi degli eventi del secolo scorso, per lo più accompagnati dall’elaborazione di teorie generali su quelli che vengono connotati come momenti chiave. Tentativi encomiabili, se affrontati da “professionisti” della ricerca, soprattutto per ciò che riguarda la ricostruzione delle vicende italiane tra le due guerre, perché – come sosteneva Rosario Romeo – «un paese idealmente separato dal proprio passato è un paese in crisi di identità e dunque potenzialmente disponibile, senza valori da cui trarre ispirazione e senza quel sentimento di fiducia in se stesso che nasce dalla coscienza di uno svolgimento coerente in cui il passato si pone come premessa e garanzia del futuro». Ma si tratta spesso di sintesi storiche il cui meritorio intento di uscire dalla ristretta cerchia degli addetti ai lavori implica, però, il rischio d letture distorte da parte dei nostalgici testimoni degli eventi narrati. O – cosa ancor più dannosa per la corretta interpretazione del passato – sono il frutto di “compilazioni” dal taglio giornalistico puramente divulgative. C’è chi tra gli storici ha dunque puntualizzato i rischi di questo indiscriminato uso pubblico della storia, notando però che le ricostruzioni congetturali del passato per certi versi fanno parte della tradizione italiana e in particolare proprio di quel periodo che oggi maggiormente è vittima delle interpretazioni dei “dilettanti”, considerando con tale termine sia alcuni autori che un buon numero di lettori. Era in virtù del principio dell’“uso pubblico” della storia, infatti, che il regime attuò una vera e propria riscrittura del passato, con l’intento sempre più palese nel corso del Ventennio di cementare il consenso delle masse attorno a quello che allora era il più vivo evento suscitatore di miti, la Grande guerra. ANTONIA LIGUORI La Grande guerra come evento costitutivo della memoria L’immagine del tapis roulant, descritta da Mario Isnenghi per visualizzare i meccanismi attraverso i quali avviene il viaggio delle memorie, sembra quella ideale per dare avvio a un percorso che, attraverso l’analisi delle pellicole di cinegiornali, documentari propagandistici e cortometraggi, si propone di ricostruire e porre l’una di fianco all’altra le innumerevoli tracce che hanno reso possibile il perpetuarsi del mito della Grande guerra negli anni del “Regime realizzato”. Come se si muovessero su una serie infinita di nastri trasportatori che si snodano tra brevi tunnel e curve improvvise, i percorsi delle memorie collettive sono talvolta ardui da rintracciare e difficili da seguire nella loro evoluzione, a volta di breve e a volte di lungo periodo. Ciò che può aiutare a ricostruirne l’origine è la convinzione che qualsiasi memoria che coinvolga un ampio raggio della popolazione è generata da eventi che hanno richiesto una partecipazione collettiva e che hanno la forza di rendersi memorabili. Il problema della durata dei contenuti di una memoria è, invece, strettamente connesso all’efficacia di quei mezzi di diffusione che provvedono in maniera sistematica a intrecciare storia e mito; primo fra tutti, nell’era della comunicazione di massa, la pellicola. La Grande guerra, la prima guerra tecnologica del XX secolo, offre innumerevoli spunti di riflessione in merito ai rapporti tra evento e memoria, con particolare riferimento al drammatico dilemma tra memoria e oblio. Appare ancora oggi forte e stridente la contraddizione in chi avvertiva il «bisogno di rimuovere» e, al contempo, «la coazione a testimoniare», posto in bilico tra l’orrore dei ricordi e la grandezza degli eventi, ed era costretto a scegliere tra la rappresentazione di se stesso come vittima o come nuovo protagonista della vita del Paese. Il fatto che la Grande guerra abbia costituito un evento epocale, una vera e propria frattura del corso storico, prima che come riflessione storiografica o come manipolazione propagandistica, compariva nell’esperienza stessa dei protagonisti. Una cosa va però puntualizzata prima di esaminare le fonti dirette, e cioè che, laddove si parli della Prima guerra mondiale come evento costitutivo della memoria collettiva, non bisogna pensare ad essa come «somma delle memorie private», poiché se si bada alle profonde differenze sociali e culturali del nostro paese, come ai più svariati livelli di “nazionalizzazione” – intesa in questo caso come partecipazione – si incorre nell’errore di chi non riconosce l’esistenza di una serie di forme di inquadramento sociale della memoria, che si concretizzavano attraverso la scelta di spazi celebrativi comuni e l’adesione del popolo agli appuntamenti collettivi. La Prima guerra mondiale, dunque, si presentava soprattutto agli L’ISTITUTO LUCE TRA INFORMAZIONE, MEMORIA E PROPAGANDA occhi dei reduci come evento catastrofico, che, aprendo un baratro tra passato e futuro, diveniva momento di accelerazione anche in tema di esperienza della morte. Tale cambiamento è assai evidente soprattutto in quella che alcuni hanno definito la «proiezione iperbolica dei culti postumi», che andava oltre la retorica d’occasione e dimostrava al contrario la necessità di evocare piuttosto che nascondere la morte di massa, quasi a volerla neutralizzare, dando ai caduti una fissa dimora, che impedisse loro di «vagare […] disturbando indefinitamente l’immaginario». La guerra moderna pose il combattente di fronte alla inevitabilità dell’incontro con la morte di massa e tale esperienza “aiutò” il fascismo in una maniera forse indiretta, ma di sicuro determinante. I soldati di prima linea si erano adattati a tal punto agli orrori vissuti al fronte da integrarli nel proprio patrimonio emotivo come motori di una lotta che non finiva con l’esperienza bellica e che andava oltre la realizzazione personale: il reduce, colui che aveva affrontato con spirito di sacrificio un’esperienza ineguagliabile, doveva trovare nel ricordo del compagno morto, nel culto dei caduti, un ulteriore stimolo ad arricchire il proprio patrimonio morale. L’esaltazione del soldato eroe – così come avveniva già nei primi anni dopo la marcia su Roma – fu il principale tentativo di giustificare ed esaltare l’esperienza della guerra, trasformando in mito la sua memoria, anche attraverso l’organizzazione delle onoranze ai caduti. Buona parte dell’adesione al mito va attribuita ai retaggi del cameratismo e al conseguente bisogno di rigenerazione collettiva. La guerra come esperienza comunitaria fu, infatti, «l’ingrediente più seducente del Mito dell’esperienza della guerra», proprio perché rendeva possibile trascendere la tragicità quotidiana attraverso l’elogio del compagno, del soldato semplice, visto come autentico rappresentante del popolo, oltre che esempio dell’uomo nuovo, l’atteso redentore dei destini della patria. È scontato dire che, in nazioni come la Germania sconfitta o l’Italia vittima del «complotto internazionale» postbellico, la memoria del cameratismo e della sacralità del martirio vanificarono inevitabilmente qualsiasi proposito di non fare più guerre, purché i moventi fossero in linea con lo scopo primario della resurrezione della patria. Ci volle la fine della Seconda guerra mondiale perché l’intera cultura europea rifiutasse il principio dell’eticità della guerra, per cui il soldato che sacrificava la propria vita per la patria non era più il prototipo della massima realizzazione della virtù civica. E la mutazione antropologica che fu alla base di questo nuovo atteggiamento intellettuale comportò anche – dopo il ’ e soprattutto in seguito allo sbarco americano – un’ulteriore e forse più determinante mutazione all’interno del “quadro morale” europeo: nei paesi conquistati o liberati dagli Alleati, la disfatta delle ideologie tota- ANTONIA LIGUORI litarie e il contatto con le truppe statunitensi restaurarono in parte quei valori della morale borghese – quali l’individualismo, l’utilitarismo e lo spirito di tolleranza – che, dopo la Grande guerra, vennero sopravanzati dall’affermarsi dell’ideale del cittadino-soldato. In Italia la partecipazione del paese al primo conflitto mondiale veniva giustificata come grande sforzo collettivo, volto non tanto a completare sul piano territoriale l’unificazione, quanto a dare sfogo alle aspirazioni alla «grande prova», ad aprire un nuovo «cammino». Qui è inevitabile accennare a quelle allusioni di Giovanni Gentile – a proposito della necessità di una riforma morale – che tanto condizionarono la successiva rilettura degli eventi fornita dal fascismo. Gentile definiva il Risorgimento una rivoluzione incompiuta, poiché aveva curato soltanto l’aspetto esteriore, cioè quello della formazione dello Stato unitario, senza badare a costituire una coscienza nazionale. E la Grande guerra – a quanto poi sostenne la propaganda di regime – sembrò dare l’occasione per forgiare questa coscienza, attraverso l’impegno di tutti gli italiani per uno scopo comune. Prima di verificare – anche attraverso l’analisi dei quindici filmati selezionati – come il fascismo tentò di risolvere il problema della partecipazione dell’italiano nuovo alla vita nazionale – e cioè facendo ricorso all’analisi della guerra come punto di incontro e sovrapposizione tra l’esperienza individuale e quella collettiva – è bene valutare un ulteriore aspetto che potrà tornare utile soprattutto per comprendere la forte carica emotiva di alcuni fotogrammi. Si tratta della nuova dimensione tecnologica del conflitto, che condizionò non poco la sua percezione e l’immagine che di essa trassero le generazioni future. I nuovi mezzi di comunicazione stimolarono l’immaginazione dei giovani in maniera assai più efficace dei semplici racconti diffusi in forma epistolare o narrati dai reduci. La tecnologia si prestava, infatti, all’inevitabile trasformazione delle esperienze visive e sonore, potenziando le possibilità di percepire il mondo sia per intensità che per diffusione. È suggestivo pensare a una sequenza di fotogrammi privi di audio come all’estremo tentativo di bilanciare l’ossessiva predominanza dell’elemento sonoro subita sui campi di battaglia, quasi a voler creare a posteriori una sorta di “anestesia acustica”. Lo sviluppo metodico del rituale La somma delle grida di dolore di chi negli occhi aveva ancora le immagini delle scene di guerra e nella memoria i racconti strazianti dei protagonisti del grande evento trovò sfogo nella coazione al silenzio, L’ISTITUTO LUCE TRA INFORMAZIONE, MEMORIA E PROPAGANDA imposto in maniera diffusa nella gestione del culto dei caduti attuata durante il Ventennio. Seppellire e ricordare i morti in guerra aveva, secondo il regime, una funzione simile a quella che avrebbe assunto la costruzione di una chiesa per la religione nazionale. E, come dimostra con estremo rigore logico lo storico tedesco George L. Mosse, fu proprio negli spazi destinati alla commemorazione dei caduti che trovò la sua maggior giustificazione il mito dell’esperienza della guerra, reso tale in quanto distinto dalla brutale realtà della trincea. Quello che si trasformò presto in un vero e proprio culto trovava il suo effettivo valore nella necessità di orientare per altre vie la memoria del conflitto: chiunque poteva dire di aver patito direttamente le conseguenze della guerra, che, alla prova dei fatti, si era rivelata assai lontana dall’entusiasmo provato alla vigilia del conflitto da quei giovani che avrebbero voluto viverlo come avventura o come possibilità di autorealizzazione personale. La liturgia dei caduti doveva annientare l’orrore vissuto e rievocare i motivi di una gloria perpetuata dai monumenti. Ciò che colpisce è quella sorta di conservatorismo che caratterizzava la natura di religione civica del culto dei caduti – come è ovvio che accada per qualsiasi forma liturgica – quasi che anche il più impercettibile mutamento potesse mettere in crisi le certezze di una fede che non ammetteva discussioni. È proprio con il culto dei morti in guerra che la nazione “eleggeva” i propri martiri, i quali, anche in tempo di pace, dovevano servire da monito alle generazioni successive sia per la forza e la virilità che avevano dimostrato nel loro farsi carico delle responsabilità di guerra, sia per la totale dedizione alla patria, culminata con l’estremo sacrificio della propria giovane vita. Si potrebbe dire che alle origini di quella propaganda che traeva stimolo dalle emozioni suscitate dal ricordo del paese belligerante c’era il mito dell’eroe anonimo, del soldato senza nome, del “milite ignoto”, che fa pensare alla tipologia che il fascismo attribuì alla guerra del ’’, al «prototipo di una guerra plebea», dove è il fante che combatte a rimanere impresso nella memoria. La forma di elaborazione del lutto personale e collettivo che nel tempo riscontrò maggiori consensi per la straordinaria capacità di coinvolgimento – dato questo evidente già nell’immediato dopoguerra sia in Italia che negli altri paesi europei – fu quella della religione civica del Milite ignoto. La guerra di massa aveva individuato il suo nuovo eroe nel “non eroe”, il figlio del popolo sul quale ognuno potesse convogliare la propria pietà. All’estero o sul proprio fronte, i cimiteri militari erano poco adatti a servire da centro del culto dei caduti, nonostante, ciascuno di essi – singolarmente esaminato – potesse svolgere la funzione di tem- ANTONIA LIGUORI pio nazionale. Per rafforzare il culto dei combattenti morti al fronte, le singole nazioni avevano bisogno di un luogo in cui raccogliere le folle, per sensibilizzarle ancora una volta – in memoria dei caduti – in funzione della missione nazionale. Il fascismo trovò nel repertorio dannunziano la motivazione ideale alla quale fare appello: essa consisteva nel particolare rilievo a quel mito del popolo concepito come unità spirituale grazie alla funzione mediatrice degli “eroi”. Il rapporto reciproco tra popolo ed eroi – riproposto durante il ventennio nelle adunate di fronte ai luoghi destinati al culto dei caduti – non implicava la subordinazione di quelli a questi, ma una comunione di spirito e volontà che il Poeta definì «eucaristica». La tomba del Milite ignoto ebbe questo fine, come luogo del culto nazionale che simboleggiava tutti i cimiteri militari dispersi lungo quelle che pochi anni prima erano state le linee del fronte. Con gli anni Trenta si andarono affiancando ai luoghi di culto a loro modo “consolanti e gentili” – come potevano essere, ad esempio, i parchi della Rimembranza – concepiti un decennio prima, gli sconfinati piazzali di cemento dei grandi ossari, che andarono a costituire ulteriori spazi «deputati ai colloqui dimostrativi tra i vivi e i morti». L’altare della morte più praticato e venerabile fra le due guerre non poteva che essere quello del Carso, posto nel cuore della regione più tragica, mirabilmente descritta, nella sua natura aspra e selvatica che la poneva agli estremi confini della civiltà urbana, nel “diario lirico” di Scipio Slataper titolato Il mio Carso. In un opuscolo celebrativo del dedicato all’allestimento del cimitero militare di Redipuglia – oggi in provincia di Gorizia – leggiamo tutta la commozione ispirata da una retorica pubblica che doveva fare i conti con le imponenti dimensioni quantitative della morte, presenza talvolta pletorica anche per chi si proponeva di gestire l’immaginario collettivo: Salme di eroi, caduti nell’impeto dell’assalto e rimasti insepolti sulla terra squarciata, perché il furor della mischia aveva precluso la via della pietà; salme di fratelli in giorni avversi dovute lasciare con immenso dolore nelle linee nemiche; salme giacenti sotto ai rottami delle opere di difesa infrante; salme affondate nelle caverne dove più lenta è l’agonia; […] poveri corpi smembrati dalle granate; innumerevoli ossa scongiunte e sparse in ogni luogo. C’è chi ha definito il grande complesso monumentale di Redipuglia «l’opera forse più compiuta di appropriazione del culto della Grande guerra ad opera del fascismo», che, nel completamento di un progetto architettonico già in parte delineato prima ancora della fine del conflitto, trovò l’occasione per creare un luogo di culto dei caduti che, per numero di salme raccolte – più di . – superava anche gli ossari monumentali della Somme. L’ISTITUTO LUCE TRA INFORMAZIONE, MEMORIA E PROPAGANDA È interessante notare la cura con cui il fascismo riuscì ad affiancare tale progetto di rivalutazione degli spazi dedicati alla memoria collettiva al tentativo di ottenere un ulteriore sostegno da parte dei Savoia. L’occasione fu quella dell’interramento del duca Amedeo d’Aosta – avvenuta l’ luglio del – il cui testamento spirituale venne scolpito nella cripta della sua tomba a suggellare il binomio Savoia-Mussolini, che, in realtà, costituiva il tarlo roditore di quello che alla lunga si rivelò un «totalitarismo imperfetto». La “pupilla” del regime: l’immagine del mito I quindici documenti selezionati presso l’Archivio storico dell’Istituto Luce contribuiscono, nel complesso, a chiarire il rapporto tra informazione, memoria e propaganda, oltre a ribadire, in maniera inequivocabile, la necessità avvertita dal regime di raccogliere la nazione intera attorno all’ideale della «nuova Italia». Ciò che preme sottolineare è l’utilità delle fotografie e, ancor più, dei filmati sia per l’analisi sia per la sintesi storiografica, tenendo presente che un’applicazione su scala più vasta dello strumento filmico può avvenire soprattutto su quei documenti realizzati a partire dall’introduzione del sonoro, che, attraverso l’integrazione tra sequenze di immagini e suoni, costituiscono «l’optimum in senso documentario». In Italia l’attività di informazione cinematografica, oltre che di divulgazione scientifica, ha avuto una sua “fioritura” già ai primi del Novecento, tant’è che, prima del Luce, esisteva il Sindacato di istruzione cinematografica – il SIC – che aveva avuto come scopo specifico quello di soddisfare le esigenze dell’Italia liberale quanto a produzione di film documentaristici di ispirazione governativa. Nel ’ tra i più accaniti fautori delle iniziative del SIC c’erano il giornalista Luciano De Feo e il generale della milizia Civelli, che, neanche due anni dopo, prospettarono a Mussolini, in un’occasione apparentemente fortuita, le potenzialità di sviluppo delle «pellicole educative». Era l’estate del ’ quando avvenne il primo contatto tra Mussolini e De Feo, all’interno della Mostra dell’emigrazione di Napoli, dove era stata inserita nella programmazione serale la proiezione di una serie di documentari. Tra questi c’era un reportage, girato il luglio da Albertelli, dedicato all’attività di Mussolini a Palazzo Chigi. Da un incontro “forzatamente” casuale di lì a poco avveniva la conversione del SIC e la nascita de L’Unione Cinematografica Educativa – il L.U.C.E. appunto – immediatamente posta sotto le dirette dipendenze del capo del Governo e del suo ufficio stampa. In meno di due anni veni- ANTONIA LIGUORI vano costituite otto cinemateche, da quella agricola a quella di cultura nazionale, da quella igienica a quella di propaganda e cultura all’estero, alle quali si aggiungevano la divisione fotografica e, dal ’, la redazione del cinegiornale. Era in quegli anni che si riprendeva a parlare di «uso extraestetico del mezzo cinematografico», alla maniera dello studioso britannico di scienze sociologiche John Grierson – un allievo di Walter Lippmann – che individuava nel cinema non più «una fonte di ricreazione», ma un potente mezzo educativo. Così scriveva a proposito dell’uso sociale del cinema, in relazione al problema del coinvolgimento delle masse: «il nuovo linguaggio dell’assimilazione, dal quale deve scaturire il senso collettivo della vita sociale, ha da essere un linguaggio più emotivo che razionale». Lezione questa sapientemente messa in pratica dalla “pupilla” del regime, che, durante tutto il ventennio, proiettò le proprie immagini in modo che il popolo non potesse vedere la realtà del paese con altri occhi che con quelli del Luce, trascinato da un’ondata emotiva assai forte. L’evidente prevalere della funzione politica nella produzione dei filmati trasformò rapidamente il Luce in strumento della più ampia «fabbrica del consenso» – interamente gestita dal Pnf, «grande pedagogo» dello Stato – verificabile nella sua efficacia a guardare dall’operosità con la quale l’apparato culturale del regime si mosse per la ricerca di locali idonei alla proiezione dei filmati. A Roma, ad esempio, veniva restaurata l’antica aula Minerva all’interno delle Terme di Diocleziano e il ottobre del veniva inaugurato il Planetario, che, in un anno, ospitò oltre cinquecentomila visitatori. Per il resto del Paese, ai locali nei quali si proiettavano i filmati una volta a settimana, venivano affiancati, a partire dal , venticinque autocinema. Non è un caso che questa maggior attenzione alla diffusione delle pellicole avvenisse proprio nel , anno d’esordio del cinegiornale, destinato subito a manifestare il suo forte tasso di politicizzazione, che, nel tempo, ne avrebbe determinato sia i contenuti che la forma, distinguendolo anche dalla tipologia delle trasmissioni giornalistiche radiofoniche. Il “limite” più evidente era senz’altro determinato dalla schematicità della struttura, in base alla quale, ad esempio, gli avvenimenti riguardanti l’Italia introducevano e chiudevano le cineattualità, per lo stesso motivo per cui le immagini del duce dovevano essere nettamente predominanti rispetto a quelle del re. Tutto doveva contribuire a rafforzare il mito della nuova Italia, scandito dalla ritualità dei suoi anniversari, rigorosamente filmati e riproposti al pubblico secondo il nuovo calendario eroico della Nazione, che contava tra le sue “feste di precetto”, oltre all’anniversario della marcia su Roma, quello dell’entrata in guerra nel ’ e della vittoria trionfale a Vittorio Veneto. Un mito, quello della nuova Italia, che, vista la ricorrente affermazione L’ISTITUTO LUCE TRA INFORMAZIONE, MEMORIA E PROPAGANDA dell’identità tra Stato e fascismo, non poteva risparmiarsi il vincolo con l’altrettanto decantato mito mussoliniano, accresciuto dalla varietà di versioni che esso consentiva, tanto da rendere il duce «il protagonista superdivistico della comunicazione audiovisiva!». Possiamo immaginare quanto il carattere ufficiale dell’informazione – sia quella fornita attraverso i cinegiornali, sia quella offerta sotto forma di documentari propagandistici – abbia influito sulla fantasia o sulla capacità stessa degli operatori, che le condizioni andavano via via trasformando in veri e propri «burocrati della cinepresa». E non si può dire che l’avvento del sonoro cambiò qualcosa quanto a necessità d’aggiornamento che esulasse dalla sola riorganizzazione tecnica. Anzi, dopo il ’, quando nei cinegiornali si iniziavano ad ascoltare le prime musiche di sottofondo o i primi rumori in presa diretta – visto che il commento dello speaker fu possibile soltanto dal ’ – i primi e clamorosi inciampi finanziari portarono a galla le rimostranze dei fascisti più ortodossi, che imputavano al deputato abruzzese Alessandro Sardi di non aver sfruttato a dovere, nei quattro anni della sua direzione, le potenzialità propagandistiche del mezzo cinematografico. La gravità delle sue presunte inadempienze – più ideologiche che amministrative – era giudicata in maniera proporzionale agli indici di diffusione delle cineattualità, che, nel ventennio, erano di gran lunga superiori rispetto a quelli della radio o, in maniera ancor più evidente, rispetto ai quotidiani. Una maggiore enfasi investì il dato oggettivo dei filmati proprio con l’avvento del commento degli speaker, che, con la loro ridondanza, oltre che per la monotona ripetitività dei contenuti, accrebbero il senso ideologico dell’informazione. E, a proposito di enfasi e di facile manipolazione della realtà, basti pensare anche alla scelta degli argomenti, che assolutamente non lasciavano alcuno spazio né alla cronaca nera – che avrebbe agito come un tarlo roditore nelle coscienze del popolo – né alle futilità, ritenute poco idonee ad un pubblico impegnato nell’austero progetto di «innalzare i destini» della propria Patria. Sono queste probabilmente le caratteristiche che nota a una prima osservazione chi si accosta oggi ai cinegiornali del ventennio con l’intento di scorgere in essi le tracce di un percorso ideologico e propagandistico di più ampia portata. Nella selezione dei quindici filmati che in questa sede si propongono come testimonianze chiave delle notevoli implicazioni connesse alla rilettura degli eventi della Grande guerra fornita dal regime fascista, è sembrato opportuno far riferimento immediato a una serie di “cineattualità”. Si tratta, infatti, di alcune tra le testimonianze più efficaci proprio perché l’estrema sintesi nella trattazione delle singole tematiche rendeva con immediatezza il senso di un “discorso” che si basava più su “enunciati minimi” che su articolate costruzioni. E la semplificazione ANTONIA LIGUORI diveniva d’obbligo per una capillare diffusione di un messaggio che fosse inequivocabile e che, al contempo, facesse appello a una fede dogmatica, che – come tale – non ammetteva repliche. Entrava, dunque, in causa il “sentimento”, o meglio, la suggestione, cioè quella qualità delle masse che si fondeva con il loro incessante bisogno di credere in qualcosa di ben definito e di creare un proprio “patrimonio intellettuale” che non le emarginasse – almeno formalmente – dallo spazio e dal tempo nel quale vivevano. Un sentimento più volte chiamato in causa e posto «di fronte a una galleria di immagini […] che tocchino acutamente le sue capacità di azione e di rivalsa». La propaganda – e ci riferiamo in particolare a quella attuata dal regime in virtù della creazione del mito della Grande guerra – consisteva, infatti, in una vera e propria tecnica, che aveva come suo scopo essenziale quello di condurre verso la conformizzazione di massa e come suoi mezzi più efficaci “l’annichilimento dell’avversario” e la quasi totale assenza di riferimenti razionali. Per “avversario” dobbiamo intendere anche chiunque non mostrasse un consenso integrale e che, a causa di una seppur parziale difformità di pensiero, nelle adunate o nelle varie ricorrenze evocative, veniva quasi indotto a vergognarsi. Il dissenziente agli occhi del regime non era poi tanto diverso dall’oppositore, che veniva a priori bollato come un traditore, «un abietto da schiacciare». Si trattava, in fin dei conti, di un controllo delle masse che non poneva in essere un vero e proprio processo di convinzione, ma che riteneva opportuno portarsi più sul fronte suggestivo e psicologico che su quello ideologico, tenendo ben presente la reciprocità dichiarata tra forza e consenso, laddove il processo “educativo” di massa imponesse un intervento più concreto. Ciò comportava un’adesione collettiva al concetto di libertà che qualsiasi totalitarismo impone e che consiste – volendo semplificare – nella subordinazione della volontà dell’individuo al bene comune. Quattro cinegiornali come sintesi del “continuum storico” Nei quattro cinegiornali presi in esame – due del ’, uno del ’ e uno del ’ – soltanto l’ultimo è provvisto di musica di sottofondo, una serie di spezzoni di inni della patria e della rivoluzione cantati dai giovani della GIL, alternata con le consuete acclamazioni della folla e con il commento del cronista. Le immagini sono, comunque, esplicative in tutti i documenti, poiché rimarcano quelli che sono i quattro punti cardine da considerare all’inizio di un percorso visivo attraverso il quale si voglia rivisitare l’interpretazione della Grande guerra così come venne ricostruita dall’apparato di propaganda fascista. Nel Giornale Luce archiviato con il codice B , il concetto attorno L’ISTITUTO LUCE TRA INFORMAZIONE, MEMORIA E PROPAGANDA al quale ruota l’intera sintesi è quello della continuità storica della quale il fascismo si fece portavoce. Si tratta, infatti, di una serie di riprese effettuate in occasione dell’inaugurazione sul Gianicolo, a Roma, di un monumento dedicato ad Anita Garibaldi, raffigurata dallo scultore come amazzone al galoppo, con una rivoltella in una mano e un lattante nell’altra. Un’abile regia mostra di saper sfruttare al meglio l’occasione per amplificare, tra l’altro, l’ovvia allusione alla duplice funzione della donna sia rispetto alla patria sia verso la famiglia: la figura femminile viene, infatti, rappresentata simbolicamente dalla statua equestre di Rutelli come «guerriero che segue il nemico e madre che protegge il figlio». Su un cartello in sovrimpressione compaiono i punti cardine del discorso commemorativo pronunciato dal duce, la cui presenza è di molto privilegiata rispetto a quella del re e di sua moglie. Inevitabile il riferimento celebrativo alle glorie garibaldine, messe in stretta relazione con le virtù del popolo belligerante e, in particolare, con gli arditi di Vittorio Veneto e con le camicie nere. Il messaggio giungeva chiaro dal colle di Roma: sia l’antico “duce” – Garibaldi – che quello nuovo possedevano una straordinaria coerenza strategica e, magari, nonostante le accuse dei malevoli, la presunta superiorità storica del fascismo consisteva proprio nell’aver saputo animare «masse di combattimento» e non «nuclei rari». La missione del regime – come «erede» del «protofascismo», che, secondo la versione ufficiale ideata dallo stesso Mussolini, consisteva nella spinta attivistica dell’interventismo – veniva, dunque, presentata come compimento della migliore tradizione morale italiana, la cui memoria veniva tutelata e salvata dal rischio di cadere nell’oblio al quale era stata condannata dai “politicanti” liberali. Nel secondo Giornale Luce del ’ – marcato dal codice A – lo spunto di riflessione sul passato dell’Italia belligerante è offerto, invece, dalle riprese effettuate in occasione della “Mostra della Rivoluzione fascista”, nata come idea celebrativa del decennale del regime. Il nucleo ideologico attorno al quale ruota l’intero montaggio delle immagini è quello della definizione dell’intervento nella Grande guerra come inizio del cammino per la «rivoluzione fascista». I primi piani e le dissolvenze sono tutti per le prime pagine de “Il Popolo d’Italia”, del quale si tende a sottolineare il ruolo centrale all’interno della corrente interventista, presentata come frazione minoritaria che, all’alba della Grande guerra, interpretò la presunta volontà di riscatto morale avvertita da un Paese ancora inconsapevole del proprio destino. Si intuisce il grosso successo di pubblico della mostra – c’è chi parla di due milioni di visitatori in due anni – che non si spiega solo con l’impegno, che pure fu cospicuo da parte del regime, di promuovere gite e visite organizzate, ma che si collega soprattutto con la vera e propria liturgia connessa alla mostra stessa, che ANTONIA LIGUORI negli anni – più volte prolungata – si trasformò in uno stabile Museo della rivoluzione. Fugaci le immagini dei numerosi pannelli fotografici presenti in una delle sale all’interno della mostra: evidente, però, la ricorrente presenza dei soldati feriti – eletti come primi «martiri della rivoluzione fascista» – e del giovane Mussolini sui campi di battaglia. Secondo la rilettura ufficiale degli eventi bellici, aveva avuto ragione Gioacchino Volpe nell’annunciare, a posteriori, l’eredità storica mutuata dalla Grande guerra, che consisteva, in sintesi, nel «patrimonio morale» acquisito da ogni singola nazione, inteso come nuovo modo di gestire i rapporti tra Stato e individuo. A dimostrazione della volontà di strumentalizzare l’intervento per giustificare l’affermazione del fascismo e la sua necessità storica, oltre che per dare una più salda base teorica a una dottrina che può essere definita come volutamente «anti-ideologica», leggiamo qualche stralcio tratto da alcune tra le pagine più rappresentative del pensiero di Francesco Ercole: Là nelle colonne del Popolo d’Italia, sin dal febbraio del ’, gli interventisti di tutte le origini e di tutti i Partiti cercavano quasi istintivamente la bussola più sicura del proprio orientamento e la ragion d’essere più persuasiva del proprio improvviso riconoscersi, al di là dei dissensi e delle antitesi, fratelli nella spontanea disciplina verso una causa comune. Specialmente rapido, quasi direi insieme istintivo e intuitivo, fu il riconoscimento di un’intima fraternità spirituale fra l’interventismo, che potremmo dire di marca immediatamente mussoliniana, e l’interventismo dei nazionalisti, nonché il reciproco agire e influire dell’uno sull’altro, quasi a inconscio presentimento del prossimo inserirsi e risolversi dell’uno nell’altro. […] Nei mesi di passione intercorsi tra lo scoppio della guerra mondiale e il nostro intervento, Mussolini fu, di fatto, di fronte agli interventismi di sinistra e di destra, per riconoscimento tacito e implicito, quasi direi per una specie di investitura naturale, il Capo. […] La storia dirà che risolvendosi la Rivoluzione fascista nella instaurazione del governo della Patria dello spirito, in virtù del quale il popolo italiano volle la guerra, essa non poteva avere altro Capo, se non Colui, che aveva guidato il popolo italiano a imporre la propria volontà di guerra al governo della Patria. Questa pagina sintetizza in maniera esemplare i punti essenziali sui quali il regime fondò la propria interpretazione ufficiale degli eventi immediatamente precedenti l’intervento italiano in guerra. Il ruolo trainante attribuito a posteriori al “Popolo d’Italia” in seno all’interventismo non deve far sottovalutare due aspetti tipici del fenomeno: innanzi tutto, l’eclettismo della realtà italiana come sintomo di debolezza delle basi teoriche dell’interventismo – in modo particolare di quello di sinistra, che non poteva rendere credibile il mito della guerra democratica e rivoluzionaria, senza l’adesione delle grandi masse cattoliche e socialiste –; in secondo luogo, il fatto che si trattava pur sempre di una corrente L’ISTITUTO LUCE TRA INFORMAZIONE, MEMORIA E PROPAGANDA minoritaria, appoggiata però da elementi fondamentali, sicuramente più efficaci della semplice forza propagandistica. Ci riferiamo sia al sostegno fornito dal governo da un certo momento in poi – al contrario di quanto farebbe credere quel carattere “eversivo” attribuito in seguito dal fascismo – sia al non indifferente appoggio di alcuni gruppi capitalistici e anche al peso di tutta – o quasi – la cultura impegnata e militante, alla ricerca di un radicale rinnovamento culturale e politico. Ciò che, in sostanza, volevano ribadire filmati con una simile impostazione era che la storia della «nuova Italia» cominciava dal «maggio radioso», perché allora – a più di cinquant’anni dall’unificazione – erano finalmente prevalsi i motivi ideali sulle ragioni politiche, a conferma dell’idea che il successo di una nazione poteva scaturire soltanto da un atteggiamento morale che comprendesse la sofferenza e l’abnegazione dell’individuo. Nel terzo cinegiornale preso in esame, abbiamo la testimonianza diretta della ritualità divenuta di routine durante le celebrazioni degli anniversari tratti dal calendario eroico della nazione. Ci troviamo, infatti, a Nervesa, in occasione del quindicesimo anniversario della battaglia del Piave, definita da Luigi Federzoni «eroico preludio della vittoria di Vittorio Veneto». Inutile ribadire quanto l’intera sequenza delle immagini miri a rafforzare il mito della vittoria trionfale, del quale si fanno portavoce, non a caso, i mutilati e gli ex combattenti. L’imponente presenza di insegne e stendardi sollevati durante la sfilata degli artiglieri fa da sfondo alla «parola rievocatrice» di Federzoni, sintetizzata a chiusura del servizio da uno striscione con la celebre frase: «Il Piave mormorò: non passa lo straniero». Qualche anno prima della realizzazione di queste immagini si era sollevata sulle pagine di “Gerarchia” una pungente e significativa polemica in merito agli eccessi di memorialismo, che faceva appello a una maggior esigenza di pudore – da intendere forse più come “ortodossia” – nel ricordo della partecipazione del popolo combattente alla Grande guerra. Comparve, infatti, un articolo di Paolo Monelli che accusava apertamente la condotta di chi si ostinava alla raccolta di cimeli bellici quasi a voler confinare le esperienze vissute al fronte in quegli oggetti, in un passato chiuso per sempre, che condannava all’inazione i reduci, mortificati nel loro spirito combattivo. Monelli scriveva, infatti: Leggo ai cantoni delle vie di Milano un manifesto che invita i combattenti a mandare cimeli ad un già esistente Museo della Guerra; e quali rabbrividenti cimeli sono indicati come quelli maggiormente desiderati. Cartoline, fotografie, indumenti, parti di corredo del povero caduto. […] La stessa roba che vedemmo da ragazzi nei vari musei del Risorgimento dove ci conducevano a schiera (uno ce n’era e c’è ancora di sicuro nella mia Bologna, che ricordo come la più triste ANTONIA LIGUORI rigatteria del genere). […] Ah no, signor conservatore del Museo di Milano. Io non ho cimeli, ma ne avessi, non li manderei al vostro Museo; li terrei ben nascosti in casa, da vedermeli io stesso assai di rado, che non me ne venisse un’inerzia sterile, un pigro compiacimento che mi confinasse per sempre, prigioniero del morto passato. La polemica sollevata sulla rivista politica diretta da Mussolini fa pensare all’interpretazione di chi, riscrivendo l’epopea della Grande guerra, ha voluto individuare nel mito postumo assunto come elemento trainante della politica culturale di regime non un semplice aggancio al passato, bensì una molla per il futuro che implicasse anche una concreta integrazione dei reduci, quali principali artefici – seppur all’alba del «maggio radioso» inconsapevoli del loro destino – della palingenesi nazionale. Il richiamo di Monelli fornì anche lo spunto per affrontare ancora una volta il problema della spontaneità nelle manifestazioni celebrative, come si può leggere nella replica che seguì nel numero di novembre, per mettere a tacere eventuali equivoci sulla validità della memoria e sulle competenze della dirigenza centrale: L’articolo di Paolo Monelli […] non era certo un incoraggiamento a dimenticare la guerra e la vittoria, e men che meno voleva deprimere i valori morali od offendere i reduci! […] Sì bene era un monito a circondare queste cose sacre – la guerra, la vittoria, lo spirito combattivo e l’amor di patria – di quel verecondo e sobrio pudore, per il quale esse meglio conservano il loro carattere di santità. Non bisogna ad ogni momento sventolare la bandiera dei grandi ricordi né tirar fuori le parole grosse; se no la retorica se ne impadronisce e le snatura avvilendole, come avviene dei conii logori per troppo uso. Per lo stesso ordine di ragioni il Duce ha limitato le parate e ha persino proibito che si suonino Marcia Reale e Giovinezza fuori che in determinate solenni occasioni. La gestione della memoria, dunque, doveva essere unica e inequivocabile, se si voleva evitare che l’abuso delle ricorrenze svilisse il significato profondo del messaggio gestito dal regime, autentico artefice del proprio culto politico. Il quarto tassello, che contribuisce a rendere chiara la base sulla quale poggiava la rilettura dei principali eventi della Prima guerra mondiale, è costituito dall’ultimo cinegiornale selezionato, datato novembre . Ci troviamo di fronte alla celebrazione dell’annuale della vittoria, che avveniva, come di consueto, nel luogo-culto per eccellenza, il Vittoriano. In quella sede, il rituale celebrativo volto alla glorificazione degli eventi emblematici della Grande guerra acquisì nel primo decennio una sua forma specifica. Si pensi, ad esempio, alla cerimonia del novembre, che si ripeteva negli anni secondo la stessa “liturgia”: la “scaletta” – così L’ISTITUTO LUCE TRA INFORMAZIONE, MEMORIA E PROPAGANDA lasciano intendere anche le fugaci sequenze riportate nel cinegiornale – prevedeva in apertura una funzione religiosa in Santa Maria degli Angeli, alla quale prendeva parte l’intera rappresentanza delle autorità; successivamente la folla attendeva Mussolini e i membri del governo in piazza Venezia, dove avveniva il consueto e commosso omaggio al Milite ignoto, di fronte al quale le autorità rimanevano in ginocchio per pochi istanti, quasi a suggellare l’ossequio della nazione intera al sacrificio dell’eroico simbolo dell’epopea bellica. Di solito ogni celebrazione si svolgeva, secondo le disposizioni del partito, in due tempi, il rito e la festa, che rappresentavano le due sfere della consuetudine liturgica, il sacro e il profano. Al rito si attribuiva una solennità degna delle maggiori cerimonie religiose: alla messa in ricordo dei caduti seguiva, infatti, la sfilata delle organizzazioni di regime, talvolta precedute dalle autorità civili e militari, tra le quali spiccavano i rappresentanti delle associazioni di reduci; il momento culminante consisteva nel discorso del duce, la cui voce si stagliava nel silenzio delle piazze colme di folla. La festa, al contrario, aveva una funzione prettamente ricreativa e si svolgeva nelle prime ore pomeridiane, accompagnata da danze e canti, quando non comprendeva anche gite in campagna. Il culto della vittoria, oltre che glorificare le gesta dei protomartiri fascisti, doveva stimolare le generazioni più giovani – quelle che avrebbero dovuto dare il proprio sostegno all’affermazione dello Stato totalitario – ad apprendere, anche attraverso l’esempio dei «gloriosi mutilati», «la gioia del dovere e la bellezza del sacrificio». Il tassello mancante, tuttavia, non consiste nella celebrazione dell’anniversario, quanto in un’affermazione del cronista che le acclamazioni della folla inneggiante al duce non possono mettere in sordina. Questi uomini nuovi parlavano un linguaggio che era anch’esso nuovo, un linguaggio che irrigidiva i modi espressivi tradizionali e li integrava in una visione del mondo manichea, fatta soltanto di amici e nemici. Durante la suggestiva panoramica sull’ormai abituale adunata oceanica, il commentatore definiva Mussolini «potenziatore della vittoria», lasciando intendere che, senza l’affermazione del regime fascista, il sacrificio compiuto dal popolo-truppa durante la Grande guerra sarebbe stato vanificato dalla condotta dei «politicanti italiani». Ecco emergere, sotto un’altra veste, quel carattere “rivoluzionario” attribuito dalla cultura fascista alla dittatura, che consisteva nel fatto che la nuova organizzazione nasceva sotto l’egida di una nuova parola d’ordine, “combattere”, anch’essa pronunciata in tempi non sospetti e proprio per questo ancor più utile per legittimare successivamente la trasformazione del fascismo da movimento in regime. Già il febbraio del ’, infatti, Mussolini, nell’articolo pubblicato sul “Popolo d’Italia” ANTONIA LIGUORI dal titolo Contro la bestia trionfante, affermava: «Noi siamo disposti a convertire le piazze delle città d’Italia in tante trincee munite di reticolati, per vincere la nostra battaglia». E si trattava di una battaglia che si muoveva sotto l’impulso della «grande voltata nella storia italiana», quella che – a quanto sosteneva lo stesso Mussolini – aveva visto «per la prima volta la maggioranza della Nazione [prendere] una decisione attiva, in contrasto ai parlamentari e ai politicanti». “Camicia nera”, il kolossal del Luce per il decennale I quattro “pilastri” che danno sostegno all’interpretazione della Grande guerra fornita dal regime nei cinegiornali selezionati sono presenti in maniera più articolata in quello che alcuni hanno definito il «kolossal del Luce», Camicia nera, film con intento documentaristico realizzato nel ’ da Gioacchino Forzano. Si tratta del frutto di un concorso indetto per un soggetto che commemorasse l’avvento del fascismo, girato parzialmente a Roma, presso gli stabilimenti della Farnesina, e costato una cifra forse eccessiva rispetto alle aspettative degli incassi e al rimborso previsto come premio. Il soggetto prende spunto da un film sovietico del ’, Frammenti di un impero, di Emler, a dimostrazione del fatto che all’Unione Sovietica spettava una sorta di primato nell’uso del cinema all’interno di un più vasto progetto di trasformazione socio-politica che mirasse a sfruttare le forme di comunicazione audiovisiva per la conquista del consenso. La sceneggiatura di Emler ha come protagonista un soldato russo in preda a un grave stato di shock che gli impedisce di ricordare il proprio paese d’origine e che lo consegna nelle mani dei tedeschi. Tornato in patria, il reduce avrà gravi difficoltà di integrazione soprattutto a causa dei mutamenti interni sopraggiunti con la Rivoluzione d’ottobre. Anche Forzano ha il suo combattente, vittima di un totale vuoto mnemonico che sarà colmato dagli psichiatri di una clinica tedesca solo al suono delle note del “Piave” e alla notizia della vittoria italiana. Al contrario della vicenda sovietica, è «inevitabile» per il fabbro-reduce l’immediato riconoscimento nel fascismo della sola via possibile per prolungare la vittoria e non vanificare gli sforzi compiuti fino ad allora. Protagonista della vicenda, che comprende i principali eventi italiani dal ’ al ’, è quel proletariato che, nell’immediato dopoguerra, si sentiva tradito tanto dai socialisti – il cui fallimento era stato decretato dalla scarsa razionalità della propaganda internazionalista e antibellicista – quanto dalla classe dirigente liberale, alla quale fa da contraltare la tanto decantata “sincerità” di Mussolini. Il mito mussoliniano è rafforzato anche dal tentativo del futuro duce di prendere atto delle sorti dei reduci e delle loro L’ISTITUTO LUCE TRA INFORMAZIONE, MEMORIA E PROPAGANDA difficoltà di integrazione una volta abbandonato il fronte. Sullo sfondo fa sentire la sua imponente presenza il mito della “vittoria mutilata”, sul quale s’innesta l’idea di un presunto complotto internazionale ai danni dell’Italia. È interessante osservare come la vicenda del protagonista di Camicia nera rappresenti la comoda occasione per innestare una storia comune su quel gran canovaccio costituito dalla progressiva affermazione del fascismo e dal più immediato e genuino consenso di massa. A tale scopo servono i continui cambi di scena che sovrappongono l’immagine del fabbro in ospedale a quella dell’organizzazione dei fasci di combattimento o all’espressione ispirata del figlio del protagonista di fronte agli scritti giovanili di Mussolini. L’ultima parte del filmato ritrae il popolo di fronte alle realizzazioni del regime, che suggeriscono ancora una volta la necessità di riversare la propria più assoluta “fede” nei confronti di chi ha definito le bonifiche «la guerra che noi preferiamo». La bonifica, soprattutto dopo la fondazione di Littoria, aveva ormai assunto nella pubblicistica corrente, come nella stampa e addirittura nella letteratura tecnica, la veste metaforica della guerra. Veniva dipinta sia come scontro destinato a vedere sconfitto il nemico che aveva per troppo tempo tenuto d’assedio alcune zone della penisola, sia come forma di esercizio bellico, applicato sul “fronte” civile e destinato a preparare le nuove generazioni alle guerre vere. Proseguendo con l’analisi dei fotogrammi si scorge, all’interno della Mostra della Rivoluzione fascista, un’inquadratura che si sofferma su una scritta alla parete fortemente esplicativa: «Nel nome di Dio e dell’Italia, giuro di eseguire senza discutere gli ordini del duce e di servire con tutte le mie forze e se è necessario con il mio sangue la causa della rivoluzione fascista». Il montaggio prevede un repentino stacco sull’immagine di un sacrario, una stanza circolare alle cui pareti compare ripetuta la scritta «presente». La “guerra” non era ancora finita: la mobilitazione generale consisteva questa volta nella totale remissività dell’individuo nei confronti delle priorità dello Stato. Le ultime immagini scorrono sulla fondazione della città di Littoria e sul richiamo evocativo alle «grandi nostalgie» della Grande guerra attraverso l’attribuzione dei nomi ai borghi della nuova città. È opportuno segnalare la presenza di numerose sequenze nelle quali prendono la parola alcuni preti fascisti, a dimostrazione del successo della politica di regime anche nella gestione dei rapporti con la Chiesa. L’atteggiamento che alla lunga prevalse fu quello del realismo politico, per cui apparve fallimentare rivaleggiare con le autorità ecclesiastiche per il controllo e la formazione delle coscienze. La soluzione vincente fu quella di applicare una «strategia di convivenza sincretica», che mirasse ad associare il cattolicesimo e la Chiesa nel proprio progetto totalitario, attraverso il frequente uso della religione tradizionale come ANTONIA LIGUORI «instrumentum regni». Leggiamo, ad esempio, un intervento comparso nel numero di gennaio del di “Gerarchia” per commemorare – attraverso la pubblicazione del suo ultimo scritto – la figura emblematica di padre Pistelli, definito «prezioso collaboratore» per la sua straordinaria capacità di forgiare le anime all’insegna degli ideali proposti già dai protofascisti interventisti, attribuendo il suo suggello di sacralità anche al sacrificio estremo: «Interventista e fascista di innanzi alla prima ora e sino all’estrema, nella buona e nell’avversa fortuna senza incertezze; fece la rivoluzione tra i più accaniti con i manipoli sovversivi accesi, nel maggio , primavera d’Italia. I ragazzi d’Italia oggi tutti piangono il papà scomparso. Essere maestri così è una maniera quasi divina di paternità e dei suoi figlioli spirituali pianse egli i migliori». La “marcia trionfale” del popolo combattente nella produzione propagandistica I temi proposti da Camicia nera, anche se prospettati con chiaro intento propagandistico, vengono avvolti nella trama sotterranea delle vicende degli abitanti delle lestre, testimoni e attori della trasformazione del fascismo da movimento in regime. Non hanno, infatti, quella stessa enfasi – e, forse, perciò hanno un maggior peso sulle coscienze – dei veri e propri documentari, nei quali ogni sequenza è studiata per rendere inequivocabile il messaggio da consegnare nelle mani del popolo. «Il compito della propaganda non sta nell’educazione critica (Wissenschaftlich) del singolo, ma nel far rivolgere la massa verso determinati fatti, processi, necessità, la cui importanza solo a questo modo verrà portata nell’orizzonte visuale della massa stessa»; nessuno meglio dell’autore del Mein Kampf avrebbe mai potuto sintetizzare in maniera così efficace il significato e lo scopo della tecnica sulla quale le dittature del Novecento hanno fondato la loro ricerca di consenso. Quel “compito” dell’attività propagandistica andava a priori definito e individuato in determinati nuclei tematici che garantissero tanto la loro facile comprensione, quanto la loro assoluta necessità. Non bisognava lasciare, infatti, nessuno spazio alla replica, puntando solo a palesare l’ineluttabilità di un determinato fatto o di una particolare interpretazione, generando la convinzione diffusa della veridicità e della realtà del fatto stesso. Fautori e fruitori della propaganda venivano posti l’uno accanto all’altro, con lo sguardo rivolto verso la stessa direzione, accomunati dallo stesso repertorio di grandi e piccoli miti, che andavano recepiti ed assimilati con il massimo dell’entusiasmo, ma in maniera del tutto acritica. Se si confronta il film di Forzano con una produzione propagandi- L’ISTITUTO LUCE TRA INFORMAZIONE, MEMORIA E PROPAGANDA stica dell’Istituto Luce che sintetizza i medesimi concetti, la diversità è facilmente palpabile. Questo piccolo “esperimento” può riuscire bene prendendo in esame un documentario del ’ dal titolo Il duce nelle trionfali giornate del decennale. Anche qui si esalta l’interventismo e l’attività dei combattenti, si accenna al fallimento di Versailles e al mito della «vittoria mutilata», ma tutto in maniera estremamente sintetica e per nulla allusiva; anzi, a nostro dire, in un modo così carico di enfasi da toccare i limiti della credibilità. Le adunate oceaniche fanno da sfondo a due importanti discorsi di Mussolini, quello di Torino del ottobre del ’ e quello di Ancona del novembre dello stesso anno. Caratteristiche comuni sono la mimica e la gestualità forzata all’inverosimile, oltre che l’uso di quel gergo cameratesco ereditato dal protofascismo combattente, del quale gli stessi fascisti andavano fieri, come del resto appare evidente in una recensione a un testo di Eugenio Adami pubblicata qualche anno più tardi su “Gerarchia”: «L’oratoria del Duce è l’espressione dell’epoca che intensamente viviamo, è la precisazione della realtà considerata da un cuore saldo e affrontata da una volontà inflessibile. È l’imperativo richiamo al combattimento inteso come necessità etica». Nei discorsi pronunciati in occasione delle celebrazioni del decennale della marcia su Roma, il viene ribattezzato come anno di nascita della «vera nazione italiana» e più volte i caduti della Grande guerra vengono chiamati in causa, «perché se fossero vivi avrebbero voluto un’Italia fascista». Quella alla quale si fa riferimento è l’epica liberatoria di una guerra vittoriosa, due volte intrapresa come insurrezione di avanguardie interventiste e due volte coralmente conclusa come guerra combattuta da un popolo disciplinato e gregario. Un approccio commemorativo più vicino a quello di Camicia nera – ma anche in questo caso meno allusivo e strutturato con fini essenzialmente autocelebrativi – può essere rintracciato in una produzione del ’, Gloria, che ripercorre le vicende della Grande guerra ritenute più significative. Un chiaro imbarazzo si fa, però, palese nel momento in cui la sequenza cronologica avrebbe previsto un accenno alla disfatta di Caporetto. Le immagini del ’ scorrono rapidamente e la sconfitta italiana è rivissuta soltanto attraverso le prime pagine di una serie di quotidiani. I fotogrammi staccano su un’animazione di una scena di propaganda ricostruita in teatro – compare un alpino che chiede aiuto al fronte interno – alla quale segue una breve “sequenza a soggetto” sulla reazione di un possente soldato italiano di fronte al tentativo di aggressione di un gruppo di austriaci. Le scene di morte e distruzione relative alle principali offensive attuate dall’esercito italiano lasciano spazio alla puntuale descrizione della scelta del milite ignoto – nella cattedrale di Aquileia il ottobre del ’ – e della sua successiva deposizione presso ANTONIA LIGUORI l’Altare della Patria. Come nota a margine, è da segnalare la presenza in questo filmato di un fotogramma assai ricorrente nei documentari relativi alla Grande guerra: si tratta dell’immagine di una casa semidistrutta con la scritta «Tutti eroi! O il Piave o tutti accoppati!», presente in Gloria ben due volte, quasi a dare il ritmo all’incedere delle trionfali giornate della vittoria. Un altro appunto che appare significativo è quello relativo al particolare interesse per le novità della tecnologia bellica, puntualmente riprese laddove si voglia stigmatizzare il valore e il coraggio dei corpi d’armata più rappresentativi della guerra di tipo tradizionale, quali i fanti e gli alpini. Tra i documenti filmici selezionati, quello che meno risente delle finalità propagandistiche e della conseguente ideologizzazione è anche il più “precoce”. Si tratta, infatti, di una produzione del ’, periodo nel quale si è ancora lontani dalla piena consapevolezza delle prospettive di utilizzo dei mezzi audiovisivi e dalla ottimizzazione della “struttura” recentemente mutuata dal SIC. La scelta dell’argomento e della relativa ambientazione è comunque significativa, anche se il mito puramente “patriottico” della Grande guerra risente ancora poco della sua successiva investitura “nazionalista”. I tratti del conflitto mondiale ridisegnati nel documentario Dal Grappa al mare sono quelli ereditati dalla propaganda bellicista diffusa al fronte, con qualche leggerissima, ma già indicativa, variante. In occasione del decimo anno dalla dichiarazione di guerra, i reduci ripercorrono il tratto dal Monte Grappa a Trieste in un ideale cammino verso la redenzione. Frequente la sovrapposizione di immagini di repertorio, nelle quali si tende a sottolineare l’ardore della truppa, l’incitamento dei comandanti e il cameratismo vissuto quotidianamente in trincea. Puntuale la visita degli ex combattenti ai sacrari, dove le spoglie dei soldati e quelle degli ufficiali riposano l’una accanto all’altra, a testimoniare come il conflitto possa rappresentare – da un punto di vista sociale – una sorta di riscatto per le persone più umili. Un filmato, invece, fortemente allusivo, grazie anche a una serie di piccoli artifici tecnici – quali la sequenza di immagini accelerate, le sovrimpressioni e le dissolvenze – è Il segreto del chicco di grano. L’apertura è dedicata alla visita di Mussolini a una comunità agricola durante la «battaglia del grano», «la prima grande campagna agricola dello stato fascista» lanciata nell’estate del e poi ripresa con forza nel in occasione della proclamazione ufficiale della politica autarchica del regime. L’intento del documentario – che una nota a margine definisce «favola vera» – è palesemente propagandistico: l’impegno dei contadini nella produzione dei cereali è messo, infatti, in relazione con il contributo dei soldati italiani in guerra, come sintetizza e chiarisce una fugace didascalia frapposta tra gli ultimi fotogrammi: «Con questa battaglia il governo ha L’ISTITUTO LUCE TRA INFORMAZIONE, MEMORIA E PROPAGANDA impegnato ricchezze che sono di tutti, e di tutti sarà l’esito della vittoria. Come un giorno gli italiani dettero il sangue per difendere la Patria dal nemico». L’immagine del germoglio che fiorisce lascia spazio a una serie di sequenze che ritraggono scene di guerra: soldati che si sollevano dalle trincee, feriti trasportati sulle barelle; i boati delle esplosioni si alternano al religioso silenzio di un sacrario sorto su un’altura. La regia stacca di nuovo su un campo con le spighe al vento: è la vita che nasce dall’operosità dell’uomo, temprato anche dall’esperienza della guerra, rigenerato e motivato dal ricordo del sacrificio compiuto per la patria. Assimilazioni un po’ “azzardate” non sono certamente prerogativa unica di questa suggestiva e breve animazione, che suggerisce il confronto con un frammento di un’altra produzione propagandistica, titolata Sulle orme dei nostri pionieri. All’interno del documentario, che si propone di mobilitare l’opinione pubblica in favore della politica coloniale fascista in Africa orientale, la prima sequenza di immagini – abbastanza prevedibile per la scelta dei soggetti – stacca repentinamente su un mappamondo in sovrimpressione che ruota sulle immagini della battaglia di Vittorio Veneto e su quelle di una nave di emigranti. Poco dopo compare una roulette, che pone evidentemente in relazione la volontà espansionistica dell’Italia con il gioco d’azzardo. Qui la lettura è un po’ più complessa rispetto al Segreto del chicco di grano, dove il messaggio non consentiva letture diverse da quelle proposte nelle didascalie. In Sulle orme dei nostri pionieri, invece, le componenti sono molteplici e la brevissima animazione non contribuisce a chiarirle; tuttavia, sono esplicite le pretese coloniali fasciste e la necessità di “poggiarle” su una base salda come soltanto il mito della vittoria trionfale – quella di Vittorio Veneto – poteva fornire. Per giunta l’attivismo del regime andava correlato alla presunta passività dei governi liberali, corresponsabili anche dell’imponente ondata di emigrazione d’inizio secolo. L’elemento del rischio nell’impresa coloniale va cercato invece nel presunto complotto internazionale del quale sarebbe stata vittima l’Italia, tradita a Versailles rispetto agli accordi previsti dal Patto di Londra, anche a causa dell’incapacità della classe politica coinvolta in quella delicata vicenda internazionale. Mentre una didascalia propone alcuni passaggi del Patto di Londra, il mappamondo in sovrimpressione riprende a girare: al centro del disegno di animazione compare una nuova carta geografica con la suddivisione delle terre d’oltremare prevista dalla politica coloniale fascista. La successiva scansione di alcune sequenze che propongono pagine dei trattati firmati tra Italia, Francia e Inghilterra dal al ha l’esplicito intento di ribadire la presunta legittimità da parte del regime dello sfruttamento minerario del nord dell’Etiopia e la possibilità di costruire la contestata strada tra Assad e Dessié. Il mito dell’Impero nel fascismo non era un’improvvisazione pro- ANTONIA LIGUORI pagandistica collegata alla conquista dell’Etiopia, ma era un mito già presente, che emerse sempre di più attraverso la valorizzazione della funzione rivoluzionaria del fascismo come movimento universale e non solo italiano, come nazionalismo che aspirava – più che all’espansione territoriale – a porsi nel mondo come centro irradiatore di una nuova civiltà universale. Nella rilettura ufficiale delle singole fasi della Grande guerra – come dei suoi “naturali prolungamenti” – sapientemente diffusa dal regime fascista, il passo dalla «vittoria trionfale» alla «vittoria mutilata» era breve, almeno da quanto chiarisce un filmato interamente dedicato a L’impresa di Fiume. Qui è determinante il commento dello speaker, per verificare come il ruolo da protagonista di D’Annunzio nella marcia di Ronchi fosse finalizzato alla rappresentazione di determinati aspetti che furono poi acquisiti come propri dal regime. Era stato il poeta a coniare la fortunata espressione della «vittoria mutilata», ma fu il duce a farne la ragione del suo mandato. Fiume – nei sette minuti del documentario – non è celebrata per la vicenda dannunziana, bensì come luogo nel quale maturò il piano della marcia su Roma e dove per la prima volta si sperimentarono rituali collettivi, quali le adunate e i dialoghi tra il “capo” e la folla. La marcia di Ronchi, dunque, era presentata come una sorta di prova generale della marcia su Roma, dove forte compariva il nesso tra l’avventura dei più audaci, capaci di violare la legge per puntare verso una meta ben definita attraverso i loro slogan, e il balcone del palazzo civico dal quale si affacciava il capo di quell’ardita milizia. Significativo è anche il risalto dato dalla regia alla presenza della popolazione civile a sostegno delle azioni dei volontari, proprio a testimoniare l’esigenza del regime di mobilitare e invitare alla partecipazione una nazione intera. L’opera intrapresa sull’Adriatico nel ’ non poteva essere consegnata in altre mani che in quelle di Mussolini, come si legge in queste poche righe tratte da un articolo di Arrigo Solmi comparso su “Gerarchia” in occasione del diciannovesimo anniversario della marcia di Ronchi: «La luce di questa impresa, durata fino al Natale di sangue del dicembre , è la premessa sicura della prossima resurrezione della patria; è il preannuncio dei bagliori del Fascio Littorio, che condurrà l’Italia, in meno di quindici anni, alla potenza e all’Impero». Verrebbe da dire «nessuna impresa che tenda a glorificare l’Italia è ardua», prendendo in prestito le parole con le quali Angelo De Vito, in un cortometraggio prodotto a New York, osannava ogni atto compiuto dal duce del fascismo. De Vito era il direttore della Cinema Productions, che trovò – probabilmente nel ’ – in Giovambattista Cincotta il suo regista per un breve film che fosse l’omaggio dei fascisti italoamericani L’ISTITUTO LUCE TRA INFORMAZIONE, MEMORIA E PROPAGANDA a Mussolini. Si tratta di una produzione – questa volta giunta dagli Stati Uniti – che aiuta a comprendere con maggiore chiarezza la forte carica emotiva che il più delle volte trascinava l’opinione pubblica verso la realizzazione del mito mussoliniano. L’artefice della nuova Italia si proponeva di ripercorrere le vicende comprese tra l’inizio della Prima guerra mondiale fino all’avvento del fascismo, secondo l’angolo di visuale offerto dal cronista, influenzato anche nella mimica dalla sua straordinaria ammirazione per il duce, definito «campione incomparabile […] davanti a tutti gli ostacoli della vita». Significative le prime immagini che propongono Mussolini combattente, favorito dal destino anche nel suo ferimento, che rappresenta il momento in cui la sorte lo risparmia per consentirgli in futuro di dare un «nuovo tono spirituale alla Nazione». Il fascismo, attraverso lo stereotipo dell’“uomo nuovo”, rappresentava se stesso come modello per l’affermazione di una società maschile che proseguiva in tempo di pace il cameratismo nato nelle trincee. Le caratteristiche del cittadino-soldato erano precisate con chiarezza: atletico, perseverante, pronto al sacrificio, l’italiano nuovo doveva incarnare una virilità forte e invulnerabile. Il sentimento dominante nel filmato di De Vito è la nostalgia dell’italoamericano nei confronti della «nuova Italia», assai diversa da quella che consentì il disperato tentativo di cercar fortuna oltremare. Era quella l’Italia dei liberali «confusionari, chiacchieroni e cerebrali», e cioè dei già stanchi rappresentanti del vecchio ordine. Bisogno estremo di certezze, di ordine apparente, di efficienza e forza dell’apparato governativo, stanchezza per una libertà mal gestita, seguita allo scollamento successivo alla prima conflagrazione universale: questa è la situazione “morale” che aveva favorito la diffusione di quella che Volpe ha definito una sorta di «religione antropomorfica»: «Carattere di tutti i movimenti di masse: esse si raccolgono attorno a un uomo, si danno, si abbandonano a lui. La loro religione è antropomorfica: togli l’uomo e la religione si stempera e svanisce». E in quel caso si trattava di un uomo che, giocando sulle astuzie oratorie e sulla più totale mistificazione di ogni evento, doveva pensare a “ricostruire” tutta una serie di circostanze storiche, politiche e persino morali, che potessero giustificare la sua ascesa al potere. È interessante notare nel documentario americano la sequenza degli anni scelti per ricostruire il percorso mussoliniano – il , il , il ’, il ’, il ’ e il ’ – posto continuamente in relazione con le vicende internazionali. A quanto scrisse D’Annunzio nel ’, il duce sembrava proprio aver raggiunto il suo obiettivo; anzi, sembrava quasi averlo superato: «Dopo tante battaglie, dopo tante vittorie, dopo tanti contrasti, dopo tanta volontà, tu hai veramente compiuto quel che nelle storie dei grandi uomini non ANTONIA LIGUORI è quasi mai compiuto. Tu hai creato il tuo mito». E i contenuti del discorso di De Vito ne sono un’ulteriore conferma: ogni commento riferito all’attività di Mussolini – dall’interventismo in poi – sembra testimoniare una «superiorità morale che non conosce ostacoli», messa alla prova e fortificata giorno per giorno proprio a partire dall’esperienza bellica. Il passaggio del fascismo da movimento a regime è riscritto in maniera del tutto unica in uno di quei filmati che risente particolarmente del periodo di realizzazione. Si tratta di una produzione “Dolomiti film” del dal titolo Il covo, che ricostruisce la storia de “Il Popolo d’Italia”, proponendolo come chiave di lettura per gli eventi compresi tra il ’ e il ’. Forte è il contrasto con quelle pellicole autocelebrative – elaborate tra la fine degli anni Venti e tutto il decennio successivo – nelle quali il quotidiano di Mussolini godeva del privilegio di essere presentato come il traino di tutto l’interventismo italiano e – durante la guerra – il solo organo di stampa capace di sollevare il morale della truppa. Il termine “ante quem” della narrazione è anche qui l’intervento in guerra, definito ormai in maniera indiscutibile come momento decisivo per le future sorti italiane. La novità consiste nell’ambientazione, che potremmo definire quasi funerea, particolarmente evocativa anche se strutturata su pochi elementi: la sede del “covo” – e cioè la redazione de “Il Popolo d’Italia” – la scrivania del duce, i gagliardetti affissi alle pareti, lo scantinato dell’edificio. Tutto scandito dall’incessante alternarsi di carrellate in ambienti più simili a musei, di dissolvenze e di interferenze di foto e cineattualità che alludono al succedersi degli eventi: i trascorsi interventisti di Mussolini, la fondazione dei fasci di combattimento e, infine, l’ascesa al potere, non descritta, ma suggerita da una “soggettiva” in movimento sulle pietre romane della via Appia Antica. La fine della retorica come parabola della morte Abbiamo lasciato in ultimo l’analisi di due filmati interamente dedicati al duce del fascismo, perché, visto il loro più recente periodo di produzione, aiutano a verificare il progressivo mutare dell’approccio rispetto agli eventi fin qui analizzati. Si tratta di Benito Mussolini – per la regia di Pasquale Prunas – e dell’assai simile Benito Mussolini, anatomia di un dittatore, realizzato con materiale di repertorio nel . In entrambi vengono proposti episodi ovviamente mai accennati nei documentari con dichiarato intento propagandistico e, per di più, il ruolo attribuito agli eventi relativi alla partecipazione di Mussolini alla Grande guerra è pressoché nullo. Addirittura, nell’ultimo filmato preso in considerazione, la vicenda del L’ISTITUTO LUCE TRA INFORMAZIONE, MEMORIA E PROPAGANDA Duce è presentata come una sorta di parabola della morte, che si apre e si chiude sulle immagini del cimitero di Predappio, quasi a stigmatizzare un destino ormai privato di qualsiasi retaggio retorico. Non tradisce emozioni neanche uno degli ultimi fotogrammi nel quale compare l’immagine capovolta di una cancellata chiusa, quella dove, forse, fu ucciso Mussolini. Immediato è il salto dell’immaginazione alla clamorosa espressione di dissenso che si consumò in piazzale Loreto, dove «lo spettatore non si identifica più con l’attore e anzi smania di mostrargli la propria dissociazione». E altrettanto evidente – quasi a voler “segnare” la parabola discendente del consenso della nazione verso il regime – è l’intento di rappresentare il fallimento di quella carrellata di miti, ai quali si è già fatto cenno, nella pavida fine di Mussolini, che, dopo aver cresciuto l’Italia al suono del motto «se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi», lasciò come ultima immagine di sé quella dell’uomo in fuga travestito da tedesco. Su questa gelida chiusura, attuata da una regia libera dagli obblighi dell’ideologia, ma forse ingabbiata dall’altrettanto vincolante scelta di manifestarsi “estranea” rispetto alle vicende rivissute nel filmato, termina un percorso con il quale si è tentato di suggerire alcune tracce di quel “debito” del fascismo nei confronti della straordinaria cesura storica rappresentata dalla Grande guerra. La lezione che si può trarre dal contatto con le fonti dirette consiste nella consapevolezza che ogni tipo di manifestazione culturale – ancor più se “viziata” dal proprio tempo di produzione – fornisce spunti ulteriori per l’analisi e lo studio del contesto nel quale si sviluppano i “codici culturali” di un’epoca. Riconoscere la diversità dei punti di osservazione – anche attraverso il confronto con quelli “investiti” dall’ideologia – può risultare utile per percepire con maggior consapevolezza la complessità degli eventi e della loro interpretazione. A tal proposito viene in mente una riflessione di Henri Pirenne – da lui elaborata qualche anno dopo la fine della Prima guerra mondiale – relativa alla perfettibilità dell’opera storica. Egli, partendo dal presupposto che anche i pregiudizi degli autori possano contribuire a migliorare le nostre conoscenze sul passato, afferma che un’opera storica – e nel nostro caso l’affermazione può essere trasferita anche all’interpretazione degli eventi fornita dal regime sia nella sua globalità che nelle sue singole manifestazioni – è sempre incompleta in quanto consiste in una «ricostruzione congetturale del passato», nella quale ciascun autore «mette in luce una parte, fa risaltare certi tratti, considera certi aspetti», che, se possono viziarne l’interpretazione, letti con cura, non perdono la loro utilità. Anzi – si potrebbe aggiungere – offrono un ulteriore stimolo alla conoscenza. ANTONIA LIGUORI Note . E. Gentile, Fascismo. Storia e interpretazione, Laterza, Roma-Bari , p. . . L’elemento sul quale la politica culturale successiva al ’ fondò le proprie radici era, da una parte, l’aspetto “dinamico” che, nel periodo prebellico, trovò eco soprattutto nelle provocazioni futuriste, dall’altra, quello che potremmo definire “etico”, che comprendeva orientamenti che andavano dall’apologia della vita nazionale compiuta da Corradini sulle colonne de “Il Regno” all’invocazione a quei “sentimenti virili” ai quali alludeva Pareto. Un afflato etico che permise al fascismo di tracciare una propria storia spirituale, il cui richiamo divenne quasi un rito in ogni momento della vita della Nazione nella quale si rendesse necessario gonfiare di elementi “rivoluzionari” una struttura fortemente reazionaria o dare credibilità alle più ricorrenti interpretazioni del passato, caricandole di un forte senso della profezia. Ecco allora ricomparire nel tessuto retorico del regime tutte quelle allusioni alla forza che i «padri della rinascita borghese novecentesca» (si veda a tal proposito A. Asor Rosa, Storia d’Italia. Dall’unità a oggi, vol. IV, t. II, La cultura, Einaudi, Torino , p. ) avevano fatte proprie per pervenire alla giustificazione teorica della guerra. Ci riferiamo in particolare ai miti della violenza, diffusi come elementi di educazione rivoluzionaria, dal pensatore francese George Sorel – principale teorico del sindacalismo rivoluzionario – condivisi e ripresi anche dai nazionalisti; o all’immagine che Oriani fornì della guerra, della quale evidenziava un valore quasi taumaturgico; o a quella che offrì D’Annunzio, che dal conflitto attendeva la più efficace manifestazione dell’individualità eroica. E come non pensare a Pareto, che mostrava la guerra come unico rimedio per arrestare l’avanzata del socialismo o alle affermazioni dei futuristi – Marinetti in testa – che inneggiano alla guerra «sola igiene del mondo», come momento massimo di «negazione dell’ordine», inteso sia in senso psicologico e individuale che politico e collettivo. . G. Bottai, L’interventismo della cultura, in “Primato”, ° giugno ; citato anche in L. Mangoni, L’interventismo della cultura. Intellettuali e riviste del fascismo, Laterza, Bari . Ecco allora rifarsi avanti nel quell’idea dell’“interventismo della cultura”, concetto già presente all’alba del Novecento, anche se ancora non ben definito, nelle menti dei giovani fondatori di “Leonardo”, che non poterono fare a meno di puntare la loro attenzione sulla priorità del pensiero rispetto all’arte, quale promotore di una immediata «rivoluzione di valori» (si veda a tal proposito D. Frigessi (a cura di), La cultura italiana del ’ attraverso le riviste, vol. I, Leonardo, Hermes, Il Regno, Einaudi, Torino , pp. -). Era il mese di agosto del quando Gian Falco dalle colonne di “Leonardo” lanciava la sua “Campagna per il forzato risveglio”, dando voce a un’esigenza ancora fumosa nei dettagli, ma già indicativa quanto a espressione di una forte volontà di rottura, resa inderogabile dalle sue parole: «Voglio che una parte, anche piccola, dell’ultima generazione italiana, si liberi da certe tendenze, da certi gusti, da certe debolezze e acquisti invece altri caratteri, nuove passioni e preoccupazioni. Modificare uomini, amputare e ingrandire anime, trasformare spiriti: ecco l’arte mia favorita”» (cfr. Gian Falco, La campagna per il forzato risveglio, in “Leonardo”, , IV, agosto, citato in Frigessi (a cura di), La cultura italiana del ’, cit., p. ). Ma esattamente un anno dopo, su quelle stesse pagine era l’ora della resa, dichiarata in maniera sconsolata da Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini, che nell’articolo La fine fanno parlare il loro rammarico per non essere riusciti in cinque anni di presunta militanza a incidere minimamente sulle coscienze italiane: «Il Leonardo è stato sempre da noi considerato come un apparecchio per eseguire determinate esperienze sull’anima vile italiana. Dopo cinque anni di queste esperienze, dopo aver cercato con questa rivista e con altre opere, di scoprire uomini, di svegliare e trasformare anime, di trovare giovani che fossero per noi compagni e schermidori e non pappagalli male ammaestrati, ci siamo persuasi che non val la pena di continuare» (cfr. G. Papini, G. Prezzolini, La fine, in “Leonardo”, , V, agosto). Trascorse ancora un anno prima che lo stesso Prezzolini L’ISTITUTO LUCE TRA INFORMAZIONE, MEMORIA E PROPAGANDA riprendesse il cammino precedente di denuncia della «mediocrità morale dominante» (cfr. A. Asor Rosa, Storia della letteratura italiana, La Nuova Italia, Firenze , p. ), questa volta dalle pagine de “La Voce”, la cui missione fu portata avanti fino al ’. Egli si oppose con forza a chi – come Renato Serra – voleva delegare alla classe colta la sola funzione di «depositario della tradizione» (cfr. Mangoni, L’interventismo della cultura, cit., pp. -) senza neanche intravederne la potenziale forza dirompente all’interno di una società che si sentiva ancora così lontana dai suoi rappresentanti. La rivista fiorentina si faceva avanti come mediatrice tra il paese e la classe dirigente, ponendo come nodo centrale del suo lavoro il concetto di «rigenerazione del sentimento morale» (Asor Rosa, Storia della letteratura italiana, cit., p. ). . F. Venturi, Corso di storia moderna, a. a. -, Cooperativa Libraria Universitaria Torinese, Torino . . A. D’Orsi in un’intervista pubblicata su “Il Foglio” il maggio del , ha dichiarato: «Come oggi uno storico possa riproporre la doppia equazione bobbiana (fascismo = incultura, cultura = antifascismo) costituisce per me davvero il quarto mistero di Fatima». Si veda anche A. D’Orsi, La cultura a Torino tra le due guerre, Einaudi, Torino . . N. Bobbio, Il dubbio e la scelta, Carocci, Roma . La raccolta di saggi sulla questione degli intellettuali è considerata dallo stesso autore uno dei suoi testi più importanti, poco letto e discusso perché uscito in un momento in cui si facevano avanti tematiche più pressanti (come la fine della guerra fredda, ad esempio). . E. Gentile, Fascismo. Storia e interpretazione, Laterza, Roma-Bari , p. . . R. Romeo, Scritti politici -, Il Saggiatore, Milano , p. . . Si veda ad esempio la lezione tenuta dal prof. Alberto Preti il marzo presso il Dipartimento di Studi storici dell’Università di Bologna a proposito delle interpretazioni del Novecento. Nel seminario rivolto ai dottorandi di “Storia e informatica”, Preti, prendendo le mosse dal confronto di quattro testi che hanno ottenuto una straordinaria risonanza anche sulle colonne dei quotidiani (Il secolo breve di Hobsbawm, l’intervento di Mayer comparso nel sulla rivista “Parolechiave”, La fine della storia di Fukuyama, Lo scontro delle civiltà di Huntington), ha puntualizzato le implicazioni connesse al concetto di uso pubblico della storia. . M. Isnenghi (a cura di), I luoghi della memoria. Strutture ed eventi dell’Italia unita, Laterza, Roma-Bari , p. VII. . C’era chi, come Bottai, avvertiva la necessità di distinguere fra miti “falsi”, con fini puramente strumentali, e miti “veri”, capaci di coinvolgere come oggetti di culto l’intera collettività, in quanto rappresentazioni profonde di un’epoca – e questo è il caso del mito della Grande guerra –; tuttavia, il successo del fascismo, nella gestione e nel recupero dei miti, non consisteva nell’abolizione dei cosiddetti miti “falsi”, bensì nella capacità di rendere labile il confine tra gli uni e gli altri, e allo stesso modo tra mito e storia. . A. Gibelli, L’officina della guerra. La Grande guerra e le trasformazioni del mondo mentale, Bollati Boringhieri, Torino , p. . . Isnenghi (a cura di), I luoghi della memoria, cit., p. . . Gibelli, L’officina della guerra, cit., p. . . La mitologia del fascismo poggiava a tal proposito sulla coincidenza tra l’adesione alla guerra e il suo significato simbolico come atto costitutivo della «rinascita della stirpe» (si veda D. Mack Smith, Mussolini. La vita del duce raccontata dal grande storico inglese, Rizzoli, Milano , p. ), di quel popolo finalmente consapevole di dover affrontare – trascinato dalle passioni suscitate dal duce – una vera e propria missione di civiltà nel mondo moderno. In particolare, secondo i fascisti, la guerra aveva dato il suo determinante contributo per l’agognata unificazione delle classi sociali attraverso l’esperienza del cameratismo dei soldati, basato su una «gerarchia del carattere» (E. Gentile, Storia del partito fascista (-). Movimento e milizia, Laterza, Roma-Bari , p. ), ossia sul valore di ognuno e sulla rispettiva adesione ai miti costitutivi della Grande guerra. L’uomo nuovo fascista, moralmente forgiato dalla trincea, esempio di virtù militare e di ANTONIA LIGUORI totale dedizione alla patria, incarnava il mito della giovinezza, in netto contrasto con il prodotto della democrazia parlamentare, «tollerante perché senza fede». Fino alla guerra, la politica era ritenuta l’oggetto di quella rigenerazione intesa come rivoluzione spirituale dalle avanguardie culturali. A conclusione del conflitto, è la politica a rivendicare la funzione rigeneratrice della nazione, poiché assume il «monopolio nella definizione del significato e del fine ultimo dell’esistenza» (E. Gentile, Un’apocalisse nella modernità. La Grande guerra e il mito della Rigenerazione della politica, in “Storia contemporanea”, ottobre , pp. -). . Gibelli, L’officina della guerra, cit., p. . . Il fascismo non può essere definito un’ideologia “di” masse, ma “per” le masse, poiché, pur comprendendo il ruolo determinante dell’anima collettiva per la vita del paese, non riconobbe alla folla né la possibilità di esprimere un’idea politica, né tanto meno la capacità di autogovernarsi. Al contrario, il processo di partecipazione doveva coincidere con l’integrazione dei singoli individui nelle organizzazioni dello Stato totalitario, attraverso la diffusione della nuova tipologia del “cittadino soldato”. Tale modello – che doveva distinguersi per qualità morali e non intellettuali – costituiva l’elemento propulsore di una sorta di «rivoluzione antropologica» (E. Gentile, La Grande Italia. Ascesa e declino del mito della nazione nel XX secolo, Mondadori, Milano , p. ): compito del regime era quello di trasformare gli italiani in fascisti integrali, attraverso un progresso morale, determinato dall’azione dello Stato, che avrebbe agito sull’innata ferinità dell’uomo. Solo instillando il valore della vita come dovere e missione, la dedizione alla patria poteva avere la meglio sul naturale egoismo dell’individuo. E tale concetto poteva trarre il suo sostegno in un ulteriore richiamo al mito dell’esperienza della guerra, laddove si facesse appello al conflitto come nuova forma di partecipazione. . La Francia, invece, nazione vittoriosa e soddisfatta, vide sorgere potenti movimenti di ex combattenti che proclamavano la fine di ogni guerra (si veda a tal proposito G. L. Mosse, Il fascismo. Verso una teoria generale, Laterza, Roma-Bari , p. ). . S. Romano, La cultura europea tra Ottocento e Novecento, in “Nuova Storia Contemporanea”, V, settembre-ottobre , pp. -. . Come non ricordare l’immagine dell’«Italia in cammino» coniata da Gioacchino Volpe nel nella sua riflessione sulle vicende dell’ultimo cinquantennio? Immagine “mitica” che testimonia in un certo senso l’adesione più “sentimentale” che politica dello storico italiano al regime fascista. Si tratta di una di quelle «immagini motrici» – per appropriarsi della definizione fornita da Sorel a proposito de «la mystique» – che, d’altra parte, fu facile bersaglio della visione critica di Benedetto Croce, il quale, in polemica con Volpe dopo la pubblicazione della sua Storia d’Italia, non tardò ad affermare che «l’Italia di Volpe cammina, ma non pensa». . G. Gentile, Guerra e fede, De Alberti Editore, Roma . Nella prefazione a questa raccolta di articoli, Giovanni Gentile affermava che per l’Italia «il problema della guerra era un problema superiore alla guerra stessa e tale da impegnare tutto l’avvenire della vita italiana». Rinnovava in questo modo l’impegno della politica postbellica, che doveva valutare come priorità assoluta la necessaria riforma del carattere italiano. Ciò procedeva inevitabilmente nella stessa direzione dell’abbandono di quella politica scettica di tipo giolittiano, sulla quale pesò la secolare sfiducia nelle capacità degli italiani di porsi di fronte a duri sacrifici e a prove impegnative. L’occhio, dunque, veniva puntato in primo luogo sulla rigenerazione collettiva, intesa come esperienza che, attraverso la trasfigurazione degli eventi vissuti dalla generazione dei combattenti, veniva abbracciata anche da chi non fosse stato al fianco dei protagonisti della Grande guerra. . Si veda anche a tal proposito, oltre all’atteggiamento di Marinetti e dei futuristi, E. Jünger, L’operaio: dominio e forma, Guanda, Parma . . Gibelli, L’officina della guerra, cit., p. . . G. L. Mosse, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, Laterza, RomaBari , p. . L’ISTITUTO LUCE TRA INFORMAZIONE, MEMORIA E PROPAGANDA . M. Isnenghi, Il mito della Grande guerra, il Mulino, Bologna , pp. -. . E. Gentile, Il culto del littorio, Laterza, Roma-Bari , p. . . Fu questo il “capolavoro” del socialriformista Ivanoe Bonomi, che, il novembre del , consegnò agli italiani quel nuovo simbolo che i fascisti non tardarono a integrare nell’istituzione di una liturgia nazionale attorno al mito della Grande guerra e alla resurrezione della patria. Si vedano a tal proposito B. Tobia, L’altare della Patria, il Mulino, Bologna , e Id., Dal Milite ignoto al nazionalismo monumentale fascista, in Storia d’italia, Annali , Guerra e pace, Einaudi, Torino . . Furono Inghilterra e Francia le nazioni che inaugurarono la pratica di innalzare una tomba al Milite ignoto come luogo del culto nazionale. . Johan Huizinga scrisse nel a proposito del ricorso al concetto di “eroe” come sintomo di una diffusa crisi di valori: «C’è qualcosa di tragico nel fatto che l’odierna degenerazione dell’ideale eroico sia partita dalla superficiale ondata di entusiasmo per la filosofia nietzschiana, che intorno al si diffuse in ambienti vasti. […] Tutti i mediocri imbecilli della fine del secolo parlarono di superuomo, come se fosse stato il loro fratello maggiore. Questo volgarizzamento intempestivo del pensiero nietzschiano è stato senza dubbio l’inizio della tendenza spirituale che oggi pone l’eroismo come parola d’ordine e come programma». J. Huizinga, La crisi della civiltà, Einaudi, Torino , (prima edizione olandese, ; prima traduzione italiana, ). . M. Isnenghi, L’Italia in piazza. I luoghi della vita pubblica dal ai giorni nostri, Mondadori, Milano , p. . . G. Antona Traversi Gismondi, Il santuario della patria. Cimitero militare di Redipuglia, Ufficio centrale cure e onoranze salme caduti in guerra, Padova , p. . . P. Dogliani, Redipuglia, in M. Isnenghi (a cura di), I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia unita, Laterza, Roma-Bari , p. . . Il progetto di ampliamento fu inserito all’interno di quell’ambiziosa politica avviata dal regime con la legge del giungo del – volta alla definitiva sistemazione dei cimiteri militari del territorio nazionale – alla quale seguì, nel ’, l’inaugurazione dei sacrari del Monte Grappa, di Pocol e del Montello in prossimità del Piave, nel ’, l’apertura della “via sacra” sul Pasubio e Castel Dante a Trento, e, nei due anni successivi, il completamento – assieme a quello di Redipuglia – dei cimiteri monumentali di Oslavia e Caporetto. . Queste sono le parole che il duca d’Aosta avrebbe lasciato come sua eredità spirituale: «Muoio serenamente, sicuro che un magnifico avvenire si dischiuderà per la patria nostra, sotto l’illuminata guida del re ed il sapiente governo del duce». Dogliani, Redipuglia, cit., p. . . G. Sabbatucci, V. Vidotto (a cura di), Storia d’Italia, , Guerre e fascismo, Laterza, Roma-Bari , p. XV. . M. Pottino, Compiti e finalità del Luce, Tipografia STET, Roma , p. . . R. D. n. del novembre . Per una sintesi dell’attività de L’Unione Cinematografica Educativa si veda la voce “Istituto Luce” curata da Gabriele D’Autilia in Dizionario del fascismo, a cura di V. De Grazia e S. Luzzatto, vol. I, Einaudi, Torino , pp. -. . Questo è l’ordine di progressione con il quale vennero istituite le otto cinemateche: agricola ( marzo ), industriale di propaganda e istruzione ( agosto ), per l’arte e l’istruzione religiosa ( settembre ), di cultura nazionale ( dicembre ), militare e d’istruzione e propaganda ( gennaio ), turistica e di propaganda marinara ( gennaio ), igienica e di prevenzione sociale ( gennaio ), di propaganda e cultura all’estero ( giugno ). Cfr. G. D’Autilia, Istituto Luce, in Dizionario del fascismo, a cura di V. De Grazia, S. Luzzatto, Einaudi, Torino , pp. -. . J. Grierson, Documentario e realtà, Ed. Bianco e nero, Roma . . Ibid. . M. Argentieri, L’occhio del regime. Informazione e propaganda nel cinema del fascismo, Vallecchi, Firenze , p. . ANTONIA LIGUORI . Già ai primi del secolo la cultura aveva individuato nella “folla” il nuovo protagonista dell’età contemporanea, specificando, attraverso le conoscenze fornite dagli esperti in psicologia collettiva, la nuova sfera di interessi che la politica doveva coltivare. In particolare, si apriva un nuovo orizzonte allo studio della mentalità e del comportamento delle masse, per giungere all’individuazione dei fattori idonei alla formazione e al controllo dell’anima collettiva. Scriveva, ad esempio, nel Scipio Sighele: «Oggi è la voce collettiva e grandiosa delle folle che guida il mondo; […] oggi si è compreso che il protagonista vero della storia, quantunque non sempre visibile, è stato il popolo, vale a dire la folla anonima su cui l’egoismo dei grandi lavorava come su un corpo vile per costruire l’edificio della propria potenza». (Citato in E. Gentile, Il mito dello Stato nuovo dall’antigiolittismo al fascismo, Laterza, Roma-Bari , p. ). L’organizzazione del consenso durante il ventennio fascista dimostrò di aver assimilato questa centralità del ruolo della folla, imparando a incanalare e controllare l’irrazionalismo delle masse attraverso la cultura dell’organizzazione, al fine di instillare valori come la disciplina e di giustificare il comando di una minoranza. Autori come Le Bon, Michels, Sorel – ai quali Mussolini fece spesso esplicito riferimento – avevano dimostrato che il predomino del sentimento nella psicologia collettiva non andava interpretato come fattore negativo, bensì come spunto di riflessione sul valore di una «svalutazione razionale della ragione» a fini politici (cfr. Gentile, Il mito dello Stato nuovo, cit., p. ). . P. V. Cannistraro, La fabbrica del consenso, Laterza, Roma-Bari . . Gentile, Fascismo. Storia e interpretazione, cit., p. . . In dodici mesi il Planetario ospitò proiezioni per ragazzi, per istituti, enti e scuole, per il pubblico e conferenze. [Dati tratti da Argentieri, L’occhio del regime, cit.]. . Notevole anche l’incremento produttivo: dai . metri di negativo sommati complessivamente nel ai . del , dai . del ai . del primo semestre . . Il duce era presentato in una infinita varietà di versioni, in qualità di presidente del Consiglio, in famiglia, a cavallo nel parco di Villa Torlonia, a bordo dei trattori, nuotatore, in motocicletta e, ovviamente, in qualità di arringatore di fronte alle ricorrenti adunate oceaniche. . Argentieri, L’occhio del regime, cit., p. . . Ivi, p. . . Per un quadro generale sull’attività propagandistica della radio italiana tra le due guerre, si rimanda al testo di A. Monticone, Il fascismo al microfono. Radio e politica in Italia (-), Ed. Studium, Roma . . Per conoscere dall’interno le dinamiche relative alla gestione delle notizie da parte del regime fascista può tornare utile consultare il recente lavoro di R. Canosa, La voce del Duce. L’Agenzia Stefani: l’arma segreta di Mussolini, Mondadori, Milano . . La scansione in sequenze e le caratteristiche tecniche di maggior rilievo sono presenti sul sito internet dell’Istituto Luce nella sezione Archivio storico, all’indirizzo: http://www.archivioluce.com. Si può risalire ai singoli documenti con una ricerca per argomento, inserendo il titolo o il codice indicato come parola chiave. . Asor Rosa, Storia d’Italia. Dall’unità a oggi, cit., p. . . Con una legge del ottobre del , l’Opera Nazionale Balilla fu assorbita dalla Gioventù Italiana del Littorio: la formazione delle più giovani generazioni passava in questo modo sotto il controllo del Partito. . Mussolini nella primavera del ’, in uno dei suoi colloqui con Emilio Ludwig, affermava: «Noi festeggiamo il maggio, giorno in cui la guerra si iniziò, non il trionfo sul vinto. […] Noi consideriamo la decisione di entrare in guerra come data rivoluzionaria: fu il popolo che decise allora contro la volontà dei parlamentari. Con ciò cominciò la Rivoluzione Fascista» (E. Ludwig, Colloqui con Mussolini, Mondadori, Milano , p. ; citato anche in F. Ercole, La Rivoluzione Fascista, F. Ciuni Libraio Editore, Palermo L’ISTITUTO LUCE TRA INFORMAZIONE, MEMORIA E PROPAGANDA , p. ). . R. Moro, Religione e politica nell’età della secolarizzazione, in “Storia Contemporanea”, n. , aprile , pp. -. . A tal proposito il retroterra culturale più ricco è senz’altro quello espresso dagli ideologi del nazionalismo nostrano. Primo fra tutti Corradini, citato dal fascismo come “profeta” per i contenuti che andò esprimendo già sulle colonne de “Il Regno”, con la sua concezione spiritualistica della nazione, che, nel dopoguerra, non tardò a gettare tra le braccia dei mussoliniani. Sintomatica la giustificazione della partecipazione alla guerra come subordinazione della volontà individuale a quella collettiva, dalla quale risultava evidente l’ammissione della negatività dell’evento bellico per l’individuo e, d’altro canto, la tensione verso uno scopo di più ampio respiro che coinvolgesse non solo la nazione, ma l’intera civiltà umana. «La guerra […] in stato d’animo individuale, veramente non si comprende: i soldati quando dallo stato collettivo (esercito che combatte) tornano nello stato individuale (timor panico), non la fanno più e fuggono, e tutta l’altra gente che non è capace di passare dallo stato individuale a quello collettivo la condanna». Una definizione, questa, riscritta a posteriori da Francesco Ercole (cfr. F. Ercole, Pensatori e uomini d’azione, Mondadori, Milano , p. ) e mutuata direttamente da quel nazionalismo corradiniano, così carico di volontarismo e tutto proiettato verso l’attuazione di una “missione” da far compiere all’intera nazione. . Una simile affermazione può rafforzare a prima vista il paradosso che si fece sempre più palese nel consolidarsi del regime. Esso consisteva, infatti, nella contraddittorietà di un movimento che, privilegiando l’azione sul pensiero, si poneva inizialmente come antideologico, ma, nel suo progressivo consolidarsi, non rinunciava a forgiare una propria ideologia, lavorando su un materiale ben caldo come poteva essere quello dell’attivismo o dell’irrazionalismo. La particolarità del movimento fascista, soprattutto nei primi anni, consisteva, dunque, non tanto nel costituirsi come movimento antideologico, quanto nel porre come princìpi basilari ideologie negative, in netta antitesi con i valori tradizionali. . Ercole, La rivoluzione fascista, cit., p. . . Oltre ai nazionalisti e ai futuristi, troviamo tra gli interventisti i collaboratori della “Voce” di Prezzolini e dell’“Unità” di Salvemini e così pure filosofi e pedagogisti idealisti, come Giovanni Gentile e Giuseppe Lombardo Radice, critici come Renato Serra, storici come Gioacchino Volpe. . Siglato dal codice dell’Archivio dell’Istituto Luce B . . La scelta di Luigi Federzoni non è stata sicuramente casuale: presidente del Senato, acquista una straordinaria credibilità agli occhi degli ex combattenti perché, interventista della prima ora, partito per il fronte come volontario, fu anche decorato con una medaglia d’argento e due croci al valore militare. . P. Monelli, Catenaccio alle celebrazioni belliche, in “Gerarchia”, giugno , pp. -. . “Gerarchia”, novembre , p. . . Siglato dal codice B . . Una vera e propria “storia” della liturgia politica fascista può cominciare a partire dal ’, attraverso la scansione di due fasi: il decennio -, nel quale è attuata la sua istituzionalizzazione, e quello tra il e il , che si esaurisce in una sostanziale ripetizione meccanica che consolida il portato del decennio precedente. . G. Lume, La celebrazione della vittoria, in “Gerarchia”, novembre , pp. -. . Ercole, La rivoluzione fascista, cit., p. . . Ludwig, Colloqui con Mussolini, cit., p. . . Argentieri, L’occhio del regime, cit., p. . . Il costo di Camicia nera fu di .. lire, il premio previsto dal Ministero delle Corporazioni di . lire e gli incassi nel ’ (comprese le vendite in Francia, Germania, Turchia e Giappone) di .. lire. Cfr. Argentieri, L’occhio del regime, cit., p. . ANTONIA LIGUORI . È interessante notare che il padre di Mussolini era stato fabbro. . La cerimonia di fondazione della prima delle «città nuove» dell’Agro pontino avvenne il dicembre del , come emblematica chiusura delle celebrazioni del decennale. Seguirono la fondazione di Sabaudia ( aprile ), di Pontinia ( dicembre ), di Aprilia ( ottobre ) e di Pomezia ( ottobre ). . I borghi di servizio creati in prossimità di Littoria si chiamavano – e si chiamano ancora – infatti: Podgora, Carso, Piave, Bainsizza, Montello, Sabotino, Grappa, Ermada. . E. Gentile, Il fascismo come religione politica, in “Storia contemporanea”, dicembre , pp. -. . “Gerarchia”, gennaio , p. . . Mein Kampf, in D. Cantimori, Politica e storia contemporanea. Scritti (-), a cura di L. Mangoni, Einaudi, Torino , pp. -. Prosegue, infatti, «il commissario dell’ipocrisia» (Hitler viene così definito nella lettera di D’Annunzio a Mussolini del agosto del , in R. De Felice, E. Mariano (a cura di), Carteggio D’Annunzio-Mussolini. -, Mondadori, Milano , p. ): «Poiché il suo compito deve consistere, precisamente come nel manifesto pubblicitario, nel rendere attenta la massa, e non nell’istruzione di chi è del resto già esperimentato criticamente per conto suo, o di chi si sforzi di raggiungere una educazione (bildung) e di farsi un giudizio, l’azione della propaganda deve essere sempre diretta più al sentimento, e solo molto secondariamente al cosiddetto intelletto». . Le feste della nazione, il culto dei caduti, la glorificazione degli eroi della Grande guerra e della “rivoluzione”, le apparizioni del duce trasformarono durante il ventennio le piazze d’Italia in uno straordinario scenario collettivo, nel quale le cerimonie d’occasione si andavano a inserire in un vero e proprio ciclo annuale della liturgia di regime. La «piazza oceanica» dell’Italia fascista si presentava come erede di strumenti già assunti durante l’esperienza della «riconquista della piazza», (cfr. Isnenghi [a cura di], I luoghi della memoria, cit., p. ) attuata sia ad opera degli interventisti sia dei legionari fiumani. Fu proprio D’Annunzio – come osserveremo più da vicino nell’analisi di un filmato interamente dedicato alla marcia di Ronchi – a riprendere nell’immediato dopoguerra quel comizio dialogico che nella corrente interventista era particolarmente caro agli anarcosindacalisti (si pensi a Corridoni, annesso successivamente come protomartire fascista, e a De Ambris, che partecipò all’impresa fiumana come luogotenente di D’Annunzio). In Germania Hitler sceglieva gli stadi per i grandi raduni di folla, Mussolini, invece, per rafforzare i princìpi di identità e di appartenenza al nuovo ideale di nazione – sorto con la guerra e ribadito dal regime – preferiva le piazze cittadine. In particolare elesse piazza Venezia – in vista dell’Altare della Patria e del Milite ignoto – come luogo simbolo per eccellenza dell’incontro rigeneratore fra il capo e la folla. In base al criterio di adoperare un’oratoria “ubiquitaria”, Mussolini moltiplicò negli anni la sua presenza sul territorio nazionale, trasformando l’Italia attraverso i suoi viaggi – più che mai frequenti nelle ricorrenze di date significative per testimoniare la progressiva legittimazione del regime – in una “piazza diffusa”. Le adunate, anche se la partecipazione non fosse stata obbligata, non lasciavano alla gente accorsa nelle piazze nessuna alternativa. La psicologia collettiva, infatti, ci suggerisce quanto in realtà abbia inciso nel nuovo universo immaginario – sapientemente gestito dai regimi totalitari – l’agglomerato della moltitudine, stretta gomito a gomito, quasi materialmente compatta tanto da trasformarsi in un nuovo soggetto collettivo. È nelle piazze oceaniche che gli individui smarrivano la rispettiva autonomia e fornivano una palese rappresentazione del nuovo rapporto istituito tra popolo e potere. L’uso del microfono permetteva l’ampia diffusione del messaggio del duce, che negli anni – con lo sviluppo della radiofonia – giunse anche in quelle piccole piazze d’Italia dove il popolo disciplinato acclamava un oratore che non era di fronte a loro e sollevavano incitamenti a un “duce” che in quel momento non poteva sentirli, a dimostrazione della loro comunione spirituale. . Imponenti furono le manifestazioni in occasione del decennale della vittoria, nel quale è particolarmente visibile quella che negli anni andò consolidandosi come peculiarità L’ISTITUTO LUCE TRA INFORMAZIONE, MEMORIA E PROPAGANDA della celebrazione: la festa del novembre, vista la sua contiguità con l’anniversario della marcia su Roma, era stata via via assimilata a questa nel senso di ulteriore tappa della rivoluzione fascista. La rievocazione della vittoria, infatti, divenne il rito di una manifestazione collettiva di obbedienza al regime, nella quale il culto dei caduti per la patria si sovrapponeva e si confondeva con quello dei caduti per la “rivoluzione” fascista. . E. Adami, La lingua di Mussolini, Società Tipografica Modenese, Modena . . “Gerarchia”, agosto , rubrica “Tra i libri”, p. . . Laddove si consideri la Grande guerra come somma di eventi mitici, la rotta di Caporetto rappresenta un momento di notevole rilievo, soprattutto se rivissuto attraverso l’ottica del futuro duce del fascismo, che esula dall’immediato dibattito relativo alle cause della disfatta e offre più di qualche spunto per giustificare la successiva rimozione dell’evento operata in pieno regime. Con il suo tipico fare esagerato, Mussolini scriveva che il ottobre rappresentava «la più importante disfatta della storia mondiale» e che niente in tutta la sua vita gli aveva mai provocato un’umiliazione maggiore. Com’è ovvio, l’immediata responsabilità di Caporetto veniva da lui attribuita al “disfattismo” dei vecchi compagni socialisti oltre che alla condotta del nuovo presidente del Consiglio Orlando. . La natura essenzialmente emozionale di un simile approccio è una di quelle caratteristiche che induce ad assimilare il fascismo alla categoria dei «movimenti situazionali» (cfr. E. Gentile, Storia del partito fascista (-). Movimento e milizia, Laterza, Roma-Bari , p. ). Come il futurismo, l’arditismo o il fiumanesimo, traeva la sua forza dallo stato d’entusiasmo generato dal mito dell’esperienza della guerra, che caricava la condotta politica, soprattutto nelle prime fasi, di un evidente impeto vitalistico. Tutti questi movimenti hanno in comune la caratteristica di essere animati da persone che hanno partecipato direttamente al grande evento suscitatore di miti e propongono le idee, scaturite da quella esperienza, come base per una repentina azione di cambiamento della società e per l’incessante appello all’identità del gruppo. . Queste le località toccate durante il percorso: Bassano del Grappa, Treviso, Possagno, San Donà del Piave, Meolo, Vittorio Veneto, Cividale del Friuli, Caporetto, Gorizia, Trieste, Fiume. . A. Nützenadel, La battaglia del grano, in Dizionario del fascismo, cit., pp. -. . Non c’era substrato ideologico migliore sul quale innestare la nuova “battaglia” del patrimonio culturale ereditato dalla più recente esperienza bellica, chiamata in causa per fortificare quegli spiriti che non potevano tradire i sacrifici della patria, affermando quel carattere rinunciatario tanto caro alla politica liberale. Questa volta non bisognava lasciarsi scappare l’occasione : c’era un “Impero” da costruire, per completare gli scopi della Grande guerra e per dare sfogo alla “Rivoluzione”. . Numerose erano le responsabilità attribuite al regime liberale per giustificare l’“immaturità” del popolo italiano: in gran parte degli interventi dei “burocrati” della carta stampata e nei discorsi pubblici del duce – nei quali si ricordava l’intervento nella Prima guerra mondiale – era ricorrente, ad esempio, l’accenno al contrasto tra le virtù definite innate nel popolo italiano e quella «strana ideologia [che] per lunghi decenni aveva definita la preparazione militare come spesa improduttivaı» (A. Solmi, XXIV Maggio, in “Gerarchia”, maggio , pp. -). . Diviene facile ritrovare nella Grande guerra quella matrice ideale che poneva in stretto legame l’intervento dell’Italia addirittura – ancor più sulla scia del mito della vittoria trionfale – con la proclamazione dell’Impero nel ’, laddove si voglia sottolineare l’interpretazione dell’evento bellico come fattore di unificazione di tutta la realtà italiana, chiamata ad assimilare il superamento di qualsiasi conflittualità interna – intesa anche come lotta di classe – e quindi «base di partenza del rovesciamento degli attriti e dei bisogni sociali verso l’esterno» (M. Isnenghi, Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti sulla cultura fascista, Einaudi, Torino , p. ). . L’Italia sapeva di soffrire, sin dai tempi di Crispi, di un incurabile “mal d’Africa”, tema sul quale si continuavano a creare evidenti confusioni ideologiche, animate ANTONIA LIGUORI dall’«illusione consueta del primato italiano», osannato per rafforzare ancora una volta quel carattere unificante che ogni esperienza bellica doveva portare con sé. In particolare, erano i giovani a essere chiamati in causa, quella generazione alla quale si voleva inculcare l’attivismo attribuito agli interventisti del “maggio radioso”. Leggiamo, infatti in un editoriale apparso su “Critica Fascista”: «Le generazioni che sembrano destinate ad essere allevate fra il ricordo lontano della guerra, quello più prossimo della rivoluzione non vissuta e una inattuabile aspirazione ad agire, trovano ora nella guerra d’Africa, la più immediata, concreta e viva fonte di esperienza e di azione cui potessero aspirare. Qui appunto si avvera il fenomeno rivoluzionario per cui quei giovani che ieri sembravano destinati ad essere i mal rassegnati epigoni di un eroismo già consegnato alla storia, ne divengono oggi invece i continuatori» (“Critica Fascista”, cit. in Mangoni, L’interventismo della cultura, cit., p. ). . Tutto si muoveva spinto da una immane ondata emotiva, dove la storia d’Italia si sovrapponeva alla leggenda del popolo italiano, votato quasi per necessità o per volontà provvidenziale alla realizzazione dell’Impero fascista. L’occasione della guerra e della vittoria – ancor di più perché “mutilata” – è un punto di partenza davvero unico per esemplificare l’esigenza avvertita dall’alto di una nuova educazione e conformizzazione collettiva. Il popolo italiano veniva addirittura riesaminato dal punto di vista antropologico, anche se il risultato appare a posteriori alquanto contraddittorio: l’esaltazione dell’attivismo guerriero – inteso come carica agonistica – sembra, infatti, contrastare con il ruolo che poi venne riservato in ambito politico al nuovo prototipo di italiano, totalmente remissivo nei confronti della volontà del regime. . “Gerarchia”, settembre , pp. -. . Nelle teorie politiche del XX secolo era più che palese il prevalere del pensiero mitico su quello razionale, così come era sempre accaduto nei momenti critici della vita sociale, a dimostrazione che il mito non costituisce un elemento transitorio, ma è parte integrante della natura umana. Esso, però, nelle dottrine del ’ – ed in particolare nel fascismo – non appariva come «un libero e spontaneo gioco dell’immaginazione» (E. Cassirer, Simbolo, mito e cultura, a cura di D. P. Verene, Laterza, Roma-Bari , p. ), ma era regolato e adattato in virtù dei bisogni della politica. L’elemento innovativo consisteva nel fatto che il mito – paradossalmente – veniva razionalizzato, trasformandosi in strategia e tecnica. Da parte nostra sarebbe sciocco indagare sulla eventuale “verità” dei miti politici, che, al contrario, vanno studiati per la loro efficacia, all’interno del più ampio processo di coinvolgimento coatto delle masse e della necessaria ricerca di consenso messa in atto dai regimi totalitari. Facendo ricorso all’etimologia del termine, il mito appare come una narrazione, che racchiude in sé un aspetto epico – che può essere quello del ricordo delle imprese di una figura eroica – e uno drammatico, che richiama in causa il confronto tra forze del bene e forze del male. L’analogia dei miti della politica contemporanea con quelli sorti spontaneamente nelle società primitive va ricercata nel loro modo di esprimere una singolare mescolanza di tendenze in conflitto: «essi sono al medesimo titolo un frutto e della disperazione e della fiducia» (Cassirer, Simbolo, mito e cultura, cit., p. ). Costituiscono, insomma, l’extrema ratio per affrontare uno straordinario sconvolgimento della società. La forte carica suggestiva che li contraddistingue si riflette anche nella conseguente modificazione della funzione del linguaggio. Se, infatti, in circostanze normali, le nostre parole devono assolvere allo stesso modo alla funzione descrittiva come a quella emotiva, laddove si affermi il potere del pensiero mitico – e perciò si rielabori razionalmente la svalutazione dell’elemento razionale – l’accento batte in maniera più decisa sull’elemento emotivo, superando di gran lunga il livello “letterale” della comunicazione sociale e della reciproca comprensione. «La parola descrittiva e la parola logica si sono trasformate in parola magica» (E. Cassirer, Simbolo, mito e cultura, cit., p. ): ed è così che nel linguaggio introdotto dai miti politici l’equilibrio tra elemento soggettivo e oggettivo viene a turbarsi in profondità, quasi a voler dimostrare che nell’era della folla il mito diviene un persuasore più efficace di qualsiasi analisi razionale L’ISTITUTO LUCE TRA INFORMAZIONE, MEMORIA E PROPAGANDA della realtà. Il fascismo, individuato il mito come motore primario del pensiero politico, diveniva potere di simboli e si avvicinava molto, per la sua arte di governare le masse, a quella che Serge Moscovici ha chiamato «l’arte di dirigere la loro immaginazione» (S. Moscovici, L’age des foules, Fayard, Paris , p. ). . Anche l’anonimato – cioè la qualità di «non essere nessuno» (A. Gibelli, L’officina della guerra. La Grande Guerra e le trasformazioni del mondo mentale, Bollati Boringhieri, Torino , p. ) – veniva posto come condizione centrale dell’uomo nella società di massa, proprio come era accaduto per milioni di persone durante la guerra, soprattutto nell’esperienza della morte. Ma non solo; si pensi anche alla mobilitazione di massa e alla sua successiva interpretazione come spunto per giustificare la standardizzazione del soldato. Le proporzioni della guerra resero indispensabile il contributo della massa, e il fascismo dalla massa scelse il suo più autentico protagonista, invocando il soldato senza qualità. Come in guerra la sua capacità di adattarsi ai tempi della trincea, la sua inerzia, la sua passività ne favorirono la riduzione ad anonima componente del meccanismo bellico, così nella “nuova Italia” quelle stesse caratteristiche che resero eroiche le imprese del soldato senza qualità venivano richieste come requisiti del cittadino soldato, pronto ad essere mobilitato ancora una volta e ad essere incorporato nei meccanismi dello Stato nuovo. C’è chi, a tal proposito, ha parlato di «catastrofe del soggetto», ponendo la guerra come punto di svolta: «col suo impasto di massificazione e tecnicizzazione del massacro, con la sua assoluta programmabilità, con il cieco scatenarsi delle dinamiche sistemiche ingovernabili da qualsiasi volontà umana individuale, essa costituiva l’esempio più clamoroso – e inedito – di evento privo di soggetto» (M. Revelli, Storia e scienze sociali, in “Movimento operaio e socialista”, n. -, a. X, , pp. -). Una simile esperienza, rintracciabile nel patrimonio mentale della gente comune, procedeva nella stessa direzione di quella ingestibile espropriazione del tempo e della vita – avvenuta durante il conflitto – che il fascismo impugnò e accuratamente gestì in funzione del controllo delle masse, ben consapevole dell’attitudine degli individui – nei momenti di crisi – a plasmare il proprio modo di agire e di pensare verso modelli suggeriti dall’esterno. In questo ambito viene in soccorso la psicologia sociale, secondo la quale, nella dialettica tra individuo e gruppo, tende a prevalere «il conformismo piuttosto che l’indipendenza» (P. G. Zunino, L’ideologia del fascismo. Miti, credenze e valori nella stabilizzazione del Regime, il Mulino, Bologna , p. ) secondo un’insaziabile sete di armonia per cui sarebbe preferibile «sbagliare con gli altri piuttosto che avere ragione da soli» (G. De Montmollin, L’influence sociale, Presse Universitaires de France, Paris ). . aprile , D’Annunzio a Mussolini, in De Felice, Mariano (a cura di), Carteggio D’Annunzio-Mussolini, cit., p. . . Ad esempio, in entrambi si puntualizza la reazione dell’opinione pubblica alla vicenda Matteotti o, in occasione della guerra di Spagna, vengono proposte le immagini delle manifestazioni antifasciste a Parigi accanto alle foto di Rosselli. . M. Dondi, Piazzale Loreto, in Isnenghi (a cura di), I luoghi della memoria, cit., pp. -. . H. Pirenne, La tache de l’historien, in “Le Flambeau”, XIV, , , p. , citato anche in C. Violante, La fine della grande illusione. Uno storico europeo tra guerra e dopoguerra, Henri Pirenne (-). Per una rilettura dell’Histoire de l’Europe, il Mulino, Bologna . ANTONIA LIGUORI
Scaricare

![Le origini e la presa del potere [g]](http://s2.diazilla.com/store/data/000068864_1-7a3b7b6cfdf5e3492d6f39a327d65d39-260x520.png)