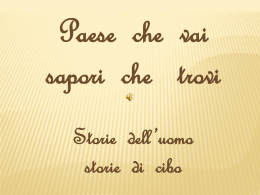Istituto Comprensivo “G.M. Sacchi” Scuola Secondaria di I grado – Piadena (CR) Il Ritmo dell’Uomo e delle Stagioni I nonni ci raccontano i lavori agricoli di una volta Anno Scolastico 2011/2012 Classi 3aA e 3aB PRESENTAZIONE Nell’anno scolastico 2011/2012, gli alunni delle classi terza A e terza B della Scuola secondaria di Piadena hanno realizzato questo lavoro iniziato tre anni fa e inserito nei Progetti d’Istituto “ Educazione Ambientale” e “Educazione al Patrimonio”. Il lavoro si è proposto di far conoscere in modo approfondito la vita della civiltà contadina così com’era nella nostra zona, frutto dell’ambiente geografico e delle condizioni economiche e socioculturali in cui i nostri anziani sono vissuti. La ricerca, nel corso dei tre anni, si è svolta sulla raccolta delle informazioni attraverso: - Visita a “Piccola mostra di oggetti d’epoca”. Incontro con esperto su “Il Canto Popolare spiegato ai ragazzi e ai giovani” a cura del Gruppo Padano di Piadena - Raccolta di testimonianze orali (interviste a persone anziane) e scritte (ricerca e consultazione di libri) - Raccolta di fonti iconiche fornite da persone, realizzate dagli alunni, ricavate da testi di vario genere (libri, opuscoli, calendari, quotidiani) e ricercate su internet - Interventi in classe coadiuvati dalla visione di brevi filmati tematici effettuati da esponenti della “Lega di Cultura” di Piadena (Sig. Giuseppe Morandi e sig. Gianfranco Azzali) In seguito alle numerose informazioni raccolte, si è reso necessario limitare il campo di ricerca ad alcuni argomenti, gli alunni hanno così puntato la loro attenzione su: - Storia e struttura della cascina padana tradizionale - La coltivazione del frumento - La coltivazione del mais - L’uccisione del maiale - La stalla e il lavoro del bergamino - L’allevamento del baco da seta Il materiale raccolto è stato organizzato e preparato utilizzando diverse tipologie di linguaggi: - realizzazione di cartelloni - realizzazione di un DVD ad uso esclusivamente didattico - dispensa. Le testimonianze degli anziani e le fonti iconiche hanno riportato alla luce eventi molto lontani dal mondo dei ragazzi di oggi, infatti il mutamento delle abitudini, della mentalità e delle condizioni di vita negli ultimi decenni è stato molto rapido. Ma la semplice bellezza delle narrazioni degli anziani e dei loro oggetti hanno fatto sì che i ragazzi stabilissero un confronto tra il passato e il presente e che riflettessero su alcuni valori tradizionali, quali l’abitudine al risparmio e alla conservazione da parte delle generazioni che ci hanno preceduto, il loro duro lavoro e l’aspra e misera vita di chi aveva imparato a valorizzare anche la polenta, simbolo della dura lotta quasi quotidiana contro la fame, e il pane, simbolo della fatica dell’uomo e della sua ricompensa. Buona lettura. Le insegnanti: Prof.ssa Vanna Brunoni Prof.ssa Vanna Pinzi Prof.ssa Elena Negrotti a a Gli alunni delle classi 3 A e 3 B Piadena, giugno 2012 LA CASCINA CREMONESE Il paesaggio della Pianura cremonese, sia nella parte alta che nella parte bassa, ha come elemento materiale caratterizzante la cascina, ossia l’edificio rustico costruito con una finalità ben precisa legata al lavoro della terra ed organizzata in modo da garantirne l’autosufficienza produttiva. La pianura cremonese era disseminata di cascine. La cascina era la tipica struttura agricola della pianura padana lombarda e faceva risalire le sue origini alla villa rustica romana, alla grangia cistercense e benedettina ed infine alle cascine a corte del XIX secolo. La diffusione massima delle cascine avvenne tra il 1700 ed il 1800, mentre è a partire dal 1900 che verranno progressivamente abbandonate sia per effetto dell’abbandono delle campagne che ha caratterizzato il Novecento, sia perché i contadini ritenevano più confortevole e sicuro vivere nei centri abitati, piuttosto che in mezzo alla campagna. La nostra cascina aveva una struttura quadrangolare ed era chiusa. La disposizione dei fabbricati era su 4 lati e derivava da un’antica tradizione che si mantenne viva fin quasi ai giorni nostri per la garanzia di sicurezza che presentava. Infatti era sufficiente la sorveglianza della porta carraia per controllare chi entrava nella corte e cosa usciva da essa. L’aia era una parte importantissima all’interno della costruzione ed era posta al centro della cascina con il lato più lungo in direzione Est-Ovest così da essere perfettamente orientata a mezzogiorno, inoltre era costruita verso il lato Nord della cascina e accuratamente isolata dagli edifici circostanti per non essere raggiunta dalla loro ombra. L’aia era anche in una posizione riparata dal vento e la sua superficie era perfettamente livellata ma in leggera pendenza in modo da far defluire velocemente l’acqua e permettere la perfetta essicazione del prodotto. L’aia era originariamente in ciottoli o in terra battuta oppure ricoperta di mattoni solo in tempi più recenti sarà in cemento. I prodotti che venivano essiccati sull’aia erano frumento e mais. Nel periodo estivo era il luogo più frequentato. Sull’aia si trovavano ancora insieme, uomini, donne e ragazzi, anche fino a notte fonda, per la sgranatura dei legumi e per la scartocciatura del granoturco, che avveniva a fine settembre. Sull’aia inoltre si svolgevano le feste: ci si sposava, si festeggiavano le sagre, si ballava. L’aia è rimasta un luogo mitico, nell’immaginario collettivo dei nostri paesi, viene spesso citata come un’isola felice. Attorno all’aia si trovavano i vari edifici agricoli: - A nord era situata la casa padronale, si tratta di una costruzione che si differenzia dalle restanti abitazioni, oltre che per imponenza edìle, anche per la presenza di qualche particolare decorativo. I particolari decorativi ne accentuano la distinzione quali ad esempio la porta d’ingresso con l’architrave curva a semicerchio, e lo sviluppo su 3 piani: al primo la zona giorno, al secondo la zona notte e al terzo il granaio nel quale si conservavano mais e frumento. - A ovest e vicino alla casa del fattore, vi era il portone che introduceva nell’ingresso coperto della cascina. L’arcata sovrastante il portone d’ingresso era policentrica o a tutto sesto. Il portico dell’ingresso si presentava architettonicamente elaborato o impreziosito da lesene. La chiave del portone era posseduta dal fattore che lo chiudeva alla sera mezz’ora dopo il tramonto e lo riapriva al mattino al sorgere del sole. Così il mondo contadino si isolava per la notte. Sempre a ovest vi erano le case dei paisaan più basse rispetto alla casa padronale, perché costituite da 2 piani, le case erano tutte uguali, modeste e disposte a schiera, senza servizi igienici, con spazi identici ed erano composte da 2 (più frequente) o 4 stanze. La porta di ingresso aveva l’architrave piana. Le finestre erano provviste di inferriate. Al piano terreno il camino e normalmente un tavolo, qualche sedia di legno o impagliata, una credenza. Al piano superiore, raggiungibile con una scala interna di legno, la stanza con un comò per la biancheria, un armadio per i vestiti, un letto in ferro, due comodini, un lavabo in ferro. Le finestre del primo piano erano piccole senza vetri e senza inferriate. Sul retro delle case dei paisaan vi erano gli orti. Il contratto dei paisaan, contadini a salario fisso, iniziava l’11 novembre, S. Martino, e terminava l’11 di novembre dell’anno successivo e al termine del contratto dovevano raccogliere le loro poche cose e andarsene, magari per trovare un nuovo contratto e trasferirsi così in un’altra cascina. Da questo è nato il modo di dire “fare San Martino” cioè traslocare. - A Sud della cascina le stalle protette da un porticato molto alto. Confinante alla stalla vi era l’abitazione del bergamino somigliante all’abitazione dei paisaan. L’ingresso alla stalla è rientrante rispetto ai pilastri e sopra di essa è ricavato il fienile aperto nella parte anteriore. I pilastri, frequentemente provvisti di richiami architettonici semplici, erano in cotto, a base quadrangolare, fasce fungenti da capitello e basamenti allargati. Fra la stalla e i pilastri si formava un porticato sotto il quale trovavano posto carri, carretti e abbeveratoio, detto in dialetto albi, al quale si abbeveravano le mucche prima di essere munte. L’abbeveratoio veniva riempito d’acqua dai ragazzi durante la pausa pranzo, prima di ritornare a scuola. Per riempire l’abbeveratoio, una vasca di marmo (botticino) rettangolare lunga 2 metri e larga uno, dovevano lavorare di braccia sulla “tromba idraulica” per tirare su l’acqua dal pozzo sottostante. Vi erano diverse stalle staccate tra loro ma vicine: la stalla per le mucche, la stalla per i cavalli, la stalla per i buoi e la stalla per i vitelli. A volte, per ragioni di spazio mucche, buoi e vitelli potevano anche trovarsi nella stessa stalla separati tra loro da muretti. I cavalli, invece, erano sempre messi in una stalla separata, perché il clima caldo-umido, tipico delle stalle dei bovini, era da loro mal sopportato. L’orientamento delle stalle bovine era sempre lo stesso, le finestre erano rivolte a nord e a sud per sfruttare la differenza di temperatura delle due facciate, provocando, con l’alterna apertura delle finestre, una buona aerazione. La forma delle finestre era quadrata o rettangolare ad arco ribassato o semicircolare. A volte i muri perimetrali delle stalle dalla base alla metà presentavano pietre più cotte quindi più scure e più resistenti all’umidità, poi erano meno cotte (cioè più chiare). Le stalle delle mucche potevano essere a una o a due poste. Le stalle grandi erano a due poste con una corsia centrale ai lati della quale scorrevano i canaletti di scolo. La posta è dove venivano collocati gli animali, il pavimento era in mattoni con pendenza verso il canaletto di scolo nel quale si raccoglievano le urine convogliate così in un apposito pozzetto; contro il muro vi era una lunga mangiatoia in mattoni con assi laterali in legno, al di sopra di essa tanti anelli, giustamente distanziati, ai quali venivano legate con catene le mucche. Il pavimento della posta veniva ricoperto di paglia formando la lettiera, il giaciglio delle mucche. Vari potevano essere i tipi di copertura delle stalle: a travi sostenute da pilastri o colonne, a volta a botte ribassata, a volta a vela sostenuta da colonne. Le colonne erano situate di fianco ai canaletti di scolo sull’area della corsia o sul bordo della posta e potevano essere in marmo Botticino, in pietra serena, in granito o in cotto. Le stalle avevano il soffitto molto basso per due motivi: conservare caldo l’ambiente durante la stagione invernale, facilitare il caricamento del fieno sui fienili sovrastanti. Nelle serate invernali, la stalla, diveniva il “salotto” dei contadini. Infatti dopo aver cenato, non più tardi delle sei, tutti andavano nella stalla dove c’era bel caldo, si portavano da casa una seggiolina si sedevano in cerchio intorno a un lume. Le donne rammendavano calzoni che già avevano tante pezze da non sapere più quale fosse la stoffa originale, lavoravano a maglia, ricamavano tramandando quest’arte alle ragazze giovani e nel frattempo recitavano il rosario oppure parlavano. Il parlare e il raccontare avvenimenti o storie al limite del reale permetteva di tramandare la cultura popolare. Ai ragazzi e ai bambini piaceva ascoltare la storia sacra, le filastrocche e gli aneddoti della vita paesana. Nelle stalle poi, non infrequenti vi erano anche le rappresentazioni di burattini (la scenografia era molto semplice, non serviva nemmeno il palco). Potevano essere proiettati anche vecchi film muti o sonori. Erano momenti di vita comunitaria, dove il senso civile e quello religioso si intrecciavano e si fondevano, toccando livelli altissimi di solidarietà, di reciproco sostegno, di partecipazione agli eventi lieti e a quelli tristi delle singole famiglie o per il semplice piacere di “stare assieme”. “Molti paisaan non sapevano leggere e scrivere, ma non erano ignoranti, la cultura era tramandata con la voce, esisteva una memoria orale.” Sul lato della cascina verso la campagna oppure dietro la stalla c’era una grossa vasca, la concimaia, dove mattina e sera veniva portato con la carriola il letame tolto dalla lettiera delle mucche. In un angolo della concimaia c’era uno stanzino, un metro per un metro, con un buco al centro del pavimento: era il gabinetto. Sopra alle stalle c’erano i fienili. I fienili erano intervallati solitamente da muri di sostegno che formavano praticamente degli scomparti facilmente circoscrivibili in caso di incendio. I fienili nella parte anteriore erano quasi sempre con apertura a giorno mentre nella posteriore erano chiusi da pareti in mattoni. I mattoni erano disposti in modo da creare fori a gelosia con aperture dalla forma rettangolare, quadrata, a esagono, a rombo o a croce per permettere una conveniente areazione. Accanto vi erano le porcilaie con sovrapposti o affiancati i pollai. Sopra i porcili-pollai veniva sistemata la legna di ciascuna famiglia. - A Est le barchesse, si trattava di costruzioni alte e lunghe, chiuse da muratura sui 3 lati e aperte verso l’aia. Non differivano dagli altri porticati per quanto riguarda i caratteri costruttivi; erano spesso più larghe e più alte in conseguenza del diverso uso cui erano destinate. Sotto le barchesse finivano la paglia, qualche volta il fieno ed anche attrezzi vari. Sotto le barchesse, se non aveva sufficiente spazio in casa, il paisaan metteva anche “li scalérii” con i bachi da seta da allevare. Si mettevano anche i covoni di frumento a stagionare prima della loro trebbiatura e gli stocchi del mais da dar da mangiare alle mucche dopo che per tutto l’inverno erano rimasti a macerare mescolati al sale. LA COLTIVAZIONE DEL FRUMENTO Anche un tempo, come oggi, era importante la rotazione delle colture per questo si seminava il frumento in un terreno in cui era stato raccolto il mais o la barbabietola da zucchero . I campi che il paisaan intendeva seminare a frumento dovevano essere arati in autunno dopo che su di essi era stato distribuito il letame. Il letame era il concime più buono per la terra, infatti questo vocabolo deriva dall’aggettivo latino “laetus”: che significa “ciò che rende lieta la terra”. La concimaia era una specie di vasca nella quale si raccoglieva il letame solido costituito dagli escrementi degli animali mescolati alla paglia, quella paglia che era servita da lettiera agli animali. La concimaia aveva anche un contenitore detto “pusét” nel quale si raccoglieva il liquame, cioè gli escrementi liquidi. Periodicamente la concimaia doveva essere svuotata, poiché la produzione del letame era continua e costante per tutto l’anno. La permanenza del letame nella concimaia permetteva la sua “maturazione”. Il letame solido, con il tridente, veniva prelevato dalla concimaia, caricato su un carro e trasportato nei campi non occupati dalle colture perché prossimi ad essere arati . Si formavano così dei mucchi in zone del campo e vi potevano restare anche per parecchi giorni. Il liquame veniva trasportato e distribuito nei campi con la botte di legno. La botte veniva riempita a forza di secchi a loro volta riempiti del liquame contenuto nel “pusèt”. Quando prossimi all’aratura, si caricava il letame su un carretto chiamato “ilsa” e i contadini, utilizzando delle forche, lo spargevano su tutto il campo. Per l’aratura si utilizzava l’aratro a mano trainato da buoi o da cavalli, il contadino camminava nel solco appena fatto e guidava l'aratro con le mani, alzandolo e spostandolo a seconda degli ostacoli che incontrava. Questo lavoro faticoso fatto del sudore dell'uomo e delle bestie, poteva iniziare alla mattina presto col buio e continuare fino a sera. Ogni tanto una sosta permetteva a tutti di riposarsi. I ragazzi detti “gargét” aiutavano durante l’aratura, tenevano l’animale per la “cavècia” e lo guidavano quando doveva curvare. Solitamente indossavano pantaloni strappati che venivano rattoppati con una pezza. Infatti la società di allora, non era consumistica come la nostra, anzi risparmiava molto e riutilizzava perché il benessere attuale non esisteva. Il numero di animali da impiegare nell’aratura dipendeva dalla forza che un animale poteva fornire ma anche da quanto era grande l’azienda agricola: più era grande, maggiore era il numero di animali da lavoro (buoi o cavalli) che poteva permettersi di possedere. Dopo l'aratura le zolle che si formavano dovevano essere frantumate e il terreno livellato. Si usava dapprima un attrezzo chiamato coltivatore che con i suoi denti affondati nel terreno spezzettava le zolle e spianava. Nonostante il campo venisse concimato con il letame, si rendeva necessario integrare a questo punto con l’aggiunta di concimi chimici quali il perfosfato e da ultimo il cloruro di potassio. Poi, appena prima della semina, si passava, l’erpice, un attrezzo con punte di lunghezza inferiore a quelle del coltivatore e disposte in modo da risultare più ravvicinate per rendere le zolle di dimensioni ancora inferiori. Tutti questi attrezzi erano trainati da buoi o da cavalli. Si usava, la sera prima della semina, spruzzare i semi di frumento con il verde rame (solfato di rame). Il verde rame serviva per impedire che i semi venissero attaccati da insetti o altri microrganismi presenti nel terreno. La semina del frumento avveniva da metà ottobre ai primi di novembre con la luna buona, mai di venerdì. Il grano dapprima si seminava a mano, a spaglio, ed erano impiegate anche le donne. Si riempiva di grano una cesta di legno leggero, “cavagna”, poi la si infilava nel braccio sinistro e con la mano destra si prelevava una manciata di semi. La semina avveniva lanciando con la mano destra manciate di grano nel campo. Il movimento eseguito avveniva coordinando la mano destra con il passo in modo da ottenere una distribuzione uniforme. Si è in molti casi seminato a mano fino alla seconda guerra mondiale perché i contadini a mezzadria non avevano soldi per acquistare alcun tipo di macchina. Sul terreno appena seminato si passava il rullo per interrare meglio i semi. Nel periodo compreso tra tardo inverno e inizio primavera si concimava, sempre a mano, distribuendo a spaglio il nitrato con la cavagna ed eseguendo un movimento coordinato come quello eseguito per la semina. Le prime seminatrici comparse all'inizio del 1900 erano di produzione estera. Quelle di produzione nazionale apparvero sul mercato verso il 1934-1935. Queste macchine erano dotate di un contenitore per la semente e di un sistema di rotelle che ricevevano il grano per poi, attraverso un tubo mobile, lasciarlo cadere nel terreno ad una profondità di 2-3 cm. Gli agricoltori inizialmente utilizzavano i buoi che avevano nella stalla per trainare queste apparecchiature meccaniche. Poi gradualmente si passò al traino meccanico. Quando il frumento aveva germogliato e le piantine raggiungevano l’altezza di 4-5 cm, si procedeva a zappare il terreno per rimuovere le erbe infestanti. Erano soprattutto le donne ad occuparsi della zappatura che a volte avveniva anche per interrare il concime a base di nitrati appena distribuito sul campo. Il numero di zappature dipendeva dalle erbe infestanti presenti e comunque, di norma, la coltivazione del frumento richiedeva 2 zappature. La raccolta del grano, mietitura, si effettuava verso la fine di giugno. Avveniva quando la spiga di frumento, carica di chicchi, aveva raggiunto un bel colore biondo. Dapprima il frumento veniva tagliato a circa 20 cm dal terreno con falce messoria e si lasciava essiccare sul campo per breve tempo. Poi, per proteggere il raccolto dalle intemperie, i “paisaan” ne facevano dei covoni, cioè dei mazzi, disposti a formare dei mucchi a forma di cono e per 2 o 3 giorni si lasciavano così nel campo per farli essiccare. Trascorsi questi giorni si caricavano i covoni sui carri trainati da cavalli e portati in cascina per essere sistemati sotto la barchessa. In seguito la raccolta verrà effettuata con la mietitrice trainata da cavalli o con la mietilegatrice, dotata di congegni meccanici che permettevano di raccogliere il frumento e di legare i covoni. Dopo la mietitura si andava a spigolare, cioè a raccogliere le spighe di grano rimaste sul campo In tempi successivi venne inventata una macchina, la trebbiatrice, che faceva uscire la paglia da una parte e i chicchi dall’altra. La trebbiatura si faceva con una motrice a vapore che metteva in funzione la vera e propria trebbiatrice. I “paisaan”, con i buoi, andavano a prelevare queste macchine di cascina in cascina. Arrivati sull’aia della cascina, il fuochista dava fuoco alle fascine predisposte sotto la caldaia produttrice del vapore necessario ad alimentare il moto della trebbiatrice. Le due grosse macchine, incamiciati da logorate lamiere, venivano bloccati sull’aia e collegati fra di loro da una cinghia che ne trasmetteva il moto. I covoni accatastati l’uno sull’altro erano gettati sulla trebbiatrice da uno degli uomini mentre l’altro li slegava e li metteva nel battitore che separava il grano dalla paglia. Con la paglia si formavano le “balle” a forma di parallelepipedo, ogni “balla” di paglia era tenuta assieme grazie alla legatura con corde. La paglia imballata e ben pressata veniva trasportata sotta la barchessa ad uso dell’azienda. I chicchi, invece, cadevano nella misura, l’ettolitro corrispondente a circa 18 Kg di prodotto, e con questa si riempivano i sacchi fino a un peso di circa 90 Kg. Per i sacchi di frumento che si volevano vendere occorreva procedere alla loro pesatura, per questo si utilizzava la pesa detta “basacüna” o la stiera. Il frumento veniva poi portato dal mugnaio per essere macinato in un mulino ad acqua. I semi di frumento che dovevano essere tenuti per la semina dell’anno successivo, venivano setacciati per pulire e selezionare i semi migliori. LA COLTIVAZIONE DEL MAIS Il mais è detto nel nostro dialetto “melegòt”. Il mais era coltivato in compartecipazione. Il paisan doveva seguire la coltivazione fino al prodotto essiccato. Si procedeva poi alla spartizione che era di solito in quarti, ma poteva anche essere in quinti o addirittura in sesti. La spartizione in quarti significava che 3 parti erano del padrone e una del paisan. Si iniziava con l’aratura che veniva fatta in autunno utilizzando l’aratro a un vomere trainato da buoi o da cavalli. L’aratura veniva fatta durante le ore fresche della giornata per cui poteva essere anche effettuata di notte . Si procedeva seguendo i bordi del campo, alla fine dell’aratura, nel centro del campo, si formava un canale che doveva essere colmato, per farlo si procedeva con due passaggi in modo da gettare le zolle una volta a sinistra e una volta a destra. Il mais seminato in primavera veniva raccolto a settembre. Molti seminavano il mais nei campi dopo averli arati, in cui era stato effettuato il primo taglio dell’erba medica dal quale si otteneva il fieno maggengo. La varietà di mais scelta era detta “quarantiin” cioè aveva un ciclo di maturazione breve: 40 giorni. A seconda delle caratteristiche del terreno, poteva essere necessario passare il coltivatore dopo il periodo delle gelate invernali. Sempre a seconda delle caratteristiche del terreno poteva essere passato il rullo e poi, appena prima della semina, l’erpice. Attrezzi sempre trainati da buoi o da cavalli. La semina del mais era effettuata con seminatrici trainate da cavalli. I semi venivano depositati nel terreno uno di seguito all’altro in filari (cavalét) distanti circa 30 cm gli uni dagli altri. Se necessario, subito dopo la semina del campo, se i granuli del terreno erano un po’ troppo grossi e se il terreno non era umido, si poteva anche passare il rullo. Nel cavalét i semi messi a dimora erano più del necessario perché diversi fattori potevano limitarne la germinazione (insetti, condizioni ambientali non favorevoli, ecc. ). Quando le piantine di mais erano nate si procedeva alla zappatura per liberarle dalle erbe infestanti, poi quando raggiungevano gli 8-10 cm di altezza venivano diradate (inciarìi al melegòt), sempre con la zappa si toglievano le piantine in eccesso e meno rigogliose lasciando uno spazio di circa 15-20 cm l’una dall’altra. Questi lavori erano eseguiti principalmente dalle donne. Quando le piante di mais raggiungevano i 50-60 cm di altezza, con la rincalzatrice trainata dal cavallo, si procedeva a rincalzarle, cioè si metteva terra intorno alle piantine. A questo punto non venivano effettuate altre operazioni, se le erbe infestanti crescevano troppo si tagliavano con la “mesura” un tipo di falce. La coltivazione del mais veniva effettuata senza irrigazione, si sperava nei temporali, anche perché solo abbastanza recentemente è stato possibile avere l’acqua nei canali e nei fossi mandata apposta e pompe capaci di prelevarla per poi distribuirla sul campo. Il raccolto serviva principalmente per soddisfare i consumi alimentari degli abitanti della cascina. La quantità di prodotto ottenuto poteva bastare altrimenti lo si faceva bastare. Quando le produzioni di mais si sono orientate verso il mercato anziché verso l’autoconsumo alimentare umano, è diventata necessaria la sua irrigazione perché permetteva di aumentarne notevolmente la produzione. Inizialmente l’irrigazione del mais veniva realizzata disponendo un certo numero di tubi collegati tra loro, attraverso i quali si trasportava l’acqua nelle varie parti del campo. Ogni tubo era lungo 4 metri, poi sono stati sostituiti da tubi in alluminio della lunghezza di 5 metri. In ogni caso i tubi venivano spostati a spalla. Al massimo si effettuavano 2 irrigazioni. Periodicamente si provvedeva alla pulizia dei canali e dei fossi, si toglievano detriti e vegetazione così l’acqua poteva defluire abbondante. L’acqua restava pulita da permettere di farci il bagno. Quando la pannocchia era quasi matura si procedeva alla cimatura delle piante di mais e alla raccolta delle foglie. Queste azioni venivano fatte per 2 motivi: - Il primo perché le cime e le foglie potevano essere date da mangiare agli animali qualora il fieno non fosse stato sufficiente - Il secondo perché il sole poteva meglio penetrare tra le piante e permetterne l’ essiccazione. Quando la pannocchia era matura e gli steli erano quasi secchi, si procedeva alla raccolta a mano della pannocchia oppure si tagliava lo stocco alla base. Con appositi attrezzi, gli uomini caricavano gli stocchi sul carro poi, una volta in cascina, il contenuto del carro veniva rovesciato sull’aia. A questo punto si procedeva a “scartocciare” cioè togliere le pannocchie e ripulirle delle foglie che le avvolgevano. Questo lavoro era svolto soprattutto dalle donne che si accompagnavano cantando, in certi momenti si aggiungevano anche i bambini. Gli uomini nel frattempo formavano dei mucchi con gli stocchi ripuliti dalle pannocchie, li legavano e li portavano sotto le barchesse. Gli stocchi così preparati potevano essere dati da mangiare alle mucche dopo la razione di fieno o erba se questi ultimi scarseggiavano al termine dell’inverno. Si disponevano strati di stocchi intervallati da manciate di sale e si lasciavano macerare per tutto l’inverno. Alla sera, se necessario, anche gli uomini aiutavano a scartocciare. I fusi scartocciati venivano poi sgranati con apposite macchine per liberare i chicchi dal tutolo. I tutoli servivano per fare fuoco nel camino della cucina. I chicchi di mais venivano fatti essiccare sull’aia sotto il sole. L’aia era divisa in quadrati, uno per ogni famiglia. Al mattino le donne scopavano bene l’aia perché i paisaan vi distribuivano, con rastrelli e pale in legno i chicchi di mais da far essiccare al sole. Nel trascorrere della giornata le donne avevano il compito di muovere i chicchi per farli essiccare meglio e in modo uniforme. Era una essicazione naturale, molto sana. Alla sera i chicchi venivano raccolti in mucchi e ricoperti con teli cerati protettivi per evitare che assorbissero l’umidità della notte vanificando l’essicazione raggiunta durante il giorno. I teli protettivi impedivano anche ai mucchi di mais di assorbire l’acqua in caso di pioggia. L’operazione di stendere e ammucchiare il mais era ripetuta per 3 giorni, l’ultima mattina lo si “palava”. Per pulire il mais lo si lanciava in alto con la pala e aiutati dal vento si separavano le impurità dai chicchi. Le impurità raccolte venivano anch’esse divise in quarti e sempre 3 erano del padrone e 1 del paisaan. In tempi un po’ più recenti si utilizzava una rete metallica messa inclinata, le maglie della rete trattenevano i chicchi di mais mentre le impurità si raccoglievano sotto alla rete. A questo punto il mais era pronto per essere insaccato. Per riempire un sacco di 83-85 Kg si usava il minòt corrispondente a 16-17 Kg. Vi erano anche altre misure quali il quarto di minòt, il mezzo minòt, la mina. Tutte le misure rappresentavano una unità di peso derivata dall’unità ponderale dei Greci e che anticamente era in uso presso i popoli del Mediterraneo. Per riempire un sacco, bisognava svuotare 5 volte il minòt e, per non sbagliare, si usavano contare ad alta voce i minòt riempiti dicendo: “ 1,2,3,4, sac”. Le donne raccoglievano lo sporco rimasto sull’aia e lo facevano passare al setaccio per recuperare ancora qualcosa e anche per questo dovevano poi rispettare le 3 parti al padrone e 1 al paisaan. Tutte le impurità raccolte e che spettavano al paisaan costituivano alimento per le galline. I sacchi del padrone venivano portati in spalla nel granaio, era un lavoro molto faticoso, ma c’era solidarietà tra le persone e ci si aiutava reciprocamente. Per ogni sacco portato in granaio si faceva una riga sul muro e ogni 10 sacchi si faceva un segno diverso per differenziarli e fare meglio il conteggio finale. Sui sacchi c’erano le lettere iniziali del nome del proprietario dei campi. Nel granaio si possono trovare anche scritte che ricordano momenti importanti di coloro che hanno avuto la volontà di scrivere. Il paisaan si portava via la sua parte, in base alle necessità e dopo aver pesato i sacchi di mais, li portava dal mugnaio per farli macinare ed ottenere la farina con la quale cucinare la polenta. La farina che tornava dal mugnaio, doveva prima di tutto essere setacciata per togliere la crusca. La crusca veniva data da mangiare al maiale. Per pesare i sacchi si utilizzavano delle pese quali la “stadera” o la “basacüna” Nella cucina del paisaan c’era anche un mobile in legno detto “farinèra”. Si apriva dall’alto ed era diviso da un asse verticale in due scomparti: uno un po’ più piccolo dell’altro. In quello più piccolo veniva messa la farina di frumento mentre in quello più grande la farina di mais. L’UCCISIONE DEL MAIALE Nell’alimentazione contadina del passato era diffuso il consumo di insaccati ed anche di carne suina fresca. Le famiglie, vivendo per lo più in cascina, potevano allevare il maiale destinato al consumo familiare. Uccidere il maiale aveva molti scopi: significava utilizzarlo interamente, avere abbondanti provviste di salumi per quasi un anno, poter risparmiare sulla spesa giornaliera. I cotechini venivano consumati maggiormente d’inverno, mentre i salami d’estate, quando c’erano anche pesci e rane. I PREPARATIVI Il maiale veniva acquistato dai paisan quando era piccolo (67Kg), a febbraio o marzo, e nutrito fino a dicembre con una alimentazione varia: ghiande, erbe e frutta di scarto, crusca, poi, nell’ultimo periodo, per farlo ingrassare, si alimentava con farina di mais non setacciata. Il maiale si allevava quindi con poca spesa. Era importante che il maiale avesse molto lardo, perché il lardo spalmato sulla polenta calda, costituiva la colazione dei poveri paisan prima di andare nei campi dove faceva freddo e c’era bisogno di tante calorie. Quando il maiale aveva circa un anno, lo si uccideva e questo avveniva nei mesi più freddi (da novembre a febbraio), perché non c’erano sistemi di conservazione delle carni. L’uccisione veniva vissuta come una grande festa da tutti i componenti della famiglia, infatti a volte i bambini stavano a casa da scuola per questo evento. La giornata prescelta iniziava prestissimo, prima dell’alba. Le donne si alzavano verso le 4 e in cortile mettevano sulla “fornella” un grosso paiolo di rame, che sarebbe servito per scottare la cotenna del maiale e poterla così privare delle setole. Intanto arrivava il norcino (“masalèr”) che aveva concordato precedentemente la data col capofamiglia, perché i clienti erano tanti e tutti i giorni egli era occupato. Gli uomini dapprima aiutavano il norcino a preparare la “forca”, cioè fissavano un grosso palo, all’altezza di circa 3 metri, fra un pilastro e l’altro del portico, per appendervi il maiale ucciso, che era stato tenuto a digiuno e dopo essere stato nutrito per circa un anno pesava 150-200 Kg: era l’orgoglio di chi l’aveva allevato. L’UCCISIONE Il condannato veniva prelevato a forza dal porcile da 4 o 5 uomini che lo trascinavano con una robusta corda legata ad una zampa, lo facevano cadere su un fianco e il norcino gli trafiggeva il cuore con un sottile stiletto molto appuntito. Poi si lasciava uscire il sangue perché la sua presenza nella carne ne diminuiva i tempi di conservazione. [Oggi si usano tecnologie nuove per l’uccisione del maiale: un colpo di pistola alla testa.] L’evento era vissuto da tutti con tristezza per gli altissimi grugniti della vittima, ma gli adulti si sentivano anche felici pensando alla scorta di cibo che l’animale rappresentava. Il corpo senza vita del maiale veniva trasportato su un’asse vicino al paiolo di acqua bollente. Si versava l’acqua bollente sulla cotenna e immediatamente si passava il raschiatoio per togliere le setole e con un uncino si toglievano l’astuccio corneo delle un ghie. Quando tutte le setole erano state tolte, il maiale veniva appeso al palo a testa in giù e sotto al grugno era posta una bacinella per raccogliere il sangue. LA LAVORAZIONE DELLE CARNI E LA PREPARAZIONE DEI SALUMI Il maiale veniva tagliato a metà con un grosso coltello o con un’accetta e se la metà era perfetta si vedeva la bravura del masalèr. Poi si toglievano le parti molli: vescica, intestino, fegato, cuore, polmoni, reni. L’intestino veniva tagliato nel senso della lunghezza e poi tagliato in pezzi della lunghezza richiesta per confezionare i vari salumi. Si procedeva quindi a lavarli una prima volta con acqua calda, e una seconda volta con vino tiepido mescolato all’aceto. Quest’ultimo lavaggio consentiva di sgrassarli meglio. I pezzi di intestino puliti venivano poi cuciti accuratamente con ago e filo dalle massaie. Due pezzi di intestino cuciti tra loro nel senso della lunghezza costituivano la misura per insaccarvi i salami, mentre 3 pezzi cuciti servivano per insaccare i cotechini. Le carni venivano selezionate in rapporto alla quantità di grasso contenuta: per il salame e la coppa erano utilizzate le carni migliori, cioè quelle magre, dalle quali si toglievano tutti i tendini e si aggiungeva il grasso della pancia perché era il migliore, mentre per la pancetta e il cotechino le carni più grasse e le parti muscolose. Nella nostra zona si preparavano soprattutto salami e cotechini, meno coppe e pancette. Il norcino, con grande abilità, spolpava le ossa e le metteva da parte, quindi con una particolare macchina chiamata tritacarne ed azionata da una manovella, macinava le carni magre del lombo a cui univa un po’ di grasso particolare detto lardo, poi aggiungeva varie spezie quali sale, pepe, cannella, noce moscata e aglio a piacere schiacciato nel canovaccio. La forma particolare dei salumi si otteneva grazie ad un tubo insaccatore che inseriva l’impasto in ciascuno dei pezzi di intestino precedentemente preparati dalle donne. Una volta riempito, si provvedeva subito ad effettuare, con lo spago, la tipica legatura che completava il salume. La preparazione del salame e del cotechino era simile, cambiava la composizione dell’impasto, infatti per il cotechino si usava oltre alla carne anche la cotenna. Diversa era la preparazione della pancetta, si adoperava, infatti, il lardo della pancia striato da fili di magro e infine lo si arrotolava. La coppa era ottenuta arrotolando la carne della parte dorsale del collo dopo averla adeguatamente aromatizzata. Il prosciutto, invece, ottenuto dalla coscia posteriore del maiale, nella nostra zona non era prodotto a causa dell’aria non adatta alla sua stagionatura. IL LARDO E LO STRUTTO Il norcino doveva distinguere il lardo, cioè il grasso sottocutaneo vicino alla cotenna, dalla sugna, cioè dal grasso che si trovava vicino alle ossa. Il lardo veniva tagliato in pezzetti e una parte di questi, macinati insieme alla carne, servivano per la preparazione dei salumi, l’altra parte, invece, veniva salata, pepata e conservata al fresco. Dopo aver assorbito il sale e le spezie, si tagliavano fette sottilissime per mangiarle con la polenta abbrustolita. Il lardo poteva essere mangiato unito ad una “pestata” molto fine costituita da aglio e prezzemolo, questo lardo veniva chiamato “gras pistat”. Il grasso chiamato sugna, veniva bollito per fare lo strutto. Dalla sua lavorazione si ottenevano dei pezzettini di grasso cotto chiamate “gripuli”, in italiano ciccioli. I ciccioli erano mangiati con la polenta. Lo strutto era messo in vasetti e, una volta raffreddato, diventava bianco e burroso. Le massaie lo utilizzavano per friggere e anche al posto del burro. LA STAGIONATURA DEI SALUMI Terminata la lavorazione, i salumi venivano appesi, legati a pertiche di legno, il tutto costituiva il cosiddetto “baldacchino dei salumi”. Questo baldacchino veniva lasciato per un paio di giorni in una stanza nella quale si provvedeva a tenere accesa una stufa oppure il fuoco del camino. Il giusto calore permetteva ai salumi di “sudare” e, attraverso opportune forature praticate prima dal norcino, di eliminare i liquidi in eccesso. In questo modo si favoriva la stagionatura. Passati i due giorni, i salumi venivano appesi in una cantina con umidità media così da permettere la formazione della caratteristica muffa dei “budelli”. LA CENA DEL MAIALE A mezzogiorno si mangiavano il fegato cucinato nella cosiddetta “rete” cioè nel peritoneo del maiale, e i filetti. La giornata finiva poi con una cena, chiamata “cena del maiale”, a cui partecipavano numerose persone, erano invitati anche i vicini. In tavola veniva servito tutto ciò che aveva dati il maiale: riso in brodo con la salsiccia, costine cotte con le verze, braciole, torta di sangue o sanguinaccio, sia dolce che salata, con un po’ di limone e la polenta, fegato fritto o rosolato con la cipolla. Dopo l’abbondante cena in alcune case si cantava e si stava in compagnia fino a tarda sera. DEL MAIALE NON SI BUTTA VIA NIENTE Del maiale veniva utilizzato tutto, non si sprecava nulla: basta pensare che molte donne ne ricavavano anche il sapone, preparandolo con pezzi di grasso sottocutaneo bolliti e uniti a una giusta dose di soda caustica comperata in farmacia. Le massaie aspettavano che il tutto si solidificasse e poi lo tagliavano a pezzi. Con le unghie si facevano i giocattoli per i bambini, come le nacchere, oppure si foravano le ossa del metatarso che, con una cordicella, producevano una musica. Le setole più le ossa venivano raccolte dai “ vescuvadin”, persone originarie di Vescovato . RICETTE TIPICHE COSTINE DI MAIALE CON VERZE (per 6 persone): si fanno rosolare circa 1 Kg di costine con olio e cipolla. Si aggiunge 1 Kg di verze affettate e si copre con acqua. Si sala, si mette una presa di pepe e si lasciava cuocere per circa 2 ore. FEGATO ROSOLATO: si fa rosolare in un tegame il fegato tagliato a fettine, poi si aggiunge il limone e si lascia rosolare ancora per qualche minuto. RISOTTO CON IL MACINATO: si fa rosolare la carne macinata del salame, poi si aggiunge un bicchiere di vino rosso. Quindi si mette il riso e lo si cucina come un normale risotto. COTENNE CON FAGIOLI (per 4 persone): si mettono sul fuoco 4 etti di cotenne e si fanno rosolare in olio, burro e cipolle. Si aggiungono salsa e odori e 2 etti di fagioli secchi ammollati in acqua sin dalla sera precedente. Si fa cuocere fino a che le cotenne saranno tenere e morbide. IL LAVORO DEL BERGAMINO Il bergamino era l’uomo di fatica e abitava nella cascina, in una delle case più povere. Il suo lavoro è la cura degli animali da latte: un lavoro duro scandito non dai tempi solari ma dalle esigenze delle bestie. Il bergamino si chiamava così forse perché i primi custodi delle mucche provenivano dalle valli bergamasche. La sua giornata iniziava al mattino presto e terminava di notte. Il suo unico svago era andare in osteria o, durante una pausa, prepararsi e fumarsi una sigaretta. Aveva due turni di lavoro, uno di notte e l’altro di pomeriggio. Ad ogni bergamino venivano affidate 1213 mucche di cui doveva prendersi cura. Ciascuna mucca doveva essere munta 2 volte al giorno con un intervallo di 11-12 ore per evitare malattie alle mammelle. Negli allevamenti grandi, il bergamino, poteva prendersi cura fino a 18 mucche. Il lavoro del bergamino iniziava con il togliere il letame ed ammucchiarlo nel solco, pulire le greppie, dare da mangiare alle mucche, mettere nuova paglia a costituire il giaciglio, caricare il letame sulla carriola di legno e portarlo nella concimaia, infine mungere. Gli steli d’erba che restavano nella greppia, venivano tolti ed usati anch’essi nella preparazione della lettiera. Le mucche da mungere erano abitualmente intente a mangiare per questo potevano non accorgersi dell’arrivo del bergamino e magari reagire scalciando. Per evitare tutto questo il bergamino si avvicinava emettendo qualche richiamo, chiamandole per nome e dando loro qualche pacca sulla schiena. La lunga mangiatoia in pietra era disposta contro il muro e, al di sopra di essa, tanti anelli in ferro, giustamente distanziati, ai quali venivano legate con catene le mucche. Appese al muro vi erano anche tante lavagnette nere su cui era scritto col gesso il nome di ognuna e sotto il nome era sempre scritta una data, quella in cui la mucca era stata fecondata dal toro. Gli attrezzi del bergamino erano uno sgabello e il secchio e in testa portava il caratteristico cappello detto “chiribiri”. Lo sgabello solo in tempi più recenti era dotato di tre gambe, inizialmente ne aveva una sola centrale. In effetti lo sgabello non serviva da vero e proprio seggiolino, ma semplicemente da appoggio che doveva permettere al bergamino di spostarsi velocemente nel caso la bestia avesse compiuti bruschi movimenti capaci di travolgere il secchio con il latte o anche il bergamino stesso. Il bergamino conosceva bene le proprie mucche, non tutte si comportavano allo stesso modo durante la mungitura: alcune erano docili, altre meno. Alle bestie più irrequiete il bergamino spesso legava la coda ad una zampa per evitare di ricevere frustate sulla testa difficili da sopportare. Il bergamino si sedeva sullo sgabello vicino alla mammella dell’animale, le gambe sotto la pancia trattenevano il secchio nel quale raccogliere il latte munto. Il latte non scendeva immediatamente, per cui occorreva iniziare con delle tirate capaci di far scendere le prime gocce con le quali si procedeva al lavaggio dei capezzoli. Poi iniziava la mungitura vera e propria grazie al ripetersi di movimenti consistenti nel tirare e strizzare i capezzoli facendo così fuoriuscire il latte. La mungitura delle 12-13 mucche durava circa un’ora. Appena il secchio si riempiva di latte lo versava nei bidoni allineati vicino alla porta, solo negli ultimi tempi si usava appoggiare all’imboccatura del bidone un colino capace di trattenere eventuali corpi estranei, di solito mosche, prima erano gli occhi del bergamino che osservando il latte durante il travaso le vedeva e quindi procedeva a toglierle con le dita. I bidoni, una volta pieni, venivano chiusi ermeticamente e, con l’apposito carretto portati uno per uno all’ingresso della cascina per aspettare il camion che li avrebbe caricati e avrebbe lasciato un ugual numero di altri bidoni vuoti. I vari bidoni, sia quelli pieni di latte che quelli vuoti, erano numerati con il numero caratteristico della stalla. I camion del latte facevano 2 giri per raccogliere i bidoni pieni e lasciare quelli vuoti, poi raggiungevano le latterie convenzionate. Terminata la mungitura, le mucche venivano liberate in numero di 4 o 5per volta così potevano abbeverarsi all’”albi”. Finito di bere ritornavano spontaneamente al loro posto nella stalla. Il bergamino doveva occuparsi del taglio delle unghie, che avveniva circa una volta all’anno, mentre al bisogno effettuava la pulizia delle unghie posteriori. Doveva anche controllare se erano in calore e capire se stavano male. Egli conosceva bene le sue mucche e il carattere di ognuna. Era anche suo compito scegliere il tipo di alimento da dare loro, che non doveva essere troppo scarso, ma neanche troppo abbondante, per evitare una spesa eccessiva. Gli escrementi delle mucche uniti alla paglia davano il letame, che era il più grande fertilizzante della terra. Una volta il ciclo produttivo di una mucca durava circa 20 anni, produceva 25 quintali di latte in un anno e veniva munta per 14-15 anni. Oggi, una mucca produce 120 quintali di latte in un anno e la si mantiene in produzione per soli 3 anni poi va al macello. Le mucche avevano 2 mesi di “asciutta”, cioè 2 mesi prima di partorire non producevano latte e quindi non venivano munte. La gravidanza della mucca dura 9 mesi. Oggi i vitelli vengono alimentati con delle macchine, un tempo venivano slegati negli orari dei pasti per permettere loro di succhiare il latte della madre. Al toro veniva messo l’anello al naso dal quale far passare una corda così da poterlo tirare ed indurlo ad eseguire il volere del padrone. Le sue corna, per motivi di sicurezza, erano tenute tagliate e arrotondate. L’ALLEVAMENTO DEL BACO DA SETA (cavaléer) Fino a circa 50 anni fa la nostra campagna, per le particolari caratteristiche del terreno e del clima, era disseminata di gelsi. Le foglie dei gelsi, molto tenera, erano l’alimento ideale per il baco da seta, un insetto originario dalla Cina che molto tempo fa è stato importato anche in Europa ed allevato. L’allevamento del baco da seta, in dialetto, lo si chiamava “i cavaléer”. Una volta era molto diffuso presso le famiglie contadine della nostra zona, perché permetteva di integrare il magro reddito derivato dal lavoro dei campi. In primavera, a ogni famiglia, veniva data un’oncia o due di “semi”, così si chiamavano le larve appena nate del baco da seta. L’oncia corrispondeva a circa 31-32 grammi. Ogni famiglia provvedeva al nutrimento con le foglie di gelso raccolte in campagna. Incaricati della raccolta delle foglie erano specialmente i bambini e le donne. Le prime foglie ad essere raccolte erano quelle raggiungibili da terra, poi, quando queste iniziavano a scarseggiare, occorreva arrampicarsi sulla pianta per raggiungere via via le foglie poste più in alto, per fare questo si usavano scale e le foglie raccolte si mettevano in sacchi di iuta tenuti aperti da un cerchio attaccato ad un bastone munito di uncino. Durante la prima fase, quando le larve erano ancora piccole, l’allevamento avveniva in cucina. Il baco veniva alimentato su speciali graticci (aréli) costituiti da intelaiature in legno con fondo in canne. Le aréli si potevano sovrapporre, formando una specie di letti a castello, chiamate scaléri. “Li scaléri” erano sostenute da pali legati alle travi con chiodi e filo di ferro. Inizialmente per evitare che i piccoli bachi e le foglie triturate passassero dalle fessure esistenti tra le canne, era necessario disporre sul fondo delle aréli dei fogli di carta. Ai bachi si dava da mangiare ogni quattro ore circa, sia di giorno che di notte, erano molto delicati, l’ambiente doveva essere riscaldato, bisognava fare attenzione a non esporli a correnti d’aria, avevano bisogno di luce ed occorreva anche giornalmente provvedere alla loro pulizia. Man mano che i bachi crescevano, venivano date loro foglie di pezzatura sempre più grossa, fino a lasciare le foglie intere. Diventando i bachi sempre più grossi, avevano bisogno di maggior spazio per cui poteva essere necessario cercare posto in altre stanze, non escluso le camere da letto. Poteva succedere anche che, sempre per ragioni di spazio e se la stagione accompagnava, si mettessero li scaléri anche sotto le barchesse. Ogni famiglia aveva la sua zona. Se tutto andava bene, si arrivava alla fine di giugno cioè dopo circa una quarantina di giorni dall’inizio dell’allevamento, i bachi avevano compiuto 4 mute per poi diventare di colore giallo fino a raggiungere la trasparenza; a questo punto smettevano di mangiare e facevano il bozzolo (in dialetto galèti). Appena prima di costruire il bozzolo, i bachi, si spostavano dal ripiano delle aréli per arrampicarsi sulle masòte. Le masòte venivano costruite intrecciando rametti e paglia e disponendole tra un’aréla e l’altra. La costruzione del bozzolo durava 3-4 giorni e al suo interno il baco si trasformava in crisalide. I bozzoli erano “maturi” quando il baco aveva completato di stendere sulla parete interna del bozzolo la sua bava di seta, questo avveniva dopo 8-10 giorni dal momento che si erano rinchiusi. Si toglievano le masòte e le donne staccavano i bozzoli, questo procedimento era detto sgalétàa. L’esperienza insegnava quando era il momento opportuno per sgalétàa e cioè quando al tatto i bozzoli apparivano abbastanza consistenti. Venivano raccolti in ceste, selezionati e puliti della ovatta esterna e portati alla Filanda di Piadena per ricavarne la seta. Solo il bozzolo sviluppato e completamente integro veniva utilizzato per la produzione del filo di seta, per cui la crisalide doveva essere uccisa prima che compisse la metamorfosi per trasformarsi in farfalla, se questo succedeva il bozzolo bucato, sarebbe stato inutilizzabile. Si soffocava la crisalide con aria caldissima e vapore e, in seguito, il bozzolo veniva immerso in acqua calda a 80° per ammorbidire la sericina dei fili di seta. Spesso era necessario che le donne, insieme ai bozzoli, dovessero immergere le mani nude nell’acqua calda, le mani diventavano rosse e potevano anche piagarsi. Filanda è il nome con cui, nel Nord Italia, sono conosciuti gli stabilimenti di lavorazione e filatura della seta. Il lavoro della Filanda era svolto principalmente da giovani donne (prima del matrimonio) e da bambine. Le bambine aiutavano nel procurare le scorte di bozzoli trattati e nel muovere l’aspo attorno al quale veniva filata la seta. I turni erano pesanti, potevano variare da 12 a 16 ore al giorno con durissimi controlli sulla quantità e sulla qualità del prodotto lavorato, le lavoratrici venivano multate se non li rispettavano. Il lavoro era faticoso e malsano per i vapori delle vasche, le mani tenute nell’acqua calda, la polvere sempre presente, e come se tutto ciò non bastasse, i salari erano veramente bassi. CONCLUSIONE Facendo un confronto tra la vita contadina al tempo dei nonni e la nostra sono emerse alcune conclusioni interessanti. La civiltà contadina della nostra zona ha messo in pratica valori tradizionali molto importanti, coma la laboriosità, la fatica, l’onestà e il risparmio, valori che sono validi ancora oggi. I contadini accettavano una vita molto dura e un lavoro prevalentemente manuale, dove la polenta, il pane, le uova, la carne, gli ortaggi erano guadagnati con enorme fatica e grande onestà e per questo valorizzati al massimo e non sprecati. Infatti l’economia delle famiglie era volta al risparmio: niente veniva buttato e tutto già allora “riciclato”. Abbiamo anche capito che la società contadina, benché povera, era socievole e solidale. Ci si aiutava, come in tutte le società povere, e ci si ritrovava sulle aie e nelle stalle per lavorare cantando o per fare “ filos”. Un pensiero va anche alla donna che nella società contadina viveva in una condizione arretrata: era sempre in casa, faticava molto e gli unici lavori che nella nostra zona poteva svolgere fuori casa (nei campi o in filanda) erano durissimi e non la compensavano delle relazioni sociali che, svolgendoli, poteva intrattenere al di fuori delle pareti domestiche. Inoltre spesso aveva molti figli e andava a lavorare fino al momento del parto. Per finire, l’ultima riflessione va a questo nostro lavoro, che ci ha impegnati tre anni ma che abbiamo svolto volentieri e che ci ha coinvolti con le sue varie attività. Poiché non abbiamo la presunzione di essere stati perfetti, eventuali critiche, correzioni, suggerimenti e approfondimenti saranno apprezzati. Gli alunni delle classi 3aA e 3aB a.s. 2011/2012 RINGRAZIAMENTI La realizzazione del lavoro è stata resa possibile grazie al contributo di: • Genitori, nonni, conoscenti degli alunni attuali e di alunni di anni scolastici passati • Amministrazione comunale di Piadena • Amministrazione comunale di Drizzona • Biblioteca dell’Unione Lombarda dei Comuni di Piadena e Drizzona • Lega di Cultura di Piadena • Gruppo Padano di Piadena Un grazie a tutti coloro che hanno fornito, a diverso titolo, racconti di vita passata, tanta disponibilità, tempo prezioso, pazienza e incoraggiamenti a proseguire. BIBLIOGRAFIA - “Casalbellotto nella storia” – Graficart Padana – Piero Zaffanella “Casalmaggiore” – Comuni d’Italia per l’Europa – Editrice Telesio – Nuove Carte – 1991 “I Paisan”- Immagini di fotografia contadina nella bassa padana – Giuseppe Morandi – Gabriele Mazzotta Editore – 1979 “Uomini Terra Lavoro- fotografie di Giuseppe Morandi” – Electa - 1999 100 anni di Latteria di Piadena Calendari della Biblioteca di Piadena (dal 1993 al 2008) CASCINE percorsi nella memoria di una civiltà – Barisani, Piccolo, Ruggeri – CREMONAPRODUCE (2007) Case contadine – Touring Club italiano (1979) Comune di Tornata: “Romprezzagno e Tornata – La lunga storia delle sue comunità” a cura di L. Roncai e A. Bellardi -1999 Cremonesi a Cremona – fotografie di G. Morandi – Nuove Edizioni Gabriele Mazzotta -1987 Foto tratte da calendari di varia provenienza IL CAMBONINO – Gruppo fotografico Beltrami – Vacchelli – Amministrazione Comunale di Cremona (1994) Il Fiume, la Terra, la Gente – la memoria del Novecento : Acquanegra, Calvatone e Canneto raccontano il loro passato in un documentario fotografico – G. Gozzi – Sometti (2002) LA CASCINA CREMONESE gli elementi architettonici, la vita quotidiana, lo sfruttamento della donna. Archivio del Movimento operaio contadino. Persico Dosimo (CR) – 1980 LA CASCINA E IL MONDO CONTADINO NEL TERRITORIO CASALASCO – ricerche e testimonianze a cura del Sistema bibliotecario Distrettuale Casalasco – autori: M.Lodi, L. Roncai, G. Sanfilippo (1983) LA FABBRICA CONTADINA – Fotografie di L. Ghisleri – Testi: P. Barbaro, E.M. Ferrari – Associazione per le arti – CR LAVORI della PADANIA – foto di Luigi Briselli (1993)– Testi di Mario Lodi, Egidio Del Canto – Editrice TURRIS CREMONA Li usavamo così … utensili, strumenti da lavoro e manufatti della civiltà contadina – Giuseppe Flisi Editrice Castello – 1980 Numerosi siti internet per notizie e fotografie. Vecchi mestieri in Val Padana (1980)- fotografie di Luigi Briselli, testi M. Lodi
Scaricare