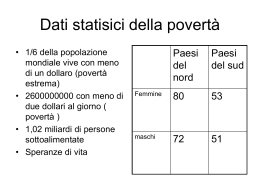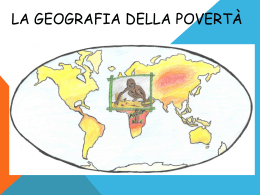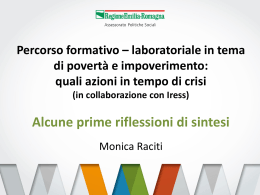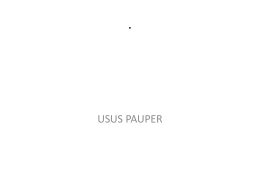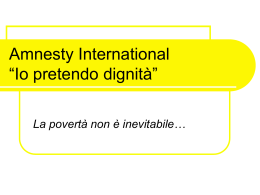UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO” FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA Corso di Laurea in Sociologia L’INCONTRO CON LA PERSONA SENZA DIMORA UNA RICERCA ETNOGRAFICA PRESSO L’ACCOGLIENZA NOTTURNA FEMMINILE “LA TRECCIA” DI GENOVA Relatore: Chiar.mo Prof. GIULIANO PIAZZI Tesi di laurea di: CLAUDIA SAMPAOLESI ANNO ACCADEMICO 2002-2003 5 6 INDICE INTRODUZIONE pag. 7 PERSONE SENZA DIMORA: ANALISI GENERALE DEL FENOMENO 1. Rappresentazioni e trattamento della povertà urbana estrema: un excursus storico pag. 15 2. Percorso della persona senza dimora 2.1. La casa 2.2. La famiglia 2.3. Il lavoro 2.4. La vita in strada 2.5. Il rapporto con le istituzioni 2.6. Il rifiuto o l’abbandono: il senza casa cronico 2.7. La gestione del corpo pag. 21 pag. 24 pag. 25 pag. 26 pag. 27 pag. 29 3. Quale povertà 3.1. Dalla povertà alla povertà estrema 3.2.Dalla povertà ai poveri pag. 34 pag. 37 pag. 45 pag. 31 pag. 32 L’ASSOCIAZIONE S. MARCELLINO 1. Storia e costituzione pag. 51 2. Il metodo 2.1. L’alloggiamento 2.2. Il lavoro 2.3. Socializzazione 2.4. Salute e benessere 2.5. Le dipendenze pag. 54 pag. 55 pag. 56 pag. 57 pag. 57 pag. 57 LE DONNE SENZA DIMORA pag. 59 L’ACCOGLIENZA NOTTURNA FEMMINILE “LA TRECCIA” 1. Nota metodologica sulla raccolta dati e loro affidabilità pag. 63 2. La storia della Treccia pag. 64 7 2.1. La specificità della Treccia pag. 65 3. Profilo delle utenti della Treccia pag. 68 4. Descrizione della struttura 4.1. I locali della Treccia pag. 77 pag. 77 5. Il “sogno”di una casa pag. 82 6. Immagini della maternità pag. 86 7. Quotidianità all’interno della struttura e relazione tra le ospiti pag. 88 8. Relazione tra le ospiti e gli operatori pag. 93 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE pag. 97 BIBLIOGRAFIA pag. 99 8 INTRODUZIONE Soprattutto: Il mondo normale, quello della società, dei ruoli, delle istituzioni e delle necessarie forme sociali in genere diventa una grande metafora, spesso insopportabile. E l’io comincia a capire perché spesso si può pensare a questo mondo come ad un enorme artifizio. E già: quella strana e sconosciuta condizione normativa del corpo e della mente, che ad un certo punto ha incluso l’io, impone all’io stesso di convincersi che l’unico, vero, grande valore di un qualsiasi mondo è il valore della vita. Quel qualche cosa di pervasivo e di sconosciuto che è sembrato determinante non è altro che la vita, ciò che anche adesso l’io confusamente chiama vita. G. Piazzi, La ragazza e il direttore Il mio interesse per le “persone senza dimora” è nato grazie al corso di “Sociologia dell’ambiente”, che seguii due anni e mezzo fa circa ad Urbino, condotto dal prof. G. Pieretti. Ho sempre pensato al “barbone”, perché è questa l’etichetta che diamo solitamente alle persone che si trovano in strada, come ad una figura particolare, quasi mitica, che si trova in quella situazione perché sceglie la libertà, non accetta nessuna regola sociale uscendo fuori da tutte quelle costruzioni, convenzioni che noi “bravi borghesi” ci siamo fatti; oppure pensavo che chi si trovasse in strada fosse lì a causa di problemi psichici e per questo abbandonati a se stessi; persone che non hanno mai avuto alle spalle una rete relazionale o comunque rifiutate da questa rete; persone fuori da quel sistema che noi “normali” viviamo. Ma è proprio questo “star fuori” che mi ha fatto riflettere…In seguito, ho imparato che l’uscita non è istantanea e non avviene totalmente, il percorso di “degrado” è 9 lungo, è costituito da piccole rotture e ogni rottura ha bisogno di un suo assestamento. Ciò mi ha portato subito alla mia realtà, e agli sforzi spesso compiuti per rimare “affiliata” ad un sistema che troppe volte diventa stretto, insopportabile; quanti sforzi per capire chi siamo e soprattutto cosa vogliamo essere. Doversi costruire un’identità attraverso l’assunzione di ruoli che vengono interscambiati a seconda del contesto. Identità che si costruisce attraverso l’interazione e la relazione con gli altri. Costruzioni su costruzioni… ma la perenne insoddisfazione rimane! M. Loiacono così scrive: “La società in cui si vive è sempre più una società senza regolamentazione e normatività, una società psicotica e a brandelli, in cui ogni individuo vive isolato nel suo delirio, preso intimamente ad ascoltare quelle voci virtuali che gli giungono dal rimosso, da una qualità di vita non ancora soddisfacente, da una sensazione ostile e asfissiante che si avverte pur nella comodità della celletta o nello sballo dell’emporio.”1Una società quindi in cui per ognuno di noi è difficile rimanere affiliati. Nel trattare il “fenomeno” delle “persone senza dimora”, non possiamo fare a meno di affrontarlo senza intrecciarlo con la nostra “normalità”, perché si tratta di un disagio, certo favorito da alcuni fattori quali la mancanza di un alloggio, una condizione economica precaria, ma gli elementi che maggiormente lo connotano e lo definiscono, sono soprattutto, una inadeguatezza della persona di fronte alla complessità attuale e una “tempesta” relazionale (che coinvolge affetti, fiducia, autostima, etc.) che destabilizza la persona stessa2. Un disagio che accomuna ognuno di noi, diffuso in quanto “indica un processo che taglia trasversalmente le variabili tradizionali e fa un po’ piazza pulita dei luoghi comuni a cui siamo abituati”3. Per questo nuovo disagio non valgono più i classici criteri dell’età, dell’appartenenza ad un ceto sociale o ad una certa famiglia, della struttura della famiglia, dell’ambiente urbano in cui si abita e tutta un’altra serie di cose che non riescono più a spiegare quello che sta succedendo oggi. “Non c’è un ruolo o una condizione che ci può precludere questa esperienza”4 Ma di povertà estreme, o comunque nella condizione di “senza dimora” si muore e si muore presto, in età giovanile. Le persone “senza dimora” sono persone che hanno perso ogni legame comunitario; il loro sistema psichico è deluso, vuole ritirarsi, fino a lasciarsi morire. Riporto una metafora, che mi è piaciuta molto, utilizzata da Gui ad una lezione del corso di formazione “Operare con le persone senza dimora”, organizzato dall’Associazione S. Marcellino5. Gui paragona la nostra vita ad una tendina canadese, la quale sta su solo piantando picchetti e tirandoli bene. Come nella tendina canadese anche nella nostra vita c’è bisogno di alcuni tiranti principali e fondamentali per la sua tenuta e poi una serie di picchetti, tre o quattro per parte che le consentano di essere ben tesa e di reggere alle intemperie. Nella nostra vita, come nella tendina, questi picchetti talvolta saltano. Se, se ne allentano due, o saltano due picchetti, la tendina, non precipita ma comincia ad essere un po’ in difficoltà, con il vento si scuote, se si allenta il terzo cordino, il rischio di tenuta è 1 M. Loiacono, Verso una nuova specie, Edistampa Nuova Specie, Lucera, 2000, p. 218. G. Pieretti, “La negazione dei diritti nel percorso di vita delle persone senza dimora”, Genova, 2001. 3 M. Loiacono, Verso una nuova specie, Edistampa, Lucera, 2000, p. 111. 4 Ibidem, p. 111. 5 La lezione è del 16/02/02. 2 10 veramente compromesso e, se tira una folata di vento un po’ più forte, tutti i picchetti saltano. Anche nella nostra vita abbiamo ogni tanto qualche picchetto che viene meno, ma il tempo ci permette di ripiantare quello che è caduto…Se ho perso il lavoro, avrò una rete affettiva pronta a proteggermi, la famiglia, gli amici, avrò comunque altri svaghi, ma se cominciano a cadere una serie di picchetti e la mia tendina aveva già due o tre picchetti mancanti fin dall’inizio, allora la possibilità di restare in equilibrio, la possibilità di continuare a stare in piedi è molto compromessa. Ogni frattura ha bisogno di una sua spiegazione. Per la persona senza dimora abbiamo un’infinità di spiegazioni, ma nascono dal nostro punto di vista, nascono dalla nostra “definizione della situazione”. Occorre “girare l’angolo”, scoprire altri punti di vista6 per vedere ciò che normalmente non vediamo, occorre attraversare i nostri confini per mettersi in ascolto. Così ho pensato di impostare la mia “ricerca”: ascoltare ed osservare, senza invadere, con l’intento di scrivere poi ogni cosa in un quaderno - diario che ho portato sempre con me, seguendo l’esempio dei “maestri” della “Scuola ecologica di Chicago”. La mia ricerca si basa su persone che si sono rivolte all’Associazione S. Marcellino, un approccio che parte quindi dal servizio e che non può certo esaurire la lettura del fenomeno. Iniziamo dal principio… Il mio primo contatto con S. Marcellino è avvenuto grazie al prof. Piazzi che, telefonicamente, mi ha presentato D., responsabile dell’Associazione. Il 1 Marzo di quest’anno ho incontrato per la prima volta D. all’interno dell’Associazione, situata in via Ponte Calvi. Durante quell’incontro, D. mi ha presentato a grandi linee l’Associazione, la sua storia, lo stile e mi ha descritto le varie strutture, cercando allo stesso tempo di capire quali erano i miei interessi e i miei obbiettivi di “lavoro”. In realtà io non avevo un’idea ben precisa: quello che mi aveva spinta ad arrivare fino a Genova era l’interesse per tutto un “mondo” a me quasi sconosciuto. Tutto per me era nuovo: Genova, S. Marcellino e il suo operare, la tesi stessa…E come ad ogni novità, ero assalita da un senso di paura, ma ad essa si univa la voglia di scoprire, di sapere…Infatti ad Aprile, esattamente lunedì 7 Aprile 2003, sono di nuovo ritornata a Genova. Ho scritto nel mio quaderno: “Inizia così la mia settimana di perlustrazione e contatto con le strutture. La prima tappa è in via Ponte Calvi, dove ha sede l’Associazione, luogo ormai a me familiare così come lo è D.” Infatti quello da cui sono stata subito colpita è stata la sensazione di avere attorno a me delle persone conosciute da sempre. D., a questo proposito, mi ha detto che sono tanti anni che l’Associazione viene a contatto con le persone e l’ accoglienza è il principio guida attraverso il quale gli operatori si muovono. “L’esperienza relazionale con le persone che provengono dalla strada ci ha portato a consolidare la convinzione che le relazioni che ‘funzionano’ sono quelle che portano a cambiamenti costruttivi coloro che li vivono. Abbiamo sperimentato 6 “Non comprendo, non sopporto che si giudichi un uomo non per quello che è ma per il gruppo a cui gli accade di appartenere (…), qualcosa che non si può capire costituisce un vuoto doloroso, una puntura uno stimolo permanente che chiede di essere soddisfatto.”, in P. Levi, I sommersi e i salvati, Torino, Einaudi, 1991, p. 143. 11 che, incontrando l’altro, se ci lasciamo toccare un po’ in profondità, gradualmente siamo costretti a porci questioni sulla nostra stessa vita, sullo stile delle nostre scelte, e possiamo incominciare a fare delle ipotesi di trasformazioni nostre, della realtà che ci circonda, della vita degli altri. Quando l’altro vive situazioni di difficoltà o di sofferenza, questo processo misteriosamente ma concretamente si accelera fino a divenire elemento propulsore di cambiamenti dinamici e sorprendenti.”7 Ritornando al mio percorso, nella settimana dal 7 al 12 Aprile, ho visitato tutte le strutture dell’Associazione: la mattina, il Centro d’Ascolto, il pomeriggio, la Svolta e la Stiva e la cena ogni sera in un dormitorio diverso quali Boschetto, Treccia, Gradino, Angolo, Ponte8. Il Centro d’Ascolto è stato il mio primo punto di contatto con le persone: esso rappresenta il punto nevralgico dell’Associazione, perché è qui che avvengono i primissimi contatti con le persone in difficoltà ed è il primo passo verso la comprensione del loro disagio. Alle persone che mi hanno domandato quale fosse il mio ruolo, ho spiegato il motivo per cui ero lì: una tesi di laurea su S. Marcellino e le sue strutture e così ho continuato per tutto il periodo che ho trascorso all’interno delle strutture. E’ difficile spiegare come sia stato l’impatto, sicuramente forte, toccante, ad ogni modo positivo; allo stesso tempo però, quella settimana a Genova mi aveva creato una grande confusione, per cui, ritornata a casa, ho cercato di mettere insieme un po’ i pezzi che avevo raccolto e fare chiarezza. Come impostare la tesi? Su quali strutture concentrare la mia attenzione? Sono ritornata a Genova un mese dopo circa, per restare 15 giorni. L’idea era quella di intervistare alcune persone, alloggiate nei tre dormitori da me prescelti (Boschetto, Gradino e Treccia), più che una intervista, avrei dovuto semplicemente registrare il racconto che le persone fanno della propria vita e concentrarmi su le spiegazioni che la persona fa circa la propria situazione, a quale “evento traumatico” collega il suo “degrado” e, nonostante quest’ultimo, come cerca di risalire, come riesce a darsi un nuovo ordine, come razionalizza e reinterpreta i processi di rottura: con la famiglia, con il lavoro…e come avviene il contatto con le istituzioni. Nei quindici giorni mi sono accorta che l’intervista non era una cosa fattibile. Alcune persone mi hanno dato la loro disponibilità, ma in concreto, non c’è stata nessuna registrazione. Il tempo a mia disposizione era troppo poco e non potevo certo essere io a dettare alle persone i tempi del racconto della propria vita. Nei giorni successivi, ho continuato ad annotare tutte le mie osservazioni nel quaderno - diario che ho sempre portato con me, partecipando attivamente alla “vita” all’interno delle strutture da me prescelte. La scelta del Boschetto è perché esso non è un dormitorio, ma una comunità dove vi vengono inviate quelle persone con le quali si è impostato un progetto da parte del Centro d’Ascolto, il Gradino e la Treccia perché entrambi sono dormitori di seconda accoglienza, ma una forte differenza li separa, l’uno è un dormitorio maschile, l’altro è femminile. Soprattutto su questa differenza si sarebbe concentrato il mio lavoro al fine di verificare l’ipotesi secondo la quale l’universo femminile racchiude in sé 7 www.sanmarcellino.ge.it. Per quanto riguarda la presentazione delle varie strutture e le rispettive funzioni, dedicherò a tal proposito un capitolo. 8 12 situazioni differenziate di povertà, rispetto a quello maschile. Agli utenti delle varie strutture di S. Marcellino, con i quali ho condiviso gran parte del mio tempo, sono stata presentata nel mio vero ruolo di studentessa che stava compiendo un lavoro di ricerca sulle varie strutture di Accoglienza di cui l’Associazione dispone. Non nascondo che non mi è sempre stato semplice portare avanti il mio ruolo di “osservatore partecipante”. Come spiega Malinowski, “Certi piccoli particolari che fanno impressione fino a che costituiscono una novità non si notano più appena diventano familiari”.9 E spesso è difficile essere osservatore di una realtà alla quale si partecipa, una realtà che mi ha permesso di mettermi in discussione ogni giorno. La mia stessa identità è entrata in gioco; mi stupiva “il pensiero che io non ero per gli altri quel che finora, dentro di me, mi ero figurato d’essere. (…). La scoperta dei centomila Moscarda ch’io ero non solo per gli altri ma anche per me”.10 Ho avuto quindi, soprattutto inizialmente, molte difficoltà ad astrarmi, uscire per un pò fuori dal contesto nel quale ero coinvolta per poterlo osservare. Talvolta poi mi chiedevo se il mio tempo alla Svolta, al Centro d’Ascolto ogni mattina, le cene e le indimenticabili serate nei dormitori, fosse stato abbastanza per essere definito “ricerca”. Spesso mi sono sentita afflitta da un senso di colpa per il fatto di non essermi occupata a riempir schede invece di occuparmi di “futilità”, il dubbio di dover fare molte più domande, di sondare un po’ più a fondo. Il dubbio di non essere abbastanza acuta nelle mie osservazioni…Poi, di colpo, tante cose mi tornavano chiare e, ai sensi di colpa si sostituiva di nuovo l’entusiasmo. Le idee, per quanto riguarda il mio lavoro di tesi, si sono chiarite definitivamente nella mia ultima permanenza di Agosto, in cui ho fatto nove notti quasi consecutive alla Treccia, dormitorio femminile. In quell’occasione il mio ruolo non era più quello della studentessa, ma quello della volontaria. Ruolo che mi ha investito di maggiori responsabilità. Ruolo che mi ha permesso di osservare la struttura da un’altra prospettiva, ruolo che ha fatto in modo che le regole che sono alla base della Treccia mi toccassero più da vicino. Per cui, per non fare troppa confusione, ho concentrato il mio lavoro di ricerca sulla Treccia, dato che, in Italia soprattutto, la letteratura che si occupa di donne senza dimora è esigua, per cui questo è un fenomeno ancora in gran parte da “scoprire”, ancora sommerso e invisibile. “La marginalità femminile d’altronde, viene troppo spesso affrontata in modo assessuato, trattata in secondo luogo, come se una marginalità femminile non esistesse o comunque non fosse così importante da richiedere la giusta attenzione. Nasce così un’emarginazione nell’emarginazione”.11 D., responsabile di S. Marcellino, mi ha fatto notare che alla fine ho scelto di scrivere sulla Treccia, forse perché anch’io sono una donna. Forse… Riassumendo le fasi della mia ricerca, dopo uno studio sul fenomeno dei senza dimora in generale, con particolare attenzione all’emarginazione femminile, ho raccolto personalmente altro materiale, partecipando attivamente e osservando la quotidianità all’interno delle varie strutture, in particolare della Treccia, senza 9 B. Malinowski, Argonauti del Pacifico occidentale. Riti magici e vita quotidiana nella società primitiva, Newton Compton, Roma, 1973 (1922), p. 45. 10 L. Pirandello, Uno, Nessuno e Centomila, Demetra, Varese, 1995. 11 P. Donadi, Emarginazione e invisibilità delle donne senza fissa dimora, Montefeltro, Urbino, 1998, p.182. 13 tralasciare lo scambio di opinioni con i diversi operatori che lavorano all’interno dell’Associazione. Il lavoro di ricerca ha utilizzato quindi come strumento determinante l’osservazione partecipante che mi ha permesso di mettere in evidenza alcuni tratti significativi dell’utenza e, soprattutto, del vissuto quotidiano all’interno della Treccia. Per tutta la durata della ricerca ho avuto rapporti diretti, in prima persona con le ospiti e con i responsabili e gli operatori dell’Associazione che ruotano attorno a queste persone. La presenza quotidiana, il rapporto diretto con le persone, lo scambio di opinione con i vari operatori, la possibilità di osservare e partecipare ad ogni attività, come coordinamenti, riunioni, mi hanno permesso di conoscere la realtà specifica di questa accoglienza. Le osservazioni condotte quotidianamente all’interno della struttura sono state trascritte e raccolte in un quaderno – diario che, successivamente, è stato utilizzato per la lettura del fenomeno oggetto della ricerca. Le schede sociali di tutte le ospiti che sono state presenti nel passato e di quelle che lo sono attualmente, sono state invece il punto d’avvio della mia ricerca sul profilo dell’utenza della Treccia. Nel corso della loro analisi ho fatto costantemente riferimento ai colloqui avuti con il responsabile e i diversi operatori che lavorano all’interno dell’Associazione. Nessuna intervista vera e propria, ad eccezione di una, fatta al responsabile dell’Associazione, sulla “storia” della Treccia. Tutto ciò che ho “raccolto” quindi durante la permanenza a Genova, costituisce il materiale empirico della mia ricerca. Ovviamente la mia tesi tratterà solo una parte di questo materiale. Il mio lavoro di tesi si suddivide in due parti: la prima, se così si può chiamare, teorica, analizza il fenomeno della persona senza dimora in generale; la seconda è concentrata sulla mia permanenza e le mie osservazioni all’interno della Treccia, cercando di evidenziare la specificità della povertà al femminile, di cui ancora sappiamo poco. Il primo capitolo “Le persone senza dimora, analisi generale del fenomeno”, si propone di presentare le diverse ipotesi di lettura del fenomeno e come queste si sono trasformate nel tempo, in seguito ho cercato di delineare, a grandi linee, il percorso della persona senza dimora seguendo la teoria delle micro-fratture. Essa mi ha permesso di introdurre anche il discorso sulla povertà, concetto che nel tempo ha subito notevoli trasformazioni. La teoria delle microfratture tende a mutare radicalmente i concetti comunemente accettati fino ad oggi e le modalità di intervento da essi derivanti. “In passato la condizione di povertà è sempre stata interpretata come un trauma significativo e attinente la società. Questo significava che l’ingresso nello stato di povertà, l’acquisizione dello status di povero e il rientro stesso da una condizione di povertà, erano segnati da avvenimenti comunemente definiti avvenimenti traumatici. L’introduzione della teoria delle micro-fratture tende invece a rovesciare questa concezione, in quanto la caduta in stato di povertà estrema non avviene mai come conseguenza di un avvenimento traumatico (…). Un evento traumatico può condurre alla povertà, ma non alla povertà estrema. Il percorso che conduce alla povertà estrema si rivela molto più lungo, complesso, confuso, disseminato di riassestamenti costanti nei confronti del mondo esterno”12. La povertà estrema quindi costituisce un’area di rottura del sistema della personalità, dei rapporti primari e del senso di appartenenza; “e necessariamente 12 P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995, p.23. 14 richiede che l’intervento sia caratterizzato da un certo grado di inventiva”13. E’ un fenomeno mutevole, sfuggente, dai mille volti e, in un sistema sociale a “differenziazione funzionale”14, sempre più complesso, il paradigma vita/morte15 diviene un passaggio interpretativo essenziale. Il secondo capitolo costituisce una presentazione dell’Associazione S. Marcellino, attraverso una breve analisi delle cinque aree di intervento di cui è costituita, quali il settore alloggiamento, lavoro salute, dipendenze socializzazione. Il terzo capitolo presenta una breve analisi del fenomeno delle “donne senza dimora”, mettendo in evidenza i limiti che ancora si hanno sulla conoscenza di questo fenomeno, in quanto sono ancora pochi gli studi effettuati. Il quarto capitolo è concentrato sulla mia permanenza a Genova, presso l’Associazione S . Marcellino e sulle mie osservazioni all’interno dell’Accoglienza femminile, la Treccia, cercando di costruirne la storia e di metterne in evidenza la singolarità, anche attraverso la ricostruzione del profilo sociologico dell’universo dell’utenza che ha usufruito di questa struttura. La Treccia, infatti, appare ambivalente in quanto, se da un lato si propone come una seconda Accoglienza, dall’altro, alcune particolarità, la fanno avvicinare ad una comunità, senza però averne le basi. Per quanto concerne la quotidianità all’interno della Treccia, si è cercato di concentrare l’attenzione sul rapporto tra le utenti e tra queste e gli operatori, non dimenticando che le donne, con la loro emotività, le loro paure, le loro storie spesso difficili, dolorose, sono le protagoniste della Treccia. Per concludere, non dobbiamo dimenticare che per riuscire a comprendere la persona senza dimora, dobbiamo cercare di liberarci dalla nostra idea di normalità, dobbiamo liberarci da quegli orpelli sociali quali il mondo dei ruoli e delle prestazioni, gli oggetti di consumo, i nomi, le categorie, le aspettative, le ambizioni…, che ci siamo costruiti e concentrarci sulla vita stessa che è il fondo comune che sta in ognuno di noi. “La vita non è una distinzione fra le altre. La vita è l’unica, vera, distinzione. Non ci sono distinzioni tranne quella che stabilisce lo scarto di esistenza fra la vita e la non vita. In particolare, non ci sono distinzioni interne alla vita stessa. Le distinzioni interne alla vita che crediamo di osservare sono solo apparenze, metafore, simulazioni” 16. 13 Ibidem, p.22. N. Luhmann, Struttura della società e semantica, Laterza, Roma-Bari, 1983. 15 G. Piazzi, La ragazza e il direttore, FrancoAngeli, Milano, 1995. 16 Ibidem, p. 39. 14 15 RINGRAZIAMENTI Non posso fare a meno di ricordare e ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnata durante il mio percorso di analisi e riflessione da cui poi è nato questo elaborato finale: Giuliano Piazzi, che per primo ha tracciato e illuminato quel percorso; Danilo De Luise, responsabile dell’Associazione, che mi ha continuamente sostenuta e aiutata, soprattutto nei momenti di sfiducia e di incertezza; Padre Nicola, e tutti gli operatori e i responsabili delle varie strutture dell’Associazione S. Marcellino che hanno contribuito alla realizzazione del mio lavoro con i loro consigli e la loro disponibilità. Un ringraziamento particolare a Gabriele, Luca e Massimo che, più volte, mi hanno accolta nella loro casa, donandomi “calore” domestico. Ringrazio tutti gli utenti e gli ospiti delle varie strutture dell’Associazione che hanno saputo, ognuno a suo modo, farmi sentire continuamente a mio agio; in particolare ringrazio le ospiti della Treccia, che mi hanno accolta nella loro quotidianità all’interno della struttura. Ringrazio Maurizio Bergamaschi che mi è stato di fondamentale aiuto. Infine, ringrazio la mia famiglia per la sua continua presenza e Daniele, insostituibile compagno di vita. 16 PERSONE SENZA DIMORA: ANALISI GENERALE DEL FENOMENO 1. RAPPRESENTAZIONI E TRATTAMENTO DELLA URBANA ESTREMA: UN EXCURSUS STORICO POVERTA’ Vivere con l’altro, abitare con lui lo stesso spazio simbolico, ci mette di fronte alla possibilità d’essere o non essere un altro. L’immagine della sua diversità ci espone alla paura e al fascino d’essere al posto suo, d’essere diversi, anzi assolutamente differenti come lui: come lui sciolti dalla doverosità dell’uno. In gioco, qui, non c’è una semplice, e superficiale, questione morale di tolleranza o rifiuto. In gioco c’è molto di più. Si tratta di sostenere la vista d’un abisso che mette in rischio l’essere Noi. R. Escobar, Metamorfosi della paura. Nel trattare un tema così vasto, come quello della povertà estrema, è importante prendere in esame la questione della povertà urbana in una prospettiva storicosociale. Oggi, come in passato, sono alcuni stereotipi culturali ad influenzare in modo inconsapevole l’opinione comune. “Il trattamento della povertà urbana estrema, nella storia europea degli ultimi secoli, si è modificato e si è strutturato in relazione alle trasformazioni più generali della società, così come le rappresentazioni del fenomeno si sono modificate nello stesso momento in cui l’oggetto povertà estrema si è costituito come tale.”17 La nozione di “povertà urbana estrema” appartiene al lessico contemporaneo, per quanto riguarda il passato dovremo utilizzare termini quali mendicità, ozio, accattonaggio, vagabondaggio, pauperismo, termini che si riferiscono quindi ad un tipo di condotta di vita. Nonostante i termini siano cambiati, essi indicano comunque una realtà simile, la realtà di una popolazione priva di uno statuto definito e socialmente accettato. Nonostante il mutamento delle rappresentazioni e delle forme della presa in carico della povertà estrema, ciò che rimane costante, nel tempo e nello spazio, è la 17 M. Bergamaschi, “Immagine e trattamento delle povertà estreme in una prospettiva storicosociale”, in P.Guidicini, G.Pieretti, M.Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995, p. 41. 17 preoccupazione di delimitare una realtà sociale e umana che appare imprevedibile e priva di contorni. La vista della povertà estrema fa paura perché destabilizza l’immagine dell’ordine sociale costituito. B.Geremek localizzava così il suo oggetto di lavoro: “Noi ci occuperemo di persone o di gruppi che sono rifiutati, o si mettono da se stessi ai margini della vita sociale, non partecipano al processo della produzione e la cui vita resta irriducibile alle norme di comportamento in vigore”18, ma allo stesso tempo, scrive “nella documentazione storica, gli emarginati lasciano poche tracce: non stabiliscono rapporti, non ereditano, non sono eroi di grandi imprese che possano passare alla storia. Sono presenti anzitutto negli archivi della repressione, quindi in un’immagine riflessa dove non appare soltanto la giustizia della società organizzata, ma anche il suo timore e il suo odio. Per questo le informazioni riguardano prima di tutto la società stessa, e solo su un secondo piano quelli che sono oggetti di repressione”19. Per cui, inevitabilmente, in un approccio storicosociale alla questione, l’oggetto non sarà costituito dalla povertà stessa ma dalla sua amministrazione e regolamentazione. Le prime figure di vagabondi e mendicanti sembrano comparire già all’epoca della decadenza di Roma dove, tra guerre e miseria, questo fenomeno trovò l’ambiente idoneo per svilupparsi. Il mondo pagano vedeva i vagabondi come uomini dediti al vizio e all’ubriachezza e, anche se spesso li guardava con simpatia, li riteneva comunque dei malviventi o dei truffatori. Con la diffusione del cristianesimo, la religione dei poveri, la povertà venne presentata come valore spirituale in quanto portatrice di umiltà e di abnegazione. Nel medioevo non vi sono politiche di lotta alla povertà, in quanto era la carità cristiana che si occupava del povero. La Chiesa, infatti, aveva assunto il monopolio del capitale caritativo con la costituzione anche di ordini specializzati deputati alla cura dei malati e degli indigenti. Il povero aveva una propria funzione sociale; infatti si riteneva che egli permettesse al ricco l’accesso al paradiso tramite la carità. A partire dal XI-XIII secolo, in seguito allo sviluppo economico delle campagne e delle città, si ebbe un forte aumento del vagabondaggio costituito non solo da poveri e mendicanti, ma anche da gruppi di religiosi pellegrini e di garzoni itineranti. Il vagabondaggio, infatti, rappresentava anche una forma di apprendistato, un sistema per imparare un mestiere. Tra il 1480 e il 1526 L’Europa fu investita da due crisi che portarono la miseria ad assumere una dimensione di massa: le città e le strade iniziano a popolarsi di mendicanti, vagabondi, prostitute, poveri. Le cause di questo fenomeno di pauperizzazione andavano ricercate soprattutto nelle campagne con la cacciata dei contadini dalle loro terre da parte dei proprietari feudali e la loro trasformazione in operai, ma anche nella crescita demografica e in corrispondenza a questa il succedersi di cattivi raccolti, guerre, epidemie, aumento del costo della vita e della fame. 18 “Nous allons nous attacher à des gens ou des groupes qui sont rejetès,ou se mettent d’euxmèmes en marge de la vie sociale,ne participent pas aux processus de production e dont la vie reste irrèducible aux normes de comportaments en vigeur”, in B. Geremek, Les marginaux parisiens aux XIV etXV siècle, Flammarion, Paris, 1976, p. 98. 19 B. Geremek, La pietà e la forca. Storie della miseria e della carità in Europa, Laterza, Roma, 1998, p.87 18 La crisi che sconvolse la società europea all’inizio dell’età moderna spinse ad un complessivo ripensamento delle categorie e degli atteggiamenti con cui trattare la mendicità. L’immagine del vagabondo venne avvicinata a quella del sovversivo e del criminale. Secondo Geremek20 la grande repressione contro queste fasce sociali viene scatenata all’alba dello sviluppo industriale: con l’industrializzazione, la colpa profonda dei mendicanti diventa proprio la mancanza di lavoro. A partire dalla Riforma, nei territori a dominanza protestante, il nuovo atteggiamento nei confronti dei poveri e mendicanti chiama direttamente in causa le amministrazioni locali e affida loro il compito di una politica sociale che mira al controllo delle frange marginali. Ma non si tratta di un fenomeno legato solo all’etica protestante, il Concilio di Trento assumerà le stesse posizioni, e nel corso del XVI secolo, almeno settanta città europee procederanno ad una riforma della beneficenza pubblica che prevedeva una qualche forma di reclusione dei mendicanti. “L’idea che i poveri dovessero essere segregati dalla società era sorta già alla fine del XVI secolo, ma si diffuse soprattutto nel XVII secolo (…).In tutta Europa inizia la reclusione dei poveri in istituti che sono a un tempo ospedali, case di correzione e talvolta opifici (…). La volontà di segregare i poveri è sostenuta, in quasi tutti i paesi europei, da motivi di fatto e da una corrente di pensiero. I motivi di fatto sono presto detti: i provvedimenti presi nel XVI secolo non hanno fatto sparire la mendicità, anzi, per tutto il ‘600 questa ultima costituisce un problema angoscioso (…). Il carattere ossessivo della miseria nell’Europa del XVI secolo induce alla segregazione dei poveri (…). Le argomentazioni svolte sono sempre simili. Un primo spunto, molto diffuso, consiste nel sostenere che la segregazione ridurrà di molto i rischi di contagio. Seconda opinione, ancor più ricorrente: bisogna segregare gli oziosi per obbligarli a lavorare (…). I sostenitori della segregazione adducono infine argomentazioni morali e religiose. La vita condotta da mendicanti e vagabondi è una vita da pagani. Trascorrono lunghi anni senza accostarsi ai sacramenti; i loro figli non vengono battezzati; si accoppiano in modo casuale, senza contrarre vincoli matrimoniali”21. All’inizio dell’epoca moderna, in conseguenza alle numerose crisi, il numero dei poveri diviene eccessivo per la capacità delle strutture assistenziali di far fronte alla situazione. Inizia così la repressione. “Con il concilio di Trento (1463-1545) assistiamo all’intensificarsi in tutta Europa della repressione contro i vagabondi e i mendicanti. In Italia l’editto del 1561 dello Stato pontificio,considerava reato l’accattonaggio pubblico. Si crearono case per mendicanti, ospedali ed ospizi volti alla rieducazione di queste fasce d’emarginati. In realtà, queste strutture, di fatto, si trasformano in veri e propri carceri e reclusori. Il compito fondamentale era quello di creare le condizioni al reinserimento del povero nella società attraverso l’insegnamento coatto del lavoro.”22 Nel 1601, in Inghilterra, viene approvata la prima Poor Law, la legge i cui principi fondamentali erano la carità e l’ordine pubblico: “La carità inizia a trasformarsi in 20 Ibidem, p. 232. M. Bergamaschi, “Immagine e trattamento delle povertà estreme in una prospettiva storicosociale”, in P.Guidicini, G.Pieretti, M.Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995, p.40 22 P.Donadi, Emarginazione e invisibilità delle donne senza fissa dimora, Montefeltro, Urbino, 1998, p.29 21 19 dovere sociale ponendo così le basi dell’assistenza pubblica. Le chiese e le istituzioni private caritatevoli non sono più le sole ad occuparsi della miseria e della povertà; l’assistenza comincia a diventare un affare di Stato”.23 In epoca moderna si assiste quindi ad una laicizzazione della carità cristiana medievale. Nel corso del XIX secolo il modo di assistere i poveri cambia profondamente: l’intervento tende sempre più a concentrarsi sul povero e ad individualizzarsi; si ricercano le cause strutturali della mendicità tanto che la figura del povero risulta mutata: gli internati sono considerati responsabili della propria condizione. In questo periodo, ciò che viene a modificarsi, in tutti i paesi europei sono i confini che delimitano i diversi tipi di povertà; viene ad approfondirsi sempre più la linea di confine, ereditata dall’epoca moderna, tra poveri meritateveli e poveri non meritateveli, tra classi lavoratrici e classi pericolose, tra povertà operose e povertà oziose. La povertà continua a rimanere una caratteristica propria delle classi popolari, ma alcuni suoi attributi saranno specifici solamente delle sue forme estreme. La condotta di vita dei vagabondi era ritenuta una minaccia all’ordine sociale e quindi soggetta a sanzioni; all’interno del codice sabaudo (1895), i vagabondi erano definiti come coloro che non avevano un domicilio fisso, né mezzi di sussistenza, non avevano un mestiere, girovagavano di paese in paese, erano dediti all’ozio e alla truffa guadagnando sulla credulità altrui. Se inizialmente lo Stato sabaudo mantenne un certo grado di tolleranza nei confronti del vagabondo in quanto si prevedeva l’obbligo di licenza alla mendicità, poi, con la legge n. 5888 del 23/12/1888 sulla Pubblica Sicurezza, si ebbe l’abolizione del permesso di mendicare. Le persone abili al lavoro, sorprese a mendicare venivano punite con l’arresto. Diverso trattamento per gli inabili che venivano ricoverati obbligatoriamente in un istituto di assistenza. L’abilità al lavoro determinava, quindi, un diverso tipo di trattamento. Nella seconda metà dell’Ottocento inizia un approccio categoriale alla povertà. “E’ infatti in questo periodo che emerge una forma d’assistenza specializzata che si differenzia da quella che sarà la previdenza sociale. Mentre la prima sarà espressione della presa in carico, da parte dello Stato, delle situazioni di povertà e deprivazione e sarà riservata a coloro che si troveranno in stato di bisogno dimostrabile, la previdenza sociale sarà rivolta esclusivamente a coloro che partecipano direttamente alla sfera produttiva e cioè a chi detiene lo status di lavoratore”.24 “Quello che si definisce è un modello di cittadinanza fondato sulla quasi totale coincidenza dello status di lavoratore con quello di cittadino”e “questa partizione delle forme di intervento favorisce inoltre il declassamento sociale di coloro che afferiscono all’area dell’assistenza, la loro stigmatizzazione. (…). Ciò che cambia è l’immagine stessa della povertà estrema, o meglio questa si arricchisce di nuovi attributi. L’immagine della povertà urbana estrema, a partire dall’epoca moderna, si arricchisce di nuovi attributi che si sedimentano l’uno sull’altro. Tutte le immagini della povertà urbana estrema sono compresenti in forma stratificata. Le 23 M. Bergamaschi, “Immagine e trattamento delle povertà estreme in una prospettiva storicosociale”, in P.Guidicini, G.Pieretti, M.Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995, p.40. 24 P. Donadi, Emarginazione e invisibilità delle donne senza fissa dimora, Montefeltro, Urbino, 1998, p.31. 20 difficoltà nella lettura della povertà urbana estrema sono in gran parte da attribuire a questa stratificazione di immagini. La figura della povertà urbana estrema ancora oggi rimanda contemporaneamente alla prossimità con Gesù, alla decomposizione delle relazioni sociali, ad una residualità, alla minaccia del ritorno di situazioni di altri tempi.”25 Nella seconda metà dell’800, la scienza medica e psichiatrica in particolare, contribuiscono alla nuova definizione della povertà urbana estrema. La scuola di stampo positivista, in particolare, vede nel vagabondaggio una patologia, ozioso per disposizione innata. Quindi, a partire dall’ottocento non ci si concentra sul fenomeno povertà, vista come costitutiva delle classi popolari, tanto che tra povertà e povertà estrema non vi era differenza di natura, ma ci si concentra sempre più sull’individuo e sulle sue caratteristiche fisiche e psichiche. Nel corso del XIX secolo, le nuove forme di trattamento della povertà e la relativa legislazione, vengono influenzate dal concetto di “pericolosità sociale”. Con la nascita del nuovo codice penale del 1889, il vagabondaggio assume una rilevanza penale e diviene materia di polizia. Il vagabondo è ritenuto un soggetto pericoloso, sia che incorra o no in un reato, è quindi soggetto a provvedimenti, anche se differenziati. “Sta qui l’imposizione al vagabondo di fissare stabilmente la propria dimora, l’internamento del mendicante nel ricovero di mendicità, l’imposizione di un lavoro all’ozioso”.26 Negli ultimi decenni dell’800 si assiste ad una maggiore ingerenza dello Stato nella beneficenza, ambito coperto in precedenza da istituzioni religiose : in Italia, con la legge n.6972 del 17/07/1890, nascono le Istituzioni pubbliche di assistenza e le Congregazioni di Carità che avevano il compito di far fronte alle esigenze delle fasce marginali della popolazione; con questa viene sempre più rafforzata la responsabilità degli amministratori locali. Alla regolamentazione statale dell’assistenza corrisponde una sempre più accentuata categorizzazione dell’utenza titolare del diritto di assistenza: “l’assistenza diventa un diritto categoriale mediante l’istituzione di strutture di ricovero specifiche per utenze specifiche”.27 Lo sviluppo di queste strutture28 avvenne soprattutto nel primo cinquantennio del XX secolo, in particolare nelle regioni con grosse concentrazioni urbane, a conferma del carattere prettamente urbano della povertà estrema. Tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, si definiscono con precisione i presupposti per accedere nell’area dell’assistenza pubblica: 1) lo stato di bisogno, 2) la dimora “Per stato di bisogno si intende una mancanza, anche parziale, di quanto occorre per il benessere fisico, morale ed economico. Ciò comporta un soccorso alle classi meno agiate, agli individui e alle famiglie che si trovano in particolari stati di 25 M. Bergamaschi, “Immagine e trattamento delle povertà estreme in una prospettiva storicosociale”, in P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995, p.48-49. 26 Ibidem, p.53. 27 Ibidem, p.56. 28 Ricordiamo alcuni di questi Ricoveri presenti nel territorio italiano a metà dell’Ottocento: asili notturni, istituti per l’infanzia, istituti per persone anziane,ospedali per cronici, deficienti, inabili e minorati fisici, riformatori, ricoveri per vedove, istituti per donne in gravidanza, ecc. 21 necessità, ai poveri che non hanno i mezzi sufficienti per la loro sussistenza.”29 L’aiuto consiste nella garanzia di un reddito minimo per coloro che ne sono del tutto privi o hanno entrate al di sotto del minimo stesso. Tale misura viene denominata minimo vitale e si rivolge a quei cittadini residenti a reddito insufficiente. In particolare ai senza-casa il diritto all’erogazione dell’assegno del minimo vitale è accompagnato dal dovere di sottoporsi a specifici progetti di integrazione e inserimento sociale. “Per quanto concerne la dimora essa si rifà al concetto di domicilio di soccorso che rappresenta il luogo in cui la persona ha diritto al pubblico soccorso. In pratica il diritto d’accesso all’assistenza è subordinato alle procedure d’assegnazione del domicilio di soccorso che permettono di individuare l’ente che dovrà farsi carico del povero. Il domicilio di soccorso si acquisisce quando la persona ha dimorato per un minimo di due anni nel territorio dell’ente senza notevoli interruzioni. Se non raggiunge tale periodo sarà ritenuta appartenente al comune di nascita. E’utile ricordare anche la norma che riguarda l’obbligo da parte della famiglia di prestare aiuto ai parenti ed affini che si trovino in stato di bisogno.”30 In questo modo però, coloro che non rientrano in una particolare categoria31, non potranno essere presi in carico dall’istituzione pubblica.32Di contro, coloro che invece ottengono le prestazioni assistenziali, si ritrovano stigmatizzati e categorizzati. Così, coloro che non vogliono accettare questo processo di declassamento, rifiutano di rivolgersi al servizio e vivono una condizione di isolamento e di abbandono. “Le due situazioni di cui sopra definiscono un’area di popolazione che, pur vivendo una situazione di deprivazione, rimane esclusa dall’intervento del welfare system. Si può parlare di un’area di non-cittadinanza quale effetto di politiche di welfare rivolte in modo specifico alle persone in condizione di povertà estrema.”33 29 P. Donadi, Emarginazione e invisibilità delle donne senza fissa dimora, Montefeltro, Urbino, 1998, p.32. 30 Ibidem, p.32. 31 Cioè coloro che non hanno una dimora, non hanno familiari tenuti ad alcun obbligo nei loro confronti e vivono uno stato di bisogno difficile da inquadrare. 32 “L’estensione alla povertà estrema dell’approccio categoriale fa di essa una povertà inquadrata, segmentata e istituzionalizzata in categorie corrispondenti alle differenti politiche sociali e alle istituzioni che le gestiscono (…) La categorizzazione delle situazioni di povertà favorisce la cristallizzazione dei percorsi di vita delle persone in condizione di povertà estrema. L’eterogeneità delle situazioni di vita viene ricondotta, quando ciò ovviamente avviene, all’interno di categorie definite per via amministrativa.”, in M. Bergamaschi, “Immagine e trattamento delle povertà estreme in una prospettiva storico-sociale”, in P.Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995, p.66. 33 Ibidem, p.67. 22 2. PERCORSO DELLA PERSONA SENZA DIMORA Dal fondo dell’armadio ho tirato fuori il mio zaino, è sporco. Ogni giorno vi lascio una traccia. Vecchio zaino quante gite abbiamo fatto insieme! E chi di noi due sarà il primo a stancarsi? Ti riempirò stasera e dentro di te deve trovare posto tutto quello di cui avrò bisogno al campo: un paio di sandali, pane per il viaggio, un lenzuolo, la mia amaca, fazzoletti, spago, biancheria, pettine, stoviglie, spazzolino da denti, un pigiama, un asciugamano, il vestito da campo, una federa, una carta della regione, prugne secche per lucciole, cetrioli per scoiattoli, un taccuino, una matita, una saponetta, qualche scherzo per divertire. Mio buon zaino sei pieno e duro come un pallone gonfiato. Sembra che la stoffa debba cedere e spaccarsi sotto la pressione degli oggetti. Ma no! Non cedi, sei solido, ti conosco; domani ti isserò faticosamente sulle spalle e ti appoggerai duro sulla mia schiena e mi farai male per tutto il viaggio, ma non fa nulla, ho bisogno di te, sei il mio vecchio compagno sporco, come sei ti voglio bene e ti voglio così. Renzo B., Il mio zaino Affrontando lo studio di queste nuove marginalità, il primo quesito che ci si pone è se la condizione di senza dimora sia una scelta o una necessità. Come mai alcune persone conducono uno stile di vita che a noi sembra assolutamente disdicevole, sconveniente, scomodo, inconcludente, come mai continuano a rimanere in quella condizione e, ancor più, come mai di fronte ad opportunità più o meno grandi non accolgono l’occasione per invertire la rotta. Dunque la presenza di queste persone nella strada, nello spazio pubblico (metrò, stazioni, giardini) che, visibilmente, non fanno di questo spazio pubblico un uso ordinario e normale, richiamano la nostra attenzione. “Esse utilizzano lo spazio pubblico come uno spazio privato per dormire, preparare e consumare i pasti, per continuare la loro vita sociale, per cercare delle risorse; ci vivono.”18 E’ opinione molto diffusa che la vita del “vagabondo” sia emblema di libertà e di un modo di vita alternativo rispetto a quello tradizionale basato sul lavoro, la casa e la famiglia. L’immagine del “vagabondo” che abbiamo è quella di un ribelle, di colui che sceglie di escludersi dalla società volontariamente per contrapporsi a regole che lo soffocano. “Celati da questo termine, migliaia di individui diventano così invisibili: non potendo essere compresi dalla società civile se non marchiandoli per dissimularli, essi sono occultati dietro un nome che è indice, causa e soluzione morale della loro condizione.”19 Nel termine “barbone” inseriamo così un mondo fatto da persone portatrici ognuna di storie e di vite differenti, un mondo che mettiamo da parte perché ci fa paura, perché stravolge il nostro ordine, le nostre certezze. L’unica spiegazione 18 J. F. Laé, C. Lanzarini, N. Murard, “Tra rotture e perdita del sé: l’homme à la rue”, in P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, Angeli, Milano, 1995, p.75. 19 F. Bonadonna, Il nome del barbone, DeriveApprodi, Roma, 2001, p.18. 23 che ci permette di passare tranquilli per le vie delle città e che ci permette di ignorare queste persone è che la loro sia una scelta. “Tante volte infatti, nel corso del lavoro sul campo, mi hanno chiesto: -Ma non hanno scelto loro di vivere così?- (…) Basterebbe seguire queste persone nei loro percorsi urbani per evidenziare come, con fatica, esse riescano a sopravvivere in un ambiente così duro ed estremo. Parlare di scelta rasenta l’ insulto ed è spesso indice di un malcelato cinismo.”20 Come inizia il percorso nella povertà estrema? Il vivere prevalentemente sulla strada è il punto di arrivo di un percorso lungo e travagliato o la conseguenza di un evento che ha cambiato e segnato in modo indelebile la biografia del soggetto? “La lettura dei materiali biografici sembra confermare, ad un primo sguardo, la seconda ipotesi. Un evento catastrofico (perdita del lavoro, morte di una persona cara, una malattia che interrompe il continuum biografico del soggetto) è sempre presente nei materiali biografici raccolti. L’incapacità di fare fronte a tale evento critico rende insostenibile la riproduzione di comportamenti fino a quel momento dati per scontati. Nelle parole del soggetto, l’evento critico segna un punto di svolta: nulla è più come prima”.21 Questa ricostruzione della rottura biografica, operata dal soggetto, apre altri quesiti. Uno tra questi è come mai persone diverse non reagiscono con le stesse modalità al medesimo evento? Come mai la perdita di un familiare, una malattia grave, la perdita del proprio lavoro o addirittura della propria casa non determinano reazioni e percorsi simili? “La diversa capacità di reagire ad un evento ci costringe ad approfondire l’analisi dei materiali biografici, a leggere, fra le righe, le ricostruzioni ex post operate dal soggetto”22. A.K. Sen, economista indiano, utilizza i termini quali “functioning” e “capability”: i “functioning”, i funzionamenti, sono le diverse condizioni di vita che siamo in grado o meno di realizzare, le “capability”, le capacità, sono le abilità a realizzarle.23 Possiamo dire, quindi, che il problema dei senza dimora non rimanda solo alla mancanza di risorse, ma anche alla capacità di trasformare le risorse. Le persone senza dimora non riescono a trasformare i beni in possibilità di vita. Dobbiamo anche chiederci perché le persone che si trovano in strada danno la colpa della loro situazione ad un solo evento catastrofico. Infatti l’evento che il soggetto pone al centro del suo racconto è una specie di garanzia, per dire “non è colpa mia, è successa quella cosa e io ne sono stato vittima”. In questo modo la persona cerca di mantenere una propria dignità, cerca di conservare la stima di sé. Ma “l’evento che il soggetto pone al centro del suo racconto, e dal quale fa discendere tutta l’ esperienza successiva come una sequenza concatenata di fallimenti in diversi ambiti della vita quotidiana (…), grazie ad una lettura più attenta al contesto biografico e sociale, perde il carattere di evento unico ed eccezionale, e viene ad iscriversi in una esistenza già segnata da diverse rotture. (…). Nei materiali biografici ricorrono quasi costantemente gli stessi eventi, pur strutturati e ordinati in maniera diversa : la perdita del lavoro, la malattia, un grave 20 Ibidem, p.18. M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, p.125. 22 Ibidem, p.125. 23 A. K. Sen, Il tenore di vita.Tra benessere e libertà, Marsilio, Venezia, 1993. 21 24 incidente, il divorzio, la perdita dell’alloggio, il consumo di alcol, ecc. L’inizio della carriera nella strada coincide, per il soggetto, con uno di tali momenti critici : quell’ evento dà origine ad una sequenza nella quale vengono ad iscriversi altre rotture. L’ordine può variare, ciò che rimane costante è la presenza delle diverse rotture.”24 Il concetto di “carriera”25 ci è sembrato pertinente, in quanto questo ci consente di sviluppare un modello sequenziale di analisi della condizione di senza dimora che tenga conto dei cambiamenti nel tempo26.Il concetto di “carriera” mette in risalto l’aspetto evolutivo di una determinata condizione, delle tappe che segnano la biografia del soggetto. “Tale concetto evidenzia inoltre l’esistenza di una logica analitica interna a ciascuna biografia : ciò che risulta incomprensibile in una determinata fase, acquista un senso e una sua necessità all’interno di una carriera. (…) Le tappe della biografia, in questa ipotesi di lettura, risultano concatenate: fattori oggettivi e fattori soggettivi concorrono alla definizione delle scelte del soggetto ”.27 Antonella Meo28ricostruisce la carriera del senza dimora individuando tre tipiche fasi principali, caratterizzate da tratti specifici : 1. La condizione di nuovo senza dimora 2. La fase di adattamento 3. Il senza casa cronico. Quando una persona si trova fuori casa, di solito il suo primo pensiero è di rivolgersi ad un amico o ad un parente che lo ospiti per la notte in via provvisoria oppure di cercare una sistemazione in albergo. Quando l’ospitalità del padrone di casa viene meno o non si ha più denaro per pagare una camera, ci si trova per la prima volta in strada, costretti a pernottare all’aperto, in qualche ricovero di fortuna o in un dormitorio : ha inizio la prima fase della carriera29. “Per arrivare nella strada, è stato necessario abbandonare l’ultimo alloggio, degradarlo, chiuderlo o esserne espulso. L’uomo sulla strada ne ha perso o gettato la chiave. (…) E’ l’ultima rottura. Cio’ che scompare con l’ultimo alloggio sono i mobili, il letto, la sedia, il tavolo, la biancheria, gli utensili della cucina, la porta per separare il dentro e il fuori, è la chiave. L’uomo sulla strada è l’uomo senza chiave.”30 24 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, p.126. 25 Il principale riferimento teorico è Goffman: “Il termine carriera è riservato abitualmente ad un tipo di privilegi goduti da chi progredisce, secondo tappe graduali, in una professione di successo. Si usa tuttavia lo stesso termine, in senso più ampio,per riferirsi ad una sorta di filo conduttore –di carattere sociale- seguito nel ciclo dell’intera vita di una persona.”, in E. Goffman, Asylums, Edizioni di Comunità, Torino, 2001, p.153 26 Per l’applicazione di questa categoria analitica è importante anche lo studio di Becker sulle carriere devianti. 27 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, p.123. 28 A. Meo, “Il senza casa : una carriera di povertà. Osservazione sul campo a Torino”, in Polis, n. 2, 1998, pp. 246-261. 29 Ibidem, p.243. 30 J. F. Laè, C. Lanzarini, N. Murard, “Tra rotture e perdita del sé : l’homme à la rue” in P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995, p.79. 25 2.1. La casa La casa non è solamente uno spazio fisico, ma è soprattutto un luogo di identità. Essa implica e permette l’intimità (il voler restare soli, occuparsi di sé), la socialità (il vicinato) e la domesticità (avere mobili, oggetti, biancheria).31 La “nostra casa” ci evoca sentimenti, immagini, ricordi, sensazioni che in qualche modo ricompongono la nostra identità, rappresenta una nicchia protettiva, generativa. Senza dimora dunque, non vuol dire solo o tanto senza casa, ma assume una valenza semantica più densa : assenza di mura domestiche, ma anche di domicilio, di rifugio, di protezione, di spazio per il sé. In lingua spagnola, non a caso, senza dimora si dice sin hogar (senza focolare). La casa quindi è uno spazio elaborativo, rappresenta il retroscena nel quale vengono praticate le tecniche di gestione e preparazione della scena dove l’ “attore” mostra le proprie abilità sociali.32 “L’alloggio, nel senso fisico, è anche il quadro in cui si iscrivono tutte le rotture (in particolare con la famiglia).”33 2.2. La famiglia “La famiglia è un potente agente di integrazione. Essa tenterà fino alla fine, fino a quando non sarà totalmente sfinita e finchè egli non avrà oltrepassato i limiti dell’inclusione”34. Infatti il “processo di smembramento della famiglia si sviluppa nel tempo: la rottura, l’abbandono e la separazione totale dal nucleo familiare sono figure progressive, ma non necessariamente consecutive. Assestamenti temporanei sembrano preludere ad una ricomposizione della frattura, che effettivamente a volte si produce”.35 Nonostante il legame familiare si interrompa nel momento in cui viene abbandonata la casa, esso sopravvive, è presente nell’intimità della persona che si percepisce ancora come membro di quella famiglia. La perdita della casa e l’allontanamento dalla famiglia, inizialmente, quindi, vengono percepiti come momentanei, temporanei. 31 Ibidem, p. 79. Il riferimento è al modello drammaturgico di Goffman. 33 J. Laè, C. Lanzarini, N. Murard, “Tra rotture e perdita del sé : l’homme à la rue” in P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995, p.79. 34 Ibidem, p.80. 35 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, p.128. 32 26 Il “nuovo senza casa”36inizialmente rivolgerà tutte le sue energie a soddisfare i bisogni primari di sopravvivenza. La sua preoccupazione maggiore sarà quella di reperire un posto dove dormire. La notte, per chi si trova da poco tempo in strada, rappresenta il momento della giornata in cui avverte maggiormente la mancanza di una abitazione e la gravità della propria situazione. Ma la situazione che la persona sta vivendo viene vista come momentanea, per cui egli cercherà un’occupazione che gli possa permettere di reinserirsi nella società e soprattutto di riprendere contatto con la propria famiglia. Questo tipo di senza casa non fa ricorso alle istituzioni di assistenza, cioè all’insieme delle strutture pubbliche e private, in quanto ritiene di poter contare sulle proprie forze, egli è orientato alla società, ai valori e alle norme dominanti e si considera membro della stessa. “Si mostra fortemente proiettato verso il reinserimento nella società e impegnato in progetti di cambiamento in tal senso. Si rappresenta la situazione essenzialmente nei termini della mancanza di una casa e di un lavoro; perciò i suoi progetti prevedono innanzitutto il raggiungimento di tali obbiettivi.”37 Egli tiene molto a sottolineare la sua diversità dagli altri senza tetto e il carattere del tutto temporaneo della situazione in cui si trova. “La visita costituisce un tentativo di riacquistare una posizione in seno al nucleo familiare, di sfuggire alla nuova condizione, di dimostrare quanto i parenti si siano sbagliati sul conto e sulle capacità del soggetto. La visita, in cui è necessario mostrare che non si è caduti troppo in basso, sembra assicurare una continuità nella linea biografica, la preservazione di un legame, già incrinatosi in più punti. Può essere il momento in cui il passato ritorna a galla: quel legame, che sembrava ricucito, in occasione del nuovo incontro, si spezza ancora. L’individuo perde poco a poco la possibilità di fare affidamento materialmente ed affettivamente, sulla famiglia. Questa fase può essere precoce o tardiva: quando la famiglia è stata sfruttata fino all’estremo, quando l’individuo sulla strada è diventato un peso insopportabile, la rottura si compie definitivamente. La famiglia può sopravvivere solo nell’immaginazione e la sua assenza viene vissuta come realtà onnipresente.”38 La famiglia quindi, nonostante sia sempre al centro nella ricostruzione della linea biografica39 e pur rimanendo viva nel ricordo, non potrà più essere un punto di riferimento certo per la persona sulla strada che non potrà più fare affidamento su di essa in una situazione di bisogno. In alcuni casi la rottura viene attuata dal soggetto medesimo: in questo caso sarà affidata alla famiglia la responsabilità della “caduta” nella strada e quindi non vi è 36 A. Meo, “Il senza casa: una carriera di povertà. Osservazione sul campo a Torino”, in Polis n.2, 1998, pp.241-261. 37 Ibidem, p.245. 38 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, p.130. 39 La “linea biografica” rappresenta il percorso della persona senza dimora, le tappe della vita concreta. Si parte da un livello di normalità sociale che viene messa in crisi da una serie di rotture, “una sequenza di rotture biografiche che interessano sia la personalità che il tessuto sociale. Esiste una sorta di soglia che potremmo chiamare area di non ritorno, che contraddistingue l’incapacità-riluttanza di provvedere a se stessi, definibile come processo di decomposizione e abbandono del sé. Quando un individuo oltrepassa questa soglia, significa che egli attacca la propria vita” . P. Guidicini, G. Pieretti, “Introduzione”, in P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995, p.12. Vi è quindi una sorta di ritiro dal mondo esterno. 27 alcuna volontà di ricostruire una relazione con essa, pur in situazioni di bisogno e in presenza di una famiglia che potrebbe intervenire se sollecitata.40 2.3. Il lavoro “Vi è un legame diretto tra la disoccupazione e la povertà, ma non vi è un legame diretto tra la disoccupazione e la strada (…). La perdita del lavoro non conduce sulla strada”41. Anche per quanto riguarda l’ambito del lavoro possiamo parlare di indebolimento delle relazioni: “l’occupazione risulta infatti sempre più precaria, in quanto la persona è sempre meno capace di gestire le relazioni sul luogo del lavoro”.42 La persona sulla strada non ha avuto una carriera lavorativa costante e solida, ma un susseguirsi di impieghi precari e dequalificati. Dopo la scomparsa di queste attività, viene meno progressivamente anche il desiderio di trovare una nuova occupazione. La voglia di “mettersi in gioco” si fa sempre più debole, perché gli insuccessi e le sconfitte cominciano a pesare troppo. “Per essere sulla strada, bisogna che il lavoro sia progressivamente cancellato dall’orizzonte, che cessi di essere il vettore della biografia: la memoria di un lavoro, l’attualità di un lavoro, il progetto di lavorare (…) sono spariti completamente. (…) Egli ha sopportato per questo delle sofferenze immense e ripetute. E’ stato necessario che egli si sforzasse e si battesse per anni. (…) E’ stato necessario che di volta in volta tutto ciò non funzionasse. (…) Restano dei ricordi. E la constatazione di non avere più chances in una società che proclama l’uguaglianza delle opportunità.”43 Se il fallimento comincia ad essere presente su tanti fronti, in tante dimensioni della vita, mano a mano l’individuo comincerà ad adattarsi ad un’altra immagine di sé, comincerà ad evitare i terreni di sconfitta che provocano sofferenza, adottando una specie di “adattamento per rinuncia”44 Attraverso questo meccanismo, l’individuo recede mano a mano dal rapporto con la realtà esterna, chiudendo l’orizzonte delle possibilità e la proprie aspettative di realizzazione. 2.4. La vita in strada “La degradazione dello status prodotta dalla vita sulla strada è una esperienza intensa, che mette a dura prova il soggetto. Il freddo, la fame, la paura, l’impossibilità di nascondersi. Sopravvivere nella strada implica una conoscenza, 40 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999. J. F. Laè, C. Lanzarini, N. Murard, “Tra rotture e perdita del sé: l’homme a la rue”, in P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di ), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995, p.81. 42 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, p.131. 43 J. F. Laè, C. Lanzarini, N. Murard, “Tra rotture e perdita del sé: l’homme à la rue” in P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995, pp.81-82. 44 L. Gui, conferenza a S. Marcellino, Genova, 16-02-2002. 41 28 una energia, un equipaggiamento mentale che mancano alla maggior parte delle persone. Bisognerà ad esempio affrontare la prova della mendicità, accettare quegli sguardi, quella sensazione molto particolare, accettare di istallarvisi.”45 Con l’aumentare del periodo di tempo trascorso in strada, quindi, nella persona si registra una serie di cambiamenti che investono tutti gli ambiti della vita, soprattutto gli aspetti morali della carriera, attinenti al modo in cui il soggetto si vede, percepisce la situazione e la fronteggia.46 “I supporti tradizionali dell’identità tendono dapprima ad indebolirsi, poi a dissolversi definitivamente. Se il loro venir meno priva l’ individuo della sua precedente identità, la nuova vita quotidiana gliene conferisce un’altra.”47 Per quanto riguarda le modalità di sussistenza, chi si trova senza tetto da più tempo, inizia ad elaborare forme di adattamento alla vita di strada in cui nulla è stabile e scontato. Lo spazio pubblico diviene la nuova dimora e per abitarlo la persona deve elaborare strategie attive di adattamento alla nuova realtà. Durante il processo di adattamento la persona, non solo modifica il proprio corpo, ma anche le proprie abitudini culturali. Viene a mancare la separazione tra sfera pubblica e sfera privata, è nella strada, nella piazza, nello spazio urbano che entrambe le dimensioni trovano il proprio luogo. Bonadonna48 dice che le persone senza dimora, adattandosi alla strada, compiono e subiscono tre tipi di mutazione correlate tra loro: culturale, fisica e psicologica. La mutazione avviene a livello culturale in quanto queste persone violano i valori e i tabù fondanti la nostra cultura, fra tutti, il valore portante della nostra società, è la produzione economica; altra mutazione è quella del non abitare uno spazio culturalmente inteso e nell’utilizzare uno spazio pubblico come privato. Per quanto riguarda la mutazione fisica, senza una dimora non è possibile una gestione “normale” del proprio corpo, dell’ igiene, della sua cura. Vivendo per strada quindi, il corpo subisce trasformazioni profonde e la stessa percezione dello spazio, del clima, del divenire temporale, cambiano. Il terzo tipo di mutazione è di carattere psichico perché la radicale trasformazione dello spazio esterno provoca una mutazione dello spazio interno, del sé interiore, che in stretta correlazione con lo spazio esterno elabora delle strategie di mutazione in relazione al nuovo ambiente vitale. Le attività quotidiane della persona senza dimora sono organizzate dallo spazio urbano. “I ritmi di vita si strutturano in relazione al carattere pubblico del luogo in cui vive: si sveglia prima che gran parte della popolazione si sia messa in movimento, cammina continuamente per non essere visibile, chiede l’elemosina nei momenti in cui le vie sono molto frequentate o all’uscita dei fedeli da una chiesa, si apparta in luoghi isolati per mangiare.”49 45 J. F. Laè, C. Lanzarini, N. Murard, “Tra rotture e perdita del sé: l’homme à la rue” in P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995, p.84. 46 A. Meo, “Il senza casa: una carriera di povertà. Osservazione sul campo a Torino”, in Polis n.2, 1998, pp.241-261. 47 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, p.133. 48 F. Bonadonna, Il nome del barbone, DeriveApprodi, Roma, 2001. 49 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, pp.134-135. 29 In una prima fase la persona, nonostante viva in strada, vuole nascondere la propria situazione, sottrarsi allo sguardo pubblico. “Nella stazione ferroviaria cercherà di confondersi con i viaggiatori, nella strada con i passanti. (…) La persona deve diventare invisibile.”50 Il senza casa cronico51 elabora un insieme di pratiche opportunistiche di sopravvivenza che gli scandiranno giornalmente il tempo. Le sue destinazioni rispondono principalmente ai bisogni legati alla sopravvivenza. “Le pratiche quotidiane vanno dal reperimento di un posto all’aperto dove riposare o di un nascondiglio sicuro dove tenere le proprie cose, dagli accorgimenti escogitati per accedere a più di una mensa lo stesso giorno, alle varie forme di accattonaggio, all’individuazione di un’osteria dove il vino sia a buon prezzo o di una sala corse dove si possa trascorrere il pomeriggio al caldo senza dare nell’occhio”52. La vita quotidiana, quindi, si organizza con regolarità attorno a ritmi definiti e le pratiche che assicurano la sopravvivenza vengono vissute come routine e consuetudine. “Sulle pratiche di sopravvivenza si struttura progressivamente anche la concezione dello spazio e del tempo. Il senza casa mappa lo spazio urbano in funzione della distribuzione delle risorse istituzionali e non, creandosi ambienti di vita quotidiana alternativi all’abitazione, che presentano tuttavia un minimo di familiarità e di stabilità proprio in virtù del fatto di essere frequentati in modo abitudinario e a cicli ravvicinati. Egli stabilisce infatti i propri itinerari nella città sulla base della localizzazione dei centri del circuito assistenziale, dei <benefattori>, delle osterie in cui si intrattiene a bere, dei giardini pubblici. Una volta definiti, tali itinerari vengono ripercorsi ogni giorno.”53 Con il passare del tempo, “il circuito della sopravvivenza nello spazio pubblico” 54, inizia a mostrare numerose falle: si viene a perdere, progressivamente, la capacità di restare invisibili 55. La persona avverte il processo di stigmatizzazione a cui è sottoposto.56 2.5. Il rapporto con le istituzioni 50 Ibidem, p.137. A. Meo, “Il senza casa: una carriera di povertà. Osservazione sul campo a Torino” , in Polis n.2, 1998, pp.241-261. 52 Ibidem, pp.249-250. 53 Ibidem, p.251. 54 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999. 55 “La visibilità costituisce un fattore fondamentale. Quello che si può dire riguardo all’identità sociale di un individuo in qualsiasi momento della sua giornata e da parte di tutte le persone che lo incontrano ha una grande importanza per lui. La conseguenza di certe rivelazioni fatte al pubblico in generale può essere di poca rilevanza nei contatti particolari, ma in ciascun contatto ci saranno sempre delle conseguenze che, prese cumulativamente, possono essere di grandissima portata.” in E. Goffman, Stigma, Giuffrè, Milano, 1983, pp.52-53. 56 Il concetto di stigma fu introdotto da Goffman il quale sostiene che “(…) elemento comune agli svantaggiati di ogni genere è da identificarsi nell’esistenza dello stigma che tende a collocare l’individuo in una categoria socialmente svalutata”, in E. Goffman, Stigma, Giuffrè, Milano, 1983, p. 62. In concreto questo è un processo di categorizzazione svolto da ogni uomo come mezzo di semplificazione in una società complessa. Lo stigma è quindi espressione di una collocazione aprioristica da parte della società di alcuni individui all’interno di categorie. 51 30 Per istituzioni intendiamo l’insieme delle strutture assistenziali pubbliche e private. Esse rappresentano dei punti di riferimento spazio-temporali nella costruzione della carriera delle persone senza dimora, in quanto vengono ad integrare, in un primo momento, “il circuito personale della sopravvivenza”57. In una prima fase la persona senza dimora sfrutterà quelle risorse che non è in grado di recuperare autonomamente nello spazio pubblico, provenienti dalle istituzioni assistenziali. In seguito, invece, il rapporto potrebbe diventare esclusivo. Si possono quindi ricostruire diverse modalità di fruizione delle strutture assistenziali che corrispondono alle diverse tappe della carriera nella strada. “E’ a questo circuito che chi si trova in condizioni di povertà estrema affida la propria sopravvivenza, ma diverse e variegate saranno le modalità con le quali ciascun soggetto utilizza le risorse presenti. L’osservazione di tali differenti modalità di fruizione (…) suggeriscono che ogni soggetto può collocarsi in modo diverso rispetto (…) alle strutture assistenziali presenti sul territorio”.58 La frequentazione delle strutture assistenziali, per l’uomo sulla strada, “presuppone il superamento di un’altra prova, intensa come la prova della strada, deve accettare la degradazione dei suoi antichi attributi”59per indossare una nuova identità: quella del senza dimora, accettare quindi lo stigma e tutte le conseguenze che esso comporta. “Le strutture di accoglienza che potrebbero far dormire le persone sono tante, ma molta gente che vive sulla strada ha avuto anche un passato e non sempre è stato così malvagio come si crede. E tante volte, pur di non togliersi quel poco di dignità che gli è rimasta, non casca in queste strutture, perché non vuole degradarsi” (Peppe).60 L’avvicinarsi alle strutture assistenziali viene vissuto come una vergogna, una discesa sociale, in quanto chiedere assistenza implica riconoscere la propria incapacità di uscire autonomamente da una condizione problematica. “Il discredito sociale e il sentimento di umiliazione connessi alla presa in carico, non possono essere accettati se non si sviluppa contemporaneamente una rielaborazione simbolica dello statuto di senza fissa dimora, una razionalizzazione e reinterpretazione individuale del senso assegnato alla nuova condizione di assistito”.61 L’assistenza viene così interpretata come un diritto e lo statuto di senza fissa dimora viene giustificato o facendo riferimento ad una malattia o ad una invalidità, o alla crisi economica e alla disoccupazione. La prima richiesta ai servizi quindi, sarà quella di un lavoro o di una sistemazione abitativa in quanto cittadini. Comunque “per giustificarsi nei confronti degli assistenti sociali dei suoi colleghi (o del sociologo) per aver accettato questa identità stigmatizzata il SDF 57 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999. Ibidem, pp.139-140. 59 P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995, p.84. 60 F. Bonadonna, Il nome del barbone, DeriveApprodi, Roma, 2001, p.99. 61 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, p.141. 58 31 tende a distinguersi dai suoi simili più degradati 62, spiega che ha accettato l’istituzione perché lui non vuole diventare come quelli là.”63 La presa di distanza dagli altri ha la funzione di mantenere una propria dignità, di conservazione del sé e di ciò che resta dell’identità sociale precedente e le piccole libertà che la persona si prende all’interno delle strutture hanno anche questa funzione. Queste micro-resistenze con il tempo possono divenire o sempre più marginali, insignificanti, o al contrario si possono rafforzare fino ad allontanare la persona dal circuito dell’assistenza. Si aprono quindi alla persona senza dimora due percorsi: Il primo è quello del rifiuto e dell’abbandono del circuito assistenziale e della scelta quindi di una “carriera nella strada”64, producendo un ulteriore declassamento delle condizioni di vita. Il secondo è dato dall’accettazione, fino in fondo e senza riserve, del nuovo statuto di assistito in quanto senza fissa dimora; in questo modo la persona accetta di entrare a far parte del circuito dell’assistenza e di seguire tutti i suoi percorsi (“fare carriera nell’istituzione”)65. Descriverò a grandi linee il primo percorso in quanto è nella strada che incontriamo l’estremo della povertà urbana, il massimo degrado; per quanto riguarda il secondo percorso, ne parlerò nella seconda parte del mio lavoro. 2.6. Il rifiuto o l’abbandono: il senza casa cronico In questa fase i rapporti con i servizi assistenziali vengono meno. La persona senza dimora non è riuscito a seguire i tempi, le procedure e l’iter burocratico che ne caratterizzano il funzionamento, per uscire dalla sua condizione è costretto a seguire dei percorsi predefiniti e questi per lui non esistono più; e “l’istituzione non può accettare questa cattiva volontà e tutti i segni che l’accompagnano: il corpo segnato, pesante, sporco che emana odori. Non si è cambiato i vestiti da più settimane ed ha rinunciato a farsi regolarmente una doccia in assenza di vestiti di ricambio; il linguaggio è brutale, incoerente, incomprensibile, ripetitivo. Parla forte, molto forte, reclama ciò che gli è dovuto e non comprende perché sarebbe dovuto venire ieri o domani, tutti i giorni sono uguali per lui”66. Per quanto riguarda l’identità, la persona senza dimora, in questa fase, sperimenta una congruenza fra la rappresentazione di sé e l’identità sociale di barbone.67 Egli non si considera più membro della società, né vuole diventarlo. Inizialmente egli 62 “Quando un individuo apprende per la prima volta cos’è che deve accettare come propria condizione, è probabile, ed è il meno che possa succedere, che provi una certa ambivalenza. Infatti, non soltanto gli altri, i suoi compagni di sventura, saranno apertamente stigmatizzati e quindi non trattati come la persona normale che lui crede di essere, ma in più avranno anche altri attributi con cui egli troverà difficile identificarsi.” in E. Goffman, Stigma, Giuffrè, Milano, 1983, p.39. 63 J. F. Laè, C. Lanzarini, N. Murard, “Tra rotture e perdita del sé: l’homme à la rue”, in P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi, Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995, p.85. 64 Ibidem, pp.94-99. 65 Ibidem, pp.84-93. 66 Ibidem, p.88. 67 A. Meo, “Il senza casa: una carriera di povertà. Osservazione sul campo a Torino”, in Polis n.2, 1998, pp.241-261. 32 tenta di ricostruirsi una “nuova” identità, riorganizzando il proprio sé in funzione della “nuova” vita che viene anche definita positivamente come “vita di strada”. A fronte di questa riorganizzazione del sé, tuttavia, mano a mano vengono a perdersi le risorse motivazionali e la capacità di reazione, viene meno la capacità di proiettarsi nel futuro e di prospettarsi dei cambiamenti. “Il tempo biografico perde profondità e si appiattisce su un presente dilatato, sempre uguale a se stesso, e sganciato dal passato e dal futuro”.68 La cronicità è un evento cruciale nella carriera della persona senza dimora. Il processo di cronicizzazione, che si sviluppa secondo una successione di tappe che manifestano progressivamente minori gradi di libertà e margini di uscita, struttura lo stile di vita della persona senza dimora in modo determinante. La possibilità di reinserimento nel tessuto sociale diminuisce mano a mano che aumenta il tempo di permanenza in strada. “La carriera dell’uomo sulla strada raggiunge progressivamente il suo limite, mano a mano che la fatica aumenta. Certi giorni non riesce a mendicare. E’ troppo stanco, non abbastanza pulito, non abbastanza digiuno, non trova più nessuno da cui distinguersi e di cui farsi beffe. Non ha più voglia di guardarsi nelle vetrine dei negozi. Non ha più voglia di scendere nel metrò per scaldarsi. Non ha più un rifugio né l’energia per cercarne uno. (…) Ha raggiunto un punto dove non crede più di poter amare o essere amato, un punto dove questa capacità è in coma avanzato. (…) Ha vinto la sua sofferenza, non la sopporta più. Questo limite è costituito dalla decomposizione del sé che risulta dalla perdita dell’intimità.”69 Il riferimento alla “decomposizione ed abbandono del sé” intende evidenziare un processo di trasformazione profondo, concreto che, passo dopo passo, diviene irreversibile. Questo processo induce un ritiro dal mondo esteriore, ritiro che designa l’”incapacità di fare territorio”70. Gli individui coinvolti, di conseguenza, perdono progressivamente interesse nelle relazioni umane e si allontanano sempre più da ogni tipo di contatto, hanno perso ogni legame comunitario, sono “dèsaffilès”71, il loro sistema psichico è deluso, vuole ritirarsi, fino a lasciarsi morire. Quando l’individuo oltrepassa questa soglia significa che egli attenta direttamente alla propria vita.72 Di povertà estrema, o comunque senza dimora, si muore e si muore presto. 2.7. La gestione del corpo Senza una abitazione non è pensabile una gestione “normale” del proprio corpo, della sua pulizia, della sua cura. “Chi è senza fissa dimora non ha la possibilità di chiudere o aprire, a scelta, un contatto con il mondo esterno (…) mancando la possibilità di interpretare uno spazio tra sé e il mondo, l’io-pelle,-la pelle del bambino alla nascita, unica 68 Ibidem, p.253. J. F. Laè, C. Lanzarini, N. Murard, “Tra rotture e perdita del sé: L’homme à la rue” , in P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995, p.96. 70 J. F. Laè, L’homme a la rue, ètapes et figures de l’abandon, Plan Urbain, Paris, 1993. 71 R. Castel, “De l’indigence à l’exclusion, la desaffiliation”, in Face à l’exclusion, le modèle francais, sous la direction de J. Donzelot, Esprit, Paris, 1992. 72 G. Pieretti, Per una cultura dell’essenzialità, FrancoAngeli, Milano, 1996. 69 33 protezione rispetto all’esterno-ritorna così ad essere il confine ultimo con il mondo stesso.”73 Oltre ad una mutazione di carattere fisico, come abbiamo detto in precedenza, il terzo tipo di mutazione che riguarda chi è senza dimora è di carattere psichico. Per adattarsi al sistema della strada, queste persone compiono delle modificazioni sulla propria psiche in relazione all’ambiente urbano. Psiche e ambiente si condizionano reciprocamente, quindi una mutazione dello spazio esterno provoca una mutazione dello spazio interno, del sé. La modificazione fisica è interconnessa a quella psico-culturale e “per quanto riguarda l’alterazione allucinogena psicofisica dovuta alla deprivazione del sonno vale lo stesso discorso. Il sonno è una necessità per tutti i primati. Chi vive per la strada è costretto a modificare spesso drasticamente le proprie abitudini del sonno con conseguenze a volto molto gravi.”74 La modificazione del sonno, tra i senza dimora avviene per molte ragioni,e la più frequente è la paura di subire violenze. Anche la mancanza di sonno, alla lunga, può provocare la morte. Abbiamo visto che in strada è impossibile mantenere un buono stato di salute; le principali malattie che si possono riscontrare tra le persone senza dimora sono: -malattie dell’apparato respiratorio sia acute, sia croniche con punte elevatissime nel periodo invernale; -malattie psichiatriche, legate all’alcolismo e al disadattamento; -stati carenziali quali dermatosi, ecchimosi sottocutanee, ecc. dovuti ad una alimentazione scorretta; -problemi alla dentatura che contribuiscono ad un deficit nutritivo; -patologie alcol-correlate.75 Comunque, trattare il tema della salute, a proposito delle persone senza dimora, può essere abbastanza difficile dato che i servizi istituzionali deputati alla cura della salute, sono predisposti al soddisfacimento dei bisogni del cittadino “normale”.76 Per cittadino “normale” intendiamo colui che nei ricoveri ospedalieri, dall’accesso a queste strutture fino alla convalescenza, ha la continua assistenza dei familiari e una casa dove possa avvenire il suo recupero. Inoltre, per usufruire del servizio delle prestazioni previsto dal Servizio Sanitario Nazionale, occorre essere appartenenti ad un dato territorio, è necessario possedere una precisa documentazione cartacea ed essere fedeli ai vari appuntamenti previsti dal servizio stesso. Coloro che non dispongono di questi standard, e le persone senza dimora ne sono un buon esempio, non godono dei benefici della sanità pubblica.77 Ma, anche se gli utenti, poi, sono assistiti adeguatamente dai servizi sanitari, le lunghe ore passate all’aperto, una alimentazione scorretta, l’impossibilità di seguire le prescrizioni mediche, e non ultima, la mancanza di una casa, rendono inutili gli sforzi effettuati da servizi stessi. 73 F. Bonadonna, Il nome del barbone, DeriveApprodi, Roma, 2001, pp.157-158. Ibidem, p.165. 75 A. Pagliaccia, “ Le malattie dei poveri”, in AA. VV., Avevo fame, I Martedì, Bologna, 1985, pp.15-23. 76 L. Gui (a cura di), L’utente che non c’è. Emarginazione grave, persone senza dimora e servizi sociali, FrancoAngeli, Milano, 1995. 77 P. Donadi, Emarginazione e invisibilità delle donne senza fissa dimora, Montefeltro, Urbino, 1998. 74 34 Paradossalmente, il corpo, nel quale sono presenti diverse malattie, è l’unica risorsa che le persone senza dimora possiedono, è l’unico luogo nel quale cercare rifugio, è l’unico rifugio alternativo all’eccesso di spazio della metropoli e di visibilità dati dall’essere sotto lo sguardo di tutti. “Non avendo che la pelle, l’io-pelle, essi possono nascondersi occultando ciò che di ultimo e prezioso possiedono, dato che è negata loro ogni tipo di dimensione privata. Oppure possono nascondersi esponendosi alla massima potenza, non lavandosi. La sporcizia è solo il segno dell’avvenuta desocializzazione (…), è bensì anche un modo per coprirsi con il proprio corpo e con tutto quel che può accumulare (…). La sporcizia diventa una maschera, (…). Alcune persone si nascondono sotto una coltre di coperte, anche d’estate, esponendosi così, velate, allo sguardo dei passanti. (…) Quest’autorappresentazione comune a molti senza fissa dimora, è funzionale a coprire la pelle. Un tentativo estremo e disperato di limitare l’incedere del mondo esterno attraverso l’abito. (…) Una protezione tra sé e il mondo”.78 3. QUALE POVERTA’ E se credete ora Che tutto sia come prima Perché avete votato ancora La sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti F. De Andrè, Canzone del Maggio. Parlando di povertà, è necessario chiedersi che cosa si debba realmente intendere con questo concetto. 78 F. Bonadonna, Il nome del barbone, DeriveApprodi, Roma, 2001, p.164. 35 “Il dibattito sociologico sviluppatosi nella seconda metà degli anni settanta intorno alla nozione di povertà in ambito urbano ha ridefinito in profondità il quadro analitico in cui tale concetto veniva ad iscriversi.”79 Le rappresentazioni del fenomeno, che si sono consolidate negli ultimi ottantanovanta anni, si sono arricchite di nuove e spesso contrastanti modelli teorici. Seguendo percorsi di ricerca differenziati, diversi studiosi del fenomeno sono giunti ad una ridefinizione della nozione, che tende ad evidenziare la discontinuità e le rotture intervenute nelle situazioni di povertà urbana emerse negli ultimi anni . Le nuove ricerche empiriche, in particolare quelle su base locale, contribuivano peraltro ad introdurre nel dibattito nuovi elementi di riflessione e di critica ad un approccio consolidato.80 In Italia, la definizione culturale e politica della povertà è andata rapidamente mutando a partire dal secondo dopoguerra e, da un punto di vista storico, bisogna aspettare la fine degli anni sessanta perché si possa ritrovare un nuovo interesse per tale ambito di ricerca. Sarpellon descrive questo passaggio parlando di “povertà ignorata” dell’immediato dopoguerra81, e di “povertà riscoperta” degli anni ottanta. Nel corso degli anni cinquanta e sessanta, i così detti anni dello sviluppo, del “miracolo economico”, del pieno impiego e dell’aumento del potere d’acquisto, sembravano aver reso marginale il fenomeno povertà. Ovviamente non tutti i problemi degli italiani erano stati risolti: due in particolare attrassero l’attenzione delle forze politiche, economiche e sociali: la condizione operaia e il Mezzogiorno. “Disuguaglianza e sottosviluppo presero quindi il posto della povertà non solo nei dibattiti dei partiti e dei sindacati, ma anche nell’allocazione delle risorse. La povertà divenne un problema ignorato e quindi un non-problema. (…). Verso la fine degli anni settanta la parola povertà apparteneva al linguaggio fuori moda e con essa sembrava scomparso anche il problema”.82Nonostante il persistere di forme di disuguaglianza nella distribuzione dei redditi, della ricchezza e delle chanches di vita, si riteneva che le situazioni di povertà potessero essere riassorbite dallo sviluppo economico e sociale del Paese. Parallela e strettamente intrecciata allo sviluppo socio-economico, è l’espansione del sistema di welfare state che si definisce come istanza riparatrice di tutte le situazioni di bisogno. Ma le istituzioni dello stato sociale si sono rivelate storicamente incapaci di affrontare la specificità del problema povertà, proprio perché l’ideologia del welfare ne presupponeva il superamento attraverso interventi automatici e indifferenziati, caratterizzati dalla generalizzazione dei 79 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, p.7. 80 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, p.7. 81 Nel 1953-1954,decisa dalla Camera dei deputati e svolta da una Commissione parlamentare d’inchiesta presieduta da Ezio Vigorelli, attraverso sue delegazioni parlamentari, fu svolta una Inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla. “ Essa intendeva valutare le condizioni di povertà e di miseria in Italia nel dopoguerra e si è articolata in indagini tecniche e in monografie pubblicate in 14 volumi di Atti. (…). Le indagini, che usano i termini di miseria e povertà come intercambiabili, presentava valutazioni quantitative.” (F. Martinelli, “ Studi sulla povertà urbana nelle ricerche sociali e nell’intervento sociale”, in Sociologia urbana e rurale n.35, 1991, pp.11-28. 82 G. Sarpellon, Dalla povertà nascosta alle nuove povertà e oltre, in P. Guidicini, G. Pieretti (a cura di), Le residualità come valore, FrancoAngeli, Milano, 1993, p.301. 36 servizi e dalla omogeneizzazione dell’accesso ad essi83. La “teoria del rientro” e “della soglia”84, che costituiscono le linee guida dell’agire del welfare, definiscono al contempo sia una rappresentazione della povertà, sia un’area dell’intervento sociale : scopo del welfare è l’uscita dei soggetti da un’area marginale per re-includerli nell’area della centralità85. “La circolarità tra la definizione della nozione di povertà che si viene a costruire nel secondo dopoguerra e l’insieme delle pratiche messe in campo per intervenire nella lotta alle situazioni di deprivazione viene ad interrompersi intorno alla fine degli anni settanta, quando la povertà acquista una nuova visibilità come fenomeno sociale e si impone nuovamente come social problem. Nuove ipotesi e nuove metodologie di ricerca cominciano a diffondersi e ad incrinare un approccio consolidato”86. Nel 1977 Giovanni Sarpellon, su una rivista di sociologia militante “Promozione sociale”, trattava della riscoperta della povertà; ad esso viene ad affiancarsi lo studio teorico sulla povertà e le classi sociali di Antonio Carbonaro, Elena Stagni che esplorava in una sua accurata ricerca il “sonno dei poveri” nel dormitorio comunale di Bologna, Renato Cavallaro e Vincenzo Padiglione, legati ad una scuola di servizio sociale romana (Eiss), pubblicavano saggi sulla marginalità e l’emarginazione, in contatto con la scuola di Ferrarotti che esplorava le borgate e i borghetti di Roma, Piero Braghin procedeva ad una accurata ricognizione dei materiali della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla miseria degli anni cinquanta. Oltre a queste ricerche, interveniva ad allargare il dibattito nell’opinione pubblica un “Sondaggio sulla povertà” del Censis, pubblicato nel 1979, il quale segnalava accanto alla persistenza di una povertà tradizionale, anche l’emergere di una povertà legata alla deprivazione di nuovi consumi indotti e di nuove povertà derivanti dalla scarsezza di relazioni sociali.87 “La riscoperta della povertà costituì di per sé una denuncia. Erano chiamati in causa tutti gli artefici dello sviluppo italiano (…).Padronato e classe operaia, partiti di governo e partiti di opposizione per trent’anni avevano ciascuno svolto il proprio ruolo nella trasformazione dell’Italia in un paese a benessere diffuso, senza tuttavia mai rendersi conto che accanto a quello del Mezzogiorno e oltre a quello del proletariato esisteva anche il problema della povertà.(…). Quando un’indagine molto accurata e ricca di documentazione contraddisse la comune credenza della scomparsa della povertà, la prima reazione che si verificò ovunque 83 P. Guidicini, “Considerazioni su di una ipotesi di ricerca empirica”, in P. Guidicini, G. Pieretti (a cura di), Tra marginalità e povertà. Uno studio sulle politiche di intervento pubblico a Ravenna, FrancoAngeli, Milano, 1989, pp.9-11. 84 Ibidem, p.15. 85 “La teoria del rientro (…) che parte dall’ipotesi che ogni intervento deve portare ad un sostanziale recupero (totale o anche solo parziale dei soggetti) è uno dei prodotti più significativi della teoria della centralità. La teoria del rientro ha, in fondo, come sua prospettiva massima il mantenimento di un sistema sociale equilibrato ed efficiente, nell’ipotesi che ogni condizione marginale è un elemento disfunzionale al sistema. Per cui, il massimo del risultato è quello di trasformare situazioni di marginalità inefficiente in condizioni di centralità efficiente”. Ibidem, p.15. 86 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, p. 11. 87 F. Martinelli, “Studi sulla povertà urbana nelle ricerche sociali e nell’intervento sociale”, in Sociologia urbana e rurale n.35, 1991, pp.11-28. 37 fu il netto rifiuto della realtà svelata”88. Sarpellon fa riferimento, nella presente citazione, al Rapporto sulle povertà in Italia coordinato da lui stesso nell’ambito di una grande indagine promossa dalla Comunità economica europea. Il rapporto in Italia (1978-1982) ebbe scarsa collaborazione degli esperti degli istituti previdenziali ed assistenziali. Il metodo di studio e di analisi della dimensione quantitativa della povertà è stato affrontato valutando la differenziazione di consumi famigliari in diverse zone del paese. Il rapporto di Sarpellon individuava una linea della povertà facendo riferimento al metodo già utilizzato in Italia nel 1975 da W. Beckerman89 e il dato di riferimento era stata l’indagine campionaria sui consumi delle famiglie del 1978. Si considerava povera la famiglia di due persone che ha una spesa media per consumi per abitante: ne è risultata una linea della povertà P1; successivamente si è calcolata una seconda linea di povertà in cui si è attribuito alla famiglia tipo di due persone l’ammontare di spesa per consumi che nella LP1 era previsto per una famiglia di tre persone e si è denominata LP2 (o linea di indigenza). Sono state considerate in tutto tre aree di povertà: la prima con uso della sola LP1; la seconda con uso della LP1 nel Mezzogiorno e LP2 nel Centro Nord, considerati equivalenti; la terza con uso della sola LP2. Il metodo consentiva di stabilire che le famiglie povere erano in Italia nel 1978 2.590.000, pari al 15% del totale delle famiglie italiane e diversamente che nell’Inchiesta sulla miseria del 1953 non si affiancano all’indagine statistica condotta con metodo campionario indagini sociologiche dirette, volte a fornire una analisi qualitativa della povertà90. Tale indagine privilegia nella misurazione, l’aspetto economico della povertà, aspetto significativo ma che non esaurisce lo spettro e la complessità del fenomeno; inoltre la definizione di soglie di povertà, come criterio selettivo per la costruzione dell’area della povertà in generale e dell’area della povertà estrema in particolare, si rivela un approccio arbitrario in quanto la soglia viene definita dal ricercatore, legittima in relazione al proprio ambito di ricerca, ma priva di fondamenti oggettivi. Fissare poi una linea della povertà in corrispondenza di una determinata percentuale del reddito pro-capite o della spesa per consumi, anziché di un’altra percentuale, risponde molto spesso ad una opzione di natura politica. Lo spostamento, in alto o in basso, della soglia, anche di pochi punti percentuali, può far variare in modo significativo il numero delle persone in condizione di povertà, o di povertà estrema.91 3.1. Dalla povertà alle povertà estreme Nello studio della povertà estrema un altro approccio si è venuto sviluppando negli ultimi anni. Si tratta di una prospettiva in cui il ricercatore definisce la 88 G. Sarpellon, “Dalla povertà nascosta alle nuove povertà e oltre”, in P. Guidicini, G. Pieretti (a cura di), Le residualità come valore, FrancoAngeli, Milano, 1993, pp.302-303. 89 Il metodo era basato su tre criteri generali: a. omogeneità del tenore di vita delle famiglie; b. equivalenza tra tenore di vita medio e tenore di vita considerato minimo per famiglia tipo; c. differenziazione tra tenore della famiglia tipo e quello delle famiglie di maggiore dimensione. 90 F. Martinelli, “Studi sulla povertà urbana nelle ricerche sociali e nell’intervento sociale” in Sociologia urbana e rurale n. 35, 1991, pp.11-28 91 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999. 38 povertà estrema a partire dai “target group” a cui attribuisce tale condizione (senza fissa dimora, ex detenuti, zingari, immigrati extracomunitari,…). Anche in questo caso l’approccio è arbitrario in quanto se da un lato si definisce la povertà estrema basandosi su “target group” specifici, dall’altro l’iscrizione di un “target group” all’interno della povertà estrema è decisa e operata dal ricercatore medesimo92. Attraverso questo approccio di tipo categoriale, è possibile , o meglio, si vuole rendere possibile l’individuazione immediata e meccanica delle persone che rientrano in un area problematica. In proposito possiamo osservare due percorsi, in parte differenti, ma sostanzialmente convergenti nel definire la povertà estrema in termini categoriali: da una parte alcune istituzioni del welfare system definiscono a priori l’insieme delle categorie globalmente identificabili nell’area della povertà estrema, dall’altra si definisce l’area della povertà estrema in termini residuali: tutto ciò che non rientra nell’area della povertà conosciuta e che non corrisponde all’immagine della povertà consolidata e diffusa, rientra nella categoria povertà estrema93. E quale è poi l’area della povertà conosciuta? Sarpellon sostiene che, nell’impossibilità di negare e di dimenticare la povertà, cosa che si pensava di fare grazie all’intervento del welfare system, la povertà fu trasformata e accanto al sostantivo si aggiunse l’aggettivo “nuova”; in combinazione con questo aggettivo la parola povertà assunse un generalissimo significato metaforico che le permetteva di connotare ogni sorta di problema che per la prima volta si presentava sulla scena o che , essendo problema antico, si presentava con nuove particolarità. Fu così che nuova povertà fu chiamata la tossicodipendenza come la condizione degli handicappati, la solitudine degli anziani come l’emarginazione degli immigrati, la situazione dei giovani in cerca di lavoro come quella degli espulsi dagli ospedali psichiatrici. Ogni espressione di disagio sociale divenne nuova povertà. In questo modo la povertà diviene tutto e niente e non si capisce più che cosa sia94. La prima cosa quindi che diviene necessaria è chiarire di quale povertà si parla. “Quale valenza universale attribuire, oggi, alla nozione di povertà: ecco il primo interrogativo al quale tentare di dare risposta, in presenza di una realtà che sempre più vede differenziarsi la povertà nei paesi ricchi dalla povertà nei paesi poveri ed in presenza di una crescita delle povertà economiche nelle stesse società occidentali. (…). Per questo è necessario tornare alla distinzione tra povertà assoluta e povertà relativa da un lato e tra povertà materiali (spesso chiamate, più o meno propriamente, vecchie povertà) e povertà simbolico-esistenziali (chiamate, più o meno propriamente, nuove povertà).”95 Per quanto riguarda la distinzione tra povertà assoluta e povertà relativa96, molti tra coloro che si occupano della sociologia della povertà, la ritengono ormai 92 Ibidem, pp.20-21. Ibidem, p. 21. 94 G. Sarpellon, “Dalla povertà nascosta alle nuove povertà e oltre”, in P. Guidicini, G. Pieretti (a cura di), Le residualità come valore, FrancoAngeli, Milano, 1993, pp.300-308. 95 G. Pieretti, “Dalla povertà ai poveri”, in P. Guidicini, G. Pieretti (a cura di), Le residualità come valore, FrancoAngeli, Milano, 1993, p.291. 96 Achille Ardigò nel 1988 mette a punto una sorta di quadrante della povertà. Divide le povertà in: - materiali o economiche: assolute o relative; - simboliche-esistenziali: assolute o relative. 93 39 obsoleta,cioè valida soltanto da un punto di vista storico, dando per scontato che, in società moderne, la povertà non possa non essere povertà relativa. Per povertà assoluta s’intende la difficoltà o l’impossibilità di riprodurre la vita biologica; invece parlare di povertà relativa significa sottolineare anzitutto la relatività della privazione, la povertà non è più una nozione autonoma, ma assume valenze residuali e comparative: la povertà sembra tale rispetto a, per rapporto a. Il rapporto viene fatto con la media dei redditi individuali o familiari. L’idea di povertà relativa quindi è un’idea che varia naturalmente da contesto a contesto, da luogo a luogo97. La Commissione di indagine sulla povertà valuta quest’ultima come fenomeno relativo, “(…) cioè la povertà è sempre commisurabile sulla inadeguata capacità di soddisfazione di un complesso di bisogni ritenuti essenziali in un dato periodo storico e in un dato paese. La povertà è pertanto un fenomeno cumulativo e multidimensionale”98. La povertà quindi sia dal punto di vista “economico”, sia dal punto di vista psicologico-percettivo (con segni di debolezza, dipendenza, rassegnazione), viene considerata dalle scienze sociali come uno status sociale99. Ed è proprio questo il punto che Pieretti mette in discussione.100 Poi ancora “parlare di povertà relativa significa anzitutto sottolineare la relatività della privazione, ma questo ha un senso sociologico finchè esistono classi o almeno gruppi sociali relativamente omogenei, finchè esistono quindi rappresentatività sociali e finchè la povertà è sicuramente una idea, e una pratica di vita, squisitamente macrosociologica: nel momento in cui il sistema sociale è sempre meno caratterizzato da distinzioni macro, di classe o di ceto, il ritenere relativa la povertà entra in discussione”101. La nozione di povertà implicita in molti studi e ricerche è ascrivibile al modello teorico parsonsiano102, cioè quello del “sociale dell’equilibrio e della convergenza”103. “Si tratta appunto del considerare la povertà uno status economico, sociale e/o psicologico, qualcosa comunque di fotografabile e descrivibile; se ci si volesse riferire allo schema parsonsiano della gerarchia cibernetica, povero è colui che, dal basso all’alto della stessa gerarchia dei 97 A. K. Sen, “Le ragioni del persistere della povertà nei paesi ricchi”, in P. Guidicini, G. Pieretti (a cura di), Le residualità come valore, FrancoAngeli, Milano, 1993, pp.309-319. 98 Commissione di indagine sulla povertà, La povertà in Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1985. 99 G. Pieretti, Per una cultura dell’essenzialità, FrancoAngeli, Milano, 1996. 100 “Il punto, o meglio il problema teorico è che tuttavia la povertà venga tuttora considerata dalla sociologia come, appunto, uno status sociale, proprio nel momento in cui (in realtà da ben oltre un ventennio) la sociologia stessa si interroga sui concetti, per così dire, unitari come quello di status o condizione sociale, e sulla validità del modello teorico da cui concetti analoghi sono derivati.” in G. Pieretti, Per una cultura dell’essenzialità, FrancoAngeli, Milano, 1996, p.35. 101 G. Pieretti, “Dalla povertà ai poveri: quali implicazioni di politica sociale”, in P. Guidicini, G. Pieretti, (a cura di ), Le residualità come valore, FrancoAngeli, Milano, 1993, p.292. 102 “Pensare la povertà attraverso tale modello significa sì pensare a dimensioni in cui l’ambito economico è prioritario, ma in cui è inoltre presente un meccanismo di interdipendenza e di interscambio per cui, a povertà economica, può fare riscontro povertà a livello di istruzione, povertà nell’accesso ai servizi, ecc.” in F. Martinelli, “Nouve relazioni sociali nuovi bisogni e stato di servizi”, in P. Guidicini, F. Martinelli, G. Pieretti (a cura di), Città e società urbana in trasformazione, FrancoAngeli, Milano, 1985. La povertà è considerata quindi una nozione e una condizione di vita unitaria che attraversa i sottosistemi in cui si dipana la vita di un individuo e di un gruppo sociale: è considerata un fenomeno cumulativo e multidimensionale. 103 G. Pieretti, Per una cultura dell’essenzialità, FrancoAngeli, Milano, 1996, p. 35. 40 sottosistemi, o viceversa dall’alto al basso della stessa: è fatto, vive, si comporta, ha atteggiamenti e credenze da povero”104. Il problema sta sul fatto che, se uno schema di stampo parsonsiano tipico del sociale della convergenza e dell’equilibrio poteva funzionare per descrivere una società a “differenziazione stratificata”105, esso potrebbe risultare, soprattutto per quanto riguarda lo studio della povertà, non esaustivo e non più adeguato per descrivere la realtà di un sociale a “differenziazione funzionale”. Secondo Pieretti, la teoria dell’evoluzione sociale di N. Luhmann, potrebbe essere un punto di riferimento attraverso il quale si potrebbe tentare di sviluppare un nuovo ragionamento sulle povertà. “Se si considerano le moderne società, cosiddette complesse, quelle nelle quali ci troviamo a vivere, come società a differenziazione funzionale, (…) si potrebbe sostenere che teoria e pratica della povertà pertengano sottosistemi diversi (…). Si potrebbe forse parlare di modi della povertà, vale a dire di stati o momenti o condizioni afferenti sottosistemi diversi (non interdipendenti né interpenetranti) all’interno dei quali (…) individui-soggetti e/o gruppi sociali vengono a trovarsi poveri. Uno schema analitico di questo tipo, all’apparenza, semplifica e complica al contempo il lavoro di definizione e di intervento nell’ambito della povertà; lo semplifica perché (…) potrebbe far pensare che i poveri, in quanto tali, come categoria ben definita ed inserita in un quadro di stratificazione sociale non esisterebbero, a rigore, più (…). La complicazione riguarda invece elementi di carattere teorico, pratico-esperenziale, percettivo e, ultimo ma non in ordine di importanza, etico”106 . Infatti la tendenziale “inclusione di tutti in tutti i sistemi di funzione” 107, comporta non soltanto un innalzamento delle aspettative, quanto soprattutto una generalizzazione delle aspettative stesse. Ciò significa che vengono messi in discussione i criteri di inclusione-esclusione, l’accesso di una persona ad un determinato sistema funzionale in una società a differenziazione stratificata. “Ciò perché, per il processo di inclusione, aumenta l’autonomia dei soggetti: essi non appartengono più ad un solo sottosistema, con il quale è sempre più difficile identificarsi, ma si riferiscono a più sottosistemi funzionalmente differenziati” 108. In una società a differenziazione funzionale o complessa 109, quindi, la povertà può difficilmente essere analizzata con linee, soglie, margini. “Oggi la povertà, a livello aggregato, non appare più una condizione unitaria e non più definibile in 104 Ibidem, p. 36. N. Luhmann, Sistemi sociali, Il Mulino, Bologna, 1990. 106 G. Pieretti, Per una cultura dell’essenzialità, FrancoAngeli, Milano, 1996, pp.38-39. 107 N. Luhmann, Struttura della società e semantica, Laterza, Bari-Roma, 1984, cap. I. 108 G. Pieretti, Per una cultura dell’essenzialità, FrancoAngeli, Milano, 1996, p. 54. 109 “La complessità di un’unità indica il fatto che non tutti gli elementi di tale unità possono essere contemporaneamente in relazione tra loro. Complessità, quindi, significa che, per attualizzare le relazioni tra gli elementi, è necessaria una selezione. (…) La complessità può essere osservata in un sistema o nel suo ambiente, o anche nel mondo. (…) Il numero di relazioni astrattamente possibili tra gli elementi di un sistema aumenta in misura esponenziale rispetto all’aumento del numero degli elementi stessi (…). Complessità è il fatto che ci sono sempre più possibilità di quante possano essere attualizzate come comunicazione nei sistemi sociali e come pensiero nei sistemi psichici.” in C. Baraldi, G. Corsi, E. Esposito, Luhmann in glossario, FrancoAngeli, Milano, 1996, p. 65 105 41 termini di fenomeno cumulativo e multidimensionale. Oggi, a rigore, non si potrebbe più parlare nemmeno di povertà al singolare ma, di plurali e differenziate forme di povertà intorno alle quali la città si ridisegna”110. La povertà, in questo modo, non è più leggibile come un fenomeno unitario e macro. Ciò comporta una nuova attenzione al livello micro sul piano metodologico, indispensabile per una lettura del fenomeno ed una ridefinizione della nozione stessa di povertà. “Ad una lettura che privilegiava i fatti macro-sociali ritenuti dominanti nella produzione delle situazione di povertà (pensiamo, ad esempio, ai fenomeni correlati alla rapida industrializzazione del secondo dopoguerra o alle rapide migrazioni dal Sud al Nord del Paese, ai processi di urbanizzazione e alla conseguente formazione delle periferie urbane) si viene a sostituire un approccio attento ad aspetti microcomportamentali, al tenore di vita dell’individuo e alla rete di relazioni in cui questo si trova inserito”111. N. Negri ci dice che la fenomenologia specifica della povertà comporta varie implicazioni anche sul piano dell’elaborazione dei modelli e della definizione dei metodi per l’analisi della povertà. In primo luogo, la piena comprensione del senso di questa fenomenologia e del conseguente significato delle politiche di lotta contro la povertà, implica la definizione di una cornice teorica che faccia costante riferimento ai concetti di formazione sociale, cittadinanza, inclusione ed esclusione sociale. L’analisi dei vincoli, privilegiata dai modelli micro-economici standard del comportamento non è sufficiente per dar conto dei complessi aspetti che caratterizzano le situazioni di estremo disagio: paradossalmente, dunque, proprio quei casi in cui i problemi sembrano più dipendere dalla mancanza di risorse e opportunità. Si può anzi ipotizzare che le sconfitte in merito alla piena comprensione della povertà, le zone d’ombra nelle ricerche su tale problema e nella interpretazione dei risultati raccolti, debbano essere imputate alla persistenza di un approccio esasperatamente economico di analisi, che riduce la questione dei poveri alla questione – pur vera- della loro scarsa disponibilità di beni112. Alla luce dell’esigenza di implementazione del modello micro-economico standard di comportamento, il riferimento all’individuo e alle sue “capacità” di trasformare i beni in possibilità di vita, costituisce, in questo dibattito, un punto di svolta importante nell’ambito della ricerca sulla povertà e della riflessione sulle politiche di intervento. A.K.Sen sottolinea, infatti, che per spiegare la povertà non basta considerare le privazioni di alcune risorse fondamentali: i primary goods, ovvero i beni “principali”. La capacità di una persona a convertire i primary goods in varie cose di cui ha bisogno per non essere povero, dipende da circostanze che non sono quindi pienamente caratterizzate dai primary goods medesimi: “per affrontare il tema della persistenza della povertà nei paesi ricchi è necessario partire da un problema basilare concernente la natura della povertà. L’approccio tradizionale alla definizione della povertà è unicamente in termini di reddito: al di sotto di un certo livello di reddito si è poveri, mentre, al di sopra di questo, si è al di là di 110 G. Pieretti, “Povertà estreme e povertà silenziose: il ruolo dei processi urbani”, in Sociologia urbana e rurale n. 35, 1991, pp.177-191. 111 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, p. 13. 112 N. Negri, “Storie di povertà e di incapacità”, in Sociologia urbana e rurale n. 35, 1991, pp. 4968. 42 questa condizione. (…). Questo approccio da molti punti di vista non aiuta. (…): una persona può essere molto ricca in Etiopia, ed assai povera, con un reddito equivalente, in un paese occidentale.”113 Le persone, dice Sen, hanno il desiderio di raggiungere certe posizioni, di avere un tipo di vita che potrebbe essere considerato ragionevole; ma anche lo standard di vita socialmente accettabile è in relazione al contesto a cui ci si riferisce. Quindi piuttosto che occuparsi di reddito e di beni Sen sostiene che bisognerebbe concentrarsi sul tipo di vita, “su ciò che Smith stesso definisce functioning”.114 Questi sono ciò che un individuo è o fa e concorrono in modo decisivo a determinare la qualità della sua vita: possono essere rappresentati da un certo livello di istruzione, da una adeguata alimentazione, una determinata condizione abitativa. L’apparato di beni e di redditi necessari per realizzare questi functionings variano da società a società e dipendono da quello che è uno standard di vita accettabile in quella specifica società. Oltre ai functionings, Sen ci dice che è indispensabile considerare le capabilities, cioè le capacità di azione del soggetto, cioè l’abilità del soggetto a realizzare le diverse condizioni di vita. “ L’applicazione di questo approccio ci permette di evidenziare che il possesso di un determinato paniere di beni non assicura meccanicamente e automaticamente una condizione di vita socialmente accettata: il problema si sposta sulla abilità e sulla capacità del soggetto di tradurre il paniere di beni di cui dispone in funzionamenti, sulla conversione dei beni in possibilità. (…). Le capabilities atte a realizzare certi human functionings non costituiscono un dato acquisito e sempre presente nel soggetto: in seguito a determinati eventi, all’interno di un percorso biografico o di fronte a certe situazioni, queste possono scomparire. L’ipotesi che, sulla base del capability approach di Sen, qui si vuole avanzare concerne la possibilità di perdere le capacità in seguito ad una serie di rotture che intervengono in più punti della biografia di un soggetto”115. La perdita delle capacità permette inoltre di spiegare gli scostamenti dell’azione dal classico schema utilitarista mezzi/fini; in questa ipotesi di lettura, infatti, la povertà estrema è l’esito della perdita delle capacità, ma a sua volta, tale perdita-assenza è accentuata dalla condizione di povertà estrema medesima. La condizione di vita caratterizzata dalla povertà estrema costituisce quindi un doppio svantaggio: da una parte, nel possesso delle risorse, dall’altra nel convertire quest’ultime in functinings. “Vi è pertanto una dimensione sociale che concerne la diversa e ineguale distribuzione delle risorse e dei beni all’interno di una popolazione e una dimensione interna relativa alle variazioni interpersonali nella conversione delle merci in capacità”116. Nonostante si sia prodotta una differenziazione all’interno della realtà della povertà, le forme tradizionali persistono e, probabilmente, si diffondono in relazione alle maggiori difficoltà, ad esempio, che si incontrano nell’accesso al mercato del lavoro117, “ma ciò che risulta nuovo è la presenza, all’interno o ai margini dei diversi circuiti della sicurezza sociale di persone e famiglie che, 113 A. K. Sen, “Le ragioni del persistere della povertà nei paesi ricchi”, in P. Guidicini, G. Pieretti (a cura di), Le residualità come valore, FrancoAngeli, Milano,1993, p. 309. 114 Ibidem, p. 310. 115 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, pp. 33-34. 116 Ibidem, p. 35. 117 Commissione d’Indagine sulla Povertà e l’Emarginazione, Secondo rapporto sulla povertà in Italia, FrancoAngeli, Milano, 1992, pp. 48-49. 43 inserite fino ad un determinato momento nella vita sociale e professionale, progressivamente si trovano a confrontarsi con situazioni di precarietà, di disoccupazione e di vulnerabilità”118. Analizzata quindi in termini generali, la povertà sembrerebbe esigere concettualizzazioni ed interventi specifici rivolti a particolari fasce di cittadini che, se non possono essere definiti “poveri” tout court, sperimentano, almeno per dei tratti della loro esistenza condizioni di povertà sia di tipo quantitativo e quindi economica, sia di tipo qualitativo e quindi di natura esistenziale; condizioni di povertà profonde e degradanti. Da un punto di vista strettamente metodologico, poiché è sempre più difficile stabilire paradigmi generali univoci di definizione della povertà, allora, la categorizzazione dei poveri, quale strumento di comprensione, è posta in crisi. In questo modo salta l’apparato strumentale dell’ideologia forte del welfare state costituito dalle categorie a rappresentanza consolidata e garantita119. Secondo tale ideologia, la povertà è un fenomeno esclusivamente macro, determinato dalla stratificazione sociale e che, proprio per questo motivo, riguarda solo particolari strati sociali. Le categorie, proposte come soluzione al problema dell’intervento, adeguate (forse) ad una società a differenziazione stratificata oggi possono risultare addirittura di ostacolo all’intervento. “Quindi fare riferimento alle categorie, significa operare inadeguatamente rispetto alla complessità, ma anche in modo discutibile rispetto ai diritti di cittadinanza. Infatti le persone che non appartengono alle categorie, se in stato di bisogno, sono ancora più povere: non riconosciute nel loro bisogno dall’ente erogatore di sevizi, non possono beneficiare di alcuno intervento”120. A soluzione di ciò non basta solo un discorso di abbassamento di soglia, di accesso o altro, ma è necessario riflettere di nuovo intorno al concetto di cittadinanza, di comunità e di uguaglianza stessa121. “Oggi pertanto, non è più possibile parlare di povertà al singolare, ma si deve parlare di plurali e differenziate forme di povertà, che spesso si calano all’interno di contesti urbani sempre più indifferenziati e di difficile lettura”122. Proprio perché non è più possibile parlare di povertà al singolare, ci si può legittimamente chiedere se ha ancora una dimensione universalistica la nozione di povertà. E’ necessario quindi ritornare alle nozioni di povertà assoluta e relativa123. Se si considerano i paesi del Terzo o del Quarto mondo, è relativamente semplice trovare una dimensione universalistica: in questi paesi sussistono problemi di nutrimento, di mancato raggiungimento del fabbisogno calorico elementare124. In questo caso è di povertà assoluta che si parla e finchè si parla di povertà assoluta, possiamo dire che nella nozione di povertà c’è una dimensione universalistica. 118 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, p. 13. 119 P. Guidicini, G. Pieretti (a cura di), I volti della povertà urbana, FrancoAngeli, Milano, 1992 (2° ed.). 120 G. Pieretti, Per una cultura dell’essenzialità, FrancoAngeli, Milano, 1996, pp. 66-67. 121 Per quanto riguarda il concetto di uguaglianza, ne riparleremo in maniera più approfondita nei prossimi paragrafi. 122 G. Pieretti, Per una cultura dell’essenzialità, FrancoAngeli, Milano, 1996, p. 67. 123 Ibidem 124 A. K. Sen, “Le ragioni del persistere della povertà nei paesi ricchi”, in P. Guidicini, G. Pieretti (a cura di), Le residualità come valore, FrancoAngrli, Milano, 1993. pp.309-319. 44 Parlare di povertà relativa, invece significa anzitutto sottolineare la relatività della privazione, ma questo ha un senso sociologico finchè esistono classi, finchè quindi esistono rappresentatività sociali. Ma nel momento in cui il sistema sociale diventa sempre meno caratterizzato da distinzioni macro, di classe o di ceto, il ritenere relativa la povertà entra in discussione125. Considerare poi la povertà come povertà relativa rinvia inevitabilmente alla società del welfare state che, in quanto tale, appare oggi superato.126 Pieretti, ci dice infatti che il welfare state è uno strumento equilibratore ed inclusivo connesso ad una società a differenziazione stratificata; strumento che entra in crisi nel momento in cui la forma prevalente della differenziazione sociale è la differenziazione funzionale della società.127 “In una società differenziata funzionalmente, le categorie, su cui l’agire del welfare si fonda, non rappresentano più gli individui, la cui realtà non è più semplificabile tramite appartenenze generiche a gruppi, ma esige di essere capita in termini articolati, contestualizzati e soprattutto non rinvianti al <tipo medio>”128. L’equazione individuo = gruppo che aveva un senso pieno in una società a differenziazione stratificata perde senso in una società a differenziazione funzionale. “La povertà a cui ci si deve riferire è quindi la povertà assoluta129, anche perché riguarda l’individuale e non il sistema sociale”130. Infatti nelle nostre società non è più possibile parlare di povertà come nozione sociologica macro, ma di poveri, “cioè di individui che, per qualsiasi motivo che di volta in volta e caso per caso andrà analizzato, non sono dentro al flusso della nostra società”131. Ritornando alla specificità del fenomeno “povertà urbana estrema”, parlare di povertà estreme, non significa considerare il gradino ultimo e più deprivato delle forme tradizionali di povertà, vuol dire che sono le forme di povertà più disperate, tendenzialmente quelle meno reversibili con interventi di tipo tradizionale; esse fanno parte dell’orizzonte della “desaffiliation”132 e richiedono specifiche politiche di intervento. La povertà urbana estrema riguarda una sequenza di rotture biografiche (microfratture)133 che interessano sia la personalità, sia il tessuto sociale. La “decomposizione e abbandono del sé”, cioè il carattere distintivo della povertà urbana estrema, è connessa con il progressivo ritiro che l’individuo porta a termine nei confronti del mondo esterno, della propria famiglia, degli amici. 125 G. Pieretti, “Dalla povertà ai poveri: quali implicazioni di politica sociale” in P. Guidicini, G. Pieretti (a cura di), Le residualità come valore, FrancoAngeli, Milano, 1993, p.291-299. 126 Ibidem 127 N. Luhmann, Potere e codice politico, Feltrinelli, Milano, 1982. 128 G. Pieretti, “Dalla povertà ai poveri: quali implicazioni di politica sociale”, in P. Guidicini, G. Pieretti (a cura di), Le residualità come valore, FrancoAngeli, Milano, 1993, p.293. 129 A. K. Sen dice in proposito: “in ultima analisi la povertà deve essere considerata primariamente un concetto assoluto, sebbene la specificazione dei livelli assoluti debba essere fatta in modo del tutto differente che in passato. (…). La deprivazione assoluta in termini delle capacità di una persona è in relazione con la deprivazione relativa in termini di beni, redditi e risorse” in A. K. Sen, Risorse, valori e sviluppo, Bollati-Boringhieri, Torino, 1992. 130 G. Pieretti, “Dalla povertà ai poveri: quali implicazioni di politica sociale” in P. Guidicini, G. Pieretti (a cura di), Le residualità come valore, FrancoAngeli, Milano, 1993, p. 293. 131 G. Pieretti, Per una cultura dell’essenzialità, FrancoAngeli, Milano, 1996, pp. 89-90. 132 R. Castel, “De l’indigence à l’exclusion, la désaffiliation”, in Face à l’exclusion, le modale francais, suos la direction de J. Donzelot, Ed. Esprit, Paris. 133 Il concetto di microfratture evidenzia come il processo di isolamento, il quale guida il soggetto attraverso condizioni di progressiva povertà estrema, si produce secondo micro-variazioni che difficilmente vengono percepite sia dal soggetto che dall’esterno. 45 I soggetti in condizione di povertà urbana estrema sono sempre più lontani dai percorsi tradizionali di inserimento sociale distaccandosi progressivamente dalle istituzioni e dal welfare system. Inoltre non vi sono servizi disponibili per coloro che hanno abbandonato ogni relazionalità. Oltre tutto chi è dentro all’ “area del non ritorno” non chiede servizi, non chiede più alcun aiuto a nessuno. Le povertà urbane estreme quindi non sono uno stato quanto piuttosto un processo. “Un processo di rotture biografiche molteplici, che ha un inizio e una fine, il cui presupposto iniziale, tuttavia, è la mancanza della società dentro gli individui (E. Durkheim): questo è uno degli elementi focali delle povertà estreme”134. Altro tratto specifico è costituito dalla sua diffusione: “non vi sono gruppi sociali, fasce d’età, professioni, situazioni familiari, livelli di scolarizzazione, ecc. garantiti sempre e comunque dal rischio dell’impoverimento estremo”135; ed infine, ad una sostanziale omogeneità dei percorsi di impoverimento e nelle situazioni di vita si sta sostituendo una eterogeneità massima136. 3.2.Dalla povertà ai poveri Vita/non vita. Umile distinzione Assoluta, però. L’unica distinzione davvero creativa. G. Piazzi, Il Principe di Casador. Nelle pagine precedenti abbiamo analizzato, evidenziandone la disomogeneità, le varie definizioni di povertà che di volta in volta i vari studiosi hanno elaborato, fino a concludere che, per la definizione della povertà, in quanto fenomeno sociale, non si può prescindere dal contesto in cui è inserita. Essa infatti può trovare una propria definizione solo nella considerazione della forma di differenziazione sociale nella quale emerge. Se assumiamo la prevalenza nel nostro sociale della forma funzionale della differenziazione, allora oggi “non è più possibile, nel nostro sociale, collocare una persona all’interno di un determinato sottosistema”137. Infatti, se consideriamo le moderne società cosiddette “complesse”138, nelle quali ci troviamo a vivere, assistiamo ad una progressiva “inclusione di tutti in tutti i sistemi di funzione”139. Ciò significa che vengono messi in discussione “i criteri di inclusione – esclusione che condizionano, in una 134 G. Pieretti, Per una cultura dell’essenzialità, FrancoAngeli, Milano, 1996, p. 25. M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, p. 25. 136 Ibidem. 137 G. Pieretti, Per una cultura dell’essenzialità, FrancoAngeli, Milano, 1996, p. 53. 138 N. Luhmann, R. De Giorgi, Teoria della società, FrancoAngeli, Milano, 1992. 139 N. Luhmann, Struttura della società e semantica, Laterza, Bari-Roma, 1984, cap. I. 135 46 società a differenziazione stratificata, l’accesso di una persona ad un determinato sistema funzionale”140. Ciò perché, per il processo di inclusione, aumenta l’autonomia dei soggetti: essi non appartengono più ad un solo sottosistema, con il quale è sempre più difficile identificarsi, ma si riferiscono a più sottosistemi funzionalmente differenziati. Il paradigma evolutivo luhmanniano, nel momento in cui il modello parsonsiano utilizzato fino ad oggi più o meno consapevolmente, negli studi sulla povertà, appare in crisi, risulta quindi utile per capire la trasformazione del fenomeno della povertà nel passaggio da una società a differenza stratificata ad una società a differenziazione funzionale; ma, la teoria luhmaniana, applicata all’ambito della povertà, nonostante consenta di compiere molti passi in avanti sul piano analitico, nonché sul piano dell’impostazione delle policies, non permette forse di riscontrare una idea generale della povertà.141 E’ difficile, oggi, trovare un elemento unificante della povertà: “esso, a ben guardare, difficilmente può discostarsi dall’ambito dell’etica (…). E’ solo con un irrobustimento di carattere etico che la teoria luhmanniana dell’evoluzione sociale può risultare praticamente vera, proprio in una società differenziata funzionalmente”142. Il rinvio al modello di G. Piazzi, paradigma vita/morte143, diviene qui un valore primo e imprescindibile che permea ogni altra valutazione, un passaggio interpretativo essenziale dentro ad una realtà in rapido mutamento. “L’essenzialità di questo paradigma scarnifica e riduce all’osso il concetto di povertà ripulendolo e liberandolo da quelle sovrastrutture definitorie che rischiano di confonderci le idee”144. Piazzi riconosce il paradigma luhmanniano nel quale ad un sistema sociale inteso come un “tutto” composto di “parti”, in cui ogni individuo è membro della comunità ed è portatore di norme e valori condivisi, si va tendenzialmente sostituendo una società caratterizzata da un crescente grado di astrazione di quelle rappresentazioni sociali. Ad una “appartenenza” di tipo “socio–culturale”, in cui il livello psichico e sociale si identificano, si sostituisce quindi quella che Piazzi chiama “appartenenza logica”. Ovviamente, così come la differenziazione funzionale è prevalente, ma non esclusiva nel sociale attuale, così pure il passaggio dal tipo “socio- culturale” al tipo “logico” di appartenenza va inteso nella sua dinamicità: non è né lineare né scontato: non c’è un momento definito e ben delimitato nel tempo nel quale si assista all’annullamento della “individualità razionale”. In particolare, Piazzi, mette in evidenza che, nonostante la vita sia un sapere, un “Tutto-idea”, “condizione specifica di globalità, armonia ed equilibrio”145, la società, qualsiasi tipo di società, nel corso della storia, chiede alla vita di non essere se stessa, di non funzionare completamente come intero. “La condizione umana nasce lacerata”146; l’uomo è destinato a soffrire perché, da sempre, “l’uomo è stato destinato ad avere una mente trapiantata dall’esterno” 147. 140 G. Pieretti, Per una cultura dell’essenzialità, FrancoAngeli, Milano, 1996, p. 54. Ibidem, p. 56. 142 Ibidem, p. 56. 143 Si veda G. Piazzi, Teoria dell’azione e complessità, FrancoAngeli, Milano, 1984; G. Piazzi, La ragazza e il direttore, FrancoAngeli, Milano, 1995. 144 P. Guidicini, “Presentazione”, in G. Pieretti, Per una cultura dell’essenzialità, FrancoAngeli, Milano, 1996, p. 12. 145 G. Piazzi, La ragazza e il direttore, FrancoAngeli, Milano, 1995, p. 342. 146 G. Piazzi, Il principe di Casador, Quattroventi, Urbino, 2000, p. 279. 147 G. Piazzi, La ragazza e il direttore, FrancoAngeli, Milano, 1995, p. 318. 141 47 Il sé mentale è opposto al sé bio-psichico; quest’ultimo rappresenta il “modo del tutto particolare ed isolato con cui ciascuno di noi si distingue nei confronti di ciò che precede il formarsi stesso della vita, ossia nei confronti del pre-vitale e prebiologico”148; mentre il sé mentale “nasce e si sviluppa soltanto in una relazionalità con gli altri che è anche, e necessariamente, differenza dagli stessi”1 49 . Più la società è di tipo consistente, più essa sarà in grado di assicurare la solidarietà fra bios e logos. “L’Errore sarà meno palese, i danni minori e minore sarà la sofferenza. Almeno quella conscia”150; Invece, più il sociale151 è allo stato puro, più verrà a mancare questa solidarietà. “L’Errore sarà sempre più palese, i danni sembreranno maggiori e la sofferenza sarà certamente conscia”152. Tornando alla differenza tra “appartenenza socio-culturale” e “appartenenza logica”, il presupposto dell’ “appartenenza socio–culturale” è la relazione di appartenenza che lega le persone ad un determinato contesto socio – culturale; le persone si identificano in quel contesto, sia esso una razza, una cultura, una classe. Per capire cosa s’intende per “appartenenza socio–culturale” è necessario “richiamare l’immagine della società semplice, ritornare cioè alla situazione in cui i segmenti sono ancora chiusi”153. Ritornare all’immagine di una società di tipo “consistente”, capace di dare imprinting e di istruire ogni singolo corpo cervello154: la Comunità. “Il fatto è che, fino ad un certo punto, la singola materia che vive e la comunità non sono affatto mondi estranei fra loro. Appartengono allo stesso codice evolutivo. Alla stessa linea strategica. Entrambe sono incluse nell’ordine della materia e della qualità. In ognuna di loro c’è lo spessore di una memoria storico-evolutiva”155. Tutto questo però finisce; infatti, con l’emergere della differenziazione funzionale, quell’insieme di rappresentazioni sociali, fino allora fortemente condiviso, diviene astratto. “Le pareti diventano permeabili ed i segmenti si aprono”156. La singola materia che vive continuerà comunque ad essere educata da fuori. “Ma adesso è una violenza”157. Vengono quindi a mancare i presupposti strutturali quali l’interfacciamento univoco, inequivocabile, tra sistema specifico e ambiente specifico. “D’ora in poi non c’è più compatibilità. In un senso, c’è la materia che vive e che adesso vuole essere in sé e per sé. In senso opposto e a partire da una Comunità conservatrice, ci sono e ci saranno le varie forme di ciò che vuole ancora trascendere la vita.” 1 58 Causa e scopo della comunità era riprodurre un rapporto organico fra sé e la singola materia che vive. “Poi il declino (…). Interviene una nuova strategia evolutiva. Economia mercantile. Valore di scambio. Capitale. La quantità. (…). 148 G. Piazzi, “Salute e malattia nel quadro della differenziazione funzionale della società: aspetti etici”, in Sociologia urbana e rurale, n. 29, 1989, p. 23 149 Ibidem, p. 22. 150 G. Piazzi, La ragazza e il direttore, FrancoAngeli, Milano, 1995, p. 320. 151 “Il Sociale è generalizzazione. E’ superamento incessante di qualsiasi forma di identità, particolarità, localismo, confine qualitativo. E’ negazione della specificità.”, in G. Piazzi, La ragazza e il direttore, p. 95. 152 Ibidem, p. 320. 153 M. Bosi, Le incerte povertà, FrancoAngeli, Milano, 1992, p. 81. 154 “La società consistente è una società che penetra dentro”, in G. Piazzi, La ragazza e il direttore, FrancoAngeli, Milano, 1995, p. 191 155 G. Piazzi, Il principe di Casador, Quattroventi, Urbino, 2000, pp. 286-287. 156 M. Bosi, Le incerte povertà, FrancoAngeli, Milano, 1992, p. 81. 157 G. Piazzi, Il principe di Casador, Quattroventi, Urbino, 2000, p. 287. 158 G. Piazzi, Il Principe di Casador, Quattroventi, Urbino, 2000, p. 288. 48 Per il Capitale sia il lavoro sia la vita sono ambiente umano da bonificare”159 e il modo con cui lo fa è questo: “rendere astratti sia il lavoro sia la vita. Cioè rendere entrambi una funzione del plusvalore di quantità”160.Ma la singola vita non ci sta, non vuole essere un ambiente da bonificare, “adesso, la singola vita vuole essere una funzione di sé. In funzione esclusiva di sé, dell’individuale. Sempre meno alla dipendenza di un qualche cosa che sta fuori di lei, e che non è materia che vive. Che è il Sociale”161. Nell’ “appartenenza logica” il livello psichico e il livello sociale sono distinti: da una parte le persone che rientrano nella categoria dello psichico; dall’altra le istituzioni e i gruppi che appartengono alla categoria del sociale; livelli che non sono più “interpenetranti”, in quanto un vuoto irriducibile li separa. Se il livello psichico è irriducibile al livello sociale e se il sociale è ambiente per il sistema psichico (e viceversa), in quanto “sono ambiente l’uno per l’altro”162, il sociale non può più essere determinante per la formazione e lo sviluppo dello psichico, l’unica funzione che si troverà a svolgere sarà di tipo promozionale, cioè non interverrà direttamente, in modo determinante su formazione e sviluppo dell’individualità, ma porterà la persona a ricercare la propria individualità in modo nuovo. Con il passaggio da una funzione formativa ad una funzione promozionale, si assiste al passaggio da una “individualità relazionale”163 ad una “individualità non relazionale”164. Ciò significa che la formazione e lo sviluppo della persona, quale appartenente alla categoria dello psichico, non scaturisce più dalla relazione con il sociale. In questo modo, il sistema psichico può ricercare la propria individualità solo nella propria specificità, nel proprio modo di essere vita, distinguendosi da ciò che non è vita . “Nella e con la distinzione che dà origine alla vita, si forma la condizione necessaria per l’autodeterminazione nella crescita di ciascuna singolarità. Anzi: la distinzione è questa stessa condizione. In base a ciò, la vita possiede in Sé la competenza a replicarsi proprio in quanto distinzione, come dislivello forte, di Valore. Per mutare o per evolvere, la vita non ha alcun bisogno di informazioni determinative provenienti dall’esterno. E non può essere altrimenti perché l’esterno è, a seguito della rilevanza catastrofica propria della separazione, il non essere. La vita ha solo bisogno di Essere quello che lei è già fin dal momento della 159 Ibidem, pp. 297-315. Ibidem, pp. 317-318. 161 Ibidem, p.303. 162 G. Piazzi, “Salute e malattia nel quadro della differenziazione funzionale della società: aspetti etici”, in Sociologia urbana e rurale, n. 29, 1989, p. 35. 163 La relazionalità propria di una società consistente, è una relazionalità forte. “Relazionalità consistente vuol dire che, negli incontri (scambio) o nei contatti empirici, reali, quotidiani fra vite dove altrimenti regnerebbe l’incertezza della doppia contingenza, il cervello (già orientato alla specificità per via dell’imprinting ad opera delle differenze di valore) riesce invece a darsi un sé della mente, ad attenuare tale incertezza e a darsi una specificazione concreta (non più soltanto un orientamento alla specificità). E questo succede perché, attraverso quegli incontri e contatti fra vite, il cervello riesce ad elaborare i conseguenti input in modo tale da registrare sui suoi nastri chimici dei confini di valore più precisi, che gli consentano, poi, di osservarsi empiricamente come diversità in più e in meno rispetto ad altri. Sempre, anche nelle circostanze più banali.” In G. Piazzi, La ragazza e il direttore, FrancoAngeli, Milano, 1995, p. 192. 164 “La singola vita è oggi, realtà virtuosa in maniera autonoma. E’condensazione dei valori di specie sia biochimici sia spirituali. Lo è sempre più. Senza avere più dentro di sé il senso dovuto alle differenze interne alla condizione umana.”, in G. Piazzi, Il Principe di Casador, Quattroventi, Urbino, 2000, p. 411. 160 49 distinzione”165. Per cui, ogni individualità, poiché specifica, è inadatta al confronto. L’aspetto da valorizzare si sposta quindi da uno “status funzionale più o meno adatto, alla pura “esistenza”166. L’unico valore positivo possibile è quello dell’esistenza. La vita è tale in quanto si separa dalla non vita, ma, al di là delle specificità della costruzione delle singole individualità, la vita è un’esperienza che riguarda tutti. Ciascuno di noi trova la propria specificità profonda, le proprie qualità più autentiche nella strategia per mantenersi in vita. Si tratta di una strategia particolare, propria di ogni individuo. “Ogni singolarità compie un suo decorso cieco per rendere esplicito l’implicito. Ogni singolarità è, al suo interno, varie unità concrete di vita con le quali la distinzione originaria si autoreplica. Si tratta di una diversificazione all’interno di ciascuna singolarità. Una volta che è sorta in quanto distinzione originaria, ogni singolarità autoreplica, in maniera cieca, tale distinzione secondo modalità interne fra loro diverse. Ogni singolarità si distingue (nasce) e, poi, continua ad autodistinguersi dall’inorganico. Ma, questa autodistinzione assume, all’interno di ciascuna singolarità separata dalle altre, varie modalità tra loro diverse”167. Nello stesso tempo però, ogni persona, elaborando una modalità propria di distinguersi dalla non vita, traccia un collegamento con le altre persone perché “non ci sono distinzioni interne alla vita stessa (…). Per quanto riguarda la vita e le diversità per cui essa è, ne esiste solo una Ed è quella della distinzione vita/ non vita . Una volta consolidatasi, la vita è perchè ci sono diversi modi di essere l’Essere, che così è ogni singolarità”168; ma la differenza fra singolarità appartenenti alla stessa specie è una diversità e non una distinzione. “Non c’è sopravvivenza del più adatto, c’è sopravvivenza dell’adatto, senza più”169. Da ciò emerge allora una nuova concezione di cittadinanza. Nella concezione di cittadinanza elaborata dai “classici”, riferendomi agli autori più noti nell’ambito della sociologia, quali T. H. Marshall, J. Rawls, R. Dahrendorf, che implicitamente si riferiscono al modello di Parsons, la cittadinanza nasce dal giusto equilibrio tra libertà ed eguaglianza. Più precisamente l’eguaglianza per i “classici” è di secondaria importanza rispetto alla libertà. Comunque, anche nella versione più democratica dei “classici”, l’eguaglianza si rende tale nelle “pari opportunità”. Si tratta di una concezione che mira a rendere paritarie le condizioni di partenza, nella convinzione che ogni cittadino abbia capacità e “talenti” non naturali, ma sociali, tali da ottenere eguali risultati. “In altre parole, all’interno di questo approccio, si assume che i cittadini siano tutti egualmente dotati e motivati all’achievement, così come richiesto dal sistema acquisitivo di stampo meritocratico”170. Secondo Piazzi, è la stessa differenziazione funzionale a richiedere una nuova cittadinanza che, secondo lo stesso autore, si realizza nell’ “idea di vita”. “Il paradigma vita/ morte costituisce un nuovo schematismo binario intrinsecamente connesso con lo sviluppo della società ad elevata complessità”171. Questo delinea un progressivo distacco etico e fattuale dal principio della selettività naturale che ha retto in particolare lo 165 G. Piazzi, La ragazza e il direttore, FrancoAngeli, Milano, 1995, pp. 41-42. G. Piazzi, “Salute e malattia nel quadro della differenziazione funzionale della società: aspetti etici”, in Sociologia urbana e rurale, n. 29, 1989, p. 37. 167 G. Piazzi, La ragazza e il direttore, FrancoAngeli, Milano, 1995, p. 45. 168 Ibidem, p. 49-50. 169 Ibidem, p.52. 170 M. Bosi, Le incerte povertà, FrancoAngeli, Milano, 1992, p. 128. 171 G. Pieretti, Per una cultura dell’essenzialità, FrancoAngeli, Milano, 1996, p. 63. 166 50 sviluppo delle società occidentali moderne. Così la differenza ego-alter non assurge a valore, mentre l’unica differenza significativa è quella che distingue la vita dalla morte. Emerge qui chiaramente lo stretto rapporto tra eguaglianza e povertà, dove l’eguaglianza è intesa non più come categoria concettuale giuridicoformale, bensì come categoria antropologica: garantire la non povertà in un sociale complesso, significa preoccuparsi della “vita reale” di tutti. Per cui l’intervento orientato ad assicurare la non povertà richiede la comprensione delle differenziate modalità di riproduzione della “vita reale”, cogliere tale diversità, diviene una condizione necessaria affinché siano rispettati i diritti di cittadinanza di tutti, “verso un nuovo universalismo etico”172. Interpretare la povertà, nelle sue molteplici dimensioni, avvalendosi di lenti differenziate, appare coerente con la tutela dei diritti di cittadinanza di tutti, anche delle persone che non rientrano nei schemi precostituiti degli enti assistenziali, così come di coloro che, portatori di visioni del mondo diverse dalla dominante, non si rivolgono ai servizi sociali pur avendone bisogno173. Partire dal paradigma vita/non vita significa quindi partire da ciò che viene prima di ogni sua trasformazione in simboli, concetti, nomi, aspettative, ambizioni, differenze socio-culturali; significa dare valore agli individui concreti, alle storie concrete di vita, alle specificità concrete, ai disagi concreti, in uno ai “fenomeni vivi”174. 172 M. Bosi, Le incerte povertà, FrancoAngeli, Milano, 1992, p. 130. Ibidem, p.130. 174 M. Loiacono, Verso una nuova specie, Edistampa Nuova Specie, Foggia 2000, p. 369. 173 51 L’ASSOCIAZIONE SAN MARCELLINO 1. STORIA E COSTITUZIONE Le origini storiche dell’Associazione si riallacciano all’attività di un padre gesuita, p. Paolo Lampedeosa che, nel 1945, fondò la Messa del Povero, appunto, e scelse di collocarsi nel cuore del Centro Storico Genovese decidendo di aprire la porta della piccola chiesa di San Marcellino in Sottoripa. Un terzo del Centro Storico era stato distrutto durante la guerra, quindi c’erano molte persone rimaste senza casa. In questa piccola chiesa così p. Lampedosa decide di iniziare una sorta di attività di accoglienza, di punto di incontro, per le persone che avevano perso la casa nell’ultimo periodo della guerra. L’opera di p. Lampedosa dal 1963 venne continuata da p. Giuseppe Carena il quale dovette far fronte alle nuove necessità di aiuto ad interi nuclei familiari, per lo più provenienti dall’Italia meridionale in cerca di occupazione, che si erano stabiliti nel centro storico per i bassi costi delle abitazioni. “In questo luogo si sono in qualche modo dato appuntamento le persone in difficoltà della città di Genova per tanti anni, a partire appunto da chi aveva perso la casa durante la guerra, in quanto il Centro Storico di Genova è un po’ il luogo dove vive la gente a basso prezzo, in quanto le case costano poco, sono fatiscenti, sono malridotte, l’ambiente quindi è degradato e tutto questo insieme ha fatto sì che da allora fino ad oggi una grossa fetta del nostro Centro Storico sia ancora occupata da persone che hanno poche risorse. (…)Il Centro Storico è anche il luogo dove le persone che vivono per strada più facilmente si ritrovano perché è un po’ la casa di tutti, è la casa dove tutti possono stare e dove, in fondo, chi sta in disagio ci si può 52 trovare senza essere messo fuori e magari dove può trovare dei piccoli agganci di sopravvivenza attraverso il contatto con la delinquenza di giovani-adulti.”34 L’intervento sviluppato in tutti questi anni ha avuto comunque una matrice tipicamente assistenziale, fornendo prestazioni e servizi tesi talvolta a sopperire all’intervento dell’Ente Pubblico e più spesso ad integrarlo. Accanto a questo impegno assistenziale, però, è sempre stata presente una cultura di attenzione alla persona nella sua globalità, ai suoi valori, alla sua dignità. “(…), c’era un sistema di adescamento molto semplice: era una chiesa dove, al contrario delle altre chiese, dove uno lascia delle offerte, lì si prendeva un offerta, cioè tutti quelli che venivano si prendevano mille lire all’uscita, quindi c’erano quattrocento, cinquecento persone. Era , evidentemente, una impronta vecchiotta di impostazione, di avvicinamento alla gente, ma comunque molto sana dal punto di vista del creare una occasione per incontrare della gente in difficoltà (…). Allora noi siamo partiti un po’ da questo retroterra, che aveva dietro tutta una serie di altre cose, per focalizzare la nostra attenzione su questo scenario di tanta gente e abbiamo deciso nell’86 appunto, fine ‘86, di concentrarci sulle persone che stavano per strada e quindi abbiamo cominciato per uno, due anni a fare un lavoro di filtro e di conoscenza, di ascolto, di avvicinamento un pochino più a stretto contatto con le persone che vivevano lì e cominciando a proporre a queste persone non più le mille lire ma una serie di possibili servizi e opportunità.”35 Dall’’87 ad oggi l’Associazione ha rivolto un’attenzione particolare all’accoglienza e alla comprensione “di quella fascia di persone di cui poco si parla ma che nelle statistiche di oggi e sulle strade delle grandi città occidentali assume una visibilità sempre più rilevante con la sua silenziosa sofferenza: le Persone Senza Dimora”36. Oggi S. Marcellino è una associazione di volontariato, iscritto all’Albo Regionale che si avvale di una ventina di operatori stipendiati e di circa 450 volontari. Dal punto di vista economico si avvale del sostegno di alcuni interventi pubblici anche tramite una convenzione con il comune di Genova per circa il 40% delle uscite; dal ’94 esiste una campagna per il reperimento di Sponsor (privati, gruppi, enti, imprese, etc.) che si impegnano a versare una cifra annuale per creare un fondo slegato dai finanziamenti pubblici spesso precari. Nel luglio ’91 è stata costituita la “ Fondazione San Marcellino “ per creare un ente giuridico cui intestare gli immobili di cui si serve l’Associazione: i locali di via Ponte Calvi, sede della stessa e del Centro d’Ascolto, quelli di Vico Neve sede dell’ “Angolo”, quelli di Vico Guarchi, sede del “Gradino”, l’immobile di Piazza Embriaci, sede dell’ “Archivolto” e quello di Piazza del Campo, sede della “Svolta”, dei “Lavatoi” e di altri alloggi assistiti. (vedi fig. 1) Scopo della Fondazione è inoltre quello di coadiuvare l’Associazione nei suoi compiti formativi e di sensibilizzazione. E’ utile a questo punto riportare alcuni stralci dello statuto che regola l’Associazione: Denominazione e sede 34 P. Alberto Remondini, corso di formazione “Operare con le persone senza dimora”, S. Marcellino, Genova, 19/01/2002. 35 Ibidem. 36 Internet: www.sanmarcellino.ge.it. 53 Articolo1° - E’ costituita l’Associazione “San Marcellino”. Articolo2° - L’Associazione ha sede in Genova, Via al Ponte Calvi 2/4. Finalità Articolo 5° - L’Associazione ha carattere volontario; essa sceglie, nello spirito di fedeltà ai valori cristiani, di prendere le parti, senza preclusione alcuna di razza, nazionalità o professione religiosa, di quegli uomini e di quelle donne che, per ragioni diverse, si trovano nelle situazioni più difficili, quali senza fissa dimora, soli, senza riferimenti di aiuto, privi dei più elementari mezzi di sussistenza, per farsene concretamente carico con diverse forme di intervento – anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati – e nei vari ambiti della vita sociale. Scopo della Associazione è perciò quello di promuovere a livello individuale, sociale e spirituale, la dignità umana di queste persone, per aiutarle a rientrare e a partecipare a pieno diritto e con possibilità di espressione al contesto sociale in cui vivono. Ciò comporta l’impegno da parte dei soci di farsi carico delle diverse forme di intervento dell’Associazione curando anche una adeguata formazione personale e sensibilizzazione a vasto raggio mediante possibili ricerche, studi e dibattiti sui problemi e sulle cause che generano il disagio sofferto da queste persone. L’Associazione intende inoltre stimolare gli Enti pubblici e privati interessati affinché operino delle scelte non emarginanti, indicando eventualmente anche soluzioni alternative. L’Associazione non ha finalità politiche né scopo di lucro. L’Associazione potrà utilizzare forme diverse di finanziamenti, pubblici o privati, per il raggiungimento dei propri scopi. FONDAZIONE VOLONTARI ASSOCIAZIONE ASSEMBLEA DI SOCI CONSIGLIO DIRETTIVO PRESIDENTE CONSIGLIO ESECUTIVO DIREZIONE AMMINISTRAZIONE RESP. SERVIZI CONSULTA RESPONSABILI AREA AREA AREA AREA AREA ALLOGGI EDUCAZ. C.D.A. PRONTA ANIMAZIONE LAVORO (fig. 1) 54 ACCOGL. L’Associazione, pur essendo a tutti gli effetti un’associazione di privato-sociale, mantiene un atteggiamento positivo e di integrazione con il welfare locale pubblico. Ciò deriva da un’impostazione che riconosce nei diritti di cittadinanza un elemento nodale da tutelare. Anche le persone senza dimora, ovviamente, vanno considerati cittadini a tutti gli effetti: essi vanno pertanto supportati dall’Associazione, che tuttavia è ben consapevole del ruolo decisivo del sistema pubblico di assistenza quanto alla tutela di cittadinanza delle persone senza dimora. Per cui l’Associazione non vuole sostituirsi al sistema pubblico, ma vuole integrarsi ad esso, in un’immagine di welfare mix e non certo di welfare residuale. 2. IL METODO L’approccio tradizionale alle persone in difficoltà, quello cioè che coglie la persona nel momento apicale della sua crisi e tenta di risolverla nel contingente, dando il buono mensa, l’asilo notturno, il vestito, i soldi, ecc., non viene aprioristicamente rifiutato, ma viene piuttosto integrato dall’intento di avvicinare la persona anche al di là del problema. Questo permette di vedere non la persona senza casa, senza lavoro, ecc., ma semplicemente la persona, con quelle che sono le sue debolezze ed i suoi bisogni ma anche con le sue risorse non mobilitate e a volte addirittura dimenticate. Permette inoltre, attraverso un contatto costante e con modalità diverse, di fare progetti il più possibile personalizzati capaci quindi di cogliere la diversità e la specificità della persona. “Accanto all’approccio più tradizionale, si è andato affiancando quindi il tentativo, sempre meglio delineato, di organizzare interventi che consentissero di riportare queste persone ad una maggiore autonomia e dignità di vita. La continua rilettura dell’esperienza fatta ci ha suggerito come sia fondamentale, nel lavorare con queste persone, non prefigurare al loro posto il cambiamento, non avere una meta da raggiungere attraverso un cammino progressivo e standardizzato, (…), ma porsi in un atteggiamento di continua ricerca”37. La richiesta dell’utente quindi difficilmente risulta aperta ad un'unica interpretazione, ogni situazione è diversa dall’altra, così come lo è ogni persona. “Questo approccio più neutrale, più aperto al cambiamento, meno carico di aspettative (nostre e dell’utente) ci pare permetta di essere più attenti ai bisogni delle persone, più disponibili all’ascolto e consente di liberare meglio le risorse delle persone che incontriamo”.38 Il lavoro di relazione, inteso in questo senso, diventa quindi un lavoro di grande indeterminatezza, per molti aspetti pericoloso per l’operatore in quanto non è difficile cadere nelle trappole dell’estreme polarizzazioni della relazione di aiuto: la collusione e l’invischiamento oppure la delega totale, la rinuncia. “Ci troviamo a lavorare in situazioni nelle quali ogni volta, prima di muoverci, siamo chiamati a fare il punto della situazione, sapendo che le coordinate sono ogni volta diverse. E’ un livello in cui per lavorare bene bisogna essere disposti a lasciare emergere tutte le potenzialità di cui si può disporre, sia quelle tecnico-professionali sia 37 38 www.sanmarcellino.ge.it. Ibidem. 55 quelle più genericamente umane. E’ come se, affrontando situazioni diverse, dovessimo ogni volta accettare di essere diversi dalla volta precedente. Questo richiede la necessità di rimettersi continuamente in discussione”39. Nel lavoro pratico, l’Associazione risponde ai bisogni delle persone secondo proposte su cinque ambiti: - ALLOGGIAMENTO, - LAVORO, - SOCIALIZZAZIONE, - BENESSERE E SALUTE, - DIPENDENZA DA SOSTANZE. Fondamentale è l’azione del CENTRO d’ASCOLTO che opera su due fronti: accoglienza e accompagnamento sociale coadiuvando il percorso delle persone all’interno dei cinque ambiti citati attraverso il lavoro di gruppo con gli operatori degli altri settori. Esistono infatti due coordinamenti settimanali cui partecipano gli operatori delle varie strutture (accoglienze notturne, comunità, laboratori, alloggi, centri diurni…) e del C.d.A., per condividere e discutere il percorso che le persone intraprendono con l’Associazione. Il CENTRO d’ASCOLTO è uno dei servizi più antichi dell’Associazione, una delle prime risposte affiancate ai servizi, il primo passo verso la comprensione del disagio delle persone, il luogo dove si accompagnano con incontri periodici, magari per molti anni. Per quattro mattine alla settimana è aperto dalle 9 alle 12 con la funzione di: - ascolto di chi si rivolge per la prima volta e per i colloqui di chi è già inserito, - prima accoglienza con distribuzione di posta, fotografie, buoni doccia, servizio diurno…Ad ogni nuovo contatto viene compilata una scheda attraverso la quale si ricostruisce l’identità della persona. 2.1.L’alloggiamento Per quanto riguarda l’alloggiamento, oltre alla disposizione di un dormitorio di prima accoglienza: l’ “Archivolto”, capace di ospitare 12 persone, l’Associazione dispone di 5 strutture capaci di dare risposte differenziate. L’ “Angolo”, situato in Vico Neve, quindi al centro storico della città, è una accoglienza notturna di primo livello, capace di ospitare per la notte 8 persone ed aperta tutti i giorni dalle 19:30 alle 8:00; nel servizio, oltre al posto letto, sono compresi una cena serale e la colazione al mattino preparate da volontari. L’accoglienza impegna al rispetto di tre regole quali puntualità, sobrietà e pulizia personale, che vengono verificate con l’ospite al C.d.A. al momento del rinnovo del tesserino che permette l’accesso all’accoglienza per la settimana. Tale rinnovo è subordinato anche alle osservazioni fatte dai volontari e riportate dai responsabili che partecipano al coordinamento settimanale dei servizi. La stessa funzione viene svolta dal “Gradino”, altra accoglienza notturna di primo livello. 39 Ibidem. 56 La “Treccia”è una accoglienza notturna esclusivamente per donne, è situata in via Mylus, piazza Carignano. Al suo interno può ospitare 6 persone e le sue modalità di funzionamento sono analoghe a quelle dell’”Angolo” e “Gradino”. “Queste accoglienze rappresentano un importante spazio in cui, rispondendo ad una urgenza, si comincia a conoscere la persona ed a farsi conoscere, per poter impostare un rapporto più continuativo che vada oltre alla durata prevista del pernottamento che solitamente è stabilita attorno ai tre mesi, rinnovabili a seconda dei casi”.40 Il “Boschetto” è, invece, una comunità, situata in via della Crocetta, che può accogliere 8 ospiti. Vi vengono inviate quelle persone con le quali si è impostato un progetto da parte del C.d.A.. E’ aperto a tempo pieno nei giorni festivi e nei giorni feriali dalle 18:00 alle 8:00. Gli ospiti versano un contributo spese di 15 euro mensili e partecipano alla gestione della casa occupandosi delle pulizie, della stesura della lista spese, della preparazione della cena che consumano insieme. Eventuali proposte o problemi inerenti l’andamento della casa o i rapporti degli ospiti fra loro, vengono discussi settimanalmente durante la riunione di un gruppo gestito dall’operatore responsabile della struttura. Il “Ponte”, anch’esso situato in via della Crocetta, è una residenza comunitaria protetta che ospita fino a 8 persone; “è nata per coloro che non sembrano in grado, dopo un percorso riabilitativo, di condurre una esistenza completamente autonoma e necessitano di sostegni per mantenere la qualità di vita raggiunta e non tornare sulla strada”41; il periodo di permanenza è indeterminato e la gestione della struttura viene affidata agli ospiti, il tutto supervisionato da un direttore che gestisce la struttura. “Lavori di manutenzione e di gestione del quotidiano vengono svolti dagli ospiti prevalentemente al mattino, così come la gestione della cucina e della casa; pranzo e cena sono in comune ma l’elasticità caratterizza questa struttura che non vuole soffocare gli ospiti”42. Gli alloggi assistiti sono appartamenti individuali la cui organizzazione e composizione è modificabile sulla base delle differenti esigenze degli ospiti, secondo il programma concordato con ognuno. La persona in alloggio continua comunque i colloqui al C.d.A. 2.2. Il lavoro L’obbiettivo del settore lavoro è quello di offrire la possibilità di fare esperienze di educazione al lavoro, intendendo con ciò “particolari situazioni in cui le persone dovranno provare a costruire capacità e abitudini che costituiscono la struttura e i vincoli del lavoro: capacità di organizzare il proprio tempo intorno ad un impegno, relazionarsi con i propri pari in una attività strutturata, comprendere la funzione della gerarchia e dell’autorità, gestire situazioni conflittuali”43. L’Associazione ha scelto prevalentemente lo strumento dei laboratori: - pulizie, - lavanderia, 40 www.sanmarcellino.ge.it. Ibidem. 42 Ibidem. 43 www.sanmarcellino.ge.it. 41 57 - manutenzioni, - kambusa. Esiste inoltre la possibilità, dopo un’esperienza proficua nei laboratori, di attivare stage di formazione professionale in azienda mediante lo strumento della borsalavoro. 2.3. Socializzazione Per socializzazione si intendono tutte le attività ricreative organizzate dall’Associazione che permettono, in primo luogo, l’incontro tra le persone. L’appuntamento “storico” è quello della Messa domenicale, ad essa si aggiungono le vacanze estive a Rollieres, le gite e le feste e la “Svolta”, accoglienza pomeridiana aperta tutti i giorni feriali dalle 15:00 alle 18:00, “una sorta di bar analcolico dove le persone possono incontrarsi, giocare e consumare bibite a pagamento. Questa struttura costituisce un importante momento di incontro e rappresenta da una parte uno strumento di osservazione delle modalità relazionali delle persone accolte, dall’altra un’occasione per le stesse persone di conoscere meglio la proposta del Centro senza essere troppo coinvolti”.44 2.4. Salute e benessere L’Associazione dispone di un ambulatorio medico e di una farmacia aperti tutte le domeniche. Altro servizio sono le visite in ospedale per le persone seguite. E’ inoltre prevista la distribuzione di alimenti alle persone che, pur possedendo un alloggio, non sono economicamente autonome. 2.5. Le dipendenze La maggior parte delle persone che entra in contatto con il C.d.A. presenta disturbi di salute psichica e/o fisica e disagi relazionali dovuti all’alcolismo. Per rispondere a tali esigenze l’Associazione si è avvicinata ai Club degli Alcolisti in Trattamento (C.A.T.). I Club, nati nel 1964 a Zagabria e ideati da Vladimir Hudolin, sono comunità composte da un numero limitato di famiglie (al massimo 12) con problemi alcolcorrelati che condividono problemi ed esperienze al fine di maturare un nuovo stile di vita e, in molti casi, consolidare l’astinenza dall’alcol.. Quando il C.A.T. raggiunge le 12 famiglie dà vita ad un nuovo C.A.T. Non vi sono regole fisse salvo la regolare partecipazione, la puntualità e l’astinenza dal fumo alle riunioni (circa h. 1.30, una volta alla settimana). Hodolin era convinto della necessità di affrontare i problemi alcol-correlati attraverso l’approccio ecologico-sociale secondo il quale bisogna difendere la qualità della vita dell’uomo e della comunità. Il programma dei C.A.T. infatti, viene definito psicomedico-sociale in quanto affronta il disturbo alcolismo nei suoi molteplici aspetti 44 Ibidem. 58 dato che le problematiche alcol-correlate sono considerate una conseguenza di diversi fattori, di origine biologica, culturale, psicologica e sociale. D., responsabile dell’Associazione, così descrive l’importanza della collaborazione con i C.A.T.: “L’ incontro con i Club ha segnato, nella storia di S. Marcellino, una svolta importante, perché abbiamo cambiato il nostro punto di vista nel considerare i problemi alcol-correlati, ma, soprattutto, perché siamo cambiati noi, abbiamo incontrato nuovi compagni di viaggio, attivi in altre realtà. Questi incontri hanno creato contaminazioni importanti che hanno arricchito tutti e tutte le rispettive realtà di provenienza” Dal momento che i Club prevedono la partecipazione di tutto il nucleo familiare, difficilmente ciò è stato possibile con i senza dimora poiché nella maggior parte dei casi i loro rapporti con le famiglie sono interrotti o molto complessi. A tal proposito, P. Remondini, sottolinea che “Ci sono anche situazioni nelle quali le persone non riescono a vivere con la vita di un Club (…) se il metodo dei Club è una proposta fatta a famiglie, quando abbiamo a che fare con persone sulla strada, le famiglie normalmente non ci sono (…) qualche volta questo tentativo è stato fatto, però normalmente questo non avviene”45. Così l’Associazione ha cercato un secondo sistema, ossia reperire un accompagnatore al di fuori del Club, per esempio un operatore o un volontario della Associazione stessa. Per gli Alcolisti senza dimora comunque il solo lavoro dei C.A.T., pur importantissimo, non potrebbe essere sufficiente. Questo soprattutto per la mancanza, reale o fantastica della famiglia; mancanza della famiglia intesa non tanto e non solo dal punto di vista anagrafico, quanto sostanzialmente. Oltre tutto “Gli alcolisti senza dimora presentano spesso una tale complessità e multiformità di problematiche che, difficilmente, si possono considerare come un gruppo uniforme di persone. La sofferenza di questi soggetti, dovuta a più fattori e ad esperienze relazionali gravemente disturbate, rende spesso molto complicato l’intervento degli operatori dei nostri centri.(…) Nonostante la nostra pluriennale esperienza non è possibile per gli operatori individuare una traccia sicura, una metodologia che garantisca un’azione efficace e un miglioramento effettivo. Possiamo dire che non esiste una traccia, un modo di agire od un percorso, ce ne sono molti e ciascuno si può adattare con maggiore o minore successo al singolo soggetto in difficoltà”.46 45 46 Progetto europeo “Il sogno di Vladimir”, p. 9 www. sanmarcellino.ge.it. 59 LE DONNE SENZA DIMORA Le donne portano la responsabilità del proprio genere nella situazione di homeless Burt Cohen Le persone sulla strada sono soprattutto di sesso maschile per vari motivi: “1) Nei casi di rottura familiare, è quasi sempre la donna che tiene i bambini. I bambini sono i veri pilastri della famiglia. Essi obbligano la madre a conservare una vita domestica. E’ per questo che la donna sulla strada è anche una donna a cui i bambini sono stati allontanati o sono stati affidati; 2) nella famiglia, la perdita del lavoro ha conseguenze più pesanti per l’uomo che per la donna. L’uomo disoccupato ha più difficoltà a conservare il suo posto nel focolare domestico. Spesso non può avere un alloggio familiare a suo nome perché la prestazioni assistenziali sono tradizionalmente assegnate alla donna; 3) i centri di accoglienza sono più esigenti nei confronti degli uomini, di cui sempre si suppone che non vogliano lavorare e uscire da una tale condizione. Le donne sono più facilmente percepite come vittime. Più deboli, suscitano più facilmente la compassione; 4) infine il degrado femminile non è culturalmente ben accettato. Le donne sanno che nella strada la forza fisica pesa il doppio, sanno che la loro relativa debolezza rispetto agli uomini, ha delle conseguenze due volte più grandi. Esse eviteranno dunque, con tutti i mezzi, di finire sulla strada”.47 Supponendo infatti che la donna sia maggiormente protetta dalla famiglia, poiché i legami con essa permangono con più frequenza e con più continuità rispetto alla controparte maschile, l’aspetto di genere del problema povertà estrema viene 47 J. F. Laè, C. Lanzarini, N. Murard, “Tra rottura e perdita del sé: l’homme à la rue.”, in P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995, p.77. 60 spesso trascurato; e anche se gli studi sulla povertà, sembrano affrontare in maniera asessuata questo tema, non significa che non esista. In Italia, soprattutto, la letteratura che si occupa di donne senza dimora è esigua, per cui questo è un fenomeno ancora tutto da “scoprire”, ancora sommerso e invisibile. Nonostante ciò, negli ultimi anni, sempre più spesso si parla di una femminilizzazione della povertà, intesa come quel “fenomeno per cui le donne costituiscono una porzione sempre più elevata degli assistiti e dei poveri, o, più correttamente, il fenomeno per cui un numero crescente di poveri è oggi costituito da donne”.48 Negli ultimi 20 anni il numero delle donne che si sono ritrovate in una situazione di povertà, è estremamente aumentato. Le cause principali possono essere attribuite all’aumento di famiglie con referente donna, famiglie con redditi inadeguati in conseguenza di divorzi, della morte del coniuge, del pensionamento49. A partire dagli anni Settanta, infatti, grandi mutamenti, hanno determinato situazioni di sempre maggiore vulnerabilità per nuove fasce della popolazione; e dopo gli anni Settanta, si sono verificati una serie di crisi economiche e di processi di ristrutturazione economica che hanno determinato situazioni di maggiore precarizzazione delle relazioni di impiego e una maggiore esigenza di flessibilità lavorativa. Conseguentemente si è verificata una crescita della disoccupazione ed una riduzione, soprattutto per le donne e i giovani, delle possibilità di inserimento lavorativo a carattere stabile.50 Inoltre, la profonda crisi dell’istituzione familiare ha esposto ad un rischio più elevato d’impoverimento la donna in situazione di separazione, divorzio, vedovanza e le ha messe di fronte alla “necessità di riacquisire le capacità professionali e i ruoli sociali irrinunciabili per il loro inserimento nel mercato del lavoro, abilità e capacità perdute nel corso della vita matrimoniale”.51 Rispetto agli uomini, quindi, le donne risultano meno autonome e più fragili in quanto hanno spesso minori capacità professionali e di reddito. Sono le donne, poi, ad avere la responsabilità primaria del carico familiare e dei figli, in conseguenza di una rottura matrimoniale e la difficoltà di trovare un lavoro o la scarsità di reddito va associata anche alla consuetudine maschile di non adempiere agli obblighi del contributo economico a cui ha diritto l’ex coniuge. Quali sono le cause specifiche che portano la donna a vivere in strada? Sembra che il percorso “deviante” della donna sia diverso da quello dell’uomo. Se per quanto riguarda l’uomo, sembra che la via che conduce alla vita di strada sia dovuta a fallimenti nell’ambito lavorativo, a solitudine, a tossicodipendenza ed altro, per la donna, le motivazioni principali, riguarderebbero soprattutto “il fallimento nei ruoli di madre e di moglie unito a problemi individuali radicati nel tempo”.52 48 Commissione d’indagine sulla povertà e l’emarginazione, La povertà in Italia, Rapporto conclusivo della Commissione studio istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Commissione Gorrieri), Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1985, p.145. 49 “Strett-people”, in Italia Caritas, n. 6, giugno 1995, pp.14-21. 50 P. Donadi, Emarginazione e invisibilità delle donne senza fissa dimora, Montefeltro, Urbino, 1998, p.140. 51 Ibidem, p.140. 52 Ibidem, p.149. 61 Una delle cause principali quindi che porta la donna alla vita di strada è la disgregazione familiare e delle relazioni parentali che diviene più determinante se la donna non ha un lavoro, ed è per questo più dipendente dal coniuge. Un altro elemento che sembra riguardare maggiormente la donna, è la maggiore incidenza del disagio psichico, anche se spesso più che di un fattore congenito, sembra si tratti di crisi provocate da problemi esistenziali. Rispetto a quella dell’uomo, comunque, la questione dell’emarginazione femminile, risulta più difficile da interpretare. Anche il fatto che la percentuale femminile sia minore, porta spesso gli operatori ad affermare che l’emarginazione femminile non è grave in quanto “sarebbero proprio la funzione di integrazione svolta nell’ambito della famiglia e la dimensione di vita all’interno della casa a preservare la donna dai rischi che conducono invece l’uomo alla condizione di senza dimora”.53 Questa idea della sfera privata come luogo di protezione, luogo sicuro soprattutto per la donna, non la rende certamente immune da percorsi di emarginazione. Se per tutti la vita in strada è molto difficile e dura da affrontare, per le donne lo è ancora di più, esse “portano la responsabilità del proprio genere nella situazione di homeless”54. In strada “le loro giornate sono caratterizzate dalla fila di attesa per usufruire delle mense, dal trascorrere il loro tempo nei bar o insieme ad altre donne nelle stesse condizioni, a volte affiancandosi ad un uomo per avere maggiore sicurezza e protezione”.55 A volte fra le senza dimora sono presenti giovani donne che, a causa di crisi familiari ed individuali, si trovano senza mezzi di sostentamento. Altre volte sono ragazze fuggite da famiglie disgregate o con patologie gravi a causa di fallimenti di inserimento in istituti o comunità, si sono ritrovate in strada. Quest’ultime hanno in genere problemi di tossicodipendenza o di alcolismo e sono quelle maggiormente soggette a stupri. In particolare, le donne tossicodipendenti, si procurano le sostanze attraverso la prostituzione. “Le donne in questo contesto vivono quindi una situazione di degrado e marginalità derivante sia dal loro stato di tossicodipendenza che di prostituzione, ma anche dalla doppia condanna sociale che viene loro inflitta ( dalla famiglia e dagli stessi tossicodipendenti)”56. Per quanto riguarda le strutture di accoglienza, in particolare dormitori, specifiche per le donne senza dimora, ve ne sono poche e spesso la donna viene delegata ad altri servizi (ospedali psichiatrici, comunità…), in quanto, al contrario dell’uomo, difficilmente viene inserita nella “categoria” senza dimora. Il dormitorio viene vissuto dalla donna in maniera diversa rispetto all’uomo e maggiormente peserà l’assenza di una casa in quanto, “culturalmente”, la donna ne è considerata il fulcro. “Dopo una giornata massacrante passata in strada, la donna arriva al dormitorio “distrutta psicologicamente e moralmente. (…) Sente l’angoscia della giornata appena trascorsa ed il peso di quella successiva. E’ questo un circolo vizioso che porta a desiderare di non pensare, si perde la speranza, la forza di essere 53 M. A. Quiroz-Vitale, “La marginalità dei senza fissa dimora. Riflessioni su alcune forme di emarginazione urbana”, in Marginalità e società, n.26, 1994, pp.122-123. 54 M. R. Burt, B. E. Cohen, “Differences among Homeless Single Women, Women with Children, and Single Men”, in Social Problems, n. 36, 5 December 1989. 55 P. Donadi, Emarginazione e invisibilità delle donne senza fissa dimora, Montefeltro, Urbino, 1998, p.153. 56 Ibidem, p.157. 62 protagonisti della propria vita e di volerla cambiare. Al contrario la malinconia e la voglia di piangere sono sentimenti sempre presenti. (…) Qualora la donna provi a parlare per trascorrere il tempo in modo meno opprimente, viene accusata di leggerezza e molti uomini si prendono libertà mai concesse. (…) Se ogni donna, in generale, affronta questi problemi, a maggior ragione una persona priva di tutto e dipendente totalmente dall’esterno può percepire la propria vita come una vera e propria sofferenza. Deve spendere le proprie energie per sopravvivere e ciò non le permette di fare progetti costruttivi, rimanendo così intrappolata in una serie di azioni che soddisfano esclusivamente i bisogni primari. Questo stile di vita, in aggiunta ad uno stato d’animo concentrato sulla depressione e sulla tristezza, porta a percepire una maggiore insicurezza, solitudine, rassegnazione. (…) Le donne, in particolare, vengono anche colpevolizzate per non essersi realizzate nella loro femminilità, creando una famiglia e procreando dei figli. Raramente si considera che ci sono donne disperate per non aver potuto tenere con sé i propri figli a causa di problemi economici insormontabili, donne sempre più rassegnate a vivere un’esistenza misera fatta di ricordi e di speranze infrante.”57 Dall’altra parte, nelle stazioni metropolitane, è possibile incontrare donne, ricoperte di vari strati di abiti, che portano con loro parecchie borse di nylon. Queste donne preferiscono dormire fuori, non si avvalgono dei dormitori. “Sono queste, donne che hanno rifiutato completamente la società, con le sue regole e i suoi valori, dimostrando una loro particolare dignità nel cavarsela da sole”58. In Italia, come ho inizialmente affermato, gli studi che si occupano del fenomeno della “donna senza dimora” sono relativamente pochi. La marginalità femminile viene troppo spesso affrontata in modo asessuato, o trattata in secondo luogo, come se il fenomeno non fosse così importante da richiedere la giusta attenzione o addirittura non esistesse. “Nasce così un’emarginazione nell’emarginazione, un tema di seconda categoria nel dibattito teorico sull’esclusione sociale e sulla povertà estrema”59. Dalle ricerche sul fenomeno della “persona senza dimora”, emerge comunque che uomini e donne hanno percorsi di emarginazione differenti dovuti ad esperienze biografiche diverse ed a necessità vitali diverse60. Queste differenze impongono quindi un’attenzione di tipo sessuato al problema, sia in un’ottica di intervento che di prevenzione. 57 Ibidem, pp.163-164. G. Tagliaferri, “Donne senza dimora: il genere dell’emarginazione”, in TRA, n.4, 1/ 12/ 1991, p.2. 59 P. Donadi, Emarginazione e invisibilità delle donne senza fissa dimora, Montefeltro, Urbino, 1996, p. 182. 60 Ibidem, p. 182. 58 63 L’ACCOGLIENZA NOTTURNA FEMMINILE “LA TRECCIA” La casa era piccola, le stanze poche, ma c’erano logge, terrazze e pergole tutt’intorno, per stare a guardare il sole, il mare e le nuvole: l’anima chiede più spazio del corpo. A.Munte, La storia di S. Michele. 1. NOTA METODOLOGICA AFFIDABILITA’ SULLA RACCOLTA DATI E LORO Il lavoro di ricerca all’interno della Treccia ha utilizzato come strumento determinante l’osservazione partecipante61; esso privilegia l’aspetto del contatto diretto con il fenomeno, in questo caso le ospiti della Treccia, inoltre mi ha permesso di raccogliere le note etnografiche, le quali comprendono anche alcuni resoconti di vita delle ospiti. La possibilità di partecipare quotidianamente, in generale alle attività dell’Associazione, quali il Centro d’Ascolto, la Svolta, i coordinamenti e in particolare alla “vita” all’interno della Treccia, mi ha permesso di venire a contatto e di conoscere una realtà e un “mondo” a me prima sconosciuto. Per riuscire a non perdere la grande quantità di informazioni raccolte sia dal contatto diretto con gli utenti, sia dallo scambio di opinioni con i vari operatori, mi sono servita di un quaderno, una sorta di diario che andavo a scrivere ogni giorno negli spazi di tempo liberi. Ovviamente il mio lavoro di stesura di tesi si concentrerà solo su una parte di queste annotazioni, in particolare su quella riguardante la mia presenza all’interno della Treccia. Agli ospiti delle varie strutture sono sempre stata presentata nel mio ruolo di studente che si apprestava a svolgere una ricerca su S. Marcellino, in particolare sulla Treccia, dove, nella mia ultima permanenza di circa quindici giorni, ho svolto il ruolo di volontaria. Le informazioni sull’Associazione S. Marcellino le ho raccolte analizzando le varie documentazioni che il responsabile mi ha consegnato. Per quanto riguarda la 61 “Osservazione in quanto implica il guardare e l’ascoltare. Ma allo stesso tempo questa tecnica comporta un contatto personale e intenso fra soggetto studiante e soggetto studiato, un’interazione prolungata che può anche durare anni, con un coinvolgimento (partecipazione) del ricercatore nella situazione oggetto dello studio che ne rappresenta l’elemento distintivo. Il ricercatore osserva la vita e partecipa della vita dei soggetti studiati . (…). Nell’osservazione partecipante il ricercatore scende sul campo, si immerge nel contesto sociale che vuole studiare, vive come e con le persone oggetto del suo studio, ne condivide la quotidianità, le interroga, ne scopre le pene e le speranze, le concezioni del mondo e le motivazioni dell’agire, al fine di sviluppare quella visione dal di dentro che è il presupposto della comprensione.”, in P. Corbetta, Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, Milano, 1999, p.367. 64 storia della Treccia, le informazioni sono state raccolte da una intervista fatta da me medesima al responsabile dell’Associazione. Inoltre, la documentazione che mi è stata consegnata dal responsabile dell’Associazione, ovvero le schede sociali di tutte le ospiti che sono state presenti nel passato e di quelle che lo sono attualmente, è stata il punto d’avvio della mia ricerca sul profilo dell’utenza della Treccia. Nel corso della loro analisi ho fatto costantemente riferimento ai colloqui avuti con il responsabile e con i diversi operatori che lavorano all’interno dell’Associazione. 2. LA STORIA DELLA TRECCIA La Treccia viene aperta il 7 Febbraio 2000. D., responsabile dell’Associazione S. Marcellino, alla mia domanda su come sia maturata all’interno dell’Associazione stessa, la decisione di aprire una struttura di accoglienza solo femminile, così risponde: “Erano un po’ di anni che pensavamo alla condizione della donna senza dimora, un po’ perché avevamo la sensazione, soprattutto attraverso il lavoro del Centro d’Ascolto, che ci fosse molto da scoprire, parlo di anni fa, poi via via abbiamo anche osservato un aumento delle persone che venivano a chiedere anche se non era un aumento consistente.(…).Eravamo abbastanza consapevoli che la nostra visibilità rispetto al problema era scarsa per tutta una serie di motivi anche a noi sconosciuti, ma anche perché non offrendo e non fornendo servizi per donna, alla fine non venivano neanche a chiederceli. La prova l’abbiamo avuta dopo aprendo la Treccia”. Nel 1999, la Regione Liguria, in particolare la Consulta femminile, contattò l’Associazione per effettuare una ricerca sul territorio della Liguria, che si proponeva di far luce sul rapporto esistente tra le problematiche legate alle donne senza dimora e le strutture. Alla fine della ricerca era emerso che l’identikit tipo della donna senza dimora in Liguria era in preponderanza un soggetto in una fascia d’età compresa tra i 40 e i 60 anni, con grosse problematiche psicologiche o psichiatriche e, nella maggior parte dei casi, con figli affidati ad altre famiglie. Riguardo alle strutture il problema evidente era la mancanza di dormitori o luoghi di accoglienza attrezzati e con operatori che potessero dare risposte concrete ed essere una valida alternativa alla strada. Questa mancanza veniva spesso contenuta con l’utilizzo di istituti religiosi per accogliere i casi più urgenti di donne senza dimora, ma tali strutture necessitavano di maggiore competenza per gestire le complesse problematiche legate al disagio delle donne senza dimora. Continuo con D. “Noi avevamo delle esperienze di lavoro con donne, viziate però dalla mancanza di strumenti. Non avendo una struttura dove poter accogliere, per molte donne il salto era quello dalla strada alla casa. Passaggio che spesso non permette di recuperare alcuni problemi e che spesso ne crea ulteriori. Ciò maturò in noi la consapevolezza che bisognava andare a vedere più da vicino questi problemi e lasciarci contaminare, nello stile di S. Marcellino che è quello di avvicinare le persone e, sulla base dell’incontro con le persone, modificare 65 progetti e costruire…e abbiamo iniziato sostanzialmente a ragionare che una struttura esclusivamente femminile sarebbe stata necessaria, con tutti i problemi che comportava.” Il percorso di progettazione è stato abbastanza lungo perché aprire una struttura del quel tipo comportava, al di là dei locali e della loro ristrutturazione, alcuni problemi di diversa natura: il primo di carattere organizzativo, quale il reclutamento dei volontari, almeno 40, con i quali, ad uno ad uno, D. ha avuto un colloquio e, di non secondaria importanza, trovare una responsabile, selezionata poi tra tre candidate. Il secondo problema, sicuramente la parte più delicata, è stato progettare la struttura, decidere se fare una comunità o una pronta accoglienza. Utilizzo le parole di D.: “Ci siamo visti per un sacco di tempo, io, la psichiatra che all’epoca lavorava qui e un paio di operatori dell’Auxilium, abbiamo iniziato a ragionare da dove partire perché poi l’esperienza con le donne era zero.” Sostanzialmente la Treccia riprende il modello dell’Accoglienze notturne maschili quali Angolo e Gradino, facendo qualche accorgimento sugli orari, in specifico quello d’entrata che dalle 19:30, viene anticipato alle 19:00. “(…).Le Accoglienze notturne ci sembravano un modello sufficientemente agile perché potevamo accogliere la gente direttamente dal colloquio, non sono eccessivamente impegnative per gli ospiti perché le regole sono tre, abbastanza semplici, anche se dal punto di vista di chi vive per strada sono una domanda forte: l’igiene personale, la puntualità e la sobrietà; le persone non sono coinvolte nella gestione della struttura e questo risolve dei problemi di varia natura . In realtà sentiamo molto la mancanza di una prima accoglienza o di una comunità.” 2.1. La specificità della Treccia La Treccia si trova a svolgere, da una parte, il ruolo di una seconda accoglienza; dall’altra parte quello di una comunità, senza esserlo, ovvero senza avere all’interno gli strumenti presenti di solito, in una comunità. La scelta del modello delle Accoglienze notturne maschili, agevola la “presa in carico” della persona in quanto quest’ultima può essere accolta direttamente dal colloquio con uno degli operatori del Centro d’Ascolto che è uno dei principali punti di riferimento per le utenti. Il Centro d’Ascolto, infatti, è un punto nevralgico perché qui avvengono i primi contatti con le persone che si rivolgono all’Associazione, è qui che si cerca di costruire un dialogo con esse, si cerca di comprendere la loro situazione e poi si inseriscono nelle accoglienze. Queste persone, una volta inserite, vengono seguite dagli operatori del Centro d’Ascolto. Gli utenti, alloggiati presso le strutture, hanno l’obbligo di recarsi al Centro d’Ascolto una volta a settimana per farsi timbrare il tesserino. Quest’ultimo è uno strumento che rappresenta un’occasione per mantenere un rapporto costante con l’utenza, permette di dare continuità al dialogo e al progetto di recupero che si tenta di costruire62. 62 “Sulla esperienza che stiamo conducendo con alcuni che hanno cambiato stile di vita e che sono riusciti a recuperare una propria autonomia personale, miriamo, quando è possibile, ad offrire alla persona occasioni diversificate per riprendere in mano la propria vita, affrontare i motivi che l’hanno portata a vivere per strada, ripromettere un futuro dignitoso, valorizzando tutto quanto di positivo appartiene alla sua storia. Questo è un lavoro che richiede tempo, spesso svariati anni, pazienza, fiducia reciproca. Per questo riteniamo di grande importanza l’accoglienza verso tutti, perché abbiamo una tenace speranza che qualunque persona che si trova in difficoltà possa essere 66 La Treccia non è stata pensata come una comunità perché quest’ultima sarebbe stato per alcune persone un salto troppo lungo rispetto alla strada. La comunità viene utilizzata come strumento efficace per le persone con le quali l’Associazione ha aperto un dialogo e un percorso riabilitativo da parecchio tempo, infatti esso è uno strumento impegnativo rispetto alle persone che ci vivono dentro perché chiede molto: gruppi settimanali, la partecipazione alla gestione della “casa” occupandosi delle pulizie, della stesura della lista spese, della preparazione della cena, ecc. Strumento quindi molto forte per chi arriva dalla strada e non riesce a stare “dentro” situazioni che coinvolgono troppo, in quanto promuovono, in primo luogo, un forte impegno individuale, in secondo luogo, un coordinamento e una gestione di gruppo. Ma all’interno della Treccia ci sono persone che è da alcuni anni che vi alloggiano.“Persone come G., che è da tre anni e mezzo che vive lì e si è adattata in quella struttura quasi come se fosse una comunità o la sua casa, senza però avere gli strumenti né lei, né chi ci lavora dentro, per governare dinamiche come si userebbero in una comunità, mi riferisco a gruppi settimanali, un certo tipo di verbalizzazione, di richiesta e di scambio nei confronti degli ospiti, si vede che è un percorso faticoso. D’altro canto per chi arriva dalla strada, magari con un po’ di problemi anche di socializzazione, trovarsi ad impattare con persone che sono lì da anni e fanno abbastanza muro, non è certo un’esperienza di accoglienza eccezionale”. Se una ospite quindi, desidera farsi gli affari propri, lo può fare, perché la Treccia non è una comunità. Dovrebbe essere un dormitorio, ovvero un luogo di passaggio, ma non lo è perché per alcune tende a diventare una sorta di sistemazione definitiva. Per cui la precarietà si lega alla stabilità, alla ritualità quotidiana. In questo modo però la Treccia non può accogliere le donne con estremo disagio, le persone più “scassate” (parola usata da un operatore), in quanto non è una Prima Accoglienza, non lo può essere perché troppo piccola come struttura; al suo interno infatti può accogliere sei persone, e un numero così basso penalizza, se pensiamo ad una Pronta Accoglienza, in quanto inevitabilmente crea legami, contatti troppo personalizzati, spesso soffocanti per alcune persone63. Oltre ciò, dice D. “Un’altra cosa che emerge come dato problematico è la percentuale molto più alta, rispetto agli uomini, di problemi psichiatrici. Per cui, essendo la struttura di soli sei posti, capita di avere un concentrato di persone con problemi psichiatrici, rischiando di diventare una comunità per psichiatrici, con tutto quello che comporta. (...).Ci siamo anche resi conto che tante donne assieme stanno assieme appunto in maniera diversa rispetto a tanti uomini assieme”. La Treccia è un’Accoglienza esclusivamente femminile, ed è anche questo a renderla specifica, particolare, in quanto non possiamo fare a meno di toccare i problemi legati all’esperienza della maternità. Quasi tutte, all’interno della struttura hanno avuto dei figli, anche se alcune sono giovanissime. Continuo con le parole di D.:“ Se durante la permanenza alla Treccia, qualcuna si trova in gravidanza, noi non abbiamo la possibilità di accompagnarla in questo percorso, aiutata a scoprire in sé le risorse per cambiare e migliorarsi.” in internet: www.sanmarcellino.ge.it. 63 “ La decomposizione ed abbandono del Sé, cioè il carattere distintivo della povertà urbana estrema, è connessa con il deciso, ma progressivo, ritiro che l’individuo estremamente povero porta a termine nei confronti del mondo esterno, della propria famiglia, degli amici: Le persone in condizione di povertà estrema sono in primo luogo caratterizzate dal ritiro dal mondo esterno.” In P. Guidicini. G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995, pp. 13-14. 67 mi sembra che questo sia un grosso limite perché accogliere le donne vuol dire anche essere in grado di accogliere questo tipo di esperienza e, vissuta per strada è un’esperienza problematica per la persona che la vive, ma anche per le altre che si trovano in qualche modo a rivivere e a proiettare su questa persona la loro storia, le loro difficoltà, le loro tristezze”. Altro aspetto da affrontare ,è quello legato ai rapporti di coppia. Nel mondo delle Accoglienze notturne maschili sono quasi sempre sfumate, mentre invece quasi tutte la ragazze che sono alla Treccia hanno un fidanzato, o un marito e chiaramente questo è un fatto funzionale allo stare per strada, avere una protezione da un comando e, quando va male, al limite le buschi solo da uno, a volte va bene, non necessariamente tutte le coppie che si formano per strada sono coppie patologiche, certamente c’è questo aspetto”. La Treccia si presenta quindi come una struttura, nel genere unica, nel territorio genovese, essa si colloca come un’esperienza sperimentale nel tentativo di comprendere e tutelare le donne senza dimora proponendosi, inoltre, di far emergere e dare visibilità ad una specifica problematica che spesso non veniva colta, quale l’emarginazione femminile. Attualmente, la Treccia è diventata, nel contesto genovese un punto di riferimento, rischiando a volte di diventare un rifugio al femminile di tanti disagi genovesi, perchè non ci sono altre risposte sul territorio; per cui spesso l’Associazione si trova a dover selezionare tra un numero elevato di domande a cui la struttura non è sempre in grado di fornire una risposta adeguata, anche in relazione al numero limitato dei posti letto disponibili. Alla domanda, se nel tempo è cambiato e come è cambiato il progetto della Treccia, D., mi riferisce che fino ad ora sono rimasti abbastanza attaccati all’idea iniziale, “anche se non ci piace. Ci sono stati dei cambiamenti significativi, ma non determinanti dal punto di vista dell’impianto e cioè un po’ di lavori di ristrutturazione.(...). Abbiamo provato a fare anche un anno di verifica sulla Treccia, però siamo bloccati dal fatto che ci mancano dei pezzi prima e dopo, cioè il ragionamento non tanto va fatto sulla Treccia, ma sul sistema e, per fare un ragionamento sul sistema, ci vogliono delle risorse, che noi per il momento non abbiamo. Per sapere meglio dove andare con una Treccia, bisognerebbe fare un ragionamento su un sistema, ma per fare un ragionamento su un sistema, bisognerebbe anche poter iniziare a sperimentare un qualche cosa sul sistema e questo diventa problematico”. 3. PROFILO DELLE UTENTI DELLA TRECCIA 68 Qual è il nostro reato? Quello di non riuscire a correre al ritmo di questa società? Allora siamo colpevoli. Piazza Grande, ottobre 2003 Dal momento dell’apertura (Febbraio 2000), ad oggi (Ottobre 2003), sono passate dalla Treccia 21 donne. In questo capitolo intendo esaminare le informazioni disponibili relative alle ospiti. I dati che andrò ad analizzare sono stati ricavati direttamente dalle cartelle sociali delle ospiti, cartelle che mi sono state fornite da D., responsabile dell’Associazione. Le cartelle analizzate, complessivamente, sono vent’uno. Non è un numero particolarmente significativo, ma va rapportato al fatto che la Treccia è una struttura di accoglienza relativamente recente e dotata di soli sei posti letto. I dati disponibili ricavabili dalla lettura delle schede concernano: la permanenza alla Treccia, il luogo e l’anno di nascita, le motivazioni all’ingresso, l’ente inviante, le problematiche prevalenti, la situazione lavorativa, la situazione familiare e il tempo complessivo di permanenza. Non tutte le cartelle sono complete a causa, anche, a volte, della breve permanenza della persona. Una cartella non presenta il luogo di nascita dell’utente, molte non presentano notizie sul titolo di studio e sulla condizione professionale. Per quanto riguarda problemi legati alla tossicodipendenza, in tutte le vent’uno schede appare “n. r.”. Le tabelle che seguono, riportano, in ordine, il periodo di permanenza alla Treccia (tab.1), l’età delle ospiti (tab.2), il luogo di nascita (tab.3), le problematiche prevalenti (tab.4), la situazione familiare (tab.5) e la condizione lavorativa (tab.6). TABELLA N. 1: permanenza alla Treccia Permanenza alla Treccia 0-30 giorni 31-60 giorni 60-120 giorni 120-180 giorni 1 anno Più di un anno Percentuale % 19 % 4,7 % 28,6 % 14,3 % 4,7 % 28,6 % La TABELLA N. 1 presenta il periodo di permanenza delle utenti nella struttura. Si può osservare innanzitutto che le percentuali più alte si registrano nelle permanenze di 60-120 giorni e in quelle che superano un anno. Quest’ultime, soprattutto, ci testimoniano la specificità della struttura in esame. Il 28,6 delle ospiti che vi risiedono da più di anno e la presenza di alcune utenti dal momento 69 dell’apertura, ci fa capire chiaramente che la Treccia non può essere definita una prima accoglienza, ma più correttamente una seconda accoglienza, in quanto intorno alla persona accolta è stato costruito un progetto che la segue nel tempo. Per alcune, che ci vivono da quando è stata aperta, la struttura diviene una specie di comunità, o addirittura la loro casa. Ma la Treccia è un dormitorio e il 19% che permane nel periodo di trenta giorni lo dimostra. La struttura è quindi un ibrido fra i due tipi di accoglienza, da una parte vi sono persone che vi sono rimaste per un breve periodo, dall’altra vi sono persone che sono rimaste per lunghi periodi e che sono tuttora presenti. TABELLA N. 2: età delle ospiti della Treccia Età Percentuale % 18-24 anni 24-30 anni 30-36 anni 36-42 anni 42-48 anni 48-54 anni 54-60 anni Oltre 60 anni 14,3% 14,3 % 4,7 % 28,6 % 14,3 % 9,5 % 9,5 % 4,7 % La TABELLA N. 2 presenta i dati relativi all’età delle ospiti. Le fasce di età più diffuse sono quelle comprese tra i 36 e i 42 anni, seguono 18-24 e 42-48. Lo studio delle fasce d’età presenti mostra come sia eterogenea l’utenza che usufruisce della struttura. L’età media delle donne risulta più bassa rispetto a quella degli uomini, anche perché ci sono alcuni casi che abbassano pesantemente la media. Dalle percentuali vediamo la presenza di un 14,3 % di donne con una fascia d’età compresa tra i 18 e i 24 anni. Giovani che spesso hanno avuto alle spalle storie difficili, figli. “Giovani donne che, a causa di crisi familiari ed individuali, si ritrovano senza mezzi di sostentamento. Altre volte sono ragazze fuggite da famiglie disgregate o con patologie gravi, che in conseguenza di fallimenti di un loro inserimento in istituti o comunità, si sono ritrovate sulla strada”64. Queste ultime sono anche coloro che più facilmente si rivolgono ad una vita di tipo criminale.65 Le giovani donne, nel rivolgersi alla struttura, possono avere avuto una esperienza di strada relativamente breve. Se consideriamo invece la fascia d’età compresa tra i 36 e i 48 anni, possiamo ipotizzare che alcune di queste donne, abbiano avuto alle spalle anni di esperienza di strada, per cui avranno maggiori difficoltà ad attivare risorse da mettere in gioco in un percorso di recupero. Per quanto riguarda la fascia d’età compresa tra i 48 e i 60 anni, possiamo notare una presenza del 9,5 % di donne. P. Donadi, ipotizza che quest’ultime possono essere “ donne che 64 P. Donadi, Emarginazione e invisibilità delle donne senza fissa dimora, Montefeltro, Urbino, 1998, p.153 65 G. Torre, E. Sperati, “La criminalità femminile minorile”, in Marginalità e Società, n. 15, 1990, p.31. 70 hanno vissuto solamente in funzione della famiglia, del marito, o donne che, vivendo da sole, hanno trascorso una vita svolgendo lavori saltuari, nel terziario, anche prostituendosi e si ritrovano senza più risorse”66.Non dobbiamo dimenticare che un’altra variabile importante che porta molte donne alla vita di strada è la violenza domestica e i maltrattamenti subiti. Ovviamente queste sono tutte ipotesi, in quanto è molto difficile racchiudere la storia di ogni persona all’interno di categorie precise. Dai dati rilevati, già da queste prime analisi, possiamo osservare che all’interno della Treccia confluiscono situazioni caratterizzate da una eterogeneità di percorsi biografici e ciò conferma l’impossibilità di costruire carriere e percorsi definiti. Continuando con la nostra analisi dei dati, possiamo notare che per oltre i 60 anni, vi è una presenza del 4,7 %. La percentuale ridotta di donne anziane all’interno della popolazione della Treccia, si può spiegare con il fatto che, da una parte, per questa fascia di popolazione sono state predisposte negli ultimi anni soluzioni alternative, dall’altra, che la durata della vita sulla strada è breve, in quanto questa condizione condanna la persona ad una morte precoce.67 TABELLA N. 3: luoghi da nascita delle ospiti Luogo di nascita Nord Italia Centro Italia Sud Italia Liguria Genova Percentuale % 14, 3 % 14,3 % 23,8 % / 38 % La TABELLA N. 3 evidenzia la distribuzione geografica del luogo di nascita delle ospiti. Il dato che subito appare in assoluto è che la maggior parte delle persone che sono passate alla Treccia è nata a Genova. Questo dato ci indica che sono persone ben radicate nel territorio genovese. “(…) l’utenza della struttura si percepisce come una componente interna alla città”68.Oltre a ciò, ci rivela anche che le donne, a differenza degli uomini, hanno maggiori difficoltà a spostarsi. Il territorio comunque ci dice molto riguardo le “rotture” subite dalla persona, esso ha un rapporto stretto con la sua biografia69. Altro dato da non trascurare è la 66 P. Donadi, Emarginazione e invisibilità delle donne senza fissa dimora, Montefeltro, Urbino, 1998, p. 153. 67 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FranoAngeli, Milano, 1999, p.94. 68 Ibidem, p.97 69 “Quale rapporto vi è tra il luogo in cui si trova l’uomo sulla strada e la sua biografia? La risposta a questa domanda permette di misurare l’intensità della rottura: A volte il rapporto è stretto: l’individuo vive nella strada, ma all’interno del comune o del quartiere dove è nato, nel luogo dove ha trascorso la sua infanzia, nel luogo in cui ha costruito la propria famiglia, o nel luogo in cui ha lavorato per qualche anno. Talvolta è solamente il luogo di un ricordo, un posto dove è venuto in vacanza o in visita. A volte è solamente il luogo dove ha incontrato un proprio collega (un altro uomo sulla strada), ha trovato un mercato (dove recupera del cibo), una chiesa accogliente (dove mendica), uno squat, un rifugio, un giardino pubblico, una panchina ecc. E a volte è solamente il luogo in cui si è fermato perché non era più in grado di spostarsi, perché era troppo affaticato. Il 71 presenza di un 23,8 % di persone che provengono dal Sud Italia; si tratta di donne abituate agli spostamenti, oppure scappate da situazioni di vita insostenibili, oppure emigrate in cerca di fortuna, ma che hanno avuto dei seri problemi di inserimento. Soprattutto non dobbiamo dimenticare che Genova negli anni ‘60 ha conosciuto una forte immigrazione dal Sud, essendo una delle più grandi città industriali insieme a Milano e Torino. Dal Nord e dal Centro, infatti, si registra un valore abbastanza basso (14,3 %), forse anche perché rispetto al Sud, sono zone in cui la rete dei servizi è più sviluppata. Oltre tutto, Genova, essendo una città portuale, favorisce un elevato movimento di persone. TABELLA N. 4: problematiche principali Problematiche Senza dimora 1 = sì (%) 100 % 2 = no (%) O% Psichiatrico 61,9 % 38,1 % Alcol correlati 14,3 % 85,7 % La TABELLA N. 4 evidenzia la distribuzione delle principali problematiche fra le utenti. Innanzitutto si può osservare che sono tutte persone senza dimora. Fra queste sono comprese anche quelle che, per brevi periodi, hanno vissuto presso fratelli, sorelle, compagni incontrati, camere in affitto, dormitori di gruppi religiosi, ma alcune hanno “vissuto” in strada o in stazione anche per sei o sette anni. Comunque tutte le biografie sembrano accomunate da situazioni alloggiative precarie. A tal proposito D. mi riferisce che “Le donne contattate, molte, prima di perdere la casa hanno fatto salti mortali, usando tutta una serie di reti che vanno da quelle più istituzionali, per esempio se hanno figli minori, intervengono i sevizi con sussidi, si sbattono di più per andare nelle parrocchie, poi c’è tutto il percorso della prostituzione...”. Tra le altre problematiche, quelle che risultano affliggere maggiormente queste persone, sono quelle legate a disagi psichiatrici. Un confronto con l’universo della popolazione che si rivolge al Centro d’Ascolto di S. Marcellino fa emergere un dato interessante: le percentuali di problemi psichiatrici femminili sono circa il doppio rispetto a quelle riscontrabili tra gli uomini, sempre senza dimora, che chiedono aiuto al Centro d’Ascolto. Tra le ospiti della Treccia c’è chi viene seguita regolarmente dai Centri di Salute Mentale e assume altrettanto regolarmente psicofarmaci, oppure c’è chi, solo durante la permanenza, ha portato alla luce i suoi gravi disturbi psichiatrici. problema del territorio dell’uomo sulla strada è collegato alla dinamica urbana. E’ soprattutto nelle piccole o medie città che si trovano sulla strada individui che hanno uno stretto rapporto con il territorio. Vi sono nati, vi hanno vissuto, vi hanno lavorato. Nel centro delle grandi città, al contrario, la distanza è massima: non ha radici. Il territorio è dunque un indicatore affidabile delle rotture successive. Ogni volta che si allontana dalla sua storia, interviene un cambiamento d’alloggio.”, in J. F. laè, C. Lanzarini, N. Murard, “Tra rotture e perdita del sé: l’homme a la rue”, in P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995, pp. 78-79. 72 Purtroppo non esistono in Italia ricerche sulle donne senza dimora che ne prendano in considerazione in maniera specifica i frequenti disagi psichiatrici. Uno studio svolto da Marshall e Reed, realizzato nel 1986 negli ostelli per poveri di Londra, ha individuato le caratteristiche socio-demografiche nonché lo stato di salute fisica e mentale di un campione di 70 donne. I risultati di questa ricerca hanno evidenziato che le donne senza dimora sono, rispetto agli uomini, più giovani, hanno maggiori contatti con la famiglia d’origine, più spesso sono state sposate ed hanno avuto figli, hanno lavorato in media per un periodo di 15 anni. Di queste, il 60 % ha avuto almeno un ricovero in strutture psichiatriche, di cui il 45% con diagnosi di schizofrenia. Le motivazioni di questa prevalenza sembrano ricondursi a situazioni antecedenti al ricovero, dato che la dimissione da un ospedale psichiatrico non comporta necessariamente una vita di strada70. Altri elementi invece, come l’alto costo delle abitazioni e la maggiore dipendenza sociale ed economica possono portarle a richieste anche improprie di ricovero71. Anche secondo un rapporto del 1985 dell’American Psycological Association, le donne senza dimora mostrano un tasso più elevato di malattie mentali della controparte maschile. In più le malattie mentali possono essere un incentivo allo sfruttamento e alla violenza sessuale. Una malata cronica e senza tetto è esposta ad un rischio triplo per quanto riguarda questi pericoli72. Le problematiche legate a disagi psichiatrici sono un campanello d’allarme nella gestione dei contatti con le donne senza dimora nonché nelle modalità di attivazione dei progetti per il loro recupero verso l’autonomia. Per quanto riguarda le problematiche alcol correlate, vediamo che non sembrano essere particolarmente diffuse all’interno dell’utenza femminile accolta dalla Treccia. L’alcol non sembra mai essere la causa principale dell’essere “senza dimora”; esso appare piuttosto come una conseguenza delle situazioni problematiche in cui si trovano i soggetti. Per i problemi legati all’uso di alcol, S. Marcellino propone il metodo ecologico – sociale dei Club degli Alcolisti in Trattamento (C.A.T). Durante il trattamento, in particolare nella fase iniziale, è prevista l’assunzione giornaliera di una compressa di “antabuse”, un farmaco passivo utile per rafforzare il proposito di non bere. Per quanto riguarda la partecipazione ai C.A.T, tra le persone che sono passate alla Treccia abbiamo una percentuale del 4,7 %. Dato che forse non ci dice molto, ma che mette in evidenza quanto la partecipazione a questi gruppi sia un passo molto forte, per alcuni molto difficile, perché presuppone l’impegno di portare avanti un progetto. Una ricerca svolta all’interno di un progetto europeo, “Il sogno di Vladimir”, incentrato sulle problematiche alcol-correlate delle persone senza dimora in tre realtà europee quali S. Marcellino (Genova, Italia), Emmaus di Forbach (Francia) e S. Martin de Porres (Madrid, Spagna), per quanto riguarda la realtà di S. Marcellino, mette in evidenza che su un campione di persone (corrispondente a 112 persone) inviate ai C.A.T. dall’Associazione stessa nel periodo compreso tra Gennaio 1988 e Dicembre 2000, di esse 108 sono maschi, 4 sono femmine. Di queste, sono ancora in contatto con l’Associazione 32 persone, 70 P. Donadi, Emarginazione e invisibilità delle donne senza fissa dimora, Montefeltro, Urbino, 1996, pp. 154-155. 71 Caritas Ambrosiana (a cura della), Barboni. Per amore o per forza? Senza dimora, esclusione sociale, povertà estreme, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1996, p. 105. 72 P. Donadi, Emarginazione e invisibilità delle donne senza fissa dimora, Montefeltro, Urbino, 1996, p. 156. 73 di cui 2 sono donne. E’ evidente la bassissima percentuale di presenza femminile, confrontata con quella maschile. Nonostante ciò, non possiamo comunque trascurare questo dato. Infatti, anche per quanto riguarda il problema alcol, è necessario affrontarlo in modo sessuato, mettendo in evidenza le differenze di approccio e di risposte al problema tra un universo maschile e femminile. Purtroppo, anche per quanto riguarda queste problematiche, in particolare per la donna, sappiamo ancora poco. Il materiale qualitativo della ricerca “Il sogno di Vladimir”, mette in luce il percorso, spesso tortuoso e fatto di ricadute , del rapporto con i C.A.T. “(…) una specie di continui alti e bassi, di miglioramenti e di ricadute, ricadute e miglioramenti che danno in pieno il senso dell’autentica processualità della vita e che contraddistinguono ogni immagine di stabilità o di risultato (positivo o negativo) permanentemente acquisito.”73 Ciò non significa che i passi avanti che vengono compiuti dai soggetti in carico non portino comunque, per loro, a dei benefici effetti: ma bisogna ben capire che i risultati positivi si acquisiscono nel tempo, con molto tempo e ciò non riguarda soltanto il problema alcol. “Diverse volte, leggendo i verbali degli incontri e dei colloqui tra gli operatori di S. Marcellino e gli alcolisti senza dimora, si potrebbe sovrapporre, quasi in fotocopia, un resoconto – mettiamo – dal 1990 con uno del 1997, relativo allo stesso utente”74. Questa sensazione, provoca reazioni molto diverse: la prima, diciamo così pessimistica, che non si muove, che non si sta muovendo nulla e che quindi il tempo che passa, ed il lavoro che si svolge, serva davvero a poco. La seconda reazione, forse più ottimistica, consiste nella comprensione del fatto che, all’interno di un cammino evolutivo, i tempi sono lunghissimi e che la staticità, la ripetizione, da parte dell’utente, rappresenta la messa in campo di un più che normale meccanismo di difesa75. “Tale meccanismo è imputabile alla paura che i cambiamenti che il soggetto ha messo in atto lo destabilizzino, non gli consentano cioè più di affrontare la vita tramite risposte note. (…) Tanto forte è la paura del dolore e il bisogno di mantenersi entro binari quotidiani di prevedibilità che quei momenti di crisi, dolorosi, (…) vengono rimossi”76. A tal proposito, ricordo che G., una ospite della Treccia, raccontandomi dei suoi problemi con l’alcol mi ha detto: “Sono 2 anni che non bevo più, ormai che ci vado a fare ai C.A.T., si dicono sempre le stesse cose. Quando andrò a vivere nella mia casa non ci andrò più!”. 73 Progetto europeo “Il sogno di Vladimir”, p. 18. Ibidem, p. 19. 75 Sigmund Freud, in un saggio scritto nel 1937, Analisi terminabile e interminabile, si interroga, senza pervenire ad una risposta standard, sulla durata del trattamento psicoanalitico, e anche sulla possibilità di pervenire a una totale guarigione, nonché sulle resistenze che ogni paziente presenta allo stesso trattamento. Nell’ambito delle terapie afferenti il people processing, guarigione e durata della terapia assumono un significato fortemente individualizzato, variano da persona a persona perché il contributo soggettivo del paziente è assolutamente decisivo. Infatti, ogni paziente, anche il migliore dei pazienti, oppone delle resistenze al trattamento, resistenze che lo porterebbero ad accontentarsi di risultati parziali e provvisori. Scrive infatti S. Freud nel saggio citato: “L’esperienza analitica ci ha mostrato che il meglio è sempre nemico del bene e che in ogni fase del processo di guarigione dobbiamo lottare contro l’inerzia del paziente che lo indurrebbe ad accontentarsi di una soluzione incompleta.” In S. Freud, “Analisi terminabile e interminabile”, in S. Freud, Opere, vol. X, Boringhieri, Torino, 1979, p.514. 76 Progetto europeo, “Il sogno di Vladimir”, p. 20. 74 74 TABELLA N. 5: situazione familiare Situazione familiare Presenza di figli Rapporti con la famiglia d’origine Divorzio 1 = sì (%) 42,8 % 2 = no (%) 57,2 % 20 % 80 % 39 % 61 % La TABELLA N. 5 descrive la situazione familiare delle utenti della Treccia. Si può osservare innanzitutto che gran parte delle utenti (80%) non ha più rapporti con la famiglia d’origine. Generalmente, per quanto riguarda il 20% di persone che mantengono ancora dei rapporti, quest’ultimi possono essere con qualche fratello o sorella, oppure telefonicamente con uno dei due genitori. Comunque si tratta di rapporti molto deboli. Di conseguenza la “distanza dalle reti primarie e/o secondarie riduce la possibilità di reinserimento e, d’altro canto, agisce come fattore propulsivo in relazione ai processi di désaffiliation. (…). E la sopravvivenza delle reti sociali non assicura comunque, meccanicamente, un supporto e un sentimento di appartenenza”77. Dai dati emerge anche che un 39 % delle donne che sono passate alla Treccia ha avuto un divorzio alle spalle. P. Donadi sottolinea che una delle cause principali che porta la donna alla vita di strada è la disgregazione familiare e delle relazioni parentali che diviene determinante se la donna non ha un lavoro ed è perciò più dipendente dal coniuge e dalle relazioni connesse al matrimonio. La rottura del matrimonio e la difficoltà di trovare un lavoro qualificato, soprattutto per le classi sociali più basse, aumenta la probabilità di questo rischio78. Continuando ad esaminare i dati a nostra disposizione, notiamo che un 42,8 % ha figli dati in affidamento o adottati. Alcune di loro riescono a mantenere dei rapporti, altre no. Questo è sicuramente uno dei problemi più forti legato alla “donna senza dimora”. Per quanto riguarda la struttura, l’accogliere le donne, vuol dire anche essere in grado di accogliere l’esperienza della maternità e di questo la struttura non è in grado di occuparsene. Purtroppo, come mi ha più volte riferito il responsabile dell’Associazione, questo è uno dei limiti della Treccia. Dall’analisi dei dati circa la situazione familiare della donne alla Treccia, sono emersi alcuni elementi di riflessione, in particolare “l’assenza di legami forti e la distanza dai propri mondi vitali. Tale condizione sembra rilevante rispetto ai processi di désaffiliation poiché, da una parte, le possibilità di fare fronte adeguatamente agli eventi critici sono direttamente proporzionali all’ancoraggio, all’ampiezza e all’intensità delle strutture reticolari, intese come risorse, e 77 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, pp. 97-102. 78 P. Donadi, Emarginazione e invisibilità delle donne senza fissa dimora, Motefeltro, Urbino, 1998, p. 149. 75 dall’altra, la mancanza di appartenenze specifiche accelera e aggrava il processo di désaffiliation”79. TABELLA N. 6: condizione lavorativa Condizione lavorativa 1 = sì 2 = no Lavoro in passato (%) 38 % 62 % Lavoro attuale (%) 42,8 % 57,2 % LA TABELLA N. 6 evidenzia le capacità lavorative fra le utenti 80. Innanzitutto si può osservare che gran parte delle utenti non ha avuto attività lavorative in passato (62 %). Tra le attività svolte da coloro che hanno lavorato in passato (38 %), primeggiano occupazioni poco tutelate (lavori stagionali, orari ridotti, contratti a termine), attività come colf , operaie generiche, ecc., per cui emerge una maggiore difficoltà d’inserimento in fasce lavorative più qualificate ed elevate rispetto agli uomini. Questo può essere spiegato da un mercato del lavoro che tende a privilegiare la figura maschile e lascia ai margini quella femminile. Da ciò emerge una maggiore debolezza e discontinuità lavorativa e una maggiore dipendenza economica della donna nei confronti del coniuge e spesso, per quanto concerne la sfera privata, le separazioni e i divorzi sono un’ulteriore causa di impoverimento per le donne che investono maggiormente nel matrimonio81. Altro dato da non sottovalutare è il 42,8 % delle donne che attualmente lavorano. Possiamo pensare che per molte di loro il cambiamento è avvenuto grazie all’inserimento nei laboratori di S. Marcellino, finalizzati a far riprendere una capacità lavorativa e a cercare di dare un senso alla parola “lavorare” in queste persone, o semplicemente grazie alla “crescita” avvenuta durante la permanenza alla Treccia. In conclusione, dobbiamo ricordare che è difficile tracciare un profilo standard della donna senza dimora in generale e delle ospiti della Treccia in particolare. “La mobilità delle situazioni concrete di vita va colta nella sua irriducibilità a categorie pre-definite o definite a posteriori: ciò che rimane è lo specifico 79 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, p. 102. 80 La nozione di désaffiliation che ho presentato per quanto riguarda la situazione familiare delle ospiti, non rimanda unicamente alla densità relazionale, questa è definita anche dalla dimensione economica e dalla non-integrazione occupazionale. “In questo modello l’accento cade sulla rottura del legame sociale, assicurato, all’interno di una società in cui la forma prevalente di differenziazione è quella stratificata, dal lavoro e dal sentimento di appartenenza. Il lavoro risulta vettore di integrazione sociale non in quanto attività, tra le altre, che assicura un reddito, che pur necessario per guadagnarsi da vivere è in sé insufficiente per lo scopo, ma in quanto fonte di identità, di appartenenza sociale, di attività produttrice di senso per sé e per gli altri.”, in M. Bergamaschi, “Rottura dei legami sociali nei sistemi urbani complessi: un’ipotesi di lettura”, in P. Guidicini, G. Pieretti (a cura di), Le residualità come valore, FrancoAngeli, Milano, 1993, p.117. 81 P. Donadi, Emarginazione e invisibilità delle donne senza fissa dimora, Montefeltro, Urbino, 1998, p. 141. 76 biografico individuale, le sue rotture, le sue strategie, ecc.”82. Sicuramente ciò che è importante sottolineare in generale è la diversità del percorso di deriva sociale tra gli uomini e le donne. Uomini e donne “hanno percorsi di emarginazione diversi dovuti ad esperienze biografiche diverse ed a necessità vitali diverse”83. Per quanto riguarda le ospiti della Treccia, in particolare, esse sono donne con situazioni di vita alquanto problematiche, con un’età compresa tra i 20 e i 45 anni. Quasi tutte hanno dei rapporti con la famiglia d’origine molto deboli o addirittura inesistenti, dato che dimostra un’assenza di legami forti. Il loro stato civile è, nella maggioranza dei casi, riassumibile in una situazione di divisa-separeta-divorziata, dato che evidenzia le difficoltà di reggere e sostenere una famiglia o meglio un rapporto di coppia stabile e continuativo. E’ conseguente al loro stato civile la riflessione sulla situazione familiare che si trovano a vivere. La maggior parte risulta vivere da sola e con dei figli che sono stati dati in affidamento ad altre famiglie. Altro dato comune è la minima esperienza lavorativa e in ultimo, non per ordine di importanza, la presenza di problemi psichiatrici spesso causati da una forte instabilità affettiva. Nel cercare di ricostruire le biografie delle ospiti della Treccia, non possiamo fare a meno di soffermarci sul concetto di “carriera”. “Il termine carriera è riservato abitualmente ad un tipo di privilegi goduti da chi progredisce, secondo tappe graduali, in una professione di successo. Si usa tuttavia lo stesso termine, in senso più ampio, per riferirsi ad una sorta di filo conduttore, di carattere sociale, seguito nel ciclo dell’intera vita di una persona”84. “Il concetto di carriera mette in risalto la dimensione temporale, vale a dire l’aspetto evolutivo di una determinata condizione, il susseguirsi delle tappe che segnano la biografia del soggetto”85. Le ospiti della Treccia presentano carriere molto articolate, ogni caso è diverso dall’altro, ma gli aspetti che spesso accomunano le varie storie di vita, sono il succedersi di esperienze traumatiche dall’infanzia in avanti, comune è il senso di precarietà, è l’aver smarrito il senso della casa, della dimora intesa come spazio dell’anima, spazio per il Sé. Comune è l’incapacità di pensarsi come protagoniste della loro stessa vita, l’incapacità di stare dentro “la normalità”, “il mondo normale, quello della società, dei ruoli, delle istituzioni e delle necessarie forme sociali”86. “Ora alcuni pensano alla relazione come ad un modo per ridare ‘normalità’ agli utenti: e, a volte, non si accorgono che le persone senza dimora non sanno che farsene delle cosiddette competenze sociali. La relazionalità, così come la si intende oggi nelle professioni sociali è in realtà una potenziale trappola in cui una persona senza dimora rischia di essere ingabbiata, proprio perché non è un ‘buon borghese’. Una persona senza dimora ha, come tutti, compresi i buoni borghesi, bisogno di sentimenti forti ed emozioni calde per vivere, ma, diversamente dai buoni borghesi, non possiede quegli orpelli che possono permettergli di farne a meno. Orpelli sociali: il mondo dei ruoli e delle prestazioni, gli oggetti di consumo, la carriera e via di questo passo. Un senza 82 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, p. 86. 83 P. Donadi, Emarginazione e invisibilità delle donne senza fissa dimora, Montefeltro, Urbino, 1998, p. 182. 84 E. Goffman, Asylums, Edizioni comunità, Torino, 2001, p. 153. 85 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, p. 123. 86 G. Piazzi, La ragazza e il direttore, FrancoAngeli, Milano, 1995, p.11. 77 dimora si è , per vari motivi, liberato da questi orpelli sociali e a volte non li ha mai posseduti: ha bisogno assoluto, pertanto, di amare e di essere amato, più di chiunque altro.(…). La linea alla quale ispirare l’intervento e, prima di esso, il suo retroterra teorico e morale, consiste nel trovare la possibilità di far vivere le persone sin hogar e di ridare loro attaccamento alla vita”87. L’attaccamento alla vita lo può dare solo un’affettività sviluppata e una relazione che sappia oltrepassare la corazza dei meccanismi di difesa che queste persone sono state costrette ad indossare. 4. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA “(…), è impossibile venire a prestare solo un servizio alla Treccia, sperare di rimanere nell’ombra come testimoni silenziosi di vite più sfortunate delle nostre, venire a fare ‘quelli bravi’, mille domande ci scavano dentro mettendoci in discussione, una cascata improvvisa di curiosità, di voglia di conoscersi, un’attenzione micidiale ad ogni minimo mutamento di taglio di capelli, di vestiti, di umore…dipenderà dal fatto che le persone ospitate sono donne? Dunque curiose per definizione?! Non credo che basti una spiegazione. Credo dipenda dalla passione, dall’allegria e dalla serietà con cui abbiamo, sera dopo sera, creato il clima della Treccia, un’irresistibile energia di vita che ci ha contagiati tutti e che ha portato ogni persona accolta (parlo di tutti al di là del ruolo) a sentirsi importante e preziosa. Per una persona che si ritrova senza casa (che di solito ha alle spalle anni di vita fatta di solitudine, di difficoltà affettive, di continui cambiamenti, spesso drammatici) è una esperienza di vitale importanza scoprire che ci può essere un modo di vivere ordinato, un luogo dove le cose sono semplici e prevedibili, dove l’affetto è gratuito e sincero. Alla Treccia offriamo questo e in cambio riceviamo il dono ogni volta stupefacente della fiducia, di un sorriso amico, di una storia confidata, del dolore che si stempera e lascia spazio alla speranza, alla voglia ritrovata di vivere ed esserci.” Anna C. 4.1. I locali della Treccia La Treccia si trova nel quartiere residenziale chiamato “Carignano”, che è una zona molto ambita e tranquilla, in via Mylus numero 5. La motivazione di questa ubicazione, al di là del possedere una parte dell’edificio, per l’Associazione è stata soprattutto quella di uscire dalla logica che le sofferenze e i disagi delle persone non si devono vedere, eliminandone così la visibilità. La decisione di inserire una struttura del genere in un quartiere residenziale, ha posto il problema del superamento della logica di emarginazione, anche parziale, di alcune categorie di 87 Progetto europeo “Testa &Piedi”, supplemento al n. 4/2000 del periodico Amici di S. Marcellino della “La messa del povero”, Genova, p. 26. 78 persone, come ad esempio le donne senza dimora. L’aspetto interessante, dice D., responsabile dell’Associazione, sta proprio nel fatto che la gente del quartiere si è accorta dell’esistenza di questo dormitorio dopo molto tempo, quasi un anno dopo. Questa accoglienza notturna occupa il primo piano di un edificio in parte di proprietà da tempo dell’Associazione. La porta d’ingresso, a piano terra, introduce alla Treccia attraverso tre rampe di scale, al termine delle quali si arriva all’entrata vera e propria della struttura. Subito di fronte alle scale, si trova la stanza dei volontari e dei responsabili; nell’entrarvi, sono situati due letti, a sinistra una piccola scrivania con sopra un telefono e le programmazioni mensili dei volontari e, nel cassetto le chiavi delle varie stanze e degli armadi e un quadernone sul quale i volontari possono annotare le loro riflessioni e impressioni personali. A destra della scrivania c’è il citofono da cui la responsabile risponde e apre alle ospiti che suonano il campanello al momento dell’ingresso che può avvenire, ogni sera, tra le 19:00 e le 20:00. Al lato sinistro della stanza invece, è situato un piccolo mobile utilizzato per contenere le medicine delle ospiti e le lenzuola dei volontari. Nell’anta di destra, dalla parte di un letto, vi è una cassetta delle lettere in cui ogni volontaria della notte può inserire le sue impressioni sulla notte trascorsa e le particolari richieste delle ospiti. La cassetta delle lettere, resta sempre chiusa a chiave e viene aperta solo dalla responsabile; essa risponde ad una duplice esigenza: da una parte si propone di rispettare la privacy delle ospiti, dall’altra intende consentire ai volontari un dialogo più riservato con chi leggerà la “posta”. All’inizio del corridoio che si sviluppa per tutta la lunghezza della struttura, troviamo un piccolo spazio riempito da due poltrone, dove le ospiti possono fermarsi a chiacchierare o ad ascoltare la musica. Nelle pareti sono fissate alcune foto delle ospiti che, o abitano ancora nella struttura o vi hanno alloggiato in precedenza e di alcune volontarie riprese in momenti di festa. Foto che danno colore e vivacità al bianco delle pareti, rievocando immagini e ricordi. Infatti, una delle prime sere che sono andata alla Treccia, G., mi ha mostrato le cartoline spedite, o dalle volontarie o dalle responsabili, durante le loro vacanze, a tutte le ospiti della struttura, poi mi ha descritto in breve, ad una ad una, le persone che erano nelle foto: “Quella, hai capito chi è? E L’altra? Sono io, non mi riconosci?Avevo i capelli più scuri e più lunghi. Trovi che così mi stiano meglio?”, ancora: “ Aspetta…di quella non ricordo il nome…sono passati un po’ di anni, ma ricordo che c’eravamo divertiti… le risate!”, poi “Questa è la foto della nostra cara E. (una delle responsabili della struttura) nel giorno del suo matrimonio e questa è di A., la nostra responsabile a cui voglio tanto bene. Invece questa è del mio matrimonio con il mio amore C..”. Dopo quest’ultima foto, con un sorriso se ne è andata in camera dicendomi che doveva telefonare proprio a suo marito, dato che nella giornata era riuscita a vederlo solo per mezz’ora, prima di rientrare alla Treccia. Siamo di nuovo alla descrizione fisica della struttura: la zona adibita al fumo, quasi indispensabile per le ospiti è situata in cima alle scale, questa è la parte della struttura più frequentata, perché la maggioranza delle ospiti fuma o comunque, anche coloro che non fumano, si fermano lì per chiacchierare. La sala da pranzo si trova nella prima porta a sinistra del corridoio. Prima di agosto, quando la Treccia ha subito dei lavori di ristrutturazione, questa stanza 79 veniva utilizzata dalle ospiti come sala fumo e come luogo in cui poter giocare a carte. La cena veniva consumata direttamente in cucina. Quest’ultima era sicuramente una delle tante particolarità della Treccia, a differenza degli altri dormitori maschili di S. Marcellino, dove la cucina e la sala da pranzo sono situate in due stanze separate. Quei tavoli quindi, all’interno della cucina, avevano un significato tutto particolare. Nel momento della cena, i sorrisi, lo scambio di battute fra volontari ed ospiti…, tutto dava l’impressione di essere in una casa dove si consumava una cena tra amici. Ritornando alla descrizione della struttura, lungo il corridoio, le altre porte che incontriamo a sinistra, sono quelle delle stanze delle ospiti. Le stanze sono tre; ognuna contiene due letti, due armadi, due comodini ed un mobile con diversi cassetti. Mi è difficile descrivere la loro esatta distribuzione perché ogni stanza ha la sua particolarità, niente è impersonale: nelle stanze le ospiti creano il loro spazio intimo28, ognuna a suo modo, attraverso foto, soprammobili, piccoli portafortuna o addirittura attraverso il disordine, riempiendo la stanza di scarpe o di vestiti perché un armadio non è sufficiente per contenerli. M., ad esempio, ha portato nella sua stanza un altro armadio per poter contenere tutti i suoi vestiti, che sono tantissimi e, oltre a questo, vi ha anche collocato un separè fra il suo letto e quello di A. che divide la stanza con lei, creandosi così la sua personale stanza.29 Quest’anno, ad agosto, quando la Treccia viene chiusa per quindici giorni, in quanto le ospiti, se vogliono, possono andare in vacanza nella casa estiva di S. Marcellino a Rollieres, all’interno della struttura, come ho in precedenza accennato, sono stati eseguiti dei lavori che ne hanno cambiato un po’ la fisionomia30e, in occasione dei lavori, si è fatto in modo che le ospiti riportassero le loro stanze un po’ alle “origini”, togliendo tutte le cose “superflue”, in particolare, facendo in modo che tutti i vestiti e le scarpe entrassero nell’armadio e nei cassetti disponibili, ricreando un po’ di ordine. Di questo “problema” si è discusso durante uno dei coordinamenti settimanali al quale ho avuto la possibilità di partecipare. Coordinamenti in cui si incontrano i responsabili delle varie strutture di accoglienza con gli operatori del Centro d’Ascolto, supervisionati dal responsabile dell’Associazione31. L., responsabile 28 “L’insieme delle proprietà personali ha un particolare rapporto con il sé. L’individuo ritiene, di solito, di esercitare un controllo sul modo in cui appare agli occhi degli altri. Per questo ha bisogno di cosmetici, vestiti e di strumenti per adattarli, aggiustarli e renderli più belli; di un luogo accessibile, sicuro, dove poter conservare queste scorte e gli strumenti di lavoro – in breve, l’uomo ha bisogno di un corredo per la propria identità per mezzo del quale poter manipolare la propria facciata personale.” E. Goffman, Asylums, Edizioni di Comunità, Torino, 2001, pp.49-50. 29 “ Se le persone fossero senza un sé, o venisse loro richiesto di esserlo, sarebbe naturalmente logico non possedere un luogo personale dove poter mettere la propria roba, (…). Ma tutti hanno un sè.” Ibidem, p.270. 30 Oltre all’aver spostato la sala da pranzo, è stata ampliata la stanza dei volontari. La descrizione che ne ho fatto in precedenza corrisponde a quella attuale. In precedenza, essendo meno spaziosa, i letti per i volontari erano a castello, mentre la mobilia, anche se è cambiata la sua distribuzione, è rimasta sempre la stessa. 31 I coordinamenti vengono fatti il mercoledì, giorno in cui il Centro d’Ascolto è chiuso; dalle 9:00 alle 10: 00, partecipano i responsabile delle strutture di prima accoglienza: Gradino, Angolo, Treccia e Archivolto e gli operatori del Centro d’Ascolto; mentre nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 16:00, partecipano i responsabili del Boschetto (comunità), del Ponte (comunità di vita), degli alloggi assistiti, il responsabile dell’Educazione al lavoro e gli operatori del Centro d’ascolto, entrambi con la supervisione del responsabile dell’Associazione. Questi coordinamenti avvengono 80 della Treccia, aveva da poco assunto questo ruolo, dando il cambio ad A.; il primo lavoro, secondo lei da fare era quello di ricreare nelle stanze ordine, in quanto, quest’ultimo, fa parte delle poche ma indiscutibili regole che le ospiti debbono rispettare, “La Treccia è un dormitorio, non una casa o una comunità, non è possibile che M. addirittura abbia portato un armadio in più!” . Per L. comunque, sarebbe stato un compito molto difficile riferire alle ospiti di ricreare “ordine” nelle proprie stanze. Questa richiesta, fatta direttamente da L., da poco alla Treccia e, come ho già accennato, al posto di A., con la quale la struttura è nata, avrebbe creato sicuramente ostilità tra lei e le ospiti. Così F., responsabile del settore alloggi, ha concluso la riunione, dicendo che avrebbe parlato lui con le ospiti, mettendo loro in evidenza che ad agosto, nella struttura sarebbero stati fatti dei lavori, per cui dovevano essere liberati tutti gli spazi. Infatti ad Agosto, al ritorno dalla vacanza di Rollieres ogni stanza era completamente in ordine. Ciò che le ospiti non sono riuscite a far entrare nei propri armadi, ognuna di loro, lo ha sistemato in una valigia. Tutte le valigie sono state messe poi in un armadio collocato in cima alle scale d’ingresso. Dopo pochi giorni dal rientro delle vacanze però, ogni stanza ha ripreso la sua particolare caratteristica: alcune scarpe a terra, vestiti appoggiati in un borsone, sempre presente. Una sera, entrando nella stanza di G. e S., ho notato un po’ di confusione; S. mi ha subito detto “Guarda che gran casino che ho fatto già! Devo assolutamente mettere a posto, altrimenti L. si arrabbia e chi la vuole sentire poi!”. Così ha infilato un po’ di cose in un borsone. Un borsone che manifesta la provvisorietà dello stare lì, ricorda che quella situazione non è per sempre. Ritorno alla descrizione fisica della Treccia: alla destra del corridoio, c’è un grande armadio contenente bagnoschiuma, shampoo, detersivo, assorbenti, phon, ferro da stiro, asciugamani e lenzuola. Questi oggetti, tranne asciugamani e lenzuola, che vengono cambiati un giorno prestabilito a settimana, possono essere richieste dalle ospiti, alla responsabile o alla volontaria di turno. Nell’ultimo tratto di corridoio, in fondo, ci sono i bagni: quello a destra è riservato ai volontari, mentre quello a sinistra è riservato alle ospiti. Sempre lungo il corridoio, a sinistra, dopo le stanze da letto, è situata la cucina. La zona cucina si sviluppa a destra con due lavelli e due blocchi di fornelli. I pensili riportano sopra scritto cosa contengono tramite delle etichette (pasta, sugo, tovaglioli di carta, piatti e bicchieri di carta, pentole, ecc.,…). La pulizia e il riordino della cucina vengono , di solito, eseguite dal volontario/a cuoco/a presente in quella serata, mentre le pulizie dei locali della Treccia vengono svolte ogni mattina dal gruppo – laboratorio di pulizia di S. Marcellino. Nella cucina poi, c’è una grande porta finestra per andare in terrazzo che è molto ampio e viene utilizzato dalle ospiti per stendere il bucato o indumenti. La cucina viene chiusa a chiave, per motivi di sicurezza, poco prima delle 22:30, orario in cui obbligatoriamente le ospiti si devono recare nelle loro stanze per il riposo. La cena alla Treccia, così come nelle altre strutture, che ho frequentato per alcune sere, rappresenta per eccellenza, il momento di incontro e di condivisione. in un’ampia sala, la cosiddetta saletta delle riunioni, con al centro una tavola in cui è collocato un foglio con su scritto l’elenco dei nomi delle persone da discutere, in base ai diversi ruoli degli operatori presenti. Attraverso i coordinamenti quindi, i vari operatori possono confrontarsi e discutere sulle varie persone seguite dall’Associazione, cercando di stabilire una “definizione della situazione” comune. 81 Durante la cena, spesso attraverso l’intervento dei volontari, si è quasi sempre riuscito a creare un clima “leggero”, allegro, in cui spesso si chiacchiera di cucina, di ricette. La cena rappresenta anche il momento in cui alcune ospiti possono fare le loro lamentele sul menù. M., ad esempio, non mangia mai pasta con il pomodoro, così a lei viene data sempre pasta in bianco, nonostante ciò, ogni tanto si lamenta perché c’è troppo olio, o la pasta è scotta, o il formaggio non ha più un buon odore. G., da quando ha ricominciato a mangiare, il mercoledì non fa altro che lamentarsi perché c’è il merluzzo che, secondo lei fa cattivo odore, mentre S. ne è addirittura allergica. A. e E., invece, non si lamentano mai della cena, così vengono prese in giro da G. e S.: “A voi va sempre tutto bene, ma non avete qualche preferenza? Non sentite i sapori?!”.Anche questo può essere inteso come un modo attraverso il quale la persona cerca di mantenere una propria dignità e soprattutto una identità.32Attraverso le lamentele le ospiti “impongono” la loro presenza, fanno sentire la loro particolarità, cercando “ciò che resta dell’immagine precedente al fine di preservare una immagine accettabile. (…). Queste microresistenze possono essere lette come un tentativo di creare, almeno per un breve periodo, un’immagine di sé che differenzi la persona dai suoi pari”33. Lo spostamento della sala da pranzo, attuata per ragioni di igiene, ha in un certo senso dato maggiormente alla Treccia le sembianze del dormitorio, anche se questo è solo un particolare. Molti volontari, al primo impatto quindi, hanno visto il cambiamento negativo, per alcuni la cucina era il particolare più significativo della Treccia perché la faceva sembrare una casa. Ma la Treccia è un dormitorio! Le regole che le ospiti devono rispettare lo ricorda, come ad esempio gli orari di entrata (dalle 19:00 alle 20:00) e di uscita il mattino (8:00) che sono tassativi così come l’orario della cena (20:30), del riposo (22:30), della sveglia (7:00) e della colazione (dalle 7:20 alle 7:40). Oltre al rispetto di questi orari, alle ospiti si richiede l’igiene personale e l’ordine della propria stanza, sobrietà, di non fumare al di fuori degli spazi consentiti e di non portare cibo o alcolici nel dormitorio, per cui nelle stanze non è consentito mangiare, così come in tutta la struttura al di fuori degli orari di cena e colazione. Queste regole si propongono di evitare che la persona si adagi in questa situazione, sperando che con il tempo arrivi ad una autonomia dalla struttura. Spesso però, in molte strutture di accoglienza, “Contrariamente a tali aspettative, tuttavia, la persona tende ad adattarsi al circuito e a sviluppare forme di dipendenza. Le tracce di autonomia (capacità di fare affidamento sulle proprie forze) progressivamente scompaiono, mentre i bisogni legati alla sopravvivenza sono soddisfatti unicamente dal circuito. (…). E’ questo un motivo ricorrente nei discorsi degli operatori: una volta istallatosi, il senza fissa dimora rifiuta di autonomizzarsi, si adagia nella nuova condizione, pur avendo a volte la possibilità di costruirsi un proprio percorso. (…). E’ il dilemma in cui si trovano gli operatori: si accetta di prendere in carico la persona, ma si teme paradossalmente di rafforzare con ciò la sua condizione di povertà.”34 32 “Essere poveri di identità significa non soltanto soffrire ma anche veder diminuire la propria capacità di sopravvivere.” In G. Jervis, La conquista dell’identità, Feltrinelli, Milano, 1999, p. 37. 33 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, p. 144. 34 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, p.149-150. 82 5. IL “SOGNO” DI UNA CASA La vostra casa è il vostro corpo più grande. K. Gibran, Il profeta. La Treccia, come ho più volte riferito, è un dormitorio di prima o, se vogliamo di seconda accoglienza. Come negli altri dormitori maschili, quali Angolo e Gradino, le persone possono restare per un periodo di tre mesi che possono essere rinnovati a seconda del caso. Alla Treccia G. è da tre anni presente, è lì da quando la struttura ha aperto. E’ stata sicuramente una delle figure femminili che ho conosciuto per prima e con la quale ho passato molto tempo: la mattina , quando veniva al Centro d’Ascolto, il pomeriggio alla Svolta, per fare una partita a carte ed infine alla Treccia. G. conosce alla perfezione ogni regola e ha vissuto tutti i cambiamenti della struttura. Rappresenta la figura leader e difficilmente le altre ospiti si ribellano alle sue richieste. Diverse volte, infatti è stata sorpresa dalla responsabile a farsi stirare i vestiti da una compagna della struttura e ogni volta si è scusata con L. dicendo “Secondo te non mi sto comportando bene? Pensi che io non sia pronta per una casa?”. Infatti G. sta aspettando una casa che dividerà con suo marito, alloggiato presso un’altra struttura di S. Marcellino; è importante quindi che si responsabilizzi anche sulle piccole e quotidiane azioni domestiche come lo stirare e il lavare! Gli ultimi giorni che ho passato alla Treccia, G. mi è sembrata molto più nervosa del solito. Una sera, che era abbastanza giù, mi ha confidato che non vedeva l’ora di lasciare la Treccia per trasferirsi nella sua casa; dove avrebbe potuto fare entrare solo chi voleva lei , dove avrebbe potuto mangiare quello che le andava e quando le andava “a differenza di qui che si mangiano sempre le stesse cose!”. Così ha iniziato a lamentarsi del menù ed infine della responsabile, facendo il confronto con la precedente. Mi ha detto di non sopportare la nuova responsabile perché con lei non è mai riuscita a confidarsi, a sfogare la sua rabbia e di non fidarsi di lei perché è da poco tempo che è alla Treccia, “Ho imparato a non fidarmi di nessuno! Ho paura di essere cacciata da qua”. Anche la sera successiva ha continuato a lamentarsi della cena e mi ha chiesto se per favore al posto del pesce poteva mangiare il formaggio. Dopo che le ho risposto che non era possibile, si è arrabbiata dicendo di essere stanca di stare lì e che tutto cambierà quando sarà nella sua casa. Non potendo sostituire il pesce con il formaggio, ha voluto, al posto del pane, crecker e, finita la cena, è rimasta seduta non permettendo di sparecchiare la tavola perché doveva finire di bere. Dopo cena sono rimasta a chiacchierare sul pianerottolo con G. e S.. G. mi ha detto che sono due anni e mezzo che non ha più problemi con l’alcol, “non ci credi? Sono stata brava! Poi lavoro tutti i giorni!”. Così si è messa a raccontare del suo lavoro nel laboratorio di lavanderia di S. Marcellino, “lavoriamo molto ed è per questo che la sera sono stanca!”. Parlando un po’ con il responsabile del laboratorio di lavanderia invece, ho scoperto che anche al lavoro G. dice di essere sempre stanca, delegando i lavori più pesanti agli altri . Dalle parole di G. ho 83 avuto la sensazione che per lei è normale che ci sia sempre qualcuno che deve fare qualcosa per lei, e non lei stessa, le cose le sono dovute, così come la casa: “con mio marito siamo andati a sentire per l’affitto di un appartamento, ci hanno chiesto 350 euro, ma che sono scemi! Io non ce li ho tutti quei soldi!”. La discussione poi si è spostata su altri argomenti perché S. ha cominciato a parlare della sua giornata, trascorsa per la maggior parte in biblioteca a leggere. Alle 22:30 ho fatto in modo che andassero al letto, e non sempre mi è stato facile ( mi riferisco a S. e G. che condividevano la stessa stanza, perché le altre solitamente alle 22:00 erano già a letto). Infatti appena ho detto loro che era l’ora di andare a dormire, G. si è subito accesa una sigaretta dicendomi “ tu puoi andare a dormire, non ti do fastidio, io non ho sonno!”, intanto S. è andata nella sua stanza. A quel punto inquietandomi un po’, le ho ricordato che si trovava in un dormitorio in cui bisognava rispettare delle regole precise. Finita la sigaretta, G. alzandosi mi ha chiesto se ero arrabbiata e, dopo averle risposto che andava tutto bene, mi ha abbracciata e dato il bacio della buona notte (come ogni sera). In quei nove giorni che ho passato alla Treccia, G. non ha fatto altro che parlare della sua ipotetica casa. La sera veniva in cucina a guardarmi mentre lavavo i piatti e per un po’ di mattine ha insistito per apparecchiare la tavola per la colazione. Sembrerebbe tutto molto semplice, fra un po’ di tempo, non so quanto, potrebbe anche essere un anno, G. e suo marito avranno una casa tutta loro. Nella realtà non è così scontato. Spesso ciò che accomuna le persone che per molto tempo hanno vissuto in strada è l’incapacità di stare dentro una realtà medio – normale. “Il processo di impoverimento che conduce gli individui a vivere sulla strada non consiste unicamente in una deprivazione crescente in più sottosistemi (abitativo, delle risorse economiche, delle relazioni primarie e secondarie, ecc.), ma comporti innanzitutto la perdita della capacità di assolvere a determinate funzioni”35. La capacità di rispettare alcune regole apparentemente basilari quindi, non può essere data per scontata e in certi casi vanno ricostruite perché non esistono. E’ proprio per questo che i tempi di permanenza alla Treccia, si sono sempre individualizzati. Come ho già ricordato G. è tre anni che si trova alla Treccia e sono molti di più gli anni con cui ha contatti con S. Marcellino. La casa è qualcosa di più che quattro mura, racchiude tutto un progetto di vita, racchiude la storia e l’identità delle persone che vi abitano. Possedere una casa implica delle responsabilità. A questo proposito voglio riportare una parte di un discorso di Pedro Meca, fatto a Genova ad un corso di formazione: “Non è indispensabile comunque passare dalla strada direttamente ad un appartamento, perché a volte non viene neanche sopportato questo: è troppo e non si sa come viverci. Quello che per me è importante è proprio educare le persone a vivere dentro una casa, perché vivere dentro una casa vuol dire anche instaurare dei rapporti con i vicini. E spesso quello che si fa è introdurre la strada in una casa, e non lasciare la strada ed entrare in casa.(…). Per dare un’idea, una persona che noi chiamiamo Gesù, tramite un’associazione riusciamo a trovargli un monolocale. Un giorno arriva al la Moquette con le chiavi dell’appartamento e dice : < ho già una casa.> Io gli ho detto: < Nascondi le chiavi, non metterle in mostra troppo.> Lui mi chiese il perché. Io risposi < perché se no tutte le persone vorranno venire lì e tu non li 35 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999, p.34. 84 farai entrare, quindi mettile via.> Lui mi ha detto: < Sì, è casa mia> e mi invitò ad andare lì. Io gli risposi che sarei andato quando sarebbe stata davvero casa sua. E lui: < No, è mia, ho le chiavi!> Io gli dissi : < Non ancora: cosa c’è sui muri?> E lui < No, non c’è nulla!> Allora gli risposi che doveva mettere qualcosa che dicesse che quella casa era veramente la sua”36 Dopo tanto tempo che si vive nella strada, si porta il modo di vivere nella strada in questa casa, e quindi “è un modo che non sta contro la persona stessa ma contro tutto il mondo esteriore (…). Si dice che la gente della strada non sa vivere. Come si può saper vivere se non ci sono le condizioni? Questo chiaramente presuppone uno sforzo con se stessi per riuscire ad avere dei rapporti, come si dice, normali. Perché ci sono delle cose che si perdono, e invece cose che si apprendono per vivere nelle diverse condizioni”37. Nonostante G. sia da più di tre anni alla Treccia, prima di passare direttamente ad una casa, avrebbe avuto bisogno di vivere all’interno di una casa- comunità, in cui oltre al rispetto di alcune regole, si costruisce un percorso di crescita grazie, ad esempio, alla presenza di riunioni settimanali, la partecipazione alla gestione della casa, occupandosi, ognuno, a turno, delle pulizie, della stesura della lista spese, della preparazione della cena, ecc. Percorso in cui ogni ospite “impara” a responsabilizzarsi e a divenire autonomo. La Treccia è un dormitorio di seconda accoglienza, per cui non ha le caratteristiche di una comunità, la provvisorietà si sostituisce alla stabilità. Le ospiti al suo interno devono rispettare alcune regole, ma non possono partecipare alla gestione della struttura; ciò sicuramente diviene penalizzante per coloro che vi alloggiano da molto tempo. In questo modo c’è il rischio che le persone che sono all’interno della Treccia da molto tempo (anni), come G., si adattino a vivere in questa struttura come se fosse una comunità, o addirittura la loro casa, adattandosi e adagiandosi alle sue regole, con il rischio di rimanere per sempre in quella situazione divenuta “normalità”. Quello che a noi può sembrare scontato o banale, per queste persone non lo è, come anche pagare una bolletta e svolgere tutte le piccole pratiche che una casa richiede. Anche il risparmio del proprio denaro è una cosa alla quale queste persone devono essere educate, come progettare il proprio futuro. Riportando ancora l’esempio di G. e di C., suo marito, mi viene in mente uno dei coordinamenti settimanali ai quali ho partecipato, in cui si parlava del fatto che fossero in graduatoria per l’assegnazione di una casa, ma nessuno dei due, nonostante il lavoro, aveva da parte dei soldi. Di questo me ne ha parlato poi anche G., dicendomi che, per risparmiare, ogni mese, lei e suo marito, lasciano dei soldi all’operatore del Centro d’Ascolto che si occupa di ognuno di loro cercando di limitare alcune spese superflue. Ha aggiunto che suo marito però non è molto d’accordo su questa cosa: “I suoi soldi se li vuole gestire lui perché non si fida!”. Il non fidarsi è un atteggiamento ricorrente tra le persone senza dimora. Anche questo atteggiamento può essere considerato come una micro-resistenza che la persona attua nei confronti del circuito38 dell’assistenza, esso manifesta anche il rifiuto della persona a riconoscere, a se stessa e agli altri, “la propria incapacità di uscire autonomamente, con le proprie forze, da una condizione problematica e critica” 39. Oltre a ciò, dobbiamo ricordare che la vita sulla strada è un’esperienza intensa, 36 Pedro Meca, corso di formazione “Operare con le persone senza dimora”, Genova, 12/04/2003. Ibidem. 38 M. Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999. 39 Ibidem, p. 141. 37 85 che mette a dura prova il soggetto. “< Ma non c’è solidarietà di strada?>, gli chiedo. <E’ una cazzata questa della solidarietà tra i barboni. Molti sono cani randagi, scappano da tutto e da tutti a partire da se stessi. Hanno scelto la libertà assoluta, vogliono stare soli, non chiedono carità, ma solo di essere lasciati in pace. E questi sono i meno peggio, si fanno i cazzi loro. I peggiori sono i topi, gente che non è degna di nulla>. <A chi ti riferisci?>. < A quelli che ti rubano le scarpe appena t’addormenti! Qui devi sempre dormire con un occhio solo e con un bastone in mano. Appena si avvicinano, colpisci! Con me non ci provano più. Ma posso resistere finchè sono giovane e forte. Quando la strada mi indebolirà, allora forse qualche sorcio m’ammazzerà. E’la legge della strada>”40. Ritornando alla specificità della donna senza dimora, P. Donadi dice che per quanto riguarda la donna, essa viene difficilmente inserita nella “categoria” del senza dimora e spesso viene inserita presso altre strutture di accoglienza, come ad esempio ospedali psichiatrici, comunità…, proprio perché “culturalmente” è considerata il fulcro della casa, della famiglia41. Utilizzando le parole di D., responsabile di S. Marcellino, “Dal punto di vista culturale è come se la donna prima di trovarsi nella situazione di senza dimora, dovesse stare di gran lunga peggio di un uomo”. Secondo i dati rilevati da Paci in una recente indagine, la differenza di genere nell’uso del tempo nella vita quotidiana speso per il lavoro familiare sono notevoli 42. Se consideriamo poi la presenza della donna nel mondo del lavoro, vediamo che ciò ha aperto il tema “della necessità di servizi sociali sostitutivi del suo compito in famiglia per la cura dell’essere umano non autosufficiente (neonato, bambino, vecchio, ammalato): ed è stato richiesto che il luogo lasciato dalle donne venisse ricoperto da donne, per cui si è avuta quasi solo presenza femminile nei compiti di aiuto domestico e si è avuta la nascita delle professioni di servizio ancora ad alta prevalenza femminile, dove l’eventuale presenza maschile necessita di venir precisata.(…). Il compito in famiglia è divenuto dunque le nuove professioni del sociale: puericultrici, maestre d’asilo, assistenti sociali, educatrici d’infanzia: in questi compiti una presenza maschile è tutt’oggi marginale, quasi deviante43. Nonostante siano cambiate sia la posizione della donna nella società, sia la sua presenza nelle professioni, entrambe però “mantengono un’attribuzione sessualizzata al compito: non si dice ad alcuno che una donna impegnata in una professione anche pulisce la casa, cucina, si prende cura del bambino, ma si infirma qualora anche l’uomo lo faccia, asserendo con ciò la caratterizzazione impropria del compito”44. Per quanto riguarda le donne senza dimora, penso che in un certo senso le storie di alcune possano mettere in discussione lo stereotipo della donna legata istintivamente alla casa e alla famiglia. La maggior parte delle ospiti che alloggiano alla Treccia, nonostante siano ognuna protagonista di storie diverse, hanno in comune il senso di precarietà e l’aver smarrito il senso della casa. Quest’ultimo, lo si sviluppa maggiormente crescendo in una famiglia e molte di loro non l’hanno mai avuta, altre hanno vissuto un’infanzia in un clima di 40 F. Bonadonna, Il nome del barbone, DeriveApprodi, Roma, 2001, p. 115. P. Donadi, Emarginazione e invisibilità delle donne senza fissa dimora, Montefeltro, Urbino, 1996, p. 153. 42 M. Paci (a cura di), Le dimensioni della disuguaglianza, Il Mulino, Bologna, 1993. 43 Ibidem, p.34. 44 Ibidem, p.34. 41 86 violenza e disamore; Il senso della casa quindi, come quello della famiglia sembrano essere anch’essi delle competenze culturali che, una volta perse e soprattutto, se mai possedute, sono difficili da recuperare. 6. IMMAGINI DELLA MATERNITA’ Dipingi rose… O madre affranta, in ogni petalo metti il tuo coraggio in ogni foglia una speranza. Sola non sei… Chi ti amava ancora ti ama Il tuo dolore selvaggio scioglie nel sole di quel fiore nascente. Renzo B., Fiore nascente Alla donna viene inevitabilmente accostata l’immagine della maternità, la madre istintivamente viene legata al proprio bambino. A questo proposito P. Donadi così scrive: “La donna si dice ha bisogno di essere madre, il suo legame con il figlio è diverso da quello paterno culturalizzato, è un legame naturale, istintivo, viscerale; la donna ha bisogno di un uomo che la protegga e, se pur impegnata in attività professionali, si sente bene dentro la casa, nei compiti di accudimento della prole. In questa confusione concettuale/semantica del significato di bisogno e di istinto, alla donna è attribuita anche una vocazione ai compiti cui sarebbe istintivamente legata: e il suo istintivo prendersi cura della prole in termini vocazionali si estende molto al di là del bisogno di quest’ultima, ove per bisogno si intenda un analogo del bisogno di cure materne di un animale”45. Se nel nostro immaginario riusciamo ad accettare il fallimento dell’uomo nell’essere padre, ci è molto più difficile farlo per quanto riguarda la donna. A tal proposito D., responsabile di S. Marcellino, mi ha riferito che nel corso dei lavori dei progetti europei sul come operare con la persona senza dimora, si sono spesso interrogati sulle differenze di approccio che gli operatori hanno nei confronti delle persone di sesso femminile, “ (…) in particolare vedevamo che c’era una certa ricorrenza di alcuni aspetti: la difficoltà a trattare problemi sulla sessualità in generale e, in particolare per le donne, la difficoltà a trattare i problemi legati ai figli, alla famiglia; questo indipendentemente dal sesso dell’operatore. La battuta che girava a quell’epoca era che se ognuno di noi riuscisse a reggere e a prendere in considerazione il fallimento della figura paterna, quella materna no!”. 45 P. Donadi, I luoghi della salute delle donne, FrancoAngeli, Milano, 1996, pp.28-29. 87 P. Donadi, afferma invece che: “Come avviene per ogni altro momento della vita umana, anche la riproduzione è un avvenimento che trova culturalmente, e non in un istinto geneticamente determinato, il proprio significato e il proprio avverarsi.”46 Per quanto riguarda le donne che per molto tempo hanno vissuto in strada, così come viene meno il concetto di dimora, spesso viene meno anche l’ “essere madre”, a causa delle storie pesanti che molte di loro hanno vissuto. Alla Treccia, ho scoperto che molte delle ospiti hanno figli alle spalle; alcune ne parlano, altre no. Confrontarsi con questa esperienza, dal punto di vista della struttura di accoglienza, risulta problematico, come emerge dalle parole di un responsabile: “Un grosso limite della Treccia è che è una struttura femminile monca, perché nell’esperienza femminile c’è anche la maternità; si accompagnano a vicenda nelle differenti forme. Tante di loro hanno figli alle spalle che sono stati tolti e sono sparsi per il mondo. Una di loro è rimasta incinta durante la sua permanenza alla Treccia e noi l’abbiamo accompagnata per un po’ fino a quando non è diventato più possibile. La donna ha con sé la maternità ed è per questo che la Treccia è monca, non ha attrezzature per farvi fronte”. Un giorno S. mi si è messa a raccontare di quando andava, con il suo compagno, in istituto a trovare il loro bambino. Mi ha toccato molto quando mi ha detto che, per motivi che non mi ha spiegato, per un po’ di tempo non è potuta andare in istituto e quando è andata e a preso il suo bambino in braccio, questo si è messo a piangere, non la aveva riconosciuta. Accanto a questo triste episodio, me ne ha raccontati altri, momenti felici, passati assieme a giocare, momenti in cui lo aveva con sé, il cambio dei pannolini, la preparazione dei pasti… Anche G. mi ha parlato di suo figlio, ora ha 19 anni. Mi ha fatto vedere una sua foto “mi assomiglia, non è vero?”. Una domenica, dopo essere rientrata alla Treccia mi ha raccontato della giornata passata con suo figlio, mi ha descritto dettagliatamente come era vestito: pantaloni militare e una maglietta elasticizzata, capelli tenuti con il gel, “Sai come sono questi giovani!”. Insieme hanno fatto una passeggiata e si sono presi un gelato. “Poi, lui se ne è tornato a casa ed io qua.” Un’altra sera invece, G., dopo aver ricevuto una telefonata, è rimasta per molto tempo in silenzio. Successivamente mi ha confidato che al telefono era suo figlio che le aveva detto di non voler più stare con i genitori adottivi perché lo trattano male. “Non lo vogliono più!”. Io non sapevo cosa dirle, le ho soltanto detto che quella è un’età in cui inevitabilmente si entra in conflitto con i propri genitori, poi passa. G. ha concluso il discorso dicendo che la sua era “uno schifo di vita.”Siamo rimaste in silenzio a fumare, poi G. è andata a letto. “Le donne in particolare, vengono anche colpevolizzate per non essersi realizzate nella loro femminilità, creando una famiglia (…). Raramente si considera che ci sono donne disperate per non aver potuto tenere con sé i propri figli a causa di problemi economici insormontabili, donne sempre più rassegnate a vivere un’esistenza misera fatta di ricordi e di speranze infrante. (…) è quindi comprensibile che le donne senza dimora possano vivere grandi conflitti interiori, depressioni e frustrazioni”47. 46 Ibidem, p.28. 88 7. QUOTIDIANITA’ ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA E RELAZIONE TRA LE OSPITI E’ difficile descrivere una serata – tipo all’interno della struttura. Ogni giorno è diverso dall’altro, anche se a volte intercorrono solo minime sfumature. Sono le ospiti con la loro emotività, con le loro delusioni, amarezze, silenzi, sorrisi, voglia di raccontare…, sono i volontari, ogni sera diversi, con le loro personalità, è la responsabile, che rendono ogni serata particolare, unica. Sicuramente l’esperienza di agosto, quando come volontaria ho preso servizio alla Treccia per nove notti, quasi tutte consecutive, mi ha permesso di inserirmi nella quotidianità della struttura e di avere maggiori contatti e confidenze con le ospiti. Nelle pagine che seguono, cercherò di descrivere la “vita” all’interno della struttura, mettendo in evidenza le particolarità che la caratterizzano. La prima volta che sono entrata alla Treccia è stata ad Aprile, un mercoledì. Il primo impatto… molto strano, ho avuto una sensazione di freddezza; nonostante A., la responsabile, mi avesse descritto la Treccia come un ambiente accogliente, caloroso. “Vedrai, sai come sono le donne, chiacchierone! E poi vogliono sempre tante attenzioni!”, mi disse. Invece E. se ne stava seduta nella poltrona in sala ad ascoltare la musica con lo walkman, sguardo fisso, sigaretta, una dietro l’altra; M., dopo essere arrivata, se ne è andata in camera, così come A. e A.; P., seduta nella poltrona, in silenzio a fumare; G.,dopo aver fumato anche lei una sigaretta, mi ha chiesto di giocare a carte (scala 40), io gli ho rivelato di non esserne capace; ha voluto giocare lo stesso, mi avrebbe insegnato lei. Nel frattempo A., la responsabile, ha chiarito loro il motivo per cui ero lì: una tesi di laurea su alcune strutture di S. Marcellino. Nessuna domanda. Ripensando poi a quel mio primo giorno alla Treccia, mi sono resa conto, quanto, nonostante fosse stata di per sé una serata un po’ tesa, i miei timori, la mia chiusura, abbia influenzato il mio stesso giudizio. Non potevo sentirmi in un ambiente caldo, accogliente, proprio perché io, per prima, non ero ancora pronta ad accogliere. Successivamente, ho imparato a conoscere e a prendere familiarità con la struttura, con i suoi tempi, le sue regole, ho imparato ad intrecciarmi con le ospiti e a capire il loro disagio, la loro sofferenza. E’ facile e allo stesso tempo difficile comprendere a pieno il dolore e la sofferenza degli altri; ciò è possibile solo cogliendo e analizzando la nostra personale sofferenza e il nostro dolore. Per capire il disagio che attraversa queste persone quindi, è necessario partire dal proprio disagio, è necessario mettersi in ascolto…E’ sicuramente una delle prime cose che ho imparato venendo a contatto con S. Marcellino. Porre tante domande, spesso anche le più banali, come il chiedere come stai possono toccare e infastidire. Una sera, ho chiesto a G. come mai la mattina non fosse venuta al Centro d’ascolto, “che t’importa? Io lavoro, non lo sai?”, mi ha risposto irritata. Così ho sempre lasciato che fossero loro a iniziare il racconto della loro giornata o 47 P. Donadi, Emarginazione e invisibilità delle donne senza fissa dimora, Montefeltro, Urbino, 1998, pp. 163-164. 89 delle loro esperienze. Spesso alcune hanno una gran voglia di raccontare, di renderti partecipe del loro vissuto, dei loro problemi. Una sera S. mi ha raccontato delle peripezie vissute con il suo ragazzo quando per un po’ di tempo hanno dormito nei vagoni dei treni, esordendo con: “adesso ti faccio morire dalle risate!”. Abbiamo passato tutto il dopo – cena , io e G., ad ascoltare le sue avventure. Un’altra sera, invece, mi ha raccontato dei momenti felici della sua infanzia, dei suoi genitori adottivi e di suo fratello, più piccolo di lei di due anni. Sicuramente S. era tra le ospiti, la più “chiacchierona”. G., invece non lo era, ma non l’ ho mai vista starsene da sola nella sua stanza; alle 19:00, ora in cui le ospiti possono entrare nella struttura, G., dopo aver salutato con un bacio la responsabile, me e le volontarie della cucina, si sedeva nella “zona” adibita al fumo, si accendeva una sigaretta e ascoltava i discorsi che le altre o i volontari intavolavano: solitamente si parlava della giornata trascorsa e ad Agosto, in particolare, del caldo soffocante; G. la sera diceva sempre di essere stanca per il lavoro e sbuffava per i dolori che spesso aveva allo stomaco, era una costante; E., invece, quando non ascoltava lo walkman, non faceva altro che parlare del suo lavoro che consisteva nel pulire le spiagge e si lamentava perché trovava sempre tutto sporco; ai suoi racconti G. e S. si guardavano tra loro e sbuffavano, tanto che un giorno G., sorridendo mi riferì di essere annoiata dai discorsi di E. perché non faceva altro che parlare di lavoro. A., non restava mai a chiacchierare con le altre, dopo essere entrata, aver salutato tutte in modo sempre pacato, dolce, usava il tempo a disposizione prima della cena, o per lavare qualche suo indumento, o per farsi una doccia per poi riposare un po’ nel letto; M., certe volte, restava con le sue compagne a chiacchierare o a farsi una partita a carte con G., altre volte, preferiva starsene sola nella sua camera a ricamare o a pulire perché aveva la fobia dello sporco. Spesso ho avuto la sensazione che queste persone fossero da sempre alla Treccia, come se fosse la loro casa, la loro “normalità”, come se niente potesse cambiare. Ma ogni volta che ritornavo a Genova, mi trovavo di fronte a dei cambiamenti e questo non solo vale per la Treccia, ma anche per le altre strutture: persone che se ne erano andate dal dormitorio, che per un po’ non si sono più presentate al Centro d’Ascolto ed altre che al loro posto si sono inserite, persone nuove o persone che già da anni l’Associazione conosceva. Ritornando alla specificità della Treccia, le persone descritte precedentemente, erano le ospiti presenti ad Agosto. Fino a metà Giugno tutte le sei stanze erano occupate, ma a metà Luglio A. è stata sospesa Con A. e la sua insofferenza a rimanere “dentro” la realtà della Treccia, si ripresenta di nuovo il discorso sulla specificità di questa struttura. Come ho già in precedenza detto, la Treccia si trova a svolgere, da una parte, il ruolo di una prima accoglienza; dall’altra, quello di una comunità, senza esserlo, ovvero senza avere all’interno gli strumenti presenti, di solito, in una comunità. A., è stata sospesa proprio perché i suoi problemi psichici, le sue fobie le rendevano la struttura soffocante e allo stesso tempo i suoi atteggiamenti mettevano a repentaglio il “quieto vivere” delle altre ospiti, soprattutto di quelle che da molto tempo vi alloggiavano. Se un ospite desidera farsi gli affari propri, lo può fare, perché la Treccia non è una comunità, è un dormitorio, ma tutto il sistema di “regole secondarie”, spesso difficile da percepire, creato dalle ospiti stesse, non sempre lo permette. All’interno della struttura, ogni ospite è informata sulle altre, “tutte sanno tutto di tutte”. Il fatto che A., avesse tagliato ogni contatto con le altre, creò un clima di tensione, ogni suo 90 movimento era tenuto sotto controllo. Una sera, dopo la cena, mentre stavamo chiacchierando, ho notato M. che in continuazione guardava verso il corridoio e ad un certo punto mi ha consigliato di controllare la cucina perché il giorno prima aveva visto A. rubare un pezzo di formaggio dal frigorifero. Allora G. è intervenuta dicendo di non sopportare più A. “e’ una pazza, non fa altro che trattarci male, noi non le abbiamo fatto niente!”, E. , sua compagna di stanza, ha continuato lamentandosi perché A., tutte le sere puliva la camera continuando a dire che c’era sporco da tutte le parti e ciò non le permetteva di dormire, “non ce la faccio più, io la mattina mi sveglio alle sei per andare a lavoro!”. Il mattino seguente, ho sentito M. e A. litigare vicino la porta della cucina, ho chiesto loro che cosa stava succedendo, così hanno cominciato ad insultarsi l’una con l’altra: M. accusava A. di essere una ladra, A. si difendeva dicendo a M. di farsi gli affari propri, “come ti permetti di accusarmi, sei forse la responsabile? La devi smettere di starmi sempre addosso!”. M. continuava dicendo che in quella struttura non era la sola a viverci, per cui non si poteva permettere di rubare le cose che non le appartenevano, mettendo a repentaglio la sicurezza di tutte. Io ho cercato di farle smettere e per fortuna dopo un pò ci sono riuscita; A. ha preso la sua borsa, una valigia con la quale, da un po’ di tempo, usciva tutte le mattine e se ne è andata; M. ha continuato dicendo che gliela avrebbe fatta pagare. Mentre A. e E. se ne erano già andate, G., ha ascoltato tutto in silenzio, ha aspettato M., e alle 8:00 sono uscite insieme. Se, ad un primo impatto, ho avuto la sensazione che tra le ospiti, ci fosse indifferenza. “Ognuno pensa per sé, ho imparato a non fidarmi di nessuno”, sono le parole di G., alcuni episodi confermano il contrario. Una sera M., dopo essere rientrata, si è subito ritirata nella sua stanza a piangere. Visto ciò, G. e S. mi hanno chiesto di andare a vedere che cosa era successo. Ho aspettato un po’, poi, prima di cena sono entrata nella stanza di M. per sapere come stava. M. mi ha confessato che stava piangendo perché tutto il giorno non aveva fatto altro che pensare a sua madre, morta mesi addietro, era stata assalita da una profonda nostalgia 48. A cena, M. ha cercato di non piangere e S., E. e G. hanno tentato di consolarla provando a farla sorridere. M. le ha ringraziate, ma subito dopo aver mangiato, ha chiesto il permesso di alzarsi per andare nella sua stanza. L’ho sentita uscire dalla sua camera diverse volte durante la notte. Il mattino seguente, era ancora giù di morale, le altre le hanno chiesto se andava meglio. M. ha risposto loro che prima o poi sarebbe passata e le ha ringraziate. Dopo aver fatto colazione in fretta, è uscita ad un quarto alle 8:00. Ad esso si possono unire altri piccoli episodi, come il preoccuparsi se qualcuno sta male, il parlare tra loro dei propri fidanzati, scambiandosi consigli…G. e S. erano sicuramente, all’interno della struttura, le più “impiccione”. Grazie a loro sono venuta a conoscenza di tanti piccoli pettegolezzi: di E. che aveva un ragazzo, lei non me ne aveva mai parlato, di G., ospite di un’altra struttura di S. 48 A tal proposito scrive P. Donadi: “ Dopo una giornata massacrante passata in strada, la donna arriva al dormitorio “distrutta psicologicamente e moralmente. (…): Sente l’angoscia della giornata appena trascorsa ed il peso di quella successiva. E’ questo un circolo vizioso che porta a desiderare di non pensare, si perde la speranza, la forza di essere protagonisti della propria vita e di volerla cambiare. Al contrario la malinconia e la voglia di piangere sono sentimenti sempre presenti”, in P. Donadi, Emarginazione e invisibilità delle donne senza fissa dimora, Montefeltro, Urbino, 1998, p. 153. 91 Marcellino, che durante le vacanze estive a Rollieres, ha fatto la corte ad A., “Li ho visti baciarsi!”, mi ha detto S., mentre G. sorrideva divertita. Ovviamente a me hanno fatto un sacco di domande in particolare sul mio fidanzato: ogni volta che mi squillava il telefonino G. mi chiedeva se era “il mio amore”. Così facevo con loro, quando le sentivo squillare i cellulari. Ciò non le infastidiva, anzi, G., ogni volta che chiamava C., suo marito, lo faceva tranquillamente davanti a me, spesso me lo passava, così S.. Tra le ospiti, tutte hanno un uomo, alcune lo stesso da molto tempo, come S. che sono sei anni che ha una relazione con S. con il quale ha avuto due bambini e G., sposata da tre anni con C. Molte di loro hanno relazioni con uomini possessivi, spesso violenti. S. ad esempio, alcune volte si lamentava della gelosia del suo ragazzo. Ma spesso è proprio quella gelosia che fa sentire alcune di loro amate, considerate e protette. P., un’ospite che ho conosciuto alla Treccia a Giugno, è stata sospesa perché per molti giorni non è rientrata a causa di una relazione con un uomo, violento, da cui è stata più volte picchiata. Una delle mie sere di Giugno alla Treccia, P.. senza che io le chiedessi niente, si è messa a raccontare della sua relazione, il suo compagno non voleva che lei stesse alla Treccia. Mi diceva di non amare quell’uomo, ma continuava la relazione perché voleva aiutarlo; ma ormai era decisa, lo avrebbe lasciato definitivamente, perché restare alla Treccia era troppo importante per lei…Non l’ho più rivista. Le donne sono le protagoniste della Treccia, con la loro emotività, le loro paure, le loro storie spesso difficili, dolorose, le loro malinconie; ma, nonostante ognuna di loro porti all’interno della struttura il proprio vissuto personale, la Treccia mantiene comunque la propria essenza, un proprio ritmo. Così A., la precedente responsabile, descrive la struttura: “Non ho mai pensato alla Treccia come a un dormitorio, mi è sembrata da subito una dimensione speciale in cui vite diverse hanno l’occasione di intrecciare e di scambiare quel patrimonio unico e irripetibile che ognuno porta con sé. (…). Ogni volontaria (volontario) quando arriva, apre un nuovo capitolo, porta un suo modo unico di stare in relazione, e quando alcune volontarie hanno, per diversi motivi, lasciato la Treccia, di nuovo l’hanno cambiata. Così le persone ospitate. All’inizio questo era molto evidente, due o tre ospiti nuove ricreavano il gruppo e mi sembrava ogni volta di ricominciare da capo. Poi ad un tratto la Treccia ha come assorbito un ritmo, un clima, le ospiti andavano e venivano, i volontari cambiavano un po’ e la Treccia restava la Treccia. Un luogo accogliente, allegro, difficile, caratterizzato dal bisogno di trovare modi per tradurre l’affetto. Un luogo caldo, vivo, dove si respira gratuità.” Affrontando il discorso sulla quotidianità all’interno della Treccia, mi è stato impossibile non trattare della relazione e del rapporto tra le ospiti. Tra esse, non ci sono sempre relazioni positive, non è facile una continua convivenza sotto lo stesso tetto, spesso si crea un clima teso, ostile, momenti di tensione. Le stanze poi sono doppie e, se alcune creano legami più solidi, altre mantengono una totale indifferenza. G. e S., ad esempio, che condividevano la stessa stanza, si sono legate molto. Spesso alle 19:00 rientravano insieme, restavano, prima di cena, a chiacchierare e a fumare nella saletta, a tavola, si sedevano vicine (G. a capo tavola e S. alla sua sinistra), la sera, andavano a letto allo stesso orario, difficilmente prima delle 22:30 (orario del riposo), il mattino erano le prime a sedersi a tavola ad aspettare la colazione e puntualmente facevano il bis; S. voleva sempre che io servissi per prima G.. Una mattina, per il bis di colazione, ho dato il 92 caffè rimasto prima a S. e lei subito mi ha detto che anche G. ne voleva, per cui avrei dovuto per primo servire lei. Alle 8:00 uscivano quasi sempre insieme, per aspettare l’autobus, poi, ognuno per la sua strada, fino la sera, di nuovo insieme alla Treccia. G., con la scusa di essere sempre stanca, alcune volte si faceva lavare la biancheria da S., si faceva stirare i vestiti e altri piccoli favori del tipo prenderle l’acqua perché non aveva voglia di alzarsi, le sigarette in camera…Piccoli favori che spesso anch’io le ho fatto! Continuando con la mia descrizione sulla quotidianità della struttura, è fondamentale che vi parli della cena. Quest’ultima rappresenta il momento in cui tutte le ospiti sono riunite insieme. La cena viene preparata, seguendo un menù settimanale fisso, dalle volontarie o volontari e servita in piatti di carta. Il tempo che si trascorre a tavola è dalle 20:30 alle 21:00 circa. Alcune cene sono silenziose, altre molto più allegre e vivaci e spesso sono proprio i volontari a renderle tali. I posti delle ospiti sono fissi, non è una regola, ma le ospiti in un certo senso fanno in modo che lo sia. G. a capo tavola, S. alla sua sinistra, M. alla sua destra, vicino a E., poi A., anche se alcune volte tra loro si sedevano i volontari, la responsabile a capo tavola, di fronte a G. Questo avviene anche quando si gioca a carte. Un giorno mi sono seduta al posto di G.; subito mi ha ripresa dicendo che quello era il suo posto, per cui dovevo spostarmi, l’ho fatto, anche se, secondo L., la responsabile, non avrei dovuto. Oltre ai posti a sedere che sono fissi, le ospiti spesso sono ancorate ad altre mansioni di routine, tipo il modo di apparecchiare la tavola. La prima mattina alla Treccia, distrattamente per la colazione apparecchiai con la tovaglia di carta, subito S. mi riprese dicendomi che la mattina, la tovaglia non si doveva mettere. Piccole cose che creano un senso di stabilità, come le regole che le ospiti devono rispettare; quest’ultime rappresentano una costante, una sicurezza e una protezione per le ospiti. La routine che si crea all’interno del dormitorio, diviene molto importante per queste persone che per diverso tempo hanno vissuto condizioni di bisogno estremo. Essa crea dei punti di riferimento spazio – temporali, ritmi definiti, che sono altri da quelli della strada49. Il sabato e la domenica, alla Treccia, si respira un clima un po’ diverso. Certe volte alcune ospiti non sono rientrate (ovviamente avvisando prima la responsabile), S., ad esempio, perché è restata con il suo ragazzo, A. da sua zia, E da suo padre,… Altre volte invece sono state tutte presenti; le volontarie della cucina o della notte, in questi due giorni possono portare dei dolci, per cui spesso lo fanno, creando un clima di festa, maggiormente rilassato. La sveglia della domenica, facendo un piccolo strappo alla regola, è alle 7:30, anziché alle 7:00, così come l’uscita che, invece di essere alle 8:00, è alle 8:30. La prima volta che ho fatto la notte il sabato, quindi la sveglia la domenica, non sapevo questa cosa, perché non è una regola vera e propria, così ho svegliato tutte al solito orario (le 7:00). G. e S., si sono alzate lamentandosi e subito dopo hanno preteso la colazione pronta, A., dopo essersi alzata senza dire niente, mi ha chiesto come mai avevano tolto quella piccola concessione, “almeno, uscita da qui , posso andare subito a S. Marcellino, a messa, se esco alle 8.00 non so come passare la 49 A. Meo, Vite in bilico. Sociologia della reazione a eventi spiazzanti, Liguori, Napoli, 2000, p. 143. 93 mezz’ora prima della messa.” Così ho spiegato ad A. che sarebbe potuta uscire alle 8:30 e che non c’era stato nessun cambiamento, solo un mio errore. G. e S. mi hanno ricordato questo errore per altri due o tre giorni, ovviamente scherzando. 8. RELAZIONE TRA LE OSPITI E GLI OPERATORI Rumori di rumori Rumori di silenzi Come il rumore soffoca il silenzio Il silenzio sveglia il rumore. Rumore grandioso Silenzio maestoso, più profondo è il silenzio più rumore si sente. Suoni squillanti Rumori eccitanti Utili suggerimenti Voci segrete. Attraverso le orecchie Giungono ai nostri cuori Dove il silenzio ci porta E si trasforma in rumore. Ascoltiamo il rumore del silenzio E facciamo silenzio Durante il rumore Renzo B., Rumori e Rumori Nei dormitori di seconda accoglienza dell’Associazione, l’organizzazione degli orari e del tempo è molto rigida50, questa impostazione è funzionale allo scopo che si propone l’accoglienza, quello di un’autonomia parziale o totale degli ospiti e, soprattutto, per ricordare loro, che non possono adagiarsi, ma devono stare dentro al percorso che stanno seguendo; inoltre rappresenta un tentativo per cercare di far riprendere le abitudini perse o mai avute, attraverso regole che adattano la persona 50 Ricordo di nuovo le regole che sono alla base della Treccia: • entrata: dalle 19:00 alle 20:00 • uscita: entro le ore 8:00 • riposo: ore 22:30 • sveglia: ore 7:00 • colazione: dalle 7:20 alle 7:40 Si richiede: • rispetto degli orari • igiene personale • sobrietà • è vietato fumare al di fuori degli spazi consentiti e portare cibo e alcolici nel dormitorio. 94 ad un certo ritmo, una certa routine. Lo stare insieme all’interno di una stessa struttura, permette alla persona di condividere la sua esperienza con le altre, facendola uscire “da una condizione di autismo”51. Anche alla Treccia queste regole debbono essere rispettate, ma, per quanto riguarda il rispetto della sobrietà, su certi casi, possiamo notare un diverso atteggiamento degli operatori nei confronti dalle donne rispetto a quello tenuto nei confronti degli uomini. Lasciare fuori dal dormitorio una donna, è per alcuni molto più difficile. “Per tutti la strada è molto violenta, per le donne lo è ancora di più” 52. Una donna sulla strada, difficilmente riesce a sopravvivere senza gravissimi danni, essa è esposta in primo luogo a rischi di stupro. Lasciare per una notte fuori una donna, ubriaca, significa sottoporla a tutti i rischi della strada. A., ex responsabile della Treccia, mi ha raccontato che una delle ospiti una sera è arrivata ubriaca. Nonostante ciò, l’ha fatta entrare; anche E. una sera è arrivata ubriaca; l’operatore presente non voleva farla entrare, ma E., disperata, si è messa a piangere attaccandosi al corrimano delle scale. E’ entrata. “In quei momenti hanno molta paura”, mi ha riferito la responsabile. E’ difficile stabilire cosa sia “giusto” fare in quei momenti. Spesso, nonostante la regola sia quella di lasciare fuori la persona, se arriva ubriaca, soprattutto per quanto riguarda la donna, la decisione di farlo dipende dall’operatore, dal suo punto di vista. Ovviamente a questo dobbiamo intrecciare lo stereotipo della donna come un essere fragile, indifeso, sottoposto a maggiori pericoli rispetto all’uomo53. Attraverso la regola della sobrietà, si cerca di aiutare l’ospite ad avere un approccio con l’alcol diverso da quello tenuto in precedenza, si cerca di presentare un altro punto di vista. A tal proposito, D., responsabile dell’Associazione, dice che la sobrietà è una delle regole principali da rispettare perché “ in questo modo l’ospite capisce che l’alcol è un problema, se non lo era fino ad allora, lo diventa, in questo modo è come dire all’ospite che se per te entrare ubriaco non ha nessun significato, per noi lo ha, l’alcol è un ostacolo tra te e la struttura!”. Per quanto riguarda il discorso sull’alcol e il personale approccio con esso, è anche l’operatore stesso ad essere chiamato in causa, in quanto è necessario che anch’egli si metta in discussione, che analizzi il suo rapporto con l’alcol. Se un ospite arriva alla struttura con l’alito che ha il sapore d’alcol, ma non è ubriaco, è molto difficile lasciarlo fuori, se si considera che è una cosa “normale” bere una piccola dose giornaliera di alcol. Ritornando alla specificità della Treccia e alle sue regole, le utenti hanno ognuna il proprio modo di porsi di fronte alle regole e soprattutto sanno quando possono non rispettarle pienamente. La responsabile in proposito sostiene: “ le tensioni scoppiano sempre quando io vado via (…) perché loro dopo non si sentono più 51 G. Pieretti, “Povertà estreme e interventi di matrice comunitaria”, in TRA, n. 1, 1999, p. 10. P. Donadi, Emarginazione e invisibilità delle donne senza fissa dimora, Montefeltro, Urbino, 1998, p.153. 53 Thomas e Znaniecki affermano che la causa di un fenomeno sociale o individuale non è mai un altro fenomeno sociale o individuale, ma è sempre una combinazione di un fenomeno sociale e di uno individuale. Facendo riferimento ai loro concetti di valore e atteggiamento, possiamo dire che la causa di un valore o di un atteggiamento non è mai soltanto un atteggiamento o soltanto un valore, ma è sempre una combinazione di un valore e di un atteggiamento. Il contadino polacco in Europa e in America, Comunità, Milano, 1968 52 95 controllate”. Le ospiti sanno bene quali sono le regole da rispettare e vedono la responsabile come colei che le rappresenta. Difficilmente fanno richieste fuori luogo, richieste che invece si possono permettere con i volontari, ovviamente me compresa. Spesso G. mi ha chiesto di andare a prendergli l’acqua, perché essendo stanca per il lavoro, non ne aveva voglia; il mercoledì, in cui a cena c’era il merluzzo, di darle al suo posto il formaggio, di aiutarla a rifare il letto, di darle una sigaretta…Richieste che non faceva assolutamente alla responsabile e nemmeno in sua presenza. La responsabile mi ha riferito che la cosa importante per le ospiti è quella di dimostrarsi a lei “brave”e spesso lo fanno parlando male delle altre ospiti, mettendosi a confronto. Nelle serate che ho trascorso alla Treccia non ho mai visto un’ospite ribellarsi direttamente alla responsabile, alcune di loro poi si lamentano, in sua assenza con i volontari, in particolare G. che, ogni qual volta veniva rimproverata da L., restava in silenzio facendole la faccia da disapprovazione alle spalle54. In sua assenza non faceva altro che lamentarsi, dicendomi che la precedente responsabile era molto più “buona” e lei le voleva un gran bene: “ L. è troppo dura con noi! Non siamo mica in un carcere!”. L., la responsabile, dovendo io trascorrere diverse notti nella struttura, mi ha consigliato di stare attenta e di non permettere loro di prendere il sopravvento su di me : “Sono molto furbe!”. A tal proposito mi ha raccontato che all’inizio del suo incarico, persino A., un’ospite che solitamente fa pochissime richieste, le ha domandato un lenzuolo pulito, sapendo benissimo che non era giorno di cambio; G. un giorno è arrivata dieci minuti prima delle 19:00, ha suonato il campanello, sapendo benissimo che prima delle 19:00 non si poteva entrare; si è giustificata dicendo che la responsabile precedente alcune volte lo ha permesso; era una bugia. Durante i primi giorni alla Treccia, le ospiti, quando non ero con loro, o perché in cucina, o perché nella stanza volontari, mi facevano in continuazione richieste: dell’acqua fresca, la carta-igienica, il detersivo, il ferro da stiro…G. e S. poi, ogni sera, cercavano ogni modo per non andare a letto alle 22:30: l’ultima sigaretta, l’ultima cosa da raccontare… Non essendo il mio ruolo, quello della responsabile, e soprattutto, essendo alla Treccia da poco tempo, in assenza di L., la Treccia, diveniva la loro “casa” a tutti gli effetti. Questo vale anche per le volontarie, soprattutto per le nuove. Infatti, come nei miei confronti, le ospiti, con le nuove volontarie, inizialmente si pongono in modo distaccato, osservano, come in difesa del proprio spazio e allo stesso tempo fanno molte richieste perché sanno che “la nuova”, non è ancora padrona della situazione. In questo modo poi, le ospiti vogliono sondare quanto sia stretto il rapporto tra volontari e responsabili. Più li sentono uniti e concordi, più sono coscienti che non possono prendersi molte libertà e allo stesso tempo ciò le fa sentire maggiormente protette. Il volontario, infatti, deve avere ben chiare le 54 “Se la funzione degli adattamenti secondari è quella di innalzare una barriera fra l’individuo e l’unità sociale di cui si presume faccia parte, dovremmo supporre che alcuni adattamenti secondari non offrano un guadagno intrinseco, e funzionino semplicemente per esprimere una distanza non autorizzata – il rifiuto di coloro che ti rifiutano – che serve alla propria tutela personale. La cosa sembra verificarsi nel caso di forme molto comuni di insubordinazione rituale, come per es. il brontolamento e le lamentele che in realtà non ci si aspetta portino a dei mutamenti. Attraverso l’insolenza diretta che non incontra un’immediata correzione, o osservazioni quasi non udite dall’autorità, o gesti fatti alle spalle, coloro che sono subordinati esprimono un distacco dal luogo loro ufficialmente accordato.”, in E. Goffman, Asylums, Edizioni di Comunità, Torino, 2001, p.331. 96 regole non dimenticandosi di mettere al primo posto l’accoglienza, deve saper stare in ascolto e non rischiare di sommergere le persone, rispettando il desiderio delle ospiti (negli orari tra la cena o tra la colazione), a volte, di nascondersi e riposarsi nelle proprie stanze; a volte è importante rispettare anche i silenzi. Per questo occorre stare sempre in ascolto di tutto ciò che accade. Per cui, il “compito” di ogni volontario/a, oltre che fare in modo che in assenza della responsabile, le regole vengano rispettate e che tutto proceda in maniera tranquilla, è anche quello di relazionarsi con le ospiti, creare nel miglior modo possibile un clima rilassato, accogliente, caldo. Ogni volontaria/o quindi, all’interno della struttura, porta la propria specificità. Il ruolo del volontario è importante, da non sottovalutare, in quanto, spesso, attraverso un buon piatto, una parola divertente durante la cena, una partita a carte, o semplicemente un sorriso, si riesce a stemperare momenti di tensione. Una sera, alla sede dell’Associazione, ho assistito alla riunione volontarie/i della Treccia, fatta anche in occasione del cambio della responsabile della struttura. F., responsabile del settore alloggi, mi aveva anticipato che la partecipazione delle volontarie/i alle riunioni sulla Treccia, era la migliore. C’è stata infatti un’adesione quasi totale: una trentina di donne e tre uomini i quali possono svolgere soltanto la funzione di cuoco. Alla riunione è stato richiesto alle volontarie/volontari di descrivere le sensazioni e le impressioni per quanto riguarda il proprio approccio con la Treccia. La cosa che maggiormente è uscita fuori è che, se all’inizio si fa volontariato alla Treccia con l’idea di aiutare, poi si scopre che l’aiuto maggiore lo si da a se stessi. A tal proposito voglio citare alcune considerazioni di Pedro Meca: “Quando parliamo dell’incontro con delle altre persone, innanzitutto bisogna tener presente che l’incontro più importante è quello che facciamo con noi stessi (…), noi diamo un’identità a queste persone: tu sei quello che non hai, (…), questo è il lavoro sociale: riempire ciò che manca. E’ un lavoro sociale utile, ma non è umano, (…): non è un rapporto tra persona e persona, ma tra persona e bisogno. Se non c’è reciprocità, non c’è rapporto umano.(…). Bisogna accettare il fatto che anche l’altro possa aiutare me, che si possa parlare delle cose quotidiane della vita come due esseri viventi normali (due persone). E questo è quello che io credo sia fondamentale dire alle persone che vengono come volontari: non solo essere disposti a dare qualcosa, ma anche a prendere e a ricevere”55. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Dopo un’analisi bibliografica del fenomeno e, soprattutto, dopo aver partecipato attivamente alla quotidianità vissuta all’interno delle varie strutture 55 Pedro Meca, Corso di formazione “Operare con le persone senza dimora”, S. Marcellino, Genova, 12/04/2003. 97 dell’Associazione e, in particolare, della Treccia, possiamo concludere col dire che la povertà estrema costituisce un’area di rottura del sistema della personalità, dei rapporti primari, e del senso di appartenenza, e necessariamente richiede che l’intervento sia caratterizzato da un certo grado di inventiva. Il fenomeno della povertà pare quindi estremamente colpito da questi cambiamenti e, se da un lato il fenomeno in sé balza in primo piano con significati quantitativi inediti, dall’altro, la povertà è una realtà che è stata sottoposta a profonde trasformazioni interne. “Partendo dall’ipotesi dei cambiamenti sostanziali, è nostro convincimento che dovrebbero essere adottate nuove strategie di intervento nell’intento di dominare un fenomeno le cui differenziazioni ed articolazioni sembrano aumentare in maniera decisa. Parlare di articolazione significa riconoscere che una situazione che in passato presentava un alto livello di omogeneità, allo stato attuale evidenzia situazioni dissimili, fra le quali quella comunemente definita come estrema povertà appare senza dubbio specifica. Il presupposto sul quale vorremmo basarci è che la povertà non dovrebbe più essere vista come una realtà omogenea ed unitaria; perciò anche gli interventi dovrebbero differenziarsi, cercando di introdurre alcune procedure maggiormente mirate allo specifico fenomeno”88. In particolare, abbiamo osservato che, all’interno della Treccia, confluiscono situazioni caratterizzate da una eterogeneità di percorsi biografici, a partire dall’età, dai tempi di permanenza presso la struttura, dai luoghi di provenienza, dalla condizione lavorativa, dalle problematiche e dalla situazione familiare. C’è molta eterogeneità nell’età; si spazia dai 18 anni ai 60. Per quanto riguarda i luoghi di provenienza, abbiamo notato invece che molte, tra le utenti della struttura, hanno sempre avuto la residenza a Genova, altre sono provenienti dal Sud d’Italia. La problematica psichiatrica è molto diffusa tra le donne senza dimora e la solitudine e le rotture familiari sono altri fattori dominanti tra le utenti, oltre la presenza di figli, quasi tutti in affido o in adozione. Altro problema è la mancanza di un lavoro nella storia di queste donne. Ciò è imputabile in parte ad un mercato lavorativo che privilegia il lavoratore maschile e lascia quasi esclusa la figura femminile. In relazione alla eterogeneità dell’utenza presente nelle varie strutture dell’Associazione in generale e nella Treccia in particolare, i progetti sono il più possibile personalizzati, le persone non vengono omologate, ma rispettate nella loro specificità e diversità. Sta proprio in questo la particolarità di S. Marcellino. Accanto alla notevole eterogeneità di percorsi biografici delle utenti della Treccia, possiamo però trovare un comune denominatore che sta nell’assenza di legami forti, nel senso di precarietà e nell’aver smarrito il senso della casa, della dimora intesa come spazio dell’anima, spazio per il Sé. Comune è l’incapacità di pensarsi come protagoniste della loro stessa vita, l’incapacità di stare dentro la “normalità, il mondo “normale”, quello della società, dei ruoli e delle forme sociali. Essendo le donne, le protagoniste della mia ricerca, non possiamo ignorare la specificità della povertà al femminile e le differenze di percorsi rispetto a quella maschile. E’ certamente vero che sulla strada gli uomini sono di gran lunga più numerosi delle donne, come evince da tutte le ricerche, ma questo dato non può autorizzare la cancellazione e il confronto con la povertà femminile che spesso sembra non incontrare risposte specifiche. Infatti la marginalità femminile viene 88 P. Guidicini, G. Pieretti, “Introduzione”, in P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995, pp. 14-15. 98 troppo spesso affrontata in modo asessuato, facendo nascere così un’emarginazione nell’emarginazione. La Treccia, all’interno del territorio genovese, ha svolto e sta svolgendo un compito importante che è quello di aver dato e di dare maggiore visibilità al problema della donna senza dimora che è un volto della povertà che, come ho detto in precedenza, rimane spesso nascosto e di difficile accettazione. BIBLIOGRAFIA Associazione San Marcellino, www. sanmarcellino.ge.it. Anderson N., The hobo. The sociology of the Homeless Man, The University Press, Chicago, 1924, tr. it. Il vagabondo. Sociologia dell’uomo senza dimora, Donzelli, Roma, 1994. Caritas Ambrosiana (a cura della), Barboni, Per amore o per forza? Senza dimora esclusione sociale, povertà estreme, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1996. Castel R., “Disuguaglianze e vulnerabilità sociale”, in Rassegna italiana di sociologia, n.1, 1997. 99 Commissione d’indagine sulla povertà e l’emarginazione, La povertà in Italia. Rapporto conclusivo della Commissione di studio istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Commissione Gorrieri), Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1985. Commissione d’indagine sulla povertà ed emarginazione, Rapporto sulle “povertà estreme” in Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento affari sociali, Roma, 1993. Baraldi C., Corsi G., Esposito E., Luhmann in glossario, FrancoAngeli, Milano, 1996 Becker H.S., Outsiders, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1997. Bergamaschi M., Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli, Milano, 1999. Bergamaschi M., “Emergenza di una nozione: L’esclusione come paradigma della coesione sociale. Dalla povertà alla società duale”, in TRA, n. 3, 1999. Berzano L., “Il vagabondo nella metropoli”, in Sociologia urbana e rurale, n. 35, 1991. Bonadonna F., Il nome del barbone, DeriveApprodi, Roma, 2001. Bosi M., Le incerte povertà, FrancoAngeli, Milano, 1992. Corbetta P., Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino,1999. Donadi P., Emarginazione e invisibilità delle donne senza fissa dimora, Montefeltro, Urbino, 1998. Donadi P., I Luoghi della salute delle donne, FrancoAngeli, Milano, 1996. Donadi P., Generi. Differenze nelle identità, FrancoAngeli, Milano, 2000. Escobar R., Metamorfosi della paura, Mulino, Bologna, 1997. Freud S., Opere, vol. X, Boringhieri, Torino, 1979. Geremek B., Les marginaux parisiens aux XIV et XV siécle, Flammarion, Paris, 1976. Geremek B., La pietà e la forca. Storie della misera e della carità in Europa, Laterza, Roma, 1998 Goffman E., Asylums, Edizioni di Comunità, Torino, 2001. 100 Goffman E., Stigma, Giuffrè, Milano, 1983. Guidicini P., Pieretti G., San Patrignano. Terapia ambientale ed effetto città, FrancoAngeli, Milano, 1996. Guidicini P., Pieretti G.(a cura di), Le residualità come valore, FrancoAngeli, Milano, 1993. Guidicini P., Pieretti G., I volti della povertà urbana, FrancoAngeli, Milano, 1992. Guidicini P., Pieretti G., Bergamaschi M.(a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995. Guidicini P., Pieretti G.(a cura di), Città globale e città degli esclusi, FrancoAngeli, Milano, 1998. Guidicini P., Pieretti G., Bergamaschi M.(a cura di), Gli esclusi dal territorio, FrancoAngeli, Milano, 1997. Guidicini P., Pieretti G.(a cura di), Tra marginalità e povertà. Uno studio sulle politiche di intervento pubblico a Ravenna, FrancoAngeli, Milano, 1989. Guidicini P., Martinelli F., Pieretti G.(a cura di), Città e società urbana in trasformazione, FrancoAngeli, Milano, 1985. Guidicini P., Nuovo Manuale della ricerca sociologica, FrancoAngeli, Milano, 1990. Guidicini P., Castrignano M., L’utilizzo del dato qualitativo nella ricerca sociologica, FrancoAngeli, Milano, 1997. Guidicini P. (a cura di), Gli studi sulla povertà in Italia, FrancoAngeli, Milano, 1991. Gui L. (a cura di), L’utente che non c’è. Emarginazione grave, persone senza dimora e servizi sociali, FrancoAngeli, Milano, 1995. Jervis G., La conquista dell’identità, Feltrinelli, Milano, 1999. Laè J. F., L’homme à la rue, étapes et figures de l’abandon, Plain Urbain, Paris, 1993 Levi P., I sommersi e i salvati, Torino, Einaudi, 1991. Loiacono M., Verso una nuova specie, Edistampa Nuova Specie, Lucera, 2000. 101 Luhmann N., Struttura della società e semantica, Laterza, Bari-Roma, 1984. Luhmann N., Sistemi sociali, Il Mulino, Bologna, 1990. Luhmann N., Potere e codice politico, Feltrinelli, Milano, 1982. Madge J., Lo sviluppo dei metodi di ricerca empirica in sociologia, Il Mulino, 1996. Malinowski B., Argonauti del Pacifico occidentale. Riti magici e vita quotidiana nella società primitiva, Newton Compton, Roma, 1973. Martinelli F., “Studi sulla povertà urbana nelle ricerche sociali e nell’intervento sociale”, in Sociologia urbana e rurale, n. 35, 1991. Meo A., “Il senza casa: una carriera di povertà. Osservazione sul campo a Torino”, in Polis, n. 2 1998. Meo A., Vite in bilico, Sociologia della reazione a eventi spiazzanti, Liguori, Napoli, 2000. Negri N. “Storie di povertà e incapacità”, in Sociologia urbana e rurale, n. 35, 1991. Paci M.(a cura di), Le dimensioni della disuguaglianza, Il Mulino, Bologna, 1993. Pagliaccia A., “Le malattie dei poveri”, in AA.VV., Avevo fame, I Martedì, Bologna, 1985. Pasolini PP., Scritti corsari, Garzanti, 2000. Piazzi G., La ragazza e il direttore, FrancoAngeli, Milano, 1995. Piazzi G., Il principe di Casador, Quattroventi, Urbino, 2000. Piazzi G., Teoria dell’azione e complessità, FrancoAngeli, Milano, 1984. Piazzi G., “Salute e malattia nel quadro della differenziazione funzionale della società: aspetti etici”, in Sociologia urbana e rurale, n. 29, 1989. Pieretti, “Povertà estreme e povertà silenziose: Il ruolo dei processi urbani”, in Sociologia urbana e rurale, n. 35, 1991. Pieretti G., Per una cultura dell’essenzialità, FrancoAngeli, Milano, 1996. Pieretti G., “Povertà estreme e interventi di matrice comunitaria”, in TRA, n. 1, 1999. 102 Pirandello L., Uno, nessuno e Centomila, Demetra, Varese, 1995. Quiroz Vitale M. A., “La marginalità dei senza fissa dimora, riflessioni su alcune forme di emarginazione urbana”, in Marginalità e società, n. 26, 1994. Rauty R., Homeless, Povertà e solitudini contemporanee, Costa&Nolan, 1997. Sen A. K., Il tenore di vita. Tra benessere e libertà, Marsilio, Venezia, 1993. Sen A. K., Risorse, valori e sviluppo, Bollati-Boringhieri, Torino, 1992. Tagliaferri G., “Donne senza dimora: il genere dell’emarginazione”, in TRA, n. 4, 1991. Thomas W. I., Znaniecki F., Il contadino polacco in Europa e in America, 2 voll., Milano, Edizioni di Comunità, Milano, 1968. Torre G., Sperati E., “La criminalità femminile minorile”, in Marginalità e società, n. 15, 1990. 103 104
Scaricare