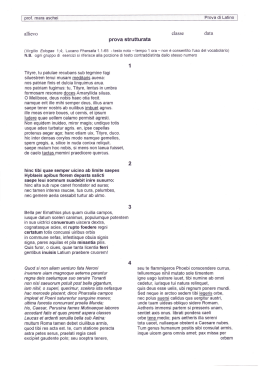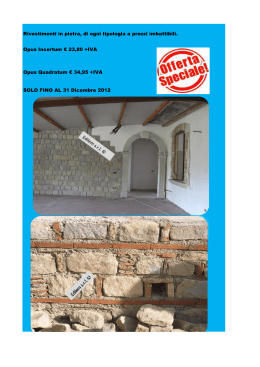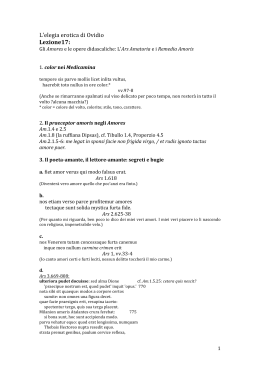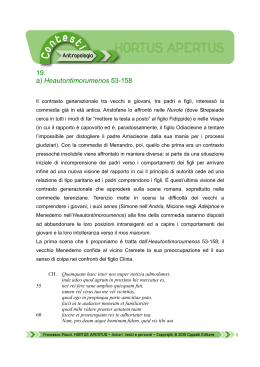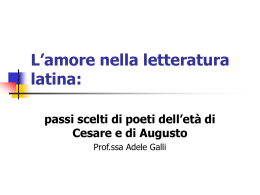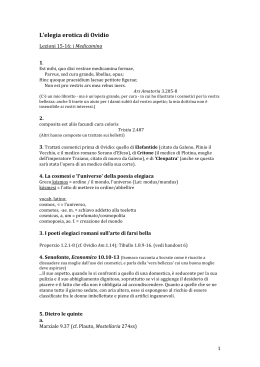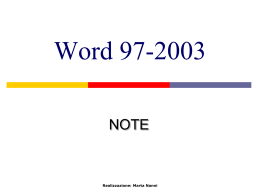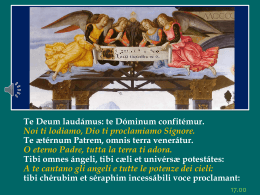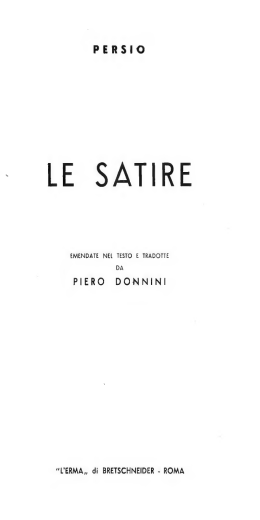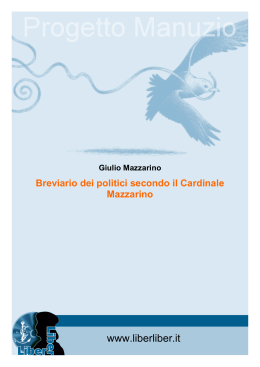Ov. Ars III 121-128 Prisca iuvent alios, ego me nunc denique natum gratulor: haec aetas moribus apta meis, non quia nunc terrae lentum subducitur aurum lectaque diverso litore concha venit, nec quia decrescunt effosso marmore montes, nec quia caeruleae mole fugantur aquae, sed quia cultus adest nec nostros mansit in annos rusticitas priscis illa superstes avis. Ov. Amores III 12, 41-42 Exit in immensum fecunda licentia vatum, obligat historica nec sua verba fide. Ov. Ars III 789-792 Sed neque Phoebei tripodes nec corniger Ammon vera magis vobis quam mea Musa canet; si qua fides, arti, quam longo fecimus usu, credite: praestabunt carmina nostra fidem. Verg. Buc. VI 3-5 Cum canerem reges et proelia, Cynthius aurem vellit et admonuit: «Pastorem, Tityre, pinguis pascere oportet ovis, deductum dicere carmen.» Prop. III 3, 13-24 cum me Castalia speculans ex arbore Phoebus sic ait aurata nixus ad antra lyra: «Quid tibi cum tali, demens, est flumine? quis te carminis heroi tangere iussit opus? Non hic ulla tibi speranda est fama, Properti: mollia sunt parvis prata terenda rotis; ut tuus in scamno iactetur saepe libellus, quem legat exspectans sola puella virum. Cur tua praescriptos evecta est pagina gyros? Non est ingenii cumba gravanda tui. Alter remus aquas alter tibi radat harenas; tutus eris: medio maxima turba mari est.» Ov. Amores I 1 Arma gravi numero violentaque bella parabam edere, materia conveniente modis. Par erat inferior versus; risisse Cupido dicitur atque unum surripuisse pedem. «Quis tibi, saeve puer, dedit hoc in carmina iuris? Pieridum vates, non tua turba sumus. Quid, si praeripiat flavae Venus arma Minervae, ventilet accensas flava Minerva faces? Quis probet in silvis Cererem regnare iugosis, lege pharetratae virginis arva coli? Crinibus insignem quis acuta cuspide Phoebum instruat Aoniam Marte movente lyram? Sunt tibi magna, puer, nimiumque potentia regna; cur opus adfectas, ambitiose, novum? An, quod ubique tuum est? tua sunt Heliconia tempe? vix etiam Phoebo iam lyra tuta sua est? Cum bene surrexit versu nova pagina primo, attenuat nervos proximus ille meos. Nec mihi materia est numeris levioribus apta, aut puer aut longas compta puella comas.» Questus eram, pharetra cum protinus ille soluta legit in exitium spicula facta meum lunavitque genu sinuosum fortiter arcum «Quod» que «canas, vates, accipe – dixit – opus!» Me miserum! Certas habuit puer ille sagittas! Uror, et in vacuo pectore regnat amor. Sex mihi surgat opus numeris, in quinque residat! Ferrea cum vestris bella valete modis! Cingere litorea flaventia tempora myrto, Musa per undenos emodulanda pedes! Ov. Amores III 9, 1-12 Memnona si mater, mater ploravit Achillem et tangunt magnas tristia fata deas, flebilis indignos, Elegeia, solve capillos. A! nimis ex vero nunc tibi nomen erit. Ille tui vates operis, tua fama, Tibullus ardet in exstructo, corpus inane, rogo. Ecce, puer Veneris fert eversamque pharetram et fractos arcus et sine luce facem. Aspice, demissis ut eat miserabilis alis pectoraque infesta tundat aperta manu; excipiunt lacrimas sparsi per colla capilli, oraque singultu concutiente sonant. Dante, Inferno XXV 49-138 Se tu se’ or, lettore, a creder lento ciò ch’io dirò, non sarà maraviglia, ché io che ‘l vidi, a pena il mi consento. Com’ io tenea levate in lor le ciglia, e un serpente con sei piè si lancia dinanzi a l’uno, e tutto a lui s’appiglia. Co’ piè di mezzo li avvinse la pancia e con li anterïor le braccia prese; poi li addentò e l’una e l’altra guancia; li diretani a le cosce distese, e miseli la coda tra ‘mbedue e dietro per le ren sù la ritese. Ellera abbarbicata mai non fue ad alber sì, come l’orribil fiera per l’altrui membra avviticchiò le sue. Poi s’appiccar, come di calda cera fossero stati, e mischiar lor colore, né l’un né l’altro già parea quel ch’era, come procede innanzi da l’ardore, per lo papiro suso, un color bruno che non è nero ancora e ‘l bianco more. Li altri due ‘l riguardavano, e ciascuno gridava: «Omè, Agnel, come ti muti! Vedi che già non se’ né due né uno». Già eran li due capi un divenuti, quando n’apparver due figure miste in una faccia, ov’ eran due perduti. Fersi le braccia due di quattro liste; le cosce con le gambe e ‘l ventre e ‘l casso divenner membra che non fuor mai viste. Ogne primaio aspetto ivi era casso: due e nessun l’imagine perversa parea; e tal sen gio con lento passo. Come ‘l ramarro sotto la gran fersa dei dì canicular, cangiando sepe, folgore par se la via attraversa, sì pareva, venendo verso l’epe de li altri due, un serpentello acceso, livido e nero come gran di pepe; e quella parte onde prima è preso nostro alimento, a l’un di lor trafisse; poi cadde giuso innanzi lui disteso. Lo trafitto ‘l mirò, ma nulla disse; anzi, co’ piè fermati, sbadigliava pur come sonno o febbre l’assalisse. Elli ‘l serpente e quei lui riguardava; l’un per la piaga e l’altro per la bocca fummavan forte, e ‘l fummo si scontrava. Taccia Lucano ormai là dov’ e’ tocca del misero Sabello e di Nasidio, e attenda a udir quel ch’or si scocca. Taccia di Cadmo e d’Aretusa Ovidio, ché se quello in serpente e quella in fonte converte poetando, io non lo ‘nvidio; ché due nature mai a fronte a fronte non trasmutò sì ch’amendue le forme a cambiar lor matera fosser pronte. Insieme si rispuosero a tai norme, che ‘l serpente la coda in forca fesse, e ‘l feruto ristrinse insieme l’orme. Le gambe con le cosce seco stesse s’appiccar sì, che ‘n poco la giuntura non facea segno alcun che si paresse. Togliea la coda fessa la figura che si perdeva là, e la sua pelle si facea molle, e quella di là dura. Io vidi intrar le braccia per l’ascelle, e i due piè de la fiera, ch’eran corti, tanto allungar quanto accorciavan quelle. Poscia li piè di rietro, insieme attorti, diventaron lo membro che l’uom cela, e ‘l misero del suo n’avea due porti. Mentre che ‘l fummo l’uno e l’altro vela di color novo, e genera ‘l pel suso per l’una parte e da l’altra il dipela, l’un si levò e l’altro cadde giuso, non torcendo però le lucerne empie, sotto le quai ciascun cambiava muso. Quel ch’era dritto, il trasse ver’ le tempie, e di troppa matera ch’in là venne uscir li orecchi de le gote scempie; ciò che non corse in dietro e si ritenne di quel soverchio, fé naso a la faccia e le labbra ingrossò quanto convenne. Quel che giacëa, il muso innanzi caccia, e li orecchi ritira per la testa come face le corna la lumaccia; e la lingua, ch’avëa unita e presta prima a parlar, si fende, e la forcuta ne l’altro si richiude; e ‘l fummo resta. L’anima ch’era fiera divenuta, suffolando si fugge per la valle, e l’altro dietro a lui parlando sputa. Ariosto, Orlando furioso XIV 92-94 Giace in Arabia una valletta amena, lontana da cittadi e da villaggi, ch’all’ombra di duo monti è tutta piena d’antiqui abeti e di robusti faggi. Il sole indarno il chiaro dì vi mena, ché non vi può mai penetrar coi raggi, sì gli è la via da folti rami tronca, e quivi entra sotterra una spelonca. Sotto la negra selva una capace e spazïosa grotta entra nel sasso, di cui la fronte l’edera seguace tutta aggirando va con storto passo. In questo albergo il grave Sonno giace; l’Ozio da un canto corpulento e grasso, da l’altro la Pigrizia in terra siede, ché non può andare, e mal reggesi in piede. Lo smemorato Oblio sta sulla porta: non lascia entrar, né riconosce alcuno; non ascolta imbasciata, né riporta; e parimente tien cacciato ognuno. Il Silenzio va intorno, e fa la scorta: ha le scarpe di feltro, e ‘l mantel bruno; et a quanti n’incontra, di lontano, che non debban venir, cenna con mano.
Scaricare