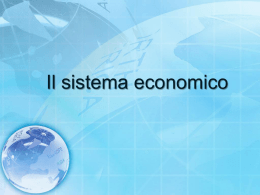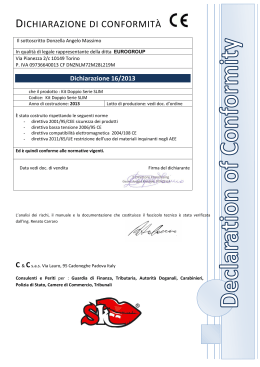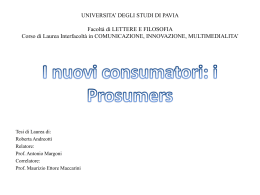IL KIT MULTIMEDIALE CONSUMACTION TEATRANDO Il materiale didattico che proponiamo agli insegnanti è stato realizzato nell’ambito del progetto “ConsumAction safe’n’sure - i giovani e la sicurezza dei prodotti“ volto a promuovere l’educazione al consumo consapevole e sicuro tra i giovani. Le attività, che hanno coinvolto scuole di cinque città europee, si sono svolte nell’anno scolastico 2002 - 2003 e 2003 - 2004, seguendo diverse tappe di lavoro finalizzate all’obiettivo di individuare i percorsi didattici più idonei per i diversi tipi di scuola e le diverse fasce di età. Il lavoro svolto ha consentito la produzione di un kit didattico multimediale, ideato con l’obiettivo di offrire ai docenti, in futuro, la possibilità di intervenire nelle classi avendo a disposizione materiali idonei a stimolare la riflessione dei giovani e favorire un comportamento consapevole, responsabile e critico. Gli insegnanti che hanno aderito all’iniziativa, hanno avuto a disposizione: - un corso di aggiornamento - laboratori didattici in cui poter discutere coi docenti del corso i propri interventi in classe - la collaborazione di esperti per quanto riguarda la scelta dei temi, degli strumenti didattici, delle informazioni sul tema della sicurezza dei prodotti - laboratorio teatrale a scuola con gli allievi - assistenza per la messa in scena dello spettacolo - riprese video. Il titolo del kit sottolinea l’esperienza di teatro: gli allievi di alcune classi che hanno aderito al progetto hanno realizzato, infatti, un saggio di fine anno con riprese video. Lo spettacolo è stato rappresentato nelle diverse città di fronte ad un pubblico numeroso di genitori, insegnanti ed allievi. In quell’occasione gli studenti hanno potuto condividere l’esperienza con le classi di altre scuole che hanno svolto lo stesso progetto e con le proprie famiglie, rappresentando in un teatro vero quanto fino a quel momento si era svolto nella quotidianità della propria aula scolastica. La videocassetta comprende soltanto una parte degli spettacoli e può fornire spunti per interventi didattici sullo stesso argomento; i testi dei copioni sono stati continuamente rielaborati dai ragazzi fino al giorno della recita finale; i materiali allegati e le riprese 1 effettuate nel corso dell’anno scolastico, danno comunque un’idea più completa delle attività che hanno portato alla scelta degli argomenti e al loro sviluppo. La dispensa contiene le relazioni svolte dai docenti del corso di aggiornamento per gli insegnanti svolto a Torino nell’autunno 2002. Iole Costantino Settore scuola Movimento Consumatori 2 SICUREZZA PRODOTTI E SICUREZZA GIOCATTOLI NELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA IL KIT MULTIMEDIALE C Cristina Barettini Parte I Al fine di ripercorrere rapidamente le tappe che hanno portato all’affermarsi del diritto comunitario dei consumi, occorre iniziare da molto lontano, cioè dall’ambito extracomunitario: l’attenzione per il consumatore, in quanto tale, e di conseguenza l’elaborazione di un diritto del consumo, nasce dagli Stati Uniti e solo indirettamente, trasmigrando in singoli Stati nazionali, arriva in Europa e si estende in ambito comunitario. Originariamente, il Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea, non prevedeva norme in materia di tutela del consumatore e, in realtà, neppure prevedeva il consumatore; non che questo tema fosse considerato poco importante, ma semplicemente non rientrava nella sfera di competenza, allora meramente economica, del legislatore comunitario. Infatti la Comunità Economica Europea è nata con finalità esclusivamente di collaborazione economica fra gli Stati. Con il Trattato di Maastricht, siglato nel ’92 ed entrato in vigore nel ‘93, la Comunità Economica Europea (CEE) è stata trasformata in una Comunità Europea (CE), proprio perché la sua finalità non è più solo quella di una collaborazione dal punto di vista economico, ma è più vasta: la collaborazione si apre anche ad altri aspetti relativi al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, non puramente economici, come il garantire un ambiente più sano, prodotti più sicuri, migliori possibilità di istruzione, di formazione, culturali... In realtà, tuttavia, la politica comunitaria del consumo e, di conseguenza, anche la produzione normativa relativa nascono prima del ’93: la Comunità comincia cioè a prendere atto dell’esigenza del consumatore di essere tutelato già prima dell’inserimento nel Trattato, che avverrà appunto nel ’93, di una specifica base giuridica. L’attenzione per il consumatore nasce sul modello statunitense, e quindi viene inizialmente vista non come un’istanza di natura economica, bensì come un’istanza di natura sociale: proteggere il consumatore in quanto soggetto socialmente debole, con 3 un’attività di tipo sociale, non rientrava tra gli obiettivi originari della Comunità. Successivamente, viceversa, si sviluppa un approccio alla problematica del consumatore tipicamente europeo, perché vede il consumatore come operatore economico del mercato al pari degli altri operatori e quindi ritiene che il consumatore vada tutelato non tanto perché ha bisogno di difesa, ma perché, per ottenere un efficace meccanismo di concorrenza sul mercato, è necessario che tutti gli operatori giochino a parità di forze a livello contrattuale: quindi, dove il consumatore ha minore forza contrattuale, va sostenuto e tutelato. Ecco perché la Comunità comincia ad introdurre, in un primo momento, delle azioni politiche e poi addirittura delle normative a protezione del consumatore. Per interpretare l’iter di formazione del diritto del consumo dobbiamo partire dagli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, già alla fine dell’800 si erano riscontrate alcune forme di associazionismo tra consumatori; dal punto di vista giuridico, però, la sensibilità per i problemi del consumo nasce in maniera significativa nei primi decenni del ‘900. Si verificano, nel particolare, alcuni fatti che hanno come conseguenza il concentrarsi dell’attenzione sui problemi del consumo. Nel 1906 si determina un incidente che ai nostri occhi sembra attuale, moderno: si verifica un caso di vendita di carne avariata con conseguente avvelenamento di molte persone; si tratta di un grosso problema di salute pubblica, al quale il legislatore, con l’obiettivo di proteggere il consumatore, reagisce emanando due atti normativi settoriali: una legge sugli alimenti e medicinali genuini ed una legge più specifica sul controllo delle carni. Successivamente si verifica un altro rilevante problema di sicurezza prodotti: si tratta di un’automobile difettosa, nel senso che una ruota si spacca mentre l’auto è in movimento, e la signora seduta accanto al guidatore si ferisce nel conseguente incidente; l’interessato si è rivolto al giudice e, per la prima volta, il diritto statunitense ha individuato una responsabilità e quindi un onere risarcitorio a carico del produttore dell’auto. La cosa era assolutamente nuova per il diritto statunitense, perché vigeva, nel diritto anglosassone, il principio della “privity” del contratto, per cui questo può avere effetto solo sulle parti contraenti; di conseguenza, il contratto di compravendita stipulato per l’acquisto dell’auto poteva avere effetti solo sul concessionario e sul consumatore, ma non sul produttore. 4 Questo principio, nel diritto statunitense, era molto rigido e radicato. Il consumatore acquista, nel caso di specie, un’automobile non direttamente dal produttore ma dal concessionario e quindi il suo contratto di acquisto di automobile ha effetti solo su di lui e sul concessionario; a causa dell’automobile difettosa la moglie si fa male, chiede il risarcimento all’unico altro soggetto coinvolto e cioè al venditore; il concessionario, però, obietta che l’automobile è chiaramente uscita difettosa dalla produzione perché lui non l’ha usata, come l’ha presa l’ha venduta, quindi, in realtà, il soggetto che deve pagare è il produttore. Per il diritto statunitense questo non è possibile, perché il produttore non ha stipulato alcun contratto con il consumatore, e quindi non c’è alcuna possibilità, per il consumatore danneggiato, di ottenere un risarcimento dal produttore, soggetto di per sé responsabile del danno. Il giudice, nel 1916, riconosce, con una sentenza fortemente innovativa, la responsabilità del produttore nei confronti del consumatore. Questa inversione è dovuta anche al fatto che il produttore è il soggetto più adatto a sopportare i costi, cioè quello che tendenzialmente, in genere, è più forte economicamente; dal momento che il venditore, in questo caso il concessionario, frequentemente non dispone di risorse finanziarie sufficienti a risarcire un danno fisico, che è comunque molto costoso. Ne consegue che il produttore è il soggetto che tendenzialmente ha più risorse finanziarie, è quello che più facilmente può assicurarsi, e quindi viene chiamato a pagare a vantaggio del consumatore. Successivamente si verificano negli Stati Uniti altri fatti significativi. Nel 1936 si ha un serio problema relativo ai prezzi dei prodotti di consumo giornaliero: a Detroit scendono in piazza le casalinghe, che non hanno più denaro sufficiente per acquistare i beni di consumo corrente; la conseguente azione di boicottaggio si diffonde anche ad altre città degli Stati Uniti, e sfocia in una sollevazione popolare che porta avanti l’istanza di avere un controllo sui prezzi di modo che non siano a livelli insopportabili per le famiglie. A seguito di questa lotta unitaria per una stessa finalità, nasce il potente movimento dei consumatori degli Stati Uniti, che porta avanti nel tempo le istanze dei consumatori. Si verifica, gradualmente, un incremento dell’attenzione per il tema del consumo, che si riflette nelle leggi, nella giurisprudenza ed in azioni pratiche portate avanti dalle associazioni di consumatori; è comunque un’attenzione che si estende e si amplia molto, tanto che negli anni ‘60 i presidenti Kennedy e Johnson citano l’importanza della 5 protezione dei consumatori. Come ha avuto modo di affermare il presidente Kennedy, “tutti noi siamo consumatori”; in effetti non si tratta di una categoria, di una fascia di popolazione, ma di tutti, e ne consegue quindi l’interesse di tutti per i connessi aspetti dell’economia. Una forte spinta ulteriore è data, nel ’65, da un nuovo caso giurisprudenziale che ha enorme impatto: è il caso di una serie di automobili difettose prodotta dalla General Motors; i compratori subiscono incidenti con danno alla salute e ne conseguono richieste risarcitorie elevate. Si occupa di questo caso un giovane avvocato alle prime armi, Ralph Nader, il quale ha avuto l’idea di raccogliere tutti i danneggiati da questo stesso difetto in una causa unica, la cosiddetta “class action”: si tratta di un’azione collettiva propria del diritto statunitense, che consiste, in sostanza, nel promuovere contro il produttore un’unica azione, che coinvolge l’intera categoria dei soggetti che hanno subito tutti lo stesso tipo di danno dallo stesso tipo di prodotto. Ovviamente, la “class action” sostiene molto l’interesse dei consumatori, perché rappresenta non solo tutti i danneggiati, ma anche i probabili danneggiati che non si sono potuti rintracciare. Tutta la classe dei danneggiati dal tipo di autovettura in questione, quindi, assistita dall’avvocato Nader fa causa alla General Motors e, sorprendentemente, vince la causa; sorprendentemente, perché si tratta di un avvocato giovane e non famoso e per il fatto che la General Motors ha una squadra di avvocati difensori ben più esperti e smaliziati. Il compenso dell’avvocato, per il diritto statunitense, è proporzionale all’importo della lite, e non, come da noi, una parcella a seconda delle prestazioni: questo incentiva gli avvocati ad impegnarsi al massimo per far avere al cliente grossi risarcimenti – infatti, negli Stati Uniti i risarcimenti per problemi di consumo sono strepitosi. L’avvocato Nader ottiene una parcella significativa ed ha la lungimiranza di investire nell’attività a favore dei consumatori.Tra l’altro, pubblica un libro che sostiene fortemente le istanze dei consumatori e dà un notevole impulso alla loro richiesta di protezione. La ricezione in Europa di questa forte ondata di consumerismo passa attraverso i Paesi più sensibili agli sviluppi e alle novità che provengono da oltre Oceano: il Regno Unito, per motivi storici e di affinità culturale e linguistica; la Scandinavia, che per la sua collocazione geografica ha avuto sempre più facilità a recepire i trends anglosassoni; e poi l’Europa centro-settentrionale in generale. I singoli Stati europei non recepiscono però globalmente le esperienze statunitensi: resi 6 attenti dalla sensibilità che sta nascendo per il consumatore oltreoceano, significativamente, si concentrano ciascuno su degli aspetti particolari della tematica consumerista. In Germania, per esempio, già dagli anni ‘30 c’è una scuola molto importante, guidata dal Raiser, che si occupa in particolare dei problemi dei contratti standard. Questa scuola mette in evidenza il fatto che tali contratti sicuramente sono utili perché accelerano le transazioni sia a favore delle imprese che a favore del consumatore, però possono nascondere qualche trabocchetto. Il consumatore, o comunque l’aderente, viene chiamato a firmare questo contratto: visto che difficilmente riesce a leggere e comprendere tutto (anche perché talvolta le clausole sono scritte in piccolo, con carattere chiaro su sfondo scuro, o sono espresse in una terminologia non facilmente comprensibile), la controparte potrebbe essere tentata di inserire qualche clausola più vantaggiosa per sé e meno vantaggiosa per l’aderente. La dottrina tedesca cerca di individuare una soluzione adeguata a questi problemi. D’altra parte, nel Regno Unito la giurisprudenza contrasta in particolare le pratiche commerciali sleali, e primariamente l’esclusione delle garanzie. Un approccio simile si ha in Scandinavia; nei vari Paesi scandinavi si è sviluppato, in particolare in materia di consumi, ma in realtà in generale, un modello piuttosto unitario del diritto; sono ordinamenti diversi tra loro, però si evolvono intorno a un nucleo comune e quindi sono abbastanza simili; tra l’altro, in tutti questi Paesi è stata introdotta una clausola generale che prevede che non possono essere ammesse pratiche che violano la buona fede a livello commerciale. Nei primi decenni del secolo, quindi, si riscontra un’attenzione specifica per le esigenze di protezione del consumatore da parte di singoli Paesi europei, anche se non si può parlare di un’attenzione europea in generale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, invece, la sensibilità per le questioni del consumo si diffonde per tutta l’Europa occidentale: ormai si sono estesi ampiamente i mercati di massa, cioè produzione e distribuzione avvengono in serie e non c’è quasi più, per esempio, l’artigiano che fa il tavolo e il compratore che va direttamente a comprarsi il tavolo; ormai si tratta di una produzione in serie e della successiva vendita nei vari negozi, quindi, in sostanza, si ha un venir meno del rapporto personale e anche del controllo del prodotto e delle condizioni contrattuali da parte del consumatore: questi non può che accettare, così com’è, uno dei beni che gli vengono offerti; in realtà, può anche non accettare, però non ha nessuna influenza su come il prodotto può essere fatto o su come il contratto può essere 7 redatto. Ecco allora che si verifica uno squilibrio nel rapporto tra il produttore e il consumatore, il quale, in realtà, non ha più alcun rapporto con il produttore ma ha un rapporto con il distributore. Di conseguenza, la dottrina comincia a domandarsi se possa ancora parlarsi di potere contrattuale del consumatore e di libertà contrattuale. La teoria classica del contratto negli ordinamenti romanistici prevede il contratto come punto di incontro tra due libere volontà, le quali, attraverso una contrattazione, una discussione, un avvicinamento delle rispettive esigenze, alla fine trovano un punto di incontro che le soddisfa entrambe: a questo punto si redige il contratto. Questo tipo di contratto andava bene quando l’artigiano e il compratore si sedevano ad un tavolo, discutevano, stabilivano le modalità e trovavano una soluzione sufficientemente soddisfacente per entrambi. Adesso invece no, perché il consumatore non può che scegliere tra diverse opportunità che gli vengono offerte, altrimenti deve rinunciare al contratto, con il fatto ulteriore che tante volte una rinuncia alla stipulazione del contratto è quasi impossibile. Pensate, per esempio, all’apertura di un conto corrente in banca: è vero che se si va in una certa banca bisogna accettare le condizioni da questa imposte, però si è liberi di cambiare banca; ma è anche vero che le condizioni bancarie sono pressoché uguali; si è anche liberi di non avere un conto corrente in banca, però vivere oggigiorno senza un conto corrente è pressoché impossibile, e quindi il consumatore è praticamente obbligato ad accettare quelle condizioni; e così accade per molti altri settori. In sostanza, nel secondo dopoguerra si diffonde l’idea che il consumatore ha meno potere contrattuale rispetto all’altra parte, per cui c’è un disequilibrio. Negli anni ‘50, di conseguenza, vengono a formarsi diversi gruppi rappresentativi dei consumatori, sempre a livello nazionale e non a livello comunitario, perché la Comunità nasce nel ‘57. Negli anni ‘70, la Comunità Economica Europea esiste già da un bel pezzo; ciò nonostante, non legifera in materia; si hanno però varie esperienze di legislazione nazionale. I primi Paesi europei cominciano ad emanare delle leggi di protezione del consumatore. Una delle prime è la legge tedesca sulle condizioni generali del contratto, punto di arrivo delle riflessioni cominciate da Raiser e dalla sua scuola negli anni ’30. A livello comunitario, che è il livello che ci interessa, inizialmente non c’è nulla, nel senso che il Trattato di Roma del ‘57 non menziona la protezione del consumatore tra gli obiettivi della Comunità. Ogni intervento legislativo della Comunità deve trovare una 8 base giuridica nel Trattato; tuttavia, con il tempo il legislatore comunitario ha trovato nel Trattato alcuni agganci per individuare una base giuridica in via indiretta, intendendo l’obiettivo del costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri non più in termini esclusivamente economici, ma in senso più ampio: anche essere protetti come consumatori fa vivere meglio, e quindi indirettamente in questo riferimento alle condizioni di vita si è individuata una base giuridica implicita per emanare direttive a protezione del consumatore. Un ulteriore collegamento indiretto si è trovato nel fatto che il Trattato parla anche della necessità di agevolare lo sviluppo armonioso nella vita economica: ciò rende necessario tutelare la situazione degli operatori più deboli, e quindi, perché ci sia armonia, è necessario intervenire a tutela dei consumatori. Da un’altra ottica, invece, si è rilevato che era necessario un intervento comunitario non solo per creare diritto e creare protezione, ma anche per armonizzare le norme varate nei singoli Stati membri, perché i singoli Stati avevano già emanato normative nell’ambito del diritto del consumo, ciascuno a modo suo, e quindi facilmente queste erano discordanti. Ciò creava un ostacolo alla libera circolazione delle merci e dei servizi. La disomogeneità delle regolamentazioni presenti a livello nazionale andava superata con una forma di omogeneizzazione, per consentire la libera circolazione delle merci e dei servizi. Proprio questo è l’obiettivo previsto dal Trattato fin dal ’57, dove parla di libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi, dei capitali. La libera circolazione deve avvenire in un mercato concorrenziale, il quale serve a creare migliori condizioni di vita e di lavoro perché la concorrenza, tendenzialmente, porta all’affermarsi sul mercato di un migliore rapporto qualità-prezzo, quindi alla possibilità per la gente di ottenere prodotti migliori ad un prezzo più basso possibile. In sostanza, anche l’importante riferimento alla libera circolazione autorizza ad emanare legislazione in materia di consumo. In definitiva, l’origine del diritto comunitario dei consumi è precedente all’istituzione della politica dei consumi nel Trattato. L’elaborazione delle regole giuridiche è preceduta da programmi quinquennali, non rigidi, ma che contengono semplicemente delle previsioni di attività che si vogliono intraprendere nel lustro successivo. Il programma quinquennale del ’75 è il primo programma quinquennale per una politica di protezione nei confronti dei consumatori. L’approccio comunitario è basato in particolare sulla tutela della possibilità di libera scelta del consumatore, mentre l’approccio statunitense 9 è, per molti versi, un approccio più paternalistico. Quindi la nostra politica del consumatore è data dalla necessità di informare proprio per garantire una libera scelta da parte del consumatore. Il programma prevede un’incentivazione alla politica di protezione e di informazione dei consumatori per due scopi: uno è quello dello stimolo alla tutela del consumatore nei singoli Stati membri, e vedremo come il diritto comunitario procede nella tutela del consumo principalmente con delle direttive che vengono poi recepite dagli Stati membri; l’altro scopo è quello di un’armonizzazione dei diritti nazionali, dovendo andare verso un mercato unico dove le merci circolano liberamente ed i diritti nazionali non devono essere in contrasto. Si cita inoltre un fatto importante, non strettamente legato alle transazioni: quello della partecipazione dei consumatori al processo di costruzione europea che si sta attuando e richiede la partecipazione di tutti gli operatori e di tutti gli attori di questo mercato e quindi anche dei consumatori. Si attribuisce così al consumatore un ruolo di rilievo che non è solo quello di acquistare nei negozi, di fruire dei servizi, ma è quello di partecipare con le sue attività alla creazione dell’Europa. Questo programma quinquennale è memorabile anche perché stabilisce i cinque diritti fondamentali dei consumatori, che vengono poi mantenuti, riconfermati ed ampliati nei programmi successivi: innanzitutto il diritto del consumatore a vedere protetta la propria salute e la propria sicurezza; poi quello della protezione degli interessi economici, da cui discendono tutti gli interventi sui contratti, ma anche sulle modalità di vendita, sulle garanzie, sulla pubblicità; è anche interesse economico del consumatore non essere indotto ad acquistare, per esempio, dalla pubblicità che lo ha ingannato, oppure da una tecnica aggressiva di vendita porta a porta; tutto questo fa parte della tutela degli interessi economici, cioè dell’interesse del consumatore a stipulare contratti che effettivamente vuole a condizioni a lui effettivamente note ed indubbiamente accettate. Ulteriori diritti sono quelli al risarcimento dei danni da prodotti difettosi, all’informazione e ad un agevole accesso alla giustizia. 10 SICUREZZA PRODOTTI E SICUREZZA GIOCATTOLI NELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA Parte II Il primo riferimento alla sicurezza a livello di Trattato si ha nel 1987, quando entra in vigore l’Atto Unico Europeo, trattato che va ad apportare la prima modifica al Trattato istitutivo. Questa prima modifica ha luogo parecchio tempo dopo la nascita della Comunità, trent’anni dopo, nell’87, proprio perché gli sviluppi storici ed economici avevano portato in questa direzione; ormai era tempo, non già di modificare le regole, ma di adeguarle alla nuova realtà. L’Atto Unico introduce nel Trattato l’articolo 100a, in cui si dice che la Commissione CEE nelle sue proposte concernenti la salute, la sicurezza, la protezione dell’ambiente, la protezione dei consumatori, prenderà come base un livello di tutela elevato. E’ la prima volta in cui, a livello di diritto primario della Comunità, si parla di sicurezza dei consumatori, di protezione dei consumatori e si vincola il legislatore comunitario, in particolare la Commissione nelle sue proposte, che poi verranno approvate dal Consiglio, a perseguire, in questo campo, non un livello di ordinaria diligenza ma un livello di tutela elevato, quindi massimo sforzo, massima diligenza. Da questo momento in poi non sono più sufficienti le azioni, i piani quinquennali a tutela dei consumatori: effettivamente il legislatore comunitario viene impegnato ad assicurare, attraverso la sua normativa, un livello elevato di tutela del consumatore. Con il Trattato di Maastricht, entrato in vigore nel ’93, viene per la prima volta introdotto nel Trattato non più solo un accenno come era stato nell’’87, ma addirittura un titolo apposito sulla protezione dei consumatori; viene inserita quindi una sezione, una parte del Trattato che parla solo della protezione dei consumatori e con ciò la politica dei consumatori diventa una “politica comunitaria”, cioè un filone di intervento e di produzione legislativa della Comunità. In questo titolo, tra l’altro, si dice che la Comunità contribuisce alla realizzazione di un livello elevato di tutela dei consumatori allo scopo di proteggere la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori e garantire loro un’informazione adeguata. Un’ulteriore modifica al Trattato, apportata dal Trattato di Amsterdam, entrato in vigore 11 nel ’99, ha ulteriormente posto l’accento sulla protezione dei consumatori: adesso esiste, proprio a livello di diritto primario, l’impegno ad intervenire per garantire, tra l’altro, la sicurezza dei consumatori. Come è intervenuto il legislatore comunitario, come ha cercato nel tempo di rispondere a questo impegno a proteggere la sicurezza dei consumatori? È intervenuto in fasi diverse a seconda delle epoche, ha avuto, cioè, un approccio iniziale, poi ha visto che non andava troppo bene e lo ha modificato nel corso del tempo. L’approccio originario è stato quello di produzione legislativa verticale: si è cominciato ad emanare delle direttive cosiddette “verticali”, così chiamate perché ogni direttiva riguardava uno specifico prodotto oppure uno specifico settore, e di questo disciplinava tutti gli aspetti, tra cui anche la sicurezza. Questo tipo di intervento risponde bene all’impegno posto dal Trattato, perché assicura che per ogni prodotto ci siano delle regole precise che riguardano, tra l’altro, come deve essere prodotto per essere sicuro; resta però un problema di fondo: si capisce che una direttiva, un regolamento richiedono parecchio tempo per essere preparati, c’è tutta una procedura complicata di predisposizione di una proposta da parte della Commissione, di lettura da parte del Parlamento, di approvazione da parte del Consiglio; quanto più la direttiva deve essere dettagliata, per cui bisogna andare a vedere tutti i singoli aspetti del prodotto, tanto più tempo ci vuole, tanto più è difficile che tutti siano d’accordo, a maggior ragione ora che il numero degli Stati membri della Comunità è aumentato considerevolmente. Mettere d’accordo tanti Stati non è facile, non solo perché le opinioni differiscono, ma anche perché nei singoli Stati ci sono tradizioni diverse di produzione, difficili da modificare. Il tema della sicurezza alimentare, poi, è particolarmente complesso, perché talvolta l’introduzione di regole che garantiscano la massima igiene nei processi produttivi va a discapito di sapori e caratteristiche tradizionalmente ricercati ed apprezzati. Questo è tanto più importante adesso perché, se finora la Comunità è stata un insieme di alcuni Stati del cuore dell’Europa, tutti abbastanza alla pari dal punto di vista del livello di sviluppo, e con tradizioni non radicalmente differenti, oggi ci troviamo di fronte all’ingresso di Paesi di tradizione diversa dalla nostra, che hanno vissuto una storia diversa e che sono ad un livello di vita assolutamente non confrontabile. Il legislatore comunitario deve garantire un minimo di sicurezza, perché i prodotti possano circolare liberamente, ed i consumatori possano acquistarli fidando nella loro qualità; la base minima di sicurezza è creata proprio dalle direttive: la direttiva verticale 12 sul miele, ad esempio, ci garantisce che il miele prodotto in qualsiasi Stato membro, quanto meno, rispetta le regole base previste dal legislatore comunitario, anche se poi ogni Stato ha le sue fioriture caratteristiche e magari le sue tecniche di produzione tradizionali. Le direttive sui singoli prodotti erano molto utili, ma il problema era che i prodotti sono innumerevoli, quindi ci vorrebbe molto tempo per disciplinarli tutti; ad un certo punto la Comunità si è resa conto che produceva qualche direttiva all’anno, a fronte di un numero grandissimo di prodotti da disciplinare: se lo strumento della direttiva verticale era di per sé valido per rispondere all’impegno posto dal Trattato, non si riusciva tuttavia a procedere abbastanza rapidamente per rispettarlo. Si è cambiato allora l’approccio, emanando direttive dette “nuovo approccio”, che sono più brevi di quelle fino ad allora adottate, nel senso che restano sempre verticali, riguardano sempre un determinato prodotto o una determinata categoria di prodotti, ma non vanno a disciplinarne tutti gli aspetti, bensì pongono una serie di principi fondamentali e lasciano poi ogni Stato membro libero di realizzare questi principi fondamentali come meglio crede, con la possibilità di riferirsi a norme tecniche elaborate dagli enti europei di normalizzazione. Questi enti sono il CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione), il CENELEC (per il settore elettrico) e l’ETSI (per le telecomunicazioni): si tratta di enti di diritto privato, che producono delle norme tecniche, cioè delle specifiche tecniche per i produttori. Il meccanismo individuato dalle direttive nuovo approccio semplifica molto la disciplina dei prodotti, nel senso che non ci vuole più molto tempo per definire una direttiva, in quanto è più breve e poi è più probabile che sugli aspetti fondamentali, gli unici ad essere disciplinati, gli Stati membri trovino un accordo. La tecnica delle direttive di nuovo approccio abbrevia di molto i tempi di adozione della direttiva, garantisce che in tutti gli Stati membri, comunque, un minimo livello di sicurezza sia rispettato, lascia però al produttore la scelta se riferirsi alle norme tecniche, che sono volontarie, e con ciò godere della presunzione di conformità del proprio prodotto ai requisiti posti dalla direttiva, o se produrre secondo regole diverse – ma in questo caso dovrà essere in grado di dimostrare di avere comunque rispettato i requisiti posti dalla direttiva. Tuttavia la tecnica suddetta lascia comunque aperto un problema: per quanto i tempi si siano ridotti, siccome i prodotti sono tantissimi, restano sempre dei prodotti per i quali 13 non si è ancora emanata una direttiva e manca uno standard minimo di sicurezza garantito. Il legislatore comunitario è intervenuto anche su questo punto, introducendo ancora un ulteriore approccio, che si affianca a quello verticale ed è di tipo orizzontale; si sono fatte alcune direttive che non riguardano, come quelle precedenti, un certo prodotto o un certo settore, ma riguardano invece tutti i prodotti di consumo. Tra queste c’è la direttiva “sicurezza generale dei prodotti”, del ’92 (ora sostituita da un nuovo testo del 2001), che non riguarda prodotti specifici, bensì tutti i prodotti di consumo, e pone un requisito fondamentale di base: i prodotti di consumo in circolazione sul mercato comunitario devono essere prodotti sicuri. Come fa il produttore a sapere se il suo prodotto è sicuro? Ogni produttore andrà a vedersi le norme CEN, CENELEC o ETSI relative al suo prodotto e il suo prodotto, se rispetta queste norme, potrà essere considerato sicuro; ci sono però anche delle altre possibilità: se su quel prodotto c’è una direttiva comunitaria o legislazione nazionale specifica, dovrà andare a rispettare quella; oppure, se per quel prodotto non ci sono ancora norme tecniche a livello comunitario, ma ci sono norme tecniche nazionali (ad esempio norme UNI per l’Italia), dovrà rispettare quelle. Se non ci sono disposizioni riguardanti quel prodotto, magari perché è un prodotto nuovo, però ci sono dei codici di condotta, dovrà far riferimento a questi ultimi. La direttiva sicurezza generale prodotti, recepita in Italia con decreto legislativo n. 115 del ’95, si pone due obiettivi: uno di tipo preventivo ed uno di tipo correttivo. L’obiettivo preventivo è quello a monte, cioè quello che prima dell’introduzione del prodotto sul mercato dice ai produttori come devono essere fatti i prodotti, e consiste nell’obbligo generale di sicurezza: il produttore è tenuto a porre sul mercato soltanto prodotti sicuri. Questo obiettivo preventivo è completato, in realtà, con delle specificazioni sulle modalità di applicazione, cioè su come fare a rispettare questo obbligo generale, e dà molta importanza, in particolare, all’obbligo di informazione: ciò significa che un prodotto, per essere sicuro, deve anche recare sufficiente informazione per il consumatore, il quale non solo deve poter disporre di un prodotto tecnicamente sicuro, ma deve anche essere informato su come usarlo correttamente quando l’uso non è proprio evidente. Il consumatore è protetto, dal punto di vista della sua sicurezza, anche se sa come montare il prodotto, come azionarlo, tenendo conto del fatto che oggigiorno alcuni prodotti sono tecnicamente abbastanza complessi e quindi può capitare di farne un uso sbagliato e farsi male; proprio per questo il prodotto deve essere accompagnato 14 da una informazione esaustiva sulle modalità di impiego. Bisogna però anche che queste istruzioni siano essenziali e chiare, altrimenti non vengono lette e comprese. L’informazione deve essere, insomma, chiara, sufficiente, ma non esagerata: non è neppure auspicabile che il produttore, per non essere incolpato di negligenza, a sua discolpa accompagni il prodotto con una enciclopedia di istruzioni che nessuno leggerà mai. Per rispondere correttamente a questo obbligo di informazione, il produttore deve trovare un modo per fornire, in relativamente poco spazio, in maniera concisa e chiara, tutte le informazioni fondamentali, e questo è un componente importantissimo dell’aspetto tecnico dell’informazione. Accanto a questo, la direttiva si pone anche un obiettivo correttivo che prevede cosa occorre fare se il guaio è già capitato, se il produttore non ha rispettato l’obbligo di sicurezza e ha inserito sul mercato un prodotto non sicuro, oppure come fare per bloccare un prodotto se si scopre che sta creando danni alle persone. Su quest’ultimo punto, la direttiva prevede anche una procedura d’urgenza a livello comunitario, secondo la quale la Commissione può ordinare il ritiro del prodotto da tutti i mercati della Comunità; a volte non è necessario il ritiro, ma basta imporre che in tutti i negozi venga affisso un messaggio in cui, ad esempio, si dice: “non consumare questo prodotto in combinazione con un altro perché fa male alla salute”. La direttiva dà alla Commissione, in particolare, la competenza, il diritto di intervenire d’urgenza per bloccare e togliere dal mercato quei prodotti che, non avendo rispettato l’obbligo generale di sicurezza, si sono dimostrati non sicuri. Questo sembrerebbe scontrarsi con il principio di sussidiarietà, secondo il quale la Comunità non ha competenza per intervenire in qualunque situazione: normalmente gli Stati sono competenti a decidere ciascuno per sé, salvo alcune ipotesi eccezionali in cui può intervenire l’autorità comunitaria. Tale principio serve a garantire agli Stati che la Comunità non intende limitare la loro competenza; solo quando si presenta un problema non adeguatamente risolvibile a livello di singoli Stati (per esempio quando si scopre che c’è un prodotto pericoloso che circola liberamente per tutta la Comunità) la Comunità è competente ad intervenire. Alcuni anni si è presentato il problema di un prodotto della Moulinex che si rompeva ferendo chi lo stava utilizzando; questo prodotto era in commercio in tutta Europa ed è emerso che c’erano state lamentele da parte di almeno 300 consumatori feriti in maniera più o meno grave da questo prodotto; certo che a questo punto bisogna bloccarlo a livello di intera Comunità, 15 perché c’è urgenza, in quanto il prodotto fa correre un rischio immediato, e lo si può fare con questa procedura. La direttiva in esame si applica ai prodotti di consumo; l’articolo 1 ci dice però che, se per un determinato prodotto esiste già una direttiva sua propria, è a quella che bisogna fare riferimento, se però non c’è, oppure esiste ma non cura gli aspetti della sicurezza, allora bisogna seguire, per tali aspetti, la direttiva generale sicurezza prodotti. In seguito la direttiva definisce il concetto di prodotto: è tale, ai sensi di questa direttiva, qualsiasi prodotto destinato ai consumatori o suscettibile di essere utilizzato dai consumatori, fornito a titolo oneroso o anche gratuito indipendentemente dal fatto che sia nuovo, di seconda mano o rimesso a nuovo. Questa regola generale di sicurezza, il prodotto deve essere sicuro, vale per i prodotti destinati ai consumatori, fatti apposta per essere usati dai consumatori, ma vale anche per i prodotti suscettibili di essere usati dai consumatori, e cioè quelli che i consumatori potrebbero usare anche se magari non sono fatti apposta per loro ma è pensabile che, comunque, possano venire in contatto con essi. Si applica anche ai prodotti che sono forniti a titolo gratuito, regalati, offerti come premio, e non solo ai prodotti venduti nei negozi, ma anche ai prodotti di seconda mano: anche se acquistiamo un prodotto di seconda mano dobbiamo pretendere che sia sicuro. Devono essere sicuri tutti i prodotti di consumo o, comunque, suscettibili di essere utilizzati da parte dei consumatori. Chi è il produttore? La direttiva ci dice che produttore non è solo il fabbricante che ci ha fabbricato il prodotto, ma sia il fabbricante, sia qualsiasi persona che si presenti agli occhi del consumatore come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo. Pensate, per esempio, ai prodotti che acquistiamo nei grandi supermercati e che hanno il marchio COOP, GS o DIxDI: si tratta di catene di distribuzione che non confezionano i prodotti ma si fanno confezionare i prodotti dal produttore e vi appongono il proprio marchio. Il consumatore che acquista il prodotto legge però in prima battuta il marchio suddetto, e vi ripone affidamento; quindi, se questo prodotto fosse insicuro, facesse male alla salute, il consumatore farebbe risalire la pericolosità del prodotto al distributore. Molti prodotti, poi, sono di importazione: qui si pone un altro problema, perché il fabbricante ha sede fuori della Comunità, e quindi non è soggetto alla direttiva, in quanto il diritto comunitario può vincolare solo i cittadini della Comunità. La direttiva però dice 16 che è produttore anche il rappresentante del fabbricante nella Comunità, se il fabbricante ha sede fuori della Comunità. Quindi, se per esempio un produttore argentino ha un rappresentante in Italia, è il rappresentante in Italia che è soggetto agli obblighi comunitari e deve garantirci la sicurezza del prodotto; noi non possiamo imporre degli obblighi all’Argentino, ma al suo rappresentante in Italia sì. Se poi non c’è alcun rappresentante in Italia, perché tanti prodotti sono importati senza rappresentante, per i prodotti di importazione si considera produttore l’importatore, deve cioè garantire la sicurezza del prodotto chi lo ha importato: è costui che deve garantire che il prodotto rispetti i requisiti della direttiva e, naturalmente, deve evitare di importare dei prodotti non adeguati agli standard minimi della direttiva. Questo ci garantisce che un prodotto di origine extracomunitaria, qualora venga importato nella Comunità e noi lo troviamo al supermercato, risponde ai requisiti minimi comunitari, perché l’importatore garantisce ed è responsabile della sicurezza del prodotto. Residualmente, ci dice la direttiva, sono considerati produttori e quindi sono tenuti a garantire la sicurezza del prodotto, anche tutti gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione, nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti commercializzati. Sono tutti quei soggetti che stanno nella catena di produzione e distribuzione del prodotto, che in qualche modo vengono in contatto con il prodotto e possono quindi influenzarne le caratteristiche. Anche chi lo confeziona, per esempio, o chi, semplicemente, lo monta, o magari acquista i pezzi da un importatore e poi li assembla, anche questo garantisce, è responsabile, perché influisce sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto. Lo è anche la ditta che redige il libretto delle istruzioni che poi viene inserito nella confezione, perché se il libretto riporta istruzioni non sufficientemente chiare e comprensibili, il prodotto, alla fine, non è sicuro; in sostanza, è produttore qualsiasi soggetto che in tutta la catena, dalla comparsa sul mercato comunitario del prodotto sia che venga confezionato nella Comunità o che venga importato - fino a quando arriva al consumatore, in qualche modo può avere impatto sulla sicurezza del prodotto stesso. La direttiva individua ancora un altro soggetto: il distributore, che è qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto, il grossista che semplicemente lo acquista, lo mette in magazzino e poi lo vende al dettagliante, oppure il dettagliante che lo acquista, poi lo rivende ma non ha alcun impatto sulle caratteristiche di sicurezza. 17 Anche questo soggetto ha qualche obbligo: gli obblighi di questi operatori professionali, il produttore da un lato e il distributore dall’altro, sono stabiliti specificamente. La direttiva, in particolare, in merito agli obblighi del produttore, ci dice che il produttore è tenuto ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri; poi rinvia, come dicevo prima, cioè dispone: il produttore, per garantire che il suo prodotto sia sicuro, deve, intanto, vedere se ci sono delle norme comunitarie al riguardo, se su quel prodotto c’è una direttiva, un regolamento, e in tal caso applicarle. Se non esistono specifiche disposizioni comunitarie al riguardo, si considera sicuro il prodotto che è confezionato secondo le leggi dello stato di produzione. Se un prodotto è confezionato in Italia, per esempio, e su quel prodotto non c’è una direttiva specifica, basta che il prodotto rispetti la legge italiana ed è considerato sicuro per tutta la Comunità. Questo è un elemento importantissimo, un vero e proprio riconoscimento delle norme interne dei singoli Stati. Può l’Italia rifiutare di ammettere sul nostro mercato un certo prodotto tedesco che non segue le norme italiane? No, perché basta che il prodotto rispetti le norme del Paese di origine, del Paese in cui è stato confezionato, e può circolare liberamente in tutta la Comunità. Può anche darsi che il nostro prodotto non sia nemmeno disciplinato dalle leggi interne dello stato di produzione. In questo caso si vanno a vedere le norme tecniche nazionali non cogenti (le norme UNI per l’Italia) che recepiscono una norma tecnica europea (CEN, CENELEC, ETSI). Il produttore non è obbligato a rispettare quelle norme, per loro natura non obbligatorie, però, se il produttore le rispetta, lo si considera adempiente all’obbligo generale di sicurezza. Come abbiamo visto, tra gli altri obblighi del produttore ci sono tutta una serie di obblighi accessori, come quello di dare sufficiente informazione, di richiamare il prodotto dal mercato se si è rivelato insicuro, di agevolare in qualsiasi modo il facile richiamo del prodotto. Peraltro, la direttiva individua anche alcuni obblighi in capo al distributore, che non contribuisce alla produzione e alla sicurezza del prodotto, e quindi non può essere lui ad assicurare che il prodotto è sicuro; il distributore è però tenuto a collaborare con il produttore nel garantire la sicurezza del prodotto. Se il produttore, per esempio, individua un rischio che si è verificato e vuole chiamare indietro i prodotti dal mercato, il distributore deve aiutarlo, cioè deve consentire al produttore per esempio di affiggere manifesti in cui c’è scritto: “attenzione, richiamo…”, deve fornire l’elenco dei clienti, se lo possiede, per permettere al produttore di contattarli e di farsi 18 portare indietro il prodotto, deve collaborare, in sostanza, alla realizzazione dell’obbligo generale di sicurezza. La nuova direttiva sicurezza, poi, è molto simile alla precedente; sostanzialmente, è più chiara nel linguaggio, specifica un pochino meglio taluni concetti, pone qualche obbligo più particolare, introduce specifica attenzione, oltre che ai prodotti utilizzabili dai bambini, anche ai prodotti per gli anziani; offre maggior tutela rispetto alla precedente, pur seguendone l’impianto. Per quanto riguarda poi, specificatamente, i giocattoli, abbiamo una direttiva settoriale, dell’’88, cioè precedente alla direttiva sicurezza generale del ’92, proprio perché il giocattolo è stato considerato uno dei prodotti che possono più facilmente essere insicuri e arrecare danno, tenuto conto dell’età di coloro che li usano e anche per il fatto che il diritto comunitario ha sempre fatto molta attenzione ai bambini, considerati una categoria meritevole di particolarissima attenzione, per vari motivi. Ovviamente spiace a tutti vedere un bambino che si fa male; anche da un punto di vista economico, però, se un bambino sventuratamente rimane inabile per tutta la vita, costa alla Comunità più di un adulto, perché dovrà essere assistito per un numero di anni verosimilmente maggiore. Per tutti e due i motivi citati, ma primariamente perché si tende a tutelare l’infanzia in generale, il legislatore comunitario è intervenuto in molti campi ponendo specifico accento sulla protezione dei bambini e, in particolare, proprio per il fatto della maggior pericolosità insita nei giocattoli, ha emanato una direttiva apposita sui giocattoli. E’ una direttiva verticale di nuovo approccio, non riguarda uno specifico prodotto ma una specifica categoria di prodotti, non riguarda tutti i singoli aspetti del giocattolo, bensì pone un requisito base: i giocattoli devono essere sicuri, non devono fare del male ai bambini; poi, proprio come la direttiva sicurezza, rinvia alle norme CEN / CENELEC apposite. Il CEN ha emanato tutta una serie di norme che nell’insieme si chiamano norma EN71, poi divisa in varie parti, che riguardano proprio le specifiche tecniche che i giocattoli devono presentare. In questo campo si è rivelato particolarmente utile il nuovo approccio, in quanto i giocattoli sono tra loro così diversi che non è possibile disciplinare in una direttiva tutti gli aspetti di sicurezza di tutti i possibili giocattoli. Così il legislatore comunitario si è servito proprio di questo nuovo approccio, cioè ha posto come base il requisito che il giocattolo deve essere sicuro, non deve far male, non deve ferire, in virtù in particolare 19 del fatto che i bambini sono imprevedibili nei loro comportamenti e quindi il giocattolo deve essere più sicuro del prodotto comune. La direttiva sicurezza giocattoli, dopo aver posto il requisito base che il giocattolo non deve fare male al bambino, nell’allegato prevede alcune specificazioni ulteriori e dice che, per esempio, i giocattoli non devono avere punte acuminate, non devono avere forme che possano ferire il bambino, non devono essere facilmente fratturabili, perché magari il giocattolo è arrotondato, ma se è facilmente fratturabile poi sulla linea di frattura vengono a crearsi delle punte che possono far male al bambino; i giocattoli devono essere di dimensioni tali che il bambino non possa trangugiarli e, in particolare, non devono rompersi in pezzettini talmente piccoli che il bambino li possa trangugiare; se contengono delle palline, dei pezzi smontabili, questi devono essere di dimensioni tali da non poter passare nella trachea di un bambino piccolo. Ci sono, per esempio, regole specifiche per le corde: le corde da saltare, o comunque i giocattoli che hanno un pezzo di cordino, comportano il rischio che il bambino si possa strangolare; i giocattoli, poi, non devono essere facilmente incendiabili; i giocattoli di peluche non devono avere del pelo che si stacca facilmente, in particolare per proteggere i bambini molto piccoli che li potrebbero leccare e accumulare in bocca del peluche, con cui si potrebbero soffocare. La direttiva stabilisce già nell’allegato tutta una serie di requisiti generali a cui tutti i giocattoli devono rispondere; poi però segue una tecnica di rinvio come quella della direttiva sicurezza generale prodotti, e prevede che il produttore di giocattoli, per essere sicuro che il suo giocattolo rispetta la direttiva, abbia due possibilità: una è quella di seguire le norme tecniche, quindi le norme del CEN, la EN71 che riguarda tutte le caratteristiche meccaniche, fisiche, organolettiche dei giocattoli e riguarda anche, in particolare, i giocattoli chimici, tipo “il piccolo chimico” che non deve dare luogo ad intossicazione dei bambini. Per alcuni giocattoli, che hanno componenti elettrici, valgono anche le norme CENELEC. Se invece il produttore preferisce non seguire le norme, visto che non sono obbligatorie, ha un’altra possibilità, quella di far certificare un prototipo, cioè farlo esaminare da un ente di certificazione - ce ne sono diversi accreditati negli Stati membri; dopo che l’ente ha rilasciato l’attestato di sicurezza, il produttore si deve attenere al prototipo. Entrambe queste vie portano alla possibilità per il produttore di autocertificare il suo 20 giocattolo con un marchio apposito, il marchio CE; qualsiasi giocattolo legalmente commercializzato nella Comunità europea deve riportare il marchio CE; questo marchio è apposto dal produttore e non da un organismo di controllo, ma il produttore apponendo questo marchio dichiara di aver seguito uno dei due procedimenti stabiliti dalla direttiva. La disciplina sui giocattoli nella Comunità è molto tutelante, perché sul mercato comunitario possono circolare solo giocattoli che recano questo marchio. La stessa cosa non accade per i prodotti di consumo in generale, la direttiva sicurezza generale dei prodotti non richiede l’apposizione di un marchio o l’autocertificazione, quindi i normali prodotti di consumo non hanno bisogno di applicare il marchio CE; il giocattolo sì, proprio perché si vuole, in particolare, tutelare il bambini e quindi impegnare particolarmente il produttore; di conseguenza, se noi acquistiamo per il bambino un giocattolo col marchio CE siamo certi, salvo contraffazioni, che quel giocattolo rispetta la direttiva e quindi è sicuro. Ciononostante, e anche nel caso in cui vengano rispettate le norme sulla produzione dei giocattoli, si verificano comunque degli incidenti a livello comunitario; la nuova direttiva sicurezza richiede alla Commissione, tra l’altro, di studiare alcuni campi in cui si è visto che negli ultimi anni ci sono stati molti incidenti e di segnalarli al CEN in modo che elabori nuove norme apposite per tutelare maggiormente i bambini. Di questo studio ci stiamo occupando, in particolare, con un’Università francese e una greca; uno degli aspetti segnalati dalla Commissione per lo studio da parte di questo gruppo di lavoro è quello degli ovetti di cioccolato con sorpresa e, in generale, di tutti i prodotti commestibili che recano una sorpresina, un prodotto non commestibile, per esempio le confezioni di patatine contenenti un regalino, quelle di biscotti con un giocattolino: sono stati infatti segnalati vari casi di soffocamento di bambini che hanno trangugiato la sorpresa. 21 LA SICUREZZA IN RETE Cristina Barettini Per affrontare la possibilità di operare in rete in condizioni di sicurezza è indispensabile avere consapevolezza, per lo meno, delle regole applicabili. Qui, anzitutto, si pone il problema della extraterritorialità della rete: il diritto dell’informatica è un diritto per sua natura delocalizzato. Quando abbiamo parlato di sicurezza dei prodotti, abbiamo fatto riferimento ad un ambito italiano, di diritto italiano, oppure ad un ambito di diritto comunitario e abbiamo visto quali sono le regole che si applicano nella Comunità, come deve essere un determinato prodotto, in particolare il giocattolo, per poter circolare sul mercato comunitario: ci siamo cioè riferiti ad un’area geografica. Il problema del diritto dell’informatica è che non c’è un’area geografica di riferimento; molto frequentemente, molto facilmente le transazioni, ed in particolare i contratti stipulati con l’e-commerce, sono stipulati con una controparte delocalizzata, nel senso che non si sa bene dov’è: l’azienda che propone il contratto a volte non dichiara neanche dove ha sede, e comunque opera da qualche paese lontano, del quale non conosciamo il diritto: non possiamo quindi sapere quali regole sono applicabili a questo contratto. Facciamo un esempio: acquisto un prodotto, un libro, dagli Stati Uniti; se tutto va bene, se non ci sono problemi, il diritto applicabile non ci interessa più di tanto: arriva il libro, pago ed è tutto a posto; se però sorge qualche controversia, se il libro non arriva o arriva danneggiato, se lo devo restituire, allora devo sapere le regole di quale diritto si applicano: le regole del diritto italiano oppure di quello statunitense oppure esiste un altro diritto apposito? Si dice sempre che il diritto serve quando le situazioni vanno male e, in effetti, se tutto va bene il problema non ce lo poniamo, ci diamo la mano ed è tutto risolto; il diritto serve invece laddove si crei qualche problema. In questo caso, logicamente, noi ci aspettiamo che si applichino le stesse regole che vengono applicate quando andiamo a comprare un prodotto sotto casa: abbiamo una certa aspettativa rispetto al diritto, sappiamo più o meno quali sono le regole del diritto italiano e implicitamente supponiamo che sia sempre così, ma in realtà non è sempre così, perché altri ordinamenti hanno regole profondamente diverse dalle nostre. Il problema è allora che si crea una situazione di incertezza del diritto, nel senso 22 che io stipulo tranquillamente un contratto di compravendita del libro o dell’oggetto che mi arriva da lontano, in realtà non sapendo quali sono le regole applicabili a questo contratto o, peggio ancora, ritenendo che siano le regole X mentre non sono le regole X e non si sa nemmeno quali siano; il problema è quindi proprio quello del come regolamentare il diritto dell’informatica e, in particolare, i contratti che si stipulano in rete. Altro problema, ma sempre analogo, è esemplificato dal caso del sito statunitense che vendeva cimeli nazisti; è capitato qualche anno fa: l’offerta via internet di tali prodotti giunge anche in Francia, dove il diritto vieta questo tipo di commercio, considerato apologia del nazismo; la Francia chiede che venga immediatamente annullata la possibilità di questa vendita, che va contro le leggi francesi; il sito statunitense sostiene che secondo le proprie leggi la cosa è pienamente legittima e quindi non intende oscurare il sito; la Francia chiede di schermare e gli Stati Uniti dicono che non è possibile, è complicato, e poi l’utente francese potrebbe comunque collegarsi ed effettuare questo acquisto. Si tratta di una vera e propria di situazione di conflitto di ordinamenti, reso difficile anche dal fatto che è un conflitto che non si sa bene dove abbia i confini. Quali soluzioni sono pensabili a questo riguardo? La soluzione ottimale (ma come sempre, quando c’è qualcosa di ottimale non è realizzabile) sarebbe quella di creare un ordinamento mondiale, cioè un diritto mondiale dell’informatica; però, non essendoci fortunatamente un padrone del mondo, un dittatore che possa imporre le stesse regole a tutto il mondo, questo è, evidentemente, irrealizzabile. Quello che si potrebbe fare è creare un accordo tra molti paesi che ratifichino una convenzione con delle regole base che siano rispettate da tutti coloro che vi aderiscono; ovviamente, il problema delle convenzioni è che non possono regolare tutto, nel senso che è già difficile mettersi d’accordo in un gruppetto su qualche cosa, e tanto più lo è a livello di numerosi Paesi; la convenzione si può fare su alcune regole, su qualche aspetto, tra alcuni Paesi, ma non è possibile creare una megaconvenzione al riguardo. Notate anche che ci sono degli approcci molto diversi tra le varie aree geografiche del mondo; se parliamo di un approccio statunitense al commercio elettronico, parliamo di un approccio molto liberista: il diritto statunitense propende molto per la non regolamentazione del cyber, o per lo meno per pochissima regolamentazione. Questo è ritenuto necessario perché l’opinione dominante è che mettendo troppe 23 regole si pongono troppe briglie agli operatori del commercio elettronico e quindi, alla fine, si rischia che questa attività non riesca poi ad affermarsi sufficientemente. La posizione europea, più ispirata al diritto romano germanico, fatto di regole scritte, propende per una soluzione di regolamentazione: non ci deve essere uno spazio cibernetico tipo far west, dove tutti fanno quello che vogliono e, in effetti, l’Unione Europea sta cominciando a porre alcune regole relative al commercio elettronico. Il legislatore europeo, ovviamente, non può imporre le sue regole ad altri Paesi e quindi queste regole valgono per i soggetti residenti o aventi sede, se si tratta di imprese, nell’Unione Europea. Se l’Unione Europea ha adottato una regola ferrea, però, sarebbe auspicabile che fossero tenute a rispettarla non soltanto le imprese che hanno sede nell’Unione Europea ma tutte quelle che operano sul mercato europeo; altrimenti, se un operatore ha la sede legale alle isole Seychelles, può operare tranquillamente sul mercato europeo senza rispettarne le regole; invece, se valesse il principio di territorialità, chi viene a vendere in rete in Europa dovrebbe rispettare le regole del mercato europeo. In realtà non vale il principio di territorialità, perché il cyber si trova ad operare in uno spazio senza frontiere. Il principio di territorialità vale soltanto, per esempio, per il diritto della concorrenza: se l’impresa americana viene sul territorio comunitario ed è in posizione dominante, è soggetta alle regole europee. L’impresa che opera via internet dalle Seychelles, invece, è vero che in realtà viene ad avere degli effetti sul territorio europeo ma, di fatto, opera in rete nel mondo e non si può neanche richiederle di adeguarsi alle legislazioni di tutti i Paesi che vengono raggiunti dal suo messaggio. Se io diffondo un’offerta in rete dall’Italia e questa arriva in Australia, in Polinesia, in Asia, in Siberia, in tutte le parti del mondo, come si fa ad imporre a me di adeguarmi alle legislazioni di tutti i Paesi del mondo? E’ impossibile, e per questo si dice che l’operare in rete è extraterritoriale, nel senso che supera i confini, supera le barriere giuridiche nazionali. Quindi, per avere una tutela del consumatore a livello mondiale come si fa? Nessuno può imporre regole giuridiche a portata mondiale; sarebbe bello, dal punto di vista etico, che i deboli, i consumatori venissero tutelati, però chi lo può imporre a tutto il mondo? Occorre fare una distinzione tra la possibilità di utilizzare a livello territoriale o mondiale una tutela; a livello mondiale questa non regge, ma una volta che il legislatore ha predisposto una valida disciplina a livello territoriale, e quindi 24 ha utilizzato appieno la sua sovranità, ha fatto quanto in suo potere; se poi il cittadino, o comunque chi è soggetto all’ordinamento in questione, vuole collegarsi ad un sito proibito dall’ordinamento di cui trattasi, lo fa a proprio rischio e pericolo. A noi le regole che conosciamo sembrano universali, ma in realtà sono solo regole del diritto italiano; altri paesi hanno regole completamente diverse; per noi il mondo è soltanto qui, per altri no. Se io compro da un’impresa in rete, implicitamente mi baso sul diritto italiano, penso che il venditore sia per esempio tenuto a garantire per eventuali difetti del prodotto e quindi che se il prodotto non funziona io possa portarlo indietro, chiedere la restituzione del prezzo pagato o la riparazione del prodotto; ma la controparte potrebbe anche controbattere: “no, secondo il nostro diritto non c’è alcuna garanzia da parte del venditore. Pensiamo, per esempio, alla regola per noi ovvia della possibile risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta: stipulo un contratto di durata, con prestazioni protratte nel tempo; se capita qualcosa di eccezionale ed imprevedibile, che rende enormemente più onerosa la prestazione rispetto a quella concordata al momento della stipula del contratto, il contratto si può sciogliere rivolgendosi al tribunale; noi siamo tranquilli che sia così, perché è così in tutta Europa, almeno in tutti i paesi di diritto romano germanico, eccetto quindi in Inghilterra: nel diritto anglosassone questa regola non esiste. Tutto questo spiazza il contraente debole, che stipula il contratto nella fiducia che le regole applicabili siano quelle cui è abituato, ma non tiene conto del fatto che queste sono le regole vigenti in Italia mentre nelle altre parti del mondo ci sono regole diverse. Il problema di entrare in rete è proprio questo: non solo non conosciamo le regole applicabili, ma alle volte siamo convinti di conoscerle, e invece non è così. Come si fa a sapere che il prodotto che si compra in un certo sito è buono, è valido, funziona, e cosa si deve fare se non funziona? Che tutela offre il diritto? L’alternativa tra regolamentare tutto con delle convenzioni, cosa che però non è fattibile, e il lasciare tutto libero, è quella di fare un’autoregolamentazione, dei codici di comportamento:tutti gli operatori di un certo settore, seri, interessati a lasciare trasparire l’effettiva immagine di correttezza, redigono un codice di disciplina e marchiano i siti che vi aderiscono con un bollino di garanzia. Così si può creare un meccanismo di fiducia, che è quello introdotto nei codici 25 di autodisciplina, nei nostri codici deontologici come, per esempio, quello dell’Ordine dei medici o degli avvocati. Questa potrebbe essere una soluzione ed è quella che poi gli autori oggi sostengono, in attesa di ulteriori sviluppi di regolamentazione. Si tratta di insistere su questa che viene chiamata l’etichetta del net, o “netiquette”, cioè l’insieme delle regole di buon comportamento. Questo potrebbe essere un valido meccanismo di tutela improntato alla fiducia; il consumatore sa che c’è un organismo di controllo che individua tutti i siti aderenti a questa organizzazione, sa che la medesima ha varato un codice di comportamento, e cliccando può far apparire tale codice sul sito: perciò può acquistare con tranquillità, se ritiene che questo codice sia una cosa seria, che queste regole siano adeguate; acquistando prodotti da quel sito, il consumatore è fiducioso, perché sa che il sito rispetterà le regole esplicitate nel codice. Al momento l’autodisciplina sembra essere la soluzione migliore, per quanto non perfetta. Ogni codice di autodisciplina viene fatto applicare certamente non da una corte statale, perché le regole sono volontarie, bensì da un organo giudicante creato dall’istituto di autodisciplina stesso; il codice di autodisciplina pubblicitaria, per esempio, è fatto applicare in Italia da un Giurì, e il Giurì ogni tanto richiama chi non rispetta le regole di autodisciplina; non può ovviamente imporre sanzioni giuridiche, civili o penali, ma può imporre le sanzioni tipiche dell’autodisciplina: il richiamo o l’espulsione dall’istituto, che è forse la sanzione peggiore. L’efficacia dell’autodisciplina dipende molto anche dal luogo in cui opera: se in Italia il pubblico ritiene che il codice di autodisciplina sia una cosa seria e che gli operatori pubblicitari corretti vi aderiscano, nel caso che qualcuno venga espulso, o che comunque venga considerato dall’organo autodisciplinare soggetto non serio, perde la propria clientela, quindi il meccanismo autodisciplinare funziona; se invece la mentalità diffusa in Italia fosse: il codice di autodisciplina è solo una stupidaggine, non accoglie solo operatori seri, allora la sua efficacia sarebbe scarsa. Questo, secondo me, è un significativo problema dell’autodisciplina, e si collega, come dicevo prima, al discorso di come l’ambiente, la popolazione locale, vede quelle norme; noi Italiani siamo abbastanza smaliziati in confronto a cittadini di altri Paesi; non siamo molto propensi ad accettare che il codice di autodisciplina pubblicitaria sia infallibile, siamo piuttosto critici; per noi non è poi sicurissimo che, se un’impresa viene redarguita dal Giurì della pubblicità, sia poco seria.Tante volte siamo incuriositi di vedere chi vince. 26 Questo atteggiamento toglie efficacia al meccanismo autodisciplinare. L’autodisciplina è un fenomeno che nasce, in realtà, nel mondo anglosassone, e per la mentalità inglese, se un soggetto viene espulso dall’ente di autodisciplina pubblicitaria, si tratta di una cosa grave, c’è mancanza di serietà. Invece da noi il giudizio del Giurì è interessante, però aspettiamo la prossima puntata. Il diritto europeo dell’informatica Il diritto comunitario ha cominciato a elaborare alcune regole per l’informatica. Abbiamo, in particolare, una direttiva generale, la direttiva 31 del 2000, che ha costituito il primo set di regole organiche in materia, in particolare, del commercio elettronico. Ovviamente questa direttiva non può porre tutte le regole sul commercio elettronico, anche perché la materia dei contratti, che poi disciplina anche il commercio in rete, è molto peculiare ai singoli ordinamenti. La disciplina contrattuale nazionale scaturisce da decenni e decenni di studi della dottrina, quindi è difficile accettare che venga sconvolta da un intervento del legislatore comunitario, che non può cambiare l’assetto della disciplina contrattuale degli Stati membri; può porre alcune regole di armonizzazione e di coordinamento su alcuni aspetti, e difatti questa è una direttiva che non regola “in toto” il commercio elettronico; pone alcune regolamentazioni, lo dice il titolo stesso: è una direttiva relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, ovviamente limitata ai soggetti comunitari. Termine di recepimento era il 17 gennaio 2002. Questa direttiva, in particolare, riguarda i servizi della società dell’informazione, che definisce come: “qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, che abbia le seguenti caratteristiche: sia un servizio reso a distanza per via elettronica e a richiesta individuale”. Notiamo subito che le regole della direttiva riguardano i servizi normalmente prestati dietro retribuzione, però anche i servizi non prestati dietro retribuzione e quindi, tra l’altro, anche le semplici comunicazioni commerciali, non necessariamente le proposte contrattuali, purché questi servizi siano prestati a distanza, cioè senza che le parti siano fisicamente compresenti; questi servizi devono inoltre essere prestati per via elettronica, cioè esclusivamente mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione, memorizzazione dei dati e per ora la direttiva richiede che siano servizi prestati a 27 richiesta individuale di un destinatario, cioè devono essere richiamati dal destinatario stesso; per la verità già in sede di preparazione della direttiva, su questo punto si era discusso molto; l’art. 21 al comma 2 dice che prossimamente si vedrà se poi modificare la direttiva estendendo la tutela, la regolamentazione, a tutti i servizi prestati a distanza e non solo a quelli prestati a richiesta individuale. Le disposizioni di questa direttiva riguardano molti aspetti: la conclusione del contratto, le informazioni da fornire in rete, le responsabilità del provider; le regole della direttiva premettono sempre: “ferme restando tutte le altre regolamentazioni del diritto comunitario”, perché il diritto comunitario ha posto delle regole generali, precedentemente, su tutte le vendite, su tutti i servizi prestati a distanza, indipendentemente dal fatto che lo siano per via elettronica oppure no. In particolare, riguardo a questo, la direttiva 97/7 sulla vendita a distanza disciplina tutte le vendite effettuate tra un venditore e un consumatore che non sono fisicamente compresenti, quindi regola le vendite per catalogo, in televisione, per lettera... Se il consumatore non è soddisfatto, per sciogliere il contratto deve trasmettere una comunicazione di recesso. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta all’indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Già nell’’85, però, era stata emanata una direttiva sulle vendite negoziate fuori dai locali commerciali, secondo diverse tipologie di marketing, come ad esempio le vendite porta a porta e le vendite durante escursioni organizzate, dove il consumatore comunque vede il prodotto e incontra il venditore, però non in un normale negozio; il legislatore comunitario ha inteso tutelare il consumatore perché queste tecniche di vendita possono risultare aggressive. In sostanza si fa il ragionamento per cui se il consumatore va ad acquistare in un negozio, c’è la sua volontà, è lui che decide, sceglie, in quanto va nei negozi, confronta e quindi si tratta di una sua iniziativa; se invece arriva qualcuno a casa e offre il prodotto, si è un po’ colti di sorpresa; si ritiene che in queste vendite il consumatore possa essere forzato nella sua volontà, e quindi che si tratti di contratti stipulati con il rischio di un vizio della volontà. La direttiva dell’’85 ha voluto non già vietare questi contratti, ma dare al consumatore la possibilità, se poi ci ripensasse, e si rendesse conto che in realtà non voleva comprare, di recedere entro sette giorni. 28 L’Italia ha recepito la direttiva dell’’85 molto in ritardo, nel ‘92, quando la Comunità stava già preparando la direttiva 97/7 sulle vendite a distanza; visto che c’era, l’Italia ha voluto già disciplinare nel decreto di recepimento anche le vendite a distanza e quindi noi siamo stati in anticipo rispetto alla Comunità europea, dato che è dal ‘92 che abbiamo il diritto di recesso anche per le vendite a distanza mentre, per la Comunità, c’è solo dal ‘97. Tornando al commercio elettronico, ci sono regole specifiche della Comunità: intanto chi vende in rete, oltre agli altri obblighi di informazione posti dal diritto comunitario, deve fornire delle informazioni specifiche relative alla trasparenza delle comunicazioni commerciali, che devono essere chiaramente identificabili, in modo che sia chiaro che quella è una comunicazione commerciale proveniente da un determinato soggetto: non può esserci un nome di fantasia non riconducile a una specifica azienda Ci sono poi delle regole sulle comunicazioni commerciali non sollecitate, il cosiddetto spamming: il problema è quello di essere invasi da comunicazioni non richieste; anche qui deve essere identificabile il soggetto che le emette e i consumatori che non le vogliono, devono poterle bloccare. 29 RIFLESSIONI SULLA SICUREZZA ALIMENTARE Gianfranco Corgiat Loia La sicurezza alimentare è un tema di grande attualità, un requisito spesso esibito e vantato ma che stenta a tradursi, nella pratica operativa, in effettiva garanzia. Soprattutto perché oggi la varietà dell’universo produttivo (agricolo, artigianale, industriale) del settore alimentare, resa più complessa dai molteplici intrecci distributivi e commerciali, rende oggettivamente difficile un efficace governo sanitario. Da qui l’esigenza, per una sempre maggior tutela dei consumatori, di creare, a livello europeo e nazionale, speciali organismi, definiti Authority, per coordinare i vari elementi del sistema, vigilando affinché l’elemento sicurezza sia centrale in tutte le fasi del processo produttivo. Un discorso che deve valere per ogni tipo di alimento, dal prodotto tipico alle preparazioni di massa. In Piemonte la sicurezza alimentare è garantita, in tutti i livelli della catena alimentare, da una rete molto valida costituita da servizi sanitari seri e rigorosi, ben supportati da laboratori pubblici efficienti ed accreditati e da Istituzioni universitarie di prestigio. Una rete che ha stimolato un alto grado di consapevolezza nel ricco e variegato mondo dei produttori che operano, anche con inevitabili momenti dialettici, in stretta collaborazione con gli organi di vigilanza. I risultati di queste sinergie si traducono in concrete garanzie offerte ai consumatori ed in una serie di consolidate esperienze operative che possono essere vantaggiosamente esportate. Per garantire una reale sicurezza al consumatore gli elementi da considerare sono numerosi. Innanzi tutto va definita, a livello generale e di ogni singola filiera, la mappa dei pericoli da cui partire per una corretta valutazione dei rischi considerando le sostanze sicuramente nocive, e quelle per le quali la sicurezza non è dimostrata. Soltanto una accurata valutazione del rischio può consentire un adeguato sistema di controlli tale da poter neutralizzare le frodi e da permettere la correzione di inconvenienti igienici derivanti di standard di qualità insufficienti. Particolare attenzione va anche rivolta alle impostazioni alimentari errate ed agli stili di vita scorretti che possono, attraverso una domanda impropria, condizionare negativamente gli orientamenti produttivi. A fianco dei controlli di processo che ricadono sotto la responsabilità delle imprese 30 della filiera agro-zoo alimentare (autocontrollo), per garantire ai cittadini la sicurezza alimentare è necessario un buon sistema di controllo pubblico, che deve essere indipendente, totalmente affrancato alle pressioni del mondo produttivo che tende inevitabilmente a richiedere la semplice legittimazione dell’esistente. Altro punto chiave è la flessibilità dell’impostazione organizzativa, nelle strategie, nei programmi e nel costante adeguamento dei metodi di analisi. La chimica e la tecnologia alimentare propongono di continuo nuove molecole ed adottano modifiche nei processi produttivi: il rischio sanitario, immediato o dilazionato nel tempo, deve essere costantemente monitorato e valutato evitando che a guidare la danza sia solo la legge del profitto ad ogni costo. Emerge pertanto l’esigenza di uno stretto rapporto con il mondo della ricerca scientifica, un supporto indispensabile sia per prevenire effetti indesiderati sulla salute sia per la lealtà della competizione commerciale. L’obiettivo della qualità e della valorizzazione dei prodotti agro-alimentari nazionali passa inevitabilmente attraverso la certezza che non ci sono effetti indesiderati, né immediati né potenziali, sulla salute pubblica. Lo stretto intreccio tra le politiche di sicurezza alimentare e quelle di sostegno della qualità delle produzioni italiane ha generato malintesi e confusioni: prosciutto crudo, parmigiano e gorgonzola sono senz’altro prodotti eccellenti sotto il profilo qualitativo ma ciò non è sufficiente a garantire automaticamente la sicurezza sanitaria (e lo dimostrano gli stati di allerta comunitari!). Anche la tracciabilità e le garanzie di informazione ai consumatori sono state spesso presentate come garanzie di sicurezza alimentare anziché come strumenti che concorrono a migliorare le possibilità di controllo e a circoscrivere le responsabilità soggettive degli operatori della filiera zoo-agro-alimentare. L’indicazione dell’origine dei prodotti alimentari che si consumano e la corretta informazione sulle principali fasi del processo di trasformazione possono orientare gli acquisti dei consumatori in particolari situazioni di allerta (es. diossina in carni provenienti dal Belgio, colorante Sudan in peperoncino macinato proveniente dall’India ecc..) Sempre più il consumatore deve essere informato del fatto che il “rischio zero” è un’utopia. Il miglioramento delle tecniche e delle tecnologie impiegate nell’analisi chimica, fisica e batteriologica degli alimenti destinati all’uomo consente oggi di 31 evidenziare quantità infinitesimali di residui potenzialmente nocivi la cui pericolosità deve essere valutata in rapporto a diversi fattori di rischio (analisi del rischio). Anche gli esami biologici hanno fatto progressi molto rapidi e fino a qualche anno fa inimmaginabili: gli studi di biologia molecolare hanno reso accessibile anche nella routine esami basati sulla moltiplicazione ed amplificazione di filamenti di acidi nucleici o di proteine patogene (prioni della BSE) in passato non rilevabili se non in quantità elevate. Ciò non significa che il consumatore debba accettare il rischio con rassegnazione e senso di impotenza ma occorre maggiore equilibrio e senso di responsabilità nel valutare le notizie di stampa e nell’approfondire gli argomenti per non restare intrappolati nel giudizio di altri. Valutazione e controllo dei pericoli in campo alimentare. E’ necessario un approccio più razionale e pragmatico al concetto di rischio la cui valutazione deve essere fatta sempre più sulla base di conoscenze scientifiche interdisciplinari. Non sempre l’obiettivo sarà quello dell’eliminazione del rischio; in qualche caso ci si dovrà accontentare dell’obiettivo meno ambizioso ma più realistico della riduzione o minimizzazione del rischio. Anche per questi motivi assume una particolare importanza la “comunicazione del rischio” rivolta ad informare correttamente il consumatore per evitare atteggiamenti di minimizzazione o di sopravalutazione del rischio sanitario (particolarmente evidenti negli ultimi anni), elementi che concorrono alla formazione di una categoria di giudizio che risponde al nome di “qualità percepita”. Alcuni problemi di sanità pubblica (es. salmonella o listeria in alimenti destinati al consumo) richiedono un approccio diverso: non è ammissibile dire che i controlli per questi microrganismi patogeni sono stati costantemente negativi (o sono stati cercati in matrici sterili o si è usata una tecnica di laboratorio inappropriata). Un atteggiamento serio e responsabile potrebbe essere quello di definire livelli di attenzione che mettano in moto procedure operative rivolte a ridurre al minimo il rischio negli impianti di produzione (trattamenti di sanificazione, rilavorazione dei prodotti ecc..) fino a prevedere informazioni di uso per i consumatori (es. da consumarsi esclusivamente cotto) o dichiarazioni di idoneità per alcune fasce di consumatori (anziani, bambini, soggetti immunodepressi ecc..) 32 Ad es. tutti sanno che le cozze crude o poco cotte possono essere pericolose; per minimizzare il rischio la norma stabilisce regole di allevamento (bacini controllati), criteri di qualità delle acque, criteri di controllo sul pescato ma senza un’adeguata informazione del consumatore (far cuocere il prodotto) il rischio sanitario potrebbe esser comunque elevato. In altri casi l’unica garanzia di sicurezza alimentare potrebbe essere quella della sterilizzazione dei prodotti posti in commercio. Gli americani, ad es. a seguito di alcuni casi di enterite emorragica mortale in alcuni bambini attribuita al consumo di hamburgher contenenti un microrganismo particolarmente aggressivo (Coli o 157 citotossico) hanno autorizzato l’irraggiamento delle carni per assicurare l’inattivazione degli eventuali germi presenti. Le ragioni di una decisione simile sono evidentemente legate all’analisi dei costi e dei benefici di un simile intervento (gli americani non rinuncerebbero mai all’hamburgher e l’industria degli hamburger occupa un posto importante nell’economia americana). E’ una strada che può rivelarsi pericolosa perché se il produttore sa che al termine del processo tutto si può risolvere con un trattamento risanatore potrebbero venir meno le attenzione sui livelli di igiene di base. La difesa della tipicità e della tradizione In Europa, e soprattutto in Paesi come la Francia e l’Italia gli orientamenti sono sostanzialmente e comprensibilmente diversi. In Italia si producono circa 350 tipi di formaggio ed altrettanti specialità si contano nel settore dei salumi, con tecniche, tecnologie di produzione e prodotti molto diversi e spesso dipendenti dall’azione di particolari microrganismi “buoni”. Soluzioni “all’americana” (sterilizzazione dei prodotti) potrebbero distruggere l’economia del paese ed irritare i consumatori italiani, abituati ad un equilibrato compromesso tra sicurezza sanitaria e gusto dei prodotti. Se vogliamo mantenere la produzione di formaggi a base di latte crudo (e quindi più a rischio di quelli ottenuti da latte pastorizzato) è necessario innalzare i requisiti di igiene e la qualità delle materie prime ed avviare iniziative di formazione e responsabilizzazione dei produttori. Da una parte le esigenze di tutela dei prodotti tipici e della cultura gastronomica, dall’altra l’indifferenza o la cattiva informazione sulla destinazione dei prodotti alimentari 33 che escono dal sistema distributivo ordinario. I punti deboli della ristorazione Uno dei canali più diffusi e meno controllabili per la circolazione di alimenti di dubbia qualità organolettica o sanitaria è quello della ristorazione pubblica (ristoranti, bar, trattorie, agriturismi, mense aziendali ecc..). L’enorme numero di esercizi da controllare, l’esiguità delle risorse disponibili e la complessità dei flussi di approvvigionamento e trasformazione di alimenti destinati alla somministrazione lascia spazio ad illeciti la cui gravità è spesso sottovalutata. In Italia, la capacità di controllo di questa rete è tale da poter assicurare, nelle aree meglio organizzate, un’ispezione, in media, ogni tre-quattro anni per ogni punto di somministrazione. La situazione è migliore nella ristorazione scolastica ed in quella ospedaliera dove la frequenza dei controlli può raggiungere i 2-3 accertamenti all’anno, ai quali si aggiunge anche una più attenta attività di autocontrollo da parte delle aziende appaltatrici. Non si spiegherebbe, ad esempio, come mai sia estremamente difficile rintracciare alimenti di discutibile qualità organolettica (es. polli congelati in salamoia provenienti dal Brasile, carni ricostruite con l’impiego di transglutaminasi, alimenti di basso costo provenienti da Paesi Terzi in cui il sistema di controllo è risultato carente ecc.) che non risultano transitare in laboratori o in industrie di trasformazione ma che sono registrate in ingresso dai posti di ispezione posti alle frontiere dell’Europa (PIF – Posti di Ispezione Frontaliera). Eppure qualche “sintomo” c’è. Resta da spiegare come siano possibili ribassi del 30 o 40% sui prezzi a base d’asta fissati con criteri di mercato. Carne bovina a 1 euro al chilogrammo o vino ad 1 euro al bottiglione devono far sorgere il dubbio sulla qualità del prodotto acquistato o quantomeno sulla trasparenza dei canali commerciali attraverso i quali l’alimento è giunto alla mensa. Non è sempre vero che l’alimento che costa di più sia anche quello che ha qualità superiori ma è certo che l’alimento che costa molto poco rispetto al valore di mercato deve essere trattato come alimento a rischio. Si può affermare che da una parte il nostro sistema di produzione e di controllo degli alimenti stia migliorando sotto il profilo delle regole generali, dei rapporti tra controllori e controllati e della qualità del controllo. 34 Migliorano infatti anche le tecnologie di laboratorio e le tecniche di indagine, migliora, seppure lentamente, l’organizzazione dei controlli e le garanzie di informazione. In passato si ignoravano molte cose ed il controllo sanitario degli alimenti era limitato a valutazioni sensoriali (vista, tatto, olfatto) o a un evidente collegamento tra malattia e causa determinante (es. intossicazione alimentare, teniasi, tubercolosi ecc..). Oggi le patologie croniche legate alla contaminazione ambientale o ad abusi nell’uso di farmaci o all’impiego illecito di sostanze ad azione estrogena sono difficilmente correlabili all’alimento consumato. Basta pensare a come sia cambiato il significato di “sicurezza alimentare” negli ultimi 5060 anni. Per i nostri nonni la sicurezza alimentare era la disponibilità di alimenti in quantità sufficiente da poter sfamare la famiglia, per noi, oggi, il concetto di sicurezza alimentare è legato alla salubrità ed all’igiene all’alimento. La disponibilità è fuori discussione. Tracciabilità - rintracciabilità Sono due concetti apparentemente simili ma che presuppongono diverse responsabilità. La tracciabilità non è altro che la documentazione delle attività di controllo svolte lungo il processo produttivo, ovvero i sassolini che Pollicino lascia per poter ritrovare la via di casa. La rintracciabilità è la possibilità di percorrere a ritroso le fasi del processo di produzione per poter bloccare la commercializzazione di prodotti risultati pericolosi per la salute pubblica e per accertare le responsabilità soggettive. La rintracciabilità è il presupposto fondamentale per la predisposizione ed attuazione delle procedure di ritiro dal mercato di prodotti non conformi e per l’applicazione di misure sanitarie urgenti (sistema di allerta). Tracciabilità e rintracciabilità non sono informazioni direttamente disponibili al consumatore finale ma sono un obbligo per le industrie alimentari e sono un’opportunità straordinaria per gli organi di controllo (ASL, NAS). Alcune di queste informazioni possono raggiungere il consumatore con l’etichetta apposta sui prodotti o per effetto di norme specifiche come, ad esempio, quella riguardante l’etichettatura delle carni bovine, resa obbligatoria dopo la crisi BSE per riconquistare la fiducia dei consumatori e rilanciare i consumi di carne. Per poter avviare il sistema di etichettatura della carne bovina si è dovuto partire dall’anagrafe zootecnica nazionale, ovvero dall’identificazione di tutti i bovini allevati in 35 Italia e dalla registrazione dei loro spostamenti, fino alla macellazione ed al commercio delle carni. Sono ora allo studio dell’Unione Europea e dello Stato Italiano progetti di etichettatura volontaria di altri alimenti e, in particolare, delle carni di pollame. Le iniziative di informazione rivolte al consumatore dipendono molto dalle loro sollecitazioni, particolarmente forti in occasione di emergenze sanitarie ma insufficienti in altri periodi. Sistema di allerta comunitario Per migliorare l’efficienza e l’efficacia i sistemi di controllo in occasione di emergenze sanitarie internazionali l’Unione Europea ha fornito precise indicazioni procedurali che definiscono il cosiddetto “Sistema di allerta comunitario” Si tratta di un sistema di comunicazione tra Paesi aderenti all’Unione che sfrutta gli obblighi di tracciabilità e di autocontrollo per assicurare il blocco della commercializzazione di prodotti non conformi ed il ritiro degli stessi dal mercato. Il sistema di allerta prevede interventi rapidi degli organi di controllo nei casi in cui il prodotto in commercio provenga da un altro Stato membro e obblighi di segnalazione e di intervento diretto nei casi in cui lo stabilimento che ha prodotto gli alimenti non conformi sia sul territorio nazionale. Questo sistema ci ha permesso di ottenere, in tempi accettabili, le informazioni sulla presenza di diossina in carni provenienti dal Belgio, la presenza di medrossiprogesterone acetato in carni provenienti dall’Olanda, la presenza di Sudan 1 in peperoncino proveniente dall’India e molte altre segnalazioni riguardanti la presenza di microrganismi potenzialmente pericolosi in alimenti destinati all’uomo. Ma occorre fare attenzione a non abusare di questo sistema per inconvenienti sanitari di scarsa rilevanza o circoscritti ad ambiti territoriali molto stretti per evitare di commettere l’errore di Pierino che gridava “al lupo, al lupo” anche quando non era necessario. Nell’ambito di questo sistema di comunicazione tra Amministrazioni pubbliche a cui competono i controlli sanitari non è necessario ricontrollare gli alimenti già analizzati in altri laboratori pubblici: le imprese di produzione si assumono la responsabilità di ritirare i prodotti del lotto risultato non idoneo al consumo o di accettarne la distruzione in loco, fatte salve le responsabilità penalmente perseguibili. Il sistema di allerta poggia sul principio che, se un prodotto appartenente ad un 36 determinato lotto di una determinata ditta, ben identificato come modalità di presentazione e di scadenza, risulta non idoneo a Palermo o a Parigi, non è idoneo al consumo neanche a Torino, indipendentemente dal fatto che lo si ricontrolli o meno. In sintesi, un bel risparmio di tempo e di danaro per il Servizio Sanitario Nazionale! I controlli di laboratorio Il campionamento e l’analisi degli alimenti costituisce un importante supporto alle attività di controllo ufficiale ed autocontrollo degli alimenti ma, a partire dagli anni ’90, l’analisi di laboratorio ha assunto via via un significato più ampio e completo. Da semplice accertamento delle caratteristiche intrinseche di un prodotto alimentare campionato in una qualsiasi fase del processo produttivo l’analisi di laboratorio è diventata anche uno strumento per monitorare i punti critici dei processi produttivi e per verificare l’idoneità dei sistemi di sorveglianza basati sul sistema HACCP messi in atto dalla imprese, che ricadono nella più ampia sfera dell’autocontrollo. L’attuale sistema di controlli sulla sicurezza alimentare prevede due piani distinti anche nelle attività di analisi: l’uno, associato all’autocontrollo, fa capo a laboratori privati accreditati ed inseriti in registri regionali, l’altro, associato al controllo ufficiale, fa capo alla rete dei laboratori pubblici dell’Istituto Zooprofilattico e dell’ARPA (Agenzia Regionale per l’Ambiente). Per assicurare l’omogeneità dei controlli pubblici e privati la norma ha previsto che tutti i laboratori che operano nel settore degli alimenti siano conformi a quanto stabilito da specifiche norme internazionali (ISO-EN). La verifica della conformità (accreditamento) spetta ad un organismo cosiddetto “di parte terza” L’attuale sistema di controllo degli alimenti tende a ridurre quantitativamente i controlli pubblici migliorandone la qualità ed orientandoli in prevalenza a valutare l’adeguatezza ed attendibilità dei sistemi di autocontrollo privati. L’impiego di sofisticate apparecchiature per la ricerca di residui chimici e di microrganismi pericolosi per la salute pubblica rende altamente efficace l’attuale sistema di sorveglianza, anche quando gli organi di stampa evidenziano irregolarità e denunciano pericoli per il consumatore. Un buon sistema di controllo evidenzia sempre irregolarità: risposte costantemente negative dovrebbero far sospettare irregolarità nei prelievi o nell’analisi di laboratorio e sarebbero inutilmente onerose per la collettività. Il campionamento e l’analisi degli alimenti sono attività che devono trovare un equilibrio 37 tra le esigenze di tutela della salute ed il diritto dei produttori a difendersi dalle accuse degli Organi di controllo: due principi costituzionali che le norme sulla sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori tengono in buona considerazione anche quando, per motivi di deteriorabilità dell’alimento occorre svolgere accertamenti semplificati ed in tempi relativamente ristretti. La principale carenza del sistema pubblico di controllo sta proprio nelle norme di garanzia nei confronti dei produttori: coloro che utilizzano in modo spregiudicato sostanze chimiche nuove e non ben conosciute nell’allevamento degli animali o nei trattamenti delle colture agricole sanno di poter contare sul vantaggio della prima mossa fintanto che i laboratori pubblici non mettono a punto metodiche analitiche legalmente inoppugnabili e scientificamente attendibili. La battaglia contro i sofisticatori dura da decenni ed i risultati sono, almeno in Piemonte, di buon livello, anche se non sempre al riparo dalle periodiche notizie di stampa che anziché valorizzare l’impegno degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale preferiscono sottolinearne i ritardi e l’inefficienza (la “malasanità” fa più notizia della buona sanità). Il principio di precauzione La prevenzione in campo sanitario consiste in un insieme di regole e di comportamenti messi in atto per evitare l’insorgenza di un evento negativo noto. Si fa prevenzione nei confronti della tubercolosi, della salmonellosi, dell’epatite, di forme degenerative, dismetaboliche o allergiche. Il principio di precauzione, introdotto dalla Commissione CEE a partire dagli anni ’80 ed inizialmente riferito a temi ambientali, è stato via via esteso anche alla sicurezza alimentare come strategia di controllo di eventi non ancora ben conosciuti e nei confronti dei quali sono in corso od occorrono approfondimenti scientifici. La “precauzione” è l’arma comunitaria contro i nuovi pericoli non ancora sufficientemente noti. In un interessante documento del 2 febbario 2000 (COM 2000 1) la Commissione CE asserisce che quando esistono ragionevoli motivi per ritenere che i pericoli potenziali possono pregiudicare la salute ambientale o umana, animale o vegetale e quando nel contempo la mancanza di informazioni scientifiche impedisce una valutazione dettagliata, il principio di precauzione risulta essere la strategia di gestione del rischio 38 politicamente accettata in numerosi campi. Sempre secondo la Commissione, per evitare il ricorso ingiustificato al principio di precauzione o a forme dissimulate di protezionismo i provvedimenti assunti dalla pubblica amministrazione devono essere: proporzionali al livello di protezione scelto; non discriminatori nella loro applicazione; coerenti con i provvedimenti similari già adottati; devono basarsi su un esame dei costi e dei benefici potenziali dell’azione o dell’assenza di azione; essere oggetto di revisione alla luce dei nuovi dati scientifici; definire le responsabilità - o l’onere della prova – la valutazione completa del rischio. Nell’adottare misure di tipo precauzionale la Commissione tiene conto dei principi generali e della giurisprudenza (Corte di giustizia) e fa sì che la protezione della salute abbia comunque la precedenza sulle considerazioni economiche. Il principio di precauzione non deve essere inteso né come politicizzazione della scienza né come accettazione del rischio zero; esso fornisce una base di azione quando la scienza non è in grado di fornire una chiara risposta. E’ evidente che a determinazione di ciò che si ritiene un rischio accettabile per l’UE rientra nella responsabilità politica e tiene conto delle espressioni dei cittadini europei. Deve essere da tutti accettato che il principio di precauzione non possa essere o diventare una giustificazione per ignorare nuove prove scientifiche o per adottare decisioni protezionistiche Le leggi dell’U.E. in materia di alimenti di origine animale La prima direttiva sul controllo delle carni in Europa risale al 1964. Da allora, prima per il settore delle carni fresche, poi per le carni trasformate, fino alle più recenti disposizioni riguardanti il settore ittico, il settore lattiero caseario e quello degli ovoprodotti, si è venuto a creare un corpo giuridico rilevante, basato su norme cosiddette “verticali” (settoriali) ed orizzontali (che toccano in modo trasversale più settori, anche di interesse non veterinario). La normativa comunitaria si è sviluppata partendo da un’impostazione che privilegiava i requisiti strutturali ed igienico funzionali degli stabilimenti che chiedevano l’autorizzazione a commercializzare gli alimenti in tutta Europa, per arrivare ad un 39 sistema di garanzie che mantiene alto il livello di attenzione sugli standard strutturali ma che abbraccia anche aspetti di carattere organizzativo, gestionale e funzionale (sistema di garanzie aziendali e pubbliche – autocontrollo e controllo ufficiale). Soltanto negli anni ’90 si inizia a porre l’attenzione anche nei settori degli alimenti non di origine animale con alcuni provvedimenti comunitari che affrontano complessivamente il problema dell’igiene alimentare con un approccio più moderno basato sull’analisi dei pericoli e sul controllo dei punti critici noto come HACCP (Hazard Analisys and Critical Control Point) Mentre per tutti gli stabilimenti che operano nei settori di interesse veterinario è previsto l’obbligo di identificare l’unità di produzione sottoposta a controllo veterinario con un apposito “marchio” anche noto come Bollo CEE (un ovale in cui è racchiuso un numero di identificazione univoco e la sigla dello Stato Membro in cui sorge l’impianto) nel settore degli alimenti non di origine animale non è ancora previsto l’obbligo di identificazione degli stabilimenti di produzione che, quindi, operano in base a regole nazionali (in Italia la Legge 283/62 e relativo Regolamento di attuazione approvato con DPR 327/80). Le emergenze sanitarie degli ultimi 15 anni hanno sollecitato una revisione generale della normativa comunitaria nel settore degli alimenti. Prima con il cosiddetto “Libro Bianco” voluto dalla Presidenza Prodi, poi con il Regolamento 178/2000 con il quale si è istituita l’Authority comunitaria per la sicurezza alimentare, poi con provvedimenti settoriali quali la decisione 471/2001 riguardante il controllo microbiologico delle carni nei macelli, si sta via via delineando un nuovo ordinamento comunitario in materia di sicurezza alimentare. Sono allo studio della Commissione Ce importanti provvedimenti che rivedranno l’impostazione delle norme settoriali riferite agli alimenti di origine animale, alcune norme di polizia veterinaria riguardanti la sanità degli animali ed il settore degli alimenti non di origine animale. E’ prevista l’abrogazione di 17 direttive comunitarie degli anni ’80 e ’90 e saranno ridefiniti i compiti e le responsabilità dei produttori e degli Organi di vigilanza nell’ambito delle attività di produzione, trasformazione, commercio e somministrazione di alimenti e bevande. Il problema degli scarti alimentari Le emergenze sanitarie relative alla presenza di diossina in carni provenienti dal Belgio 40 e la più recente vicenda della cosiddetta “mucca pazza” hanno messo in evidenza lo stretto legame tra alimentazione animale e consumo di alimenti da parte dell’uomo. L’alimentazione zootecnica ha stretti collegamenti con la gestione degli scarti dell’industria alimentare: la zootecnica intensiva risparmia sui costi di alimentazione del bestiame e permette all’industria alimentare di risparmiare sui costi di smaltimento. In altri termini si potrebbe affermare che una certa zootecnica si è specializzata nello smaltimento di alcuni materiali di scarto. Oli di recupero contenenti diossina, animali morti diventati farine per uso zootecnico, residui dell’industria laniera diventati lettiera e fonte di contaminazione da cromo sono alla base delle più note e recenti emergenze sanitarie. L’industria alimentare e quella zootecnica producono scarti che devono essere smaltiti e, all’inizio degli anni ’90, qualcuno ha pensato che un buon sistema poteva essere quello di chiudere il cerchio: gli animali morti in un allevamento venivano recuperati e trasformati in farina proteica in impianti specializzati. Le farine proteiche erano utilizzate nella dieta degli animali produttori di alimenti ed i grassi fusi erano utilizzati come combustibile o come integratori per il latte destinato ai vitelli. E il ciclo continuava a ripetersi all’infinito. Oggi quando si macella un animale, si devono distruggere (senza possibilità di riutilizzo) tutti gli organi che possono essere potenzialmente pericolosi per la presenza di prioni (circa trenta chili per ogni bovino macellato). Sono migliorate le garanzie di difesa della salute dei consumatori ma in Piemonte, tutti i giorni, si producono ottanta tonnellate di scarti da allevamenti e da macelli che devono essere inceneriti. I costi di produzione sono cresciuti ma nessuno è disposto a pagare i costi generati dall’applicazione delle nuove misure di controllo. I ricchi Paesi industrializzati hanno finora prestato poca attenzione al problema delle eccedenze produttive e dei cosiddetti “scarti” alimentari. Supermercati e mense spediscono in discarica ingenti quantitativi di risorse alimentari prossime alla scadenza o non riutilizzabili nello stesso circuito (ad.es. mense scolastiche) ma ancora idonee al consumo, mentre un crescente numero di indigenti non ha di che sfamarsi e le Associazioni di volontariato o i centri di accoglienza chiedono finanziamenti per poter sostenere iniziative come il “Banco Alimentare” o le “Mense dei Poveri”. E’ opportuno sottolineare che il termine di consumo indicato in etichetta non è 41 sinonimo di alterazione o di cattiva conservazione dell’alimento ma, per evitare il riciclaggio indiscriminato dei prodotti che escono dal commercio ordinario, servono interventi legislativi che dettino le regole per il recupero di alimenti ancora idonei al consumo e consenta al nostro Paese di uscire dall’ipocrisia generale che fa credere ai consumatori ed ai media che tutto ciò che esce dal circuito commerciale normale sia incenerito o, nella migliore delle ipotesi, destinato agli animali. Il consumatore deve sviluppare un maggiore senso critico ed imparare ad incanalarlo nelle giuste direzioni attraverso l’associazionismo o la partecipazione politica alle scelte del nostro Paese ma deve essere più disincantato; vivere nell’ignoranza e illudersi che tutto sia perfetto aiuta a vivere più sereni ma espone a grandi rischi e genera reazioni incontrollate o ingiustificate nei confronti di pericoli indicati dai media che non sempre coincidono con i pericoli reali. E’ lecito porsi la seguente domanda “Che fine fanno gli alimenti giudicati non più idoneo al consumo umano o ritirati dai banchi di vendita”? E’ quasi scontato sentirsi rispondere frettolosamente “sono destinati ad uso zootecnico o vanno alla distruzione”. IL concetto di pericolo sanitario è un concetto scientifico universale perché si basa sulla certezza che un residuo chimico, un virus o un batterio non solo possa ma abbia sicuramente colpito negativamente uno o più individui. Il concetto di rischio, invece, è legato alla società che affronta i pericoli e dipende dalle risorse che si spendono per controllare i pericoli, dall’atteggiamento culturale dei cittadini, dalla conoscenza del problema e dalla possibilità di controllarlo. Generalmente l’uomo accetta di correre rischi se ritiene che vi siano benefici e vantaggi che giustificano il rischio stesso e se ritiene che le misure di controllo del pericolo attuate siano comunque di buon livello (es. viaggiare in aereo, correre in formula 1). Si accetta il rischio anche nei casi in cui si è costretti a scegliere tra due rischi alternativi (es. gettarsi dal balcone quando l’abitazione è in fiamme). La presenza di un microrganismo patogeno è un pericolo ma non sempre gli Stati forniscono le stesse risposte (es. limiti accettabili di cariche microbiche) venendo meno, in alcuni casi, al principio della libera circolazione delle merci (un prodotto idoneo al consumo nel Paese produttore potrebbe non esserlo nel Paese di destinazione). Anche la gestione degli scarti o dei resi alimentari non trova ancora un’adeguata regolamentazione a livello comunitario. Un alimento non più destinato al consumo (es. 42 alimenti con data di scadenza superata) non è sempre un alimento pericoloso per la salute o in cattivo stato di conservazione. Il termine di consumo viene fissato dal produttore per la vendita del prodotto tal quale ma se quest’ultimo, ritirato in prossimità della scadenza ed inviato in un impianto di trasformazione diventa un altro prodotto alimentare (es formaggi fusi) la vita commerciale si allunga. IL recupero e la valorizzazione di alimenti in scadenza o di scarti produttivi derivanti da difetti tecnologici (es. confezionamento difettoso, fuoriuscita dai contenitori, rifilature ecc..) sono realtà spesso sconosciute ai consumatori e possono alimentare circuiti industriali (es. produzione di estratti di carne, gelatine alimentari, formaggi fusi ecc..) o servizi di volontariato nel campo dell’assistenza a persone non abbienti (poveri vecchi, extracomunitari, centri di recupero per tossicodipendenti ecc.). La produzione di scarti nei sistemi industriali complessi come quello agro-zooalimentare pone problemi anche sotto il profilo economico (lo smaltimento degli scarti costa) e sono inevitabili le confluenze tra il sistema alimentare umano e l’industria mangimistica che rifornisce gli allevamenti. Scarti alimentari non più idonei al consumo alimentare umano sono spesso dirottati nel settore mangimistico e soltanto da pochi anni queste attività sono disciplinate in modo rigoroso per gli scarti di origine animale (in risposta all’emergenza BSE) ma in modo ancora insufficiente per gli scarti di altra natura (residui dell’industria risicola, molitoria, prodotti da forno scaduti, residui della lavorazione di prodotti agricoli ecc…). Molto resta ancora da fare in questo settore ma il consumatore deve sapere che la sicurezza alimentare non è sinonimo di qualità delle materie prime utilizzate e che alcuni alimenti “industriali” (estratti di carne, formaggi fusi, polveri di formaggio, carni ricostruite, surimi ecc.) originano da materie prime di qualità inferiore se non da residui della lavorazione delle pelli come nel caso delle gelatine alimentare. Forse l’ansia dei consumatori dipende proprio dal fatto che si è perso lo stretto legame tra produzione e consumo di alimenti, tipico delle civiltà contadine, e dalla scarsa conoscenza dei processi produttivi sempre più complessi e sempre più lontani. Forse è un’ansia da globalizzazione. 43 44 LA SICUREZZA ALIMENTARE NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE (Appunti liberamente tratti dall’intervento di Anna Bartolini) Da alcuni anni si è aperto un dialogo tra Europa e Stati Uniti, per cercare di trovare dei fili conduttori comuni nella regolamentazione in materia di sicurezza dei prodotti, onde evitare gli attuali contrasti, soprattutto in alcuni settori quali la sicurezza alimentare, il commercio elettronico e la proprietà intellettuale. Tra i contrasti più evidenti che ci sono oggi tra Europa e Stati Uniti, c’è quello che tocca il problema della globalizzazione, soprattutto per la parte agro - alimentare; è un contrasto serio, profondo, per cui noi ci troviamo a gestire una situazione che ha un’infinità di incertezze e di cui non conosciamo quali saranno gli sbocchi futuri, ma che fanno intravedere un’infinità di problematiche assai serie, una per tutte: la BSE. La BSE è stata sicuramente la molla che ha fatto scattare, nell’Unione Europea, la necessità di avere il “libro bianco” per la sicurezza alimentare. A questo è correlata la questione della tracciabilità, che noi consumatori chiediamo da anni. Altre cose importanti, che sono conseguenze del libro bianco, sono le norme veterinarie, la direttiva sull’etichettatura dei prodotti che costituisce un grande strumento d’azione, e l’autorità alimentare, la quale è purtroppo una rappresentanza dei paesi membri. Vi sono alcuni problemi che devono essere affrontati prioritariamente dall’autorità alimentare: le sostanze allergogene, con la loro identificazione in un regolamento e con l’obbligo, per tutti i produttori mondiali, di indicare nell’etichetta la presenza di queste sostanze negli alimenti (il latte e i derivati, ad esempio, le noccioline e tutto quello che è ormai scientificamente dimostrato che sia allergenico); l’analisi del rischio e l’informazione sul rischio. Fra i nuovi problemi che si affacciano in Europa oggi e che creano ancora notevole preoccupazione alla Comunità Europea dal punto di vista della sicurezza alimentare, due sono particolarmente rilevanti: la presenza di PCB e la resistenza agli antibiotici. In uno studio pubblicato nella rivista “Que choisir”, risulta che la resistenza agli antibiotici dei francesi è passata dal 5 al 50%; la Francia è quindi il paese europeo che ha la più alta resistenza agli antibiotici; il problema si fa grave rispetto all’uso degli antibiotici per i neonati. Esiste un malcostume nell’uso degli antibiotici, che ha portato ad un tasso 45 troppo elevato nel loro consumo. Da ricerche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, emerge che l’otite, soprattutto quella infantile, è una malattia sulla quale è inutile dare gli antibiotici sia ai bambini che agli adulti, perché gli antibiotici non hanno nessuna funzione su certi tipi di malattie. Per quanto riguarda la direttiva sull’etichettatura alimentare, essa dovrà essere adottata dagli stati membri; non ha nessun effetto cogente come ne ha, invece, un regolamento ma potrebbe diventare un testo unico per tutta l’Europa sulla normativa alimentare. Questa direttiva offre degli strumenti validissimi, perché pone nei confronti del legislatore nazionale ed europeo degli obblighi precisi: nessuna etichetta può essere fatta in modo da trarre in inganno il consumatore. L’Europa ha, sotto il profilo della sicurezza alimentare, una buona legislazione: la Francia, l’Inghilterra e la Germania hanno delle autority alimentari che lavorano molto bene. Un grosso problema è oggi quello dell’importazione, e crescerà nei prossimi anni con l’entrata dei nuovi paesi candidati nell’Unione Europea. Nel momento in cui in un paese europeo la legislazione sta cominciando ad imporre l’HACCP, la tracciabilità e tutta una serie di divieti di usare sostanze nocive per allevare il bestiame, i capitali nazionali e multinazionali emigrano nei paesi dove si può produrre senza controlli. Prendiamo l’esempio della carne di pollo: l’Europa, lo scorso anno, ne ha importato 80.000 tonnellate; non polli interi, bensì soltanto, dal Brasile, parti di pollo. Poiché in questo modo gli importatori pagano una tariffa doganale inferiore. Queste carni arrivano in Europa ad un prezzo che è il 50% inferiore a quello della produzione europea, portando ad una turbativa del mercato. Questa carne viene utilizzata quasi esclusivamente nelle ristorazioni scolastiche e industriali, e dalle aziende che fanno prodotti a base di pollo già elaborati. Le analisi hanno individuato una sostanza che è estremamente tossica, che l’Unione Europea vieta. Sono state invece bloccate le frontiere con la Cina, perché i polli che arrivavano erano infetti di salmonellosi. Ciò è stato possibile anche perché la Cina aveva accettato i controlli veterinari in loco. Occorre che il consumatore acquisti soltanto quei prodotti che indicano in etichetta il luogo da dove viene il prodotto, dove è stato allevato, come è stato alimentato; è quindi importante che non vengano comperati prodotti di pollo trasformato che siano anonimi; non esiste però per il produttore italiano che usa prodotti non suoi, importati magari dall’estero, l’obbligo di indicare in etichetta la 46 provenienza del prodotto. Nel rapporto e nella normativa sulla sicurezza alimentare in Europa, l’esperienza della BSE ha avvicinato competenze. Le criticità arrivano però oggi dal mercato globale. Veniamo ora al TACD ( Trans Atlantic Consumer Dialogue). La prima questione è l’OGM. L’Europa si è pronunciata per avere una tracciabilità degli OGM e quindi un’etichettatura di indicazione che rispetti la scelta del consumatore. In Italia i semi di OGM sono ammessi soltanto nelle coltivazioni a livello sperimentale; sulla nostra linea politica c’è la Francia e altri paesi europei, mentre i più vicini agli americani sono gli inglesi; la Gran Bretagna ha però inserito in internet un documento che tiene conto di tutti gli aspetti degli OGM: dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista delle possibili allergie, e, soprattutto, dal punto di vista delle possibili contaminazioni alimentari. Su questo argomento il dialogo tra Europa e Stati Uniti è assai difficile, poiché questi ultimi sono già pronti ad avere animali e piante geneticamente modificati. Gli Stati Uniti hanno tra l’altro un atteggiamento ricattatorio nei confronti dei paesi del Sud del mondo. Questo desta molta preoccupazione perché se le compagnie multinazionali vendono semi transgenici nei paesi poveri, si verificherebbe una grande diffusione delle coltivazioni transgeniche. Negli Stati Uniti il salmone transgenico è allevato in allevamenti chiusi; esiste però il rischio che una fuga accidentale di un animale inquini tutti gli altri salmoni, con un effetto a catena, per diffondersi nei vari fiumi e laghi, creando a livello mondiale un problema che non sarebbe più governabile. Riprendiamo il discorso degli antibiotici. Gli americani hanno rinunciato a fare un sistema di controllo igienico come l’HCCP. In America, è stato dimostrato, stanno usando l’irraggiamento per rendere i prodotti igienicamente sicuri, ciò significa che sono utilizzati i raggi gamma, in particolare nelle carni, nei polli, nella frutta e nella verdura. L’Unione Europea, invece, su questo tema ha inserito sul sito internet un documento in cui si spiega quando è ammessa la ionizzazione, quando non presenta alcun rischio per la salute.Viene sostenuto inoltre che l’irraggiamento non può mai sostituire misure d’igiene e di buona pratica. L’unico paese che utilizza le radiazioni ionizzanti in modo quasi trasversale è Israele; negli altri paesi sono usate con cautela: in Italia sono ammesse solo per gli agli e le cipolle; una ricerca recentissima dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, condotta su topi da laboratorio che hanno mangiato alimenti irradiati, sostiene che fra loro si sono 47 verificate delle morti premature, mutazioni genetiche, deficienze nutrizionali, problemi riproduttivi, danni agli organi e dei tumori. L’organizzazione di Ralf Nader ha chiesto quindi che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme alla FAO, costituisca un insieme di ricercatori indipendenti che possano dare indicazioni più corrette. Se noi utilizziamo un prodotto diffuso a livello globale dobbiamo chiederci come sia stato prodotto: tante carni provenienti dai paesi dell’est sono state respinte non tanto per un problema di BSE ma per problemi di igiene. Accanto al problema grave dei residui contaminanti, nel dialogo tra Stati Uniti ed Europa ha un grosso peso quello dell’etichettatura. Prendiamo ad esempio la recente direttiva creata in Italia con un decreto sugli integratori alimentari: sostiene che questi prodotti sono alimenti e quindi, come tali, non possono promettere quello che fa un farmaco; pertanto afferma che non si può usare nell’etichettatura di questi prodotti nessuna parola, nessuna frase che possa indurre il consumatore a pensare che questi eliminano il fattore di rischio; nella loro etichettatura invece, gli americani dicono solo, per esempio, che l’aggiunta di calcio ad un alimento può contribuire a diminuire l’incidenza di un fattore di rischio; negli integratori gli americani hanno aperto in modo pazzesco; ciò significa che avremo prodotti funzionali di ogni genere, e tutto quello che può essere fatto di sofisticazione viene fatto. Facciamo un esempio concreto: pensiamo ad un gelato di crema e cioccolato a cui viene aggiunto il calcio; l’etichetta di questo prodotto dirà che questo è un healthy product, perché contiene del calcio in dose abbastanza elevata per cui lo si può assumere contribuendo ad eliminare un fattore di rischio. Ma vogliamo parlare di quanto grasso c’è in questo prodotto o no? Perché quella persona che lo consuma può avere dei problemi di assunzione di grassi; gli americani non vogliono che si dica quanto grasso c’è in questo gelato, per cui ci troveremmo di fronte a un’etichetta di un prodotto salutista che, dal punto di vista, invece, dell’assunzione di acidi grassi saturi e insaturi è un disastro. La nostra legislazione sull’etichettatura alimentare dice che gli ingredienti devono essere indicati in ordine decrescente: grassi, proteine, eccetera; provate a prendere un prodotto che contiene dei grassi: sull’etichetta c’è scritto:“grassi vegetali”, quando sono grassi vegetali, ma quali sono i grassi vegetali che in tutto il mondo vengono usati? Pensate che sia l’olio d’oliva? Assolutamente no, sono solo palma e cocco, che, tra l’altro, danno dei problemi alla salute; vedete quindi che attraverso queste etichette noi possiamo dire tutto e il contrario di tutto o, perlomeno, tacere delle cose 48 che per il consumatore sono fondamentali. Passiamo al problema degli antibiotici: gli americani non vogliono neanche iniziare il dialogo con l’Europa sull’uso degli antibiotici. Nel caso degli OGM gli americani sono andati così avanti perché sono partiti dal presupposto che è sufficiente che il produttore dichiari che il prodotto contiene elementi geneticamente modificati e contemporaneamente dichiari anche che non ci sono rischi per la salute. I problemi della diossina sono sopiti fin tanto che non scoppierà un altro scandalo. L’Italia non ha terminato l’anagrafe bovina, quindi le due etichette che attraverso l’obbligo dei regolamenti comunitari avremo saranno una farsa, saranno due etichette assolutamente inattendibili, perché per quanto riguarda l’etichetta che dice l’origine della carne, nessuno è in grado di dare tutte le informazioni; forse soltanto chi ha un allevamento di soli animali di razza piemontese, marchigiana, chianina, romagnola, può dimostrare di allevare solo carne di quelle razze, ma per il resto nessuna di queste etichette garantisce al consumatore l’origine della carne per il fatto che finché non c’è un’anagrafe bovina, un allevatore può aver importato vitellini dalla Francia, ad esempio, e allevarli qui dichiarando che sono italiani. Abbiamo il problema della diossina perché ormai è nei rifiuti, e quello degli additivi alimentari. Quest’ultimo, però, è un problema al quale l’industria alimentare sta molto attenta, perché le associazioni dei consumatori hanno la possibilità di fare test comparati; una certa tranquillità vi è anche sull’uso dei pesticidi: i risultati forniti dal Ministero della Sanità e le indagini svolte dalle associazioni dei consumatori per l’Italia sono rassicuranti; non abbiamo più, se non in casi rari, quelle quantità di pesticidi che erano rilevate in passato. Il rischio oggi nasce sul biologico, intanto perché abbiamo l’esplosione della domanda; l’ultima indagine che è stata fatta dalla Coldiretti mostra che i consumatori sono disposti a pagare di più per i prodotti alimentari quando è garantito che non contengano organismi geneticamente modificati. Se nel settore della frutta e verdura il problema si può delimitare, nel caso della carne il marchio biologico è una farsa, poiché gli animali vengono trattati con farmaci, soprattutto antibiotici. Un altro aspetto problematico è quello dei controlli. La divisione tra controlli sanitari e controlli finalizzati a verificare che non esistano frodi negli alimenti, crea ancora delle difficoltà: i dati non sempre sono reperibili. 49 ALLEGATI 50
Scaricare