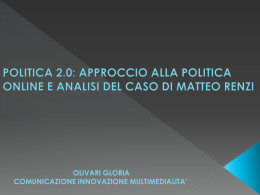RASSEGNA STAMPA lunedì 7 luglio 2014 ESTERI INTERNI LEGALITA’DEMOCRATICA RAZZISMO E IMMIGRAZIONE SOCIETA’ BENI COMUNI/AMBIENTE INFORMAZIONE CULTURA E SCUOLA INTERESSE ASSOCIAZIONE ECONOMIA E LAVORO CORRIERE DELLA SERA LA REPUBBLICA LA STAMPA IL SOLE 24 ORE IL MESSAGGERO PUBBLICO IL MANIFESTO L’UNITÀ AVVENIRE IL FATTO IL RIFORMISTA PANORAMA L’ESPRESSO VITA LEFT IL SALVAGENTE INTERNAZIONALE L’ARCI SUI MEDIA del 04/07/14, pag. 14 Il caso “Ferrulli” non può finire così Ci lascia preoccupati la sentenza della corte d'Assise di Milano sulla morte di Michele Ferrulli. Siamo curiosi di conoscere la motivazione di quella sentenza che ha portato all'assoluzione di 4 agenti delle forze dell'ordine, di fronte ad una richiesta di condanna del Pm a 7 anni. Siamo vicini alla famiglia Ferrulli in questo momento difficile e ci auguriamo che trovi la forza e il coraggio per proseguire il procedimento penale in altri gradi di giudizio. Restiamo convinti che nel nostro Paese la riflessione sul rispetto delle garanzie costituzionali sulla libertà personale non possa essere trattata superficialmente. Come per Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva, Stefano Cucchi e Riccardo Magherini, la necessità di verità e giustizia è una priorità per la qualità della nostra democrazia. Francesca Chiavacci, presidente nazionale Arci Da Asca del 04/07/14 Caso Ferrulli: Arci, non puo' finire cosi'. Attenzione a diritti civili (ASCA) - Roma, 4 lug - ''Ci lascia preoccupati la sentenza della corte d'Assise di Milano sulla morte di Michele Ferrulli. Siamo curiosi di conoscere la motivazione di quella sentenza che ha portato all'assoluzione di 4 agenti delle forze dell'ordine, di fronte ad una richiesta di condanna del Pm a 7 anni. Siamo vicini alla famiglia Ferrulli in questo momento difficile e ci auguriamo che trovi la forza e il coraggio per proseguire il procedimento penale in altri gradi di giudizio''. E' questo il commento del presidente nazionale Arci, Francesca Chiavacci dopo la sentenza. L'Arci torna, quindi, a chiedere che la questione del rispetto delle garanzie costituzionali sulla liberta' personale non sia ''trattata superficialmente'' come, si conclude, e' sembrato avvenire per i casi di Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva, Stefano Cucchi e Riccardo Magherini. ''La necessita' di verita' e giustizia - ha infatti detto la Chiavacci - e' una priorita' per la qualita' della nostra democrazia''. red-gc/ Da Redattore Sociale del 04/07/14 Caso Ferrulli, agenti assolti. Chiavacci (Arci): "Non può finire così" La presidente nazionale dell'Arci sulla sentenza che ha portato all'assoluzione di 4 agenti per la morte dell'uomo, avvenuta 3 anni fa. " La necessità di verità e giustizia è una priorità per la qualità della nostra democrazia" 2 ROMA - "Ci lascia preoccupati la sentenza della corte d'Assise di Milano sulla morte di Michele Ferrulli. Siamo curiosi di conoscere la motivazione di quella sentenza che ha portato all'assoluzione di 4 agenti delle forze dell'ordine, di fronte ad una richiesta di condanna del Pm a 7 anni". Così Francesca Chiavacci, presidente nazionale dell'Arci, sulla sentenza che ha prosciolto i 4 imputati di omicidio preterintenzionale e falso in atto pubblico. Michele Ferrulli è deceduto il 30 giugno del 2011 a Milano mentre gli agenti lo stavano ammanettando. La morte è avvenuta per arresto cardiaco mentre gli agenti lo avevano bloccato dopo un tentativo di controllo. Aggiunge la presidente dell'Arci: "Siamo vicini alla famiglia Ferrulli in questo momento difficile e ci auguriamo che trovi la forza e il coraggio per proseguire il procedimento penale in altri gradi di giudizio. Restiamo convinti che nel nostro Paese la riflessione sul rispetto delle garanzie costituzionali sulla libertà personale non possa essere trattata superficialmente". "Come per Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva, Stefano Cucchi e Riccardo Magherini conclude la Chiavacci -, la necessità di verità e giustizia è una priorità per la qualità della nostra democrazia". Da Asca del 04/07/2014 Crisi: da Rapporto diritti globali emerge realta' 'catastrofica' Piu' che di crisi, si rischia ormai di dover parlare di ''catastrofe globale''. Dopo sei anni, infatti, tutti gli indicatori economici e sociali rivelano un quadro ''drammatico e univoco''. La poco incoraggiante fotografia viene dal nuovo Rapporto sui diritti globali che sara' presentato martedi' 8 luglio, alle ore 11.00, presso la sede della Cgil nazionale, in Corso d'Italia a Roma. In Italia il numero di quanti vivono in condizioni di poverta' assoluta, evidenzia lo studio, e' esattamente raddoppiato tra il 2007 e il 2012, passando da 2 milioni e 400 mila a 4 milioni e 800 mila, l'8% della popolazione. Il tasso di occupazione nel 2013 e', invece, tornato ai livelli del 2002: 59,8%; all'inizio della crisi, nel 2008, era al 63%. Peggio stanno solo i greci (con il 53,2%), i croati (53,9%) e gli spagnoli (58,2%). Tra il 2012 e il 2013 sono stati persi 424 mila posti di lavoro. Dall'inizio della crisi hanno perso il lavoro oltre 980 mila persone. Dati altrettanto drammatici riguardano il tasso di disoccupazione tra i giovani dai 15 ai 24 anni, arrivato al 42,4%. Muoiono le piccole imprese: dal 2008 ne sono scomparse 134 mila. E muoiono le persone: per quanto sia difficile stabilire nessi causali univoci e certi, alcuni studi indicano in 149 le persone che si sarebbero tolte la vita per motivazioni economiche nel 2013, quasi il doppio rispetto agli 89 casi dell'anno precedente. Numeri moltiplicati e non meno tragici sul panorama mondiale: nel 2013 i disoccupati erano 202 milioni. Lievita anche il fenomeno dei lavoratori poveri: sono 200 milioni e sopravvivono in media con meno di due dollari al giorno. Il Rapporto sui diritti globali di quest'anno, giunto alla dodicesima edizione, e' a cura di Associazione Societa' Informazione Onlus, ed e' promosso dalla Cgil con la partecipazione di realta' quali ActionAid, Antigone, Arci, Cnca, Fondazione Basso-Sezione Internazionale, Forum Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente. A presentarlo a Roma saranno, oltre al segretario nazionale Cgil Danilo Barbi, Francesca Chiavacci, presidente nazionale Arci Marco De Ponte, segretario generale ActionAid Italia e Maurizio Gubbiotti, coordinatore nazionale di Legambiente. Interverra' anche Luigi Manconi, presidente della Commissione Diritti Umani del Senato. 3 Da Redattore sociale del 07/07/2014 Dopo la crisi, la crisi - Rapporto sui diritti globali 2014 Data: 08 luglio 2014 Luogo: Cgil nazonale, Corso d'Italia 25, Sala Simone Weil Comune: Roma Scarica allegato Da rassegna.it del 07/07/2014 Economia, lavoro Gli appuntamenti dal 7 al 12 luglio Settimana cruciale per Alitalia: martedì inizia la trattativa a oltranza sugli esuberi. Ilva, scioperi e Novi Ligure e a Taranto, venerdì il decreto sul prestito ponte. Martedì a Perugia l'iniziativa unitaria di Cgil Toscana, Umbria e Marche Settimana importante per Alitalia e Ilva, le due principali vertenze in attesa di soluzione. Per la compagnia aerea l'appuntamento è per domani a mezzogiorno, quando azienda, governo e sindacati saranno al tavolo del ministero dei Trasporti per trovare un accordo sugli esuberi. Si annuncia una trattativa a oltranza per raggiungere al più presto l'intesa considerata indispensabile per concretizzare il matrimonio con Etihad. L'intento, secondo quanto ha affermato il ministro dei Trasporti Maurizio Lupi, è chiudere entro il 15 luglio, ma risolvere il rebus dei 2.251 esuberi non sarà affatto facile. Per il gruppo Ilva è atteso entro la settimana il decreto del governo sul prestito ponte, un provvedimento indispensabile per l'azienda in gravissima crisi di liquidità. L'esecutivo pensa a un decreto per introdurre la prededucibilità a favore delle banche, in pratica una sorta di corsia preferenziale che garantisca alle banche stesse la restituzione dei finanziamenti in caso di fallimento del gruppo. Intanto i sindacati dei metalmeccanici hanno deciso di sospendere lo sciopero nazionale che avrebbe dovuto svolgersi l'11 luglio. Non si fermano, però, le proteste a livello locale. Oggi tocca ai lavoratori di Novi Ligure con uno sciopero di 8 ore contro il mancato pagamento del premio di produzione (una media di 1.500 euro a testa). Giovedì, invece, quattro ore di sciopero a Taranto, alla fine del primo e secondo turno, con una manifestazione in mattinata davanti al siderurgico. Pubblica amministrazione. Si tiene oggi di fronte alle prefetture di tutta Italia la mobilitazione dei lavoratori degli enti locali indetta da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl per rilanciare le proposte unitarie sulla riforma della Pa. Domani in Commissione Lavoro alla Camera prosegue l'Indagine conoscitiva sui call center presenti nel territorio italiano con l'audizione di rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Lo scenario è drammatico: sono infatti circa 3mila i posti a rischio nel giro di poche settimane, fanno sapere le sigle di categoria, conseguenza di chiusure e delocalizzazioni. Monta la protesta alla Tirreno Power, uno dei principali produttori di energia elettrica in Italia, che ha aperto una procedura di licenziamenti collettivi per oltre il 60% della forza lavoro (315 dipendenti su 521). Immediata la dichiarazione di sciopero generale, innanzitutto del lavoro straordinario per tutto il mese di luglio. In casa Cgil, domani a Perugia l'iniziativa di Cgil Toscana, Umbria e Marche "Per un Piano del Lavoro nell'Italia di Mezzo", parteciperà il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, insieme ai tre presidenti di Umbria, Marche e Toscana, Catiuscia Marini, Gianmario Spacca ed Enrico Rossi. Sempre domani, in Cgil nazionale, la presentazione del Rapporto sui diritti globali 2014 pubblicato da Ediesse (Sala Simone Weil, Corso Italia 25). Giovedì a Firenze l'assemblea di quadri Rsu e delegati Cgil Cisl Uil sulla piattaforma unitaria fisco-previdenza. Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria organizzano per venerdì mattina una 4 manifestazione davanti alla prefettura di Perugia, in Piazza Italia, per chiedere l’immediato sblocco della cassa integrazione in deroga. Lunedì 7 luglio Economia Roma, Banca d’Italia: pubblicazione rapporto “Rimesse verso l’estero degli immigrati in Italia”; Roma, Ministero Economia: diffusione Bollettino entrate. Lavoro e sindacato Roma, Palazzo Montecitorio: presentazione dati su infortuni e malattie professionali, partecipa il presidente Inail Massimo De Felice (Sala della Regina, ore 11). Società Roma, Cnel: presentazione Rapporto Ocse “L’integrazione degli immigrati e dei loro figli in Italia”, partecipano il presidente Anci Piero Fassino e il presidente della Conferenza Regioni Vasco Errani (Viale Lubin 2, ore 14.30). Martedì 8 luglio Economia Roma, Banca d’Italia: pubblicazione supplemento al Bollettino statistico “Moneta e banche” di maggio e diffusione dati su principali voci dei bilanci bancari in maggio; Roma, Istat: diffusione dati su consumi delle famiglie nel 2013 (Via Cesare Balbo 16, ore 10). Internazionale Bruxelles, Unione Europea: Consiglio dei ministri dell’Economia e riunione informale ministri Interni e Giustizia. Istituzioni Roma, Camera dei Deputati: audizione di Sindacato italiano librai, Sindacato nazionale scrittori e Slc Cgil su libro multimediale (Commissione Cultura, ore 14.30); Roma, Camera dei Deputati: audizione di rappresentanti Cgil, Cisle, Uil e Ugl su call center (Commissione Lavoro, ore 10). Lavoro e sindacato Perugia, Teatro del Pavone: iniziativa Cgil Toscana, Umbria e Marche “Per un Piano del lavoro nell’Italia di mezzo”, partecipa il segretario generale Cgil Susanna Camusso (Piazza della Repubblica, ore 9); Montecatini Terme (Pistoia), Terme Tettuccio: assemblea Confindustria Lucca Pistoia Prato “Integrarsi, rinnovarsi, crescere. Le Confindustrie Lucca, Pistoia e Prato insieme per guardare al futuro”, partecipa il presidente Confindustria Giorgio Squinzi (Sala Regina, Viale Verdi 71, ore 10); Roma, Ance: presentazione nuovo Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni, partecipa il ministro dell’Infrastrutture Maurizio Lupi (Via Guattani 16, ore 11); Roma, Camera dei Deputati: relazione annuale Inps (Sala della Regina, Palazzo di Montecitorio, ore 11); Roma, Hotel NH: presentazione “Un modello di banca al servizio dell’occupazione e del paese” di Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Dircredito, Ugl Credito e SunFub (Corso d’Italia 1, ore 11); Roma, Ministro Trasporti: incontro tra Alitalia, governo e sindacati (ore 12.30); Benevento, Teatro de Simone: assemblea Confindustria “Le strade per lo sviluppo”, partecipa il presidente Confindustria Giorgio Squinzi (Via Franco 18, ore 15). Mercoledì 9 luglio Internazionale Bruxelles, Unione Europea: riunione informale ministri Interni e Giustizia. Lavoro e sindacato 5 Roma, Tempio di Adriano: convegno Confassociazioni-Anpib “Il futuro possibile: scenari 2014-2015. Finanza, economia, politica, professioni per guardare insieme oltre la crisi”, partecipa il segretario generale Cgil Susanna Camusso (Piazza di Pietra, ore 16); Roma, Palazzo Montecitorio: presentazione Relazione annuale Inail 2013, partecipano il presidente Massimo De Felice, il presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini e il ministro del Lavoro Giuliano Poletti (Sala della Regina, ore 11); Roma, Galleria del Cardinale Palazzo Colonna: convegno “Integrare il welfare, sviluppare la white economy”, partecipano il presidente Unipol Pierluigi Stefanini, i ministri della Salute e del Lavoro Beatrice Lorenzin e Giuliano Poletti (Via della Pilotta 17a, ore 15). Giovedì 10 luglio Economia Roma, Banca d’Italia: pubblicazione Bollettino statistico trimestrale; Roma, Istat: diffusione dati su produzione industriale in maggio (Via Cesare Balbo 16, ore 10); Internazionale Bruxelles, Banca centrale europea: pubblicazione Report mensile. Venerdì 11 luglio Lavoro e sindacato Perugia: sit-in di Cgil Cisl Uil in piazza Italia, davanti alla prefettura, contro il mancato rifinanziamento della cassa integrazione in deroga. Sabato 12 luglio Lavoro e sindacato Montepulciano (Siena), Festival Luci sul lavoro: convegno “Una garanzia per i giovani”, partecipa il ministro del Lavoro Giuliano Poletti (Fortezza, ore 15). Da greenreport.it del 04/07/2014 Rapporto diritti globali 2014: una riconversione ecologica dell’economia deve soppiantare la finanza speculativa Crisi e diritti, le alternative al neoliberismo sono ancora possibili E’ in atto una “lotta di classe dall’alto”, una resa dei conti totale con i sistemi democratici e di welfare Di Umberto Mazzantini Il rapporto sui diritti globali 2014 verrà presentato l’8 luglio a Roma nella sede della Cgil nazionale, ma il sindacato ne fornisce alcune anticipazioni e dice che «Più che di crisi, si rischia ormai di dover parlare di catastrofe globale. Dopo sei anni, infatti, tutti gli indicatori economici e sociali rivelano un quadro drammatico e univoco. In Europa le persone che hanno perduto il lavoro sono cresciute di 10 milioni, portando a 27 milioni il totale di disoccupati. Per il quinto anno consecutivo l’occupazione è in calo nel continente. I nuovi poveri sono cresciuti di 13 milioni di unità. Nell’Europa a 28 Paesi, nel 2012, le persone già povere e quelle a rischio di esclusione erano ben 124 milioni, poco meno di una ogni quattro, con una crescita di 2 milioni e mezzo rispetto all’anno precedente». Il rapporto, curato dal’ Associazione Società Informazione e promosso dalla Cgil con la partecipazione di ActionAid, Antigone, Arci, Cnca, Fondazione Basso-Sezione Internazionale, Forum Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente, esamina anche la situazione del nostro Paese e sottolinea che «Nel suo piccolo, l’Italia contribuisce 6 significativamente a questa mappa della privazione: il numero di quanti vivono in condizioni di povertà assoluta è esattamente raddoppiato tra il 2007 e il 2012, passando da 2 milioni e 400 mila a 4 milioni e 800 mila, l’8% della popolazione. Il tasso di occupazione nel 2013 è tornato ai livelli del 2002: 59,8%; all’inizio della crisi, nel 2008, era al 63%. Peggio stanno solo i greci (con il 53,2%), i croati (53,9%) e gli spagnoli (58,2%). Tra il 2012 e il 2013 sono stati persi 424 mila posti di lavoro. Dall’inizio della crisi hanno perso il lavoro oltre 980 mila persone. Il tasso di disoccupazione tra i giovani dai 15 ai 24 anni è arrivato al 42,4%. Muoiono le piccole imprese: dal 2008 ne sono scomparse 134 mila. E muoiono le persone: per quanto sia difficile stabilire nessi causali univoci e certi, alcuni studi indicano in 149 le persone che si sarebbero tolte la vita per motivazioni economiche nel 2013, quasi il doppio rispetto agli 89 casi dell’anno precedente». A livello mondiale la situazione sembra esplosiva: «Nel 2013 i disoccupati erano 202 milioni. Lievita anche il fenomeno dei lavoratori poveri: sono 200 milioni e sopravvivono in media con meno di due dollari al giorno». Il rapporto sui diritti globali 2014, che si intitola significativamente “Dopo la crisi, la crisi, sottolinea che «Questo stato di catastrofe – umanitaria, non solo economica – non è una realtà inevitabile, bensì il risultato di scelte politiche precise. Nessun serio investimento è stato fatto per promuovere l’occupazione e sostenere il lavoro. La rotta non è stata invertita e nemmeno corretta. Anzi. Le politiche della Banca Centrale, del Fondo Monetario Internazionale e della Commissione Europea, la famigerata Troika hanno portato allo stremo i lavoratori e i ceti medi nel paesi destinatari dei programmi di assistenza finanziaria, Grecia, Portogallo, Irlanda, Spagna, Romania». Per la Cgil e le altre organizzazioni, «Complice la crisi, è in atto l’intensificazione di una “lotta di classe dall’alto”, una resa dei conti totale con i sistemi democratici e di welfare, per come sono stati edificati nella seconda metà del secolo scorso, a partire dal modello sociale europeo. Sono potenti le spinte in direzione della privatizzazione dei servizi di protezione sociale in Europa, un potenziale mercato di 3.800 miliardi di euro l’anno, vale a dire ben il 25% del Pil verso il quale si stanno indirizzando gli incontenibili appetiti dei gruppi finanziari e delle multinazionali. Risulta sempre più evidente il contrasto tra due idee diverse e antagoniste del mondo, la più forte delle quali, fondata sul dogma del libero mercato e sulla religione del profitto, vuole fare una definitiva tabula rasa di tutti i diritti faticosamente acquisiti dalle classi subalterne nel corso della seconda metà del Novecento». Ma se il capitalismo liberista fa il suo mestiere, non altrettanto si può dire di chi dovrebbe contrastarlo, lo stesso rapporto ammette che «La crisi globale ha reso maggiormente manifesta l’incapacità di perseguire alternative. Negli ultimi anni a livello mondiale si è assistito alla bancarotta del liberismo. Eppure i responsabili della crisi – grande finanza, corporations e tecnocrazie – hanno stroncato violentemente ogni ripensamento sui paradigmi della crescita infinita e dell’asservimento totale dei viventi alle logiche del profitto, che sono state architrave di quella dottrina fraudolenta. E ora addirittura rilanciano, con quel Transatlantic Trade and Investment Partnership, il trattato commerciale Usa-Ue che incombe sull’Europa». Sembra davvero che l’arretramento moderato di gran parte della sinistra europea non abbia consentito di portare avanti le proposte alternative che sono da tempo sul tavolo. «Certo, non bastano le piattaforme – dice il rapporto – Per trasformazioni di tale radicalità occorrono la forza politica, il consenso e la cooperazione sociale. Ma, per determinarne le precondizioni, necessita prima di tutto definire una nuova cornice culturale e valoriale. Un’altra Europa e un’altra globalizzazione, insomma, quella dei cittadini, dei diritti e della solidarietà politica e sociale, ha bisogno di essere pensata e di nascere presto dalle macerie di quella delle monete e dei mercati». 7 Il punto che ci pare centrale ed innovativo, visto la coalizione che lo propone, è che «Una riconversione ecologica dell’economia deve soppiantare il castello di carte della finanza speculativa, che da tempo detta le agende ai governi e che vorrebbe ora addirittura forzare e svuotare le Costituzioni antifasciste europee. Un deciso investimento sul lavoro stabile e di qualità e su un nuovo welfare deve spodestare la mortifera politica dell’austerità (solo in Grecia sarebbero 2.200 le morti direttamente riconducibili alle politiche del rigore) che sta strangolando economie e stato sociale e a cui l’Unione Europea e i singoli governi si sono inchinati». Luciano Gallino nel rapporto afferma che «i Parlamenti hanno sbattuto i tacchi e hanno votato alla cieca perché ce lo chiedeva l’Europa. Non esistono alternative, ci è stato detto. Questa espressione è un corollario del colpo di Stato in atto». Ma secondo la Cgil e gli altri, «Le alternative invece sono possibili, oltre che necessarie. Ma non possono che sortire dal basso, dalle forze vive del lavoro, della società, dei popoli. Per contrastare quel “colpo di Stato”, difendendo la democrazia, ricucendo la profonda ferita delle diseguaglianze, ristabilendo equità e giustizia sociale. Globalizzando i diritti». http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/crisi-diritti-alternative-neoliberismopossibili/#sthash.s9bRwfUj.dpuf 8 ESTERI Del 07/07/2014, pag. 1-24 America il sorpasso dell’immigrato d’Oriente FEDERICO RAMPINI NEW YORK MURRIETA , cittadina della California a 90 km da San Diego, è la capitale di un’emergenza- immigrazione: il boom degli immigrati bambini, in costante aumento dai paesi più poveri dell’America centrale. Lincoln, cittadina del Nebraska, è la capitale di una non-emergenza: l’aumento costante, ordinato, per nulla inquietante, della popolazione asiatica. A Lincoln i media locali dedicano un ritratto lusinghiero all’ufficiale Tu Tran della polizia locale. Vietnamita, e punto di riferimento di una comunità etnica tra le meglio integrate nella popolazione del Nebraska. Mentre le ultime ondate di arrivi dal Sud catalizzano l’attenzione e il dibattito politico, il Census Bureau federale che realizza i censimenti demografici rivela una realtà molto diversa: sono gli asiatici la componente più in crescita dell’immigrazione negli Stati Uniti. La loro rivoluzione silenziosa sta cambiando tutto: dalla geografia urbana alle gerarchie socio- economiche. Senza provocare resistenze, o quasi. A Murrieta in California non passa giorno senza una manifestazione di protesta. Da una parte ci sono cittadini indignati che si oppongono all’arrivo dei torpedoni noleggiati dalla Border Patrol. Trasportano minorenni entrati clandestinamente dalla frontiera col Messico. Secondo quei manifestanti, troppi bambini e ragazzi dopo un breve colloquio coi magistrati riescono a rimanere negli Stati Uniti sfruttando leggi permissive sul diritto di asilo. Dall’altra parte dei torpedoni manifestano cittadini altrettanto indignati, contrari alle deportazioni dei ragazzini che non superano l’esame coll’Immigration Office e il giudice. Barack Obama ha dovuto occuparsene anche nel bel mezzo del ponte del 4 luglio, Independence Day. Le leggi sulla regolarizzazione dei clandestini sono prese in ostaggio dal Congresso, nell’estenuante ostruzionismo dei repubblicani maggioritari alla Camera. Ma la realtà dei flussi migratori è ben diversa dalle apparenze. Uno studio appena pubblicato dal Census Bureau ridimensiona lo “tsunami dal Centroamerica”. Per il secondo anno consecutivo, rivela l’istituto, gli arrivi di asiatici sono stati superiori a quelli degli ispanici. In 12 mesi sono entrati negli Stati Uniti 338.000 asiatici, con un aumento del 68% rispetto alla recessione del 2008 2009, quando la drammatica crisi del mercato del lavoro aveva frenato anche gli arrivi dall’estero. Negli stessi 12 mesi gli ispanici in arrivo sono stati un numero inferiore, 244.000, e per di più in forte calo (meno 60%) rispetto al picco massimo degli ingressi che avvenne nel 2005-2006. Se l’autorevole studioso di geostrategia Samuel Huffington pochi anni prima di morire lanciava l’allarme per una “ispanizzazione strisciante” della società americana, ed altri evocavano scenari apocalittici di una “Mexifornia” (il Messico che ingoia la California), il corso della storia sta deviando in un’altra direzione. È l’America dagli occhi a mandorla, il futuro che prevale. Anche perché tra i due flussi migratori c’è una differenza qualitativa cruciale. La spiega il demografo William Frey della Brookings Institution di Washington su Usa Today: «I mestieri che vengono svolti dagli immigrati ispanici sono per lo più le attività manuali meno remunerate, dalla ristorazione all’edilizia. Attività che hanno ricevuto i colpi più duri durante la recessione». Inoltre, checché ne dica la destra che accusa Obama di lassismo, la sorveglianza della Border Patrol (polizia di frontiera) lungo il confine con il Messico è andata intensificandosi. Negli arrivi dall’Asia, sottolinea Frey, è più consistente invece la quota degli immigrati legali, quelli che hanno un visto regolare. E in ogni caso i due flussi 9 migratori si dirigono verso destinazioni diverse. Gli ispanici finiscono in maggioranza nelle fasce sociali più basse. Gli asiatici-americani hanno un reddito medio superiore agli stessi bianchi, spesso fin dalla prima generazione. Un terzo delle imprese tecnologiche della Silicon Valley sono possedute e dirette da imprenditori e top manager di origine asiatica: cinesi, indiani, coreani. Il cambiamento del “panorama” etnico e demografico accelera, per effetto dell’invecchiamento del ceppo bianco di origine europea. Le generazioni dei babyboomer (nati fra il 1945 e il 1965), le più numerose della storia, si avviano gradualmente verso l’età pensionabile. I loro figli sono generazioni “sottili”, tant’è che l’età mediana della popolazione Usa è salita di 2,3 anni nell’ultimo decennio. A compensare questa transizione demografica ci sono gli arrivi degli stranieri. Gli ispanici restano tuttora la prima componente dopo i bianchi cosiddetti “caucasici” (di provenienza storica dall’Europa): 54 milioni nell’ultimo censimento. Gli asiatici per adesso non sono neppure la metà, hanno appena raggiunto la soglia dei 20 milioni. Ma crescono del 2,9% all’anno, e nei trend di lungo periodo sono destinati ad agganciare e superare altre minoranze. Gli ispanici tendono a crescere soprattutto per effetto delle nascite locali (i figli di chi è già immigrato); mentre per gli asiatici la componente più dinamica della crescita viene ancora dall’immigrazione. Viste le qualifiche professionali di cui sono spesso portatori, e il dislivello d’istruzione in loro favore (nelle classifiche Ocse-Pisa i licei di Seul, Shanghai e Singapore stravincono la gara con quelli americani), per gli asiatici è più facile ottenere l’ambito visto H1-B che le aziende hitech procurano agli ingegneri informatici, e poi la Green Card. Il 74% degli adulti asiatici sono nati all’estero, questo conferma che si tratta di una popolazione recente, giovane, dove i flussi di arrivo prevalgono di gran lunga sulle nascite locali. Per lo stesso motivo, i cinesi, vietnamiti, indiani e filippini, in media sono un po’ meno giovani dei messicani, ecuadoregni, salvadoregni, guatemaltechi. L’asiatico medio ha 36 anni contro i 28 del latinoamericano. Questo perché nella prima categoria ci sono tanti che arrivano in cerca di lavoro al termine dei loro studi. In numeri assoluti la California ha la più vasta popolazione ispanica con 15 milioni, seguita dagli asiatici che sono già più di 6 milioni e soprattutto aumentano di circa 150.000 ogni anno. Le Hawaii hanno una maggioranza asiatica. Perfino all’interno delle singole città il mix etnico imprime dei segni paesaggistici e culturali. Little Italy a Manhattan è ormai un’enclave assediata da Chinatown che l’abbraccia e la sommerge; avanza la selva delle insegne al neon con caratteri in mandarino e cantonese. A San Francisco la Chinatown storica continua ad attirare i turisti, ma sta stretta alle ondate dei nuovi immigrati asiatici, che si dirigono verso il vasto quartiere del Sunset o cittadine-satellite come Fremont. Dove meno te l’aspetti accadono metamorfosi come quella del Nebraska, lo Stato che dà il titolo al film di Alexander Payne premiato a Cannes nel 2013: una metafora dell’America profonda, la provincia bianca, tradizionalista e ottusa. Non certo una terra dalle tradizioni cosmopoliti paragonabili a quelle delle metropoli portuali sulle due coste. Eppure il Nebraska sta cambiando fisionomia, a furia di ondate fresche di asiatici. Cominciarono i vietnamiti fin dal 1975 (fuga da Saigon con il ritiro dell’esercito americani; seguita dalla crisi dei boat people; oggi ce ne sono 1,7 milioni su tutto il territorio degli Stati Uniti). Poi nel Nebraska sono arrivati i birmani e perfino gli immigrati del Bhutan. I residenti del Nebraska con origini asiatiche sono aumentati del 70%. E l’ufficiale di polizia Tran ha il suo daffare come interprete e uomo di relazioni pubbliche con la comunità dei 7.000 connazionali. 10 Del 07/07/2014, pag. 14 Pozzi, mitra e contrabbando ecco il petrolio dei jihadisti per finanziare la guerra Fruttano mezzo milione al giorno gli impianti presi dall’Isis Il greggio viene venduto a intermediari. E al nemico Assad MAURIZIO RICCI GIÀ mezzo milione di dollari al giorno, destinati, probabilmente, a raddoppiare nel giro di qualche settimana. Linfa vitale per un esercito di jihadisti, impegnato a realizzare, sulla punta dei fucili, il califfato nel cuore del Medio Oriente. Abbastanza per fare del sogno dell’Isis (lo Stato Islamico dell’Iraq e del Levante) un petrocaliffato. Perché quei soldi vengono — come quasi sempre nel mondo arabo — dal petrolio: il greggio che i jihadisti pompano dai pozzi che hanno occupato, in Siria come in Iraq, nella loro guerra lampo e che, dall’inizio di luglio, hanno iniziato a vendere al di fuori dei mercati locali, a livello internazionale. Il grosso, per ora, viene dal versante siriano. L’Isis controlla ormai l’intera provincia orientale di Deir al-Zour, un deserto che racchiude la quasi totalità delle — limitate — riserve petrolifere della Siria. Nelle mani dei jihadisti è finito il giacimento di Al Omar, il più importante del paese. Vale 30 mila barili al giorno, ma gli insorti non sembrano in grado di assicurare una produzione superiore a 10 mila barili. È, comunque, il primo mattone del petrocaliffato. Invendibili sul mercato legale, i 10 mila barili finiscono sul mercato nero dove spuntano un prezzo pari, mediamente, alla metà di quello ufficiale: 50 dollari a barile invece di 100. E’ il mezzo milione di dollari che già arriva, quotidianamente, nelle casse dell’Isis. Destinato ad aumentare, perché i jihadisti hanno assunto, in questi giorni, anche il controllo di Tanak e degli altri pozzi della regione. In teoria, l’area siriana di Deir al-Zour può produrre oltre 400 mila barili di greggio al giorno, ma l’Isis non sembra avere le risorse di tecnici e macchinari per reggere questi ritmi di produzione e, soprattutto, il mercato nero non è in grado di assorbire volumi così importanti di greggio. Anche se i jihadisti sunniti, a quanto sostengono i servizi segreti, in particolare francesi, un compratore solido, affidabile e affamato di petrolio lo hanno. E’ più che uno dei tanti paradossi del Medio Oriente di oggi: è una vera e propria piroetta all’insegna di uno sfacciato cinismo. A comprare il greggio dei jihadisti sarebbe, infatti, proprio il nemico di Damasco, sostenuto dagli sciiti e contro il quale i sunniti come l’Isis hanno proclamato una sorta di guerra santa. Il petrolio, a quanto pare, non puzza e conviene a tutt’e due. Assad, rintanato nell’ovest — senza giacimenti — del paese, ne ha bisogno per riempire i serbatoi dei suoi carri armati e lanciarli contro i ribelli. I suoi nemici jihadisti ne hanno bisogno per finanziare la loro guerra in Iraq e il progetto del califfato. Sarebbero questi affari, dicono i critici siriani dell’Isis, a spiegare perché, finora, le truppe di Assad abbiano evitato di scontrarsi direttamente con i jihadisti del califfato e perché, a loro volta, l’Isis si tenga in larga misura lontano dalle operazioni contro Damasco. I jihadisti, tuttavia, non guardano solo ad Assad. Da giovedì sera, non in Siria, ma in Iraq, nel giacimento di Ujil, non lontano da Kirkuk e dall’area governata dai curdi, hanno cominciato a riempire camion cisterna, da spedire verso il confine turco, dove li aspettano gli intermediari. Finora, l’Isis aveva tentato di vendere in Turchia benzina e gasolio già raffinata, ma la qualità era scadente e gli intermediari non avevano voluto saperne. Così i jihadisti hanno deciso di vendere direttamente il greggio, anche se il guadagno è minore. In teoria, Ujil è in grado di produrre 20 mila barili al giorno: sul mercato nero, potenzialmente, un altro milione di dollari di incasso quotidiano. Ma spostare questi volumi sui camion non è semplice e venderli clandestinamente — in assenza di un compratore 11 come Assad — anche più complicato. È il segno che il petrocaliffato rischia di essere un progetto di breve durata e poco più che un mezzo di finanziamento estemporaneo. Lo sfruttamento di un giacimento petrolifero è un’operazione tecnicamente e finanziariamente assai complessa. E, anche se riuscisse a procurarsi i tecnici adatti, l’Isis avrebbe, nel giro di qualche mese, bisogno di macchinari, per un verso, mercati, dall’altro che oggi appaiono difficili da ottenere. Soprattutto, avrebbe bisogno, come sanno le compagnie petrolifere, di un flusso continuo di investimenti per assicurare il fluire della produzione. E, qui, il problema non è solo del califfato. In un mondo tuttora assetato di petrolio, infatti, l’Iraq appariva, fino all’offensiva jihadista, la carta vincente per soddisfare la domanda globale. Nel suo ultimo rapporto, diffuso proprio nei giorni in cui l’Isis lanciava la sua offensiva irachena, la Iea (l’agenzia che, per conto dell’Ocse, l’organizzazione che raccoglie i paesi industrializzati, segue il mercato petrolifero) calcolava che il 60 per cento del petrolio in più, necessario, nei prossimi anni, per soddisfare la domanda globale, sarebbe arrivato dall’Iraq, tornato, finalmente, a produrre a pieno ritmo, versando sul mercato mondiale, non più tre milioni di barili al giorno, ma nove milioni di barili. Oggi, è una previsione non più verosimile. I super-giacimenti iracheni e, probabilmente, anche le super-riserve del paese sono al sud, attorno a Bassora, lontano dalle aree controllate dall’Isis e da qualsiasi rivendicazione sunnita. Ma le compagnie petrolifere stanno scappando dall’Iraq. Nessuno, oggi, sembra disposto ad investire un dollaro in giacimenti che potrebbero cadere sotto il controllo dei jihadisti. La carta irachena della Iea è bruciata e il mondo è a caccia di sei milioni di barili che non sa dove trovare. Del 07/07/2014, pag. 15 E i curdi si preparano a difendere Kirkuk “Non cederemo il nostro oro nero” ALBERTO STABILE BAGDAD «NON cederemo neanche un centimetro della nostra terra», dice rivolto a una selva di microfoni Mahmud Shngawi, il comandante dei mitici Peshmerga, i guerriglieri curdi che, abbandonati i covi sulle montagne da dove lanciavano i loro attacchi contro i convogli di Saddam Hussein, si sono trasformati, oggi, nell’esercito regolare del Kurdistan iracheno. L’avvertimento è innanzitutto rivolto ai jihadisti dello Stato Islamico i quali, avendo provato all’inizio della loro travolgente avanzata ad avvicinarsi ai confini della regione autonoma curda, si sono visti costretti ad indietreggiare. Ma, per quanto possa sembrare paradossale, il messaggio risoluto del militare è indirizzato anche al governo centrale guidato da Nuri al Maliki. Le immagini che arrivano dalla regione dei curdi, creata nel 2003 nel Nordest dell’Iraq, dopo la demolizione del regime di Saddam, mostrano i peshmerga, con i loro tipici turbanti attorcigliati intorno alla testa, intenti a innalzare terrapieni, a costruire postazioni e ad stendere chilometri di barriere elettroniche e non attorno ai ricchi campi petroliferi di Kirkuk, la capitale contesa di questa fetta di Kurdistan iracheno, baciata dalla benedizione del petrolio e forse per questo lasciata, per così dire, in sospeso tra le rivendicazioni territoriali dei curdi e le pretese dello stato centrale. Fatto sta, che appena i miliziani del Califfo jihadista, al Bagdadi, hanno cominciato ad avanzare verso Kirkuk, l’esercito iracheno schierato a difesa della città e dei giacimenti s’è letteralmente squagliato, esattamente come, qualche giorno prima, era successo Mosul, la seconda città irachena 140 chilometri a Ovest di Kirkuk. Ma con una manovra 12 evidentemente prevista da tempo, l’armata dei Peshmerga ha preso immediatamente posizione al posto dei militari di Bagdad, bloccando le mire dello Stato Islamico su una regione classificata al quinto posto fra gli esportatori mondiali di greggio e al settimo, sempre su scala mondiale, per quantità di riserve petrolifere. Un tesoro immenso. I peshmerga, dice Harwey Morris, un analista britannico che segue da 40 anni gli infiniti intrecci della politica mediorientale, «sono virtualmente la sola forza capace di affrontare i combattenti dello Stato Islamico». La regione autonoma curda è, di conseguenza, l’unico bastione che può contenere l’avanzata delle formazioni jihadiste. Ma fra le priorità della dirigenza curda non c’è quella di correre in soccorso del premier iracheno al Maliki, considerato “causa del suo male” e ripetutamente avvisato dal leader di curdi iracheni, Massud Barzan, i che le sua gestione settaria e accentratrice del potere avrebbe portato il paese alla rovina. In realtà, Bagdad e Irbil, la capitale “provvisoria” del Kurdistan iracheno (in attesa che venga definito lo status di Kirkuk) sono ai ferri corti da mesi. La travolgente campagna delle forze jihadiste ha impresso un’ulteriore accelerazione alla crisi. Il motivo è semplice. Della grande torta petrolifera amministrata dal governo iracheno, la fetta dei proventi spettante alla Regione curda ammontava al 17 per cento. Fatti i conti, lo stato centrale s’era impegnato a pagare un obolo di 7 miliardi di dollari al mese alle autorità di Irbil. Poca roba, secondo i curdi, rispetto alle entrate garantite dai 750.000 barili di petrolio estratti ogni giorno e venduti sul mercato internazionale. Per giunta, i pagamenti, uno strumento ovviamente adoperato anche per regolare i conti della politica, hanno cominciato a subire ritardi. I dirigenti curdi decidono allora di vedere in proprio, bypassando l’azienda petrolifera nazionale, il greggio necessario a riequilibrare le casse della regione autonoma. Ma al Maliki, con l’appoggio dei protettori americani, che non hanno mai veramente lasciato l’Iraq, si oppone minacciando addirittura di portare la contesa davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Due navi-cisterna piene di petrolio curdo sono ferme da mesi in un porto del Marocco. Così, mentre nei palazzi di Bagdad si diffonde il panico per l’ipotetica conquista jihadista della capitale, il leader curdo, Massud Barzani annuncia di volere organizzare un referendum per l’indipendenza, il passaggio mancante verso l’istituzione di un vero e proprio stato. Al Maliki, in risposta, lo accusa di approfittare delle circostanze. Nel frattempo, mentre i pershmerga costruiscono le loro difese contro i jihadisti, a Kirkuk, tornano in silenzio le famiglie che Saddam Hussein aveva cacciato dalle loro case per “arabizzare” la città. Adesso l’80 per cento della popolazione di Kirkuk è composto da curdi, turkmene e arabe le minoranze. Più capitale di cosi. Del 07/07/2014, pag. 17 Confessa uno dei sei catturati. Avevano già tentato di rapire un bambino Netanyahu: “Lo Stato ebraico condanna i nostri estremisti e quelli palestinesi” Giovani e ultraortodossi arrestati i killer di Mohammed Il premier: no a tutti i terrorismi FABIO SCUTO DAL NOSTRO CORRISPONDENTE GERUSALEMME Sono sotto la custodia dello Shin Bet, il servizio segreto interno, i sei giovani israeliani arrestati per il rapimento e l’assassinio di Mohammed Abu Khdeir, il 13 ragazzino palestinese rapito all’alba di mercoledì scorso e ritrovato poco dopo arso vivo in un parco della parte ovest della Città Santa. Dopo giorni — in cui i quartieri arabi sono teatro di una guerriglia di giorno e di notte — gli investigatori hanno finalmente imboccato la strada dell’estremismo nazionalista inquadrando l’assassinio del giovane nella possibile vendetta per l’uccisione dei tre seminaristi ebrei a Hebron. Polizia e sicurezza interna hanno effettuato all’alba di ieri una trentina di fermi, ma l’attenzione era dedicata a questi sei. Un “gag order” (la censura) impedisce di pubblicare i loro nomi, ma qualcosa è trapelato. Sono tutti giovani, alcuni sono minorenni, vengono da Beit Shemesh, da Gerusalemme e da Adam, un piccolo insediamento alle porte della Città Santa. Stando alle tv israeliane uno di loro, descritto dalla polizia come un estremista, durante l’interrogatorio avrebbe ceduto e confessato il rapimento e il delitto, implicando gli altri cinque. I sei non farebbero parte di un gruppo estremista formale, come era stato ipotizzato in precedenza, sarebbero piuttosto giovani radicali che hanno deciso di farsi vendetta da soli per rappresaglia per la tragica morte di Eyal, Naftali e Gilad, i tre ragazzi rapiti alle porte di Hebron lo scorso 12 giugno. Sono ancora senza nome, ma due dei loro volti sono stati “catturati” dalle telecamere di sorveglianza che ci sono lungo la Shuafat Road: si vedono pochi attimi prima che costringano il ragazzino arabo a salire in macchina. Le telecamere erano state subito consegnate alla polizia dal padre della vittima che adesso reagisce: «Ho dato il filmato cinque giorni fa, solo adesso hanno capito che erano estremisti ebrei?». La polizia adesso dà anche seguito a un’altra denuncia. Nello stesso quartiere palestinese il giorno precedente il rapimento di Mohammed, non appena era stata diffusa la notizia del ritrovamento dei corpi dei tre seminaristi ebrei, qualcuno aveva cercato di rapire per strada un ragazzino di nove anni, Mousa Zalun, e solo le grida della madre e l’intervento di alcuni passanti avevano fatto fallire l’azione. Anche di quel tentativo ci sono filmati delle telecamere di sorveglianza ed è grazie a essi che si sarebbe arrivati al “commando” che ha rapito Mohammed, perché l’auto usata era la stessa. La fidanzata di uno dei sospetti ha detto ieri sera al sito web di notizie Walla che il suo ragazzo è uno studente universitario e lavora nell’impresa di suo padre. «Si tratta di una famiglia di ultraortodossi, ma lui è un ortodosso moderno». Non l’ha mai sentito parlare di vendetta: «Io non credo che abbia fatto qualcosa di simile. Non avrebbe rischiato la sua vita per qualcosa così, lo conosco». Il vicino di un altro degli arrestati ha raccontato in tv che i parenti sono sconvolti e egli stesso non riusciva a credere che il ragazzo fosse coinvolto nell’omicidio. Ieri sera il premier Benjamin Netanyahu, nel tentativo di far calare la tensione, ha detto che «Israele non fa differenza tra il terrorismo palestinese e il terrorismo ebraico», facendo capire che i colpevoli saranno trattati con la stessa severità. Questo nella speranza che la situazione interna migliori, che la protesta nei quartieri arabi della Città Santa — e anche in altre città come Nazaret e Haifa — vada man mano scemando. Le stesse prerogative sono difficilmente applicabili nel Sud di Israele, dove da Gaza continuano a piovere missili (180 negli ultimi sette giorni) e i caccia israeliani — ma ieri sera anche l’artiglieria — tornano a colpire le basi mobili dei lanciatori. Hamas si dice d’accordo (con Israele) per una tregua, ma sono i gruppi minori — la Jihad Islamica e i Comitati popolari — a essere contrari a un intesa. del 07/07/14, pag. 13 In Kenya nuovi massacri sulla costa dei turisti 14 Bruciate diverse case e una chiesa. Un messaggio su una lavagna: «Non rubate la terra ai musulmani» Michele Farina Due attacchi, almeno 29 morti e un messaggio sulla lavagna della scuola: «Invadete un Paese islamico e pretendete di vivere in pace?». Il terrore torna nell’ex paradiso turistico di Lamu, la città più antica del Kenya, gioiello della cultura swahili tra i siti protetti dell’Unescu, in quell’area costiera a maggioranza musulmana dove il mese scorso erano stati massacrati 60 cristiani. I responsabili? Da Mogadiscio Al Shebab, la milizia islamica somala affiliata ad Al Qaeda, ha rivendicato gli assalti di sabato sera a Gamba e Hindi. Il governo di Nairobi invece punta il dito sui separatisti del Consiglio Repubblicano di Mombasa (Mrc). «Al Shebab non c’entra», ha dichiarato il presidente Uhuru Kenyatta, secondo il quale i colpevoli si nascondono nelle «reti politiche locali» e di opposizione che hanno preso di mira membri dell’etnia cristiana kikuyu. «Ci usano come capro espiatorio», ha dichiarato alla Reuters da Mombasa (300 km più a sud) Randu Nzai Ruwa, segretario dell’Mrc. La dinamica dei raid è più chiara dell’identità dei mandanti: a Hindi è morto anche un ragazzino che tentava la fuga mentre decine di assalitori a Gamba hanno bruciato diverse case (e una chiesa), uccidendo gli uomini (con coltelli e armi da fuoco) e risparmiando le donne. Hanno anche assediato una stazione della polizia liberando una persona sospettata per gli attacchi del mese scorso a Mpeketoni. Elizabeth Opindo ha raccontato di aver visto una decina di persone bruciare le case come la sua: «Parlavano inglese, swahili e somalo. Mi hanno detto che combattono perché la terra viene rubata ai musulmani». Quale terra? Per Al Shebab il Kenya è «zona di guerra», a causa della sua partecipazione alla missione militare dell’Unione Africana che ha ridimensionato il potere del gruppo in Somalia allargando il suo raggio d’azione. I sopravvissuti al massacro di Mpeketoni hanno raccontato che gli assassini parlavano somalo, portavano i vessilli di Al Shebab e hanno ucciso cristiani. Cento anni fa, con l’abolizione della schiavitù, l’area che fa capo all’isola di Lamu sulle magnifiche coste dell’oceano Indiano conobbe un declino che il turismo negli ultimi anni ha in parte ribaltato. Quel paradiso architettonico e naturale a misura di uomo e di asino (sull’isola niente autoveicoli)ora è diventato il centro di una zona di estremo pericolo (non solo) per gli stranieri. Minaccia esterna o locale? Forse glocal : è probabile che il verbo dei «giovani» somali di Al Shebab abbia attecchito tra i «giovani» keniani della costa. Terrore in franchising . 15 INTERNI del 07/07/14, pag. 2 Il percorso a ostacoli delle riforme Servono altri 812 provvedimenti Mancano i regolamenti attuativi dei programmi degli ultimi governi Di Antonella Baccaro ROMA - Non basta fare le riforme. Bisogna averle attuate. Sale l’asticella che l’Italia è chiamata a saltare per dimostrarsi affidabile in Europa e guadagnare maggiore flessibilità. Ma i conti non tornano. Al 18 giugno, mettendo insieme i cantieri normativi dei tre ultimi governi dal novembre 2011, Monti, Letta e Renzi, secondo l’Ufficio per il programma di governo, mancavano 812 provvedimenti attuativi, senza dei quali le riforme che dovrebbero dinamizzare il Paese restano sulla carta. Di questi provvedimenti, 133, il 16%, sono già dell’esecutivo Renzi (334 sono di Monti su 846 prodotti e 345 di Letta su 457 emanati), che è in carica da quattro mesi e mezzo e ha prodotto 33 norme pubblicate in Gazzetta ufficiale, solo nove delle quali non rinviano ad atti di secondo livello. Segno inequivocabile di un affanno che non riguarda solo il Parlamento, dove le Camere sono impegnate ormai quasi solo a convertire decreti e attuare deleghe, ma anche gli uffici tecnici dei ministeri, dove spesso queste riforme s’impaludano affossate, in alcuni casi, da veti incrociati. I decreti attuativi Non per niente il governo Renzi ritiene che la «riforma delle riforme» sia quella istituzionale che semplificherà il meccanismo di produzione normativa, dimezzando Camere e tempi. Il secondo tassello, che avrebbe dovuto produrre il «miracolo» di saltare a piè pari il meccanismo dei provvedimenti attuativi, è invece finito su un binario morto. La norma, contenuta nel decreto di riforma della P.a., che imponeva tempi stretti ai tecnici dei ministeri, pena l’intervento diretto di Palazzo Chigi in sostituzione degli uffici inadempienti, non ha visto mai la luce. Che fare? Renzi in Europa si gioca la partita più importante e ha fretta. Dalla sua, per convincere i burocrati del suo piglio innovatore, ha un pacchetto di ben nove riforme da spendere, solo due delle quali però hanno già ottenuto il via libera parlamentare. Si tratta del decreto che ha tagliato il cuneo fiscale, mettendo nella busta paga di 10 milioni di italiani 80 euro al mese, e della riforma del lavoro, almeno la prima parte, quella che ha trovato posto nel decreto Poletti. Soprattutto quest’ultima riveste un’importanza particolare nella strategia immaginata dal governo in vista del negoziato sul patto di Stabilità. La norma prevede il rilancio dell’occupazione, attraverso la semplificazione del ricorso all’apprendistato e ai contratti a tempo determinato. L’obiettivo è favorire i giovani e agevolarne l’inserimento nel mondo del lavoro. Il decreto, convertito in legge il 16 maggio scorso, è in attesa di due decreti attuativi. Mentre il decreto Irpef, quello del bonus, in vigore dal 24 giugno, di provvedimenti ne attendeva, al 18 giugno scorso, ben 31. Dal lavoro al Fisco Ma il percorso di riforma del mercato del lavoro prevede anche un disegno di legge delega, ora giunto all’esame del Senato, con interventi di revisione degli ammortizzatori sociali, di riordino dei rapporti di lavoro, di sostegno alla maternità ed alla conciliazione. I senatori si sono impegnati a chiudere le votazioni entro fine luglio, ma certezze in merito non ce ne sono. In Parlamento sono arrivati da poco altri due provvedimenti varati a passo 16 di marcia dal governo Renzi: si tratta del decreto di riforma della P.a. e del decreto Competitività. Entrambi, dopo un impegnativo ping pong tra Palazzo Chigi e il Quirinale, sono approdati in Aula per avviare l’iter di conversione in legge. La Camera ora sta esaminando il decreto sulla P.a. e ha tempo fino al 23 agosto per votarne la conversione. Il provvedimento, assegnato alla commissione Affari costituzionali di Montecitorio, contiene gli interventi in favore della cosiddetta «staffetta generazionale». Nel dettaglio, si tratta di misure come l’abolizione della possibilità di restare al lavoro oltre l’età di pensione, la maggiore mobilità per i dipendenti pubblici, il dimezzamento del monte ore dei distacchi e permessi sindacali. Nel pacchetto sono finite anche le norme anticorruzione che rafforzano i poteri del commissario Raffaele Cantone. È ancora atteso in Parlamento invece il disegno di legge delega sulla riforma della P.a. che completa il pacchetto. Corsa contro il tempo Al Senato la commissione Industria e Ambiente è, invece, impegnata sul decreto Competitività, una serie di misure a favore delle imprese, da convertire anch’esse in legge entro il 23 agosto. Dentro si trovano novità come la possibilità da parte delle compagnie assicurative di concedere credito alle imprese. Il decreto prevede inoltre il potenziamento dell’Ace, il cosiddetto Aiuto alla crescita economica, che garantisce benefici fiscali a fronte di aumenti di capitale. Sul versante energia sono infine previsti interventi per ridurre il costo della bolletta elettrica delle Pmi di circa 1,5 miliardi di euro all’anno. Al governo non sfugge che la conversione di due decreti così articolati richiederà esami a tempi di record per arrivare al voto entro fine luglio. Intanto procede il cammino della legge delega sul Fisco. Al momento il governo ha prodotto un unico decreto attuativo, quello che introduce la dichiarazione dei redditi precompilata, insieme con altre semplificazioni e la revisione delle commissioni censuarie in vista della riforma del catasto. Il testo è arrivato in Parlamento nei giorni scorsi: le commissioni avranno tempo fino al 1° agosto per esprimersi. Ma già il governo ha in mente di produrre ulteriori decreti per snellire il regime fiscale delle piccole e medie imprese: tra le novità, l’introduzione dell’Iri, la nuova Imposta sul reddito imprenditoriale. Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, ha dichiarato al Corriere , che l’intero pacchetto dei decreti sarà completato «dopo l’estate». I nodi politici Sul fronte della giustizia per il momento il Consiglio dei ministri del 30 giugno ha esaminato un elenco di dodici punti: i dettagli arriveranno a settembre, anche alla luce dell’esito della consultazione popolare dei cittadini. Tra gli obiettivi, la riduzione ad un anno i tempi di giudizio in primo grado e l’introduzione della responsabilità civile dei magistrati. Anche il decreto «sblocca Italia», col quale Renzi vuole snellire e semplificare gli iter procedurali di cantieri, opere pubbliche e concessioni, è allo stato di annuncio e non verrà approvato in Consiglio dei ministri prima della fine di luglio. E la «riforma delle riforme»? A Palazzo Madama, ormai dal 6 maggio, procede l’estenuante braccio di ferro tra maggioranza e opposizione sulla bozza di riforma del Senato presentata l’8 aprile dal ministro Maria Elena Boschi, che potrebbe arrivare in Aula prima della chiusura estiva. A marzo la Camera ha approvato l’Italicum, la nuova legge elettorale frutto di un accordo politico tra Renzi e Berlusconi. Sul testo il dibattito politico è in pieno corso. Del 07/07/2014, pag. 10 Senato, le fronde Pd e Fi mettono a rischio il sì in aula Renzi: non cedo su nulla 17 I “ribelli” insistono sull’elettività. Il premier smentisce trattative. Consulto con Alfano: stringiamo i bulloni FRANCESCO BEI ROMA Se stasera Matteo Renzi andrà all’assemblea dei senatori del Pd — il che visto il clima non è neppure detto — non offrirà alcuna sponda ai “ribelli” contrari al disegno di legge Boschi- Delrio. La linea è questa, ormai è tracciata: «O di qua o di là». Dopo che in giornata si erano diffuse alcune voci su una possibile apertura del premier sulla questione dell’elettività dei nuovi senatori-consiglieri, è stato Renzi stesso, conversando con i suoi ieri sera, a lasciar filtrare l’assoluta indisponibilità a rimettere in discussione il punto più contestato della riforma costituzionale. «Sarò durissimo sul no all’elettività », promette infatti il segretario. Il quale intravede, dietro la bandiera di un Senato ancora eletto direttamente e non formato dai consiglieri regionali, «l’estremo tentativo di ripartire da capo forzando la situazione ». Il perché è presto detto. «Se i senatori sono scelti dal popolo allo stesso modo dei deputati — osserva Renzi — come impedire loro di votare anche la fiducia al governo e di esaminare il bilancio?». Con la stessa fonte di legittimazione popolare si avrebbero di nuovo due Camere sullo stesso piano. E la fine del bicameralismo perfetto (identiche funzioni tra i due rami del parlamento) andrebbe a farsi benedire. Quanto alle polemiche sulla mancanza di legittimazione dei futuri componenti di palazzo Madama, il premier nelle sue conversazioni private si lascia sfuggire una battuta velenosa: «Chi è più rappresentativo? Corradino Mineo, Augusto Minzolini oppure un consigliere regionale eletto da decine di migliaia di cittadini?». La citazione dei due senatori non è casuale. Entrambi infatti figurano tra i più fieri oppositori del suo progetto e stanno organizzando un fronte trasversale Pd-Forza Italia per ostacolarlo in tutti i modi. Si parla ovviamente del passaggio in aula, giacché in commissione ormai i «sabotatori » Mineo e Mauro sono stati fatti fuori. Per questo, in vista dell’assemblea di stasera, un renziano come il senatore Giorgio Tonini spara preventivamente contro chi dovesse appellarsi alla libertà di coscienza. «Lo statuto del Pd — sostiene Tonini — dice che la questione di coscienza può essere sollevata alla presidenza del gruppo su questioni etiche e principi fondamentali della Costituzione ma la modalità di elezione del Senato non è una questione di coscienza». Ergo varrebbe la disciplina di gruppo, comprese le sanzioni per chi non si allinea. Ma le minacce al momento non sortiscono effetto. Sarebbero una ventina i senatori dem pronti alla rivolta, che vanno a sommarsi alla trentina di forzisti ribelli e all’altra decina tra Ncd e ex Scelta civica. Numeri importanti dunque, che potrebbero rendere molto complicato il passaggio in aula. Anche per questo ieri Renzi ha stretto i bulloni della maggioranza, chiedendo ad Alfano quanto fosse seria l’intenzione di Ncd di opporsi al Senato non elettivo. Ricevendone in cambio assicurazioni. Certo, anche Berlusconi ha richiamato i suoi all’ordine. Ma come dice un vecchio navigatore del palazzo come il leghista Roberto Calderoli, relatore della legge, «ormai quelli se ne fregano ». Anzi la fronda dentro Forza Italia si sta allargando. Esasperati per il mancato rispetto della promessa fatta da Berlusconi giovedì scorso («le questioni che ponete sono serie, ci rivedremo martedì per decidere»), i ribelli sono pronti a muovere in blocco contro la linea ufficiale del partito. Raffaele Fitto resta in silenzio, per non dare alibi a chi vorrebbe usarlo come capro espiatorio per schiacciare la rivolta, ma i senatori pugliesi e campani ormai si muovono come una falange. È in corso una raccolta di firme su una richiesta di riunire il gruppo prima che la riforma Boschi vada in aula. Una ventina di senatori sono pronti a dare battaglia. Filtrano i nomi di Milo e D’Anna, Bonfrisco e Tarquinio, Malan e Zuffada. Oltre ovviamente a Minzolini. La Vandea è solo all’inizio, ha bisogno di tempo per organizzarsi e raccordarsi con l’offensiva parallela in corso nel Pd. Ed è proprio il tempo il fattore che gioca contro Renzi. La discussione in commissione 18 infatti procede a rilento. Dopo l’incontro a palazzo Chigi tra Renzi e Berlusconi, che ha ridefinito nei dettagli il patto del Nazareno, si tratta ora di tradurre in norme l’intesa politica. Per il momento l’esame degli articoli 56 e seguenti del disegno di legge è stato sospeso. E dopo che il governo avrà battuto un colpo i relatori Finocchiaro e Calderoli dovranno riformulare i propri emendamenti. Ci vorrà tempo. «Di sicuro mercoledì — ammette Calderoli — non ce la facciamo ad andare in aula». L’obiettivo di Renzi arrivare almeno a un via libera in commissione entro il Consiglio europeo del 16 luglio rischia di saltare. Del 07/07/2014, pag. 10 “Impegni scritti”. I Dem gelano il M5S TOMMASO CIRIACO ROMA Pattinando su una lastra di ghiaccio sottilissima, i grillini inseguono un incontro con il Pd che si tinge di giallo. Dopo il tonfo elettorale hanno un disperato bisogno di tornare centrali, che è poi la ragione per cui Matteo Renzi li lascia sulla graticola facendo sapere che è necessario formalizzare la risposta ai dieci punti per non rendere vano un nuovo summit sulle riforme. E così, dopo un vorticoso giro di telefonate serali, Luigi Di Maio impartisce ai suoi l’unico ordine possibile: calma e sangue freddo, nessuno reagisca in modo scomposto. Tocca al vicepresidente della Camera e alla Casaleggio associati studiare la prossima mossa e l’ipotesi — su cui si ragiona fino a tardi — è quella di inoltrare già oggi una risposta scritta sui dieci quesiti avanzati dal premier. Accompagnata però da una postilla che suona più o meno così: «Perché quando si tratta di discutere con Berlusconi il Pd non esige risposte scritte?». Dopo una domenica di ping pong mediatico, Maurizio Buccarella non si rassegna al rischio di un rinvio: «Non capisco la forzatura, né questa storia del compitino scritto che ci chiedono. Non vedevo proprio la necessità di una risposta scritta. A me sembra tattica...». La tattica, in effetti, domina questa fase. E nel Movimento è affidata a Di Maio. È lui che ha in mano il Movimento ed è sempre lui, assieme allo staff — a Rocco Casalino, Ilaria Loquenzi e Silvia Virgulti — a gestire la trattativa sull’Italicum, tanto che dalle colonne del Corriere della Sera sposa otto dei dieci punti renziani. Il giovane deputato campano sa che i cinquestelle — e il cerchio magico che regge il Movimento — puntano tutto sulla possibilità che la maggioranza si incagli sulle riforme. E infatti, nonostante la nuova frenata dem, i grillini continuano a ripetere come un mantra che l’incontro si terrà oggi alle 15. «La nostra disponibilità rimane — si limita a dire Buccarella — vogliamo sederci attorno a un tavolo per discutere anche dei dieci punti». L’obiettivo primario, comunque, resta quello di attentare al patto del Nazareno, costi quel che costi. Per raggiungere lo scopo, i pentastellati si muovono anche su un binario parallelo, riservatissimo. Pochi giorni fa, per dire, alcuni emissari cinquestelle hanno proposto alla sinistra Pd un patto per sostenere il Senato elettivo. Non se ne è fatto nulla, ma a Palazzo Madama i quaranta voti del Movimento pesano tantissimo e potrebbero risultare decisivi se davvero qualcuno presenterà in Aula un emendamento “spacca-maggioranza”. In attesa di capire come si chiuderà nel Pd il braccio di ferro sulle riforme, la Casaleggio associati cerca strade alternative al “Democratellum” per rispondere alla richiesta di governabilità avanzata dai democratici. Oltre all’ipotesi del Mattarellum, il guru ha sollecitato anche bozze di correttivi sul doppio turno e sul premio di maggioranza. Tutto, pur di restare centrali. Sul territorio, intanto, si moltiplicano le faide. Ieri, ad esempio, i parlamentari calabresi del Movimento si sono scontrati per nove ore in diretta streaming. Da una parte Nicola Morra e altri tre deputati, dall’altra Sebastiano Barbanti e il senatore Francesco Molinari. Alla vigilia 19 correva anche voce di una sfiducia per i due “dialoganti”, ma nonostante uno scambio d’accuse durissimo la resa dei conti è stata di fatto rimandata. Da il Messaggero del 07/07/14, pag. 2 Servizio civile ecco la riforma il governo cerca 100mila giovani Claudio Marincola Un esercito di giovani senza divisa: i primi 37 mila verranno «reclutati» a partire dal prossimo ottobre utilizzando risorse avanzate dal Fondo nazionale del servizio civile. Un tesoretto fino a qualche tempo fa gestito dal ministero della Difesa, in cui affluiscono le donazioni pubbliche e private. I fondi sono già disponibili: circa 125 milioni di euro, cui se ne aggiungeranno altri 55 provenienti dai progetti regionali del piano Garanzia-giovani. L’obiettivo è ambizioso: coinvolgere nel giro di un triennio 100 mila giovani cambiando pelle al nostro servizio civile attraverso progetti di solidarietà, inclusione, legalità a tutela del patrimonio culturale e geologico. Il quadro di riferimento è la legge del 6 marzo 2001 n° 64 che istituì su base volontaria il servizio civile. Derivazione della vecchia, abrogata, legge 772 che introdusse l’obiezione di coscienza per chi si rifiutava di imbracciare un fucile. PORTE APERTE «Una cosa che vogliamo fare è aprirlo agli stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro Paese», annuncia Luigi Bobba, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle politiche sociali con delega alle politiche giovanili e al servizio civile. Vuol dire: sì agli immigrati, porte aperte, oltre ai cittadini Ue, anche ai profughi richiedenti asilo. Una quota di giovani verrà destinata a progetti no profit fuori dal confine nazionale. Per tutti gli altri sarà un’opportunità di servire il Paese attraverso «forme di difesa non armata». Non servono titoli di studio, solo un’età compresa tra 18 e il 28 anni di età. Aggiunge il sottosegretario Bobba: «Stiamo studiando, in collaborazione con i ministeri dell’Ambiente e della Cultura la possibilità di legare il servizio sociale dei giovani volontari a progetti di recupero già finanziati». LA SPINTA DI RENZI Attualmente i volontari sono circa 15 mila, un migliaio sono gli enti accreditati (che selezioneranno i giovani). Le consultazioni sono andate avanti per oltre 3 mesi. Le aree di intervento sono state ridefinite: protezione civile, assistenza, ambiente, patrimonio artistico e culturale, servizio civile all’estero. I volontari riceveranno 433 euro al mese per una durata minima di 8 mesi prorogabili a 12. Ognuno costerà alle casse dello Stato circa 6.000 euro l’anno (si pensa all’esenzione dall’Irap). L’obbligo è limitato alle 30 ore di lavoro settimanali. Il rimborso non sarà compatibile con altri redditi. LA RIFORMA Il 16 giugno scorso è stato emanato un unico bando ma i provvedimenti di selezione sono differenziati a seconda che si riferiscano a progetti nazionali o regionali. Già in settimana in Consiglio dei ministri potrebbe presentare la legge delega che dà attuazione alla trasformazione del servizio civile nazionale. Una eccellenza italiana, non abbiamo niente da imparare, anzi molto da esportare. Un vecchio pallino di Matteo Renzi, che il 13 maggio scorso per la prima volta parlò del «servizio civile universale» collegandolo alla riforma del Terzo settore. Non a caso nel suo primo intervento di presentazione del semestre europeo a Strasburgo, Renzi ha battuto proprio sul tasto del volontariato, «non ci sarà un’istituzione degna di questo nome senza l’istituzione del servizio civile europeo». Il piano sta molto a cuore al rottamatore fiorentino. È stato portato avanti in questi mesi dalla deputata 20 piemontese Pd Francesca Bonomo, che ha la delega al servizio civile e alle politiche giovanili. Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di una variante del reddito di cittadinanza. Un contentino ai giovani. «Non è un lavoro – chiarisce la Bonomo – e non vogliamo sia un lavoro sottopagato tantomeno però è un volontariato puro. Ma pensiamo che debba essere un’esperienza anche orientata ad avviare un percorso professionale. Pensiamo a un attestato finale, un riconoscimento in termini di crediti formativi. E stiamo lavorando per renderlo valido anche ai fini contributivi Inps». É dimostrato che il volontariato per i giovani in cerca di occupazione può trasformarsi in un volano. Lo spera anche il governo. Da il Messaggero del 07/07/14, pag. 3 Gli Alpini rilanciano la naia: Renzi e Pinotti hanno detto sì L’ipotesi: addestramento militare e corsi anti-incendio e di studio della montagna. La proposta si inserisce nell’ambito della riorganizzazione del terzo settore di Carlo Mercuri A nove anni di distanza dalla sospensione del servizio militare obbligatorio e cinque anni dopo l’introduzione della mini-naja del ministro La Russa (con relativo strascico di polemiche) si torna a parlare di leva. Questa volta lo fanno gli alpini, sfruttando l’onda lunga del servizio civile universale proposto dal premier Renzi. MILITARE O CIVILE Ma che c’entra la proposta renziana di servizio civile con la leva degli alpini? In realtà il discrimine tra le due forme di servizio alla Patria è più sottile di quanto non sembri. Il sistema solidaristico gestito dall’Ana (Associazione nazionale alpini) è una delle più potenti macchine organizzative di protezione civile del nostro Paese. Il presidente Sebastiano Favero snocciola qualche dato: «Abbiamo mobilitato ottomila uomini per il terremoto d’Abruzzo. In accordo con il sindaco di Fossa abbiamo ricostruito 33 case e rifatto la chiesa. In cambio abbiamo chiesto solo vitto e alloggio. Nel corso del 2013 i gruppi alpini dell’Ana hanno fatto interventi a seguito di calamità stimabili in circa 70 milioni di euro tra ore di lavoro e varie operazioni». Favero è inarrestabile: «Il primo ospedale da campo è nato 25 anni fa con l’Ana. Ora è a Bergamo. Ma l’ultimo intervento è stato in Giordania, per supporto ai rifugiati che venivano dalla Siria». Come chiamare tutto ciò se non protezione civile? IL PROGRAMMA Eppure gli alpini sono un Corpo militare e vanno fieri della loro militarità. L’idea fissa di Favero di tornare a un servizio di leva (per avere una base di ragazzi su cui contare in caso di necessità) si è materializzata nel corso dell’ultimo raduno delle penne nere a Pordenone, nel maggio scorso. Favero ne ha parlato al premier Renzi e al ministro Pinotti. E in luogo di ricevere solo benevoli sorrisi di circostanza il presidente dell’Ana ha incassato inviti a formulare proposte concrete. «Ed io le ho formulate le proposte, eccome se le ho formulate - ribadisce Favero - il presidente Renzi mi ha risposto con una lettera dicendosi entusiasta, spiegando che condivideva il nostro programma ed esortandomi ad andare avanti». I COMPITI Ma che prevede il programma della leva alpina? «Prevede un minimo di inquadramento militare - risponde Favero - poca roba, nel nostro caso non dobbiamo formare combattenti. 21 Giusto per inculcare il senso della disciplina. L’ipotesi è di fare un primo periodo di addestramento di cultura alpina per circa un mese e mezzo e successivamente passare alla formazione vera e propria, con corsi di antincendio boschivo e di conoscenza della montagna sia d’inverno che d’estate. Il tutto potrebbe durare 6-8 mesi complessivamente e riguardare 5.000 giovani all’anno. Ci sono tante caserme dismesse che potrebbero essere utilizzate come punti-base». La proposta di Favero potrebbe concorrere a informare le linee-guida della prossima legge di riforma del Terzo Settore e quindi ad ottenere dei finanziamenti. Il presidente dell’Ana però si schermisce: «Nel Dna degli alpini non c’è il volontariato a pagamento. Il servizio che i nostri ragazzi offrirebbero sarebbe un servizio reso a tutto il Paese. Ci sarebbe bisogno solo di un rimborso spese e del vitto e dell’alloggio. Oltre naturalmente a veder riconosciuti i giusti crediti sul mercato del lavoro a questi ragazzi». I FINANZIAMENTI L’Ana (360.000 iscritti e 81 sezioni in tutta Italia) si autosostenta ma beneficia anche di notevoli elargizioni da parte di «alcune realtà industriali e finanziarie che credono in noi», come dice Favero. D’altronde l’ingaggio di Enti "profit" non farebbe a pugni con lo spirito del nuovo Servizio civile universale voluto da Renzi. E’ stato chiamato "universale" proprio perché misto, dal momento che prevede una compartecipazione al finanziamento dei progetti sia da parte pubblica che da parte privata. E siccome la finalità dichiarata è di far concorrere i giovani alla Difesa della Patria attraverso modalità non armate (articolo 52 della Costituzione), ecco che anche gli alpini intendono mettersi pazientemente in fila. Del 07/07/2014, pag. 1-23 Quando i Partiti si ribellano ai Capi ILVO DIAMANTI È SIGNIFICATIVO il moltiplicarsi, in questa fase, di conflitti — accesi — dentro a quel che resta dei partiti. Dentro al Pd e (perfino) a Forza Italia, in particolare. Dovunque, la fonte dei contrasti è la stessa. I leader contro (oltre) i partiti. E viceversa. I partiti, d’altronde, nel corso degli ultimi vent’anni sono cambiati profondamente. Si sono “personalizzati”. Fino a trasformarsi in “partiti personali” (come li ha definiti Mauro Calise), più che personalizzati. Differenti versioni del “partito del Capo” (per echeggiare un recente saggio di Fabio Bordignon, pubblicato da Maggioli). Dove il Capo non emerge dalla selezione e dalla mobilità interna al partito. Ma ne è l’origine e il fine. Fino alla fine. Tanto che, negli ultimi anni, abbiamo assistito all’ascesa e al declino — rapido — di formazioni, nuove ma anche vecchie. In seguito al destino del Capo. L’Idv, scomparsa insieme a Di Pietro. Scelta Civica, insieme a Monti. L’Udc insieme a Casini. Fli insieme a Fini. Mentre Rivoluzione Civile si è dissolta con Ingroia. E Sel è in bilico. Accanto a Vendola. Solo la Lega resiste, anche dopo Bossi, molto ridimensionata. Ma si tratta di un “derivato” dei partiti di massa. I casi del Pd e di Fi, attraversati da divisioni e polemiche interne, sono, però, esemplari. Perché raffigurano due versioni simmetriche e opposte del Partito del Capo. Fi è un partito aziendale, “costruito” intorno a Fininvest e, soprattutto, a Publitalia — la società di marketing e pubblicità. Impensabile distinguere il Partito dal suo Capo. Proprietario e imprenditore. Ma anche marchio originale e originario. Così, la decadenza politica del Capo, seguita alla fine dell’ultimo governo Berlusconi, nel novembre 2011, ha segnato il fallimento della “costituzione di un grande partito liberal- conservatore” (come chiosa Piero Ignazi, nel recente saggio sulla parabola del berlusconismo Vent’anni dopo , edito dal 22 Mulino). Ma ha prodotto, al tempo stesso, il rapido declino elettorale, avvenuto alle elezioni politiche del 2013 e proseguito alle recenti europee. Così, sorprende la reazione di alcuni gruppi ed esponenti di Forza Italia. Indisponibili ad accettare i patti negoziati dal loro Capo con Renzi, in tema di riforme istituzionali ed elettorali. Sorprende: perché Fi “dipende” da Berlusconi. Eppure, al tempo stesso, è automatico che gli eletti e i dirigenti — a livello locale e in Parlamento — si ribellino alla prospettiva di venire assimilati dentro al Pdr: il Partito di Renzi. D’altronde, anche se “incorporata” nel Capo, Fi, nel corso del tempo, ha assunto una propria struttura stabile e autonoma, presente e diffusa nelle istituzioni e negli organismi pubblici. Da cui dipende il presente e il futuro professionale, oltre che politico, di moltissime persone. Difficile chiedere loro di suicidarsi senza, almeno, tentare di resistere. Anche il Pd, peraltro, è “in rivolta” contro il Capo. Come titolava Repubblica sabato scorso. Ma si tratta di una storia molto diversa. Perfino opposta. Perché il Pd è l’erede dei partiti di massa della Prima Repubblica, Pci e Dc. Emerso dall’esperienza dei soggetti politici post-comunisti e post- democristiani. Alleati nell’Ulivo e riuniti, infine, nel Partito Democratico. Un soggetto politico, per questo, dotato di radici ideologiche e organizzative profonde. Impiantate sul territorio e nella società. Anche per questo, estraneo a modelli leaderistici. Attraversato, semmai, per tradizione, da correnti e gruppi, a livello nazionale e locale. Così, nella Seconda Repubblica, se il Centrodestra si è identificato in un solo Capo, il Centrosinistra non ne ha avuto nessuno, di in-discutibile. Semmai, molti, in continuo conflitto reciproco. Nel Pd, per questo, ogni leader che emergeva è stato, puntualmente, delegittimato e allontanato — più o meno in fretta. Così è avvenuto a Prodi, D’Alema, Amato, Rutelli, Veltroni. Per ultimo, a Bersani. Anche per questo non è riuscito a reggere la concorrenza di Berlusconi. E ha sofferto quella di Grillo. Che ha “personalizzato” una rete ampia di esperienze di segno diverso. Offrendo rappresentanza alla crescente ondata di delusione (anti) politica. Il Pd. È cambiato profondamente dopo l’avvento di Renzi. Il quale ha conquistato il più “impersonale” e “multi-personale” dei partiti. Il Pd, appunto. Renzi: lo ha espugnato attraverso un (lungo) rito di massa. Durato oltre un anno. Le (doppie) primarie. Divenuto segretario, Renzi ha “conquistato”, in fretta, la presidenza del Consiglio. Ha affrontato, quindi, la campagna elettorale per le europee. Sempre di corsa. Senza quasi fermarsi. Annunciando, in rapida sequenza, le cose da fare, le riforme da realizzare. Con tale e tanta velocità da rendere difficile, agli elettori e agli stessi attori politici, verificare se e cosa davvero venisse fatto. Così, Matteo Renzi ha realizzato il post-Pd. O meglio: il Pdr. Il Partito di Renzi. Un modello “presidenziale”. Dove lui comunica, direttamente, con i suoi elettori. Che superano i confini del Pd. Alle recenti elezioni, infatti, nei comuni dove si è votato anche per il sindaco, il Pd, alle europee, ha ottenuto14 punti in più che alle comunali. E ha sfondato i confini tradizionali della zona rossa, dove era rimasto quasi imprigionato per oltre 60 anni. Ma se perfino nel partito personale per definizione, Fi, le logiche di partito sono entrate in contrasto con quelle del leader, ciò appare ineluttabile anche per il Pd. Che mantiene ancora tradizioni ideologiche e legami sociali profondi. Ha gruppi dirigenti e parlamentari eletti “prima” dell’avvento di Renzi. Così il confronto fra il Partito e il Capo diventa inevitabile. Fra Renzi e il Pd. Fra il Pdr e il Pd. Siamo alla resa dei conti. In particolare perché le questioni in gioco — legge elettorale e abolizione del Senato elettivo — mettono in discussione il principio di legittimazione e l’esistenza stessa dell’attuale ceto politico. Eppure converrebbe a entrambe le parti una soluzione condivisa. Perché il Pd senza il Pdr, senza Renzi, rischia di ritrovarsi marginale. Ma Renzi (e il Pdr), senza “conquistare” e modellare il Pd, rischia di rallentare la propria marcia. E Renzi, a velocità “moderata”, non riesco proprio a immaginarlo. Potrebbe fermarsi presto. Forse mi sbaglierò, ma nel contrasto tra Fi e Berlusconi, tra il Pd e Renzi, i margini di mediazione sono sottili. Quasi invisibili. Fra il Partito e il Capo: ne resterà soltanto uno… 23 del 07/07/14, pag. 5 Forza Italia, la trincea dei ribelli Offensiva Ncd per cambiare le soglie Alfano e Formigoni allo scoperto: «L’Italicum così non va» ● L’ira di Berlusconi alle prese con la fronda interna Federica Fantozzi Silvio Berlusconi continua ad essere convinto che la fronda sulle riforme istituzionali rientrerà. Ma i ribelli stanno tirando la corda con sprezzo dell’unità di partito, oltre che del pericolo. Per contare e magari modificare gli equilibri interni finora blindati. La situazione però rischia di sfuggire di mano ai frondisti ragionevoli come Renato Brunetta (che propone di mandare a Palazzo Madama i consiglieri regionali più votati) e ai pontieri come Maurizio Gasparri. I due stanno lavorando il leader ai fianchi per convincerlo a convocare la seconda assemblea dei gruppi, mentre Verdini e Romani se la eviterebbero volentieri. L’idea dell’ex Cavaliere è piuttosto chiamare i perplessi uno per uno e richiamarli all’ovile. Finora il metodo ha funzionato, ma stavolta? È vero che lo scontento attanaglia mezzo gruppo, una trentina di senatori su 59, ed è impossibile prevedere quanti saranno gli oltranzisti. Renzi però ha avvisato che vuole portare a casa la prima lettura del testo prima dell’estate. Quindi entro le prossime tre, quattro settimane. Di certo, più che sul Senato elettivo o meno, i fulmini si concentreranno quando in aula - in autunno - approderà la legge elettorale. Non ci sarà solo la battaglia tra liste corte bloccate, preferenze o collegi uninominali, che sarà uno dei punti dell’incontro tra Pd e M5S in programma oggi salvo cancellazioni. Ncd punta ad approfittare dell’asse con i grillini - contingente e ancora tutta da verificare - per modificare radicalmente l’impianto dell’Italicum (che pure hanno condiviso prima che Renzi lo sottoponesse a Berlusconi e poi l’hanno votato alla Camera). Ieri, dopo Quagliariello, Cicchitto e Formigoni, si è esposto in prima persona anche Angelino Alfano: «Così la legge non va. Occorrono almeno tre correzioni su soglie di sbarramento, preferenze e partecipate degli enti locali ».È la seconda il vero cuore dell’offensiva Ncd: abbassare le soglie per evitarsi di dover pietire l’alleanza con Forza Italia, alle condizioni di Berlusconi. Su questo, dopo il magro 4% con cui sono usciti dalle Europee, gli alfaniani si giocheranno il tutto per tutto. Lanciando, intanto, i gruppi di Coalizione Popolare con Udc e centristi sparsi alla Mario Mauro. Il tentativo è ambizioso: diventare, con l’aiuto della sorte e dell’età nonché dei processi di Berlusconi, alternativi al partito azzurro. OBIETTIVO RICANDIDATURA Anche a piazza San Lorenzo in Lucina, però, buona parte della partita si gioca in chiave interna. I parlamentari fuori dal cerchio magico temono la mancata rielezione. Magari a breve termine, se come sospettano il premier dovesse chiudere in anticipo la legislatura per votare con le Regionali 2015. I pugliesi di Fitto vorrebbero cautelarsi con le preferenze, ma Berlusconi ha ottenuto da Renzi la promessa (non proprio a prova di bomba, raccontano in Transatlantico) che la nuova legge elettorale non favorirà Opa sul suo partito da parte di quelli che considera “signori delle tessere”. I “sudisti” - Mara Carfagna, Saverio Romano, Daniele Capezzone, lo stesso Fitto, l’ex governatrice del Lazio Renata Polverini - sono in fibrillazione. Si torna a parlare di una cabina di regia: una segreteria politica, un organismo ristretto che federi tutte le varie correnti garantendole nella lotta al coltello per i (pochi) posti al sole. Ma niente, Berlusconi da quell’orecchio non ci sente. 24 «Decido io - ripete spalleggiato da Toti, Pascale e la tesoriera Rossi - Ci ho messo la faccia e l’accordo sulle riforme deve reggere. Il partito lo guido io, non mi farò commissariare da nessuno. Ho ascoltato tutti,ma non posso mancare alla parola data. Anche perché se fanno la riforma con il M5S non prenderanno certo in considerazione le nostre esigenze ». AVVISO AI MOROSI Ecco perché, dopo l’amara sorpresa ai parlamentari che sono stati invitati a mettersi in regola con le quote da versare al partito, gira voce che stia per arrivare loro una lettera con «avviso di morosità». Il debito da versare di ognuno calcolato e messo nero su bianco, con la data in cui dovranno mettersi in regola. Anche se stavolta qualche sorpresa potrebbe esserci. «Se mi arriva la missiva - si sfoga un deutato - giuro che passo al gruppo misto. Tanto questa è la mia ultima legislatura...». Giovanni Toti intanto continua a lavorare sulla riorganizzazione del partito. Primo obiettivo: fund raising, aiutato dalla Rossi e da un’altra imprenditrice, l’ex finiana Catia Polidori. Anche l’ex sindaco di Pavia Alessandro Cattaneo non è inoperoso: diventato responsabile della Formazione degli amministratori locali di Forza Italia sta per partire, da Ascoli Piceno, per un tour dell’Italia ad «ascoltare la base », racconta alla rivista Formiche. del 07/07/14, pag. 11 Dall’Eurofighter agli F35 Perché l’Europa vola Usa Michele Di Salvo Abbiamo un aereo che funziona, prodotto da un consorzio europeo e lo abbandoniamo per affidarci a un progetto americano che costa di più, senza che i nostri militari abbiano le chiavi di accesso del nostro armamento. Perché? L’Italia è parte della Nato e un progetto come quello degli F-35 non rientra nella libera decisione del nostro Paese, bensì - cosa che molti ignorano - in un progetto del 1994 di riordino, riassetto e coordinamento degli armamenti dopo la fine della guerra fredda. La logica è tagliare i costi ottimizzando ruoli e funzioni. Tradotto, ciascun Paese si specializza in una cosa, e si dota di un certo tipo di armamento, che funziona come pezzo di un unico puzzle bellico - che doveva essere di difesa, ma che è sempre più di «difesa preventiva», ossia di attacco. Ed è per questo che mano a mano che gli equipaggiamenti diventano obsoleti, quelli che li vanno e andranno a sostituire devono rientrare in una stretta cerchia di prodotti che si compensano e integrano tra loro. Ed è anche per questo che sino a un certo punto conta quello che decide il Parlamento, essendo la funzione centrale spostata in seno al «Consiglio Supremo di Difesa » che partecipa di quanto avviene in sede Nato. E tuttavia è bene ricordare anche che i parlamenti non sono tagliati fuori dalla conoscenza e decisione di queste politiche, perché esistono missioni permanenti presso la Nato. Ci piaccia o no, non è possibile intervenire su un pezzo del puzzle militare strategico senza entrare nel merito dell’assetto complessivo della Nato, delle sue regole e del suo funzionamento. JOINT STRIKEFIGHTER Il programma di sviluppo e costruzione degli F-35 ha il nome ufficiale di Joint Strike Fighter (Jsf) e ha l’obiettivo di costruire un aereo da combattimento cosiddetto «di quinta 25 generazione». È svolto dagli Stati Uniti in collaborazione con Regno Unito, Italia, Canada, Danimarca, Norvegia, Olanda, Australia, Turchia, Singapore e Israele. I diversi Paesi hanno diversi livelli di coinvolgimento nel progetto: il Regno Unito è l’unico di primo livello (partecipa a circa il 10 per cento delle spese di ricerca e sviluppo), mentre Italia e Olanda sono due partner di secondo livello (partecipazione intorno al 5 per cento). Il programma serve, nel caso dell’Italia, a sostituire tre modelli di aereo militare, e cioè i Tornado, gli Amx e gli Av8b della Marina. Nel 2001 la realizzazione dell’aereo è stata data a un gruppo industriale guidato dalla statunitense Lockheed Martin e di cui fanno parte ai primi posti NorthropGrumman(americana), Bae Systems (britannica) e, per i motori, le statunitensi Pratt & Whitney, General Electric e Rolls Royce (quest’ultima britannica). Il «Lightining» (cioè «lampo») F35 è figlio imprevisto di un altro caccia, l’F22 «Raptor». Quest’aereo, l’F22, è invisibile al radar (o almeno furtivo, secondo la traduzione letterale di «stealth »). Avrebbe dovuto essere prodotto in 750 esemplari, ma poi il costo unitario elevato e forse anche problemi tecnici (peraltro mai ammessi ufficialmente) ne hanno ridotto gli ordinativi ad appena 183. Gli americani hanno deciso di riservare l’F22 al ruolo di caccia puro (intercettazione e combattimento aereo) e di affiancargli un aereo più semplice ed economico per le mansioni di cacciabombardiere, cioè l’attacco al suolo o in mare e l’appoggio tattico alle truppe a terra. Questo figlio (inizialmente non pianificato) dell’F22 è l’F35. L’F35 ha tradito molte promesse. Costa meno dell’F22 ma molto più del previsto, addirittura l’80% in più; in particolare i 90 F35 italiani costerebbero 155,5 milioni al pezzo. I problemi sono anche tecnici. L’F35 fruendo della tecnologia già sviluppata per l’F22 avrebbe dovuto crescere in fretta e invece ha avuto un sacco di problemi. Innanzi tutto, ed è una beffa per un aereo che si chiama «Lightning», l’F35 è risultato vulnerabile ai fulmini. Nel marzo scorso un rapporto del Pentagono ha denunciato che sull’F35 il display nel casco di volo non fornisce un orizzonte artificiale analogo a quello reale, a volte l’immagine è troppo scura o scompare, e il radar in alcuni voli di collaudo si è mostrato incapace di avvistare e inquadrare bersagli, o addirittura si è spento. La quasi tragica considerazione finale del Pentagono è che in un duello aereo l’F35 verrebbe abbattuto dai vecchi caccia americani F15, F16 e F18 (evoluzioni di modelli che volano da 30 o 40 anni), dal paneuropeo Typhoon e dal Sukhoi 30 russo e dal J-10 cinese. La Lockheed assicura che questi problemi saranno risolti. Comunque l’F35 è (di base) un monomotore più lento e meno potente di molti potenziali oppositori vecchi e nuovi, per la maggior parte bimotori; può superare l’handicap con la tecnologia superiore, ma non se questa tradisce le aspettative. FINMECCANICA Il gruppo italiano Finmeccanica - che per il 30% è di proprietà del ministero dell’Economia - partecipa attraverso tre aziende principali: Alenia, Selex Galileo e Selex Communications. Anche Avio, un’altra azienda aerospaziale italiana in cui Finmeccanica ha una partecipazione, è coinvolta nel progetto. Alenia partecipa già da tempo ad alcune fasi di progettazione insieme alla Lockheed Martin, nella sede di Pomigliano d’Arco. Partecipa soprattutto alla costruzione di alcune componenti finali delle ali dell’aereo (per ora in due stabilimenti a Foggia e a Nola). Lavora poi nella base dell’aeronautica militare di Cameri, in provincia di Novara, dove è stata costruita l’unica linea di assemblaggio finale, manutenzione, supporto logistico e aggiornamento degli aerei al di fuori degli Stati Uniti. Selex Galileo partecipa alla costruzione del sistema di puntamento. Le stime per la vita operativa - ossia il prezzo di ricambi, manutenzione e aggiornamenti tecnici - dell’intera flotta di F-35 statunitensi per i prossimi 50 anni arrivano a 1510 miliardi di dollari, pari a 618 milioni per ogni aereo. Altri Paesi come la Norvegia prevedono che per ogni velivolo si spenderanno 769 milioni di dollari. La Marina americana reputa questi costi superiori di 26 442 miliardi rispetto alle previsioni ragion per cui il Pentagono ha minacciato che se queste stime non verranno ridotte toglierà alla Lockheed il controllo delle forniture di ricambi. LA SCELTA Perché l’Italia ha scelto l’F-35? La decisione è stata sostenuta soprattutto dai militari, dalla Marina in particolare: è il solo aereo a decollo verticale sul mercato e quindi l’unico che può operare dalle nostre piccole portaerei Garibaldi e Cavour. L’Aeronautica l’ha definito il miglior velivolo disponibile per le missioni d'attacco. Le forze armate ritengono che si potranno creare 10mila posti di lavoro e ci sarà una ricaduta per le aziende italiane pari a 18,6 miliardi di dollari. Queste stime si basano però su una produzione a Cameri di 250 velivoli e sulla prospettiva che altri acquirenti dell’F-35, ad esempio la Turchia e Israele, affidino allo stabilimento piemontese la manutenzione dei loro caccia. Al momento non ci sono accordi firmati. Lockheed invece ha prospettato una ricaduta per l’Italia di 9 miliardi di dollari, senza calcolare l’attività di supporto e manutenzione, più altri quattro miliardi di dollari da assegnare. Nessun dubbio che si tratti di una vicenda decisamente intricata, alla base della quale ci sono due certezze. La prima è che parliamo di un argomento estremamente tecnico e delicato, in cui spesso se si vuole davvero scavare a fondo, c’è qualcuno che può appellarsi al segreto militare. La seconda è che i tecnici che veramente possono mettere in dubbio le tesi dei militari, sono spesso al servizio dell’industria bellica privata. E anche quando ne trovi uno disposto a sostenere una posizione differente, l’industria bellica può schierarne altri dieci a difesa. Resta comunque la domanda: possibile non esista una vera alternativa all’F35, al punto che in tutto il mondo occidentale questo sia l’unico aereo possibile, e che vi sia davvero solo un fornitore che debba monopolizzare la difesa aerea di tutta la Nato? Si scopre che in realtà un’alternativa c’era e c’è ancora, tutta made-in-Europe, e questa alternativa era sino a pochi anni fa vincente sia sul piano tecnico che su quello economico. Un’alternativa che aveva due «difetti »: rendeva indipendenti i Paesi europei da forniture belliche - e quindi anche dal controllo sugli armamenti - per migliaia di miliardi di dollari, e poteva costituire una base solida per la nascita di vere proprie Forze armate europee, capaci nel tempo di sostituirsi alla Nato. In questo settore l’industria europea ha esperienza ed expertise da vendere, e non mancano esempi eccellenti: uno tra tutti il programma Neuron per la creazione di un dimostratore tecnologico per lo sviluppo del primo Ucav stealth europeo, nato nel 2003 dalla cooperazione tra Italia, Svizzera, Spagna, Grecia, Regno Unito e Francia. Un altro esempio ben più noto è sicuramente quello del consorzio Eurofighter (Germania, Italia, Spagna e Regno Unito), che ha dato alla luce il caccia multiruolo di «quarta generazione e mezza» Ef2000-Typhoon. IL TYPHOON Proprio quest’ultimo velivolo è legato ad uno dei più grandi paradossi dell’industria aeronautica europea: l’introduzione dell’F-35 in Europa porterebbe al rimpiazzo di numerosi esemplari di Typhoon, nonostante quest’ultimo sia un velivolo estremamente efficiente. Se da un lato l’F-35 presenta una tecnologia estremamente avanzata, è pur vero che supera i parametri del Typhoon solo per quel che riguarda la tecnologia stealth. Al contrario il Typhoon è maggiormente manovrabile, specialmente a media ed alta quota, e più veloce, dal momento che superato il regime transonico l’F-35 riesce a malapena a sfiorare velocità Mach 1.6 contro Mach 2 del Typhoon. Ancora, l’F-35 presenta una serie di problemi di progettazione che la Lockheed Martin si è affrettata a definire «problemi di gioventù» dell’aereo, mala cui risoluzione comporta un notevole aumento dei costi. I due esempi più rilevanti sono rappresentati dall’abitacolo, che pecca di scarsa visibilità negli angoli posteriori e compromette la sicurezza di volo e l’efficacia negli scontri (dato confermato in un rapporto del Pentagono) e dall’impianto elettrico a 270 volt, estremamente delicato, che al più semplice danno rischia di provocare pericolose 27 fiammate. Restando in casa nostra, l’industria aerospaziale e della difesa italiana non si è mai trovata così in contrasto con il suo cliente naturale, le Forze Armate, come con il programma F-35. L’Aeronautica Militare Italiana non ha mai avuto un atteggiamento così duro, al limite dello sprezzante. Il Joint Strike Fighter ha finito per accrescere la distanza fra le due parti rendendo ancor meno conciliabili le prerogative e le esigenze di entrambe. Sentito alla Camera dei Deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui sistemi d’arma, l’ex Amministratore delegato Alessandro Pansa ha denunciato la sofferenza di Finmeccanica nei confronti del programma americano affermando che con esso il gruppo è stato ridotto al ruolo di semplice «esecutore intelligente» di scelte altrui, estranee alla logica industriale. Per converso ha sottolineato il valore strategico e la rilevanza economica della partecipazione dell’industria nazionale al programma europeo Eurofighter. Nell’intervista a più voci rilasciataci nel maggio 2012 da ex-alti dirigenti di Alenia Aermacchi, era stato rimarcato come nella definizione dei loro requisiti le forze armate dei Paesi avanzati siano solite avvalersi quantomeno dialetticamente delle «solide competenze tecnico-industriali » della loro controparte, e come un tale dialogo sia invece mancato nel processo decisionale che ha portato alla scelta dello strike «invisibile» di Lockheed Martin. BUY AMERICAN Nonostante l’«intelligenza» con cui Finmeccanica si conforma a scelte che le sono state imposte e che ovviamente anche per questo non condivide, il Typhoon e il Lightning II sono insomma gli alfieri delle opposte ragioni dell’industria e segnatamente dell’Aeronautica Militare. Sulla prima pesa l’oggettivo differenziale di dimensioni con l’industria statunitense, mentre dal canto suo la seconda, votandosi al «buy american», si sente finalmente affrancata dall’obbligo di assecondare un fornitore nazionale considerato talora «tiranneggiante ». I piloti italiani del caccia europeo sono invitati a non divulgare le sue notevoli doti, quando i colleghi britannici, all’indomani della guerra in Libia, le hanno sbandierate pubblicamente. L’imbarazzo è evidente anche tra i vertici delle primarie società coinvolte nel programma Jsf, ma anche per loro la consegna è quella del silenzio. Alla rivista Analisi Difesa Enzo Casolini - un ex ufficiale che ha ricoperto il ruolo di coordinatore della partecipazione delle aziende Finmeccanica al programma Jsf, per poi passare con la carica di Amministratore delegato alla guida del consorzio Eurofighter - ha dichiarato: «Nella mia veste di coordinatore di Finmeccanica fra il 2007 e il 2008 ho gestito la fase preliminare dell’intesa industriale fra Lockheed Martin e le aziende del gruppo. Gli accordi erano molto promettenti in quanto prevedevano anche, in alcuni casi, la capacità di integrazione di sistemi nazionali come ad esempio il missile aria-aria Iris-T, e di conseguenza tutte le attività ingegneristiche derivate. Si citava addirittura la capacità di accesso al Software Code del velivolo. Però tutti gli accordi fatti con Lockheed, con il supporto determinante del Segretariato Generale della Difesa nelle trattative con la controparte americana, si chiudevano con una formula che spiegava la necessità dell’approvazione, per ciò che concerneva il trasferimento del know how, delle autorità governative Usa. Cioè, tutto ciò che si stabiliva nei contratti doveva essere approvato dall’Amministrazione, la quale in omaggio alla legislazione nazionale, non ha consentito l’esportazione delle tecnologie più sensibili del velivolo ». Riassumendo sin qui. Abbiamo un aereo che funziona, prodotto da un consorzio europeo, con ampie ricadute occupazionali e industriali e di fatturato sull’Italia, e «chiudiamo il programma» per affidare il monopolio della nostra difesa aerea ad un progetto americano, di un’azienda americana, che costa di più, non garantisce le stesse ricadute economiche, industriali ed occupazionali, ed in più senza che i nostri militari abbiano in mano le chiavi di accesso del nostro armamento strategico. Come è stato possibile? 1/continua 28 del 05/07/14, pag. 1/2 Bidoni di lusso e di morte Tommaso Di Francesco Giulio Marcon Ve l’avevamo detto. I cacciabombardieri F35 sono bidoni di lusso e ne stanno passando di tutti i colori. Dopo l’ennesimo incidente, ieri il Pentagono ne ha deciso la sospensione dei voli. Da ultimo avevano preso fuoco durante il decollo, ma prima ancora erano stati fatti atterrare a causa di un temporale. Il software che va in tilt, il peso eccessivo della fusoliera e i caschi milionari dei piloti che fanno vedere doppio come dopo una sbronza sono solo alcune delle falle di un sistema d’arma pagato a peso d’oro e che fa acqua da tutte le parti. Una vera débacle per l’industria militare e la politica estera Usa che ha impegnato e condizionato molti paesi alleati ad acquistarli. Con la incessante crescita delle spese, gli F35 sono una gallina dalle uova d’oro per la Lockheed — che ne è il capofila della produzione — e un secchio bucato per i governi che lo stanno producendo ed acquistando. Negli Stati Uniti (e soprattutto negli altri paesi partner) se ne stanno accorgendo, ma in Italia la ministra Pinotti, troppo nella parte delle nostre gerarchie militari e delle lobbies delle armi, fa finta di niente e, spalleggiata dal presidente Napolitano e dal Consiglio Supremo della Difesa, continua a nicchiare e a sperare in tempi migliori. Dopo l’approvazione delle mozioni parlamentari del giugno del 2013 che chiedevano la sospensione di altri acquisti (decisione violata dal governo nel settembre del 2013 e nel marzo del 2014: ora di F35 ne abbiamo 6 in produzione) e che ha portato a qualche riduzione di spesa nel 2014, abbiamo passato quasi un anno in una indagine conoscitiva (terminata nel maggio scorso) che avrebbe dovuto aiutarci a prendere la decisione definitiva: continuare o meno nell’avventura degli F35. Ma così non è stato. Perché, finito un temporeggiamento, ne è iniziato un altro. Ora bisogna aspettare il Libro Bianco della Difesa, sul quale il Parlamento potrà dare «valutazioni e suggerimenti», dice la Pinotti. La palla passa di nuovo dal Parlamento (così espropriato) al Governo e al Consiglio Supremo di Difesa. Quanto tempo ci vorrà, comunque? Non si sa: potrebbero trascorrere altri 8–10 mesi. E così la tattica dilatoria continua, mentre il Consiglio Supremo di Difesa dice al Parlamento di non intromettersi troppo nelle scelte della difesa e soprattutto di non permettersi di ridurre eccessivamente le spese militari, pena la nostra operatività nelle missioni all’estero in cui siamo impegnati. Ma andrebbe ricordato che gli F35 sono concepiti come caccia da first strike , da primo colpo d’offesa — altro che «difesa» — e possono montare anche testate nucleari. Dietro questa tattica temporeggiatrice c’è sullo sfondo lo scontro tra la Pinotti, Napolitano, i vertici militari e una parte minoritaria del Pd che quegli F35 non li vorrebbe. Con la speranza che — passata la buriana di questi mesi e la dichiarazione del Pentagono che per i cacc’è la «no fly zone del Pentagono» — si possa prendere la decisione di acquistarli e avviarli gli F35, magari distratti da qualche avvenimento più importante. E Renzi? Dopo i roboanti annunci (non veritieri) di qualche giornale di un paio di mesi fa sui tagli degli F35, resta muto, silenzio assoluto. Nemmeno un tweet. Vuole combattere — così dice — tutte le caste. L’unica che non tocca è quella delle gerarchie militari e del business delle armi. Giustamente vuole ridurre gli sprechi delle auto blu (per qualche milone), ma niente dice sugli sprechi degli F35 (risparmio 14 miliardi). Evidentemente non vuole disturbare le lobbies militari e gli Stati uniti. Non è retropensiero: basta ricordarsi su questo le pressioni dell’ambasciata Usa. Stavolta dovrà risponderne ancora in Parlamento. Il prossimo 29 luglio la Camera dei deputati discuterà la nuova mozione che chiede lo stop agli F35. Un’occasione per mobilitarsi e per portare 29 allo scoperto le contraddizioni di un governo che non cambia il verso delle spese militari e del riarmo atlantico. del 05/07/14, pag. 1/14 Il metodo Ferrulli Luigi Manconi Da oggi in poi dovremo chiamarlo «metodo Ferrulli». Si tratta di un modello marziale, di un prontuario tecnico-agonistico o, piu semplicemente e brutalmente, di un sistema di immobilizzazione della persona sottoposta a fermo o arresto: e prende il nome dall’uomo di 51 anni — Michele Ferrulli, appunto — morto il 30 giugno del 2011, in via Varsavia a Milano. Si può arrivare a prevedere che il «metodo Ferrulli» verrà insegnato nei corsi di formazione presso le scuole per agenti di polizia e per carabinieri. Secondo il pubblico ministero della procura di Milano, Gaetano Ruta, quella tecnica di fermo consiste nella seguente procedura: la persona viene costretta in «una prolungata posizione prona»: e viene esercitata, in «quattro contro uno», una «violenza gratuita e non giustificata» ai danni di «una persona bloccata a terra» e che «invoca aiuto». L’esito possibile («preterintenzionale») del «metodo Ferrulli», sempre secondo il procuratore Ruta, è il seguente: «Se io butto a terra una persona e infierisco, posso fargli molto male e a questa persona può venire un infarto, anche se è una conseguenza non certo prevedibile». La corte di Assise di Milano ha deciso diversamente. Quella tecnica di immobilizzazione non ha avuto alcun ruolo nel determinare la morte di Michele Ferrulli fermato per «disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone». Dunque è legittimo che gli operatori della pubblica sicurezza agiscano come hanno agito a Milano, e non solo a Milano. Perché questo è il punto più vero e più dolente. Il «metodo Ferrulli» va considerato un vero e proprio metodo proprio perché assomiglia in modo impressionante a una tecnica abituale, a un sistema operativo collaudato, a un modello di intervento sperimentato. Il fermato viene bloccato a terra, i polsi ammanettati dietro la schiena e tre o quattro uomini che gli gravano addosso con tutto il proprio peso. Ne deriva una compressione toracica, che può determinare l’asfissia o l’infarto. E’ accaduto così, con tutta probabilità, nelle vicende che hanno portato alla morte di Riccardo Rasman, Federico Aldrovandi, Bohli Kayes, Riccardo Magherini e chissà di quanti altri, rimasti anonimi e caduti nell’oblio. Ho parlato più volte col capo della polizia Alessandro Pansa e col comandante generale dei carabinieri Leonardo Gallitelli. Entrambi, in forma diversa, si dicono impegnati a elaborare un protocollo che fissi prescrizioni e vincoli, limiti rigorosi e cautele severe per le procedure del fermo. Evidentemente, oggi, quel protocollo non c’è. E oggi la prassi, la concreta modalità di azione, la tecnica generalmente adottata corrispondono in modo sinistro al «metodo Ferrulli». Quello che, come ha solennemente affermato la corte di Assise di Milano, «non sussiste». 30 LEGALITA’DEMOCRATICA Del 07/07/2014, pag. 3 La Madonna si inchina davanti a casa del boss l’ira dei carabinieri Processione shock a Oppido Mamertina, in Calabria Alfano: rituale ributtante. I vescovi: ora provvedimenti drastici GIUSEPPE BALDESSARRO OPPIDO MAMERTINA La processione con la Madonna si ferma sotto casa del boss del paese e in Calabria, a quindici giorni dalla visita dalla scomunica annunciata dal Papa ai mafiosi, scoppia la polemica. Stamattina sulla scrivania delle procure di Palmi e di Reggio Calabria ci sarà la relazione del maresciallo di Oppida Mamertina, Andrea Marino. Di quanto accaduto durante la processione della Madonne delle Grazie si occuperanno anche i magistrati della Dda. Il comandante della stazione dei carabinieri ha filmato tutto, e in queste ore si sta procedendo all’identificazione dei protagonisti. Quel gesto di far girare la statua della Madonna verso la casa del boss Peppe Mazzagatti, ergastolano ma ai domiciliari per questioni di salute, avrà un seguito sia sul piano giudiziario che su quello religioso. Quanto accaduto mercoledì scorso ha provocato un vero e proprio terremoto. Alla vista dell’omaggio al boss, il maresciallo Marino ha lasciato la processione per dissociarsi da quanto stava accadendo mentre il resto del paese, istituzioni civili e religiose comprese, non ha fatto una grinza. Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, ha detto «che la Madonna non si inchina ai malavitosi. Chi ha fatto fare l’inchino alla Madonna le ha fatto fare un gesto che la Madre di Dio non avrebbe mai fatto. Si è inchinata la statua, non la Madonna». Una dichiarazione che fa il paio con quelle del vescovo delle diocesi Francesco Milito che ha annunciato «provvedimenti energici in modo da far capire che non ci possono essere alleanze contro la fede». Insomma la Chiesa ha deciso di non tollerare più certe scene. E che la tensione sia alle stelle lo dimostra anche quanto accaduto ieri in chiesa a Oppido dove il parroco don Benedetto Rustico, parlando dal pulpito ha invitato i fedeli a «prendere a schiaffi ed allontanare» un giornalista che era andato a chiedere conto di quanto accaduto durante la processione. Dure anche le prese di posizione sul piano politico. Il ministro Angelino Alfano ha definito quanto accaduto in Calabria un «rituale ributtante». Il maresciallo Marino ieri è stato anche raggiunto telefonicamente dalla presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi, a cui ha detto di essersi limitato a «fare il proprio dovere». Per la Bindi «Lui e tutta la stazione hanno preso le distanze, ma non hanno abbandonato il luogo. Hanno quindi potuto filmare quello che succedeva, hanno fatto un’inchiesta sul momento. È terribile come in Calabria la ‘ndrangheta usi la religione per legittimarsi». Ieri sera è arrivata anche una nota della moglie del boss ai domiciliari, Giuseppina Polimeni. Suo marito, ha spiegato è ridotto «ad un vegetale». E poi: «Avverto un clima di preconcetta ostilità nei confronti della mia famiglia». Una famiglia pesante quella dei Mazzagatti, protagonisti di una delle faide più cruente della Piana di Gioia Tauro che nel tempo lasciò sul selciato oltre cento morti ammazzati, senza risparmiare donne e bambini, e con i nemici ancora vivi dati in pasto ai maiali. 31 Del 07/07/2014, pag. 13 Calabria, il Consiglio degli inaffondabili ogni mezzo per rinviare lo scioglimento GIUSEPPE BALDESSARRO REGGIO CALABRIA Restano aggrappati alla poltrona, prendono tempo, accampano urgenze. Ma non mollano. Il Consiglio regionale della Calabria, ad oltre cento giorni dall’annuncio di dimissioni del governatore Giuseppe Scopelliti, condannato a sei anni di reclusione, continua a galleggiare. E non si scioglie. Si parla di tornare alle urne, il centrosinistra ha già lanciato le primarie per il 21 settembre, ma di date per le elezioni regionali neanche l’ombra. Forse ottobre, ma c’è chi guarda a maggio, alla scadenza naturale. Non ha guida la Calabria: eppure si firmano decreti, si assegnano finanziamenti, si annunciano progetti. L’ultimo appiglio a cui si sono attaccati i politici calabresi è la legge elettorale approvata il 3 giugno scorso. Un atto che avrebbe dovuto chiudere la partita ed aprire la campagna elettorale. Invece no. La maggioranza ci ha messo dentro lo sbarramento al 15% per i partiti che non si presentano in coalizione e l’introduzione del consigliere regionale supplente, che va a ricoprire il posto del consigliere chiamato in giunta come assessore. Quanto basta per “costringere” il Ministro agli Affari regionali Maria Carmela Lanzetta ad annunciare che così non va bene, e che la legge sarà impugnata dal Governo. «Difenderemo, senza esitazioni le nostre ragioni dinanzi alla Consulta», ha detto il presidente del parlamento regionale Francesco Talarico. Ci vorrà insomma ancora tempo. Solo Domenico Tallarico, consigliere eletto nelle fila di Idv, sostiene apertamente: «Ci voglio due ore per fare le modifiche e tornare alle urne, ma mi pare che manchi la volontà politica». Per la maggioranza di centrodestra invece neppure a parlarne, e neanche dall’opposizione si registrano voci che vanno in direzione troppo contraria. Da marzo la Regione è ingessata. Fino all’approvazione della legge elettorale contestata si lavorava a pieno regime. E questo nonostante le condanne, gli arresti di tre consiglieri, le inchieste giudiziarie, le dimissioni annunciate e la sospensione del governatore arrivata con l’applicazione della Severino. Per mesi l’emergenza si è chiamata riforma dello Statuto e legge elettorale. Dovevano essere rifatte per portare da 50 a 30 i consiglieri (come previsto per le regioni con meno di 2 milioni di abitanti), quella precedente solo di una manciata di mesi — di 40 consiglieri — era stata bocciata dalla Corte Costituzionale. Nell’attesa di capire cosa fare tra le pieghe della legge, l’aula ha contemporaneamente preso atto delle dimissioni di Scopelliti e approvato la nuova legge elettorale con 30 consiglieri, ma aggiungendoci un paio di elementi che hanno riaperto il caso. Ora ufficialmente il Consiglio si può riunire soltanto in via straordinaria, la Giunta continua ad affidare qualche incarico e qualche consulenza e tutti mettono fieno in cascina sotto forma di diaria. L’impugnazione del Governo fa ben sperare gli oltranzisti della poltrona, ci vorrà altro tempo. Scopelliti, ad esempio ha trovato la maniera per utilizzarlo. Si è candidato alle Europee (non eletto) ed ha firmato alcuni decreti nella veste di commissario straordinario della sanità calabrese. I suoi uomini sono tutti saldi al loro posto. Se poi ci sarà da rifare la legge elettorale per la terza volta si tornerà in aula. In autunno forse. 32 SOCIETA’ del 05/07/14, pag. 7 “Svuotacarceri, a rischio la difesa sociale” di Grazia Longo La speranza è che domani la commissione giustizia alla Camera accolga le richieste di modifica al decreto legge, entrato in vigore lo scorso 28 giugno, sulla riforma della giustizia. Altrimenti niente carcere, ma solo arresti domiciliari, per chi dovrà scontare pene inferiori a tre anni. Ve lo immaginate un marito accusato di stalking, costretto in casa con la moglie, sua vittima prediletta? Il rischio è quanto mai probabile se non si provvede a distinguere la fase della custodia cautelare da quella che scatta al momento di una condanna. E riguarda in generale reati che hanno come protagonisti persone ritenute socialmente pericolose. Come, appunto, quelli indagati per stalking ma anche per maltrattamenti in famiglia e per rapina aggravata. Persone che, se non dovessero avere un luogo dove poter essere poste ai domiciliari, dovranno essere rimesse in libertà, sia nei giudizi celebrati in seguito di arresti in flagranza (per direttissima) sia di primo e secondo grado. Basta e avanza per mettere in allarme avvocati e magistrati. "La difesa sociale è a rischio" afferma il presidente dell'Anm (Associazione Nazionale Magistrati), Rodolfo Sabelli. E il segretario generale Maurizio Carbone insiste: "Martedì ribadiremo chiaramente la necessità di non confondere l'esigenza dell'applicazione della misura cautelare, indispensabile quando si temono la reiterazione del reato, l'inquinamento delle prove e il pericolo di fuga, con la possibile pena. La prima non è e non deve assolutamente essere confusa con la condanna definitiva". Poiché siamo ancora in fase di conversione di legge - entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto - esiste un margine di manovra. "I due piani non vanno sovrapposti, altrimenti si corre il rischio concreto di una scorciatoia legislativa che alla riforme strutturali preferisce norme emergenziali, per fronteggiare il sovraffollamento delle carceri, che espongono il fianco a delle criticità". Carbone è, comunque, ottimista sull'attenzione al problema da parte del ministro della Giustizia Andrea Orlando. Il quale infatti, nei giorni scorsi, aveva precisato che si tratta "di un intervento con cui il Governo ha corretto una norma già approvata da Camera e Senato che, invece, stabiliva il divieto di qualunque misura cautelare detentiva, sia carcere che arresti in casa, nel caso della previsione di una pena non superiore a tre anni". E ancora: "Un intervento che va nella direzione di garantire una maggior sicurezza dei cittadini e consentirà comunque al Parlamento di intervenire sulla materia con eventuali correzioni". Se lo augurano anche gli avvocati, in particolare quelli che assistono le vittime di stalking. Come Francesca Zanasi, legale da tempo sensibile al problema, affrontato anche in diversi libri (l'ultimo dall'eloquente titolo "L'odioso reato di stalking"). "Il decreto va rivisto - afferma - perché occorre applicare la legge in maniera più rigorosa possibile. Chi picchia una donna, ne abusa sessualmente, ne condiziona le relazioni sociali, deve essere assolutamente fermato. E spesso la custodia cautelare è l'unico rimedio utile per far finire il tormento". L'avvocato non ha dubbi: "Non possiamo invitare le donne a denunciare gli stalker e poi non proteggerle concretamente". 33 BENI COMUNI/AMBIENTE del 05/07/14, pag. 4 Ilva, la mortalità infantile è choc Gianmario Leone TARANTO Veleni. I dati di un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità riguardano la fascia pediatrica tra gli 0 e i 14 anni La mortalità infantile nella fascia pediatrica tra gli zero e i 14 anni è aumentata a Taranto del 21% rispetto alla media regionale pugliese insieme al tasso di ospedalizzazione per le malattie respiratorie acute. Per tutti i tumori è stato registrato un eccesso di incidenza più che doppio: +54%. Nel corso del primo anno di vita vi è un eccesso di mortalità per tutte le cause (+20%) ascrivibile all’eccesso di mortalità per alcune condizioni morbose di origine perinatale (+45%): per questa stessa causa si osserva un eccesso di ospedalizzazione (+17%). Sono gli ultimi dati choc dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) all’interno del progetto «Sentieri», pubblicato aggiornato lo scorso maggio e basato su dati del 2008. La scorsa primavera, sono stati resi noti i dati che confermavano come la mortalità per tutte le cause, tutti i tumori, l’apparato circolatorio, respiratorio e digerente rivela, in entrambi i generi, presentasse eccessi rispetto al riferimento regionale. Considerate le polemiche, ieri l’Iss è intervenuta con una nota ufficiale. Il progetto «Sentieri» è uno studio di tipo ecologico e «non prende in considerazione le esposizioni dei singoli individui a particolari inquinanti, ma esamina la situazione sanitaria delle popolazioni che risiedono in luoghi in cui sono presenti sorgenti di inquinamento». Lo studio, in linea generale, non permette la valutazione di nessi causali, ma può individuare situazioni di possibile rilevanza sanitaria da approfondire con studi mirati. «Lo studio conferma le criticità del profilo sanitario della popolazione di Taranto emerse in precedenti indagini – continua la nota – Le analisi effettuate usando tre indicatori sanitari segnalano eccessi di rischio per le patologie per le quali è verosimile presupporre un contributo eziologico delle contaminazioni ambientali che caratterizzano l’area in esame, come causa o concausa, qualiù: tumore del polmone, mesotelioma della pleura, malattie dell’apparato respiratorio nel loro complesso, malattie respiratorie acute, malattie respiratorie croniche». Il sindaco di Taranto, Ippazio Stefàno ha scritto al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin sollecitando la nomina di una «commissione che possa valutare tutte le azioni che sono state poste in essere fino ad oggi». «Voglio capire — ha scritto Stefàno — se quanto è stato fatto va nella direzione della prevenzione, del controllo e della terapia». Per Edo Ronchi, subcommissario all’Ilva il cui mandato è scaduto il 4 giugno scorso, «gli effetti dell’inquinamento storico dureranno a Taranto per anni, anche se oggi la qualità dell’aria è migliore». Ronchi insiste sul fatto che «i dati da me resi pubblici, quelli dell’Arpa Puglia, hanno evidenziato chiaramente i miglioramenti della qualità dell’aria intervenuti nel 2013» e che quelli resi pubblici dallo studio dell’Iss riflette gli effetti dell’inquinamento storico degli anni passati: effetti che si manifesteranno ancora purtroppo per diversi anni anche se le emissioni industriali fossero azzerate». «Nella Terra dei Fuochi l’Istituto Superiore di Sanità ha riscontrato eccessi di mortalità e di rischio per gli adulti e un eccesso di ospedalizzazione per i bambini — affermano Alessandro Marescotti, presidente di Peacelink, e Fulvia Gravame, responsabile nodo PeaceLink Taranto — A Taranto si registrano gravi criticità per gli adulti a cui si somma 34 anche, cosa ancor più grave, un eccesso di mortalità per bambini. Quindi i bambini di Taranto sono un’emergenza nazionale che non ha eguali in Italia». Clima di tensione Per provare ad arrestare l’irreversibile crisi finanziaria dell’Ilva, il governo è pronto ad intervenire con un nuovo decreto che il Consiglio dei Ministri pare intenzionato a varare entro l’11 luglio. Andrà ad implementare quanto previsto dalla legge n. 6 approvata lo scorso febbraio. L’esecutivo ha convinto le banche, Intesa San Paolo, Unicredit e Banco Popolare, a concedere alla società un prestito ponte, attraverso il meccanismo della prededuzione. La conferma è arrivata dal ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi, dopo l’incontro avuto nella serata di giovedì a Roma con i sindacati metalmeccanici. Il prestito, non meno di 3–400 milioni di euro, si è reso necessario per evitare il fallimento dell’Ilva. Gli stipendi di giugno saranno regolarmente retribuiti, anche se monchi del premio di produzione che per gli operai è una sorta di quattordicesima. Le risorse serviranno all’Ilva per tornare a pagare le ditte dell’indotto e dell’appalto del siderurgico tarantino, che vantano crediti per oltre 46 milioni di euro. Ciò consentirà all’azienda di restare in vita sino a dicembre. Il clima all’Ilva resta molto teso. A Taranto sono in corso da giorni le assemblee di fabbrica dove si sono vissuti momenti di scontri accesi tra operai e sindacati. A Genova i lavoratori sono scesi in piazza per due giorni consecutivi, bloccando la stazione e arrivando allo scontro con le forze dell’ordine all’esterno della Prefettura. del 07/07/14, pag. 6 È partita trivella selvaggia Sotto le acque dell’Adriatico si nasconderebbero giacimenti di gas e oro nero. Così, si dice, anche in tante altre regioni, dalla Puglia alla Sicilia. Allora via alle perforazioni. Ma benefici e danni non sono chiari di Thomas Mackinson Un’esca che galleggia lenta nell’Alto Adriatico rischia di provocare una marea nera lungo tutte le coste italiane, dal Veneto alla Sicilia. A lanciarla è stato l’ex premier Romano Prodi che, in una lettera al M e ss a g g e ro , ha chiesto al governo di darsi una mossa per cogliere un’occasione d’oro. In questo caso l’oro è nero, come petrolio. Proprio lungo la linea di confine delle acque territoriali della Croazia, sotto 12mila km quadrati di mare, si nasconderebbero enormi giacimenti di gas e oro nero. Basterebbe prenderli – assicura il professore – per migliorare la bilancia dei pagamenti, aumentare le entrate fiscali, ridurre la bolletta energetica e la dipendenza da Russia, Libia, Algeria. Problema: rientra tra i tesori che l’Italia non sfrutta, scrive Prodi, per il principio di precauzione che tutto blocca. Nel caso del Golfo di Venezia, le attività di esplorazione e coltivazione di idrocarburi sono bloccate dal 1991 per il rischio di subsidenza delle coste e lo rimarranno finché Regione Veneto e Consiglio dei Ministri – supportati dagli enti di tutela ambientale – avranno accertato l’assenza di rischi in via definitiva. Ma in Italia, si sa, nulla è più definitivo del provvisorio. La gara con la Croazia Ecco servita, allora, l’altra ragione per trivellare in quell’area: se non lo facciamo noi, comunque lo fa la Croazia. Il nostro dirimpettaio, quel tesoro, non intende farselo sfuggire. 35 E corre tanto che a gennaio ha concluso la fase di prospezione dei fondali, entro fine anno assegnerà le concessioni di sfruttamento delle 19 piattaforme che dal 2019 inizieranno a pompare, secondo le stime, fino a 3 miliardi di barili. La mossa, ragiona Prodi, mette due volte in difficoltà l'Italia: se non fa nulla rischia di condividere tutti i rischi dell'impresa croata (già evidenziati dal ritrovamento di carcasse di delfini e tartarughe lungo le coste italiane) e di lasciare tutti i vantaggi al governo di Zagabria; se si muove in ritardo rischia poi l'effetto “granita”, per cui chi succhia per primo dallo stesso giacimento mette in pancia la parte più nobile e ricca di idrocarburi. L’idea di uscire dall’angolo deferendo il vicino a un arbitrato internazionale non sfiora il governo. E non solo per le scarse possibilità di successo. Il fatto è che la contesa a largo di Chioggia, con le sue contraddizioni, potrebbe segnare il match point di una partita ultraventennale che vede contrapporsi, anno dopo anno, gli evocatori della nuova Dallas italiana e le associazioni di ambientalisti, pescatori e cittadini non arresi all’imperio del petrolio. Una tempesta perfetta in un bicchier d’acqua, vista l’estensione dell’area marina, che consentirebbe però ai primi di schiacciare le resistenze dei secondi sotto il peso di mirabolanti vantaggi economici. Prodi ricorda, ad esempio, che se l’Italia accelerasse su progetti e giacimenti già individuati “potrebbe produrre 22 milioni di tonnellate entro il 2020, con investimenti per 15 miliardi di euro e dare lavoro a decine di imprese”. Messaggio diretto anche a Palazzo Chigi: “Come i governi precedenti non sa dove trovare i soldi per fare fronte ai suoi molteplici impegni...”. E che fa il Governo? Al richiamo della sirena risponde subito Federica Guidi, ministro del Petrolio in pectore. “Non solo in Adriatico ma in diverse zone del Paese, spesso localizzate nelle regioni più svantaggiate del Mezzogiorno, abbiamo importanti giacimenti. Non capisco perché dovremmo precluderci la possibilità di utilizzarli, pur mettendo al primo posto la tutela dell’ambiente e della salute”, ha detto all’ultimo G7. Il governo ha dunque intenzione di dar seguito agli strampalati obiettivi della “Strategia energetica nazionale” che un dimissionario governo Monti ha lasciato in eredità, con l'indicazione di raddoppiare la produzione di idrocarburi nazionali entro il 2020, tornando ai livelli degli anni Novanta, e di portare il loro contributo al fabbisogno energetico dal 7 al 14 per cento. La leva individuata nella Sen per “liberare” questo potenziale imprigionato nella roccia è la stessa chiesta a gran voce dai petrolieri: accelerare e semplificare le procedure di rilascio dei titoli minerari. La risposta è un “nuovo modello di conferimento dei permessi che preveda un titolo abilitativo unico per esplorazione e produzione, con anche un termine ultimo per gli enti interessati dalle procedure di valutazione”, fanno sapere dal Mise. Una volta passato il termine, la decisione spetta solo al Consiglio dei Ministri (come previsto dal DL 83/2012). In pratica si ridimensiona, fino a estrometterli del tutto dai processi di valutazione, proprio quegli enti, territori e associazioni che negli ultimi 20 anni hanno dato battaglia contro la devastazione ambientale e accresciuto la sensibilità pubblica in tutto il Paese. Lo sblocco delle piattaforme “L’effetto sarebbe devastante”, spiega Giorgio Zampetti di Legambiente. In una manciata d’anni, dalla dorsale adriatica alle coste dell’Abruzzo, fino al tratto di mare tra Sicilia e Malta, si assisterebbe a un’epopea delle trivelle in mare che non ha precedenti. Alle 105 piattaforme e ai 366 pozzi attivi oggi nell’offshore italiano si aggiungerebbero quelli derivanti dallo sblocco di 44 istanze per permesso di ricerca e 9 istanze di coltivazione depositate dalle compagnie. Per non dire dell'effetto- calamita che una regolazione del settore ancor più favorevole ai produttori avrebbe sulla presentazione di ulteriori richieste. Senza scomodare gli scenari dei rischi e dei costi ambientali che tutto questo comporta tocca chiedersi: a che pro? Alessandro Giannì, direttore della campagne di Greenpeace, non ha dubbi. “Questa campagna per le perforazioni si basa su presupposti falsi. I nostri fondali marini non sono poi così ricchi di giacimenti, come si vuol far credere. Le riserve 36 certe ammontano a soli 10,3 milioni di tonnellate di petrolio che, ai consumi attuali, sarebbero sufficienti a coprire il fabbisogno nazionale per qualche mese. Alla luce di questo vorrei che qualcuno ci spiegasse che senso ha questa corsa al raddoppio delle produzioni che espone le nostre coste, soprattutto quando i consumi nazionali di idrocarburi sono in costante calo”. Obiezione cui ministero (e petrolieri) rispondono all’unisono: “Lo Stato avrà sempre valori delle riserve sottostimati se agli operatori non viene concessa la possibilità di condurre operazioni di accertamento e quantificazione delle potenzialità del sottosuolo”, replica Franco Terlizzese, capo della direzione per le risorse minerarie ed energetiche del Mise. “Anziché ragionare su come aumentare la produzione d'idrocarburi – insiste Zampetti – potremmo mettere in campo adeguate politiche di riduzione di combustibili fossili, a partire da settori arretrati come l’autotrasporto cui in 10 anni abbiamo regalato qualcosa come 4 miliardi tra buoni carburante, sgravi fiscali e bonus pedaggi autostradali. Basterebbe usare diversamente quei soldi per incentivare il trasporto merci su rotaia e ridurre senza sforzi la nostra bolletta petrolifera”. Ma su questi temi la “svolta buona” sembra lontana. Far consumare carburante in Italia - attraverso tasse, accise e Iva - resta il modo più comodo per ripagare buona parte della spesa corrente dello Stato. Il petrolio, a suo modo, è welfare. Rendere altrettanto profittevole l'oro blu richiederebbe ai decisori pubblici ben altro impegno. del 07/07/14, pag. 8 La gran balla della produzione “ecosostenibile” LE ESPLORAZIONI SONO SPACCIATE PER INNOCUE MA CAUSANO MORIA DI PESCI: LE TRIVELLAZIONI DISPERDONO GLI INQUINANTI, LE PIATTAFORME SONO BOMBE AD OROLOGERIA di S. Feltri e T. Mackinson Aben vedere qualcosa s'è mosso, anche nella parte italiana dell'alto Adriatico e sono le carcasse di delfini e tartarughe marine, a centinaia, trasportati un anno fa dalle correnti sulle spiagge italiane, dal Veneto alle Marche. Per i biologi cetacei e caretta sono stati uccisi dalle onde d'urto utilizzate per setacciare i fondali a caccia dei giacimenti di gas e petrolio che fan gola al governo dalmata (e ora pure a quello italiano). La prova autoptica se ce ne fosse bisogno - che il mito dell'esplorazione “pulita” è un falso, così come quello delle trivelle che non provocano danni all'ambiente. Un pozzo esplorativo “tipo”, per dire, scarica tra le 30 e le 120 tonnellate di sostanze tossiche nell'arco della sua (breve) vita, spiegano gli esperti che lavorano per Onu, Fao e Oms. Soprattutto fanghi sintetici utilizzati nelle ordinarie attività di trivellazione e produzione. E tuttavia la Strategia energetica nazionale, che punta al raddoppio della produzione di gas e petrolio entro il 2020, sembra non tenerne conto ed evoca una fantomatica “produzione sostenibile di idrocarburi”. I rischi dell’offshore Sono 105 le piattaforme di produzione disseminate lungo i 7.500 km di coste italiane. Da 67 pozzi di coltivazione estraggono 4,9 milioni di tonnellate di Olio e 6 Msm 3 di gas. Presto potrebbero essere molte di più. Ad oggi si contano 20 permessi di ricerca nei fondali cui si aggiungono 44 istanze di permesso di ricerca (6 in fase decisoria) e 6 di 37 prospezione in aree marine ancora libere da attività mineraria. Il governo punta sbloccarle per rilanciare l'offshore italiano, un'espressione che subito evoca i grandi disastri ambientali che hanno impressionato il mondo (British Petroleum, 2010 e Piper Halfa del '88). Per stare in casa nostra, l'incidente alla piattaforma Paguro (Agip) nel '65 che costò la vita a tre persone. Proprio un anno fa, l'affondamento della Perro Negro 6 (Saipem, Eni) durante le operazioni di posizionamento della piattaforma tra Angola e Congo. La sicurezza di questi giganti del mare è dunque un altro mito da sfatare. “Non è vero che gli incidenti sono rarissimi, sono invece numerosi”, spiegava il dirigente di ricerca dell'Ispra, Silvio Greco, a commento della tragedia messicana. “Negli ultimi vent'anni se conta uno all'anno. Può succedere anche da noi, solo che i nostri mari hanno un ricambio minimo, sono bacini chiusi, e l'impatto anche minore potrebbe essere devastante”. Il gigante malfermo Altri due esempi, recenti e nostrani, sul “trivellare senza rischi”. La Scarabeo 9 è l'unità di perforazione Saipem di ultima generazione che ha inaugurato l'attività estrattiva al largo di Cuba (in predicato di scavare il pozzo Vela 1 nel Canale di Sicilia, al largo di Licata). Ebbene durante il suo trasferimento da Yantai (Cina) a Singapore ha imbarcato acqua, “cosa che ha causato forzatamente lavori di riparazione e un'approfondita ispezione per assicurare la sua capacità di stare in mare”, racconta un rapporto sulla sicurezza citato da Greenpeace Italia (“I vizi di Eni”, 2013). Un'altra piattaforma, la Scarabeo 8, nel 2012 si è inclinata di 7 gradi perforando il campo “Salina” nel mare di Barents, in Norvegia. Senza conseguenze, ma ottenendo un ordine dell'autorità di controllo norvegesi di assicurare “la gestione dei processi in conformità con la salute, la sicurezza e l'ambiente”. Parole come pietre. Del resto, c'è chi ha apertamente messo in dubbio gli standard di sicurezza della flotta italiana. E dice di aver subito per questo pesanti rappresaglie, fino al licenziamento. Denunce zittite Due ex dirigenti Saipem, Gianni Franzoni e Giulio Melegari, hanno trovato sponda nel M5S e in particolare nel senatore Vito Petrocelli che ha portato la loro vicenda in Parlamento. Denunciano di essere stati allontanati dopo le loro denunce sulle procedure di sicurezza dentro Saipem (trasmesse anche all'ex ad Eni, Paolo Scaroni, una delle ragioni del licenziamento). Nelle rispettive cause di lavoro hanno presentato documenti a sostegno della tesi secondo cui “Saipem avrebbe eseguito operazioni navali, di perforazione petrolifera e lavori industriali in acque profonde, senza il personale idoneo, in violazione delle certificazioni emesse o addirittura senza i certificati necessari come richiesto dalla legge italiana e dalle normative internazionali”, come si legge nell'interrogazione del M5S. Tra i dettagli che sottolineano i due dirigenti: i mezzi Saipem battono bandiera delle Bahamas, dove si applica un codice marittimo che rende difficile perseguire i tecnici che fanno certificazioni di sicurezza disinvolte. “Le denunce non hanno avuto alcun impatto sul loro licenziamento”, replica l’azienda. “Le loro segnalazioni sono sempre state prese in seria considerazione e verificate con audit che hanno avuto esito negativo”. Ma Franzoni e Melegari non si arrendono, e il M5S continua a sostenerli. Ora il nuovo ad di Eni Claudio Descalzi pare intenzionato a mettere sul mercato una quota di Saipem, per fare cassa. 38 INFORMAZIONE del 07/07/14, pag. 1 Ai lettori Il conto alla rovescia per il nostro giornale è già partito: se entro fine luglio non arriverà un’offerta solida e credibile ai due liquidatori, non resterà che la chiusura per fallimento. Sarebbe un passo scellerato, tanto più nell’anno che celebra il novantesimo della testata. Domani presenteremo alla stampa e agli amici dell’Unità le ragioni dei lavoratori (appuntamento ore 12 in redazione, via Ostiense 131L), che continuano a denunciare e a battersi contro una serie infinita di scelte sbagliate e una gestione irresponsabile della società. Il nostro nemico è il tempo, il nostro incubo è il fallimento, ciò su cui possiamo contare è il sostegno dei lettori e di tante donne e uomini che lavorano, con generosità, alle Feste in corso in tante città italiane. Il loro appoggio ci dà coraggio e l’orgoglio di riaffermare che solo grazie all’impegno di giornalisti e poligrafici il giornale è ancora in edicola; lavoratori che da mesi non ricevono lo stipendio. Chi davvero vuole salvare la testata, non deve più limitarsi alle parole: deve spingere perché arrivi un’offerta seria e credibile che salvi l’azienda. Il tempo per studiare una soluzione c’è stato: ora bisogna agire. IL CDR 39 CULTURA E SCUOLA del 05/07/14, pag. 6 Soprintendenze, il parere a giudizio Paolo Berdini Beni culturali. I nulla osta o i veti di tutela saranno valutati da una apposita Commissione di garanzia. La Commissione cultura della Camera approva l’emendamento, un mostro giuridico con la scusa di «assicurare l’imparzialità» e «contenere la discrezionalità» La commissione Cultura della Camera dei deputati ha approvato un emendamento della maggioranza che di fatto cancella il ruolo delle Soprintendenze in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali. Si legge nell’emendamento che verrà istituita una commissione di riesame dei pareri di tutela espressi dai soprintendenti. La commissione lavorava alla conversione del decreto legge n. 83 del 31 maggio 2014, misure per la semplificazione e la trasparenza, l’imparzialità e il buon andamento dei pareri in materia di beni culturali e paesistici. L’emendamento all’articolo 12 recita che «al fine di assicurare l’imparzialità… I pareri di nulla osta possono essere riesaminati d’ufficio… da apposite commissioni…». Un inedito mostro giuridico. Nel suo illuminante articolo sulla deriva mercatista nel campo dei beni culturali apparso ieri su queste pagine, Adriano Prosperi citava lo scandalo del battistero di Firenze affittato alla maison Emilio Pucci. E proprio da Firenze è partito il virus che rischia di cancellare le ragioni della tutela che, come è noto a tutti meno che agli estensori dell’emendamento, è iscritta nei principi della nostra Costituzione. È nel capoluogo toscano infatti che l’allora sindaco Matteo Renzi ingaggiò un braccio di ferro con il soprintendente reo di aver negato l’uso di ponte Vecchio per una serata di gala della Ferrari. Il ponte è un bene culturale e perciò stesso, patrimonio di tutta la collettività: un luogo inadatto a far svolgere una festa privata. Apriti cielo. Renzi fece svolgere lo stesso la festa. Anche Ignazio Marino ha cancellato il prescritto parere negativo della soprintendenza per far svolgere il concerto dei Rolling Stones al Circo Massimo, nel cuore della città. Anche lui fece appello al rischio del tracollo economico del paese. Poveri replicanti del ben più incisivo presidente di Confindustria. Pochi giorni fa Squinzi ha tuonato contro la «burocrazia rea di sabotare la ripresa dell’Italia». Niente meno. Detto fatto, dall’ufficio studi di viale dell’Astronomia deve essere stato fatto recapitare l’emendamento che la maggioranza ha votato senza fiatare e senza capire. Squinzi dirige un’azienda che ha praticato la strada dell’innovazione di prodotto. Non può essere dunque accusato di appartenere alla classe dirigente che da decenni lucra sui ritardi strutturali dell’Italia. Ma sicuramente conosce molti suoi associati che non investono un euro e vivono di rendita finanziaria e immobiliare, le vere patologie che soffocano l’Italia. E la dimostrazione più solare sui motivi veri che causano il declino del paese viene proprio da uno dei tanti annunci del premier Renzi. Come si ricorderà, appena un mese fa aveva tuonato contro i ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche chiedendo ai sindaci di inviargli l’elenco delle opere che avrebbe inserito nello «Sblocca Italia». Il provvedimento ritarda perché l’elenco delle opere finora pervenuto è un clamoroso atto d’accusa contro la classe politica di cui Renzi fa parte. Solo alcuni esempi. Marino lamenta il mancato completamento del palazzo del nuoto di Calatrava. Costerà un miliardo per completarlo ma non è stato deciso dai burocrati, bensì da uno dai sindaci onnipotenti (Veltroni) che 40 pensavano di mettersi un fiore all’occhiello con i soldi di tutti. Ancora. La metro «C» di Roma: uno scempio senza fine che ha travolto tutti i pareri di tutela e sperperato miliardi di euro. Da Perugia si chiede il completamento della quadrilatero Umbria-Marche un’opera pubblica che ha devastato l’Appennino e che è ferma non per le tutele, ma perché hanno prosciugato irresponsabilmente le risorse. Si aspetta la segnalazione del Mose e della devastazione del lungomare di Salerno in atto per volontà del sindaco. L’elenco dell’incapacità amministrativa della politica potrebbe continuare. Per nasconderle è partita l’offensiva contro l’untore. Prima era la magistratura, oggi la tutela del paesaggio. Ma per quanto arroganti e dotati di una copertura mediatica che neppure Berlusconi poteva vantare, perderanno la partita. La tutela è sancita dalla Costituzione e non sarà la vandea dell’ignoranza a scardinarla. 41 ECONOMIA E LAVORO del 05/07/14, pag. 8 IL VERO SPRECO È QUELLO DEL CAPITALE UMANO: CHI HA PERSO IL LAVORO, I GIOVANI DISOCCUPATI Debito, crescita e occupazione: il flop dell’austerity Carlo Buttaroni Presidente Tecnè In un saggio del 2002, «Globalization and Its Discontents», l’economista e premio Nobel Joseph Stiglitz analizza le crisi finanziarie degli anni Novanta, mettendo in luce come le ricette imposte ai Paesi in crisi dalle istituzioni economiche internazionali (in particolare il Fondo Monetario Internazionale), fossero sempre basate sulla riduzione della spesa pubblica e su una politica monetaria deflazionista. Ricette che, peraltro, in tutti i casi si sono rivelate inefficaci o, addirittura, dannose per il superamento della recessione. Quello che sembra sempre più un «dibattito proibito», per riprendere il titolo di un felice libro di Jean-Paul Fitoussi, si rivela quindi non così nuovo, ed evidenzia come l’austerità messa a punto dai tecnocrati di Bruxelles sia un principio attivo del quale era stata già ampiamente dimostrata la tossicità per le economie nazionali. Ma tutte le critiche alle politiche economiche basate sull’austerità sono sempre state avvolte da una cortina di silenzio che ha visto complice la politica. Anche in Italia gli esempi sono innumerevoli e vanno dal «fiscal compact» alla follia del «pareggio di bilancio» in Costituzione. Esempi che dimostrano la subordinazione della sovranità politica agli indirizzi delle élite tecnocratiche europee, al mantra dei «sacrifici inevitabili» e della politica dei due tempi che si fonda sull’idea che per non diventare poveri nel futuro è meglio diventarci subito. La prova del «silenzio» che avvolge il dibattito intorno all’austerità è in un’opinione pubblica convinta che la crisi abbia origine nell’eccessivo debito pubblico, mentre la causa scatenante della crisi è nell’indebitamento privato e, per paradosso, anche nei salari troppo bassi dei lavoratori che hanno avuto progressivamente meno reddito per acquistare ciò che, invece, erano in grado di produrre in quantità sempre maggiore. Sembra inverosimile che intorno al portare avanti scelte di politica economica così dannose ci sia stata tanta perseverante determinazione, anche quando gli effetti collaterali si sono resi così evidenti da non richiedere alcun supplemento di riflessione. Nessuna delle premesse delle politiche dell’austerità si è realizzata: non la crescita del Pil, che si sta rilevando talmente lenta da far pensare a una fase di stagnazione; non l’occupazione, in continua diminuzione; non il debito pubblico, in inarrestabile ascesa. Basta vedere gli effetti sull’occupazione nel nostro Paese, diminuita di oltre un milione di unità dall’inizio della crisi. E con un rapporto tra popolazione e lavoratori come quello attuale, non c’è possibilità di uscire dalle acque basse in cui il Paese si è incagliato, perché manca la forza motrice. È questo lo spreco vero, di cui non si parla mai, irrecuperabile e intollerabile. Lo spreco del capitale umano, di chi ha perso il lavoro e, mese dopo mese, vede deteriorarsi le proprie competenze; quello dei tanti giovani che oggi non lavorano e che, se e quando lo troveranno, sarà a salari inferiori di quelli che percepivano coloro che li hanno preceduti, compromettendo qualsiasi aspirazione e progetto di vita. Questi sprechi sono superiori a qualsiasi debito che si possa immaginare 42 e non rappresentano solo il fallimento di una prospettiva individuale, ma il dissolvimento di un orizzonte pubblico. È questo il risultato dell’«austerità e precarietà espansiva» che ha agito in base alla teoria che dal contenimento dei deficit pubblici si liberassero risorse che il privato avrebbe utilizzato più efficacemente. Una teoria che non teneva in minimo conto del «vuoto di domanda» che l’arretramento del pubblico determinava sul mercato interno. Il risultato è stato, invece, che la minore domanda pubblica non è stata compensata da quella privata, facendo precipitare la domanda interna e lasciando l’onere della crescita a una domanda estera (non più trainante) che pesa meno del 20%, mentre il rimanente 80% è rappresentato dai consumi delle famiglie, dagli investimenti (privati e pubblici) e dai servizi collettivi. Il secondo pilastro delle follie tecnocratiche europee è stata la convinzione che l’aumento dell’occupazione potesse essere generata da un aumento della flessibilità del lavoro, sia contrattuale che retributiva. Anche in questo caso gli esiti sono stati quelli prevedibili: una sostituzione delle condizioni più che una creazione di lavoro, con conseguente riduzione di tutele e diritti, per chi li aveva conquistati nel passato e l’istituzionalizzazione della precarietà per chi si attendeva un miglioramento dello stato in cui era confinato. Col risultato, altrettanto prevedibile, che le retribuzioni nominali sono state compresse, le retribuzioni reali diminuite e i consumi delle famiglie conseguentemente ridotti, aggravando gli effetti negativi delle politiche di austerità sulla domanda interna. Non è un caso, quindi, che il problema principale dell’Italia, in questo momento, sia proprio la debolezza della «domanda interna». Così come non è uno strano scherzo del destino che la contrazione dei redditi abbia avuto come effetto un consistente calo dei consumi, considerando che a trovarsi con meno soldi da spendere sono state proprio quelle fasce di lavoratori che convertono in acquisti una percentuale proporzionalmente più elevata del proprio reddito. Gli effetti della compressione della domanda, inevitabilmente, hanno condizionato l’offerta. Basti pensare che il grado di utilizzo degli impianti delle imprese manifatturiere italiane oggi è soltanto al 72% del potenziale e dall’inizio della crisi l’industria ha perso quasi un milione di posti di lavoro. Se la domanda interna avesse, invece, stimolato un utilizzo al 100% degli impianti, l’effetto si sarebbe tradotto in un milione di occupati in più che, stimolando a loro volta la domanda, avrebbero alimentato nuova occupazione. Con la domanda che langue, invece, se anche il costo di un lavoratore fosse pari a zero, le imprese non avrebbero comunque alcun interesse ad assumere, perché le merci che quel lavoratore sarebbe in grado di produrre rimarrebbero chiuse nei magazzini o invendute sugli scaffali. E in queste condizioni, l’interesse dell’impresa non può essere che quello di sostituire un lavoratore che costa di più con uno che costa meno, ricevendo un vantaggio immediato in termini di costi di produzione, ma un danno sul lungo termine come capacità di crescita della domanda. E, soprattutto, in questo modo non ci può essere alcun vantaggio in termini di occupazione, vero ostacolo e, nel contempo, unica ricetta per una reale ripresa. del 07/07/14, pag. 1/5 Ue, non si gioca con le parole Lettere a Padoan Stefano Fassina Caro Pier Carlo, così non va. La tua intervista al Corriere della Sera è preoccupante. Confermi che, nonostante l'autorevolezza e la determinazione del Governo italiano, i 43 rapporti di forza politici e economici dominanti in Europa, espressi dalla granitica ideologia liberista alla quale parte della sinistra rimane culturalmente subalterna, bloccano la correzione dei difetti sistemici dell'euro-zona. E rendono impraticabile la virata necessaria per lo sviluppo sostenibile, il lavoro e la riduzione del debito pubblico. Ma non abbiamo più tempo per interventi al margine. La discussione sulla flessibilità nell’applicazione delle regole di finanza pubblica è surreale. Siamo passati dall’«austerità espansiva», un tempo celebrata da Alesina e Giavazzi e tanti altri ora in imbarazzato ripiegamento keynesiano, all'austerità «growth friendly», amica della crescita, suggerita della Commissione uscente, all’«austerità flessibile» indicata dal recente vertice di Bruxelles. Si gioca con le parole per nascondere i dati di realtà e le prospettive di fronte a noi. La realtà è la seguente: dopo quasi 7 anni di cure raccomandate dalla Commissione europea al seguito di alcuni paesi forti, la Germania in primis, e di potenti interessi economici, il Pil dell’Unione monetaria è ancora 3 punti percentuali al di sotto del 2007, vi sono 7 milioni di disoccupati in più e, dato sempre omesso dai racconti ufficiali, il debito pubblico medio è salito dal 65 al 95%. Le prospettive, data l’avvenuta distruzione di Pil potenziale e l’agenda da te ricordata, sono, come rivelano le misure non convenzionali decise dalla Bce, di stagnazione, elevata disoccupazione, sostanziale deflazione e di ristrutturazione dei debiti pubblici di tanti paesi tra cui l’Italia, curati direttamente o indirettamente dalla Troika. Inevitabilmente, di disintegrazione della moneta unica. Il selfie proposto a Strasburgo dal Presidente Renzi ci farebbe vedere un volto di disperazione, altro che di noia. In sintesi, lungo la rotta imposta da Berlino e ribadita a Bruxelles e Strasburgo, il Titanic Europa va a sbattere all’iceberg. La flessibilità, richiesta o temuta come rivoluzionaria, è sostanzialmente irrilevante: potrebbe rallentare la velocità di navigazione, ma l’impatto sarebbe solo rinviato. È necessario, invece, affrontare i nodi sistemici dell’euro-zona, insieme alle riforme interne da portare avanti con determinazione. Cosa sarebbe urgente fare? 1. Ampliare la prevista iniezione di liquidità da parte della Bce per portare rapidamente l’inflazione oltre il 2%; 2. Finanziare attraverso euro-project bonds programmi di investimento, innanzitutto in piccole opere; 3. Aumentare le retribuzioni sempre dietro alla produttività nei paesi in avanzo commerciale eccessivo, come la Germania, per sostenere la loro domanda interna; 4. Costruire un’efficace banking union, dopo l’accordo al ribasso della primavera scorsa, per liberare le principali banche europee dalla zavorra rimasta immutata dei crediti inesigibili; 5. Introdurre una soluzione cooperativa nell’eurozona per gestire i debiti pubblici oramai insostenibili; 6. Arrestare l’opaco negoziato per un’area di "libero" scambio transatlantica (Ttip) e aprire la discussione ai parlamenti nazionali. È un grave errore tentare di minimizzare i problemi a causa della difficoltà di costruire le condizioni politiche per le soluzioni. I problemi dell’euro-zona e dell’Unione europea vanno riconosciuti e affrontati con le soluzioni possibili sul piano politico. Altrimenti, i problemi esplodono e la politica rimane a guardare e viene, inevitabilmente, spazzata via dalla rabbia. Dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia la realtà. Lungo la rotta mercantilista germano-centrica, le riforme interne da fare con determinazione non evitano all’Italia la rottura del precario equilibrio di oggi. Tuttavia, la rottura può essere caotica oppure possiamo provare a governarla per ridurre i danni e costruire le basi per una ricollocazione della nostra economia. Purtroppo, è ora di un Piano B per l’Italia da mettere sui tavoli di Berlino, Bruxelles e Francoforte per affrontare debito pubblico e regime monetario. Continuare con la favola della primavera in arrivo, grazie alle mitiche riforme strutturali e qualche decimale in più di deficit per un paio di anni, è l’umiliazione finale della politica, oltre che la condanna per il lavoro e la democrazia. Saremo annoverati tra i «gufi». Pazienza. È già successo durante il Governo Monti di 44 andare controcorrente. Il nostro guaio vero sono gli innumerevoli struzzi che insistono a tenere la testa sotto la sabbia. Un abbraccio Ps: lasciamo stare la privatizzazione di ulteriori quote di aziende pubbliche. ENI, Enel, Finmeccanica, Poste, Fs sono tra le poche grandi aziende di qualità rimaste in Italia. Privatizzarle indebolirebbe le nostre potenzialità industriali, priverebbe il bilancio dello Stato di dividendi preziosi e, soprattutto, non avrebbe alcun effetto sostanziale sulla dinamica del nostro debito. del 07/07/14, pag. 15 Crescita, la sfida del New Deal europeo ●L’ELEZIONE DI JEAN-CLAUDE JUNCKER NELLA SESSIONE DEL PROSSIMO 15 LUGLIO A STRASBURGO NON SARÀ un atto dovuto ma farà parte di un processo che è iniziato – su proposta di Martin Schulz – con l’indicazione di sei candidati alla presidenza della Commissione europea da parte delle maggiori famiglie politiche europee (Ppe, Pse&D, Alde, Verdi, Gue) e terminerà con il voto di fiducia sull’intera Commissione, presumibilmente entro la fine di ottobre. Di questo processo fa parte la decisione del Consiglio europeo del 27 giugno di proporre Jean-Claude Juncker al Parlamento europeo, tenendo conto delle elezioni europee e in particolare del fatto che il gruppo del Ppe ha ottenuto la maggioranza relativa dei seggi nel nuovo parlamento (28%) pur perdendone una quota consistente, del profilo dei candidati (dal 1995 in poi la scelta è sempre caduta su un ex primo ministro) e infine del fatto che popolari, socialdemocratici, liberali, verdi e socialcomunisti hanno confermato il diritto dei popolari di rivendicare in prima battuta quella poltrona. Si è così deciso di dare un forte contenuto politico- parlamentare all’elezione del Presidente della Commissione. Il voto dell’Assemblea dovrà dunque essere fondato sulla formazione di una maggioranza favorevole non solo al nome del candidato proposto dal Consiglio europeo ma anche e soprattutto sul suo programma per la legislatura, sulla composizione della squadra con cui egli intende «governare», sulla coerenza fra squadra e priorità politiche che intende portare a compimento in cinque anni e infine sul suo impegno a invertire la tendenza degli ultimi cinque anni (di cui José Manuel Barroso è stato silenzioso complice) a trasferire poteri e competenze dall’area comunitaria (Commissione e Parlamento) all’area intergovernativa (Consiglio europeo). Per quanto riguarda il programma, è evidente che Jean-Claude Juncker non potrà presentarsi in aula limitandosi a leggere - come fa la Regina Elisabetta quando pronuncia il discorso della Corona - le priorità quinquennali scritte da Van Rompuy e dagli sherpa dei 28 governi (ancorché il Consiglio europeo abbia proclamato con arroganza che «istituzioni europee e Stati membri sono tenuti ad applicarle» e che esso «ne monitorerà regolarmente il rispetto») o inchinandosi davanti al diktat rigorista del Ppe e del suo capo- gruppo Weber. Dal dibattito sulle priorità della presidenza italiana del 2 luglio è emersa una variegata volontà maggioritaria di uscire dal lungo periodo in cui ha prevalso il sillogismo «rigore= crescita» ed entrare in una nuova fase che unisca flessibilità e gradualismo nelle politiche nazionali a un «New Deal europeo» fondato nello stesso tempo su una diversa politica economica e su una genuina democrazia europea. Per quanto riguarda la composizione della squadra, è evidente che a essa non potranno appartenere commissari i cui gruppi politici o partiti voteranno contro Juncker (il conservatore britannico di Cameron e il popolare ungherese di Orban dovranno restare a casa) e che i «portafogli » dovranno 45 essere distribuiti secondo una rigorosa logica europea. Gettando alle ortiche il metodo «Barroso» - che ha spappolato per anni le competenze dell’energia, dell’ambiente e del cambiamento climatico fra tre commissari diversi o giustizia, affari interni e diritti fondamentali fra due commissarie, ha confidato a un unico commissario l’allargamento, le relazioni con il Mediterraneo e la politica di vicinato verso l’Est - bisognerà rilanciare il metodo Prodi che aveva creato nel 1999 gruppi omogenei di commissari e riprendere l’idea - recentemente ricordata da Albero Quadrio Curzio - di «cluster» coordinati da commissari- senior con commissari-junior trovando una soluzione pragmatica al pasticcio giuridico-diplomatico creato nel 2009 dal Consiglio europeo con la decisione di mantenere una Commissione con un membro per Paese. In questo spirito, sarebbe ad esempio essenziale unire in «cluster» energia, ambiente e lotta al cambiamento climatico: industria, innovazione e ricerca; dimensione sociale, cultura e formazione; cittadinanza, affari interni, giustizia e libertà; affari economici e monetari, bilancio e politica fiscale; coesione territoriale e orientamento rurale; tutte le relazioni esterne che il Trattato di Lisbona ha sconsideratamente allontanato le une dalle altre. Sarebbe illogico e inefficace, in questo spirito, dare seguito all’idea - attribuita a Junckerdi avere un commissario all’immigrazione, che non disporrebbe né dei mezzi, né delle competenze né degli strumenti di governance per affrontare il dramma dei flussi di persone che cercano in Europa asilo, rifugio e rispetto della dignità umana fuggendo da terre in cui le guerre o il degrado ambientale e socio-economico impediscono questo rispetto. Ci vuole un cluster con un commissario-senior che abbia i poteri di trattare con i Paesi terzi, gli strumenti per creare corridoi umanitari che inizino nei consolati e nelle ambasciate dei Paesi membri in stretta cooperazione con le delegazioni dell’Unione europea e terminino in Europa applicando il principio del mutuo riconoscimento del diritto di asilo; i mezzi per gestire e rafforzare Frontex; la competenza per controllare il rispetto dei diritti essenziali dei cittadini di Paesi terzi sul territorio dell’Unione. Pensiamo che Jean-Claude Juncker – o a chi sarà il prossimo presidente della Commissione europea – dovrebbe attribuire a una personalità con esperienza europea e internazionale, rete di conoscenze e umana sensibilità il coordinamento di questo cluster. del 07/07/14, pag. 13 Lavoro Madri e operaie: i diritti ottenuti a caro prezzo «SENZA GIUSTA CAUSA» CI RIPORTA NELLA BOLOGNA DEGLI ANNI 50. QUANDO MILITARE NEL SINDACATO O NEL PCI E DIFFONDERE L’UNITA’ COSTAVA IL POSTO Andrea Bonzi Rosa fu licenziata perché, «dopo settimane di lavoro senza riposo, chiesi di poter rimanere a casa al mattino perché dovevo studiare». Bruna ricorda come il padrone «ci facesse lavorare fino alle dieci di sera senza pause. Faceva in modo di avere un magazzino bello pieno e poi, dopo due o tre mesi, ci licenziava ». E quando fu cacciata Teresa pianse, perché, nonostante tutto «alla Sasib volevo bene. A me, che ho fatto la quinta elementare la fabbrica mi ha insegnato come se fossi andata all’Università, a muovere le mani, a lavorare, a ragionare, a ponderare le cose». Racconti forti, quelli delle donne licenziate per 46 rappresaglia politico-sindacale negli anni ’50 a Bologna, uno dei cuori manifatturieri dell’Italia di quegli anni, raccolti nel volume Senza giusta causa di Eloisa Betti e Elisa Giovannetti uscito per i tipi dell’Editrice Socialmente con il sostegno della Camera del lavoro del capoluogo emiliano- romagnolo e dell’Unione donne italiane (Udi). Storie attuali oggi una volta di più, a pochi giorni dai numeri diffusi dall’Istat sullo “sprofondo rosa” della disoccupazione femminile, che ha sfiorato il picco del 14%. Vicende che – seppur a distanza di sei decadi - ci fanno capire come, nel mondo del lavoro spesso a pagare siano le donne, le madri, le lavoratrici. ALMENO 15.000 LICENZIATI PER RAPPRESAGLIA Sul territorio nazionale i licenziati per rappresaglia – ovvero perché sostenitori del Partito comunista o attivisti nel sindacato – furono oltre 15.000. Questo è il numero dei lavoratori che videro riconosciuto questo status,ma le domande pervenute dall’introduzione della legge nel 1974 furono almeno il doppio. Dunque non è facile capire quanti furono colpiti da questa discriminazione, ma alcune ricerche ipotizzano che la sorte di perdere il lavoro per aver sostenuto le proprie idee toccò almeno a 40.000 italiani e italiane. Erano tempi in cui le autorità cercavano di negare il permesso alle Feste de l’Unità e di ostacolare le attività delle Case del popolo e dei Cral, i Centri ricreativi per lavoratori. Si tennero processi per gli operai che raccoglievano firme e vendevano l’Unità (nella sola Bologna tra 1948 e 1954 furono 657), per chi partecipava a incontri politici (331 sempre nel capoluogo emiliano nello stesso periodo), infine per chi – la maggioranza, oltre 2.000 – si era reso colpevole di reati di parola, opinione e propaganda. E le donne? Si calcola che le licenziate per rappresaglia fossero almeno il 16% di quanti avevano fatto domanda,ma è difficile avere una quantificazione più precisa. In particolare, a Bologna, ricordano le autrici, «le donne avevano un ruolo nella sfera pubblica e produttiva senza eguali», e dunque nel secondo Dopoguerra cominciarono a rivendicare il lavoro non solo come mezzo di sostentamento, bensì come diritto in quanto tale e strumento per la stessa emancipazione della condizione di sudditanza sociale”. Un diritto, per la verità, ostacolato in primis dalle istituzioni con provvedimenti discriminatori che davano, di fatto, la possibilità di licenziare le donne e ne decretavano l’espulsione da settori a gestione statale come le Ferrovie. Le motivazioni erano paradossali: oltre a ribadire il ruolo “essenziale” delle madri in famiglia, si aggiungeva la convinzione che espellendo le donne dalla produzione si sarebbe potuto risolvere facilmente il problema della disoccupazione. A Bologna su 1.900 licenziati per rappresaglia riconosciuti, 690 furono donne, quasi tutte cacciate tra 1948 e 1955, ricorda lo storiografo Luigi Arbizzani. Sempre numeri ufficiali, sempre in difetto. Tra i nomi delle fabbriche in cui si svilupparono le vertenze più dure figurano marchi noti, dalla Sasib alla Fonderia Calzoni, dalla Hatù alla Maccaferri, dalla Weber alla Giordani. Prendiamo la Ducati: durante la Seconda guerra mondiale quattro dipendenti su cinque erano donne. Negli anni successivi, la forza lavoro verrà ridotta dai 2.900 addetti del 1948 ai 2.212 dell’aprile 1953. In mezzo, una lotta durissima, fatta propria dalla popolazione e dalle istituzioni bolognesi con iniziative di solidarietà (i contadini portavano il grano e la farina alle famiglie degli operai), e in cui le donne furono in prima linea, scioperando, distribuendo volantini, facendo picchetti. Venendo anche manganellate, la polizia non faceva complimenti. Solo una piccola parte dei licenziamenti fu fermata: essere mandata via «fu triste - spiega Jole - perché avevo sulle spalle la mia famiglia: mia mamma e mia sorella piccola. Rimanere a casa dal lavoro era dura ». Da Maria, una sua ex collega, una riflessione sull’importanza del sindacato: «Dopo abbiamo lavorato in altre fabbriche, ma non era come alla Ducati. Là c’era il sindacato; con i “piccoli” lavorare a testa bassa oppure via». Il rispetto dei diritti delle lavoratrici-madri, peraltro stabiliti da una legge del 1950, era spesso una chimera. E non può non far pensare a quello che succede ancora oggi, con le dipendenti costrette a firmare dimissioni in bianco. Ecco la testimonianza di 47 Laura, che lavorava alla Sasib. «Il giorno del ricevimento della lettera di licenziamento ero incinta di 15 giorni – scrive la lavoratrice -. Non potevano licenziarmi. Io gli ho dato la documentazione e loro mi hanno mandato dal medico per il controllo. Però non mi hanno più fatto entrare, allora io tutte le settimane, il lunedì, mi presentavo. Mi vedevano,mi salutavano e io tornavo indietro. La pancia cresceva, e ritiravo tutti i mesi lo stipendio». Il giorno della nascita del figlio, scattò il licenziamento. E tanti saluti. IN CERCA DI UN FUTURO Dopo l’espulsione dalle fabbriche i destini prendevano strade diverse. Jole, ad esempio, dopo la Ducati, «dove facevo condensatori che erano una finezza », andava «da una signora che realizzava le ciabatte a casa» e sbrigava le faccende di casa dalla sorella, senza dimenticare il proprio bambino. Bruna, per vent’anni, ha fatto la camiciaia in negozio del centro storico di Bologna,ma«senza libretto e senza contributi». Teresa e Laura hanno invece trovato un posto: la prima alla Omas stilografiche, ma solo dopo aver tantzighè (cioè, «tanto pianto » in dialetto) per la perdita del lavoro alla Sasib; la seconda «a fare le caramelle dai fratelli Toschi, fuori Mazzini». Ma non era facile riciclarsi, come non lo è oggi, per i tanti over 50 troppo giovani per andare in pensione, troppo vecchi per essere appetibili alle società in cerca di agevolazioni fiscali. Adriana Lodi, classe 1933, sindacalista, che come assessore nel 1969 aprì il primo nido pubblico inaugurando un’era, esemplifica così: «Le donne pagavano di più perché, non essendo mano d’opera qualificata, avevano più difficoltà a trovare un’altra occupazione. Non che per gli uomini fosse facile, intendiamoci…». A chiudere il testo una postfazione di Susanna Camusso, numero uno della Cgil nazionale. «La repressione, i licenziamenti, furono, come spesso viene chiamato, l’emblema della Costituzione negata nei luoghi di lavoro – tira le fila la leader del sindacato -. Negata perché veniva negato il fondamento di libertà, di uguaglianza e di pari dignità fra uomo e donna. Ma la Costituzione continuerà ad essere negata se il lavoro seguiterà ad essere pensato al maschile al punto da non leggere e vedere le discriminazioni». Del 07/07/2014, pag. 8 L’Italia ha speso 7 miliardi e mezzo in corsi di cui non si conoscono né costi né benefici Inclusione sociale, solo 233 nuovi impieghi contro i 3050 mila di Germania e Francia Lo scandalo dei fondi europei 500 mila progetti di formazione non sono serviti a creare lavoro VALENTINA CONTE ROMA Una montagna di miliardi, sfuggita di mano. Ogni anno l’Italia spende cifre impressionanti in progetti finanziati con fondi strutturali europei, eppure nessuno è in grado di valutarne gli effetti. Se ad esempio favoriscono davvero l’inclusione sociale, se creano nuova occupazione e se questa è strutturale e come viene retribuita. Anzi, va persino peggio. Non solo non conosciamo l’efficacia della spesa, ma ogni euro di fondi ricevuti ce ne costa due in tasse: uno da versare all’Europa come membri dell’Unione e un altro come cofinanziamento, obbligatorio per utilizzare quei fondi. Eppure, nonostante il clamoroso black-out informativo, in cinque anni sono stati messi in campo ben 504 mila progetti di formazione, per una spesa di quasi 7 miliardi e mezzo. Con quali benefici? La risposta 48 dello studio curato dagli economisti Roberto Perotti e Filippo Teoldi e pubblicato sul sito lavoce. info è una sola: i benefici sono ignoti. «Nessuno riesce a districarsi tra piani europei, nazionali e regionali », osserva Perotti, docente alla Bocconi e in passato consigliere economico di Renzi. «Centinaia di documenti stilati per fissare obiettivi che nessuno rispetta. E i soldi diventano una mangiatoia pazzesca per sindacati, assessorati regionali e provinciali ». La soluzione per Perotti è una sola: «Non diamo più soldi a Bruxelles, così non rischiamo di vederli finire nelle mani dei maestri dello spreco, in un sottobosco politico parassitario ». La tesi è ardita, ma suffragata dai numeri dello studio dal titolo “Il disastro dei fondi strutturali europei”. Nel 2012 l’Italia ha versato 16,5 miliardi come contributi alla Ue e ne ha ricevuti in cambio solo 11, di cui 2,9 di fondi strutturali, tra Fse (per formazione, sussidi al lavoro, inclusione sociale) e Fesr (sussidi alle imprese e infrastrutture). Questi fondi per essere spesi devono essere “doppiati” tramite il cofinanziamento, dunque denari italiani. «Ottima idea, per coinvolgere il beneficiario. Ma se prendiamo il solo Fse, appena il 4% del finanziamento totale viene dalle Regioni (quasi niente dalle Province), il resto è finanziato in parti uguali da Stato italiano e Ue». I soldi di questo fondo dunque «sono completamente gratuiti per i soggetti che poi attuano il progetto, cioè Regioni e Province». Di qui la prima stortura. «Lo scopo del cofinanziamento è completamente negato». Lo studio passa poi ad esaminare la spesa per i progetti di formazione, che rappresentano la quasi totalità dei progetti dell’Fse (504 mila su 668 mila). Nel periodo 2007-2012 (dati Open-Coesione) ben 7,4 miliardi su 13,5 sono stati impiegati qui. La valutazione di questi corsi è «un’industria che non conosce crisi» e tiene in vita «decine di centri di ricerca» che hanno prodotto tra 2007 e 2011 ben 280 documenti di valutazione, per la stragrande maggioranza «inutili, un sottobosco nel sottobosco ». Poiché nessuno è davvero in grado di raccontare l’efficacia dei corsi. Le variabili di solito citate sono la percentuale di soldi spesi e il tasso di occupazione. Ma la prima non è per forza indice di successo: si possono spendere molti soldi in progetti inutili o dannosi. E la seconda spesso è effetto della congiuntura, se non si riesce a misurare i posti di lavoro che davvero i corsi di formazione e gli stage favoriscono. Il confronto europeo è poi agghiacciante. Se l’Italia tra 2007 e 2013 ha offerto corsi a 21 mila persone, la Francia aveva 254 mila iscritti e la Germania 208 mila (dati del network di esperti sulla spesa dell’Fse per l’inclusione sociale). Ebbene, tra quelli che hanno completato le attività (appena 233 italiani, contro 50 mila francesi e 32 mila tedeschi), solo il 14% risultava poi occupato in Italia, contro l’85% della Francia e il 35% della Germania. Ma, aggiunge lo studio, «è possibile che i partecipanti italiani abbiano ricevuto servizi non finalizzati a trovare un posto di lavoro». Ma allora a che cosa servono questi corsi? La Commissione europea, lo scorso marzo, sosteneva che grazie ai fondi Ue in Italia sono stati creati tra 2007 e 2013 più di 47 mila posti, 3.700 nuove imprese, banda larga estesa a più di 940 mila persone, sostegno per 26 mila pmi, 1.500 chilometri di ferrovie e progetti di depurazione delle acque. La Corte dei Conti però, in febbraio, diceva che dal 2003 ad oggi gli “eurofurti” (frodi, imprenditori fasulli, finti progetti, costi gonfiati, incarichi irregolari) hanno raggiunto la cifra record di un miliardo e 200 milioni. Solo nel 2012 ne sono stati scovati 344 milioni (al top la Sicilia con 148 milioni finiti nelle tasche sbagliate, vedi il caso del deputato pd Genovese che secondo le accuse in cinque anni avrebbe lucrato ben 6 milioni di euro di fondi europei destinati proprio alla formazione professionale). Nel 2013 poi la Guardia di Finanza ne ha recuperati altri 228 di milioni. Arrivati come fondi strutturali, poi finiti nelle tasche del malaffare. E certo non usati per creare posti o crescita. 49
Scaricare