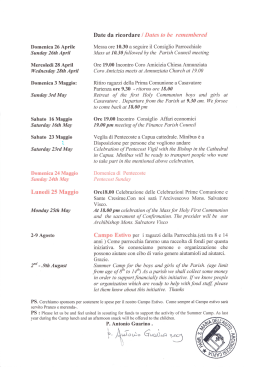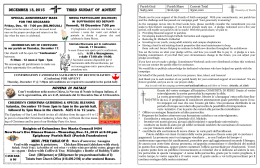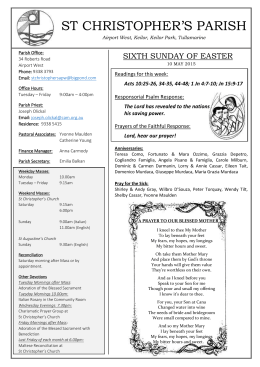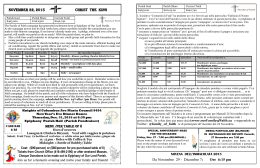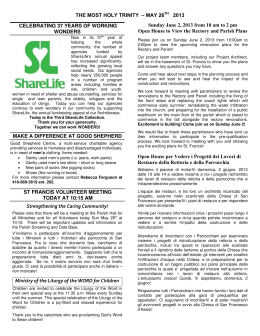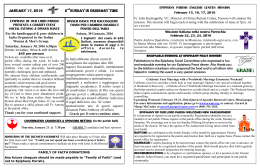LADOMENICA DOMENICA 16 OTTOBRE 2011 NUMERO 348 DIREPUBBLICA CULT All’interno La copertina L’artista scende in campo Ecco le star dell’impegno BIZIO, CERCAS E TOBAGI Viaggio negli archivi del teatro a pochi giorni dalla riapertura Frasi, disegni, caricature Gli spartiti ritrovati raccontano la storia dell’Urss Il libro Moto e amicizie così Grossi narra l’incanto della giovinezza DARIA GALATERIA L’intervista Terry Eagleton “Il mio saggio sulla nostra felicità da jazz band” RAFFAELLA DE SANTIS Spettacoli Ingegner Vian, le canzoni mai cantate ANAIS GINORI e BORIS VIAN L’incontro Sofia Coppola, “Non sono più una figlia di papà” MARIO SERENELLINI FOTO PETER TURNLEY/CORBIS I fantasmi del Bolshoi DANIELE MASTROGIACOMO I NICOLA LOMBARDOZZI MOSCA l tempo l’ha ingiallita. Rischia di sfaldarsi come una pergamena. Gli angoli sono consumati; soprattutto quello destro, in basso, levigato da migliaia di dita che durante i concerti seguivano gli accordi sul pentagramma. Boris sfiora quel pezzo di carta. La musica invade la stanza mentre l’indice affusolato dell’archivista scorre le note. Si ferma sul margine e indica una parola scritta a mano, in stampatello. Un tratto di matita, il commento lapidario dell’autrice: «1923, vediamo solo orrore». Al secondo piano di un palazzo color ocra, dietro piazza Teatralnaya, nel cuore di Mosca, c’è l’archivio storico di quello che è considerato il tempio del balletto e della musica classica. Il Bolshoi, “grande” in russo, dopo sette anni di restauri il 28 ottobre riaprirà i battenti. Ma è in questo immobile separato, l’Operetta, che si nasconde un segreto conservato da quasi due secoli. (segue nelle pagine successive) S MOSCA u una panchina che dà le spalle alla statua di Karl Marx, nel centro di piazza Teatralnaya, Alesja Shuzhiraskaja, splendida pensionata di quarantasette anni, guarda gli operai che danno gli ultimi ritocchi al Bolshoi. Il racconto viene fuori da solo. Senza pause, e con gli occhi un po’ lucidi. «Più che gli applausi, ricordo i funghi e le patate che ci portavamo in giro per il mondo negli anni Settanta e Ottanta. Eravamo proprio delle strane star io e le altre ballerine di prima fila. Gli americani, i francesi, tutti, impazzivano per noi. I nostri politici erano fieri del nostro mito esportato in Occidente. Eravamo la vetrina della macchina invincibile dell’Unione Sovietica. Sorridevamo con quell’aria di leggera supponenza che copiavamo dalle foto dei divi di Hollywood. Poi trasformavamo le nostre suite in un campeggio e tiravamo fuori dalle valigie in similpelle quello che ci eravamo portate». (segue nelle pagine successive) La mostra Arrivano gli indiani, l’arte glocal di una nazione ACHILLE BONITO OLIVA Il teatro La Biennale dove si mette in scena la realtà ANNA BANDETTINI Repubblica Nazionale DOMENICA 16 OTTOBRE 2011 LA DOMENICA ■ 28 La copertina Fantasmi di carta “1923, solo orrore” scriveva in stampatello su un pentagramma l’étoile Anastasia Abramova Dagli archivi del celebre teatro, a pochi giorni dalla riapertura, spuntano i vecchi spartiti su cui artisti noti e meno noti appuntavano i grandi e i piccoli fatti della storia CARICATURE A sinistra la caricatura di un suonatore di corno inglese e alcuni appunti su personaggi legati al Kgb; qui sopra la disperata voglia di una sigaretta durante le prove esorcizzata con un disegno e una scritta: “Fumare!” Bolshoi Sulle note ritrovate la vita ai tempi dell’Urss DANIELE MASTROGIACOMO (segue dalla copertina) un diario, raccolto in trentamila fascicoli, dove compositori, direttori, orchestrali, adattatori e scenografi raccontano lo spirito del tempo, gli avvenimenti che hanno scandito la storia di tutte le Russie. Parole, frasi, poesie, disegni, caricature, bozzetti. A volte semplici schizzi; altre interi affreschi. La scoperta è avvenuta per caso. Per procedere alla digitalizzazione dei ventiduemila spartiti conservati al Bolshoi, una squadra di archivisti ha dovuto sfogliare ogni singolo foglio, fotografarlo e immetterlo su file elettronici. Boris Mukosey, Aleshia Bobrik e Sergei Konayev, tutti sulla trentina, accettano È di incontrarci e ci spiegano la loro avventura. Mentre ordinavano con delicatezza questi reperti ammassati su alte pile e sommersi dalla polvere, hanno cominciato a notare degli appunti a margine degli spartiti. «Sulle prime», ricorda Boris, «abbiamo pensato a delle correzioni. Molte delle scritte, infatti, riportano annotazioni tecniche. Poi ci siamo resi conto che c’era molto di più». Sulle opere di Boito, Masetti, Rossini, Verdi, Chopin appaiono brevi commenti, battute, riflessioni filosofiche, giudizi politici; anche semplici saluti ai colleghi che in altri teatri di altre città prima o poi si sarebbero ritrovati tra le mani gli stessi spartiti. «Sono testimonianze uniche», si appassiona Sergei, «piccoli frammenti di storia. Alcune parole sono in latino, altre in cirillico, altre ancora in francese, in tedesco. Ma la maggioranza sono in italia- no». «Gli spartiti», aggiunge Aleshia, «venivano fotocopiati dal direttore e distribuiti a tutti gli orchestrali. Questi stavano la maggior parte del loro tempo chiusi nella fossa a provare e riprovare i pezzi per decine di volte». «Probabilmente si annoiavano», suggerisce Boris, «restare seduti per ore, aspettando il proprio turno, concedendosi ogni tanto delle pause, tutto ciò li spingeva a scarabocchiare sullo spartito che avevano davanti. Ma c’era anche chi su quei fogli lanciava messaggi, descriveva quello che stava avvenendo. Confermava o smentiva gli effetti di certi sconvolgimenti politici che hanno segnato la storia del nostro Paese». L “orrore” scritto in stampatello è un commento di Anastasia Abramova, famosissima ballerina degli anni Venti. «Si riferiva», spiega Boris, «a quanto stava accadendo dopo la rivoluzione bolscevica». Non è stato facile legare le frasi e i disegni ai singoli musicisti o ballerini. Ma lo studio comparativo consente di descrivere anche le caratteristiche degli orchestrali. Gli addetti agli archi erano più razionali e pragmatici. «I loro spartiti sono pieni di numeri», racconta Aleshia. «Forse avevano meno tempo: i violinisti devono intervenire più spesso nel concerto e questo li obbligava a scrivere cose semplici. La maggior parte calcolava quanto avrebbe dovuto percepire a fine settimana. Molti si perdevano nei conti». Gli addetti agli ottoni, agli strumenti a fiato, avevano molto più tempo e largheggiavano in disegni. In alcuni spartiti ci sono quasi degli affreschi colorati. In altri interi sonetti. In altri ancora caricature di colleghi colti in posizioni strane mentre si concentrano durante le prove. «È un vero diario CONTI Da sinistra, i conti sui giorni mancanti alla consegna della busta paga accanto a un ritratto femminile; appunti del 1892 sulle prove SCHERZI A destra, la presa in giro di un suonatore di fagotto: “A diciott’anni era così, oggi è così”. In basso, ballerine del Bolshoi dietro le quinte Repubblica Nazionale DOMENICA 16 OTTOBRE 2011 ■ 29 PACE FIDEL Ballerina prima dello spettacolo Sotto, caricature su pentagramma e una scritta in italiano: “pace pace” Fidel Castro, Nikita Kruscev e Emilio Aragones Navarro a un balletto del Bolshoi il 1° maggio del 1963 STALIN Tra le scritte e gli scarabocchi su un pentagramma compare la frase: “5/III/1953. Il grande Stalin è morto”. Qualcuno ha cancellato la parola “grande”. Nella foto accanto, il dittatore al Bolshoi in occasione del suo settantesimo compleanno AMERICANO A destra, una delle stelle del teatro moscovita: Mikhail Baryshnikov Qui la sua interpretazione nel Lago dei cigni, al Bolshoi, nel 1983. Tre anni più tardi il celebre ballerino sceglierà di diventare cittadino americano La ballerina “Il mondo ci applaudiva, noi sognavamo le Barbie” NICOLA LOMBARDOZZI (segue dalla copertina) etrioli e salsicce sfuggiti ai controlli con la complicità degli equipaggi dell’Aeroflot. L’importante era non spendere un centesimo dei 15 dollari giornalieri di diaria per ogni tournée. E investire tutto nell’unica cosa che contava: regali per gli amici, jeans, profumi, qualche disco proibito dei Beatles, cioccolato. All’inizio era un gioco. Poi cominciai a organizzarmi. Un po’ di risparmi nascosti nella biancheria. Un capitale per comprare merce da rivendere o regalare a Mosca in cambio di piccoli favori indispensabili: l’inserimento nella cooperativa che costruiva nuove case, una fornitura di elettrodomestici rarissimi, un salto in avanti nella lista d’attesa per una Zhigulì. Ma non crediate che ci sentissimo inferiori a nessuno. Io, ero orgogliosa di essere una protagonista nel corpo di ballo più famoso del mondo. Non una stella di prima grandezza come Ekaterina Maksimova, per intenderci, ma neanche l’ultima arrivata. I giornali sovietici dicevano che chiunque di noi avrebbe potuto essere la prima donna in qualsiasi teatro occidentale. E forse avevano ragione. Ero fiera della qualità della nostra danza. E, lasciatemelo dire, grata al sistema per essere diventata quello che ero. Nei primi anni Settanta non era come adesso che danza chi vuole danzare. Perché ha i soldi o perché lo vogliono i genitori. C’era una ricerca scientifica dei talenti come del resto avveniva per gli atleti. A otto anni fui obbligata come tutte le bambine a fare delle prove a scuola. Poi mi ordinarono di fare un altro test davanti a Jurij Grigorovich, il più grande coreografo di tutti i tempi. Ma figuratevi, mia madre era ingegnere, niente di più lontano dall’arte. Io stessa eseguivo gli esercizi per puro dovere, come facevo quelli di matematica o di grammatica. Ma la selezione era implacabile. Fui assegnata alla scuola del Bolshoi. E non ci fu discussione. Arrivarono richieste anche da altri celebri teatri, dallo Stanislavskij per esempio, ma ero stata giudicata da Bolshoi e fu detto loro di non insistere. Avevo un talento, anche se non lo sapevo, e dovevo metterlo al servizio della Patria. «C In cambio ho imparato un’arte che adesso non si insegna più. Alla corte di Marina Timofeevna Semionova, un mito per chi conosce un po’ di storia della danza. Niente super allenamenti, niente ossessione perfezionistica, non fidatevi dei luoghi comuni. Studiavamo danza ma anche recitazione e pianoforte. E sapete in cosa consisteva la nostra superiorità? Nell’anima. Adesso vince il modello occidentale, spettacolare, potente. Si strappa l’ovazione con il salto più in alto, con le piroette più difficili. L’arte però è un’altra cosa. Non puoi ballare Ciaikovskij come fosse Ravel e viceversa. Devi entrare nel ruolo, sentire la musica, metterci il cuore. E non era solo arte. Il prestigio sociale era immenso. Ricchi no, guadagnavamo anche meno degli operai. Ma quanti privilegi. Vi dico solo una cosa. Mi davano due biglietti omaggio per ogni rappresentazione. Il prezzo era alto ma soprattutto le code infinite. Quei tagliandi erano oro puro. Con soli quattro biglietti regalati a ginecologo e ostetrica ho rimediato un trattamento da regina per il mio primo parto. Con meno di una decina, ho ricevuto per mesi forniture alimentari introvabili al bancone dei negozi. Certo, c’era anche il rovescio della medaglia. A cominciare dall’indottrinamento politico. Penso a quelle lezioni alle otto di mattina, quando avevamo finito uno spettacolo la sera prima a mezzanotte. Tutti assonnati, docente compreso, fingevamo di occuparci del socialismo e dei suoi obiettivi. Una farsa, ma si doveva fare. E prima di ogni tournée, quanti interrogatori e raccomandazioni. Erano terrorizzati dalle fughe. Un omino del Kgb ci seguiva ovunque. Implorava, poveretto: non fuggite, non stavolta che ci sono io, sarei rovinato. Ma per fuggire ci voleva coraggio, motivazione politica. Io stavo bene. Non ho mai visto l’Occidente come il Paradiso in terra. Piuttosto un sogno che mi capitava di vivere spesso. Ricordo il mio primo viaggio, a New York, da allieva, nel ’74. Avevo dodici anni. Impazzii per le Barbie. Mai visto bambole così. Ne comprai tre. E non vedevo l’ora di tornare dalle mie amiche a Mosca. Io, la piccola ballerina del Bolshoi. Quella con le Barbie». © RIPRODUZIONE RISERVATA di quanto accadeva sulla scena e nella vita di tutti i giorni. Tenuto spesso con grande umorismo e con un vero talento artistico». Su alcuni spartiti ci sono anche disegni all’epoca piuttosto rischiosi, come le ballerine nude in posizioni erotiche disegnate su un Rigoletto. L’archivio originale era molto più vasto di quello attuale. I tre incendi che nell’Ottocento aggredirono il teatro hanno distrutto la metà degli spartiti. Si sono salvati, per fortuna, i più famosi, spesso donati al teatro dagli stessi compositori e per questo ancora più pregiati. Nascosti tra gli scaffali di questa piccola stanza rimasta a lungo chiusa e isolata, hanno resistito ai momenti più difficili, la campagna di Napoleone, la caduta degli zar, la rivoluzione d’Ottobre, due guerre mondiali, gli assedi delle truppe di Hitler. Oggi quegli spartiti restano i testimoni di una lunga storia. «Il grande Stalin è morto», annuncia nel 1953 una mano anonima in fondo a un pentagramma. Mentre un’altra cancella, con un graffio nervoso, quel «grande». «Suoniamo con 5 gradi», ricorda uno spartito del compositore Carl Maria Von Weber nel 1940. «Alcune persone hanno il naso congelato». Fino a commenti più allarmati che rievocano il terrore della polizia segreta, l’allora Kgb: «Sembra che siano venuti per Tatiana», appunta nel 1968 un violinista durante le prove dell’Eugenio Onegin, romanzo in versi di Puskin arrangiato dal grande Ciaikovskij. I tre archivisti sorridono. «L’autore voleva dire un’altra cosa», suggeriscono. «Tatiana era una pessima cantante. Non vedevano l’ora che se ne andasse e speravano che qualcuno la portasse via». © RIPRODUZIONE RISERVATA RITRATTI Sopra, altri disegni dei musicisti del Bolshoi: una voluttuosa ballerina e due caricature su un pentagramma Repubblica Nazionale LA DOMENICA DOMENICA 16 OTTOBRE 2011 ■ 30 L’attualità Si chiamano Woodland, Spirit Land, Tinkers Bubble. Sono microscopiche comunità di persone che hanno deciso di vivere lontane dal consumismo e di costruire le proprie case di tronchi e foglie nelle foreste inglesi del Devon, del Pembrokeshire, Into the Wild del Somerset. E che da qui difendono il loro diritto a un’esistenza fuori dal comune EMMA & JOHN. Sono membri della comunità Brithdir Mawr, MARY & JOE. Vivono in questa casa nella foresta del Somerset e fanno parte della comunità Tinkers Bubble Popolo C’ alberi Il degli ENRICO FRANCESCHINI LONDRA era una volta una strada nel bosco. O meglio, un’autostrada. Potrebbe essere l’inizio di una favola postmoderna. Precisiamo, però: il bosco c’era, l’autostrada che ci passava in mezzo ancora no. Volevano costruirla nel Devon, per portare il traffico nel countryside inglese e così alleggerire gli ingorghi di una tangenziale vicina. Forse sarebbe piaciuta agli automobilisti, ma certo non al bosco, ai suoi animali, alle sue piante secolari. Così nove anni fa un gruppo di ambientalisti decise di piantare le tende tra gli alberi di quella foresta, con l’obiettivo di bloccare l’avanzata di ruspe, camion, asfalto, insomma per fermare l’autostrada. L’iniziativa riuscì. Con il sostegno della potente lobby dei campagnoli, ossia degli amanti della vita di campagna, che è una delle sacre icone dell’Inghilterra: una singolare alleanza di verdi e tradizionalisti, di ecologisti e conservatori ha fatto cambiare idea alle autorità e salvato il bosco dall’autostrada. Sembra la versione moderna de Il segreto del bosco vecchio, indimenticabile apologo di Dino Buzzati in cui uno speculatore è pronto a tutto pur di abbattere un bosco. Solo che nella realtà la fiaba non è finita con lo stop alla costru- BRIGYN. La sua casa si trova nel bosco della comunità Brithdir Mawr, nel Pembrokeshire, in Galles zione dell’autostrada. Gli ambientalisti si sono trovati così bene nella foresta che ci sono rimasti. Le tende sono diventate capanne, poi casupole, poi case, naturalmente eco-sostenibili, fatte in proprio, non inquinanti e appoggiate, avvinghiate, arrampicate agli alberi, o addirittura sopra di essi. È nato così poco per volta uno strano movimento, dapprima in Inghilterra, poi anche altrove (Italia compresa). People of the Trees, si autodefiniscono: “Il popolo degli alberi”. «Albericoli», li chiamano talvolta quelli che stanno fuori dal bosco, evocando il termine «cavernicoli». Ed è a una vita più semplice, primitiva, elementare, che loro effettivamente ambiscono, perciò non lo prendono come un insulto. La prima è stata la Steward Community Woodland nel Devon. Si è autoproclamata comunità nel 2004, qualche anno dopo la campagna per fermare l’autostrada. «Tra gli alberi e sugli alberi si vive bene, certamente meglio che tra le auto, lo smog e tutte le follie del consumismo urbano», dice John Asher, circondato da Sonya, Daisy, Marley e dal cane, considerato il capo di questa speciale tribù. La pensano come lui Emma e Bill del Tir Ysbrydol (Spirit Land, “La terra dello spirito”), una comunità analoga nel Pembrokeshire, e i residenti del Tinkers Bubble (“Bolla dei pensatori”) nel Somerset, e tutti gli altri seguaci del ritorno alla natura. La vita degli “albericoli” non è facile. Intanto, bisogna saper costruire una casetta con materiali naturali, facendo tutto da soli, sopravvivendo senza elettricità, gas, acqua. Poi, quando le casette sono almeno mezza dozzina, bisogna combattere contro le leggi e la burocrazia che si rifiutano di considerarle un villaggio: le stesse leggi e la stessa burocrazia che sarebbero pronte ad abbattere un bosco per farci passare un’autostrada, ma che giudicano incivile la presenza di qualche decina di esseri umani rispettosi dell’ambiente. Quindi servono avvocati, lobbisti, soldi, per difendere il proprio diritto a un’esistenza fuori dalla norma. «Ma questa è gente che crede in quello che fa e non arretra davanti a nulla», ci dice David Spero, il fotografo inglese che per un decennio ha documentato CUCINA. Pentole e stoviglie a disposizione dei membri Repubblica Nazionale DOMENICA 16 OTTOBRE 2011 ■ 35 IL FESTIVAL La decima edizione del Festival internazionale FOTOGRAFIA (al Macro Testaccio di Roma, in piazza Giustiniani, fino al 23 ottobre) diretto da Marco Delogu, è dedicata al tema “Motherland” e affronta il rapporto tra fotografia e territorio Sotto il titolo Settlements sono esposte anche le immagini di David Spero, alcune delle quali pubblicate in queste pagine. Le sue e quelle degli altri fotografi che partecipano alle collettiva sono inoltre pubblicate nel catalogo Motherland edito da Quodlibet (264 pagine, 25 euro) nel Pembrokeshire, in Galles LONGHOUSE. Tipica casa nel bosco abitata dai membri della Steward Community Woodland, nel Devon L’eremitaggio senza trucchi della donna che rinnegò soldi e cognome PAOLO RUMIZ on ricordo più il nome, ma la faccia ce l’ho stampata davanti. Avrà avuto quarant’anni e pareva uscita da un altro tempo. Abbronzata come un tagliaboschi, portava capelli a caschetto, tagliati alla buona. C’era qualcosa di francescano e medievale in lei. Si era fermata a una fonte, in un paesino sloveno di dieci abitanti. Sulle spalle aveva uno zaino e a tracolla una bisaccia da cui sbucava un quadro a tempera. Io passavo di lì, in gita col mio compagno preferito, Virgilio, e la donna — accortasi che parlavamo italiano come lei — ci chiese la strada per andare a un altro villaggio. Ci mostrò la sua carta e vedemmo con sbigottimento che era scala uno al duecentomila, buona per automobilisti e non per camminatori. Un tipo speciale. Viveva di ciò che dava il bosco. «D’autunno — disse — è impossibile aver fame. Trovo uva, castagne, bacche di ogni tipo. E poi mi regalano zucche, patate». Spiegò che veniva dalle valli del Friuli Orientale e andava a piedi da sola a un santuario in località Strugnano, alto sul mare dell’Istria. Pregava spesso, disse, ma non era cattolica e nemmeno cristiana. Le sua divinità stavano effigiate in piccole icone indiane raccolte nella bisaccia. Il santuario lo cercava solo per sondarne l’energia. Raccontò che dormiva sotto gli alberi con una coperta e un telo e la pioggia non era un problema. Poi raccontò la sua storia. Viveva in una grotta, e si preparava all’inverno racco- N gliendo la legna del bosco. Le chiedemmo come si procurava il cibo. Spiegò che ogni tanto scendeva a valle per prestare lavoro e avere cibo in cambio. Niente danaro, l’aveva bandito dalla sua vita. Il resto era eremitaggio puro, senza trucchi. Roba vera, per vivere: non per suicidarsi nella wilderness o scrivere libri alla moda millantando prestazioni inesistenti. Era piemontese, figlia di ricchi industriali, e aveva mollato il suo mondo da vent’anni. Della vecchia pelle aveva rinnegato tutto, persino il cognome. Rifiutava di avere documenti e la polizia, comprensiva, le ristampava ogni tanto un foglio di smarrimento della carta d’identità. La fuggitiva parlava senza reticenze, quasi meravigliata che non la deridessimo. Non sfuggiva al mondo, lo attraversava e basta. A piedi era stata fino all’ultima Ucraina, quattromila chilometri dormendo «dentro i covoni» nei mesi freddi. Poi l’avevano trovata senza passaporto dalle parti del Don e l’avevano messa in galera. «Lì ho imparato a cantare. C’era una prostituta dolcissima che mi insegnava ballate stupende. Sono stati i giorni più belli della mia vita». Le regalai un block notes, le dissi che non poteva non scrivere quelle cose. In cambio, lei ci offrì due mazzetti di fiori gialli minuziosamente annodati con fili d’erba, poi se ne andò, soletta, verso la notte. © RIPRODUZIONE RISERVATA l’epopea del Popolo degli Alberi. «Per fotografare le case ho dovuto prima guadagnare la fiducia di quelli che ci abitavano. È stato come entrare a contatto con una specie sconosciuta, perché in un certo senso anche queste persone, con la loro scelta radicale, sono diventate parte della fauna del bosco, parte del bosco, e guardano giustamente con una certa diffidenza chi viene da fuori». In Inghilterra, come altrove, ce l’hanno fatta, almeno finora. Qui hanno persino ricevuto un aiuto del tutto inatteso: una campagna stampa del quotidiano conservatore Daily Telegraphcontro le nuove regole di pianificazione approvate dal governo (conservatore anche quello) di David Cameron. Il premier voleva sostituire 1300 pagine di regolamenti con un libretto di appena 52. Il messaggio era chiaro: tutto è permesso. «Un assegno in bianco agli speculatori per distruggere il nostro patrimonio forestale e allargare a dismisura le città», accusa John Rhodes, inizialmente uno degli autori della riforma, che ora ha ritrattato passando dalla parte degli “albericoli”. Gli inglesi adorano la campagna, anche quelli che non ne posseggono neppure un pezzetto, sicché nel nome di sentimenti a metà strada tra tradizioni vecchio stile e ecologismo militante sperano che il progetto sarà bloccato – come anni fa l’autostrada che doveva sradicare gli alberi del Devon. Fanno venire in mente gli gnomi, gli elfi, i folletti del bosco, questi uomini e donne (e anche qualche bambino) che hanno scelto di abitare tra gli alberi. Alcuni di loro hanno l’auto parcheggiata non troppo lontano e ogni giorno vanno al lavoro in città. Le loro originali costruzioni hanno attirato anche l’interesse di agenzie immobiliari: c’è chi le acquisterebbe a suon di milioni di sterline come seconda casa. Ma gli “albericoli”, come Robin Hood, stanno bene nella foresta. E come il Barone Rampante di Italo Calvino rispondono alle offerte di denaro allo stesso modo in cui rispondevano alle minacce delle ruspe: fermate il mondo, da quassù non si scende. © RIPRODUZIONE RISERVATA della comunità Tinkers Bubble, nel Somerset ROTONDA. La casa funge da spazio comune per i membri della Tinkers Bubble, nella foresta inglese del Somerset Repubblica Nazionale DOMENICA 16 OTTOBRE 2011 LA DOMENICA ■ 36 La lettura “Addetto all’ufficio informazioni delle ferrovie salva bambino da un incendio”. La notizia appare sul giornale e per qualche giorno la vita di Earl Parish cambia. Poi il tempo passa, tutti dimenticano, tranne lui. La storia di un’ossessione in un racconto Noir totalmente inedito del creatore di Sam Spade Dashiell Hammett DASHIELL HAMMETT alla porta aperta e da una finestra al secondo piano uscivano sottili spirali di fumo senza propulsione che svanivano nell’aria. Più in alto, il viso di un bambino — appeso al davanzale come se fosse in punta di piedi — era schiacciato contro il vetro di una finestra del terzo piano. Sembrava perplesso, ma non impaurito. L’uomo a sinistra di Earl Parish fu il primo a vederlo. «Guardate!» esclamò, indicandolo con la mano. «C’è un bambino, lassù!» Gli altri guardarono in alto e ripeterono: «C’è un bambino, lassù!». «Qualcuno ha già dato l’allarme?» chiese un uomo appena arrivato. «Sì» gli assicurarono diverse voci. E una aggiunse: «I pompieri dovrebbero arrivare da un momento all’altro». «Il bambino sta bene». L’uomo che aveva visto per primo il bambino elogiava la sua scoperta. «Non piange nemmeno». «Probabilmente non sa nemmeno che cosa stia succedendo». «I pompieri arriveranno tra un attimo. È inutile che proviamo a fare qualcosa. Lo tireranno fuori con la scala molto più in fretta di quanto potremmo fare noi». [...] Da una casa dietro agli uomini, giunse la voce di una donna. «Qualcuno dovrebbe andare a tirar fuori quel bambino! Anche se non si brucia, potrebbero venirgli le convulsioni dallo spavento o qualcosa del genere». [...] L’uomo che aveva scoperto il viso alla finestra si schiarì la gola, gli occhi fissi in modo un po’ rigido alla finestra. D «Forse quella donna ha ragione» disse. «Quel bambino rischia di avere una crisi di panico. Avevo un nipote a cui veniva il ballo di San Vito per la paura, se un gatto gli saltava addosso». «Ma davvero?» chiese l’araldo dei vigili del fuoco con straordinario interesse. «Forse sarebbe meglio se noi...» suggerì Earl Parish. «Forse sarebbe meglio». Il gruppo oscillava senza prendere una decisione. Poi, otto uomini attraversarono la strada, affrettando il passo via via che si avvicinavano all’ingresso fumante. Nel salire i quattro gradini di legno, si urtarono l’un l’altro, perché ognuno voleva arrivare per primo. Stavano entrando in quella casa e avrebbero corso tutti lo stesso rischio. Ma chi entrava per primo avrebbe portato giù il bambino, mentre gli altri sarebbero stati solo un coro di poca importanza. Varcata la soglia, li avvolse una folata di fumo che offuscò la luce bruciandogli gli occhi e la gola. Per strada, si sentirono risuonare le campane e le sirene. «Ecco i pompieri!» gridò il profeta. «Porteranno giù quel bambino in un attimo!». Sette uomini tornarono in strada e nulla nel loro atteggiamento rivelava che intendessero scusarsi. Earl Parish rimase nella casa. [...]Esitò. Vo- leva salire quei gradini e portare giù il bambino, o restare con lui finché il fuoco non fosse stato spento. Ma farlo poteva sembrare una mancanza di fiducia negli uomini che erano tornati per strada. Se avesse detto loro che voleva continuare nell’impresa, lo avrebbero accompagnato. Essendo rimasto silenziosamente indietro, se ora fosse uscito con il bambino o se si fosse fatto trovare di sopra con lui dopo lo spegnimento del fuoco, avrebbero pensato che li aveva imbrogliati per mostrarsi come uno che, da solo, aveva fatto ciò di cui loro avevano avuto paura. Fece un passo verso la strada e si fermò. Uscire senza il bambino, a questo punto, non sarebbe stato meglio. Gli uomini in strada, che senza dubbio si erano ormai accorti della sua assenza, avrebbero pensato che, dopo aver tradito la loro fiducia, gli era mancato il coraggio. Due righe in cronaca per l’impiegato che si immaginò eroe Earl Parish salì i gradini con le aste d’ottone. Via via che saliva, il fumo diventava più spesso, ma mai così denso da impedirgli di continuare ad avanzare. Non vide nessuna fiamma. Al terzo piano, una porta sgangherata gli impediva l’accesso alla facciata dell’edificio, ma poi si ricordò che questa era un’occasione insolita, un’emergenza, per essere precisi e aprì la porta con una spallata. Nella stanza dove si trovava il bambino c’era poco fumo, ma una lieve nebbiolina entrò insieme a lui. Il bambino gli andò incontro. «’umo» disse con tono serio. «È tutto a posto, figliolo» disse Earl Parish prendendolo in braccio. «Adesso ti porto subito fuori da qui». Avvolse con leggerezza una tovaglia rossa e verde intorno alla testa del bambino, lasciandone libero un lembo se per caso ne avesse avuto bisogno. Fece uno sforzo per non mostrarsi alla finestra e poi scese da dove era salito. Per strada, qualcuno prese il bambino. Gli girava un po’ la testa per il fumo, per lo sforzo nello scendere giù con il bambino e per l’emozione che era cresciuta in lui mentre scendeva... quel nervosismo che accompagna anche la più tranquilla delle ritirate. Tenne la schiena dritta ed evitò gli sguardi curiosi.[...] *** Il mattino dopo, seduto alla sua scrivania, Earl Parish cercò sui quotidiani. Sul Morning Post, Rimase disteso pensando che molta gente, in tutta la città, aveva letto ciò che aveva fatto Adesso sapevano che era un uomo coraggioso trovò una notizia di due righe: un incendio di origini sconosciute era stato domato con lievi danni dopo che un bambino era stato tratto in salvo da Earl Parish. Piegò il trafiletto in mezzo al giornale e lo mise via. Tra la partenza del 131, diretto a sud, e l’arrivo del 22, un impiegato delle ferrovie si avvicinò allo sportello di Earl Parish e gli rivolse un sorriso da sopra il cartello “Informazioni”. «Dov’è la medaglia?» chiese l’impiegato delle ferrovie. Earl Parish gli restituì il sorriso con aria ebete. Il sangue gli salì alla testa, cominciò a sudare. Alla stazione, la notizia si diffuse in un baleno: Earl Pa- Repubblica Nazionale DOMENICA 16 OTTOBRE 2011 ■ 37 rish aveva salvato un bambino da un edificio in fiamme... due bambini! Gli impiegati della stazione con cui era più in confidenza lo presero in giro per la sua impresa. Quelli più importanti — il responsabile dell’ufficio bagagli, il capostazione, il dirigente centrale — si congratularono solennemente con lui, quasi a nome della compagnia. A mezzogiorno, il direttore generale dell’ufficio passeggeri in persona, mentre andava a un congresso a St. Louis, si fermò a lodare il coraggio di Earl Parish. Earl Parish lo ascoltò, rispose alle sue domande, mantenne lo sguardo fisso sulla catenella dell’orologio del direttore generale dell’ufficio passeggeri e sudò. Finalmente, venne annunciato il treno del direttore generale dell’ufficio passeggeri, che strinse la mano a Earl Parish e se ne andò. [...] Era piacevole rimanere disteso sul letto sapendo che molta gente, in tutta la città, aveva letto ciò che aveva fatto, che i suoi conoscenti lo consideravano un uomo coraggioso e che forse si vantavano un po’ di conoscere Earl Parish.[...] *** Il mattino dopo, andò al lavoro con il volto sereno. Uscì di casa di nascosto per evitare la padrona di casa, diventata improvvisamente troppo affettuosa. Fu una giornata meno imbarazzante della precedente. Da una parte, si stava abituando al suo nuovo status tra i colleghi, dall’altra, le cose stavano tornando come la settimana prima. I bigliettai davanti al suo sportello facevano ancora delle battute parlando attraverso la grata: «La prossima volta che salvi delle donne e dei bambini, salvami una bionda!». Ma ora riusciva a restituirgli il sorriso senza sudare. A volte, incontrava delle persone conosciute che avevano letto la notizia sul Poste gliene parlavano. In queste occasioni, arrossiva e si sentiva a disagio, ma poi si godeva il ricordo. Certo, non usciva mai sperando di fare uno di questi incontri per strada. Sull’ultimo numero dell’Employee’s Magazine delle ferrovie c’era la sua fotografia e un dettaglia- to racconto della sua impresa. Poi, fu come se l’incendio non ci fosse mai stato. Nessuno ne parlò più. Un paio di volte lo citò casualmente nella conversazione, ma nessuno mostrò il minimo interesse. Dapprima, pensò che questa freddezza nascesse dalla noia. Poi, pensò che fosse colpa dell’invidia. Cominciò a chiudersi in se stesso. Dopotutto, che cosa aveva in comune con la gente che lo circondava? Era gente poco interessante: abitanti minori del mondo, rotelle irrilevanti in macchinari non particolarmente importanti. Lui stesso era una rotella, questo è vero, ma con la differenza che in certe occasioni poteva avere un’identità. L’ultima goccia dello spirito d’avventura ancestrale non era stata ancora distillata dal suo sangue. Giocò con questo pensiero inventando una frase che gli piaceva: «L’industrialismo ha distillato dalle loro vene tutto il loro coraggio ancestrale». Guardava il mondo da sopra il cartello con la scritta “Informazioni” e si ripeteva da solo la frase. Chiunque passasse davanti al suo sportello o gli chiedesse qualcosa veniva catalogato. Possedeva ancora un po’ di coraggio ancestrale? Oppure no? Il primo gruppo era piccolo. Agli uffici della direzione generale, che si trovavano in centro, giunsero delle lamentele: l’uomo allo sportello delle “Informazioni” era stato poco disponibile, era stato maleducato, aveva detto delle cose offensive. Earl Parish ricevette una lettera ufficiale che richiamava la sua attenzione sulla quantità di lamentele e sullo slogan viola che promuoveva la compagnia: «La cortesia ovunque». Dipartimenti importanti come l’ufficio informazioni, insisteva la lettera, avevano una grande influenza sull’atteggiamento del pubblico nei confronti della compagnia e da quell’atteggiamento dipendevano non solo i ricavi della compagnia, ma anche il suo successo nell’ottenere una legislazione favorevole. A Earl Parish la lettera non piacque. Con una matita e un blocco di carta cominciò a buttar giù una risposta, ma non la risposta che ci si potrebbe aspettare da una rotella. Al suo sportello si presentò un vecchio irritabile con una domanda senza risposta. L’Earl Parish di qualche tempo prima avrebbe portato il vecchio a un punto in cui la risposta a una domanda completamente diversa lo avrebbe soddisfatto. L’Earl Parish alle prese con la bozza di risposta agli uffici della direzione generale disse al vecchio a bruciapelo che la sua domanda era sciocca. Il vecchio era una persona a suo modo importante. Il giorno seguente, Earl Parish ricevette due settimane di preavviso. Se ne andò dopo dieci minuti.[...] *** Earl Parish stava lavorando temporaneamente in una fabbrica di saponi quando un giorno lesse sul giornale che il corpo dei vigili del fuoco pativa una grave carenza di personale. Lasciò immediatamente la fabbrica di saponi, stupito di aver avuto bisogno che il giornale gli indicasse la strada: era ovvio, il corpo dei vigili del fuoco era il posto più adatto per lui! Presentò la sua domanda di lavoro e fu visitato da un medico. Trascorsero alcuni giorni e finalmente gli dissero che non aveva superato la visita medica — per una questione di reni. Lo stesso giorno, nell’ufficio del comandante dei vigili del fuoco, Earl Parish diede spettacolo. Davanti agli occhi del comandante, venne brandito un trafiletto di giornale. Il comandante fu chiamato vecchio pazzo. Earl Parish fu preso e sbattuto fuori. Si recò nell’ufficio del Morning Post, dove trovò qualcuno disposto ad ascoltare la sua storia. In quel momento, il Morning Postera un giornale dell’opposizione e dedicò mezza colonna alla storia di un uomo che un giorno «si lanciò in un edificio in fiamme per salvare un bambino» e a cui ora, non riuscendo a trovare un altro impiego, veniva impedito di entrare nel corpo dei vigili del fuoco da «quella stessa burocrazia a cui si deve la loro incapacità di trovare e mantenere un’adeguata quantità di personale». Da questa pubblicità, Earl Parish ottenne — oltre che un nuovo articoletto — un impiego come guardia notturna in un conservificio. Lo pagavano quattro dollari a notte e presto venne a sapere che due uomini che si dividevano quel lavoro erano stati licenziati per far posto a lui. Compito del guardiano notturno era fare il giro di tutti gli edifici ogni ora lasciando prova del suo passaggio in quindici piccole scatole appese al muro. Dopo la prima set- timana, Earl Parish cominciò a saltare delle scatole, quelle più lontane. [...] Lo licenziarono alla fine della terza settimana. [...] *** Trascorse molto tempo in una piazza poco lontano dalla zona degli uffici. Seduto su una panchina o sdraiato sull’erba, classificava i passanti come era sua abitudine. Sempre meno erano quelli a cui la civiltà industriale non avesse distillato dalle vene il coraggio ancestrale. Ogni tanto, mandava una lettera alla rubrica dei lettori del Post, con amari commenti sulla decadenza della razza. A volte andava al porto, fingendo di partire per una terra virile dove ancora prosperavano i coraggiosi e le pecore si mangiavano. Non metteva mai piede sul ponte di una nave, non faceva mai una domanda che potesse portarlo a bordo. I periodi in cui cercava svogliatamente lavoro si allungarono. Le parentesi di lavoro si fecero più brevi. Certi giorni, ebbe fame. In uno di quei giorni, andò in quella casa da cui aveva tratto in salvo il bambino. La famiglia del bambino se n’era andata dal quartiere e nessuno sapeva dove fosse. Una mattina in cui la fame si era fatta un groppo duro nello stomaco, camminava per la strada studiando i volti delle persone che incrociava, classificandole, ma non nel suo modo abituale. Ora cercava di distinguere tra chi probabilmente era di idee liberali e chi probabilmente non lo era. Per tre volte si avvicinò a dei volti che rivelavano generosità. Per tre volte, all’ultimo momento, la timidezza e l’eccessiva vicinanza di altre persone nella strada gli impedirono di parlare, facendogli affrettare il passo come se un urgente impegno lo aspettasse alla fine della strada. Il quarto volto che lo attrasse era molto anziano e gli anni avevano dilavato ogni colore, ogni espressione, a parte una mite cordialità. Il proprietario di quel volto camminava solo, a passo lento, con l’aiuto di un bastone dall’impugnatura d’argento. Le sue scarpe erano specchi neri. Earl Parish si girò e seguì il vecchio. Passarono e ripassarono altri passanti. Earl Parish si manteneva a mezzo isolato di distanza da quell’uomo e mentre camminava tirò fuori dalla loro busta i ritagli di giornale che aveva sempre sottomano e se li mise in tasca sciolti, pronti per essere mostrati se la sua richiesta di «qualche soldo» avesse avuto bisogno di essere corroborata da qualche documento. A quel punto, il vecchio svoltò in una strada dove c’era poca gente. Earl Parish affrettò il passo e la distanza fra di loro diminuì. Affrettandosi in quel modo, arrivò in un angolo dove un uomo a capo scoperto stava rompendo il vetro di un allarme antincendio con un fazzoletto avvolto attorno al pugno. Earl Parish dimenticò la sua preda dal viso gentile. «Dov’è?» chiese all’uomo a capo scoperto in un tono secco e professionale. «Nella strada qui dietro». Earl Parish corse dietro l’angolo. Tre uomini si stavano dirigendo verso l’imbocco di un vicolo che divideva un caseggiato. Si affrettò a seguirli. Da una casa bianca e rossa, a metà del caseggiato, si levava un fumo spugnoso che ingrigiva la strada. Davanti alla casa, un uomo cercò di afferrare Earl Parish per un braccio, ma lui spinse via quella mano che si intrometteva e salì rapidamente i gradini esterni. «Ehi! Esca da lì!» gli urlò l’uomo. Earl Parish aprì con una spinta la porta d’ingresso e si slanciò nell’interno fumoso. Un colpo al petto lo fermò, risospingendolo indietro, svuotandogli i polmoni dell’aria pulita che avevano portato dalla strada. Il fumo gli bruciava la gola, il petto. Le sue mani trovarono la cosa che lo aveva colpito, il montante della scala. Vi si afferrò, poi chiuse gli occhi per il fumo bruciante e tossì. [...] Earl Parish urlò — una protesta soffocata dal fumo contro quell’inganno, quel tradimento. Nell’altra casa non c’era stato un fuoco visibile. C’era stato solo del fumo e un bambino da portare fuori, null’altro. Qui c’era un fuoco vivo — che scemo era stato! — e forse nessuno da portar fuori. Come poteva sapere se c’era qualcuno al piano di sopra? Era possibile? [...] Fissò il foglio con una strana concentrazione. Gli risultava familiare, quel piccolo rettangolo di polpa di legno arrotolata, così totalmente privo di importanza, una cosa così banale, lì, in una casa in fiamme. E quando riconobbe il foglietto, continuò a guardarlo, vedendo ora per la prima volta nella sua vera misura il suo amato ritaglio del Morning Post dell’anno prima: la notizia di due righe di un incendio di origini sconosciute domato con lievi danni dopo che un bam- bino era stato tratto in salvo da Earl Parish. Vedendo quel ritaglio per quello che era, ne vide il suo significato e vide anche altre cose: vide se stesso con una chiarezza che screziava il suo volto più di quanto potessero fare il fumo e il fuoco. Si rialzò sul pianerottolo e guardò verso il piano superiore con un pezzo di giornale accartocciato nel pugno. «Finora ho avuto il mio divertimento, brutto...» disse rivolto al ritaglio di giornale. E dopo averlo coperto di pesanti invettive quasi fosse una persona, lo gettò nel fuoco. «Ma adesso me lo vado a guadagnare!» C’era un turbine di fumo per le scale, una luce rossa che crepitava e vivide lingue di fuoco che lambivano il soffitto. Earl Parish le attraversò per salire al secondo piano. Ma non le attraversò tutto intero. Un po’ di capelli, un lembo di pelle di una mano, alcuni brandelli dei suoi abiti ridotti scomparvero, ridotti in cenere. Il resto di Earl Parish giunse al secondo piano, sbatté la porta tra lui e le scale e soffocò con le mani le numerose bruciacchiature sui suoi vestiti. [...] In un angolo, sentì un piccolo starnuto. L’uomo si mise a quattro zampe e guardò sotto la sedia. Un micino color cannella smise di fregarsi il naso con le zampine per starnutire di nuovo. Earl Parish rise rocamente. Prese il gattino dal suo nascondiglio e lo infilò nella tasca del cappotto. Faticò a rimettersi in piedi, ma alla fine ci riuscì. La finestra si sollevò facilmente, creando una corrente che spalancò la porta e risucchiò nella stanza una palla di fuoco che non assomigliava più a lame di spada. Earl Parish si arrampicò sulla finestra e vide le facce per strada che guardavano in su. Un poliziotto agitò il braccio. «Resisti, fratello» gridò. «Stanno arrivando i pompieri!» «Attenti!» rispose urlando Earl Parish. E saltò. Ci fu un impatto, ma non quello del duro marciapiede che si aspettava. Si trovava su una specie di cuscino blu: il poliziotto era corso a mettersi sotto di lui. Alcuni uomini li trascinarono via per far posto ai pompieri in arrivo e li aiutarono a rialzarsi. Il poliziotto aveva il volto sanguinante. «Tu sei matto!» disse. Earl Parish era alle prese con la tasca del suo cappotto per districare il gattino color cannella dalla fodera strappata. Qualcuno prese il gattino. Si udirono delle voci, delle domande. Una di queste riguardava il nome e l’indirizzo di Earl Parish. «Earl...» tossì violentemente per coprire la pausa e ripeté: «Earl... John W. Earl» e aggiunse il nome di una strada e un numero, sperando che non appartenessero a nessuno dei presenti. Ripeté che si sentiva bene, che non aveva bisogno di un medico. Sgattaiolò via tra la folla. Si allontanò frettolosamente dal fuoco lungo un vicolo. Girò tre angoli prima di fermarsi. Dalla tasca, tirò fuori due ritagli... uno, della rivista degli impiegati delle ferrovie e l’altro di un giornale. Li strappò in minuscoli pezzetti e poi li lanciò per aria come un turbine di neve artificiale. *** A Howard Street, tra un negozio di abiti usati e una tavola calda, c’è un ufficio con un ampio ingresso non ammobiliato a eccezione di una squallida scrivania, una sedia e un tavolo dietro a un logoro bancone sul retro e una lavagna che occupa una parete laterale. Su questa lavagna c’è una lista di cose tipo: «operai, azienda, campagna, $3,75; taglialegna, campagna, 4 piedi e legna da ardere, $2,50-4,50 a catasta; bracciante, campagna, $45-65; saldatore piombo, azienda, $8». Sotto alcune di queste voci, c’era scritto «rimborso spese di trasferimento». Un pomeriggio, si presentò in questo ufficio un uomo basso e robusto sui trent’anni, con gli abiti logori e la faccia sporca. Non portava il cappello e una parte dei suoi capelli sembrava smangiucchiata. Al posto di un sopracciglio vi era uno sbaffo. Camminava in modo malfermo. Gli occhi rossi avevano l’ilarità interiore del filosofo ubriaco, ma non puzzava d’alcol. Aveva piuttosto un odore di fumo, di legna bruciata da poco. Si appoggiò al bancone e sorrise giovialmente al titolare dell’ufficio. «Voglio un lavoro» disse. «Un lavoro qualsiasi. Basta che mi permetta di lasciare la città prima che escano i giornali del mattino». Traduzione di Luis E. Moriones (An Inch and a Half of Glory © 2011 The Dashiell Hammett Literary Property Trust Published by Arrangement with Roberto Santachiara Literary Agency) Ha collaborato Gabriele Pantucci © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 16 OTTOBRE 2011 LA DOMENICA ■ 38 Spettacoli Su una pila di fogli la versione censurata della sua canzone più celebre, “Il Disertore”, e accanto la chitarra con cui la suonò E poi disegni, invenzioni, appunti per romanzi, brani inediti Bricoleurs Nella casa di Montmartre il mondo segreto del più eclettico tra gli artisti di Francia. Ora celebrato con una grande mostra e un raffinatissimo libro LE CANZONI Cha cha cha Fu mentre andavo a comprare il torrone Ai grandi magazzini Printemps Che sentii per la prima volta Questo cha cha cha ossessivo Parlava di tenerezza e d'amore Con ritmo pulsante Non compresi che un verso solo Ma definitivo In ogni occasione io gioco col cuore Io perdo, tu vinci, si piange Parte una nuova mano Carte truccate, misdeal Non ho niente… mi lasci, il giro riparte Tocca a te, cuor mio, Tu perdi, io vinco, si piange Che gioco idiota, cambiamo disco Smettiamola, corriamo il rischio (...) L’incontro Accanto a me il tuo corpo si allunga Le nostre due mani s’incontrano Da una sigaretta Trarremo il medesimo sogno Tutto acqua fresca e baci La musica tenera Ci avvolge Ecco, è ora di sognare INEDITI In queste pagine, appunti dell’artista con svariati disegni e cinque testi di canzoni inedite scritte a mano Sotto ogni testo originale la corrispondente traduzione a cura di Marzia Porta Boris Vian Le poesie mai cantate del musicista-ingegnere La canzone del vento Ti dice Che il mio amore ti attende Non ho che te sulla terra A cui aggrapparmi Mai Anche nei sogni più belli Ho sperato nel tuo ritorno Ma il giorno che sorge Risveglia il mio amore Sei molto distante Eppure Vorrei rivederti E ho urlato al vento il mio dolore E la mia speranza ANAIS GINORI A PARIGI l muro è appesa la chitarra con doppie corde sulla quale è stata composta Il Disertore. Boris Vian aveva acquistato questo strano strumento ispirato all’antica lira greca nel negozio del fratello Alain, in Saint-Germaindes-Prés, quando le difficoltà respiratorie non gli permettevano più di soffiare nella sua amata tromba tascabile, che lui teneva sempre sotto al braccio e chiamava «trompinette». Tra una pila di fogli, il manoscritto della prima versione della canzone che si concludeva con: «E dica pure ai suoi/se vengono a cercarmi/che tengo un’arma/e so anche usarla». Era il 1954, guerra d’Indocina. Nessuna casa discografica accettò di incidere la canzone. Alla fine, Vian cambiò l’ultima strofa in un manifesto pacifista senza più ambiguità: «E dica pure ai suoi/se vengono a cercarmi/che possono spararmi/io armi non ne ho». «Molti pensano che Il Disertoresia stata scritta durante la battaglia di Dien Bien Phu, invece risale a qualche tempo prima» racconta Nicole Bertolt, direttrice della fondazione Boris Vian che ci guida nella casa dell’artista a cité Veron, dietro al Moulin Rouge, accanto a quella dell’amico Jacques Prévert. Sulla porta di vernice verde, la targhetta dice solo: “Ingegnere, musicista”. Ma qualsiasi categoria va stretta a Boris Vian, troppi talenti per quarant’anni di vita appena. Ha lasciato dietro di lui una scia luminosa di romanzi, poesie, racconti, articoli, traduzio- ni, disegni, spettacoli, oggi celebrati in una grande mostra alla Bibliothéque Nationale e da un raffinato libro, Post-Scriptum (edizioni Cherche-Midi). Onnivoro, ecclettico, visionario. La musica è una passione iscritta nel nome, scelto dai genitori in omaggio all’opera Boris Godunov di Modest Mussorgsky. La madre è pianista, il padre ascolta Carlos Gardel. Lui s’innamora del jazz, il ritmo proibito, è il primo dei suoi tanti gesti di contestazione. Nella prefazione a L’Écume des Jours, scrive: «Sono solo due le cose che contano: l’amore, in tutte le sue forme, con belle ragazze, e la musica di New Orleans e di Duke Ellington. Tutto il resto è da buttar via, perché è brutto». Un’altra parete è coperta dai 33 giri, i cofanetti rilegati di Charlie Parker, Louis Armstrong, Coleman Hawkins. «Ha incominciato a collezionarli da adolescente, li usava per fare i surprises-parties nella casa di famiglia di Ville d’Avray». Suona con i fratelli, creano il gruppo Accord Jazz. Nell’aprile 1939 vede finalmente il suo dio, Ellington, che si esibisce al palazzo di Chaillot. Miscela esplosiva di regole e improvvisazione: il suo stile. Con la «trompinette» va a suonare per gli americani nelle caves di Saint-Germain, insieme alla prima moglie Michelle e all’amica Juliette Gréco. Oggi la trombetta di Vian non esiste più, è rimasta solo la custodia che si era fabbricato, in legno e cartone con fodera di velluto arancione. «Vian costruiva quasi tutto con le sue mani. In questa casa — racconta Bertolt — non solo ha fatto alcuni mobili e librerie ma anche il sistema elettrico e di riscaldamento». C’è ancora lo sgabuzzino con i suoi attrezzi di lavoro. Un bricoleur di oggetti e parole, come quel «pianocktail» che s’ispira al pianoforte nell’appartamen- Repubblica Nazionale DOMENICA 16 OTTOBRE 2011 ■ 39 Ah, che amanti Ah! quant'è triste star di vedetta Sul cammino di ronda, Con le dita serrate attorno a un moschetto, Mentre potrebbero, sì, sì, Stringer delle belle bionde Ah! quant'è triste star di vedetta In cima a una garitta to parigino e rimanda all’ebbrezza tra jazz e alcol. Il chansonnier Vian firma oltre seicento canzoni, molte inedite, alcune mai messe in musica e rimaste orfane. Nella casa di Montmartre, sono state tutte conservate dalla seconda moglie Ursula, morta l’anno scorso, e ora da Nicole Bertolt, che rappresenta gli eredi. Vian scrive una canzone in poche ore, è un paroliere nato, abituato a pensare in rime. Usa quasi sempre una penna Bic blu, a volte rossa. Accanto ai testi, compaiono fiorellini, strane geometrie o i «miam», testoline sorridenti che sembrano anticipare gli attuali smiley. Con la musica ha un rapporto d’amore subito ricambiato, mentre i suoi romanzi non vendono abbastanza, lo fanno litigare con gli editori e lo costringono ad affrontare tormentate vicende giudiziarie. Il vero successo letterario sarà postumo. Scrive critiche musicali sui giornali, diventa direttore di case discografiche, scopre giovani talenti come Georges Brassens, Serge Gainsbourg. Lavora spesso in coppia con il compositore Alain Goraguer, tenta anche di cantare i suoi brani ma dura poco. «Soffriva troppo della tensione davanti al pubblico» ricorda Bertolt che mostra una foto di Vian prima di andare in scena. Con l’amico Michel Legrand fa scoprire ai francesi con ironia cos’è il rock. «I suoi interpreti preferiti sono Henri Salvador e Magali Noël, perché sapevano divertirsi e avere la leggerezza necessaria». L’artista impegnato, sovversivo, era anche un raffinato burlone. C’è una vecchia registrazione di Fais-moi mal Johnny in cui Noël e Vian alla fine scoppiano a ridere. Nella musica, Boris Vian ha fatto tutto: compositore, paroliere, musicista, interprete, critico, discografico. «Solo, non amava CHITARRA E GATTO danzare» aggiunge Bertolt. Era un uomo alto e massiccio. Prendeva Ursula, che era una bellissima ballerina, e la faceva salire in punta dei piedi sulle sue scarpe. «Facciamo il ballo del Bisonte e dell’Orso», scherzava cercando di camminare con lei abbracciata in equilibrio. Prima di morire, nel 1957 aveva incominciato a scrivere un’opera. Titolo: Il Mercenario. L’ultimo appello a Monsieur le Président. Nella foto grande, Parigi 1953: Boris Vian, in compagnia del suo gatto Wolfgang Busi von Drachenfels, suona la chitarra-lira su cui ha composto Il Disertore La acquistò nel negozio del fratello Alain, in Saint-Germain-des-Prés, quando le difficoltà respiratorie non gli permisero più di suonare la sua amata «trompinette» Qui sopra un collage raffigura Vian nudo che passeggia nella neve A lato scarponcini in cartone, risultato di una delle sue attività preferite: il découpage © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 16 OTTOBRE 2011 LA DOMENICA ■ 40 Next Vocabolari Si apre per trascrivere le sue informazioni in molecole di Rna. Se la parte copiata è un gene, si tratta di un Rna-messaggero Se viene trascritto uno pseudo-gene, si formano Rna diversi, detti Micro-Rna Destinata ad aprire nuove strade nella lotta contro il cancro e altre malattie, la scoperta è stata fatta nei laboratori dell’università di Harvard diretti dall’italiano Pier Paolo Pandolfi Che qui spiega cosa racconterà la nostra “materia oscura” Dna La lingua segreta dei geni Dna GLOSSARIO O genoma. Lungo filamento che contiene le istruzioni per la vita Struttura e funzionamento sono simili in tutti gli organismi viventi Codice genetico Codone È il linguaggio del Dna Ha un alfabeto di solo 4 lettere e parole sempre di 3 lettere Le parole possibili sono 64 Anche detto tripletta Sono le tre lettere che definiscono l’aminoacido Ad esempio: A, C, T = Tirosina Aminoacidi Le 64 parole corrispondono ai 20 aminoacidi che compongono le proteine e ad alcuni ordini per la loro produzione Repubblica Nazionale DOMENICA 16 OTTOBRE 2011 ■ 41 l Dna ha una seconda lingua, finora rimasta segreta, per parlare alle cellule e al corpo. Comunica istruzioni per la vita molto più complesse ed è più usata di quella conosciuta. Quando sarà completamente svelata ci farà comprendere anche il linguaggio del cancro e, si spera, gli ordini giusti per riportarlo alla normalità. Ma la scoperta finalmente dipana anche molti altri misteri in cui si sono impantanate la medicina e la biologia e contribuisce a spiegare il perché delle tante e drammatiche mancate promesse. La decodificazione della lingua segreta dei geni è iniziata alla Harvard University, in uno dei laboratori di ricerca biomedica più grandi e dotati di risorse al mondo. È diretto dall’italiano Pier Paolo Pandolfi. Da lì è partita la rivoluzione che il New York Timesha definito «il Big Bang della vita» perché avrà sulla medicina lo stesso impatto che sull’astronomia ebbe la teoria sull’origine dell’universo. I I micro-Rna interagiscono tra di loro per precisare il comando Così regolano precisamente la funzione dei geni LO SCIENZIATO Pier Paolo Pandolfi, 48 anni, romano Dirige il laboratorio di genetica del cancro della Harvard University Le promesse «Negli anni Novanta sembrava tutto chiaro», ricorda Pandolfi. «Il Dna porta le istruzioni per la vita depositate sotto forma di lunghe frasi. Le parole del suo vocabolario sono appena 64, risultanti da tutte le possibili combinazioni ternarie di un alfabeto di sole quattro lettere: A, C, G, T. Le 64 parole si traducono in 20 aminoacidi che a loro volta si attaccano in sequenza a formare le proteine. Sono queste l’impalcatura (proteine di struttura delle cellule, dei muscoli, eccetera) e il motore (gli enzimi che gestiscono le reazioni chimiche) degli organismi viventi. Le lettere, le parole e i significati del codice genetico sono universali, valgono per tutti gli organismi. “Errori” in queste parole sono stati considerati finora l’unica causa di molte malattie, compreso il cancro». “Vado al potere. Vado al podere”. Lo scambio di una sola lettera, la “t” con la “d”, fa assumere non solo alla parola ma anche alla frase un significato diverso. Così basta una sola mutazione (la sostituzione di una delle quattro lettere dell’alfabeto del Dna) perché la “parola genetica” corrisponda a un altro aminoacido, che cambia la funzione della proteina. E, se la proteina mutata regola la moltiplicazione della cellula, è il cancro. “Scoperto il gene del tumore al...”. Sono questi i titoli che negli anni ’90 rimbalzano sui quotidiani dalle riviste scientifiche e promettono una cura per ogni tipo di cancro. «Si mettono a punto i primi farmaci “intelligenti” che colpiscono solo la mutazione, e si ottengono alcune clamorose vittorie — ricorda Pandolfi — tuttavia le cure si rivelano efficaci per pochi pazienti, quelli col sottotipo di tumore con la mutazione. La maggioranza dei malati sembra avere un Dna codificante proteine “sano”. E allora, da dove viene la malattia? Non può che arrivare dal Dna. Ma da dove parte? E in che lingua è scritto? Il codice genetico a 64 parole non ha le risposte». I misteri Le scoperte della biologia aggiungono altri misteri. Alla fine degli anni ’90 si sequenzia il genoma umano e quello di numerose specie viventi e si iniziano a contare i geni. Nel- Gene È la sequenza di “parole” corrispondenti alla sequenza di aminoacidi di una proteina da cui dipende la sua funzione vitale Dna codificante Parte del Dna composta dai geni che danno origine alle proteine Occupa appena il 2 per cento della lunghezza del Dna umano l’uomo si stimava ce ne fossero centomila, numero compatibile con la sua complessità che lo posiziona al vertice della scala evolutiva. Tuttavia, si scopre che i geni umani che producono proteine sono appena ventimila. Inoltre questi geni occupano solo il 2% della lunghezza del Dna. Che c’è nel restante 98%? È ancora la biologia, con le sue ricerche, a svelare un ulteriore paradosso che, contemporaneamente, indica la strada da battere. La scoperta che lo scimpanzé ha solo lo 0,2% di geni codificanti per proteine in meno dell’uomo lascia perplessi. Scendendo nella scala evolutiva aumenta lo sgomento quando si scopre che nelle cellule del lievito di birra o di un vermetto il Dna contenente i geni che fanno proteine è lungo poco meno di quello umano. La parte di Dna “muta” è invece di ben trenta volte più corta. «La specie umana quindi ha il record di dotazione di Dna “oscuro” — osserva Pandolfi — Non fa proteine, non si sa che fa, eppure è qui che devono risiedere le informazioni genetiche ‘‘ L’opportunità Quando sapremo parlare la nuova lingua avremo un’opportunità senza precedenti per la terapia e la prevenzione delle malattie Pier Paolo Pandolfi Harvard University, Boston che fanno dell’uomo l’organismo vivente più complesso. E più vulnerabile alle malattie. In quel 98% c’è la differenza tra noi e le altre specie che popolano il pianeta». La comprensione del ruolo di questo “genoma oscuro” arriva dalle ricerche sul cancro di Pandolfi. La chiave sta nella nuova prospettiva in cui si guarda un prodotto del Dna sinora considerato un semplice esecutore, l’Rna. Questa molecola è da tempo nota per essere il messaggero del Dna. Su di esso il gene trasferisce l’informazione necessaria a costruire la proteina. L’Rna poi raggiunge le strutture di produzione della cellula dove materialmente le proteine sono assemblate a partire dagli aminoacidi quello che Pandolfi ha scoperto è che l’Rna porta altre informazioni indipendenti da quelle che “fanno le proteine”. La scoperta «Una parte di Dna “oscuro” contiene gli “pseudogeni” — continua il professore — Sinora sono stati considerati “relitti evolutivi” dei geni “veri”, che fanno proteine, informazioni ereditarie obsolete dimenticate nel codice della vita. Ma come mai decine di migliaia di geni vengono risparmiati dalla dura legge di selezione naturale che elimina tutto ciò che non serve più? Perché questo 98 per cento di Dna “inutile” continua a essere trasmesso di generazione in generazione? Il fatto è che, come i geni, anche gli pseudogeni producono “messaggi”, molecole di Rna. Ma questi Rna non raggiungono le catene di montaggio delle proteine e rimangono a fluttuare nella cellula. Lungi dall’essere inutile, ognuno di questi Rna reca dei messaggi precisi, basati su un nuovo linguaggio, un nuovo codice. Messaggi che significano “accendere”, “spegnere”, “accelerare” e “rallentare”. Questi messaggi sono indirettamente destinati a tutti gli altri Rna presenti nella cellula, sia quelli prodotti dai geni che poi fanno le proteine, che quelli prodotti dagli pseudogeni. È questo l’aspetto più sconvolgente della scoperta: questa nuova lingua è parlata da ogni Rna, cioè non solo dagli Rna degli pseudogeni, ma da tutti gli Rna cellulari. Per capire la dimensione del fenomeno basti pensare che nel nostro Dna ci sono moltissime unità geniche, forse decine di migliaia, che come gli pseudogeni fanno solo Rna. Ebbene, la nuova lingua è condivisa da tutti questi nuovi protagonisti». A fare da “portavoce” di questi messaggi sono un’altra categoria di molecole di Rna più piccole e che non fanno proteine: i microRna. Questo nuovo linguaggio basato sugli Rna espande enormemente la percentuale del Dna funzionale. Obsoleti diventano i concetti “relitto genetico evolutivo” e “Genoma oscuro”. La lingua «A rendere più complesso il sistema informativo sono poi le caratteristiche del linguaggio usato dagli Rna per comunicare — aggiunge Pandolfi — Questo linguaggio è scritto nella molecola di Rna, si può leggere informaticamente ed è sempre basato sulle quattro lettere del Dna, ma le “parole” e le frasi hanno lunghezza non fissa bensì variabile, come avviene nel linguaggio parlato. I significati possibili quindi sono molti più di 64. Sono già state individuate 500 parole diverse, ognuna delle quali viene riconosciuta da un microRna diverso. Insomma si delinea finalmente un linguaggio con una ricchezza di significati compatibile con la complessità delle informazioni necessarie a guidare lo sviluppo e la gestione della struttura del corpo umano, delle sue funzioni, anche quelle mentali. E delle malattie, prima di tutto il cancro, quando la comunicazione tra molecole di Rna viene danneggiata da mutazioni, sia dei geni che degli pseudogeni. La completa decodificazione di questo nuovo linguaggio non solo aumenterà le nostre conoscenze sull’eziologia del cancro e delle malattie in generale, ma offrirà nuove strategie per la loro cura». Pandolfi ha descritto la nuova teoria “Rna-centrica” ad agosto su Cell, la rivista scientifica più prestigiosa nel campo della genetica. E sempre su Cell, venerdì scorso, Pandolfi ha svelato il ruolo determinate nei tumori di prostata, colon e cervello umani di 150 Rna che usano il nuovo linguaggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA Rna messaggero Dna oscuro È la molecola in cui il gene trasferisce l’informazione per fare la proteina e la porta al sistema di assemblaggio È il 98 per cento del Dna. Gli Rna dei suoi geni non fanno proteine, fluttuano intorno al Dna apparentemente senza scopo INFOGRAFICA PAULA SIMONETTI ARNALDO D’AMICO Il nuovo codice Gli Rna della parte oscura, con una lingua diversa, regolano il Dna codificante in modo più sofisticato di quello conosciuto Repubblica Nazionale DOMENICA 16 OTTOBRE 2011 LA DOMENICA ■ 42 I sapori Le prime coltivazioni risalgono addirittura al Neolitico, i Romani lo offrivano a Cerere chiedendo la fecondità per i giovani sposi Dimenticato nel Medioevo, è stato riscoperto per l’abbondante Ritrovati contenuto di proteine e l’alta digeribilità. Che ne fanno il compagno ideale dei legumi nei piatti d’autunno Piccolo Medio Grande Vecchio di diecimila anni, il Triticum Monococcum è il primo seme di frumento piantato dall’uomo. Ha poco glutine, rese basse, sapore intenso Il Dicocco è il più coltivato in Italia, soprattutto al Centro In Garfagnana, dove viene ancora macinato a pietra, è protetto dall’Igp europea Dall’incrocio tra Dicocco e Aegilops squarrosa — battezzato col nome tedesco spelz, l’involucro del seme — si ha la farina del Panpepato LICIA GRANELLO n nomeomen, sostenevano i Romani. Un destino nel nome, ma anche un biglietto da visita prezioso. Farro come farina, da fero, verbo latino per portare, sostenere e quindi nutrire. Duemila anni fa, la gente del Mediterraneo aveva come base della dieta quotidiana le antesignane di focaccia (libum) e polenta (puls), impastate con la farina di triticum monococcum, dicoccum e spelta. Allora come oggi, seminati tra fine ottobre e inizio novembre. Quando arrivò sulle tavole dei popoli latini, il farro aveva fatto già moltissima strada e vissuto più a lungo di qualsiasi altro cereale, se è vero che le prime coltivazioni risalgono al Neolitico (8000 a. C), tra Mesopotamia, Egitto e Palestina. A Roma, da semplice alimento diventò simbolo di fecondità grazie alla pratica della Confarreatio, in uso tra le famiglie patrizie: l’offerta della focaccia nuziale richiamava sugli sposi la protezione di Cerere, dea delle messi, portatrice di potenza e fertilità. Le fortune del farro originario sono durate per il tempo dell’agricoltura di sussistenza. Fin dal Medioevo, l’adozione di nuove varietà, figlie di incroci più produttivi (da cui sono nati grano tenero e grano duro) ha causato una riduzione delle coltivazioni, confinate nelle zone agricole marginali, dove la produzione intensiva è impossibile. Il farro si è adattato, imparando a non soffrire il freddo e amare i terreni in pendenza, meglio se calcarei, crescendo anche oltre i mille metri. Oltre alle rese basse, la raccolta faticosa — i chicchi maturi non restano sulla spiga, ma cadono sul terreno — e la perdita di sapienza culinaria lo hanno condotto sul bilico I Farrotto Quaranta minuti di cottura per il risotto di farro, cucinato per contrasto (con acciughe o frutti di mare) o assecondando la tendenza dolce (con funghi, zucca, carote, topinambur) Pane Profumato, saporito, ricco di fibre, si impasta con la farina forte (tipo Manitoba) per irrobustire la modesta quota di glutine necessaria alla lievitazione Zuppa Dopo l’ammollo, si insaporisce in un soffritto di verdure miste e poi si copre d’acqua A piacere, funghi, fagioli, pancetta, olio e crosta di Parmigiano Il cereale antico come il mondo dell’oblio alimentare. Ma per fortuna, il tempo del cibo è galantuomo. La nuova attenzione agli equilibri dietetici ha spinto a riscoprire i cereali negletti, primo fra tutti il farro, straordinario a partire dalla pianta, che protegge i chicchi con un guscio robusto, ostico a insetti e parassiti: un atout fondamentale per la riuscita della produzione biologica e biodinamica. Tra i cereali, è il meno calorico — 335 calorie per cento grammi — e quello a più alto indice di sazietà, grazie allo smisurato assorbimento d’acqua in cottura (quasi tre volte il suo peso). Nei suoi chicchi, abitano generose quantità di nutrienti essenziali: sali minerali (calcio, fosforo, magnesio), vitamine del gruppo B e tante fibre, a patto di sceglierlo nella versione decorticata, che preserva la glumettaesterna, mentre quello perlato è del tutto svestito. Grazie al contenuto di proteine — abbondante e ad alto tasso di digeribilità — è il compagno ideale dei legumi, che contribuiscono con l’aminoacido Lisina a equilibrare il più salubre dei piatti unici. Se vi stuzzica l’archeogastronomia, regalatevi una gita in Franciacorta e dintorni, andando a visitare la cooperativa sociale Antica Terra, a Cigole, Brescia, che ha recuperato la coltura del monococco. I consigli su come cucinare il cereale più vecchio del mondo, invece, chiedeteli a Vittorio Fusari, che pochi chilometri più in là dirige le cucina de La Dispensa (Torbiato). La sua zuppetta di monococco al nero di seppia con tartare di gamberi e crema di mozzarella vi illuminerà il cammino. © RIPRODUZIONE RISERVATA Tortino Dalla base lessata si cucina in versione dolce (amalgamato con cioccolato e uvetta), o salata (legato con uova, formaggio grattugiato ricotta e noce moscata) Farro Repubblica Nazionale DOMENICA 16 OTTOBRE 2011 ■ 43 ILLUSTRAZIONE DI CARLO STANGA Gli indirizzi DOVE DORMIRE PALAZZO TUCCI Via Battisti 13 Lucca Tel. 0583-464279 Doppia 150 euro con colazione HOTEL IL CIOCCO Via del Ciocco 2 Castelvecchio Pascoli-Barga Tel. 0583-766365 Doppia 115 euro con colazione ALBERGO LA LANTERNA Località Le Monache 300 Castelnuovo Garfagnana Tel. 0583-639364 Doppia 90 euro con colazione L’ALTANA Via di Mezzo 1 Barga Tel. 0583-723192 Chiuso merc., menù 25 euro IL MECENATE Via della Chiesa 707 Lucca Tel. 0583-512617 Chiuso lunedì, menù 30 euro ANTICO PANIFICIO DELL’ANGELA Via Garibaldi 12 Castenuovo Garfagnana Tel. 0583-62656 AGRITURISMO PALLUNGA (con camere) Località Pallunga di Sopra San Romano in Garfagnana Tel. 328-9264045 DOVE MANGIARE IL VECCHIO MULINO Via Vittorio Emanuele 12 Castelnuovo Garfagnana Tel. 0583-62192 Chiuso lunedì, menù 20 euro DOVE COMPRARE Insalata Sulla strada Cottura lunga, sapore e consistenza originali per il cereale bollito che sostituisce il riso come base per potpourri golosi: dadini di verdure, uova, formaggi (la foto è tratta dal libro Cucina Mediterranea, Edizioni White Star, a cura di Academia Barilla) Garfagnana a passo d’uomo, un viaggio nell’altrove MAURIZIO MAGGIANI S e davverovolete andarci in Garfagnana, se avete l’intenzione di un viaggio e non di una gita, arrivateci per le strade alte, quelle tracciate dai romani e dai longobardi, quelle che seguono l’andamento dell’Appennino e dell’Apua Alpe con il passo degli uomini. Volete arrivare a un antipodo della contemporaneità, fatelo dandovi uno sguardo adatto. Passo del Vestito e passo del Cipollaio, dalla Versilia, dalla Via del console Aurelio. Passo dei Carpinelli, passo della Pradarena, salendo dalle vie padane che si dipartono da quella del console Emilio. Fatelo con l’accortezza di una moderata velocità di pensiero, perché le gole che vi si parano davanti sono precipizi in cui sono rovinati molti sguardi stranieri. Se è nelle vostre disponibilità, andateci a bordo di un elefante: lo fece Annibale e si procurò, unico tra i passanti in armi, l’amicizia e l’alleanza dei garfagnini. E considerate la morbida complessità della valle del Serchio nel giro d’orizzonte di San Pellegrino in Alpe, da dove il santo barbaro credette di indovinare Gerusa- lemme e fu preso a schiaffi dal diavolo; considerate l’irsuta Garfagnana dal balcone della fortezza delle Verrucole, da dove il governatore Ariosto smaniava nella deprimente digestione del suo castigo di cortigiano, e intanto andava cercando tra i banditi che depredavano i suoi vitalizi chi gli leggesse qualche paginetta dell’Orlando. Ascendete al sacro pastorale di Campo Catino, buttatevi su un masso candido di marmo, strizzate gli occhi e fatevi confondere dal sole che stride dalle lame della Roccandagia, prendete atto che siete nell’altrove. E allora imparate un po’ della lingua di lì e chiedete alla Luciana di Treppignana se per favore vi da una tazza di zuppa, o all’Olinto della Gragnanella se potesse per caso favorirvi di un piatto di ossetti di maiale con la polenta di neccio. Se siete fortunati, e di metabolismo adattabile, potete allora capire l’intimità delirante di un poeta e la misterica veggenza di un santo che si sono nutriti di quell’universo e di quel farro e di quel suino e lì si sono persi per sempre. © RIPRODUZIONE RISERVATA LA RICETTA Rombo al vapore con farro in più consistenze Ingredienti per 4 persone Igles Corelli è uno dei più bravi e “didattici” cuochi italiani. Dopo una lunga esperienza a Ostellato, sul delta del Po, da pochi mesi dirige le cucine di “Atman”, a Pescia, confine tra Lucchesia e campagna pistoiese, dove interpreta con sapienza e creatività i migliori prodotti dell’Appennino toscano. Ha preparato questa ricetta per i lettori di Repubblica 600 gr. di rombo chiodato 600 gr. di farro della Garfagnana bollito in un fumetto di rombo 50 gr. di spinaci puliti 1 scalogno 1 rametto di timo 50 gr. di burro 1 spicchio d’aglio 2 dl di fumetto di rombo Olio extravergine di oliva sale pepe q. b. La cialda: setacciare e frullare100 gr. di farro bollito condito con sale e pepe Stendere il composto tra due fogli di carta da forno unti con extravergine, tirarlo sottile con il mattarello e infornare a 140 ° fino a che non risulta croccante Il gelato: frullare 150 gr. di farro con burro e timo, setacciare e mettere in gelatiera Il purè: frullare il restante farro, setacciare, condire con extravergine, sale, pepe e tenere in caldo. Saltare gli spinaci in padella con un filo d’olio, uno spicchio d’aglio e tenere in caldo La salsa di salicornia: tritare lo scalogno, insaporire con poco olio, aggiungere la salicornia tagliata a pezzi, coprire con il fumetto di rombo e cuocere un quarto d’ora Frullare, setacciare e tenere in caldo.Cuocere il rombo a vapore Presentazione: Velare con la salsa di salicornia il fondo del piatto, su cui appoggiare il purè di farro e poi il rombo. Guarnire con gli spinaci, la cialda e il gelato ✃ ANTICA BOTTEGA DI PROSPERO Via Santa Lucia 13 Lucca Tel. 0583-496234 Repubblica Nazionale DOMENICA 16 OTTOBRE 2011 LA DOMENICA ■ 44 L’incontro Figlie di papà Ci sono voluti quarant’anni, quattro film di successo, due maternità e altrettanti matrimoni per uscire dall’ombra paterna e diventare semplicemente se stessa: “È vero, ho vissuto buona parte della mia vita in una prigione dorata” risponde la regista “Ma oggi sono fiera di far parte di una grande famiglia circense. Nella quale Sofia Coppola faccio un numero che tutti riconoscono come solo mio” ha fatta esordire neonata nel battesimo del Padrino. L’ha portata con sé, a sedici anni, a Cuba da Fidel Castro. Le ha finanziato i suoi film, quattro in dodici anni e tutti di successo. Quanto può essere lunga per una figlia l’ombra di un padre come Francis Ford Coppola? Forse solo adesso che ne è uscita Sofia Coppola lo può dire. A quarant’anni compiuti a maggio, reduce dal matrimonio a Bernalda, nella Basilicata del bisnonno, con il leader dei Phoenix Thomas Mars — padre delle sue due figlie Romy e Cosima — si è finalmente regalata quella libertà cui ha brindato lo stesso padre battezzando “Sofia” una partita del suo champagne californiano con queste parole: «Giovane in rivolta giunta a maturità». E dunque cìn cìn, Sofia. Lei ascolta l’impietoso riassunto sorseggiando Coca Cola, l’espressione concentrata di sfinge intellettuale, nella suite regale di uno dei tanti hotel esclusivi della sua vita e del suo cinema, con la sicurezza semplice di chi è cresciuta nella bambagia di Hollywood: «È vero, la mia infanzia l’ho trascorsa con mio padre tra i privilegi del jet-set e sotto i riflettori del cinema. Come la mia amica e attrice Kirsten Dunst. I set sono stati i nostri primi e unici giocattoli: ma anche i nostri prematuri richiami al futuro. Nell’89 lei, a sette anni, esordiva sul grande schermo in New York Stories, nell’episodio di Woody Allen, Edipo ‘‘ domanda che mi rivolse mia madre: “Non trovi una correlazione tra il soggetto del film e la tua vita privata, il privilegio d’aver vissuto come una principessa sotto l’ala di tuo padre?”. Rispondevo di non aver voluto tracciare espliciti paralleli con la vita di MarieAntoinette, enfant gâtéenella quale mi riconoscevo anche in quanto, fin da bambina, stava subendo quella stessa forma d’apprensione sorda, quella pressione palpabile nello sguardo dell’entourage familiare, nell’aspettativa d’una affermazione senza appello». Va bene, riproviamoci. Detrattori maligni e cinefili devoti concordano nel ricondurre il suo cinema a una formula fissa. Ecco la ricetta: prendere una ragazza, preferibilmente bella, bionda, solitaria, tagliarla a fettine sottili dentro una famiglia inadeguata (Vergini suicide) o oppressiva (MarieAntoinette) o assente (Lost in Translation) o arresa (Somewhere), introdurre una figura paterna in jet-lag esistenziale, cuocere a fuoco lento in ambien- Fin da bambina ho subìto un’oppressione sorda ma palpabile: era l’aspettativa del successo senza appello FOTO PHOTOMOVIE L’ PARIGI relitto; io, che di anni ne avevo diciotto, proprio per New York Stories insieme a mio padre scrissi la sceneggiatura del suo episodio, La vita senza Zoe. Destini di star bambine: due vite dorate ma già prigioniere. Io mi ci ero abituata, dai tempi delle riprese di Apocalypse Now, quando a sei anni avevo seguito la famiglia nelle Filippine, frequentando lì il primo anno di scuola». Da bambina ha assorbito il cinema, ma l’ha anche “suggerito”: «Sì, le mie giornate allo Sherry Netherland, albergo tra i più lussuosi di New York, dove ho abitato a lungo, furono poi reinventate da mio padre in quel suo episodio di New York Stories: la Midtown vi è osservata con gli occhi d’una bambina immersa in un mondo incantato grazie al padre famoso». Pare già il soggetto di Somewhere, il suo Leone d’oro dell’anno scorso a Venezia: il genitore, colosso annoiato dello star system, e la bambina che lo risveglia con l’impazienza di vivere: «È un film che non a caso ho girato dopo esser diventata mamma. Le figlie mi hanno mutato il modo di percepire l’esistenza: mi hanno ribaltato le prospettive, le priorità, influenzato i punti di vista. Un figlio ti cambia davvero la vita. Rallenta di colpo la corsa quotidiana: cammini in un parco con quell’esserino che trotterella sotto di te e ti ci vuole mezz’ora per raccogliere una foglia. Mai, prima, avevi trascorso tanto tempo a osservare una foglia, farla tua. È un riappropriarsi della vita, la riconquista dello sguardo, di cui i bambini ci sono maestri». Somewhere è il ritratto d’una star internazionale, lost in business, di colpo a tu per tu con la paternità: lei e suo padre o lei e le sue figlie? «I rapporti con mio padre e mia madre sono assai diversi da quelli del protagonista con la sua bambina. Ma mettiamola così: girare quel film mi ha portato a guardare in modo nuovo i miei genitori, il mio compagno e anche le mie figlie». Le protagoniste del suo cinema vivono tutte in un tempo sospeso, tra un’infanzia non ancora o non del tutto alle spalle e, dietro l’angolo, l’incognita adulta, che in Marie-Antoinette e nello splendido Giardino delle vergini suicide verrà appena assaporata. Fino a non troppe stagioni fa, quel limbo fatato è stato il suo universo esistenziale, vero? La regista increspa in un sorriso le labbra tumide da eterna collegiale: «Dal pressbook di Marie-Antoinette, cinque anni fa, ho fatto togliere una te chiuso, popolato di estranei, meglio se ostili, far croccare con una spalmata di rock Doc e servire riscaldato. Radiografia troppo tagliente? «Sono d’accordo sull’“ingrediente” colonna sonora. Chi ha da ridire sul duo elettronico Air dei miei primi tre film o su My Bloody Valentine e Death in Vegas in Lost in Translation? Si dirà che i Phoenix sono un po’ ovunque, ma è dalle Vergini suicide che frequento il loro cantante, ora diventato mio marito...». Il milieu rock/cinema indipendente (ribadito dal primo matrimonio con Spike Jonze, finito nel 2003, e dal successivo flirt con Quentin Tarantino) ha fatto della Coppola un’icona della cultura pop e dell’eclettismo musicale spinto fino alla recente regia della Manon Lescaut con Roberto Alagna all’Opéra di Montpellier: «La voglia di darmi al cinema m’è venuta abbandonandomi al sogno di personaggi romantici e fiammeggianti mentre ascoltavo Purple Rain di Prince. Non immaginavo ancora che un giorno mi sarei trovata davanti a una delle cineprese che mio padre aveva regalato a me e ai miei fratelli ancora bambini. Poi, una volta su questa strada, ho premuto a fondo, con determinazione, seguendo puntigliosamente desideri e sogni di grandezza». Ad esempio ottenendo di girare Marie-Antoinettenei saloni di Versailles: «Volevo aprire ogni mattina gli occhi sulle fughe di stanze sontuose che si offrivano due secoli fa alla giovane regina. Ma il Settecento l’ho rifatto di mio gusto, con fruscii di modelle, pettinature punk, broccati da favola, in sintonia perfetta con la costumista Milena Canonero. Per intenderci sui colori, evocavamo sughi per la pasta o nostri sorbetti preferiti: ci si capiva al volo». Sofia Coppola è pop non solo nella musica ma anche nella moda, dove si esprime forse ancor più liberamente che nel cinema: «Mi sono formata al California Institute of the Arts e ho fatto la gavetta per due anni a Parigi da Karl Lagerfeld, dedicandomi nello stesso tempo a foto per Vogue, Interview, Allure, con mostre in Giappone, dove ora si vende in esclusiva la mia linea d’abbigliamento Milk Fed. I miei primi passi sono nella moda: creata, interpretata e ritratta. Sono stata testimonial del profumo di Marc Jacobs, ho firmato una nuova linea con Kim Gordon e girato spot per Miss Dior Chérie. La scorsa primavera ho infranto la linea classica Louis Vuitton, per lanciare una borsa con le mie iniziali. È stato come l’avverarsi d’un sogno d’infanzia, la mia borsa come l’ho sempre immaginata». Ed ecco di nuovo la bambina viziata da un papà onnipotente. Qual è l’insegnamento più importante ricevuto da suo padre? «L’entusiasmo per il proprio mestiere: anche perché mi ha fatto crescere con l’idea che il cinema non è solo un mestiere ma un modo di esprimere se stessi. Per questo ho fatta mia la sua regola d’oro: meglio un piccolo budget che ti lascia libera di realizzare quel che senti piuttosto che una pioggia milionaria che ti seppellisce sotto mille condizionamenti e compromessi e ti toglie l’ultima parola». Si chiude così una staffetta circolare, con passaggio di testimone. Una volta si diceva: Sofia Coppola, la figlia del regista del Padrino. Oggi, sempre più: Francis Ford Coppola, il padre di Sofia. «Non esageriamo! Tra l’altro, non sono l’unica della dinastia. C’è mio fratello Roman, lui pure regista. Mia zia è l’attrice Talia Shire. E ho tre cugini attori, Jason Schwartzman, Robert Carmine e Nicolas Cage, che trovo formidabile: vorrei girare il mio prossimo film con lui. Più che figli e cugini d’arte, ci sentiamo una carovana di circo, ognuno con le sue specialità, i suoi numeri. Tutti in azione sulla stessa pista, a tramandare l’arte di padri e antenati. Sono fiera, oggi, di farne parte: con le mie iniziali su una borsa, il mio nome per esteso nei titoli di testa e un numero che tutti possono riconoscere come mio». © RIPRODUZIONE RISERVATA ‘‘ MARIO SERENELLINI Repubblica Nazionale
Scarica