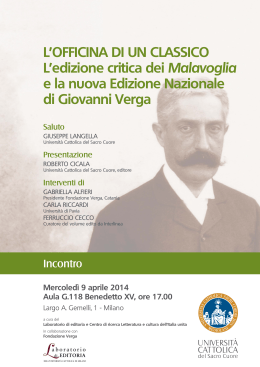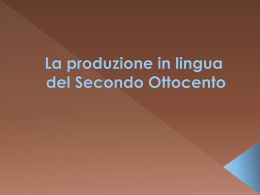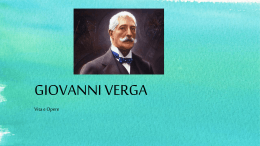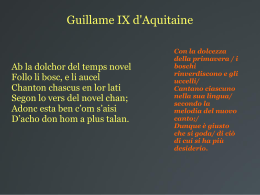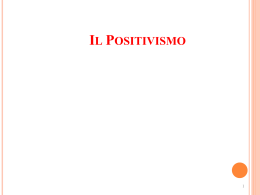TRE ANNI IN SICILIA
(e altrove...)
di Marzio Pieri
LEGENDA – Tre anni fa (2002) l’Ufficio Stampa della Utet, per segnalare l’uscita del
secondo tomo di una vasta antologia del Verga da me (penso improbabilmente)
confezionata per i Classici italiani della Casa torinese (diretti da Giorgio Bárberi Squarotti).
mi invitò a mettermi in contatto col dottor Gianni Bonina, redattore di una pagina culturale,
“Stilos”, su “La Sicilia” di Catania. Ne nacque una intervista (che qui di séguito si
ripubblica) e un invito a collaborare alla pagina. Lo feci volentieri: in vita mia ho
collaborato a “La Balestra”, al “Corriere del Ticino” (poesie....!) cui mi aveva indirizzato il
poeta e mago fiorentino Roberto Sicuteri (si cercavano i maestri dove si poteva), alla
Gazzetta di Parma, dove addirittura diressi (di fatto) per tre numeri (di nome, per tre anni,
visto che per un misterioso disguido non si decidevano a depennare il mio nome dai
responsabili della testatinai) un secondo “Raccoglitore” (pagina culturale, mitica in Parma
come il prosciutto, per la serie degli anni Cinquanta, antologizzata da Paolo Briganti) ma
soprattutto costituii per un quindicennio un vero “numero”, un houdini o un bagonghi, per le
mie lettere al direttore (l’indimenticabile Baldassarre Molossi), all’Avvenire, al Manifesto,
eccetera. Mi cercavano loro e poi smettevano di cercarmi. Si vede che non piaccio, ci si
nasce. Non era una tragedia, visto che non mi davano una lira. Quando non costi nulla è
proprio vero che non conti nulla. Per questo è bene fare le antologie scolastiche. Io, si sarà
capito, riesco a vivere senza i giornali. Ma l’antico vizio di scrivere, “se mi toccano”, mi
ripiglia facile. Su “Stilos” le cose sono andate benino, poi, d’improvviso, il mio scrivere un
poco dissennato cominciò a parer intollerabile al Bonina (che, stranamente, a un punto del
percorso si era visto lui stesso, mi rivelò, assalire dal solito ignoto per il suo “scriver
difficile” – ma il “difficile” non è oggettivo, io ripetei la seconda media per aver trovato
difficile il teorema di Pitagora e l’Iliade del Monti, questa tuttora a me incomprensibile
come il Verdi dei parmigiani o il flauto di abbado –, tanto che mi chiese difenderlo, in una
lettera che gli scrissi e che poi non pubblicò; quella che chiude qui in avanti la scelta). Non
ho mai desiderato sporcare i tappeti di nessuno, dunque ne sono uscito come un leprotto non
però spauritoii. Raccolgo qui una serie di contributi, per questi due o tre anni, al foglio
trinacrio, in memoriam. Li impinguo con alcune pagine destinate ad altre sedi, certune
pubblicate (ad es. sul torinese “Giornale della Musica”), altre in corso di stampa in sedi
diverse (le segnalo con un asterisco accanto al titolo). Tutti insieme i pezzulli riescono a
dimostrare, mi auguro, una prospettiva d’insieme non arbitraria, per quello che valga.
E valga nulla. Ci sono le antologie, materiali senza l’immaginario. Han da esser dobloni.
(marzio pieri)
i
La notte della mia designazione a direttore della pagina (scelsi però, avendo già mangiato la foglia, una specie di codirezione alla pari con altri del giornale o della buona societas parmigiana) ricevetti una strana (?) telefonata, da un
signore di alto prestigio nella cittadina (toscano, d’origine, come me), che mai mi aveva telefonato prima e non mi
avrebbe mai ritelefonato dopo (un dopo di vent’anni): “badi che le dànno questa direzione per favorire il lancio di certi
giovinotti salottardi, poi la faranno fuori...”. Mi mise la curiosità e tirai dritto. Il terzo numero era a cura di uno di questi
giovinotti (un caro, stimabile ragazzo, che poi si levò sùbito dal cervello le frenesie letterarie) e riguardava l’allora
confermando (ma si poteva sconfessare) rinnovo dei patti lateranensi. Il giovine, serissimo, diede una pagina ai
favorevoli (firme illustri) e ai contrari (illustri firme). Una cosa onesta. La mattina che uscì la pagina, alle sette fui
svegliato dal direttore del giornale: “Che cosa mi hai fatto? Qui il telefono sembra impazzito”. La curia non voleva che
neanche se ne parlasse; e aveva azioni nel giornale. Eh eh.
ii
Io ho stima del Bonina. Ma fra i carichi che ab irato mi diede fu anche quello (ridiculus mus) che io fossi al soldo delle
piccole case editrici delle quali – per meditata e ragionevole scelta di campo – preferisco segnalare i libri, avendo quelle
grandi a disposizione tutta la grande stampa nazionale. Se Lei, caro professore, vuole fare pubblicità gratuita ai suoi
amici, non deve chiedere 5 mila spazi-battuta a stilos. 5 mila spazi! Sono il corrispondente di una cartolina postale
scritta davanti e di dietro. M’hanno detto che beppe va soldato. Della Finestra di Albertazzi sono, è vero, e non è un
mistero per nessuno, consulente editoriale (si pubblica marino, benco, lubrano, anton maria salvini, esiodo, petronio in
salsa napolitana, i minori dell’800...); albertazzi ne trae il conforto di un amico studioso più anziano col quale
consultarsi e io quello di un giovane che non si lascia disarmare dall’indirizzo lucrativo e rinunciatario dei tempi, ma
non si arricchisce certo coi libri che gli suggerisco di pubblicare (ne vende poche copie quasi esclusivamente fuori
d’Italia) – e io non ne ricevo compenso alcuno, intendo che sia ben chiaro: compenso monetario, ma l’unico e altro che
per me conta: il sentimento di una collaborazione fra gente che studia. Come conobbi la Finestra? Ricevetti per posta il
dono, del tutto inatteso, di una magnifica ristampa anastatica delle poesie di Onofri. Non mi sentii di accettare il dono e
chiesi all’ignoto editore di permettermi di pagare il libro. Ne ebbi però (per sua iniziativa) uno sconto; e ne seguì una
visita, con la sorpresa di trovarmi di fronte non un maturo signore ma un ragazzo più giovane o quasi dei miei figliuoli.
Ecco. Quanto alla Mesogea (visto che quello ha poi suscitato gli scandali manifestieri), io non sapevo nemmeno che
esistesse. Un amico, un siciliano che vive e lavora a Prato, editore accuratissimo di Pizzuto, di Ripellino, di Fiore, mi
fece avere in omaggio due libri da lui curati per quella casa, un nuovo Fiore e un nuovo Pizzuto. Il dono si
accompagnava a un catalogo, come fanno molte case editrici. Io scorsi il catalogo e ne colsi una singolare originalità,
sicché per prima cosa ordinai tutta una serie di libri alla Casa, regolarmente pagandoli (senza sconto) – il che dovrebbe
essere ovvio, ma si sa che è contro il costume corrente. Uno ‘pretende’ dall’editore l’omaggio del libro. Ci lasciai, visto
che vivo di uno stipendio e non ho beni al sole, una buona fetta del mio mensile e tanto ne fui soddisfatto che scrissi
quel pezzullo di presentazione degli indirizzi mediterranei della Casa.( E non ricordo di averne avuto nemmeno un
biglietto (non dovuto) di grazie). Inde irae. La funesta casseruola va squassando la città / e il lavello un po’ giulivo
versa l’olio qua e là. / Pentolone manifesto, ce ne resta la metà. / Cuoco illustre ma malatto, che bel pezzo di manzo hai
tu bruciatto.
PROLOGO IN CIELO*
(ieri, oggi, ierilaltro...)
Il giorno di San Valentino (leggo su Televideo) il presidente ha parlato a Grosseto, fante tra
i fanti: toscano fra i toscani. Ha detto che in Italia si bisticcia troppo. Benedetto uomo. Qui,
in pochi mesi, un regime ha chiuso tutti gli oblò; chi è dentro è dentro. Magra consolazione
pensare che non è che il passaggio da un regime all’altro [ora (2005) probabile il ritorno
dell’Identico]; chi si aspetta vantaggi dal nuovo non è incomprensibile che possa gioirne, e
che si dolga chi era venuto sù convinto di essere inamovibile. C’è anche chi ha subìto gli
oltraggi dell’antico e subisce quelli del nuovo montante. Mi assiste il fatto di non avere mai
sperato o brigato per favori. Il medico che sta di guardia al pronto soccorso non può darsi
alla fuga se gli càpita una testa da riattaccare, delle budella da ricucire nel sacco immondo.
Così chi fa il mio mestiere (chiamatelo come volete, l’insegnante, [il professore indegno.
R.C.], il critico, l’intellettuale, lo scrittore, il rompiscatole, il guardiano del faro...) non può
turarsi gli orecchi, cucirsi gli occhi perché quello che vede, e che sente, non gli piace, gli è
anzi tortura. Cassandra? Ma fossi magari anche l’oca del Campidoglio... In Italia presto non
ci sarà che una opposizione telecomandata. La scuola è un lager, l’università una fabbrica di
servi ubbidienti, l’informazione è libera di indagare sul bambino di Cogne (ma attenzione!
ci potrebbe essere chi pensa ad andare in vacanza altrove, dove la gente non ammazza
bambini...) ma non sa nulla e nulla vuole sapere di Manhattan, basta strillare tutti in coro
sulla falsariga del mezzo-vero mezzo-falso. Certo questi talebani scalcagnati non parevano i
guerrieri da science-fiction che hanno potuto realizzare quel delitto atroce — non conosco
atti di guerra che non lo siano e non mi appaga la coscienza tener la distinzione formale fra
guerre dichiarate e non dichiarate, [“achtung! Banditen...” e vedere i giornali borghesi che
cosa scrivevano] ma se volete fatelo, e tiratene però, poi, anche le conseguenze — ma
perfetto: troppo perfetto. Sarà la mia abitudine al dubbio sistematico – al: “chi glie ne viene
qualche cosa in tasca?” cui mi addestrarono i miei maestri di storia (Cantimori, Sestan, ed
ovviamente il Droysen, mica i collitorti televisivi). Se Geronimo fosse riuscito a eludere le
pattuglie delle giubbe blù e a scaricare l’atomica su Washington, che volete vi dica? «Credo
quia absurdum». Ora [e ancora...] abbiamo un fascista agli esteri, e voi dite che è solo un exfascista, dopo i lavaggi rettali di fiuggi? Uh corvaccio corvaccio. Uno si può lavare la
camicia. Semel abbas semper abbas. E tornano, [e ci stanno], da ultimo, i cittadini Savoia.
L’onorevole Angius (ne avreste dubitato?) è corso a unirsi al coro dei plaudenti, di quelli
che capiscono e si adeguano. Questa è gente che non si immagina se non vicina al potere.
Serba sempre l’ultima raffica, ti può sempre venire buona. Lizzani è passato dal Processo di
Verona – livido, colore del tempo, con una vigorosa Silvana Mangano (ahi non più
coscialunga!) che faceva la figlia di Mussolini e cercava di salvare “il suo uomo” – ai colori
in prima serata della Beata Maria Josè. Gente così, gli italiani. Non stai mai troppo in basso.
Chiaro che il richiamo in terra italiana, repubblicana [?], dei “cittadini” Savoia non è per le
loro virtù, piuttosto per assenza di delitti (per quanto qualche fucilatina principesca,
scappata come un peto, nottetempo, su uno scoglio deserto, sia rimasta fra le tante ustiche
d’italia, minime, imperscrutate) e poi perché (dice): “non faranno politica”. Sarà; ma
l’appetito vien mangiando. Del resto la prima legge è stata l’oblianza della storia. Puntuale
rispunta il “libro cuore”, lo traducono in Francia? va bene, deamicis o calvino, questo o
quello per voi pari sono. I Savoia non fecero un gesto per fermare il fascismo (ne fecero
però per chiamarlo al potere); ne presero le distanze (e con una vigliaccata) arrestando il
dittatore quando era rimasto disfatto, trucibaldo e solo. Ah è morto dunque, è proprio
andato. Il Manzoni non scrisse un gran romanzo ma gli italiani li aveva capiti. Poi
scapparono come scapparono, quella lunga notte delle macchine a fari spenti. Monarca che
fugge buono per un’altra volta. Non puoi non volergli bene, al presidente. A me basterebbe
la sua passione verdiana (ferma al va-pensiero ma non basta?), la sua convinzione che la
patria si serva (e si salvi) anche cantando insieme una canzoncina sentimentale, volare-oh
oh, una marcetta basta non sembri l’Internazionale (scommettete che mettono in
proscrizione la Norma, per quel coro dei Druidi che sembra proprio la vexata quaestio? O ne
rifanno una edizione critica, inventandosi un autografo belliniano dove i Druidi cantino:
“Norma Norma chi non saprà morir? / Questo Irminsùl chi mai lo tradirà? / Snuda la spada
degli antichi eroi / e manganello al vento noi verrem con te»). Il Presidente del
Borgorossofootballclub la pensava uguale. Si è arreso del resto perfino Muti, [allora ancora
dittatore-in-ostaggio della Scala] dopo un abbozzo di resistenza per decenza e pro forma,
come quando date la mancia a un facchino e quello dice “non permetto”, mentre intasca la
moneta; ora se glie lo ordinano suonerebbe (basta di salvarsi [ma non è bastato...] la Scala
seppure degradata ad Arcimboldo) anche giovinezza anche faccetta nera anche la marcia
regia in pentola ... “le donne non ci vogliono più bene” e: “rapidi ed invisibili partono i
sommergibili.” Ma ve lo ricordate Il federale? La fisiognomica non tradisce. Muti
nell’albero genealogico deve averci avuto quantomeno un carabiniere. Io non son bello
come lui ma posso mostrare di averci, all’uopo, le carte in regola: la mia nonna materna,
friulana — la chiamavano “la Carabiniera.” «In una casa dove uno s’impicca, altri si
ammazzano fra di loro, altri si danno alla prostituzione o muoiono faticosamente di fame,
altri ancora vengono avviati al carcere o al manicomio, si apre una porta e si vede una
vecchia signora che suona — molto bene — la spinetta». Era (per Saba) l’“ultimo” Croce.
Ne vennero degli altri, meno bravi, ottusi (alla storia, che leggono da padroni) alla pari, alla
pari.
I
INTERVISTA SU VERGA
1) Lei rilegge Verga consapevole che “nessuno ha mai parlato così”. La più innovativa,
rivoluzionaria, delle sue osservazioni riguarda la statura decadentista del maestro del
verismo. Luperini parlò di un Verga allegorico ma non è la stessa cosa dirlo adesso
decadente. Ma c’è un anello da stringere meglio: come nasce il “matrimonio” tra il sermo
humilis cristiano e l’enigma decadente, sempreché si accetti la natura cristiana di Verga?
Già una domanda così complessa mi ràdica nella mia convinzione che è davvero difficile
riuscire a farsi intendere; qualcosa di simile deve avere osservato Ezra Pound, che citai da
qualche parte (non so tenere la nota dei miei libri, la distinta delle mie affermazioni, che non
mirano mai a stringersi in sistema, o in dimostrazione, ma a far procedere il discorso, e tanto
meglio se vicino a una possibile verità arriva prima l'interlocutore, da me stanato, o
depistato, di me). Del resto l'unico poeta, di quelli da me personalmente conosciuti, che sia
riuscito a suscitare in me ammirazione ("è del poeta il fin la meraviglia") e durevole
rispetto, Vittorio Sereni, l'onesto, il perplesso, il non decadentista per definizione, e per
mira, mi ammoniva, fingendo di autocriticarsi: "quando non riesco a farmi capire, la colpa è
sempre mia, per mancanza di espressione adeguata". Per me Verga è fuori d'ogni ipotesi di
decadenza (la quale richiede, alla fine, sempre l'idea-base, nichilista e aggressiva insieme,
che la parola è sempre sostituibile, "appare" e non è costretta a mantenersi fedele quando le
si mostri una gibigianna di poter apparire "di meglio", o "di più", o semplicemente diversa,
basta che non si spengano i riflettori); Luperini è decadente, con la sua allegoria che c'entra
quanto i cavoli a merenda, e infatti la sopravvivenza di certo marxismo accademico non è,in
fine, che un fatto di sottigliezza e appariscenza, come si fa a escogitare, a tavolino, un punto
di vista diverso, pungente, e che finisca direttamente in quella sottospecie della critica che
sono i manualetti di "storia della critica"? Dionescampi. A me sembra sommamente inutile
mettere in mano a uno scrittore degli strumenti che egli non ebbe, non sospettò, e dei quali
dunque non si servì. Verga lettore di Auerbach? < .... > Meno mi fa specie che il Verga
possa essere detto cristiano; ma non cattolico, per carità. E questo basta e avanza a
distinguerlo dallo scrupolosissimo Alessandro Manzoni, questo poi è un sapegnismo
addirittura larmoyant. Come se non bastasse la differenza delle scritture in atto, vogliamo
chiamarle le poetiche? Per Manzoni non ci deve essere una virgola che sia sfuggita al
controllo (e al tormentoso frugarsi) dello scrittore, nel cui mondo non deve esserci a
muoversi foglia che lo scrittore (riflesso di un Dio perfetto) non voglia. In lui è il trionfo
della prospettiva. Verga monta su dio (lo scrivo, per lui, minuscolo, come dada) come su
una giostra impazzita e dal rumore assordante del divenire (tragico, anche nell'idiozia che
spesso tormenta gli uomini, li riduce a fantocci doloranti, ad automi con le budella, e qui
Verga senza saperlo è più russo che italiano o francese, e molto prima che i russi via Parigi
venissero in moda) strappa dei gridi, dei frammenti, dei cristalli impazziti e pericolosi (guai
a tagliarsi, non sono i liquidi cristalli petrarchisti, son pezzi di vetro che tagliano le arterie,
che tetanizzano). Dunque, se Verga è cristiano (ma, Le confesso, sono abbastanza stufo
della cabalettuccia "perché non possiamo non dirci cristiani", tante altre cose non possiamo
non dirci, e insieme tante cose non vogliamo che di noi si dicano, la tradizione è
amputazione mirata, non un basto grandioso che ci schiacci), lo è nel segno (poco italiota)
del cristianesimo tragico e, più che mai, per il senso corporeo, antiplatonico, "creaturale",
della umanità. Il più grande studioso del Verga, Gino Raya, aveva escogitato quella sua
teoria della fame, e non per nulla era la bestia nera dell'idealista Luigi Russo (oh, un grande
critico, un grande polemista, e non di rado un grande uomo, per quello che sia consentito
esserlo a un professore d'università) che aveva targato il Verga coi segni scolasticamente
vincenti (e piccolo-borghesi) della espressione (in senso crociano), della memoria, della
sicilianità affettiva ("mamma son tanto felice..."), dei "buoni" sentimenti, insomma ne aveva
fatto un poeta. Ecco, su questo insisterei. E che Verga, discendente di baroni impoveriti,
questo no, non fu mai un piccolo-borghese, come lo fu invece sempre d'Annunzio e la
legione dei dannunziani.
2) Ma Verga è anche uno scrittore antistorico, l’antistoria rappresentando il suo filo
d’Arianna nello speciale “labirinto” che è il suo mondo, esplorato bene da Sanguineti. Lei
lo ritiene un autore in linea con la storia? Dopotutto fu lui a sollevare tra i primi la
questione meridionale in Sicilia.
Mah. Luigi Baldacci è fra quelli che ho conosciuto il critico universitario che ho amato di
più (non contano le differenze di giudizio particolare). Al nostro primo incontro (ero
studente) gli diedi un piccolo dispiacere opponendomi alla sua idea che Fucini, dico Fucini,
il piccolo maestro toscano, col suo sigaro e il suo schioppetto da caccia per medicarsi del
fatto immedicabile d'essere nella vita ispettore scolastico o qualcosa di simile, avesse, con la
sua Napoli a occhio nudo, dato una mano al varo, fra le belle signore dei salotti, e l'onesta
borghesia dei lettori pancifici e manzoniani, di una questione meridionale, allora portata
sugli scudi da uomini di buona razza politica come Giustino Fortunato. Quella è l'inchiesta
da rileggere per chi sia interessato alla "vera" questione meridionale. I letterati sono un poco
mosche cocchiere di parte bianca e (quando va bene) il soccorso di Pisa. Io, dissi a Baldacci,
con la tagliente limpidezza di una nouvelle vague che sentivo prepotente ricalcitrare in me,
ritengo che proprio l'"occhio nudo" vantato dal titolo sia una menzogna, non dico volontaria
o per far male. Fucini pensava a fare il pittore, il macchiaiuolo in partibus, era un poco la
bella dama con tutte le sue valigie che scende ad Aci Trezza, col suo amante (il Verga
piaceva alle signore, non ho mai capito se fosse per le dame una specie del bello stalliere
dell' Amante di Lady Chatterley) e prende una cotta per il colore locale, ma non ci mette
molto a rinsavire; e il Verga le indirizza la famigerata sculacciata che abbiamo tutti letto col
titolo Fantasticheria. Verga (debbo averlo anche scritto, da qualche parte) non ha l'istinto
dell'occhio, quando fa il pittore (specie nelle novelle) lo fa sempre con applicazione, con
diligenza; qui davvero è una parola di secondo grado, una messa su carta della visione dei
pittori. La sua percezione del mondo è acustica (leggere i Malavoglia a volte sembra come
ascoltare i chilometri di nastro registrati da una spia telefonica) e basso-corporea (senza però
rabelaisismi o scurrilità), la luce che vede è solo assoluta, accecante, come proprio nei
quadri di un grande pittore siciliano, Guccione, e il suono è un brulichio a distanza stellare,
come nelle pitture musicali di un grande poeta in musica siciliano, Salvatore Sciarrino. Il
suo filo d'Arianna, del Verga, è questo, non l'ideologia. Anche l'antistoria è una ideologia.
Verga (non dimentichiamocelo mai) era di quegli uomini che, per destino, non prendono
moglie.
3) Non ho capito bene se lei preferisce il Verga siciliano, il secondo e più grande Verga, o
quello milanese, dei romanzi borghesi e tutto sommato dannunziani?
Rileggevo proprio stamani una pagina di diario di Gianandrea Gavazzeni (un grande
ammiratore del Verga, fra l'altro). Il critico musicale Massimo Mila era tornato sulla accusa
fatta a chi sembrava che ammirasse, fra le opere di Giuseppe Verdi, più quelle giovanili, e
minori, che i cinque o sette capolavori conclamati. Risponde Gavazzeni: "non è vero, non è
che si preferiscono i Masnadieri al Rigoletto, o la Battaglia di Legnano all'Aida, si chiede
solo il diritto di poterseli studiare, e, magari, una volta nella vita, eseguirli o vederli
eseguiti". Potrei fermarmi qui. Ma nella mia prospettiva una cosa è più vera: per me,
"capolavoro" non è una posizione in classifica, ma uno stato, quasi un "genere". In questo
senso, i Malavoglia sono, in misura diversa, un capolavoro come Eros, e, addirittura in
esordio, quando la riuscita o no deve decidere del futuro di Giovannino Verga come
scrittore (voleva dire un salto senza rete), i Carbonari della montagna. Nessuno si
scandalizzi. Per spiegarmi meglio, dirò che non è un capolavoro la Cavalleria rusticana in
teatro, fortemente voluta da Giacosa più che dall'autore stesso, mentre un capolavoro è In
portineria. Se Cavalleria, che ebbe enorme e sorprendente successo, fosse caduta, Verga
avrebbe semplicemente rinunciato al teatro. Quando cadde, comprensibilmente ma
immeritatamente, In portineria, dove Verga davvero aspirava a realizzare una sorta di
avanguardia teatrale, un "teatro del futuro", come si diceva "musica del futuro" per quella
scandalosa wagneriana, Verga ne fu ferito quasi a morte e colse l'occasione per
demilanesizzarsi. Un chiarimento, però: la mondanità verghiana non ha nulla dello
sperellismo dannunziano, Se c'è un romanzo che assomiglia a Eros, non è il Piacere, ma
Decadenza di un amico del Verga, più parigino che milanese, (scriveva un francese
magnifico, non maccheronico alla d'Annunzio), il Gualdo, che piaceva al nostro critico più
davvero francese, Carlo Bo. Quanto alla Sicilia del Verga, una cosa va tenuta ferma: è per
lui come la remota California di Bret Harte, lo scrittore americano diffuso in Italia dal più
ufficiale editore anche del Verga, Emilio Treves. I Racconti californiani sono nella
biblioteca di Giovanni Verga. Cavalleria, la Lupa, il Gesualdo, non pèrdono a essere
immaginati come storie di un West semiselvaggio e con sue leggi proprie, eccezionali, con
le sue sfide all'OK Corral, che noi sappiamo bene essere stati regolamenti di conti fra mafie,
i suoi Duelli al sole, con un bel prezzo pagato a una sessualità quasi ferina, e all'aria aperta,
e i suoi baroni del bestiame, come nel Fiume rosso o nel Grande paese.
4) Verga secondo lei è stato lo scrittore più cristiano dell’Ottocento. Dunque è più vicino a
Manzoni di quanto non si creda. Dunque la Provvidenza non è solo una barca.
No no no. Credo di avere già risposto. La "Provvidenza" è una barca una barca una barca
una barca. Con banderuola antimanzoniana.
5) Se Verga è cristiano ha torto dunque Vittorini ad averlo definito “schifosissimo” perché
reazionario. Eppure Verga reazionario lo fu davvero: anche come scrittore oltre che come
cittadino della migliore società.
Uno può essere cittadino dell'ottima società e non essere reazionario (e, viceversa, uno può
essere del quarto stato e fascista, Pasolini docet). Vittorini - che è il più grande scrittore
siciliano del Novecento - aveva le sue contraddizioni e i suoi scatti quasi operistici.
Esemplari, in una terra critica delle mezze verità pronunciate a mezza bocca e pronte ad
esser sùbito ritrattate. Non si deve dimenticare che quando Elio stilò quel celebre giudizio,
poteva vedere in Verga una doppia, trascorsa, improduttiva ufficialità: quella crociana e
quella fascista. Verga fu adottato dal fascismo quasi quanto Dante e Leopardi, e, a
differenza di questi ultimi, aveva agli occhi dei crociani il vantaggio di sembrare (nella
breve rosa dei capolavori accolti) tutto risolto in liricità. Tanto vero che Croce, nella sua
Letteratura della Nuova Italia, che tante volte ci sembra un ospizio di vecchi cantanti
sfiatati, non trova posto per Federico De Roberto, l'anti-lirico, l'intellettuale e quasi
matematico De Roberto, che apre magari la strada a Borgese, a Brancati, a Pirandello (ma
non al Principe di Donnafugata, qui c'è un equivoco nato da una lettura superficiale dei
Viceré), vogliamo spararla grossa?, perfino al fogazzariano Piovene; e a Vittorini, anche,
perché no? Vittorini per certi versi (l'ambizione teorica, l'aspirazione alla leadership)
sembra più un Capuana (l'altro gran siciliano ingiustamente dequalificato nella tradizione
crociano-marxista dei manuali) e per altri versi (la visione vasta, lo sguardo avanti, la
sensibilità mitico-antropologica) è uno scrittore che non si può immaginare prima del
Novecento e senza la letteratura (biblica) americana. Il suo capolavoro è irrealizzato, Le
donne di Messina. Un altro western, western autunnale, anarchico (da Peckinpah a Cimino,
uno ha origini pellirosse, Cimino credo proprio siciliane).
6) Lei nega in buona sostanza che Verga sia un romanziere, uno scrittore di romanziromanzi: semmai ha allungato delle novelle così da fare di Fantasticheria I Malavoglia, de
La Roba Mastro Don Gesualdo. Avrebbe più che altro rifatto gli altri: non solo Balzac e
Flaubert, ma anche Foscolo l’Ortis del quale diventa la Capinera. Dunque un Verga
rifacitore e quindi tutto sommato minore?
No, qui Lei mi fa dire troppo più di quello che io non voglia; a parte il fatto che non mi è
possibile credere ad alcun rapporto di Verga con Balzac. Letteratura non facit saltus, la
società italiana, fattasi ormai sabaudo-verdiano-manzoniana (poi ci prendiamo un digestivo
forte...), non era certo in grado di concepire (ben maculata concezione) un Balzac. Qui si
tratta di giganti. Dante, o il Capitale, per non dire la solita Recherche (ma in Balzac non c'è
ombra di barocco, o preziosismo, come in Marcel). Certo, romanzi-romanzi in Verga sono
solo i Carbonari, su modello dumasiano. Ma non mi contenterei nemmeno di dire che la
novella, come il sonetto secundum Carducci, è un "breve e amplissimo carme". Verga non
era un lirico, era un intellettuale molto intuitivo. Se capì che data quella società il
romanzone era un abuso, una stonatura, un prodotto di palestra body-building, va tutto a suo
onore. L'Ortis si pone (anche sotto l'influsso iniziale del patriota e spretato Dell'Ongaro)
come vessillo antimanzoniano e anticlericale (non mi viene in mente un prete nel Verga che
faccia bella figura), io trovo molto suggestivo che Verga (con un bisogno di confessione che
gli anni smorzeranno in lui) si autoritragga prima come Corrado il Carbonaro, poi (alla resa
dei conti con la realtà politica) come il protagonista del romanzetto Una peccatrice (che ha
ceduto il fucile per le glorie altrettanto illusorie del palcoscenico) e poi come la "capinera"
monacata per forza. Madame Bovary c'est moi? Certo che dei francesi lo scrittore che più
incide su Verga è Flaubert (dianzi ho detto la California, per Sicilia, ma potrei anche dire la
Cartagine di Salammbô, fra i miraggi donde rinasce la Sicilia "more geometrico
demonstrata" del Verga). La differenza è che Flaubert poteva giovarsi di una lingua
letteraria moderna in pieno vigore e Verga, se si ritraeva dal gergo manzoniano, aveva solo
da cadere nelle paludi - fra giornalismo sciatto e preziosismi da nuovi ricchi - della doppia
Scapigliatura. O Cameroni o Boito, con una preferenza (che era anche scelta politica) per
Boito.
7) Verga autore in bianco e nero, contrapposto al mondo degli autori suoi contemporanei,
D’Annunzio in testa, che è tutto a colori. E’ un modo per sminuirlo o per distinguerlo?
Distinguerlo, distinguerlo. Che Dio lo benedica. Ma in bianco e nero era anche perlopiù
Capuana, e De Roberto sempre.
8) Lei dice che in fondo la novellistica italiana si riduce a due sole grandi raccolte: il
Decamerone e Novelle per un anno. Questo vuol dire che Pirandello fu più grande di
Verga? Eppure, lei stesso precisa che il migliore Verga è quello delle novelle.
Lo dico a tutto raggio e un poco al gioco della torre. Forse ho fatto capire, a questo punto,
quello che credo della falsa scissione fra romanzo e novella in Verga. Certo, Verga è un
grande scrittore come ce ne sono nell'intero arco storico della letteratura italiana. Altro
discorso è quello dei fondatori. La letteratura italiana è fondata da Boccaccio (Dante è
un'altra dimensione, e non ha séguito se non retorico, Dante appartiene al Medio Evo cioè
all'idea di una letteratura universale, e non autonoma!, null'affatto nazionale). Per trovare un
autore di pari livello (e di pari portata all'estero) io credo si debba saltare al Tasso. Se no, si
esce dalla letteratura: Leon Battista Alberti, Leonardo, Michelangelo. L'altra grande
creazione è l'Opera secentesca (Firenze-Mantova, Roma, Napoli, Venezia). Rossini (lo
pensava anche Bacchelli, dopo Stendhal) si beve il modernismo timorato di Manzoni e il
classicismo eroico inciprignito di Giacomo Leopardi. Poi bisogna saltare a Pirandello. Padri
fondatori, ho detto.
9) Tre anni dopo i Romanzi, Utet distribuisce le Novelle e il Teatro. Lei scrive nella sua
introduzione che Verga “sta richiudendosi in una solitudine diversa da quella, fiera e
repulsiva, in cui egli stesso era riuscito a rinchiudersi”. E parla di enigma. In che senso? E
qual è l’idea di questa nuova riproposta delle opere novellistiche e teatrali di Verga?
Non è stata una marcia trionfale. I Romanzi, che mi erano stati proposti da Giorgio Bárberi
Squarotti come una vera e propria provocazione, della quale gli sono molto grato, per
tirarmi fuori dalla mia dolce caverna di manieristi, barocchi e operisti, spiacquero a
qualcuno che non so, "in alto loco", nella casa editrice, e rimasero in giacenza un numero
d'anni che non sto a dire, tanto parrebbe incredibile. Sembrava addirittura che non sarebbero
usciti mai, tanto che una affiliata dell'Utet, la TEA, estrapolò a un certo punto dal mio
lavoro l'edizione e il commento ai soli Malavoglia. Poi, non certo per mio merito, le cose
sono cambiate, oggi la letteratura italiana ha rinunciato alla sua visione basata sulle
convenienze e inconvenienze risorgimentali. Basta aver letto Manganelli. Oggi, dire di uno
scrittore che è fiero, solitario e ripulsivo non fa più paura a nessuno. Magari si ricalcitra ad
ammettere che, come uomo, non sia un grande uomo, forse per questo ci manca una
edizione scientifica e il più vicina possibile alla completezza delle lettere del Verga.
Nemmeno la quasi abortita Edizione Nazionale la prese in considerazione. Verga, da
Firenze, scrive alla madre, ovviamente adorata, e ai fratelli, essenzialmente dilettissimi,
rimproverandoli perché non son puntuali con lo spedirgli l'assegno mensile tanto che, in una
delle bollenti estati di Firenze, egli non può nemmeno comprarsi il gelato. Giambattista
Marino avrebbe potuto avere le stesse preoccupazioni ma, nel metterle su carta, si sarebbe
mascherato in un genere letterario burlesco o di stile basso-ludico. Verga dice sempre quello
che pensa, quando pensa, anche questo è un enigma. I vasi più misteriosi son quelli lasciati
esposti alla pubblica fede.
II
VERDI NEL CASSETTO*
E hanno dunque ragione i portaborse, che allora tacquero. Nel Duemilauno mancò non
soltanto l'Odissea nello spazio; nella accoppiata scienza-fantasia il termine secondo è
perpetuamente sconfitto, quando global-politiche congiunture non intervengano a dargli una
mano. Mancò anche una degna celebrazione verdiana, seppur grande ne fosse il rimbombo.
Dicono i portaborse, già preoccupati di trovarsi ai primi posti della coda per le future
ricelebrazioni (al 2013), che si è molto esagerato e da una parte e dall'altra; una parte
essendo i promotori-autovantatori delle celebrazioni, delle quali dispiace aver visto cadere
tra vittime e complici anche il rimpianto Luciano Berio e anche il non mai tanto poco
sulfureo Sanguineti (ma la colpa è di Verdi, della sua davvero storica, e tagliente, ambiguità,
divisa fra i miliardi, meritamente accumulati, e il quarto stato; e fra le latomìe e la barricata).
E l'altra parte, allora soffocata, che maramaldescamente bartaleggiava. Non le andava bene
nulla. Ma a Busseto (e, significativamente, in una divisione emarginata dalla più imponente
irregimentazione festivaliera, benedetta dai soldi romani) qualcosa di importante, e a mio
credere di decisivo, si produsse: la messa in scena della Aida affidata a Franco Zeffirelli
dalla Fondazione Toscanini e dalla Orchestra che ad essa fa capo. Anticipo che sotto il
medesimo vessillo si son viste, in meno di tre anni, anche una Traviata, sempre diretta da
Zeffirelli, che tornava così sui proprî passi cinematografici, rispetto alla discussa (quando
mai Zeffirelli non è stato discusso? e dio lo benedica fosse solo per questo) realizzazione
cinematografica (con la Stratas) del 1983, dei Vespri Siciliani e un Aroldo, la produzione
più recente, con le regìe dei quali Pier Luigi Pizzi (ma ce n'era bisogno, per chi al teatro ci
va in buona fede, e si fida dei proprî occhi?) ha ridimostrato mendace la favola di esser
piuttosto un sarto sontuoso che un vero interprete di storie — con questo Aroldo l'opera
riminese di Verdi, dopo l'effimera moda del dissepolto Stiffelio, ha passato quella dogana
che il Trovatore varcò sulle soglie del Novecento, a Milano con Toscanini, che la Forza del
destino e il Ballo in maschera e i Vespri siciliani francarono nella gloriosa Verdi
Renaissance germanica degli anni Venti, che il Boccanegra vinse con Gobbi, Christoff,
Gavazzeni, e buoni ultimi ma celebratissimi, i diòscuri Strehler-Abbado, e che il Don
Carlos guadagnò, ma a Londra, con Giulini e Visconti ritrovatisi dopo la Traviata 'della
Callas'. Andata a male, bussetanamente, solo l'idea biricchina di affidar Rigoletto a un
indiavolatissimo e poco pettinato personaggio di fama variotelevisiva. E in fondo anche
quello è stato un bene, come la Traviata diretta da Giuseppe Bertolucci fra i capolavori
troppo annunciati del Verdi Festival parmigiano: punto e a capo. Di qui non si passa. Era
bene che il lettore fosse sbrigativamente rimesso a parte di un accaduto, perché possa
meglio valutare l'eccezione felice costituita — anche come lettura critica e fondazione di
metodo — dalla Aida zeffirelliana. La quale, non solo contribuì così a rimettere sul
piedestallo la statua incerottata di un gran cavaliere del Tempo perduto andata trafugata nel
bel mezzo delle Feste che si facevano (nel chiesone si avvertiva un gran freddo e sull'altare
il sancta sanctorum era ostensibilmente vuoto, ma guai al bambino che avvistosene, avesse
fatto come quell'altro della favola che coram populo urlò, mamma, l'imperatore non ha nulla
addosso!), ma anche mise fine a un tormentone che, dioneguardi, rischiava di impedire, o
senz'altro impediva e sviava, qualsiasi altro ragionamento sulla Aida, alla pari dello
scrofoloso dissertare se alla trobadorica pira spetti o non spetti quel do che Verdi s'era
prudentemente dimenticato di scrivere (ma: non si può scrivere tutto figliuoli, pare si
giustificasse, ab antiquo, con un musicista che gli stava addosso e lo metteva alle strette,
l'aggrottato signore delle Roncole). Il tormentone aidesco era quello, l'avete indovinato, di
un'opera senza elefanti. La mia personale memoria verdiana risale più o meno alle
celebrazioni di un mezzo secolo prima, quando nel 1951 perfino la radio di stato si era
mostrata in grado di varare (ricordo i cartelloni giubilanti esposti nel paginone centrale del
"Radiocorriere") un tutto Verdi che credo bandisse dall'ascolto soltanto lo Stiffelio e la
povera Alzira. Una decina d'anni sono venne alla luce un nastro della radio berlinese con
l'Alzira cantata in tedesco, forse alla presenza dell'intero staff nazionalsocialista, e con la
bionda quasi debuttante Elizabeth Schwarzkopf accorsa in taxi all'ultimo tuffo per sostituire
con preavviso di minuti una celebre star verdiana costretta a dar forfait per motivi di salute;
e se i tecnici post-fascisti della radio italiana, negli anni Cinquanta, fossero stati in grado di
registrare un'opera o un concerto come i loro colleghi nazisti riuscivano splendidamente
perfino sotto le bombe, avremmo conservato un corpus di interpretazioni verdiane che oggi,
ristampato e rimesso in circolazione, sembra una di quelle fruttiere sotto vetro — come
vetroso è il suono di quei dischi — che al tempo di Nonna Speranza ornavano il salotto
buono. Bene, fu allora che per la prima volta lessi su un rotocalco il minaccioso vanto di un
regista, ancora tedesco, che si preparava a marciare su Verona col bellicoso proposito di
dimostrare all'inclita e al colto che l'Aida non era per nulla "un'opera con gli elefanti". Né
con le tigri le scimmie i camelli e gli uccelli del paradiso che, in una fantasia da Circo
Barnum, sembravano fare corpo con la creatura verdiana. Che strano; si diceva anche il
bambino che ero. Il problema non mi era parso così pertinente e grave quando alla radio
passavano i dischi del terzo atto dell'opera con Lauri Volpi, la Rethberg e De Luca, i Cieli
azzurri della Ponselle o il Celeste Aida di Galliano Masini. Non emergeva dalla
registrazione completa, che periodicamente andava in onda, della Aida romana di Serafin,
che come il Quo vadis cinematografico di qualche anno dopo, servì a riscaldare i cucinotti
di orchestrali e coristi e figuranti e comparse romane, nella gran fame della appena passata
guerra, benché Gigli Caniglia Stignani Bechi e Pasero ci tenessero a dimostrare, si direbbe,
prima di tutto, che le loro ugole leggendarie non avevano subìto danni irreversibili nelle
trascorse convulsioni del mondo, e dilì a poco non sarebbe emerso dalle prime registrazioni
in microsolco dell'operone egiziaco, né quella in technicolor della DECCA inglese, dove
Del Monaco Tebaldi Protti sembravano avere imparato la lezione dai settantotto giri
romaneschi di cui si è appena toccato (e la Stignani rifaceva se stessa) né quella che ci
parve, al confronto, perfino raffinata, incisa a Roma dalla RCA statunitense, con un
direttore rumeno, un tenore svedese, un soprano jugoslavo regina del Met, un basso bulgaro,
un baritono americano, e la pugnace Barbieri quasi smarrita in quella raffinata babele delle
lingue. O come diancine, ci si chiedeva, questo signor regista ce l'ha tanto con una fauna (e
relativa flora salgariana?) da dimostrativamente amputar via perché l'Aida torni a farsi
ammirare come opera né esotica né de-luxe. Fuor d'ogni equivoco cecildemillismo! Non ci
sarebbero voluti né molti anni né molte riprove perché mi avvedessi, in séguito, che quella
dichiarazione rodomontana era né più né meno che una rodomontata giornalistica, o un
ingenuo atto di fede non petito; ché non una volta alla prova dei fatti mancarono di dilagare
(e nelle scene che lo permettessero, che sono poi meno che per un terzo dell'opera intera)
comparse e ballerini ammonticchiati in pittoreschi grappoli vagamente memori delle foto di
gruppo ("io ho quel che ho donato...") di quando l'Impero risorse sui colli fatali, tre o sette
palme sotto la luna nell'atto del Nilo, e magari perfino un vecchio cammello o elefante preso
in prestito al Circo Orfei e che maestosamente sbadigliando traversava lo sfondo della
scena, non una volta scordandosi di lasciare a ricordo del passaggio qualche pallottola poco
odorosa che gonfiava la iugulare del regista, dietro le quinte, e suscitava il riso dei monelli.
Se, d'altro canto, si potesse ragionare con delle prove e contrario, nemmeno il famigerato e
a suo modo onesto film a colori (onesto è chi mantiene ciò che promette) che Clemente
Fracassi fabbricò dell'Aida (1953) con una Sofia Loren pressoché debuttante, la buttava più
dell'ovvio sul Kolossal, a parte un breve flashback di battaglie con un Amonasro uscito
com'era giusto da Tarzan e lo Stregone, e qualche balletto virtuoso di quelli che sarebbero
poi dilagati nelle trasmissioni per famiglie della televisione imbraghettata. Ordunque?
Resisteva piuttosto nella critica verdiana un certo imbarazzo, per non dire, anzi, che
imbarazzo non c'era tanto dichiarata era la preferenza per la seconda parte (notturno-nilotica
e giudiziario-sepolcrale) dell'opera e l'ammissione che per arrivare a quel nucleo di
perfettissimo cioccolatte bisognava essersi rassegnati a dover rosicchiare, prima, una
porzione di più casareccia boccadidama o di dolciastro caramellato. Insomma (ero un
ragazzetto impertinente): si fossero tolti di mezzo due balletti di nanerottoli o schiavi
nubiani e tutti i cori quando non fossero perduti sullo sfondo col carisma della distanza (il
"vago" leopardiano), l'Aida era una gran bell'opera, con le sue musiche. Il ragazzetto crebbe
e (complici anche i dischi, arrivati in ritardo, di Toscanini) si vide confermato nella sua idea
di sempre, che l'Aida era un'opera senza vergogna d'essere un'opera e che, in questi limiti
non poi così inconfessabili, era tesa e funzionale, fusa in un blocco e incalzante. Funzionò a
farlo riconoscere perfino il fatto che Toscanini fosse riuscito a imporre un inaudito tour-de
force alla squadra dei tecnici che stamparono in dischi la sua Aida: che ognuna delle sei
facciate comprendesse intera una scena dell'opera, mettendo allo scoperto le strutture
portanti della fabbrica musicale. Sembrava nulla, ma ecco che la bipartizione critica fra una
Aida lohengrinesca e una Aida meyerbeeriana era messa fuor d'uso. Diciamocela tutta: a
quel punto il problema critico era risolto, e restava lo spazio per repliche aggettivali quasi
tutte legate al gusto generale dei nuovi interpreti (e dunque il decadentismo accentuato nella
versione Karajan, il francesismo esotizzante della versione Maazel, il wagnerismo
ipercalorico della lettura di Solti, il toscaninismo energetico di Muti o quello strutturante di
Claudio Abbado), mentre una parola diversa, ma anche superbamente deviante, riusciva
detta solo dalla regìa scaligera di Ronconi, proiezione di masse materiali e di masse umane
ugualmente nemiche e sofferenti. Dall'esotismo da Mille e una notte con Sabù e Maria
Montez si passava a una sorta di tragedia lunare, sul Pianeta delle Scimmie o nei deserti di
Stargate. Zeffirelli — alzi una mano chi non sente il suo nome e si sente autorizzato a dirne
male. Buon toscano, non ci avrà fatto mai grazia di un paradosso o di una qualche velleità
integralista, e semmai una volta tentasse di difendere quella che è ormai una illustre ed
antica maniera (e miniera) registica, teatrale e cinematografica, sarebbe magari capace di
spalancar l'ombrello della "ars gratia artis" o dell'eternamente umano. Buon toscano, e
questo c'è più d'uno a non avvedersene, sa però il peso da dare alle chiacchiere, spesso che
vengon comode per distrarre l'avversario dalle carte che uno sa di ritrovarsi in mano.
Prendiamo sul serio il populismo zeffirelliano? Ma certo. Prendiamo sul serio l'artigianato
zeffirelliano? Ma certo. Prendiamo sul serio la sua attitudine a mettere un problema al
punto? Ma certo! Per quest'ultimo tratto si valuti quanto merita il fatto che tale trasporto a
levigare l'osso scintillante di un problema è la compensazione oppositiva del proliferare di
accidenti, di ghirigori e riboboli, di carabinieri in montura e paesanelle alla festa, di galline
maiali somarelli e muriccioli e carri degli zingari che quasi proverbialmente si sposa
all'immaginario dello Zeffirelli. Non si stia a scomodare il Barocco. Troppo lontano e
troppo intellettuale, lo Zeffirelli detesta l'allegoria. La sua esperienza è tutta ottocentesca,
non mi sorprenderebbe che serbasse memoria di aver letto i libri del Guerrazzi e di Massimo
d'Azeglio, il Mondo di Dolcetta del Pratesi e magari perfino (una volta scopertolo fra i libri
di un amico priore) uno o due romanzoni del Padre Bresciani. La sua realizzazione filmica,
recente, della Storia di una capinera del Verga 'popolare' ha avuto lo scontabile insuccesso
di critica; diversamente era un terremoto. Ma lo Zeffirelli è di quelli che saprebbero sempre,
con un loro candore, rimandare la palla a chi gliel'ha tirata: era ragionevole quello che mi
sono proposto di fare? e, se ragionevole, sono stato capace di realizzarlo? Il critico può
scuotersi via questi interrogativi come una mosca fastidiosa posatasi sulla spalla della
giacchetta. Ma, rimasto solo, (i critici non vanno mai presi in compagnia, quando si scrutano
l'un l'altro timorosi d'essere scavalcati o a destra o a sinistra), in un'ora di melanconia, quel
critico può anche domandarsi se davvero sia così irragionevole — non sul piano di un
"oggi" astratto e di un "dover essere" imposto non si sa da chi — cavare un film dalla
Capinera, che possa far blocco col resto della storia del regista. Quel principio della
coerenza, del rigore rispetto ai proprî assunti, che a volte per battaglie meno degne viene
normalmente applicato a fatti dell'arte visuale o della poesia, schiera l'intera opera
zeffirelliana, nei suoi alti e nei suoi bassi, a favore di una storia personale ricca, falsoingenua e ostentatamente beffarda. Così, l'Aida di Zeffirelli davvero — nel teatrino-cassetta
dei burattini del Verdi di Busseto, dove nacque, ma poi in giro per l'Italia e per l'Europa, e
internazionalmente acclamata perfino nell'escaparatto o bonsai della trasposizione su DVD
— si presenta senza elefanti e senza fiere dell'Impruneta (quella sorta di brueghelismo
toscano che pare come s'è detto quasi il marchio di fabbrica del regista antintellettuale,
falso-ingenuo). Non c'è, peraltro, disagio negli interni così poco abitati. Si indovina che
Aida, Amnerís, Radamès sono come tre personaggi di un giardino dei Finzi Contini (il
versante mortuario, cemeteriale dell'operone egiziaco è così registrato con esattezza non
ostentativa). Il mondo è di fuori. La scena del trionfo vista (anzi non vista, solo indovinata
aldilà dei cordoni della folla) dalle ultime file degli ultimi arrivati è ormai riconosciuta come
un momento classico delle regìe verdiane; ed era l'ovo di Colombo. Indimenticabile, ormai,
come quell'Otello che (nello spettacolo scaligero con un Domingo fresco nel ruolo ch'è poi
invecchiato con lui) sbarcava dalla nave e quasi non lo vedevi tra la folla e passando come
una visione, "diceva" l'Esultate e spariva nelle stanze del Duce, anziché piantarsi lì a gambe
larghe e trarre dalle canne due acuti da knock-out, Quelle tre statue del vocalizzo, nell'Aida,
Amneris, la sua schiava e il generale di quindici anni, possono parlare basso, carezzarsi fra
loro, sfiorarsi la fronte con un bacio d'addio. Son tre fanciulli crudeli pei quali la morte è
uno dei giochi proibiti cui attingere piacere e verità. Si sa che, alle origini, l'Aida nacque
dalla impressione che sui lettori francesi (e di rimbalzo su Verdi o sulla Strepponi, così
intinti di cose francesi) fece Salammbô, il romanzo cartaginese di Flaubert. Se "Madame
Bovary c'est moi", secondo la proverbiale assunzione di responsabilità dell'Autore,
potremmo dire che l'incubo esotico e sadomasochista di Salammbô è come un sogno
bovarista dello scrittore-Tiresia, uomo e donna insieme. "Amnerís c'est moi"? Seguitiamo a
chiedercelo, quando passiamo dall'ascolto dell'Aida alla riflessione sull'opera. Zeffirelli ha
intanto individuato e credo non si avrà motivo di tornarci sopra, la "camera" dentro la quale
si muove questo trio, strutturalmente così elastico ed eccitato da saper farsi a tempo un
quartetto o un quintetto o settimino con cori, come negli pseudo Contes d'Hoffmann. È
l'immaginario del fumetto. Radamès è Rodolfo Valentino e lo Sceicco Bianco, Zeffirelli
(partito da Visconti) ha fatto i film che non seppe fare, condannato alle sue messe
amarcordiali, funebri & trionfali, Federico Fellini. Mentre Verdi è maturo per sostituire,
ormai, Metastasio nel nostro immaginario collettivo.
III
PER UN CANONE DEL NOVECENTO
(MA CE N’È DAVVERO BISOGNO?)
Da tempo firme autorevoli su autorevoli testate vanno resuscitando una questione che in
fondo si presenta come generazionale o quasi: quella del canone. Della letteratura italiana in
generale e della sua lunga avventura nel secolo breve in particolare. Il lettore guardingo si
cala già sul viso la celata del sospetto ironico: in quattro righe mi è riuscito ammucchiare
una serie di sconcertanti concetti come autorità letteratura italiano (e secolo!) e lungo e
breve. Per non dir dell'abuso del termine avventura per una categoria d'opere che si
realizzano a tavolino e non è detto l'esser poeti velivoli o aerodinamici guidi a produrre
opere più benedette o maledette o vitali di quelle ispirate dalla sediola o dal meridiano della
solitudine. Ho lasciato lo scudo sul campo di battaglia e alzato un monumento più perenne.
Bei versi che chiamano le pernacchie. Un mio collega insigne in una università impoverita
di valore e di talenti ma dei pochi che sanno in una pagina lanciare un arco vasto di casi e di
pensieri battezza il rilancio sotto bandiera Treccani della gloriosa collana della letteratura
italiana storia e testi della Ricciardi voluta fortemente dal banchiere Mattioli. Operazione
avviata fin dagli anni di guerra che la letteratura italiana crocianamente diplomata poteva
quasi giocarsi in borsa. Saba: il fascismo fu il braccio secolare di Benedetto Croce alla
spinetta. Del Mattioli mi piace una caratteristica susurrata dagl'intimi: si esprimeva per
parolacce, ai fidi spulizzire e decrittare. La parolaccia non è un accidente o un'inflorescenza
fecale è un punto di prospettiva. La Commedia di Dante è tutta scritta in parolacce indi ci
misero il perizoma della Divina. Montale si specchia nell'upupa in hilaritate tristis ma poi le
fa un corno e vagheggia quel bischero del merlo. D'in su la vetta del trono di sterco bischero
solitario alla caverna cantando vai. Estrema e salutifera incarnazione del Sileno la scuola
italiana ha deglutito a fatica. Montale onorato al gabinetto Vieusseux da un cultor di
ginestre come dai rostri funzione antifascista di ossi e occasioni e il poeta in pieno
parkinson come un fauno legato. Non è la prima volta che si rilancia a suon di tube la
veneranda Ricciardi. Studente avrei dato una mano per possedere anche un solo di quei
volumi solenni. O monumento come dice il Barnaba di Tobia Gorrio a una buca delle lettere
nella Gioconda. Ma oggi? S'infranse il progetto su non molti volumi che restavano da fare e
un nuovo modo d'intendere il senno delle lettere. Sapegno uscì col Trecento potendo riattare
un lavoro già fatto ma Dionisotti non mise fine al suo Cinquecento. Làtita il Seicento, non
sarà libertino e marinista non però collotorto spigolistra come piace ai novelli gesuiti.
Metter insieme un'antologia di Carducci parve lavoro da spezzare le reni a un piccolo
maestro. Con gli anni 60 s'era propalata l'ideologia dell'edizione critica e dell'eruditissima
erudizione, son tutte belle cose ma mi annoiano (altro libretto d'Opera, Manon Lescaut). Per
Carducci professorissimo oggi non basta una commissione di professori. Carducci senza
retorica? Ma Carducci con la politica. Manon è una parabola. Ci si misero in enne al libretto
nessuno lo volle firmare. Anticipando senza teoria e ahimè senza musica Lo Zar è morto
grande romanzo d'avventure dei Dieci, Beltramelli Bontempelli D'Ambra Marinetti Zuccoli
eccèteri. Rientrerebbe nel canone di un novecento classico? e i reattivi romanzi futuristi che
diecianni fa A. Masi riunì col titolo Zig Zag pel Saggiatore? Otto fra Soffici e Marinetti e il
più bel nome delle nostre lettere dopo Zucchero Bencivenni: Spiridigliozzi. Pel suo San
Francesco in areroplano dò tutti i Palomar. Dove un'opzione Calvino è meglio di una
opzione patafisica? Scrissi una volta di Moravia scrittore che Italia neanche si meritava e fui
equivocato. Siciliano mi tolse il saluto. Ma ora che al gioco della torre fra il Culo & le
Quarantore di PPP, la Sostenibile leggerezza del Più modesto Ariosto di San Remo e la
Mente Temprata Illuminista Con Défaillances Ebraiche di Moravia buttano prima Alberto lo
Sgradevole dopo pierpaolo il Santo commediante & martire per potersi beare in buone
cuffie a le petit montagnard delle lezioni americane? Se una notte d'inverno un
posteggiatore. Richiamo il 1929 in cui escono i Dieci e la Storia della età barocca in Italia:
ritrattazione. I giochi si fanno allora più che nel 23. Svevo un accidente viennese Pirandello
un farnetico tedesco, difficile ciò da capire li hanno messi allo scolo della scuola. Lì si
aspetta Caronte fra singulti e sospiri. Croce per far dispetto a Mussolini commesso
viaggiator marinettiano protettor di Gentile leopardiano proconsol mette al bando il Barocco
dannunziano, con tante rime Saturno divora i figlioli. Un canone arcadicorisorgimentale,
opporre Béranger a Rimbaud o Rota a John Cage. Il marito in dispetto alla moglie si staccò
gli attributi da bravo, l'è ona bèla alegrìa. Allora Tessa? Ma se entra Tessa ci entra
Cicognani? Due burchielleschi tragici pur con orecchie d'oggi sorde al Mercato vecchio
dove si fece dante. Non faccenda di addendi, a volte vale non esserci. Il più bel passi a
Bertolucci lo diè Sanguineti escludendolo, oggi chi vede vede: Attilio vive, Sanguineti si
sopravvive. Il rilancio della Ricciardi ripete il tuono fatto diecianni fa per le ristampe
critiche di Croce maestrevolmente esatte e rimaste lì. I professori in busca d'autorità han
naso per l'aria nuova (il Croce riattivato mentre sorgeva l'astro Berlusconi) ma poi sul
cocchio del trionfatore salgono in troppi ed il carro ribalta. Oh voci che spezzarono il
silenzio del coprifuoco! È cascato Mussolini. Si è fatto male? Sfuggono a certe ricognizioni
sullo stato dei classici i Cento libri per mille anni del Poligrafico dello Stato. Son centomila
pagine per una letteratura che dopo Trento fu minore perché di nazione irrealizzata e
minore. Malissimo distribuiti e non sempre ben fatti, la carica si è infranta per il passo della
gestione a un governo di destra che ha isolato il timoniere dell'iniziativa. Ma il disegno
risale a Bertolucci Macchia Roncaglia superba trinità e Borsellino Villari Malerba. Pel
Novecento vien fuori la questione dei diritti d'autore ed è una cosa seria, vedi sconquasso in
Francia per un librobianco sulla gestione SACEM, una cognata della nostra SIAE. Sghèi
han da essere sghèi! In una cattedrale della ciarla a specchio della veneta laguna una dama
milanese quasi minace a cento musicologi raccolti: lavorate in gloria della Ricordi. Si è
lavorato ma Ricordi ha chiuso. Nuove tecnologie hanno messo al dunque un sistema di dritti
progettato a un tempo in cui la macchina che tirava era l'orrendo mostro che si sferra. Ci son
leggi umane o divine (e viene il Rodo delle guerre sante, tutte lo sono per definizione) e
léggi a copertura di situazioni storiche e interessi contingenti. Se queste mutano o quelle si
adeguano o fan la fine delle grida manzoniane. Se il diritto d'autore si fa oscurantista va-de
retro il diritto d'autore; imporre ai detentori se lo vogliono mantenere l'obbligo doveri contro
diritti di una messa a disposizione di un totale dei testi in camicion di penitenza pel diritto
allo studio. Spingersi oltre: ognivoltaché un maestro usa a scuola un libro un disco o proietta
un film non dovrebbe aver sulla testa la spada di damocle dei padroni delle ferriere anzi
diritto ad una ricompensa. Eccofatto! Fingono non capire che nessuno usa più leggere o a
leggere è tenuto. Chiedi a un rettore di università. L'importante è san Marketing. Didentro
un cimitero di cadaveri che han smesso persino di fermentare. Tentai di spiegare la cosa in
avvìo d'una scelta secolare di libretti d'opera per la collana poligrafica contro i criterî
classici di scelta del Meridiano omologo. Vedono il Novecento come un ricco pascolo da
occupare. Illusi. Ogni volta che si apre un libro si entra senza scarpe nel cammin di nostra
vita e si scende all'inferno, anche dovesse trattarsi dell'Imitazione di Cristo.
IV
GIACOMO DEBENEDETTI
E IL NOVECENTO SEGRETO
Verticale d’autunno? Il lettore può ricordare la Verticale del ’37 di Debenedetti (Saggi
critici II). Significa rilevare una posizione rispetto a diversi punti d’osservazione. M’induce
a farlo l’uscita quasi simultanea di alcuni libri di diverso pregio affacciati su un Novecento
dal quale ci separiamo con un sentimento diviso di riconoscenza e di perdita. Il Novecento
segreto di Debenedetti - e Pedullà scrive un altro dei suoi libri straordinarî (Rizzoli). Suo
merito maggiore è lasciare il soggetto anche più segreto. Quale altro critico del Novecento
suscita libri radicati nell’anima come questo? Giacomino era un gigante ferito, nel suo
metro e cinquanta di statura. Anche straordinario fu il libro dedicato al padre da Antonio
Debenedetti. Fra lui e Pedullà c’è quasi una primogenitura da contrastare ma Pedullà
rispetto a Debenedetti è come un poeta barocco rispetto a Torquato Tasso. Io sto con
Pedullà quando teme un errore tattico del maestro l’aver esitato a gettar un ponte fra quelle
sue mitiche lezioni accese ad estri d’Affabulazione e Bulimìa e i suoi esclusivi saggi ancora
ahi! rondescamente intonati. Il saggio di cui ancora si bisbiglia, ma che palle, con scandalo
ipocrita sullo stile oratorio di Mussolini indicava digià la stessa strada: rompere l’assedio,
dare carne alle idee. Rotte le acque Pedullà balza fuori coi suoi modi romanzeschi,
corpulenti. Rode il Novecento il tarlo di una cartellonistica equalizzatrice poco tentata da
Iconoclastia. Seducono più le cadute; par più merito l’essersi ostinati come Debenedetti a
capir troppo tardi uno Svevo dandolo al braccio secolare dei manualisti che non nell’aver
capito tutti e sùbito, da Pirandello agli ospiti in seduta permanente degli odierni salottini
televisivi. “Non è difficile scrivere bene. Sono centinaia oggi i narratori che fanno bella
scrittura”. E il riscatto del comico: “nel Novecento è il padre delle maggiori tragedie”. Pure
sulla soglia di Gadda Debenedetti s’è fermato incerto: temeva il birignao tragicomico, l’
eterna secchiarapita col suo formalismo d’en bas o duravano le sue resistenze agli scrittori
con strizzacervelli appresso? Svevo Gadda Berto. Sul fronte opposto Bárberi Squarotti
anche lui fiume di libri felicemente non traslucidi esce con un forte libro riassuntivo, Il
tragico cristiano. Da Dante ai moderni (Olschki). Punto d’incontro con Debenedetti
l’Alfieri (ci sarà entrato che tutt’e due i critici son piemontesi e riescono a scorgere sotto il
gran manto in posa dell’”irato ai Numi” una sorta di, sanamente intendete, dialettalità?).
Vittorio aspetta quello che Ugo si ebbe dal Gadda e Tommasèo da Giacomino: barba,
grasso, dispetto. Il Bárberi non solo padroneggia ma trascorre l’intera esperienza letteraria
italiana. Il gran saggio sul tragico cristiano approda a uno scrittore strettissimamente
contemporaneo, l’estetologo Givone con la sua Favola delle cose ultime. Quando sul fondo
appare Dostojevsky, la letteratura italiana si scancella. “C’è qualcosa di necessario
nell’esporsi fino alla perdita della propria identità, nello snudare la radice, nel tentare il
nulla”. Quanta scarnificazione, quanta pena (il Nobel negato val qui la cattedra negata a
Giacomino) nell’approdo, allora, di Luzi al suo libro che credo più bello, la Dottrina
dell’estremo principiante (Garzanti) in cui ogni traccia del Luzi oratore par strizzata e
balenano incontri di fraseggio con l’estremo Caproni ateologico. Due poeti che mi ostinai a
non capire. Con l’uno arrivai a spiegarmi (anche lui entrato nella sua fase più nuova e ilare
fino al finto-Flautomagico del Conte di Kevenhüller) con Luzi sento ora di POTERLO fare.
Sulla soglia mi fermò troppo a lungo la comune sorgiva fiorentina: credevo di conoscere
quel tanfo di parrocchia, quel profetismo curatizio, quella parola dòcile. L’”estremo
principiante” suona come un Webern, un Giacometti. Il Novecento non è tutto perduto.
Qualche sospetto viene semmai a riaprire gli Scritti dispersi di Savinio preziosamente riediti
da Adelphi. Un doppione dell’ormai introvabile volume curato da Sciascia per Bompiani;
un doppione con qualche giunta e qualche pasticcio. Imbarazzato il saggio (Sciascia e
Savinio) del Tinterri più at home in altri lidi. Certo ogni titolo d’autore è scrupolosamente
restaurato sui titoli redazionali. Savinio è uno scrittore che non ha segreti? Una dissipativa
facilità sembra lo abbia distratto dalla tragedia dell’infanzia con tanto acume da lui
dichiarata. In una sua malattia legge alcuni libri a letto. Una “piccola biografia di Bach”
scritta da Alfredo Casella: “Uno dei libri più chiari che io abbia mai letto – in italiano. E
toccante”. La Curatrice non trova nel ’50 altri Bach che quello pubblicato da Bompiani del
famigerato van Loon. Un divulgatore dalle grazie gravi, una specie di Montanelli-Gervaso.
La sua Storia d’America fu tra i miei libri d’infanzia. Che uno a letto ammalato possa
leggersi un libro uscito anni prima (nel ’42 il Bach-Casella) è inciampo ai topi d’archivio,
ma Povera Italia.
V
ERMETISMO E DINTORNI
Amo sempre meno i poeti e mi preoccupo sempre dipiù della poesia. Ci vorrà l'analista? Gli
direi, sul lettino: non sono il medico della mutua, mi attira l'entelechia (e l'eziologia) del
morbo, lascio a eroici colleghi, gli ammalati. Malato anch'io, se sono sul lettino. E gli occhi
del dottor S. lanciano lampi dietro le lenti spesse, annichilenti. È il diavolo! mi dico d'un
tratto, riconoscendolo (sia tutta una faccenda di agnizione? è dunque una commedia in cerca
di autore) e vorrei scappare, ma il lettino è di contenzione, le stringhe che mi allacciano non
sono di quelle che cedono a un primo sforzo, a un semplice volere. Carducci non avrà avuto
motivi per amare Imbriani. Il cignale maremmano vagheggiava, forse, digià, grandi
risanamenti di paludi e sterminii di zanzare, ma una specie di ossessione formulare lo teneva
pel braccio: il treno è orrendo mostro, come nelle figure di Doré l'illustrazione mèlo sposa il
liberty e prefigura il surrealismo. Ossia l'opera lirica si fa adulta - come Pinocchio all'ultima
pagina - e finisce in fumetto. Imbriani si vietava di vagheggiare se non la forca, tutte le sue
scritture (le uniche necessarie dell'Ottocento?) si possono raccogliere in un cartone con
scritto sopra "Bagattelle per un massacro". Mi piacerebbe scrivere una novella in cui
Vittorio e Federico, quel dello Zarathustra, si fanno le confidenze a un tavolino di caffè, ma
occhio al cameriere che li serve con zelo e mercuriale allusività ("in compendio": un
ammicco, due gocce rovesciate sui calzoni dei due interlocutori, per richiamarli o distrarli).
Carducci e Imbriani su una cosa si incontrano. Che per far poesia (?) ci vuol l'archivio e la
metrica. E su un altro fatto (supremamente antiottocentesco) si trovano d'accordo: l'antipatia
per Goethe. Sono più avanti di Busoni, di Borgese, di Thomas Mann e di Auden-Stravinsky,
che al Dottor Faust, a Mefisto e al Libertino in carriera hanno geniali sparso suffumigi e
capidopera. Anche Sanguineti giocava al Mefistofilo, homunculus sortito dalla bella fucina
di Anceschi, ma a mezza strada si era già venuto a noia e non si è più riusciti a pigliarlo sul
serio. Un peccato, ma mi sarebbe piaciuto chiedere che cosa pensava dei suoi pentacoli un
Lucio Piccolo, nel suo vero giardino delle notturne Esperidi.
L'ho presa da lontano, sarà un vizio o una necessità di attaccare il filo a una boa più
distante. Il punto decisivo è quando Imbriani scaglia a terra l'ampolla della sua anima e
svanisce in odore di empietà. Lo stesso Federico (Gozzano fu uno dei pochi a capirlo sùbito,
la pietà per gli animali, cavalli battuti o desperate cetonie, è un rito al Dio che ha fatto gli
animali, e non l'uomo, a sua immagine e dignità). Carducci (il DNA italiano, dopoumanistico, non si sconfessa mai) da ultimo vende l'anima per una croce di commendatore.
Da quel momento, la storia fattuale della poesia italiana, per tutto il secolo digesto, ha il
proprio basso continuo: chi ha scelto l'annullamento? Pascoli, che si rintana nella vulva
maternale della non risolta infanzia (ma badiamo, il Fanciullino non è Pinocchio, è
finocchio). Onofri, che aveva il più nativo magazzino di 'attacchi' lirici e di temi
ossessionanti, ciajkovskiani, più del bancarellaro Govoni (un altro fermatosi a mezzo) e del
superbidonista d'annunzio, e addirittura rinunciò alla poesia, ci mise sopra un cartello
CHIUSO PER MUTATA GESTIONE, e si fece il Messiaen, dico l'organaro, o il Palestrina
dell'Also Sprach. La poesia finisce dove finisce l'individuo con le sue magagne. Poi
Montale, "merda d'artista"; solo la Cima l'aveva capito.
Nelle prospettive critiche parse fin ieri vincenti, ci si spartiva il campo: un Fortini
sconfessava in Montale il non c'è più religione, l'opportunismo cinico (secondo il temibile
fustigatore, oggi un tantino dimenticato ed è la sorte di tutti i Beckmesser). Era una battaglia
per la verità, nonostante tutto positiva e umanistica per Fortini, prete mancato. Un
Sanguineti sconfessava in Quasimodo (e nell'ermetismo quasimodeo) la maniera.
Memorabile l'atto di condanna: "l'ondata melodica della emigrazione meridionale". Ma le
caratteristiche epigrammatiche delle "anime belle" che qui si condannano non son poi
risultate molto diverse dai calembours degli sformati corpi (kafkiane metamorfosi?) dei
post-novissimi. Tanto che il loro musicista è Berio, un più virtuoso Casella, maestro delle
civili disarmonie. Uno è poeta solo quando ci rimette del suo. Così, da qualche tempo a
questa parte, ci si è rimessi agli archivi. Chiusi quelli del Futurismo con un match nullo fra
bocciature ideologiche e penultime raffiche di Salò, si son riaperti quelli ermetici; e il
bilancio è sostanzioso. Anticipo una schematica bibliografia di libri che sarebbero tutti da
vedere, per chi crede alla poesia come cerimoniale o come malattia. L'impegno di Anna
Dolfi, da Firenze, su Ruggero Jacobbi e su Oreste Macrì. Qui l'editore è il Bulzoni. Le
Maschere alla ribalta, cronache teatrali (1961-65) di Jacobbi, critico onnivoro (non solo di
versi) e poeta (non solo in versi) fluviale. Gli Scritti d'arte (a cura della ispanista Laura
Dolfi, con uno studio di Donato Valli) del Macrì e il monumentale studio-antologia
dell'epistolario macriano, a cura sempre di Anna Dolfi (Lettere a Simeone), da congiungersi
alla trilogia Vita della parola, di cui è disponibile finalmente anche l'ultimo e forse più
affascinante volume, Da Betocchi a Tentori. A questo punto entra in campo, sempre in
collaborazione con la instancabile studiosa fiorentina, la Finestra editrice di Lavis (Trento),
che ha fornito in mirabili anastatiche (e, cronologicamente, cancrizando) titoli leggendari
dello Zar dell'Ermetismo, la quasi programmatica Realtà del simbolo (1968), i Caratteri e
figure della poesia italiana contemporanea (1955) e, ora ora, gli Esemplari del sentimento
poetico contemporaneo (1941). Ma dallo stesso editore (che è Marco Albertazzi, anche lui
poeta, e filologo medievista) era intanto anche uscito quell'Anello del Nibelungo della
poesia italiana che sono le raccolte poetiche di Arturo. [Ma dallo stesso editore (che è
Marco Albertazzi, anche lui poeta, e filologo medievista) è intanto anche uscita, sempre a
cura della Dolfi, e di Gabriella Sica, L'Italia simbolista, straordinaria antologia del pensiero
e della prassi poetica in Italia dall'Unità alla prima guerra mondiale (l'antologia che
avremmo voluto quando ci tentava di contentarci; ma non può, non deve essere troppo tardi)
come era a suo tempo uscito quell'Anello del Nibelungo della poesia italiana che sono le
raccolte poetiche di Arturo Onofri] (il ciclo lirico della Terrestrità del sole, in tre tomi non
senza inediti, e quella sorta di Onofri del Lohengrin che sono Arioso e Orchestrine, ancora,
come dire, 'tonali' e monodiche)
Qui ci vogliono in piedi e descamisade tutte le Nove Muse. A tiratura limitata, e
quasi domestica, per gli amici, è da segnalare l'impresa di Giuseppe Pierri, figliuolo d'uno di
quei (per Sanguineti) "posteggiatori" melodici meridionali, Michele Pierri. Son sette
quaderni di inediti, l'ultimo intitolato Poesie spirituali e la formazione de L'anima. Un altro
quadernetto è in prosa e appare pungente, pieno di rivelazioni su un carattere che non è solo
magico e solo lirico e solo liturgico e solo epigrammatico (seppure la sua ricerca sembri
ostinarsi intorno alla magìa del quotidiano, alla trasformazione delle particole in ostia santa)
ma fermo e polemico e paradossale e insomma (lo si dichiara nel titolo) leopardiano.
Dialoghetti dei morti (se ne occupò anche Macrì). Di più facile reperibilità, sempre a cura di
Giuseppe Pierri, la silloge delle raccolte edite, E ti chiamo - Libera verità. Anche in questa
occasione il poeta meridionale ha trovato una sede in un editore settentrionale, la solita
Finestra. Archivio e libertà (meno m'importa la metrica), di qui ripartirebbe lo studio non
più riduttivo e didattico della poesia di un secolo? Le cinghie mi si allentano, forse, e intanto
son sceso dal lettino.
VI
PROFESSORI
Grandi sono i poeti sui quali si scrivono miliardi di pagine? non avrei argomenti per negarlo
come non ho interesse per sostenerlo. Incontrai Mario Marti, credo per ogni rispetto oggi il
decano dei professori di letteratura italiana, a un remoto convegno romano sui 'minori'. Io,
chiamato da un grande amico di là, Enzo Esposito, come Marti supremo studioso di Dante,
mi trovavo nella mia broda e sciolsi il mio cantare di ranocchio forse gonfiato per parere
bue (v'era diffuso imbarazzo, mentre parlavo, anche se di scandaletti un poco sempre
annunciati si tratta, a quei convegni vado di rado e mi contento di fare la mia figura di
clown, e quasi scappai d'accanto al venerabile Sapegno che dirigeva i lavori della
mattinata). Sostenni che dopo il Marino la letteratura italiana è una letteratura minore;
perché dopo il Seicento l'Italia è una penisola minore. Sapegno mi fece sapere che la
letteratura italiana era minore, d'accordo, dal Seicento, ma dal Marino (complemento di
colpevolezza) e non dopo il Marino. Marti, però, si trovava davvero in partibus, perché lui
ai minori credo non creda di credere, parlò di un Oronte gigante, poema cavalleresco, di cui
a distanza di qualche tempo fornì poi una esemplare edizione. Qui cominciano, in fondo, i
nostri dispiaceri; se un borgo appenninico incarica l'assessore al turismo e allo sport di
rilanciare un pittore locale che ha coperto l'abside della chiesa di angeli spennacchiati e
madonne in ciccia, ma con qualche tocco romantico di boscaglie e dirupi sullo sfondo e un
cielo nuvoloso da cui par che si sciolgano fulmini, state pur certi che accorreranno turisti, si
assieperanno ai bar e alle pizzerie del loco e compreranno il cataloghino con quel Maestro
della Annacquata del quale diranno poi, a casa, mirabilia. Se sette diplomati del
conservatorio, sottoccupati, fanno un disco di madrigali, messe o serenate con Giove e
Ciprigna, possono fermarsi alla Tactus, alla Bongiovanni (serissime imprese discografiche
'minori', insostituibili) o ascendere alle Virgin, alle divise industriali globali e che vendono
poi gli stessi cento dischi di Piccinini, Salomone Rossi o Maso della Leutessa (d'Annunzio
non c'entra, piuttosto Laforgue o Ragazzoni) che le case minori bolognesi. Però i minori
della letteratura proprio non vanno. L'editore di un recente Silvio Benco mi dice di aver
faticato perché un insigne distributore di libri su scala nazionale, fiorentino e ricco sfondato,
accettase di assumere quei due libretti, in fondo dignitosissimi, fra le centinaia che accetta
senza fare una piega. Non è solo questione di prima o seconda repubblica. Ma se qualche
porco burocrate della Roma ladrona, divino Bossi! (penso, naturalmente, a Osmino del
Ratto dal serraglio, non al Guglielmo Tell del Varesotto) è pur riuscito a trasformare
l'università e segnatamente le facoltà umanistiche in asili d'infanzia, cottolenghi o aree di
parcheggio (barrare con una crocetta l'ipotesi ritenuta più probabile) io credo che questo sia
avvenuto anche per colpa dei professori. Sapete come va: prima servi e lecchi il pomo
d'adamo per avere la tesi, poi per avere la dolce lode, indi per 'vincere' un dottorato, cui
consegue la borsa di post-dottorato e a furia di leccare se non ti casca la lingua fai la scala di
Giacobbe: ginnasio, liceo, poi l'università... No. Non son più belle le mamme del mondo.
Assistente volontario, ricercatore, ricercatore con incarico, associabile, associato, poi lecca
lecca ti fai chiedere il posto e lecchi lecchi per avere la commissione giusta (nelle ultime
tornate candidati e giurati andavano sùbito al bar, cannoli alla siciliana e caraffe di
lambrusco), insomma da ultimo sei professore? Macché. Poi devi farti 'chiamare', poi devi
farti 'richiamare' vicino a casa (suocere moribonde, bambini sulla strada, ignude consorti,
mogli o mariti che se no non ci stanno, provvidenze da tirare in secco, case del nespolo da
pagare col mutuo, nemmeno i mendicanti del gran mercato di Nuova Delhi sanno inventarne
tante e così colorite. Poi c'è da far la scalata ai ruoli direttivi interni, poi si cerca di entrare
nelle commissioni di concorso, un poco come farinelli diceva ai nuovi castrati fammi sentir
la tua voce. No, no. Il disastro è cominciato non per il non lavoro dei professori, in più
pagnottesche faccende avviluppati, ma proprio per il loro lavoro.
VII
UN RITORNO DIFFICILE
PETRARCA
Chissà se ancora qualcuno si ricorda del vecchio Con Dante attraverso il Seicento di
Umberto Cosmo professore antifascista, un altro dei padri della patria di cui fu sempre
fertile la patria piemontese (poco monta che il Cosmo nascesse trivigiano). Il basso
continuo: nel Seicento non stampano più Dante, dunque per questo il Seicento è una nave
degli uomini e delle donne maledette. Un Cosmo dei nostri dì potrebbe dire lo stesso per il
Petrarca di cui ricorre ora il settimo centenario della nascita? Non è detta l'ultima parola, se
la più fedele (ossia fedele nella intelligenza, nella penetrazione linguistica) allieva del gran
Contini riuscisse a piazzare entro l'anno solare il nuovo commento al Canzoniere che sta
preparando. La Bettarini prese un bel granchio col Montale in su la Cima, ma questo me la
fa anche più amare. La vera critica è esposta all'errore. Nel quadro delle celebrazioni
petrarchesche, per ora piuttosto rimesse, si inaugura una collana Sub specie Petrarchae
diretta da Anna Dolfi e Carlo Ossola (La Finestra editrice) e si inaugura bene, riproponendo
in anastatica un libro che a suo tempo, l'avvio degli anni 70, lessero in pochi perché il vento
tirava da un'altra parte, Le poetiche critiche novecentesche di Adelia Noferi. Credo fosse
l'ultimo libro della Biblioteca di letteratura e d'arte fondata pel Le Monnier da Giuseppe De
Robertis, illustre convegno di alti spiriti (Gargiulo e Barbi, Devoto e Contini, Parronchi e
Bigongiari, con in limine l'Epistolario di Renato Serra e a metà strada la raccolta postuma
degli scritti di Domenico Petrini Dal Barocco al Decadentismo) ma ormai De Robertis era
morto e non si poteva sostituirlo. La ristampa del libro della Noferi è resa preziosa
(imperdibile da chi ancora si interessasse alla morte e non è detto resurrezione della critica
letteraria) da una postfazione ch'è un vero saggio datato al marzo del corrente anno.
Riesaminando un trentennio di critica petrarchesca, competentissimamente catacombale, la
Noferi prende il toro per le corna esordendo con un capitolo La crisi della critica e
Petrarca, ch'è una bella risposta alla domanda retorica di un recente Segre: Dove va la
critica letteraria? Aramengo direi; me n'ero accorto quando la rivista ufficiale della nuova
metodologia critica, asso pigliatutto dei Settanta, dopo il terzo o quarto fascicolo cominciò a
riempirsi di tartufi di scuola. Anche a tavola detesto, fin dal profumo, il tartufo. A un amico
che si vanta musicologo ho appena risposto che io senza vantarmi potrei chiamarmi
piuttosto antropologo (avrei dalla mia Arbasino) o anche antropofago. Una parabola? Soffici
cui il poeta straccione Campana aveva confidato i Canti Orfici disse poi di averli smarriti.
Passarono cinquant'anni, la stella sanguinante del poeta di Marradi saliva in cielo donde era
scesa con un tuffo ingiù la cometa di Poggio a Cajano. Morto, gli rimisero in ordine le carte
e gli Orfici erano lì, sul tavolo, solo sotto altri fasci di carte. Così quando Petrarca e i suoi
compagni di erranza ricercarono i libri di età più umane: c'erano tutti, erano tutti lì.
Bisognava riaprirli e ritrovare la chiave per leggerli. Poveri lettori giovani, usciti da una
scuola strumentatissima dove rendevano noiosa perfino l'enormità del rabelaisiano Gadda e
priva di prurigini bordellesche la Camena gurgandina di Sandro Sinigaglia. La c'è la
provvidenza! Torneremo a razzolare fra le cataste e i cocci delle montagne del Rifiuto. Ci
vogliono stivaloni, guantoni, il richiamo dell'antitetanica e una pezzuola sulla bocca e sul
naso. Velluti e lapislazzuli vi si van disfacendo accanto a televisori ricusati, scatolette,
aborti e estruse turpitudini dell'Adamo. Ci sono segni positivi in cielo. Se passa la Moratti
ex-Berlinguer muore la scuola e tutto può ripartire, fuorigioco le vestali e i lanzichenecchi
che subiamo da un secolo. Leggendo la postilla della Noferi mi venivano meditazioni del
genere. Certo, la civilissima studiosa fiorentina è più prudente di me nello scrutinio dei
lasciti della critica universitaria e fa bene. Io mi ritrovo con Paul De Man (il
decostruzionismo, ovvero il ritorno della filosofia, bestianera del Segre), con Lacan, con
Zanzotto, con Gramigna e dei colleghi in cappa senza spada preferisco quei pochi che non
desistano dalla provocazione dell'espressionismo a parte obiecti e a parte subiecti. Siamo
onesti: la critica accademica, e proprio sul Petrarca, ha fatto faville, negli ultimi decennî, e
tuttavia Petrarca è nella gabbia. Sibilla cosa vuoi? Voglio morire. Come i dischi delle
majors classiche, splendidamente filtrati che non ne resti il nerofumo che si attacca alle ali,
sopra i tetti. Io, Pierino di periferia, arrivai all'università con due miti, a tempo per vedere
che erano in disuso: Momigliano (maestro dimenticato di Bigongiari, compagno di strada e
lezione essenziale alla Noferi accanto a quella del figlio di De Robertis) e Giuseppe De
Robertis. Era già tardi. E oggi sogno.
VIII
PER IL RITORNO DI GIORDANO BRUNO
Risparmiamoci di prendercela coi mass media come Montale (ma quanto autodafé ci sarà
stato in quel divino umorista) se la prendeva sempre con la televisione. C'è un passo che
meriterebbe fama del grande Beniamino Dal Fabbro, musicologo e valérysta di uno sparuto
mazzetto di primi, l'autore dell'indimenticabile pamphlet Crepuscolo del pianoforte contro il
benedettimichelangiolismo, che dovrebbe stare sullo scaffale accanto al Libertino di Cajumi
e al Modena 1831 di Antonio Delfini. Un incontro con Malipiero, difronte al Conservatorio
da lui diretto, nella Venezia 1950 (ve n'è una sinopia nel Mambo di Rossen, quello del negro
zum-bum). Il sulfureo Signore di Asolo, e delle pause del silenzio, canterella: "Se una donna
nuda, se una bella donna nuda si trova a passare dentro un folto bosco, dentro una gran selva
tutta piena d'uomini, alla fine le dovrà ben capitare d'essere violentata". La bella donna nuda
in frenesia di stupro da subire era la stessa musica di Malipiero che prima o poi avrebbe
dovuto trovare chi se la amasse per impeto. Ai nostri fini adattiamola (un poco
capovolgendo il significato della ballatetta): se cultura e letteratura, arte e poesia si mettono,
al calar della sera, vestiti incapriccianti e mini-gonne, perché poi farla tanto lunga se la tivvù
ribalda o i birbanti mediatici le sodomizzano? Fui sottotenente dell'Arma aeronautica,
dicerto gloriosissima e benemerita quanto la Benemerita, ma io quei colonnelli li
sorprendevo ogni giorno a spiare bramosi nei segreti degli annuarî e degli organigrammi per
vedere se ce l'avrebbero fatta ad aggiungere le sospirate greche che gli mancavano al
sommo della carriera prima della minacciata messa a disposizione. Anche su questi prati
fioriscono gli eroi alla Cicciolone. Qui le arti belle e le passioni culturali aspettano a
scatenarsi il passaggio della bella (o dei belli — par condicio!) degli anniversarî. Mi ricordo
quando alla Cini gli scappò di sotto il decennale della morte del suo ex-presidente, ancora
Malipiero; furon costretti a rivolgersi a me, in extremis, e agli ultimi che si poté racimolare
visto che a Reggio Emilia gli avean soffiato la carrozza d'oro. Ma credereste voi che a
Reggio Emilia, poi, ed è passato già un quarto di secolo, abbiano messo in conto mai di
portar sul glorioso palcoscenico dell'attuale "Valli", le Sette canzoni o la Favola del figlio
cambiato? Passata la festa gabbato lo santo. Per un anniversario del Tasso, cominciarono
anni prima a riunirsi consulenti insignissimi e probiviri, ma a parte il solito convegno dei
soliti noti dal quale Torquato uscì né più simpatico né più antipatico di prima (pesa su lui la
condanna di avere aperte le porte al Barocco, che vale a Michelangelo da assoluzione),
riuscirono a conti fatti solo a ristampare, in galante edizioncina tascabile, le Rime nella veste
cucita loro addosso dal Solerti (per l'ultimo appuntamento anniversario col poeta della
Gerusalemme, nel secolo decimonono) e che appena indossata e per oltre un secolo, dunque,
hanno poi furentemente ripetuto ch'era una veste a pezze d'arlecchino e che rendeva
illeggibile il poeta. Ora, sarebbe stato strano che la stessa faccenda non si ripetesse, alla
scadenza del quadricentenario dal rogo in Campo de' Fiori, per un autore dei pochi davvero
essenziali della nostra storia ideale eterna come Giordano Bruno (Dante Boccaccio
Machiavelli e Tasso e Pirandello, pochi più). È gran fortuna che Giordano Bruno sia riuscito
in parte a sfuggire a questa comica condanna (ma il Nolano in Flammis ci insegna che il
comico va preso dimolto sul serio) e a fare, in apparente ritardo, in realtà gettando le pietrebase per una fase sperabilmente diversa, cippirimerli al gufo. Mi spiego (come dice Messer
Ford a Sir John Falstaff). Sulla scadenza anniversaria, correndo giusto l'anno duemila a
spartiacque fra l'èra cristiana e l'era bushiana (tardi se ne avvide il papa e medita aver
sbagliato gli alleati, fatti fuori i più deboli non più rei), i soliti Meridiani milanesi
bruciarono un poco furbescamente la linea di tappa. Dispiace ne andasse di mezzo uno
studioso per altri versi non immeritevole come il Ciliberto, accorso a metter pecette (le
muse degli inchiostri polemici e satirici hanno, qualche lettore si ricorderà, per qualche
mese spuntato pennini e prosciutto calamari anche su queste colonne) su un mancato
accordo fra il massimo filologo bruniano, Giovanni Aquilecchia (che ne ebbe forse
accorciata la nobile vita) e gli imperiti (a far migliore ipotesi) uffici contratti e stampa
momdadoriani, desiderosi solo di una sbrigativa ma autorevole copertura su una impresa
allestita con superficialità — la furia d'esser primi e puntuali (da non prendersi in
considerazione poter smaltire le opere bruniane a fare tempo dall'alba, "dopo i fuochi", del
primo gennaio 2001) risultando la pessima consigliera. Né più fortuna il Filosofo aveva
avuto col volume opportunamente dedicatogli nella misteriosa collana 'nazionale' dei Cento
libri per mille anni, con vasta prudenza architettata da un critico come Walter Pedullà ma
condannata dal Poligrafico dello Stato a realizzazione sgarbata e indifferente. In quel caso ci
si era limitati a puntare su una ristampa redazionale, della cui opportunità può giudicare
ciascuno, degli scritti bruniani nelle inattendibili stampe prodottene, prefilologicamente,
dall'Ottocento e traguardando alle generose ma ormai per gran tratta di tempo sorpassate
revisioni con libera intelligenza procuratene da Giovanni Gentile. Più dignitosi dei
Meridiani gli Adelphi con la sorpresa di un volume di bell'aspetto dedicato alle opere
magiche, non tuttavia perfette, del Pensatore-Fenice. È qui il tratto che si vuol segnalare a
tutto onore delle Opere Italiane del Bruno recentemente edite dalla Utet in due esemplari
volumi. Come in un kolossal hollywoodiano del buon tempo antico, conviene passare in
rassegna i nomi di coloro che hanno reso possibile una impresa di davvero inusitato valore.
In primis l'Aquilecchia, cui pertengono i testi critici e la nota filologica, già stati base (e
splendida conclusione di una vita dedicata alla filologia bruniana) della edizione bruniana
nella collana bilingue de Les Oeuvres complètes (1993-1999) diretta da Yves Hersant e
Nuccio Ordine per Les Belles Lettres. Secondi alla pari, Ordine, coordinatore della nuova
edizione italiana, e Giorgio Bárberi Squarotti, direttore dei Classici Italiani della Utet, che
così (in un momento climaterico della gloriosa casa torinese) invece che raccogliersi in
trincea, a scampo di battiture, anzi rinnova e rilancia con gesto strepitoso e responsabile una
collana a volte anche troppo fedele, in passato, a equilibrismi pedemontani timorosi di vere
escursioni critiche (ma questa è storia dell'Italia d'oggi, che sorte dalla pelle della
ottocentesca incompiuta rinascita, e non se ne rende conto, e ancora in pochi sbarrano le
pupille in un futuro che non si vede), e lettore bruniano fin dai lontani anni in cui la
riscoperta letteraria del Barocco era una avventura anche un poco rischiosa; da perderci la
faccia. La presenza dell'illustre critico torinese è qui in un ruolo chiave, in quanto non solo
egli rinnova antiche sue e già luculente agnizioni di lettura prestate all'unica opera non
filosofica del Bruno, il solforoso Candelaio, l'ipercommedia manierista controspecchio alla
Cena delle ceneri, ma lo fa, in accordo con la lettura più generale affidata alla oggi
ineguagliata competenza bruniana di Ordine, in un quadro d'insieme per cui il Candelaio
non è un 'a parte' nella storia del pensiero del Nolano, ma ne costituisce una sorta di
intingolo generativo, antiporta e matrice o DNA da non poterne prescindere. Il commento
alle singole opere avvalendosi inoltre del lavoro di addetti al cantiere come, ancora, Nicola
Badaloni, la signorina Ellero, Miguel Angel Granada e J. Seidengart (nonché Lars Berggren,
D. Mansueto e Zaira Sorrenti). Ci si stropiccia gli occhi. L'ardente bocca vulcanica di un
pensatore che non ebbe patria se non il fuoco dal quale venne e in cui fu ridissolto diviene il
polo magnetico di una impresa davvero internazionale. Sembra nulla? I testi di Bruno sono
difficili quanto i più imprendibili, la longeva polemica su un pensiero conosciuto per sentito
dire e su un processo del quale nessuno par che davvero voglia (se non per gesti finti e
opportunistici) davvero farsi carico, con vergogna, è più una ennesima dimostrazione della
miseria italiana, trombonismo dei laici e ipocrisia dei figli della catastrofe tridentina. Si
aprono le finestre, entra la luce e l'aria. L'avventura riparte. Qualche lettore si sarà avveduto
di come, senza affatto nominarlo, Bontempelli ponesse Bruno sulla soglia della avventura
novecentista (settembre 1926, primo preambolo). «Nessuna norma, nessun dato di
confronto per giudicare i risultamenti. Non sarà possibile combinarvi sopra alcun
aristotelismo. ... Nessuna legge; ma ogni opera, ogni capitolo, ogni pagina, detterà a se
stessa la propria ferrea legge unica, che non deve più servire un'altra volta. Ecco la regola di
vita e d'arte per cent'anni ancora: avventurarsi di minuto in minuto, fino al momento in cui o
si è assunti in cielo o si precipita». Straordinario corsaro, innamorato della bruttezza virile,
veramente romana, del Duce. E oggi a dare il moto è Nuccio Ordine, con una introduzione
di quasi duecento pagine che, inappagata, mareggiante (e, s'intende, corposa e
razionalissima) dà luogo, in immediato, in più ampia stesura, a un libro per la Marsilio (La
soglia dell'ombra, Letteratura, filosofia e pittura in Giordano Bruno), sùbito balzato alla
ribalta per la riproposizione di un vigore saggistico di cui si era un poco perduta la speranza,
in tempo di vacche magre, e, senza che l'abbrivio si acqueti, predisposto ad aggiunte
ulteriori, non decorative, nella imminente versione francese del libro. Quasi venti anni fa,
questa strategia dove parola poetica e filosofica, emblema e pittura s'incorporano, quasi
coitando fra loro, era stata precorsa, in un lancinante profilo del manierismo, da Andrea
Gareffi. Gianandrea Gavazzeni non è noto che abbia mai eseguito in pubblico musiche di
Giovanni Sebastiano Bach (più vicino credo ci sia andato con un Messia haendeliano in
Santa Croce, a Firenze, nel settimo centenario della nascita di Dante, al quale fu presente il
suo intrinseco amico Gianfranco Contini) ma rivelava agli intimi che non c'era mattina che,
levatosi, non si mettesse al pianoforte e vi eseguisse pagine del Gran Germano. Posso dire,
arrossendo, altrettanto di me, nei dintorni del Bruno? L'ho letto fedelmente per tutta la vita e
alcune opere (non tutte) mi sono familiari. Inutile quanto inopportuno che io prenda ora il
posto di un Leporello per esporvi il catalogo delle idee direttive di Nuccio Ordine. Meglio
che qui ci si limiti a informare il lettore che l'idea della collana bilingue ha germogliato
un'altra collana bilingue, in corso di stampa, sempre diretta per Les Belles Lettres da Ordine
ed Hersant, inaugurata con l'Orlando furioso, tradotto a fronte da A. Rochon, proseguita con
altre rarità umanistiche e cinquecentesche, ma anche con Cuoco e Leopardi, e che ora si
accinge ad affrontare l'edizione bilingue delle maggiori opere del Cavalier Marino. «Alteri
saeculo» e «Nemo propheta in patria», ma questo spiega anche, in questa notte dell'Europa,
il ruolo dignitoso che solo Parigi, insomma, ha saputo esprimere fino in fondo. Quando si
dice Europa torneremo a guardare a lei, viva come quando ne scrisse, pei pittori, il glorioso
Gualtieri di San Lazzaro. Anche ora che non ha più pittori.
IX
LO SGUARDO APERTO
COSA CI VALSE IL CINEMA
Faceva scandalo, nei remoti tempi della neo- o forse meglio post-avanguardia (tutto il
secolo scorso ebbe sempre, nonostante o forse proprio per i suoi disastri e le sue efferatezze
non solo mentali, un ambiguo sapore di postumo), l'idea dell'opera aperta, in cui il lettore o
'utente' doveva voler intervenire non meno che l'esecutore, decifratore e sollecitatore
fantastico di quanto nero su bianco affidato al libro o alla partitura, e non meno che, a
monte, quello che non aveva più tanto diritto di chiamarsi il compositore. Parve opera
anarchica, ed era in fondo socratica; si trattava di far nascere. Si trasferiva sull'opera-non più
opera quella che dovrebbe essere l'attitudine costante, e perfino normale (anche la morale è
abitudine, ma non passiva) nei confronti di quanto il presente incessantemente ci passa ed
archivia. Certo, se qualcuno di noi ancora riguarda, a interrogarlo non a venerarlo che
sarebbe davvero indebita pretesa e arresa venerazione, il passato, i tempi si sono ristretti.
Noi siamo postumi all'arte che parve moderna, novecentesca, marmo e manna e distruzione
(Montale), per eccellenza, il film. Si legge l'archivio del cinema (un secolo scarso) come si
legge il Petrarca o il codice di Hammurabi. Ogni parola è una scommessa, una estraneità
provocante. Le notti brave e infinite di Ghezzi sul terzo canale della Rai non sono che una
mistica catacombale, affidata alla immaginosa fuga dei fantasmi, i corpi illusorii della
proiezione. Uno si allaccia all'altro, lo completa e violenta. Uno dei miei dubbî davvero
teologici, da bambino, è, una volta che mi fui accorto proiettarsi il medesimo, a volte, film
in due diverse sale cinematografiche in contemporanea (nomi per me allora mitici come la
Terra Promessa o il casino di via dell'Oche: Fulgor, Belfiore, Edison, Chiardiluna d'estate,
sotto le stelle, sotto scorreva silenzioso l'Arno), come fosse possibile che il medesimo Wild
Bill Hickock-Gary Cooper (la Conquista del West di de Mille) cavalcasse, combattesse,
fosse messo al palo della tortura, "non parlare Jane!... con Custer ci sono cento soldati...!", si
salvasse in extremis, cavalcasse ancora, e finisse ammazzato alla schiena dal traditore e vile
Jack Mac Call, in contemporanea lì dove io ero, turbato e affascinato, e altrove.
"L'americano attore ghericupo - del dono dell'ubiquo dotato?" Andavo anche dietro lo
schermo, nanerottolo settenne, e stupivo non trovarvi i campi, i cavalli, gli indiani, la notte
ed il fiume. Già in questa chiave, di stupore infinito, si possono leggere gli scritti
cinematografici di una meteora del nostro piccolo mondo culturale, il ragazzo Simone Ciani,
appena editi col titolo Two Rode Together - il fordiano (per l'Italia) "Cavalcarono insieme" dalla fiorentina Polistampa, per le cure di chi si fece, con stupore e pietà di superstite a
quella intravista meteora, editore degli scritti sparsi non solo cinematografici di quel
ragazzo-monstre, un allievo bravissimo della università di Siena, morto crudelmente e quasi
misteriosamente, per chi non crede al dono degli iddii che volentieri se lo riprendono per
goderne nei loro cieli, nel momento stesso in cui si affacciava, quasi incalzato da una furia
di sapere tutto, alla vita. Curatori sono il latinista e poeta oggi dei primi Alessandro Fo e il
misterioso, appartato siciliano in partibus (vive e lavora a Prato di Toscana) Antonio Pane;
costui ricorda (nell'essere appartato e misterioso e attivamente ubiquo ai casi) il mitico
Renato Serra, altro morto (e, questo, ammazzato) ancora in boccio, sul Podgora, solo che il
proprium dell'insigne letterato romagnolo era stata la critica e per Antonio Pane è una specie
di fattiva vocazione alla ricostruzione positiva, archivistica, di opere e figure ed epistolarî
del recente passato. Tra Fo e Pane si mette insieme la testimonianza di fede in Angelo Maria
Ripellino, in Antonio Pizzuto, in Angelo Fiore, scrupolosissimamente riediti e reinterrogati,
e non si dimentichi la traduzione che il Fo diede mirabilmente di un antico noto solo ai
manuali di storia letteraria latina per i licei, Rutilio Namaziano, caro a Pound. A Pane e Fo
si congiunge nell'occasione un giovane critico cinematografico di residenza in Parma,
Michele Goni, cui si deve anche la bella copertina evocatrice di fantasmi filmici, del libro di
cui si parla. Simone Ciani concepiva il sapere come una unità fiorente, nulla gli sarebbe
parso estraneo come l'università, la scuola, l'editoria correnti oggi per quasi piccose
divisioni di (in)competenza, ma si sa, lettere e religione e logos hanno comune radice, il
collegare, e questo certo sommove e terremota (e, di fatto, disvela ed umilia) l'idea falso
ingenua e realmente aggressiva dell'unico DNA di una Europa che, di fatto, si ritrova oggi
senza lettere, senza religione, senza pensiero e, ultima delle beffe, anche senza quadrini,
nummi, sghei, palpiroeu, eurodollari o insomma spiccioli e banconote.
Mentre invito a cercare questo piccolo libro di idee e insieme diario di
sperienze vogliosamente fatte, insisto sulla compresenza, in Ciani, di bulimia cognitiva e di
dedizione alla scrittura in proprio. Così mi torna a mente Remo Pagnanelli (1955-1987),
pari meteora, un ventennio fa, che dalla sua Macerata partiva alla ricerca di una poesia
testimoniata nei poeti viventi, che tutti ansiosamente ricercava e contattava, vittima
promessa alla rapida fiamma, come in effetti fu. Il terzo o quarto tentativo suicida di Remo
riuscì, in un garage, col gas di scarico della automobile. Ricordo l'ultimo rapido incontro,
quando lo accompagnammo in macchina alla stazione di Parma sotto una specie di diluvio
universale. Gli Studi critici di Pagnanelli su poesia e poeti italiani del secondo Novecento
(prediletti Sereni e Bertolucci, basilare, scavante Fortini) sono ancora in catalogo da Mursia,
e le sue poesie, dai bei titoli (Musica da viaggio, Preparativi per la villeggiatura...)
andrebbero cercate da chi ama ancora leggere versi non solo sonori.
Fra i rapiti dal cielo troppo presto (?), voglio anche qui in coda richiamare il
nome di un musicista (e tenore contraltista) e studioso del Barocco francese, Jean-Loup
Charvet (1961-1998), di cui le milanesi Edizioni Medusa presentano ora il secondo titolo,
un libriccino dal titolo La voce delle passioni, che conclude un dittico aperto col più corposo
e sempre affascinante saggio L'eloquenza delle lacrime, purtroppo sciupato in partenza,
nella edizione italiana, dalla vacua prefazione di un vacuo e rinominato biblista monsignore
milanese e televisivo, che speriamo sia almeno riuscita a far vendere. Fu un errore della pur
meritoria Medusa, è l'ossessione degli attuali editori di premettere sempre alla forza nuda di
un libro il placebo della presentazione di esso da parte di un qualche collotorto televisivo o
giornalistico, che riduce l'osso a minutaglia e del raro fa poltiglia o formaggino-mio. Ma
tutti e due i libretti vanno recuperati. Pensare che un tempo ti bocciavano a scuola se non
ripetevi che la Francia era stata l'unica nazione d'Europa salva dal morbo del barocco. Si
avverte che negli studî di Charvet, a lungo pensionnaire a Roma di Villa Medici e direttore
di un superbo complesso barocco (ne resta qualche disco) Les passions de l'âme, si esce
ormai dal forte mito della "voce" barocca (linea, ad esempio, Deleuze-Carmelo Bene) e si
accede a quello più articolato della "eloquenza". Il lettore potrebbe fare un salto alla vicina
bottega dei dischi e comprarsi quelli del regista (anche cinematografica, sulla linea di
Chéreau) e attore Eugène Green, prodotti dalla raffinatissima piccola casa Alpha. Green ci
ha fatto sentire come va letto e articolato il supremo retore Bossuet, o Racine, e allora
davvero dove sta la parola, dove la musica, dove il suono strumentale, dove la poesia
radicata nel suono della voce? Una esperienza decisiva. Una retorica a pieno delle passioni e
dei loro effetti mai sicuri, una poesia e una musica ricongiunte nel liquido amniotico del
mistero del voler dire, della nascita lancinante. Anche per questo da alcuni troppo presto,
ma presto?, si muore.
X
LO STRATEGA STREGONE
NEL SECONDO CENTENARIO DELLA NASCITA DI BERLIOZ
Il lettore più anziano ricorda la fanfara dell’Eurovisione. Tattà-tatatà-tattà-ta. Ci spiegarono
che il musicista era un tardo barocco, Charpentier, da non confondersi con lo Charpentier
della un tempo celebre opera socialista e parigina, Louise. Ne perpetuano il ricordo i soprani
dalle note tenute estatiche, dal soffio paradisiaco : “Depuis le jour...”, perla dei concerti di
un tempo, dei recital in digitale di oggi. Non so se il lettore guarda i bollettini dei dischi di
musica classica che si pubblicano oggi nel mondo. Vasta la crisi della affezione,
dell’appetito e della distribuzione mercantile. Ma in testa alle vendite oggi sono i barocchi e
le Case - soprattutto francesi e inglesi, poco o nulla negli States che preferiscono non del
tutto a torto l’innovazione minimalista congiunta a una piena consapevolezza raggiunta
delle virtù attrattive ed espansive del musical; all’inseguimento con qualche fiatone tedeschi
e italiani - impegnate nella riscoperta del Barocco fanno (uniche forse) affari d’oro. Alpha,
Harmonia Mundi, Opus 111, anche se in Inghilterra hanno soppresso la mitica e
pionieristica Oiseau Lyre, in Germania la leggendaria e califòrnica Archiv. Va da sé che
l’avventura era iniziata nel mondo delle lettere e, anche prima, delle arti figurative, la
polemica sul Barocco iniziandosi dall’architettura. Seguì, fra gli estetologi, la scoperta che
l’architettura era musica congelata, che le pietre cantavano (fin dai primordî, il mondo che
nasce dal suono). “In principio erat musica...”. I provetti fra noi hanno memoria di tempi
non remotissimi in cui alla condanna scolastica del Barocco si legava una musicologia
accademica, di origine tedesca, in cui scontata la maturità nel ciclo furtwaengleriano dei 3 B
(“bibbo, balla e berdiga”, come in uno jacovitti? no : Beethoven, Brahms, Bruckner; o a
scialare : Bach Beethoven Bruckner, strettamente ricalcato da Furtwaengler nelle sue
sinfonie di aspirante compositore, come le poesie di Totò o di Gina Lollobrigida) e la
visione in Dio in una W (di Wagner), la chiara mappa che ne risultava era quella di un
Antico Testamento che dai Fiamminghi si portava a Mozart o all’ircocervo Mozart-Haydn e
dal Tristano culminava nel Moses und Aron, novissimo testamento alla faccia della Gestapo.
Toscanini “tornò” a Verdi da Wagner (Toscanini, come Pierre Boulez, fu avanguardista fino
a quarant’anni e uomo di potere, dunque ritardatario, gloriosamente ritardatario, per i
quaranta che si sopravvisse), la Germania “scoprì” Verdi quando volle purgarsi dal
bismarckismo wagneriano che l’aveva portata al primo disastro. Il piccolo pedaggio da
pagare fu il tradurlo in tedesco, Der Troubadour, Die Macht des Schicksals, Ein
Maskenball... e poté darsi il caso di una Alzira (“ah quella è proprio brutta”, giusta un
giudizio d’Autore che da noi ebbero troppa furia di prendere alla lettera) rappresentata a
Berlino alla presenza del Führer e del suo svasticato entourage. Segnò il debutto di
Elizabeth Schwarzkopf. L’ho presa da lontano, ma il lettore intende che qui non c’era
alcuna fretta di riannodarsi a Berlioz. Non dico nei miei anni universitarî, quando della
Sinfonia Fantastica si parlava appena come di una sorta di incunabulo in terra di Francia del
futuro (e non commendato) poema sinfonico straussiano. E vederlo (ce n’erano i documenti)
come un inciucio fra il vecchio Gluck e il futuro Wagner era una frase come il volume del
cubo qual è, si manda a mente e non si fa la riprova; se qualcuno la tenta davanti a noi, ci
distrae il volo di una moschina, un mucchietto di cenere in procinto di tracimare dalla
conchiglia, una scia di lume polveroso che entra dalla finestra. Tanto sappiamo come va a
finire. Questo comporta un altro inghippo pratico; alle volte mortale : gli specialisti. C’erano
gli specialisti - e che compunta competenza e noia - di Gesualdo, di Gluck, di Haydn, di
Berlioz (in Francia, ma anche in Inghilterra dove lo degustavano come una sorta di
oratorista improprio, fra il Messiah e il Gerontion di Sir Edward William Elgar). Berlioz
non era riuscito nemmeno a farsi fare “sir” o qualcosa di equipollente. Con la voglia di
scommessa dei nostri Conservatorî, è ovvio che il nostro Berlioz, si fosse trattato dei
musicisti, non si moveva più dall’angolo dei vergognosi. Più sensibili i letterati, o i critici
scrittori dei quali oggi si è non perduta ma davvero strozzata fin dalle fasce, la razza. Non
lasciatevi impressionare da qualche tardiva e sporadica iniziativa in onore dei trapassati
Massimo Mila, D’Amico Fedele, Vigolo Giorgio e B. Dal Fabbro, nonché il Poeta
Seppiaceo, che avevano un torto originario : si dannavano l’anima per la musica, volevano
vederci dentro; dentro alla forma, forma di vita, non dentro allo stile, grammatica di
burocrati. Fu leggendo i loro interventi in diretta, su quotidiani e riviste, poi raccolti in libri
che tesaurizzavamo, che fummo presi dal tarlo, dal rodìo, dalla smania, dal verme solitario
berlioziano. Che magia dovevano essere quei Troiani da Virgilio, mai ascoltati se non nel
lacerto della Caccia reale e tempesta : ridotti a episodio sinfonico, a poema sinfonico (ahi)
in un collo di bottiglia. Come l'Eneide in un madrigale. Fuori d’Italia (ho sempre
considerato Trieste “fuori d’Italia”, come del resto la nostra Sicilia, e non v’è in questo
diminuzione ma cognizione d’una ricca e invidiabile estraneità) il wagneriano Silvio Benco
ne tracciava, al principio del secolo perento (1903), un ritratto privo di simpatia, ma, come
spesso riusciva a Benco, internamente contraddittorio, mosso e aperto alla verità. Si legga
l’articolo del grande critico triestino nella recente riedizione di una antologia storica dei suoi
scritti, promossa addirittura alla vigilia della prima guerra mondiale dall’amico di Benco
Umberto Saba (La corsa del tempo, a cura di Gianni Gori, Trento, La Finestra, 2003, euro
28). La rinascita berlioziana seguì di poco la rinascita mahleriana degli anni 60. Potrei
indicare tre dischi storici, le Nuits d’eté, su poesie di Théophile Gautier, cantate da Regine
Crespin, una offenbachiana, con la direzione dello stravinskiano Ansermet. La Symphonie
Fantastique diretta (con Lélio al séguito, come si deve) dall’ex-darmstadtiano e surrealista
‘freddo’ Pierre Boulez. E i Troiani nella edizione completa del Covent Garden, per opera di
Colin Davis, ch’era noto come insigne mozartiano (ed è anche, irriconosciuto, uno
straordinario stravinskista). Le carte si rimescolavano, l’Atlantide riaffiorava. Fu una
battaglia strepitosa e in luce e, come la storia matura, vinta quasi al solo presentare le carte.
Così, come accade, Berlioz entrò finalmente nel repertorio e questo volle dire un guadagno
e però anche una perdita. Lucifero aveva ore le ali mozze, il nerofumo era di liquirizia. Sarà
vero? L’occasione bicentenaria sta per riscatenare omaggi (mi riattacco all’esordio)
charpenteriani - qualcuno ricorda ancora il nome di Charles De Gaulle, di Malraux? Berlioz
come epifenomeno della grandezza del Re Sole, di gran moda - anche cinematografica - di
questi tempi a Parigi. In Italia, una volta tanto, li si è colti d’anticipo e di contropiede. Fin
dall’anno scorso è in libreria un libro di singolare ampiezza culturale e libertà mentale come
le Strategie del fantastico (Berlioz e la cultura del romanticismo francese) di Laura Cosso
(Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2002, euro 18,08). La Cosso, insegnante nei conservatorî e
a tempo debito regista teatrale di mano preziosa, è allieva di Giorgio Pestelli allievo di
Massimo Mila. È la Torino che più ci piace. Chi ha conosciuto l’Autrice sa che è donna di
spiccato fascino personale e di suggestiva autorevolezza nell’insegnamento dal vivo. Il
libro, nella scrittura, può apparire al confronto singolarmente frenato. È una scelta d'autore e
lo si capisce meglio a pensare al bataclan che si prepara. Il libro della Cosso culmina, non a
caso, in una analisi molto sottile del Berlioz meno babilonese, il liederista delle Nuits d’été,
che aprono sul ricco futuro della poesia cantata decadentista, da Debussy e Fauré a Satie
(sarà paradosso) con la coda dei "Six" e al non estinto vigore del genere nella Francia postbouleziana. La Cosso deve aver ragionato così : Berlioz suonato su un grancoda, come un
Liszt letterario e visionario, ci menerebbe in una trappola ben trincerata. Avete sentito il
fracasso? Era lo Steinway precipitato da una finestra. Sul palco ora portano un fortepiano e
al fortepiano siede con calma, pazienza e ben velata sensualità - un suono secco, legnoso,
tutto significante, per un poeta del suono ridondante, grasso e visionario - la nostra
scrittrice e musicologa. Uno strumento antistorico? Non è la prima volta che la verità nasce
dal coraggio di leggere la storia a contropelo.
XI
IN MORTE DI MIRIAM DONADONI*
Nei giorni immediatamente successivi alla Pasqua, il 22 aprile, è mancata, nella sua casa di
Siena. Miriam Donadoni Omodeo. Era figlia di Eugenio Donadoni (1870-1924), italianista e
critico insigne (nata il 25 luglio del 1916) e moglie di Pietro Omodeo, l'illustre storico della
scienza, figlio a sua volta del grande storico e amico del Croce Adolfo Omodeo. Tradizioni
familiari così eccezionali avrebbero potuto schiacciare sotto il loro peso chi non avesse da
natura portato un carattere indomito e una intelligenza umana e intellettuale pari a quelle di
Miriam Donadoni. Musicista, pianista, concertista, insegnante nei conservatorî, studiosa e
infaticabile ricercatrice, fu anche madre di molti figli, come non è più delle attuali signore in
carriera, ed ebbe molte bestie domestiche amate, cosa che non di rado è sufficiente a
distinguere dei temperamenti privilegiati. Perché il segno che Miriam Donadoni lascia in
retaggio a chi ebbe il privilegio di conoscerla ha una faccia doppia e, a ben guardare, unica:
la passione della verità e l'amore. Non ci vuol nulla a concluderne: non era una studiosa
d'accademia. L'oggetto di studio privilegiato dalla Donadoni fu davvero un fantasma, quel
Giannotto Bastianelli di cui restava un ricordo, ammirato e segretamente imbarazzato fino
alla reticenza, da parte degli antichi intellettuali vociani, che avevano imparato da lui il
linguaggio poetico della musica, e che nella storia della nascita di una critica e di una
estetica musicale moderna, nella Italia del melodramma sfiorito dalle sue antiche glorie, si
segnala come quei che va di notte e porta il lume e a sé non giova. Disperato, incalzato da
misticismi e omosessualità, era morto in circostanze misteriose, forse suicidio, forse
winckelmanniano assassinio, a Tunisi, nel 1927. Cecchi aveva detto (mettendoci una pietra
sopra): andrebbe bene per un romanzo di Cicognani (ma non il Bruno Cicognani che
qualche lettore più curioso avrà in mente per il suo L'età favolosa,un Cicognani precoce,
'nero', del quale anche si son perdute le tracce). Sul pensiero, ricco e complesso, di
Bastianelli (un debussyano che capisce come va inteso Mascagni, un pizzettiano
dissenziente che divina all'istante il neoclassicismo infernale di Malipiero, un italiano che
guarda all'Europa senza gli imbarazzanti nazionalismi della corrente musicologia) si era
illuminati da personaggi atipici come Massimo Mila, Gianandrea Gavazzeni e Luigi
Baldacci. Ma, tranne i libri non ristampati e che si potevano comunque riscovar fuori nelle
biblioteche meno peggio fornite, di Bastianelli era disperso tutto, le carte critiche, la musica
dimenticata; la famiglia stessa pareva più desiderosa di silenzio. Fu dedizione eroica e
paziente quella che aiutò Miriam Donadoni a risolvere le intorte fila di un caso disperato; a
quel punto anche l'accademia si era mossa e diciamo, con l'occhio di poi, che non ci fu vera
partita, tanto il progetto era incompatibile. Le fila per la Miriam tendevano a comporre un
gliommero che rimaneva caldo e come ancora un poco cruento; la scienza universitaria
guarda al geometrico e al teorematico e ognuno è libero di fare le proprie opzioni. Le
ricerche bastianelliane di Miriam Donadoni sono affidate ad alcuni volumi di documenti e
indagini tuttora nel catalogo di Olschki. Della attività di pianista della studiosa restano
scarse testimonianze, ma non reticenti. Almeno due compact, uno (edizioni Ares di Verona)
di musiche bastianelliane (il Concerto per due pianoforti, con la fedele collaboratrice Piera
Brizzi, e la Sonata per violoncello e piano, con Gisella Pasquali) e uno, più
recente(EDIPAN) dal programma insieme rivelatore e quasi autobiografico: si parte con
Unilateralità. Sintesi e Trasfigurazione di Roberto Lupi, si prosegue con due gruppi
dialettici, quello italiano (Petrassi, Muzio Clementi e Casella) e quello francese (J.A. Alain,
J-L Martinet e Messiaen). Nè l'accademia né le società concertistiche ci sono ancora
arrivate. Miriam Donadoni andava dilà dalla esattezza tecnica, del resto infallibile; trattava
la musica come una lingua che dice parole, che tiene ragionamenti in un lessico sconosciuto.
La malattia la colse mentre rileggeva le meno sciupate sonate di Beethoven: decifrazione e
canto.
XII
UN GENTILE SILENO MUSICALE
SAPER ASCOLTARE I DISCHI
Qui ci vorrebbe La Fontaine. A raccontare diversamente la favoletta del Sileno il quale
com'è noto ci trovava il suo gusto a sembrare di fuori un porcospino e ad essere didentro un
alchermes. Il nuovo libro di Giorgio Pestelli (fortunati i suoi scolari all'università, ora che
perfino sulle rivistine patinate di musica e dischi fanno tutti i sovracciò) si presenta
all'inverso di un bestione ringhioso, mettiamo in esempio i libri musicologici del mio
amatissimo Adorno che per fortuna tornano sui banchi di libreria e anche meglio tradotti che
all'epoca eroica del mispezzo ma non mispiego, e nemmeno sventaglia la coda giardiniera
del pavone (linea-Barilli a intenderci). Il bello è che questo libretto, chiaramente facendo le
viste di volgersi a un pubblico il più largo e dunque il più facile a spaventarsi, presenta fin
dal gioco di titolo (Gli immortali, come quei film buoni per tutte le pasque avvenire o le
collane da edicola) e sottotitolo (Come comporre una discoteca di musica classica) le carte
di una giocondità pacata e appena autoironica. Benedetta negli scrittori la capacità
d'autoironia. Come intento dichiarato (e occasionale; altra misura d'ironia) il libriccino
raccoglie le recensioni discografiche di musica classica (dizione ahimè tanto poco ironica
quanto imprecisa) uscite per alcuni anni su "La Stampa". Vediamo che si tratta di altra cosa
nella sostanza, ovvero di una microstoria della musica europea da Palestrina o Monteverdi
(ma ci sono puntate all'indietro) al Novecento meno linguisticamente esposto (i più avanzati
mi pare siano la coppia dei cugini Britten e Sostakovic). Pestelli sapeva bene che sarebbe
stato difficile farsi seguire da lettori in primis torinesi su lande più agghiacciate e impervie,
ma soprattutto sa che non si può più contare su un pubblico di formazione definita e
d'appetito sicuro. Questi immortali in cd son come gli uomini grandi degli antichi sipari di
teatro, tutti ispirati alla Scuola di Atene di Raffaello. In pose esemplari aspettano i nuovi
venuti e se son degni, tutti onor gli fanno. Anche la scrittura di Pestelli è raffaellesca e mi
vien voglia di commentare come il carceriere dell'Andrea Chénier corrotto con gioielli e
denaro: "evento raro in tempo d'assegnati" cioè di cartamoneta svalutatissima. Faccio il
professore come Pestelli e quando i miei scolari mi presentano i loro lavori extraccademici o
si rifanno i poeti a Zanzotto o si credono, i prosatori, Busi-nati. O ragazzi io vi esorto al
disegno dal vero. Ma la trincea più dura da conquistare è quella di convincere i musicisti
che l'ormai enorme patrimonio di musica registrata che il Novecento ci ha messo a
disposizione non è una perdita secca. Esemplare il tombeau di Gieseking stilato da Fedele
d'Amico: "Molti si consoleranno coi dischi. Ma purtroppo, quanto a fede nei dischi, io sono
un povero ateo". Non parlo di quei sopranini che non ascoltano la Callas per non esserne
dicono influenzati. Una vera dottrina di Monroe della educazione alla musica. Molta musica
del Novecento è nata prevedendo l'immillazione discografica. Io non mi dolgo di avere lo
Strawinsky di Ansermet o il Britten di Rostropovic. Magari averci la pira ottocentesca del
Bucardè! Che tanti bei soldoni portò a Verdi. Nemmeno Massimo Mila, che fu maestro a
Pestelli, stravedeva pei dischi; e Gavazzeni odiava soprattutto registrarli (ma so che frutto
sapeva trarre dall'ascolto dei dischi di Toscanini). Si arriva a quelli che credono al Platone
esoterico della tradizione non scritta e tuttavia non fanno una piega quando si tratta di
fondare sugli appunti presi a lezione dagli assistenti di Aristotile. La verità è che lo spirito
soffia dove vuole, mentre Mila restituisce Verdi alla cultura italiana sonandoselo al
pianoforte o mentre Schnabel registra l'integrale pianistica di Beethoven fissando l'ombra
del beato regno. Comprendere è approssimare. La tattica di Pestelli è di partire da un nucleo
di sapienza abbastanza condivisa e poi scheggiarlo al caso della esecuzione di fatto
proposta; la pedagogia dell'ascolto consapevole celebra qui senza metterla giù troppo dura i
suoi ammirevoli fasti. Anche lui favolista sottile: Rilke fanciullo si scontra "duramente in un
signore corpulento" che è Brahms, da allora rifiuta la musica. Pestelli, come Mila, è di quelli
che più sottilmente hanno saputo sfruttare l'immensa lezione di Brahms, musicista elusivo,
gonfio e accademico come un romanziere ottocentesco per quelli che han fretta di arrivare al
finis. Mila faceva però per lui il nome di Proust. La tensione è fra la spinta immensa,
fluviale, e la capacità di dar vita a quelle definizioni dalla giacitura agiata, a quelle frasi
brevi che incidono la memoria una volta per sempre, dove il possesso si fa nostalgia. Un
segreto degli scrittori veri, per Pestelli uno strumento normale. Prendi un caso difficile,
Gesualdo: "anche le espressioni più lievi o liete sono sempre segnate dalla nervosità
manieristica di questo musicista splendidamente solo". È l'uovo di Colombo.
XIII
TRADUCIBILE PIZZUTO
Ci si domanda dove ci si era sbagliati e ci conforta l'intrapresa via ch'è riparo all'errore. Non
mancarono cure mai né fede né sfarzo di intelligenza e non mancarono gli unici lettori coi
quali in fondo si sarebbe trovato a consentire l'autore misteriosissimo e altero, i lettori
pazienti e gioiosi. Ma la battaglia ogni volta era perduta di nuovo. E forse dicendo così
sbaglio e avrei dovuto dire ch'era anche troppo vinta. Troppa grazia sant'Antonio? Segnamo
intanto due titoli e tre nomi: Sul ponte di Avignone e Signorina Rosina. Antonio Pane, Denis
Ferraris e Rosalba Galvagno per le cui cure la Polistampa di Firenze realizza il nuovo dittico
della sua nuova edizione Pizzuto intanto annunziando ch'è in partenza una nuova desiderata
edizione delle opere scomparse di Pea. La figura di Polistampa alternativa a quella di
tonitruanti collezioni di classici italiani del Novecento che si stancano a mezzo. Vizio
d'origine l'autoreferenzialismo filologistico di alcune imprese o i conti fatti dai consigli
d'ammministrazione di altre. Innegabile che una ventina d'anni fa salutai mia moglie che
usciva per fare due soldi di spesa e me la vedo tornare dopo mezz'ora con tre borsoni carichi
e dentro non vettovaglie ma tutto il Pizzuto del Saggiatore comprato lo giuro a peso. Ebbi
tutto Pizzuto per mille lire e me lo tengo. Era un'altra delle sue Signorine Rosine? Il lancio
era stato felice, ora si apprende che dopo mille incertezze il libro fu portato da Solmi a Luzi
e Bilenchi per Lerici e questo vuol dire una cosa; che Solmi aveva fissato la propria
immagine di Pizzuto in quella del narratore-poeta. Se la vedranno loro si sarà detto.
D'altronde solo quando sarà fatta la storia di editori come Lerici avremo in mano la
tramutazione che avvenne anche nelle lettere al passaggio degli anni 60. Noi sappiamo bene
che Pizzuto non è un narratore-poeta. Non è però nemmeno l'eroe della grammatica tentato
poi di introdurre con petulanzia. Cambio di marcia violento e Speedy-Pizzuto perse per
strada alcuni dei primi lettori consenzienti senza riuscire ad attrarne molti dipiù se non per
uno sfaglio della moda. Anche Pizzuto parve travolto dalla nuova onda ma noi sappiamo
che non lo fu. Il passo nuovo lo fissò Pane col suo "leggibile Pizzuto" e leggibile non solo
mettiamo nella Rosina o sul ponte o ai venturosi recuperi di Ràpin e Ràpier e Così ma fino
alle ultime pagine che spengono le caldaie. A volte il segreto di Pulcinella se uno si
convince che i libri anche estremi di costui si lasciano agilmente penetrare quando il lettore
innesti una sorta di commutatore automatico: come pellicole viste alla moviola incantate per
sospensione dei fotogrammi singoli in montaggio poi degustate. Un mezzobusto tv disse
una volta con disprezzo che in fondo anche Pizzuto non è che un poliziotto che scriveva. Se
ne ringrazî Iddio. Fra quello che ha affondato le lettere in Italia ma l'Italia sia chiaro avrebbe
affondato altro che le lettere è la pretesa che uno faccia sempre e soltanto il poeta. Mestiere?
professore, scrittore. No vivaddio. Può bastare uno pseudonimo (il grande diplomatico
Saint-Léger Léger è il sommo Saint-John Perse già apparso a Larbaud come Saintléger
Léger) e anche Pizzuto finché fu 'sotto le armi' ne riuscì convinto. Sul ponte d'Avignone fu
accreditato a un misterioso Heis che forse è come argomenta la postfazione un greco 'Heis,
l'Uno, o forse sarà un Àis, il Diàccio, anzi in veritate scripturae e l'una e l'altra ed altre cose
ancora che si possano pensare. Pizzuto pensa grande senza staccare l'occhio dalla vita. La
quale è quello che è. Gliòmmero. Lo scrittorucolo di professione pensa che la scrittura possa
risarcire la vita. Alla sua mensa mai si pronunci mercante. Quando Pizzuto e Spinelli
incrociano i fioretti sui modi del narrare son due alti burocrati che non dissertan di lettere
messa sù la toga curiale. Oh quel ser Nicolò in robone rubizzo sul vaso apertovi accanto il
Titolivio. Quello che sta più dalla parte della musica, Spinelli, poi crede meno (ne ha meno
bisogno) a una scrittura che sia totale musica e Pizzuto ne lo rimprovera forte. Chi scrive
mallarmiano blocca le funzioni vitali in sigle inesportabili e Madeleine Santschi a suo
tempo tradusse a fronte e in diretta le Ultime con le Penultime. Traducibile Pizzuto. Dunque
la musica di sillabe è non fine a se stessa, la musica è allusa ma fu. Pizzuto sarebbe stato
compreso meglio da siciliani più antichi, pregreci, da un dipintore rasena di morti volti, ah
forse è lui la Donna che fuggì a cavallo. La sua scrittura il suo supplizio (il Sacre) e basti
Corman a farlo vedere. Penso a Pizzuto e non mi vien di accluderlo a una serie Petrarca o
Carlemilio o Giàimegiocio ma alla luce filmica. Il segreto del film è la parusìa del poco e
tutto essere ch'è: vita. Altro segreto: vita ha tutti i suoni e lo scrittore è tramite che l'eco
d'uno almeno se ne serbi, "come in perfetto silenzio e compostamente nella gioia".
Crocifisso allo scrivere, non ultimo. Così moristi gattina Camilla.
XIV
“M A”
*
Il piccolo, fragile ebreo aveva tirato l’ora tarda; sulla tavola gli avanzi della cena, le cicche
spente male nei piatti sporchi, i bicchieri a mezzo bevuti. Qualche tovagliolo scivolato da
mani ormai semi-addormentate; eravamo bambini e lui rievocava, con una voce di tenero
congedo, il tempo vissuto nelle fauci dell’Orco. Si chiamava Levi e mentre, in una notte che
pareva non dover mai finire, cantava forse per l’ultima volta il suo canto di perdono e di
testimonianza, moriva lì in mezzo a noi, sembrava diventasse di momento in momento più
piccino, già si raggomitolava in posizione fetale. Aveva di carta velina le pareti del cuore.
Non passò molto che sentii dire che era morto. A me aveva lasciato un segno, la
famosa pallottola di diamante che ti si pianta in mezzo alla doppia arcata delle ciglia e
comincia a scavare la sua via, retrocedendo con ostinazione invisibile, fino a che abbia
messo radici al centro del cervello e sarà allora anche la tua morte. Ma la ferita non venne
dalla rievocazione degli orrori. Ne avevamo sentito dire a scuola, a volte erano venuti
politici a “sentirsi” parlare. Gli scolari ammucchiati in palestra, a volte in chiesa. Se i
maestri, se i politici sapessero quanto un bambino, un ragazzo sa guardare nella bocca di chi
gli parla. Non sa nulla se non riconoscere, a primo colpo, l’insincerità. Se lo sapessero
chiuderebbero, finalmente, le atroci scuole, metterebbero le spranghe ai parlamenti.
Quanta gente veniva in casa nostra, alla tavola di mio padre (poco meno che povero, appena
agiato minacciatamente, aveva un concetto elastico, allargato di famiglia); una gran casa (di
poche stanze), a un piano, presa in affitto, credo, alla vigilia di sposarsi, con un grande
salotto, una immensa cucina con camino (e l’unico balconcino) ai due capi di un corridoio
diritto, lungo e buio, sul quale due camere mediane e, di fronte, un bugigattolino che era la
ritirata, il cesso. Vi si apriva un finestrino grande quanto un libro e dava su una corte di
contadini, dove cantava il gallo a tutte le albe. Posso dire che fu la mia isola del tesoro e non
durò che fino all’Anno Santo. A quel punto anche la casa si trasformò, diventò la base di un
edificio, brutto, a tre o forse quattro piani; aumentarono le stanze, guadagnando dal lato del
cortile, e fu una casa come tutte le altre. Era stata una storia durata meno di cinque anni, la
storia dell’Italia che aveva cercato d’essere democratica. Questo costò agli italiani l’averci
una vasca da bagno.
Venivano colleghi di mio padre, viaggiatori di commercio, “rappresentanti” come anche si
disse, azzimati come in un film dei telefoni bianchi, reduci dall’Affrica (“io ho quel che ho
donato”), reduci dalla Russia, giovani atleti (mio padre s’era trovato a dirigere una
squadretta d’allievi ciclisti), giocatori di scopone (forse di qualche pokerino a rischio
minimo), commessi con una bella voce e nemmeno una romanza intera nella memoria, a
volte qualche attore dilettante, qualche piccolo truffatore, alcuni ex-fascisti delusi,
amarissimi, degli assicuratori nerofumo, poche volte, mi sembra ricordare, un poliziotto che
lasciava alla porta il casco da centauro. Scendeva uno dall’Appennino romagnolo che
periodicamente entrava in un convento e poi ne usciva quando si era un poco allentata la
stretta dei creditori. Ne diffidavo. Non avrei potuto dire: “sembrava di vivere in un film”,
quando il sentimento ignorato era che il film e la vita non conoscessero ponti da scavalcare,
non pagassero dogane dall’uno all’altra. Era un filo che si svolgeva naturalmente, il filo
della vita. Difatti non vennero mai preti, maestri né politici.
Prendendomi di sorpresa, anni fa, un mio fratello che immagino, oggi, berlusconiano o, già,
ex-berlusconiano, mi disse che mio padre era fascista. Certo aveva dieci anni l’anno della
marcia su Roma e l’educazione fascista lo avrà intriso (della propaganda sapeva sùbito
scrollarsi perché era rimasto bambino). Un giorno forse qualcuno studierà il caso d’una
istintiva democrazia che albergava come un dono naturale, senza ricercatezza, nei modi di
rapportarsi di figli involontarî del fascismo che nel mutato regime non avevano intravisto
una bella occasione per salire. Si può rigirare la giacca, cambiare la gabbana, farsi rifare la
faccia, ma la voce non cambia. Preti maestri politici ce l’hanno sempre nel naso.
La freccia-gioiello del piccolo ebreo moribondo fu quando prendendomi a obiettivo diretto
del suo dire a se stesso, un monologo-agonia interminabile, e mi prese a obiettivo perché ero
in fama a nove o undici anni di primo della classe (la mia fortuna fu l’avere ripetuto la
seconda media, sentirmi rifiutato e vulnerabile, so perché fu — si era entrati nei cupi
Cinquanta della celere e della censura e il potere si era andato ricomponendo, qualche
monello di periferia che attentava alla scuola media borghese era, ad maiorem dei gloriam,
da respingere; la patria si salva anche facendo la guardia al teorema di pitagora — e ne
ringrazio lo stesso i manigoldi che mi impartirono la lezione, sbirri e bidelli d’una
provvidenza che se ne serve e li butta), mi parlò della fortuna di vivere a Firenze. Era
innamorato delle ricchezze d’arte di quella città-museo, ma invece di lodarmi, da passatista,
i musei (la freccia, in quel caso, andava a vuoto, tanto mi ripugnava tutto il morto) mi andò,
come al cadere d’un sipario, rivelando la normalità di vivere in mezzo a cose toccate dalla
bellezza. Ogni città ha il suo museo, come il suo cimitero. Dava parola a una cosa che
conoscevo benissimo senza aver mai pensato che si dovesse darle parola. Si allargava, però,
la mia mente. Non solo non c’era dogana fra la vita e la fantasia, non c’era dogana
nemmeno fra la vita ed il bello.
Come non son mai riuscito ad amare il museo così mi sottraevo, già nell’infanzia, alla visita
allo zoo, dove dilà dalla gabbia le bestie vivono fra i loro escrementi e vanno disfacendosi
in putrefazione.
Credo di avere parlato, fin qui, di Marinetti. Nel suo futurismo c’è meno posto per il futuro
(seppur in un cielo che è cielo di terra, cielo sulla terra, ed espediente semantico, non
platonica opposizione; e lo percorrano lampi, forse solo metafore, di messianismo e
progressismo materialistico ingenuo) che per il sentimento del presente. V’è dell’estetismo
romantico — le armi del futurista sono la poesia, la pittura, il disegno, la musica, il teatro, la
danza, sviscerate nei radicali del getto di parola, dell’irradiarsi segnico, della pulsazione
fonica e mimetica primitiva, o meglio preistorica — senza di che ci troveremmo in
presenza di una ennesima divaricazione, la parte del reale e la parte del sogno, la parte del
vissuto e la parte del bello. Assente, in Marinetti, e basterebbe a farne un caso non
contemplato, una volontà di affermarsi nel brusco e nel non dissodato, ogni consenso verso
la dialettica. V’è, prepotente, corporale, come lo scarto da una malattia, la recusazione del
non vivo. Esso è chiuso nei musei, nei codici, nelle scuole, nelle ripetizioni, nei lazzaretti
del passato. Il Passato che uccide.
Non v’è tragedia e non v’è rivoluzione in uno che si sveglia incatenato in piedi in una bara
d’acqua e mentre l’acqua tesse in alto le sue spire e vuole arrivargli alla bocca si dibatte,
sguazza, scalcia via l’onda assassina, urla, boccheggia e stride a un fessolino aperto sul
vetro della bara a furia d’unghie. Unico tempo il presente.
Il tempo vissuto da Marinetti è in quello che i giapponesi chiamano il “MA”. Heinz Reber,
musicista bernese dei nostri giorni, ha dedicato due sue composizioni, di acuto fascino
intellettuale, di profonda suggestione sonora, a questo concetto, per noi, esotico (si cerchi il
disco ECM dei Two Songs di Reber, I School of Vienna – II School of Athens / School of
Nô) e serviamoci della complice scheda firmata per il disco da Hans-Klaus Jungheinrich
(solo volgendola in italiano): «In giapponese lo spazio intermedio chiamato MA si scrive
combinando i caratteri per dire “porta” e quelli per dire “chiaro di luna”. La “porta”, presa
da sola, è una metafora ambivalente, dato che può implicare l’idea di barriera come quella di
accesso. “Porta” e “chiaro di luna” combinati indicano una distanza discreta — la luna non
tocca la porta ma il suo chiarore sì; esso inonda la porta di luce e penetra lo spazio racchiuso
dietro di essa». Il concetto del MA «diviene qualcosa di simile a un motivo-guida» per chi
ascolta i due pezzi di Reber (eseguiti nel disco da tre artisti orientali): «Per gli esecutori
asiatici essi sono un richiamo alla tradizione antica; per gli altri musicisti una apertura sul
nuovo».
Ucciso il chiaro di luna resterà solo la porta? E sempre nella sua duplicità.
Questo, per me, il messaggio, che ero pronto a raccogliere, del piccolo ebreo dal cuore di
cartavelina. La bellezza non stava in un museo. Non ci si bagna nella stessa acqua due volte.
Il tempo incatenato è una illusione e va rimosso, ché suscita pestilenze.
Si è fatta gran questione dell’inno marinettiano alla guerra igiene del mondo. Nugoli di
anime belle (pronte a farsi tolleranti, come si è visto anche di recente e come mai si smise di
vedere, quando non complici, di guerre e altro se la retorica o il vantaggio di parte sappia
dipingerle buone ai beoti) erano pronte a fingere di credere che il gran bagno di sangue
dell’Europa sia stato un favore fatto ai poeti guerrafondaî. Nessun conto si è fatto mai di
quanta fosse stata la scabbia da radere. Ai poeti si è sempre chiesto di suonare il piffero (ché
la tuba richiede altri polmoni) per dare un tocco di plausibilità a decisioni prese sulla cima
di Olimpi cui essi non accedono se non per allietare i convitati. Imbiancano la casa, non la
fondano, neanche la distruggono. Gli studenti in piazza che chiedevano la guerra? Ebbero
tutto il tempo per pentirsene. La “voce”? Diventò bianca. Ma gli studenti in piazza, gli
operai in sciopero, le donne sui binari a gambe aperte servono solo a coonestare quello che
si vuole che sia voluto. Se no bastò qualche carabiniere a cavallo, i mitra ad alzo-uomo nella
piazza maggiore di Reggio Emilia, i carrarmati a Tien-an-men Square.
D’Annunzio che trascinano tutto lustro allo scoglio di Quarto, andò sui fondi neri del
ministero. Gli pagarono i debitucci, la solita orgietta dopo il discorso (un deputato socialista
tentò il colpo gobbo di rivelare la cosa in parlamento e fu peggio che aver detto male della
madonna). Ripitturò alla Bisanzio in crême liberty le cartoline precetto già partite a migliaia
di migliaia. Era del resto, senza concorrenza, il più grande poeta d’Italia.
Ho detto che Marinetti non aveva gran conti aperti col messianico. Per chi si scandalizza,
tuttavia, di un fortunato slogan e di qualche cazzotto (cose, si ammette, che fortemente
datano quei fatti, bisogna abituarsi al pensiero che quando li leggiamo nudi e crudi, quando
li andiamo ripercorrendo sopra testimonianze documentarie non mediate, essi avranno per
forza del ridicolo come le solenni parate e le mortali uscite dalla trincea viste nel
ballonzolante ansimare delle pellicole cinematografiche del tempo), basti riaprire Matteo, X
34:
Non pensate ch’io sia venuto a metter pace in terra: io non son venuto a metter la pace, anzi la spada.
«Bellum in terris». Il punto non è la pace o la guerra astrazion fatta da tutto il resto. Dalla
parte del pacifismo parla la scelta di Palazzeschi, che sa una cosa che Marinetti, nell’alcova
d’acciaio, non sa: la tenerezza dei corpi giovani, il dato primordiale, paradisiaco e materno,
della docile, piegata (piagabile) animalità. In una repubblica la cui costituzione, prima
d’esser ridotta carta da cesso, ripudiava la guerra, i Tre imperi… mancati dovrebbero essere
prescritti come testo di lettura fin dalla scuola media. Ma in un testo sacro ci dev’essere
pane per tutte le bocche, c’è la spada e l’agnello di Dio. Lapidare Marinetti per il suo
bellicismo è mettersi al riparo di ogni storia, magari, come il Resuscitatore (lo spazio d’un
mattino) del Lazzaro-Lucini, per contentarsi alla fine d’un laticlavio o d’uno scranno
imbottito di retorica, ai Lincei.
Marinetti lo ebbe anche lui, in mancanza d’altro, il suo scranno (con la feluca, in
Accademia). Per vicino di posto si sarà magari trovato l’Angiolo Silvio Novaro.
Immaginiamo gli scambî di bigliettini profumati: “gli obici rondini in volo e la màmmola
calda degli shrappnels…”, “partono i reggimenti…”. Era una specie, anche quella, di
governo d’unità nazionale. E non si fece mai Leporello, il Filippotommaso!, ma quando
Don Giovanni da Predàcchio ebbe la botola aperta sotto i piedi, volle cavalleria, non
servilismo, che il Duce del Futurismo si calasse nel fuoco anche lui. Erano ossessionati dal
do di petto. Duce infelice corro a salvarti o TEEEEEEEEEEEco almeno … corro a morir.
Maurizio Tiberi, alla Discoteca di Stato, ha preservate le testimonianze orali di Giacomo
Lauri Volpi, il tenore del Duce, e quelle vocalistiche (arte della phoné…) di Marinetti, e a
volte sullo sfondo dello sfrigolìo dei vecchi dischi detti amorevolmente: “padelloni”, le due
linee vocali segmentate, nervose e melodrammatiche, si possono quasi confondere.
Imitavano il Duce o il Duce imitava loro.
Lasciamo in bilico Chi imitava Chi. Quando è l’ora le cose precipitano da sole. Il vecchio
Ezra scrisse allora quei due suoi unici Cantos direttamente in italiano. In una terra di
nessuno arcaica e brancaleoneggiante, così il miscuglio di un inglese biblico, di antichi
dialetti di popolo o gerghi specialistici di professioni e d’usi, l’incrocio con olandesi,
francesi, spagnuoli, ebrei, mori e moriscos, schiavi, soldati e puttane, fermentato dal
bisogno di esprimersi, di una lingua per vivere, in assenza quasi totale di scritture, certezze e
vincoli “di riferimento”, dà luogo in tempo reale, in tempore necessitatis, alla lingua degli
americani. Nel Canto LXXII (“Purché si cominci a ricordare la guerra di merda…”) è
l’addio a Marinetti, morto di crepacuore e di strapazzi, vecchio soldato alla guerra, non
arreso nemmeno dopo la morte.
«Be’, sono morto,
Ma non voglio andar in Paradiso, voglio combatter’ ancora.
Voglio il tuo corpo, con che potrei ancora combattere…»
La greve mascheratura repubblichina dei due canti in presenza (il successivo è quello di
Cavalcanti e della «contadinella» innamorata, prima stuprata dai canadesi, poi morta da vera
kamikaze guidandoli sopra un campo di mine, fra Edmondo dei languori e “Paisà”, e si
presenta in cielo con due tedeschi a braccetto) non era fatta per assicurare una lettura, non
dico tollerante, almeno paziente, di questo Pound della X Mas. I due poemi, scritti di getto,
uscirono, rammento, su «Marina Repubblicana», nel gennaio e nel febbraio,
rispettivamente, del 1945. Si era proprio agli sgoccioli. Certo la distruzione del Tempio
Malatestiano, causata dalle bombe degli «alleati», non era fatta per tenere a bada quel
profeta di prateria, sedotto dal suo sogno neorinascimentale e tutto preso nella sua guerra
privata contro gli usurieri. Ma con Ezra è difficile prendere le misure col bilancino; e Dio
gli perdoni fosse solo per questo. Come scrisse di lui, anni dopo, un poeta dalle idee tanto
diverse, William Carlos Williams, eppure unito a lui nel saper porger l’orecchio alla musica
del deserto? Non dimentichiamocelo; hanno letto davvero tutti i libri (anche Marinetti, con
riserva e a modo suo) o li hanno consumati dentro di sé. Ma nella consapevolezza forte,
ripeto la parola, forse sconveniente, “profetica”, che il mondo dei libri, delle musiche, degli
oggetti d’arte, delle repubbliche d’utopia, è cenere di cenere, eco enorme e beffarda per un
rimpianto non risarcibile. Futurismo è anche questa coscienza.
Scrisse a e per Pound W. C. Williams (lo dico con la voce di Ariodante Marianni, che
dedica la versione delle poesie di Williams a un altro traduttore e ammiratore di Williams,
certo davvero al di sopra di ogni sospetto, Vittorio Sereni):
—
o fosse un Ebreo
o un Gallese
spero che ti diano il Premio Nobel
ti servirebbe bene
in perpetuo
con un tal nome
Se io fossi un cane
mi accuccerei su un freddo marciapiede
sotto la pioggia
ad aspettare un amico (così faresti tu)
se così mi piacesse
anche se fosse Gennaio o Zukofsky
Il tuo inglese
Non è abbastanza specifico
Come scrittore di poesie
Ti mostri inetto per non dire
Usuraio
Non sfugga la riserva sull’inglese poundiano; la stessa riserva pone Uncle Ezra, acutissimo
(e forse vive in questo un’eco di discorsi fatti col poeta confratello), sul canto di Marinetti :
In gergo rozzo (non a (h)antar ’oscano)
(Marinetti è, dai critici della buona razza melodiosa italiana, accusato di una lingua
inaccurata, provvisoria, scialba, e quasi un luogo comune della critica meno avversa è
diventato che, peraltro, in francese se la sarebbe cavata molto meglio, prova ne sia che molti
suoi poemi scritti di getto in francese transitarono in italiano per la penna servizievole di
Decio Cinti camerata in futurismo) e forse anche l’invito ad aggregare, pure da morto, ad
abitare, anzi, il corpo vivo di «hualche ziovinozz’ imbelle ed imbecille», per rinascere in
quelli e portarli in battaglia e «morir una seconda volta», potrebbe per inconsapevole
accumulo di giudizio scaricarsi sul passato, non bellico ma letterario, del fondatore del
futurismo italiano, anche allora insediatosi in quasi imbecilli ed imbelli per farne, nella sua
vampa, i «poeti futuristi». Quelli accertabili, «storici», eppure così làbili, così lèmuri, stretti
da lui a coorte (ahimè, anche questo è «italiano!») nelle storiche sortite pubbliche, teatrali e
piazzaiuole, e nelle almeno due celebri antologie da lui messe insieme. Ed è la seconda della
accuse portanti: galvanizzava i morti, per un istante solo.
Il giudizio di Pound è singolarmente equilibrato: eccesso d’amore per l’avvenire, in
Marinetti, controbilanciato dall’eccesso d’amore per il passato, nell’altro grande amico
italiano di Pound, Manlio Torquato Dazzi, originario di Parma, il traduttore del Mussato,
l’editore del Goldoni e, a suo tempo, di una antologia della lirica veneziana dal Due al
Novecento che vale una storia alternativa alla poesia e alla storia italiana. Ma a Marinetti è
dato giustificarsi, con argomenti di singolare forza apologetica:
In molto seguii vuota vanitade,
Spettacolo amai più che saggezza
Né conobbi i savi antichi e mai non lessi
Parola di Confucio né di Mencio.
Io cantai la guerra, tu hai voluta pace,
Orbi ambidue!
all’interno io mancai, tu all’odierno.
L’«odierno» — questa è la definizione vera di quello che fu il futurismo. Nel poemetto di
Vittorio Sereni sul Posto di vacanza (la poesia in sette parti che l’Autore non voleva
chiamata poemetto), alla stazione quinta è la comparsa (dantesca, poundiana) dell’ombra di
un poeta trapassato:
Viene uno, con modi e accenti di truppa da sbarco
mi si fa davanti avvolto nell’improbabile di chi,
stato a lungo in un luogo in un diverso tempo
e ripudiatolo, si riaffaccia per caso, per un’ora:
«Che ci fai ancora qui in questa bagnarola?»
è Vittorini:
«Elio! » riavvampo «Elio. Ma l’hai amato
anche tu questo posto se dicevi: una grande cucina,
o una grande sartoria bruegheliana…» Ci pensa un poco su:
«Una cucina, ho detto?» «Una cucina.»
«Con cuochi e fantesche? Bruegheliana?»
«Bruegheliana.»
«Ah, dice e anche sartoria? con gente che taglia e cuce?»
«Con gente che taglia e cuce…»
A questo punto, disfatto o soddisfatto, col suo tempo scaduto, il marinaio da sbarco Vittorini
fugge a tempesta. Uomo di guerra, non di pace, anche lui.
XV
RICORDO DI ARBASINO
Marescialle libertini e fratelli d’Italia il dì delle ceneri. Il nuovo libro di Arbasino potrebbe
recare una fascetta: Arbasino non è più nuovo. Non censura ma constatazione. Il suicidio di
Desideria alla fine del romanzo-manifesto del più straordinario accenditore di girandole
dell’ultimo mezzo secolo, in Italia, aveva del resto dichiarata la vocazione sepolcrale di
questo finto-attuale. Critici musicali teatrali del costume in Italia si fan venire il bruciaculo a
ogni volo di calabrone o se dicono: il nuovo, tanto lo ideologizzano che lo fan perder di
vista. Ammenoché non ci finiscano a letto fra coltri scomposte e al rimorso si diano veleno
come la Signora del Dottor Bovary. Lo videro Pasolini e il suo Bertolucci (Attilio, da non
confondere con un omonimo parmigiano ogni tanto ricordato nella patria del culatello): i
crepuscoli sono eterni. Così Fratelli d’Italia era tutto un volo altro che dannunziano! o
marinettista! da un aeroporto a una autostrada da un casello a un botteghino di teatro da un
cenone a un concerto di mezzogiorno e con una irripetuta capacità di far scintille anche solo
a nomarli di libri musiche città marche patronimici in fuga a rottadicollo e come riescon a
fare solo le cose che contano, incideva sulla normale percezione del tempo, sempre lìlì per
essere riperduto in graziadidio e sempre lìlì per essere a dispetto dei santi ritrovato. Sì lo si
sa: il catalogo delle navi l’idea del labirinto la liturgia bizantina il poema barocco l’eterno
Gluck il divino Schubert (un socrate coi suoi fratelli di Serapione nelle ‘buche’ viennesi) il
Parsifal la Recherche i Cantos l’Horcynus Orcaloca ma il vero fratelditalia del beato Alberto
da Voghera finì proprio con l’esser il venerabile Federico da Rimini e non a caso l’unico
episodio memorabile dell’unico film di Fellini insipido, Giulietta degli Spiriti - del resto
recuperabile ai modi dell’Albertino Sonnacchioso del Principe costante risposta a quello un
pochino distratto di Homburg e conferma del legame metadanubiano Calderon-Kleist,
Barocco-Restaurazione dilà da erudite babuaggini - era quello sùbito quasi iconico,
dell’apparizione di una giunca o galeone o praho o fusta di pirati, come in un Satyricon del
Postmodern. Ullallà vi pare che me la cavi? L’opposizione fin dal titolo dell’ultimo
Arbasino è dunque quella fra manierismo neoclassico o ritorno all’ordine puro (in sostanza
sempre liturgico-fabuloso-tranquillante) del Principe Igor (Stravinsky) e modernità
anticlassica (benché in apparenza sodisfatta, e fors’anche a parte subiecti, fino al sussiego e
allo strofinìo) di Strauss. Sempre Arbasino amò piroettare sul fildirasoio del Canone e
giudizio diverso sarà su lui dato da chi sospetti che aldisotto ci stia la rete o trasecoli per
disotto l’abisso, Lui starebbe volentieri dalla parte infetta di Strauss ma si sente da ultimo
strawinskiano (cioè novecento) e ne soffre. Il Corsaro Nero piange.
Ricordate Il ruggito del topo? Un gruppetto di lillipuziani s’insinua nei gangli
della maggiore potenza del mondo e la riduce all’impotenza. Non me ne voglia l’amico
mascagnista Cesare Orselli se per il suo bell’invito a Strauss per le palermitane edizioni de
L’Epos mi accade di pensare, a paragone col sommo Arbasino, a quel vecchio film. Tutti
siam topogigi quando l’Albertone Lombardo scrive una riga di prosa. Orselli non discute il
canone, con toscana avarizia ha in dispetto i Massimi Sistemi, mette avanti un libro che con
arguzia truffaldina - peggio per chi ci casca - finge di voler essere un prontuario, un
avviamento a, un manuale. Manualisti si nasce: noi si doventa òmini. Senza alcun
terrorismo Orselli c’imbarca in un tragitto che sarà senza rischi forse, ma al termine della
crocera, quando uno si riaccorge di averci sottopiede la terraferma, si asciuga il sudore con
un fazzoletto e si accorge di avere toccato tutti i porti di un itinerario che, in realtà, richiede
un pilota perito e rassicurante. Allora il lettore si volge al Capitano con un sorriso di
complice grazie, abbiamo capito e mentre si sfioravano scille e cariddi o sargassi e terre
incognite tu ci illudevi che fosse senza risico. Perché il rischio, a dirla tutta, è Strauss. Non
puoi godertelo come una cassata alla siciliana, cui pure si apparenta per arabesca dovizia e
delizia, non puoi scansarlo come un guastafeste di carte nautiche ormai tutte sdate. Orselli
conosce tutte le guide e al Secondo Riccardo Mùsico (dopo Riccardo I Wagner) ne son
toccate di eccellenti, anche qui il vecchio Cimbro (1926) per i poemi sinfonici, e poi Levi
dalla sua Trieste e da ultimo le corazzate Magris Principe Serpa Bortolotto avino avolio
otone e berlingieri. Fuori, l’estrosa preferenza di Glenn Gould per Capriccio. Ma qui da noi
Strauss a conti fatti resta sospetto. Il tiro piazzato di Orselli lo lascia meritamente sulfureo
(l’alternativa è darlo per un idiota): Richard Strauss Vive, è migliore , anche meno retrivo di
Johann (sai la barzelletta che un tempo si scambiavano i conoscitori). Arrangiatevi.
XVI
SOLITUDINE DELL'ITALIANO*
Mi son dovuto arrendere. Mai uno mi scrisse o mandò un libro, un disegnotto, un pamphlet
(pronuncia universitaria: pàmplet!) che io non lo ringraziassi a giro di posta. A volte
accennavo un giudizio, con letizia donavo una lode o movevo una riserva. Talora mal me ne
incolse; il lodato, se poeta, si ritiene adottato per la vita. Il discusso si inàlbera. Uno il cui
nome si ràdica in quelle che in francese sono le nàtiche, come il famigerato prefetto di
Parigi che aveva in odio i surrealisti, mi scrisse minaccioso: vedrà chi sono io. Ma son
passati venti anni e chi l'ha più visto. A volte uno mi scriveva: temo che lei non mi leggerà
per pregiudizio ideologico, mettiamo perché sono un cattolico, un fascista. Quasi ogni volta
seppi umanamente sconfessarlo. Io divido il mondo fra chi parla (cerca di parlare) e chi
chiacchiera a retrocarica. Mi son dovuto arrendere. Come i venditori di libri "attraverso i
servizii postali", i poeti si passano gli indirizzi e da ultimo, risolvendomi all'unico Pirandello
che conoscono e citano gli ignoranti (quasi tutti finiti ad insegnarlo all'università), "la vita o
si vive o si scrive", mi sono arreso. Non rispondo più. Come il camerata Baldacci scomparso
nei cieli d'Albania, il poeta di: "chi alla gloria ci conduce? - Il Duce", in realtà nascostosi in
soffitta donde gli tocca ascoltare che la camicia nera Tognazzi, suo adoratore in quei versi,
gli santifica la moglie (è il celebre film Il federale, qualcuno ancora è in grado di
riconoscerlo), spero di salvarmi la moglie ma anch'io mi son chiuso in soffitta; e ogni tanto
tiro fuori il lampo degli occhiali, magari per questi pezzulli che Stilos mi onora di
accogliere.
Fogli d'Hypnos, taccuini di caro m'è il sonno, come quelli fulgenti di René
Char, di uno che non potrebbe a Char nemmeno allacciargli le stringhe. Ma tant'è. Questo
esordio per dire che ai bei tempi solo a un dono d'incogniti a lungo non risposi, con qualche
mala coscienza, ed era un foglio di una associazione culturale anarchica non sovversiva che
veniva dal Meridione e si chiama, si chiama ancora, I Medicanti. Animatore e forse unico
membro, come Satie delle sue società misteriosofiche tra lo scherzo e la follia, ne è Luigi
Bianco, uno che buttò davvero alle ortiche la gabbanella del giornalista avviato per darsi a
una protesta, perlopiù affidata a mezzi non letterarii, happenings e altre carnascialerie, nel
più profondo e misterioso sud. Vox clamantis in deserto, nell'evitare di rispondere mi
autodenunciavo: anch'io sono, mi illudo di essere, tendenzialmente anarchico (l'anarchico in
fondo è l'unico rimasto a credere nell'autorità, alla quale chiede semplicemente e
impositivamente di essere all'altezza del grado), ma credo essere un anarchico di destra, da
Nietzsche a Sam Peckinpah ("The Wild Bunch") e invece in Bianco intravedevo un
anarchico di sinistra, dunque a fondo cristiano, religioso, e mi sarò sbagliato ma la vela del
discorso cadeva. Mi sentivo parallelo. Poi, tramite Adriano Accattino e la effimera
esperienza del foglio volante "Il Martello", cui collaborai, e di cui Bianco era co-direttore, le
parallele, aldomorescamente, un poco conversero eppure resta in me e in lui Bianco un
disagio. Non me ne dò vanto. C'è sempre quella parabola del ricco che chiede a Gesù cosa
deve fare per seguirlo ma quando Gesù gli dice rinuncia alla tua ricchezza quello ci ripensa.
E io, che ho uno stipendio all'università, sono purtroppo il ricco, rispetto a Bianco che al suo
stipendio di giornalista promettente rinunziò. Ora, viriamo di colpo, come il lettore da me
sempre s'aspetta e teme. L'editrice La Finestra di Lavis, abituata a prendere di sorpresa il
lettore (da Cecco d'Ascoli a Silvio Benco i libri nel suo catalogo), ha appena ripubblicato un
mitico e sconosciuto libretto, Il Trentino visto da un socialista, di un Benito Mussolini
prefascista (1911, fra i "Quaderni della Voce"). A Trento il giovane Mussolini era andato a
dirigere "L'avvenire del lavoratore". Ricordiamo che si era in terra d'Austria. In quel libretto
si capisce una cosa: che allora un paese si conosceva camminandovi non solo idealmente
attraverso. Vorrei raccomandare al lettore la scoperta (a scuola certo non glie ne avranno
parlato) degli scritti geografici di Cesare Battisti. Era ancora la terra dello spazio.
La splendida prefazione alla ristampa mussoliniana è firmata da Franco
Cardini, una delle voci rare della nostra cultura ufficiale. Le nostre adolescenze si
intrecciarono, facemmo addirittura un giornalino scolastico che si chiamava "La Balestra".
Cattolico e militante nella gioventù di destra, l'ammirevole Franco era avanti a me, sui
sedicianni, anni-luce. Aveva sùbito riconosciuto i suoi interessi, i suoi fantasmi. La cultura,
come l'eros, è fantasia, sennò solo una indigestione di fogli e una ripetizione balorda di atti
banali. Ci ritrovavamo sul terreno, italianissimo! (e nazionalpopolare, non melochécchico
come alla Scala e alla radio) della passione per la lirica; indimenticabile un nostro non
programmato incontro sulle gradinate dell'antico Politeama di Firenze per una rara e
portentosa ripresa della Gioconda di Ponchielli. Infettammo di lirica passione tutta una
classe di condiscepoli. Cardini, nella prefazione, tocca molte corde, come un citarista di
genio, e fra l'altro rievoca la figura del suo Maestro universitario, il medievista Ernesto
Sestan, anch'esso nato (e coscritto, quando la guerra fu) sotto l'amparo dell'aquila di Cecco
Beppe. Seguii anch'io le lezioni di Sestan, io ero uno studente sbalordito, entusiasta e
somaro, e poco appresi da un corso che frequentavo per obbligo, ma vi conobbi i libri di
Marc Bloch, come frequentando Storia romana con Pugliese Carratelli lessi il divino
Rostovzeff, e presso Cantimori fui introdotto agli eretici cinquecenteschi. Gente come
Bernardino Ochino, alieni, perseguitati, sia dai cattolici romani sia dai protestanti tedeschi.
Si andava disegnando una mia figura ideale, alla quale uniformarmi o soccombere. Sestan,
all'esame, mi chiese come mai con gli Ottoni l'impero fosse andato a ramengo, mentre dopo
Carlo il Grande aveva tenuto: io esitavo, lui (aveva occhi limpidissimi) caro giovanotto, mi
disse, Carlo sapeva educare i figliuoli con mano di ferro.
Si era prima del Sessantotto almeno cinque anni, che Sestan fosse come il
caloprese abate gioachino "di spirito profetico dotato"? In una sua lettera ultima, bellissima
— Cardini è l'ultimo uomo che abbia qualche fama sulla terra, a saper scrivere una lettera
bella — l'antico compagno di banco mi dice della sua solitudine in questa finis Italiae. Di
Mussolini parla, soprattutto, con una profonda forma di pietas, che non gli viene certo dalle
sue origini "di destra". Lui, come me, siamo da un tempo estranei a queste geometrie
d'imbroglio. Ora ritorno a Bianco. Mi ha fatto avere un suo compact di rumori e di parole,
poesie, barbagli, luminarie, fosfeni, balbettii, che lui si strappa come dalla milza. Ne ebbi
uno simile circa un anno fa e si intitola "la voce sgradevole", sottotitolo "sconnessioni
sociali-amodali-sonore". Mi seduce stranamente che si dica "registrato in presa diretta
presso la sevesinop di squillace". Dove in via San Matteo 23 hanno sede I Medicanti. Io
credo che così leggesse i suoi versi Dino Campana, che una serie di disgraziati film
sentimentali ha messo a disposizione dei lettori come un caso da collezione Harmony. No!
di Campana non si dà filologia; nel quindicennio trascorso l'università ci si mise di buzzo e
fallì. Nemmeno però si deve darne un romanzo coi buoni e i cattivi. Scrissi la prima volta a
Bianco perché lo vidi maramaldescamente assalito senza possibilità di replica dal potente
Vassalli su un quotidiano del nord. Vassalli aveva scritto un fortunato libro su Campana e
non si avvedeva più che lui si comportava con Bianco come Soffici, da lui denunciato con
enfasi quasi calunniosa, si era comportato col mendicante-medicante Campana. Un altro che
camminava sempre. Nei Canti orfici come nel Parsifal il tempo si fa spazio. Cardini mi
scrive che Mussolini era un uomo dell'Ottocento; certo, come noialtri siamo uomini del
Novecento e già ce ne avvediamo a scuola, chi di noi fa l'insegnante, di parlare una lingua
sdata. Non ci si incontra più in alcun referente comune. Nenni, per dire, o Fellini, Verdi o
Picasso sono ormai degli sconosciuti. Che sia stata qui la deriva del Mussolini anarchico in
Mussolini interventista, marciasuroma, fassista? Intanto una cosa: l'uomo italiano è
impastato di balbuzie e di solitudine. Per gli altri, ed agli altri, il potere. E Mussolini ne ebbe
fino al vomito. Leggessimo la sua storia come un suicidio?
XVII
SICILIA
Sicilia Sardegna Corsica: le tre isole italiane. Mare nostrum! Dovrò chieder ai miei colleghi
di storia della pedagogia se qualcuno si è dato mai la briga di studiare quello che
c’insegnavano nelle prime scuole della Repubblica. Le prime pagine dei vecchi sussidiarî
messi fuori uso da Piazzale Loreto erano state frettolosamente ritoccate, per le ristampe; ma
all’interno potevi trovare che gli Unni di Attila erano stati vinti dai Romani (questo
contraddiceva il prete che all’ora di catechismo esaltava con tanta brezza papa Leone che
tragitta il Tebro e lo convince, l’Attila!, a ritornare indietro, Raffaello e Giuseppe Verdi
faventibus senza che il prete né noi mocciosetti allora neanche potessimo sospettare
l’esistenza accaduta di sì illustri garanti) e che le Paludi Pontine erano state bonificate per
gl’immarcescibili comandi del Duce. Avessero avuto il cercatrova dei computer d’oggi!
Oggi la vita dei bugiardi è facile. Anche allora lo era ma non sarà un caso che il libro dove
stranamente s’incontravano i favori degli educatori e di noi marmocchietti era Pinocchio,
col suo naso a stantuffo. Tutto tutto la vita scancella. Se Carlo Lorenzini avesse avuto
ragione, oggi c’è in giro un premier che dovrebbe portarsi dietro un galoppino con un
seghetto che gli accorciasse la proboscide ogni volta che dev’entrare in un ascensore. Ma
Carlo Lorenzini era anche lui un bugiardo tanto vero che si era cambiato perfino il nome da
sembrare un giardino rococò, con scherzi di puttane-fontane fra le aiuole e le alèe tutte
fiorite, lì a du’ passi dalla casa ov’era nato. Il mio incontro con la Sicilia avvenne ancora sui
banchi di scuola, ma qualche anno dopo e mentre ormai era certa almeno una cosa: che la
mia fame di libri non l’avrebbe riempita la scuola (anzi sembrava messa lì per distrarci e
deludere, quando io avevo con me un solo bene, omnia mea: il tempo che non si deve mai
perdere) e che io avrei fatto lo scrittore. Battevo e ribattevo frontespizî e valorosi incipit di
romanzo sulla vecchia tartaruga a nastro rosso e blù. Fu una strana ventura fatta della
coincidenza fra un libro di scuola e una strana insegnante: ero arrivato in prima media dopo
molti patèmi per quello che allora era il cosiddetto esame di ammissione (mai altri la vita
me ne apprestò poi di più difficili e intimamente ontosi, come una dogana di classe) e fra i
libri, tutti brutti, da comprare (andavano le prime due mattine prima che solennemente la
lista fosse finita di dettare) ne spiccava uno, l’antologia di letture, che l’anno dopo fu
frettolosamente soppressa e sostituita con una di quelle che avrebbero dominato le mezze
scuole degli anni 50. Quale disguido aveva portato sui nostri banchi quella intrusa? L’altra
intrusa era la professoressa. Era una siciliana, una piccinina biondo-stopposa, con una
pronuncia non meridionale ma appena preziosamente artefatta, e di età incerta, a me pareva
già vecchia e magari non avrà avuto trentacinquanni. È stata l’unica insegnante da me
conosciuta che privilegiasse il fuoco della espressione alla minestra ricucinata della
grammatica. Va da sé che le colleghe-kapò la tenevano in gran dispitto, l’anno dopo
scomparve, la classe fu soppressa e sparpagliata nelle altre sezioni, l’antologia l’ho detto,
abolita, e io ripetei l’anno per protesta. Io nacqui allora, con rabbia, e posso dire d’essere
l’unico professore ripetente (o, protestante) delle scuole del regno… oddio, della repubblica.
Io penso che l’autore fosse anche lui siciliano, chissà, magari il maestro della mia maestra
(che, seppi dipoi, era di razza povera, veniva dal Magistero anziché dai licei della razza
padrona, in cui poi invece io mi incuneai), ma non posso accertarmene perché il libro sarà in
qualche cassapanca della mia casa d’infanzia; può darsi si chiamasse D’Auria, un nome
così. Lei aveva un nome bellissimo, Dell’Aria: in quelle aule sorde e grigie (o diacce e
scalcinate, repellenti come la broda che ci toccava d’ingurgitare pena scuriate) l’aria
mancava. La caratteristica di quel mitico, unico libro di scuola, privo di vezzi in una sua
stampa fittafitta su carta da svendita, era che gli autori non italiani pareggiavano se non
prevalevano (allora non ero in grado di avvedermene) su quelli italiani, scolastici, e dunque
io, che tranne il libro di matematica tutti li altri li leggevo dalla prima all’ultima pagina e
arrivato all’ultima ripigliavo con moto retrogrado o cancrizans, mi imbattei lì in Schiller in
Storm in Wilde in Fontane in Crane in Hofmannsthal, sarà stato mica un tantino
germanofilo oltrecché esterofilo, l’antologista? Di quella germanofilìa che permea le
succolente antologie di narratori e poeti e teatranti ispanici o germanici o slavi o statunitensi
promosse negli anni di guerra da Vittorini, siciliano a Milano e meno antifascista di quello
che si preparava poi ad essere (davvero, come dixit il Gattopardo: “tutto deve cambiare
perché tutto rimanga quello di prima”), per la collana Pantheon di Bompiani (la più
rammentata fra esse, Americana). Certo non c’era De Amicis e non c’era Angiolosilvio
Novaro, o magari anche c’erano ma era un’aria tutta diversa. Degli italiani ricordo però
Fogazzaro (Eden Anto), Albertazzi (“il pesciolino galleggiava, morto”), De Marchi (il finale
del Demetrio Pianelli), Bacchelli (il finale del Mulino del Po) e un bel po’ di d’Annunzio
(le glorie garibaldine della Roma del Quarantanove, cantate nei versi di marcia di Elettra).
M’innamorai lì delle poesie di uno che a scuola non è mai stato da alcuno caldeggiato, il
lirico Villaroel catanese (piacque a Francesco Flora) e dunque mi chiedo: l’antologista sarà
stato un fascista rispolverato, un dannunziano dell’alalà? Boh. Se fascismo è chiusura, lì
dentro era aria d’Europa. Lo so, magari l’Europa unita vagheggiata da Baffo Buco sotto le
croci uncinate. La prima volta ne sentii parlare da Marlon Brando ufficiale nazista
affascinante e utopico in quel film dei Giovani leoni. Mi s’erano ormai spalancate le porte
del liceo. In quell’aria non italiota io (che avevo già stupito la cara maestra col dirmi a
undicianni ammiratore di Pirandello, del quale avevo divorato fra un Sàlgari e un Sabatini
un volume spaiato delle Maschere nude, rimanendo stupefatto della sterminata lunghezza ed
esattezza delle didascalìe) m’imbattei per la prima volta in un esordio incantato che mi è
dolce ripetere:
“Il viandante che andava lungo il Biviere di Lentini, steso là come un pezzo di mare morto,
e le stoppie riarse della Piana di Catania, e gli aranci sempre verdi di Francofonte, e i
sugheri grigi di Resecone, e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, se domandava,
per ingannare la noia della lunga strada polverosa, sotto il cielo fosco dal caldo, nell’ora in
cui i campanelli della lettiga suonano tristamente nell’immensa campagna, e i muli lasciano
ciondolare il capo e la coda, e il lettighiere canta la sua canzone malinconica per non
lasciarsi vincere dal sonno della malaria: - Quel di chi è? . sentiva rispondersi: - Di
Mazzarò. …. E cammina e cammina….”
Strano non me ne sia accorto quando un caso non da me previsto né cercato (esiste una
provvidenza anche in letteratura?) mi vide antologista e postillatore (agli esordî diffidente e,
peggio ancora, disappetente, per come il piatto ormai, a libro chiuso, ufficialmente si
presentava) del Verga. Quest’appena riletta è come una diana (Verga diolobenedica non
amava teorizzare) che sostituisce il Manzoni (“Quel ramo del lago di gadda…”) con la
giusta cosalità del fatto compiuto. Il fatto compiuto è la pagina che fra duemila anni potrà
rappresentare che cosa fosse l’arte dello scrivere in una terra distrutta, forse in gran parte
inventata che chiamavano Italia. E il ricordo di quelle strade lunghe bianche polverose che
non ha conosciuto, forse nemmeno in Sicilia?, chi è nato dopo il Sessanta. A piedi anche
nudi ci andavo, nella Toscana di dopo-la-guerra (dunque un incrocio d’immagini, una
sovrimpressione viscerale). Da quelle parti era andato in scarpe di vacchetta il babbo di
Pinocchio, in stivaloni da padule il Fucini, sui cuscini delle prime automobili-salotto, con
autista innestato, il Puccini, il Mascagni. Gl’ideologi, marxistucci miei immaginarî hanno
avuto facile gioco nel ripetere fino alla stufaggine che la Cavalleria rusticana del Verga non
è la Cavalleria rusticana del Mascagni. Ideologi e manualisti sono sordi sennò si sarebbero
accorti che nella finta Sicilia di Mascagni v’è sì del ponchiellismo ma anche una premurosa
auscultazione del Parsifal; Santuzza è accompagnata come un carro d’uva dalle api, dal
tema di Kundry. E il sinfonismo un poco da sagra del Sor Pietro è aggiornato su Brahms,
poi anche su Rimskij, su Strauss. Così Verga leggeva con antenne vibranti Flaubert (anche
quello cartaginese di Salammbô), Balzac Mérimée il temuto Zola e aveva fra i suoi libri le
novelle californiane di Bret Harte da cui a suo tempo la Fanciulla del West di altri due
toscani, Puccini e Guelfo Civinini, con la mediazione del Pascoli, tosco-romagnolo ma
passato come insegnante di grammatica latina dalla Sicilia. Quante lacrime di coccodrillo
della piccola borghesia dei lettori piagnoni a-non-pagar-dazio, su quelle ostriche dei
Malavoglia. Verga, il dì che si imbarca pe’l Continente, lo fa con un biglietto di sola andata.
Ostrica addio, ostrega; o strega. I Malavoglia sono un puro referto (e acustico più che
visivo) come l’Anabasi o come l’Après midi. Il Fauno Verga adotta Milano (che non lo
adotta) come una Cima delle Nobil Donne. Zac!
Sicilia ossia Europa… I vecchi (senza accorgermene, lo sono diventato) amano ricordare.
Non così vecchio però che non mi soccorra uno sfaglio, una qualche favilla non moribonda.
Si ricorda quel film col maresciallo che mette la palmaperta sulla carta d’Italia coprendo con
quella l’isola triangolare: sogno d’una Italia liberata. Ma chi ce li aveva chiamati mi dico.
Da bambino sentivo i giornali-radio con le notizie sul Bandito Giuliano. Percepivo d’intorno
l’angoscia della famigliuola sbigottita, come se il Brigante potesse comparire d’un tratto
sulla porta di bottega, in vista della foscoliana Bellosguardo; anche più percepivo la
menzogna nelle parole dei trasmettitori. Nei bambini ci dev’essere una prontezza atavica, va
perduta con l’educazione, a riconoscere le parole bugiarde come una saliva cattiva. No non
stavo col Bandito a quel modo che l’altra eroina verghiana, l’Amante di Gramigna,
s’innamora a sentirne parlare del Solitario, dell’Agnello di Dio. Gramigna è Cristo e la sua
donna una figura della Maddalena. Sentivo però che non la contavano giusta. Non ho amato
molto (sa il lettore fui sempre disarmonico) il film di Francesco Rosi sul Bandito Giuliano;
Rosi è di Napoli e quando mi dissero dell’estraneità reciproca e forte fra i due tronconi delle
antiche Due Sicilie, io dissi solo: mi pareva bene. Invece è fra i miei film prediletti Il
Siciliano di Cimino, che riinventa la storia nella verità del melodramma. La figura del
Principe Siciliano rapito dai briganti che li segue con intimo distacco a dorso di muletto e
coll’ombrello da sole tenuto in alto come una bandiera a me pare di quelle sublimi. Ma
sentendo quella ruggine di menzogna degli speakers democristiani, una volta entrai glorioso
nella botteguccia di mio padre, rara di clienti e ahimè fitta dall’alba al tramonto di quei
penitenti che si fanno chiamare ‘rappresentanti’ e stanno giorninteri a scroccarti le sigarette
e ad accoccarti delle fregature con facce di Jago; e dissi lo sapete? Hanno preso Giuliano.
Eh che chi come. Mi godetti il quadro, come Giamburrasca.
All’opposto del carabiniere ‘all’italiana’ io pongo la palma spalancata sullo stivale e sogno
la Trinacria che si stacca. La mitica Ortigia staziona da molte vite all’imbocco del porto di
Siracusa, ma fu un tempo (un pre-tempo) isola vagante pel mare. Scilli t’invoco, Cariddi mi
raccomando. Quando arriveranno le ruspe e i pontili per buttare autostrade aldilà dello
Stretto, fate vedere le zanne, siate Orcini e rifatevi Nèmesi. Ricordatevi Esiodo e la Bibbia,
la Torre di Babele e il Nocchilìa, E quando il gran polverone sarà salito alle nuvole,
vedranno al posto di Sicilia una gran macchia di spuma. E l’Isola sarà tornata, apollinea,
notturna, di mare in mare, con tutte le sue candele accese, con tutte le sue torri alluminate:
Gelone Gerone Dionisio i Kalbiti l’emiro Benavert Ruggero Federico Alfonso il
Magnanimo, Antonello Antonio Veneziano il viceré Caracciolo il Meli lo Scinà, Vincenzo
Bellini Giovanni Verga il gran Capuana De Roberto però nato a Napoli Borgese Lucio
Piccolo Pippo Di Stefano. Poi Ripellino Pes Sciarrino La Licata (non solo fari d’antan). E
Giovanni Gentile.
XVIII
MEDITERRANEA
L’esplosione, “esploda ed echeggi” (per Gadda, Contini) sendo mai impossibile nelle
lettere, mentre nelle esplosioni quotidiane implode l’Occidente e un passo per volta
l’Oriente dal Medio all’Asia Centrale (“nelle steppe...”) al rifatto minàce Catai; parlerei di
implosione ossia di rimessa in giusta postura d’uso del Museo – istituzione nobile e
necessaria – per la lunga e non retorica fedeltà di Antonio Pane ai suoi scrittori glorie di
Sicilia: ora la sorpresa di una Sinfonia 1923 di Pizzuto in coppia discorde e concorde con
L’erede del beato del sempre fra i sospesi Angelo Fiore eterno supplente. Editi da Mesogea
messinese, una di quelle piccole case editrici che suppliscono al managerialismo segaiolo
delle ex-grandi. E vedi il fallimento delle “globali” o vestali della Classica. Lo stesso
avviene nei partiti, del resto, e la partita è tutta da riaprire. Credo per chiudere la prima
questione che a Pizzuto abbia fatto del male Contini coi suoi settatori più balbi, come a
Fiore l’onesto Pampaloni; la critica non è il salotto delle contesse maffei. Ma voglio dire di
Mesogea, che ora anche lancia (dopo il numero 0) la sua rivista di bandiera, col medesimo
nome, e contiene una cosa mirabile, la traduzione della ristampa integrale della rivista
“Rivages”(Algeri, “Rivista di Cultura Mediterranea”, due soli numeri a cavallo del 1938 e
39, ispiratore Camus, e il suo maestro Jean Grenier col mitico Isole 1933, qualcosa che vale
a quel disegno più come un Montale, da noi – del resto presente, con la suite Mediterraneo,
nella breve rivista, tradotto a fronte da Filippo Donini in una versione più vicina a quella
meno neoclassica dei primi Ossi). Spina dorsale di Mesogea un patto mediterraneo con la
migliore scuola storico-geografica francese (là i Braudel, qua i Dionisotti e i Bobbio, razza
piemontese rapace e burocratica, incapace di progettazione; del primo mi fu sempre sospetta
l’indignazione antipartenopea, esiste il mare, signori, come la vostra roccia, e la “terra del
fuoco” non ha motivi se non accademici di inferiorità, semmai di utile e rappresentativa
differenza, dai vostri indigeribili “giornali storici” indicizzati) donde la riproposta italiana
dei dieci volumetti Rappresentare il Mediterraneo ideati da Thierry Fabre per la Maison
méditerranéenne des sciences de l’homme. Lo sguardo italiano, lo sguardo tedesco, lo
sguardo spagnuolo, quello francese, libanese, turco... su uno spazio simbolico. “un luogo
sovraccarico di rappresentazioni”, rivissuto da uno scrittore (per gli Italiani, Consolo, la sua
Sicilia accesa come un’Arabia o le valve della vulva-melone) e da un non letterato. Meglio
chiarisce gli intenti della intrapresa un saggio sulla rivista di un giovane docente napoletano
in Pedagogia della formazione, Stefano Oliverio, su uno psicodramma-chiave della cultura
postbellica quale lo scontro fra Sartre il grande Inquisitore e Albert Camus. La chiave? Un
uso umano (l’uomo nasce libero e questa sarà la sua croce) invece che ideologico della
memoria della resistenza. Bastò la Maiuscola a fare fuori i resistenti veri. Avemmo padri
nobili, a un punto della vita parvero nonni, non per vecchiezza loro ma dei referenti cui
voleano tenerci incollati, da Leopardi a Mussolini da Manzoni a Benedetto Croce, e facevan
rinascere l’”uomo italiano” - con De Sanctis ministro dell’accordo fra chi lo aveva fatto il
Risorgimento e chi mai l’avrebbe digerito - col braghettbozzo Parini in giuggiolio di dolci
inganni da sedare con dolce fustigazione. Signorino giù le calze e senti qui. Arbasino? I
padri ignobili, allora, gli zioni o cugini anziani; la generazione del Trenta. Son finiti col
laticlavio o alla Adelphi e son cose che si pagano. Ogni tanto un sobbalzo, nasce la
generazione dei fratelli? Nasciamo tardi lo so. Mancò l’ingegno e l’impegno, mancarono
anche i mezzi. Qualche carica di cavalleria polacca contro i carri armati, qualche
tienammente. Alle origini di Mesogea c’era Nino Recupero, professore alla Statale di
Milano, nato a Catania nel 1940, mio coetaneo stretto. Goccia diaccia: morto due anni fa.
Richiamano digià anche le nostre classi. Forse il nostro compito era una paziente
ridistribuzione dei pesi e delle misure. Che il Patto Atlantico, ad esempio, vada spostato su
un Patto (del) Pacifico e su un Patto Mediterraneo? Fra le linee portanti della magion
messinese vedo Franco Cassano col suo “pensiero mediterraneo”. Qui c’è speranza: i
neonazisti della lega si riconoscono nei cantoni svizzeri e loro giusto contrappasso è che sia
loro un supplizio di Tantalo. Ci toccherà tenerceli. Mi viene in mente la lettera di Camus “a
un amico tedesco”: ho combattuto, costretto, con la spada e lo spirito voi credenti soltanto
nella spada. Ma non ho odiato mai l’uomo che è in voi anche nel suo errore. Camus si
ammazzò con l’automobile, come il Cable Hogue della ballata di Sam Peckinpah. Feci a
tempo a concludere nel ricordo di quella perdita il mio tema della maturità ed ebbi un dieci.
Non ne avevo ancora letta una riga.
XIX
PRO ARCHIA (O PRO DOMO MEA)
Fresche le uova. Sarà già barocco? Ogni tanto qualcuno risolleva la questione dello scrivere
scrio scrio e papale papale. Parla come mangi di solito viene a ruota sicuro come la panza
sciolta dopo una indigestione di carrube. Ahi! le carrube saranno indigeste? Io non ne dubito
anche se non se ne è mai mangiate (e: saranno commestibili?) Diciamolo papy-papy: io non
so com’è fatta una carubba (non so nemmeno come sia fatto un babirussa). Ma pria lettore
che letterato, la trovo sul Verga, mi faccio una idea che sieno una specie dei cactus di quella
waste land che è la terra del Mago della Pioggia (ahi, Arbasino) e le trovo incommestibili
perché le trovo nel Verga. Non sarà lesa patria. Né lesa la Sicilia cui non feci mancare mai
durando la mia vita attestati di fedeltà. Proprio su stilos letto stamani mi è brillato il cuore a
legger la freccia del Parto (e: del parto) di Vanni Ronsisvalle in chiusa del suo pezzullo
verghiano: “a lungo mi si trattenne nelle narici quell’odore di cucina al quartiere Prati”.
Bene, Arbasino e Ronsisvalle sono i pinnacoli della buona critica sul Verga. Agli altri
basterà il guazzetto (oggi si dice ragù) di buoni sentimenti, di vento di terre lontane (ouuero,
la porti un bacione a Aci Trezza) e di refettorio. Madri mediterranee in lutto stretto. Parla
come ti ha insegnato la mamma, diomio ma se la mamma poi è analfabeta? o sordomuta? E
segue la questione dell’uso della lingua italiana. Io a volte mi chiedo dove viva questa
gente. La lingua italiana è una specie di araba fenice che veniva scritta apposta “sibi et
paucis”, arcades trimbo (& trumbo). Il calunniato latinorum era al confronto un trionfo della
democrazia. Anche nel caso da esposizione della lettera qui al Bon., viene poi fuori la
faccenda dell’operatore culturale (non sarà quello che, uso Cinemaparadiso, proietta le
filme d’essai, pardon, le pellicole-saggio, insomma i mattoni, che a Firenze ad esempio
chiamano con arguzia un bel lavoro, un filmone, o quello che disacerba un premionobel
delle emorroidi?) e del giornale come carta igienica (pardon, voglio dire neutra) di una
comunicazione per direttissima. Io trovo molto più difficile intendere che cosa sia davvero
questa operazione culturale che non papy papy mettiamo la diffrazione fra high brow e low
brow dove l’inglese non è solo tirchio ma anche icastico come una caricatura. Qui non
c’entra il barocco. Nessuno scriverebbe sui giornali, nessuno si prenderebbe la briga di
mandare avanti cinquanta inserti culturali all’anno se il lettore immaginario fosse davvero
quel pupattolo che ci si vuol dipignere. Il pupattolo si ferma alla pagina sportiva e qui il
gergo o l’esotico è insieme gusto e strumento: football, corner, goal, il mister… solo arbitro
cornuto è interamente nostrano. E si sa che c’è stato almeno un Arbasino della cronaca
sportiva e si chiamava Gianni Brera. Potrei metterla dura partendo dalla secolare diatriba fra
stile alessandrino e stile classico, ma poi col volger dei secoli anche lo stile alessandrino
entrò a far parte del mondo dei classici con la scusa che in classe si leggevano e gli uni e gli
altri. Qui, si sa, si videro cascare molti innocenti dalle nuvole: càpita che Callimaco barocco
sia meno ostico dell’attico Sofocle o del collodesco Omero. Che tradimento è mai questo.
Una cosa caratteristica di chi se la prende con chi scrive difficile da costringerlo ad aprire il
vocabolario è che di solito, data la stura, poi scroscia giù una catadupa di altri indigeriti
bocconi: qui, ad esempio, le “nostre democrazie”, che parrebbero un bel volo pindarico se
non si fosse lesti (io sono lesto, ancorché volentieri ricorra a quanti vocabolarî mi si prestino
e, vedi caso di malformazione, senta una specie di grato trasporto a chi mi induce a farlo, e
fin qui mi dicevo: sotto la scudo di Democrazia mi salvo la libertas di anchora inparare
quando nemmeno un pelo ho che non sia fatto bianco) a registrare la sindrome. La colpa
della “nostra” democrazia è quella di “permettere”quell’abuso di libertà che fa scrivere a un
Bon. quattro righe di séguito inzeppate di parole rare o difficili o stravaganti o inventate
cioè di portare in tavola una pizza che brilla di occhi di zenzero e fettine di avocado e chiodi
di papavero e rallegra l’intera tavolata (davvero parleranno come mangiano? Ma allora
minestrine da gastròpati, gavettoni da campeggio) o esibirsi in un balletto verbale che
chiede la più innocua e affettuosa delle complicità: aver voglia di far quattro salti insieme.
Ma le maestre, cupe, hanno in mente soltanto la lingua che non brilla e che non dona: vai a
posto, ti metto un quattro e torna accompagnato dai genitori. Fin qui si scherza ma si
scherza col fuoco. In una cupa cittadina padana dove di me fur spesi i migliori anni, scrissi a
lungo sulla locale gazzetta. Mi fermavano per la strada per dirmi che non si capiva. Il fatto è
che capivano tanto bene che una volta che gli spiegai sopra le stesse pagine la cabala, quella
gazzetta mi si chiuse per sempre.
Marzio Pieri
Scaricare