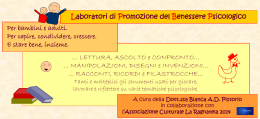Mark Rowlands
IL LUPO E IL FILOSOFO
Lezioni di vita dalla natura selvaggia
The Philosopher and the Wolf:
Lessons from the Wild on Love, Death and Happiness, 2008
“Credo di aver capito perché ho amato Brenin così tanto e perché sento
così dolorosamente la sua mancanza, adesso che non c’ è più.
Lui mi ha insegnato una cosa che non avrei mai imparato con i mezzi
dell’ istruzione ufficiale, cioè che in una qualche antica parte della mia
anima viveva ancora un lupo”.
Mark Rowlands, giovane e inquieto docente di filosofia in un'università
americana, legge per caso su un giornale una singolare inserzione, si
incuriosisce e risponde. Qualche ora dopo è il padrone felice di un cucciolo
di lupo, a cui dà nome Brenin ("re" in gallese antico). Per undici anni, sarà
lui la presenza più importante nella vita del professore, che seguirà
ovunque: assisterà alle sue lezioni acciambellato sotto la cattedra, incurante
degli iniziali timori e del successivo entusiasmo degli studenti, ne
condividerà avventure, gioie e dolori, lo accompagnerà nei suoi spostamenti
dall'America all'Irlanda alla Francia, dove Mark si trasferisce dopo aver
troncato quasi ogni legame con i suoi simili. E sarà, soprattutto, una fonte
continua di spunti di riflessione e idee filosofiche perché, contrariamente
allo stereotipo che ne fa un emblema del male, della ferocia, del lato oscuro
dell'umanità, il lupo è per Rowlands metafora di luce e di verità, la guida
per un viaggio interiore alla scoperta della propria più intima e segreta
identità: "Il lupo è la radura dell'anima umana ... svela ciò che rimane
nascosto nelle storie che raccontiamo su noi stessi". La sua natura selvaggia
e indomabile, infatti, rivela a chi gli sta accanto un modo di vivere e di fare
esperienza del mondo non solo radicalmente diverso da quello degli uomini,
ma forse anche più autentico e appagante perché immune da doppi fini, da
ogni atteggiamento di calcolo e manipolazione.
Divertente e acuto, profondo e bizzarro, a tratti drammatico, e costellato
di una miriade di episodi curiosi che sono l’ inevitabile corollario di un così
strano ménage, Il lupo e il filosofo è la storia struggente della meravigliosa
amicizia tra Mark e Brenin, raccontata con grande passione e suggestione
emotiva. Ma è anche la storia di un filosofo che impara a guardare ai temi
fondamentali della sua ricerca (il senso della vita, l’ essenza della felicità, la
natura del tempo, i misteri dell’ amore e della morte) con occhi veramente
nuovi solo dopo averli visti riflessi negli occhi di Brenin, il suo fiero e
incorrotto alter ego animale.
Mark Rowlands insegna filosofia all’ Università di Miami. Autore di
numerosi saggi e articoli specialistici, ha pubblicato due libri di
divulgazione filosofica: The Philosopher at the End of the Universe (2002)
e Everything I Know I learned from TV (2005).
Indice
Capitolo Uno La radura
Capitolo Due Fratello lupo
Capitolo Tre Decisamente non civilizzato
Capitolo Quattro La Bella e la Bestia
Capitolo Cinque L'ingannatore
Capitolo Sei La ricerca della felicità e i conigli
Capitolo Sette Una stagione all'inferno
Capitolo Otto La freccia del tempo
Capitolo Nove La religione del lupo
Ringraziamenti
A Emma
Uno. La radura
Questo libro racconta la storia di un lupo di nome Brenin. Per oltre un
decennio - buona parte degli anni Novanta e i primi anni del Duemila - ha
vissuto con me. Costretto a convivere con un intellettuale irrequieto e
giramondo, è diventato uno straordinario viaggiatore, essendo stato negli
Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Irlanda e infine in Francia. Ha anche
ricevuto, in gran parte involontariamente, più istruzione universitaria
gratuita di qualsiasi lupo mai esistito. Come vedrete, lasciarlo solo
comportava terribili conseguenze per la mia casa e le mie proprietà, per cui
ho dovuto portarlo al lavoro con me e, dato che sono professore di filosofia,
ciò ha significato portarlo alle mie lezioni. Lui se ne stava acciambellato
sotto la cattedra o disteso in un angolo dell'aula a sonnecchiare, come molti
dei miei studenti, mentre io pontificavo monotono su questo o quel filosofo.
A volte, quando la lezione risultava particolarmente noiosa, Brenin si tirava
su a sedere e ululava, un'abitudine che gli aveva assicurato le simpatie dei
miei studenti, i quali con ogni probabilità lo avrebbero imitato volentieri.
Ma questo è anche un libro su ciò che significa essere un uomo, non come
entità biologica bensì come creatura in grado di fare cose che nessun'altra
creatura può fare. Nelle storie che raccontiamo su noi stessi, la nostra
unicità è un ritornello abituale. Secondo alcuni, tale unicità consiste nella
capacità di creare cultura e di proteggerci così dalla natura, «rossa di zanne
e di artigli». Altri sottolineano il fatto che siamo le uniche creature in grado
di capire la differenza tra il bene e il male, e di conseguenza siamo le uniche
creature davvero in grado di essere buone o cattive. Alcuni affermano che
siamo unici perché abbiamo la ragione: siamo animali razionali, i soli in un
mondo di bestie irrazionali. Altri ritengono che sia l'uso del linguaggio a
distinguerci nettamente dagli animali, privi della parola. C'è chi sostiene che
siamo unici perché siamo i soli dotati di libero arbitrio e di libertà d'azione.
Altri credono che l'unicità umana si basi sul fatto che siamo i soli capaci di
amare. Alcuni dicono che soltanto noi sappiamo comprendere la natura e
l'essenza della vera felicità. Altri, infine, ritengono che siamo unici perché
siamo i soli consapevoli del fatto che moriremo.
Io non accredito nessuna di queste tesi come la testimonianza di un
profondo abisso tra noi e le altre creature. Loro fanno alcune cose che noi
pensiamo non siano in grado di fare. E noi non siamo in grado di fare alcune
cose che pensiamo di poter fare. Per il resto, bè, è soprattutto una questione
di livello, piuttosto che di genere. La nostra unicità sta invece, e
semplicemente, nel fatto che noi ci raccontiamo tali storie e, soprattutto,
possiamo davvero indurre noi stessi a crederci. Se volessi definire gli esseri
umani con una frase, direi: gli uomini sono quegli animali che credono alle
storie che raccontano su se stessi. In altri termini, gli esseri umani sono
animali creduloni.
In questi tempi oscuri non vale certo la pena sottolineare che le storie che
raccontiamo su noi stessi possono essere la più importante causa di
divisione tra un essere umano e l'altro. Tra la credulità e l'ostilità, spesso il
passo è breve. Ciò che mi interessa, tuttavia, sono le storie che ci
raccontiamo per distinguerci non l'uno dall'altro, ma dagli altri animali: le
storie su ciò che ci rende umani. Ogni storia possiede quello che potremmo
definire un lato oscuro, cioè getta un'ombra. E tale ombra dev'essere cercata
dietro quello che la storia dice: è lì che troveremo ciò che la storia dimostra
e che probabilmente risulterà oscuro sotto almeno due punti di vista. In
primo luogo, ciò che la storia dimostra è spesso un lato poco lusinghiero,
addirittura sgradevole, della natura umana. In secondo luogo, quello che la
storia dimostra è in genere difficile da vedere. Questi due aspetti non sono
disgiunti. Noi uomini abbiamo una spiccata abilità a sorvolare sugli aspetti
di noi stessi che troviamo spiacevoli. E ciò si estende alle storie che
raccontiamo per spiegare noi stessi a noi stessi.
Il lupo è, naturalmente anche se ingiustamente, il tradizionale emblema
della faccia oscura dell'umanità. Il che è paradossale sotto molti punti di
vista, non ultimo quello etimologico. In greco, «lupo» si dice lykos, una
parola così simile all'aggettivo leukos, «bianco», «splendente» (e quindi tale
da evocare la luce), che i due termini sono stati spesso associati. Può darsi,
quindi, che tale associazione sia derivata semplicemente da errori di
traduzione, oppure che fra le due parole ci fosse un nesso etimologico più
profondo. Ma, quale che fosse la ragione, Apollo veniva considerato il dio
sia del sole sia dei lupi. E in questo libro è proprio il collegamento tra il
lupo e la luce l'elemento importante. Pensate al lupo come a una radura
nella foresta. Nelle viscere della foresta ci può essere troppo buio per
riuscire a vedere gli alberi, mentre la radura è il luogo che consente a ciò
che era nascosto di essere svelato. Il lupo, come cercherò di dimostrare, è la
radura nell'anima umana. Il lupo svela ciò che rimane nascosto nelle storie
che raccontiamo su noi stessi, ovvero ciò che quelle storie dimostrano ma
non dicono.
Noi siamo nell'ombra del lupo. Una cosa può gettare un'ombra in due
modi: ostacolando la luce o essendo la fonte di luce che altre cose
ostacolano. Ci sono le ombre proiettate da un uomo e quelle create da un
fuoco. Con l'espressione «ombra del lupo» intendo non l'ombra proiettata
dal lupo stesso, ma quella che noi creiamo ostacolando la sua luce. E
guardarci di nuovo a partire da questa ombra è proprio quello che non
vogliamo conoscere di noi stessi.
Brenin è morto qualche anno fa. Mi trovo ancora a pensare a lui tutti i
giorni. A molti questo potrà sembrare una manifestazione di affetto
eccessiva: dopotutto, era solo un animale. Ma sebbene adesso la mia vita
sia, sotto tutti i punti di vista più importanti, migliore che mai, io mi sento
più povero. È davvero difficile spiegare perché, e per molto tempo io stesso
non l'ho capito. Ora credo di avere trovato la risposta: Brenin mi ha
insegnato qualcosa che nel mio lungo percorso nelle istituzioni scolastiche
ufficiali nessuno mi aveva mai insegnato, né avrebbe potuto insegnarmi. E
si tratta di una lezione difficile da tenere a mente con il giusto grado di
chiarezza ed entusiasmo adesso che Brenin non c'è più. Il tempo guarisce,
ma lo fa attraverso la cancellazione. Questo libro è il tentativo di fissare
sulla carta quella lezione prima che svanisca per sempre.
Un mito irochese narra di una scelta che una volta quel popolo dovette
compiere. Ne esistono diverse versioni. Propongo la più semplice. Venne
convocato il consiglio delle tribù per decidere dove trasferirsi per la nuova
stagione della caccia, ma nessuno sapeva che il luogo alla fine prescelto era
abitato dai lupi. Secondo la leggenda, gli irochesi vennero ripetutamente
attaccati e via via decimati dai branchi. Si trovarono così di fronte a un
dilemma: spostarsi altrove o uccidere i lupi. Ma si resero subito conto che la
seconda opzione li avrebbe disonorati e li avrebbe resi quel tipo di persone
che non volevano essere. E così si spostarono. Per non ripetere lo stesso
errore, decisero che in occasione di tutte le successive riunioni del consiglio
si sarebbe nominato un rappresentante del lupo, il cui intervento sarebbe
stato sollecitato dalla domanda: «Chi parla per il lupo?».
Questa, naturalmente, è la versione irochese del mito. Se ci fosse una
versione «lupesca», sono sicuro che sarebbe molto diversa. Eppure, nel
racconto c'è del vero. Cercherò di dimostrare che, in generale, ciascuno di
noi ha l'anima di una scimmia. Non investirò troppo nella parola «anima».
Con «anima» non intendo necessariamente una parte di noi, immortale e
incorruttibile, che sopravvive alla morte del corpo. Può darsi che l'anima sia
questo, ma ne dubito. Oppure può darsi che l'anima sia semplicemente la
mente, e che la mente sia semplicemente il cervello. Ma dubito anche di
questo. Nell'accezione in cui uso tale termine, l'anima degli esseri umani si
rivela nelle storie che raccontano su se stessi: storie sul perché sono unici;
storie che noi uomini possiamo davvero indurci a credere, a dispetto di tutte
le prove contrarie. Ciò che ho intenzione di dimostrare è che si tratta di
storie raccontate da scimmie: storie in cui struttura, tema e contenuto sono
palesemente scimmieschi.
In questo contesto uso la scimmia come metafora di una tendenza che
esiste, in misura maggiore o minore, in ognuno di noi. In tal senso, alcuni
esseri umani sono più scimmie di altri. Anzi, alcune scimmie sono più
scimmie di altre. La scimmia è la tendenza a comprendere il mondo in
termini strumentali: il valore di ogni cosa è in funzione di ciò che quella
cosa può fare per la scimmia. La scimmia è la tendenza a vedere la vita
come un processo di valutazione delle possibilità e di calcolo delle
probabilità, per poi sfruttare i risultati di quei calcoli a proprio favore. È la
tendenza a vedere il mondo come una serie di risorse, di cose da usare per i
propri scopi. La scimmia applica questo principio tanto alle altre scimmie
quanto - se non di più - al resto del mondo naturale. La scimmia è la
tendenza ad avere non amici, ma alleati. La scimmia non guarda i suoi
simili, li tiene d'occhio. E intanto aspetta l'occasione giusta per ottenere
qualche vantaggio. Vivere, per la scimmia, è attendere di colpire. La
scimmia è la tendenza a basare i rapporti con gli altri su un unico principio,
immutabile e inesorabile: che cosa puoi fare per me, e quanto mi costerà
fartelo fare? Inevitabilmente, questa consapevolezza che anche le altre
scimmie hanno la stessa natura avrà un effetto boomerang, permeando e
infettando la visione che la scimmia ha di se stessa. E così essa pensa alla
propria felicità come a qualcosa che può essere misurato, pesato,
quantificato e calcolato.
E pensa all'amore negli stessi termini. La scimmia è la tendenza a ridurre
le cose più importanti della vita a una questione di analisi costi- benefici.
Questa, vorrei ribadirlo, è una metafora di cui mi servo per descrivere una
tendenza umana. Tutti noi conosciamo persone simili. Le incontriamo sul
lavoro e nel tempo libero, siamo stati seduti di fronte a loro a un tavolo da
riunioni o a quello di un ristorante. Ma tali persone sono solo
estre-mizzazioni del tipo umano fondamentale. Sospetto che la maggior
parte di noi sia così più di quanto ci rendiamo conto o ci piaccia ammettere.
Ma perché definisco scimmiesca questa tendenza? Gli esseri umani non
sono l'unica specie di scimmie che sa soffrire o godere dell'intera gamma
delle emozioni «umane». Come vedremo, altre scimmie possono provare
amore, così come possono sentire un dolore tanto intensamente da morirne.
Possono avere amici, e non solo alleati. Ciononostante questa tendenza è
scimmiesca nel senso che è resa possibile dalle scimmie; più precisamente,
da un certo tipo di sviluppo cognitivo che è avvenuto nelle scimmie e, per
quanto ne sappiamo, in nessun altro animale. La tendenza a vedere il mondo
e coloro che ci vivono in termini di costi- benefici, a pensare alla vita, e a
ciò che di importante vi accade, come a qualcosa che può essere
quantificato e calcolato è possibile solo perché esistono le scimmie. E, fra
tutte le scimmie, è in noi che tale tendenza trova la sua espressione più
completa. Ma c'è anche una parte della nostra anima che esisteva già molto
tempo prima che diventassimo scimmie - prima, cioè, che questa tendenza
potesse afferrarci nella sua morsa - ed è nascosta nelle storie che
raccontiamo su noi stessi. È nascosta, ma può essere scoperta.
L'evoluzione opera per accrescimento graduale. Nell'evoluzione non
esiste una tabula rasa, una lavagna pulita: l'evoluzione lavora solo con ciò
che esiste e non ritorna mai al tavolo da disegno. Così, per citare l'esempio
più banale, i tratti grottescamente distorti dei pesci piatti - nei quali gli occhi
si sono spostati su un solo lato - dimostrano che le pressioni evolutive che li
hanno spinti a specializzarsi nel giacere sul fondo del mare hanno agito su
pesci che si erano originariamente sviluppati per altri scopi e che, pertanto,
avevano gli occhi posizionati sulle superfici laterali, anziché dorsali.
Analogamente, nello sviluppo degli esseri umani l'evoluzione è stata
costretta a lavorare con ciò che era dato. Il nostro cervello è essenzialmente
una struttura storica: è sulle fondamenta di un primitivo sistema limbico un sistema che condividiamo con i nostri antenati simili a rettili - che si è
sviluppata la corteccia dei mammiferi, una cui versione particolarmente
robusta caratterizza gli esseri umani.
Non intendo suggerire che le storie che raccontiamo su noi stessi, e in cui
crediamo, sono prodotti dell'evoluzione come gli occhi dei pesci piatti o il
cervello dei mammiferi. Credo però che si sviluppino in modo analogo:
attraverso un accrescimento graduale, in cui nuovi strati narrativi si
sovrappongono a temi e strutture preesistenti. Non c'è una lavagna pulita
per le storie che raccontiamo su noi stessi. Cercherò di dimostrare che, se
guardiamo con sufficiente attenzione e se sappiamo dove e come guardare,
in ogni storia narrata dalle scimmie troveremo anche un lupo. E il lupo ci
dice - è questa la sua funzione nella storia - che i valori della scimmia sono
rozzi e inutili. Ci dice che ciò che conta nella vita non è mai una questione
di calcolo. Ci ricorda che ciò che ha davvero valore non può essere
quantificato o barattato. Ci rammenta che a volte dobbiamo fare ciò che è
giusto, quali che siano le conseguenze.
Tutti noi, penso, siamo più scimmia che lupo. In molti di noi il lupo è
stato quasi del tutto cancellato dalla narrazione delle nostre vite. Ma è a
nostro pericolo che permettiamo al lupo di morire. Alla fine i complotti
della scimmia non porteranno a nulla; l'intelligenza della scimmia ti tradirà
e la sua fortuna si esaurirà. Sarà in quel momento che scoprirai ciò che è
veramente importante nella vita. E non si tratterà di quello che ti hanno
procurato i tuoi complotti, le tue capacità e la tua fortuna, ma di ciò che
resta quando complotti, capacità e fortuna ti avranno abbandonato. Tu sei
molte cose. Ma il tu più importante non è quello che ordisce complotti: è
quello che resta dopo che sono falliti. Il tu più importante non è quello che
si compiace della sua astuzia: è quello che resta quando l'astuzia ti lascia per
morto. Il tu più importante non è quello che cavalca la fortuna: è quello che
resta quando la fortuna ti gira le spalle. Alla fine la scimmia ti deluderà
sempre. La domanda più importante che puoi farti è: quando ciò accade, chi
e che cosa resta?
Ci ho messo molto tempo, ma alla fine credo di avere capito perché ho
amato Brenin così tanto e perché sento così dolorosamente la sua mancanza,
adesso che non c'è più. Brenin mi ha insegnato qualcosa che la mia vasta
cultura non poteva insegnarmi: che in una qualche antica parte della mia
anima viveva ancora un lupo.
A volte è necessario lasciare parlare il lupo che c'è in noi per mettere a
tacere l'incessante chiacchiericcio della scimmia. Questo libro è un tentativo
di parlare per il lupo nell'unico modo che conosco.
«L'unico modo che conosco» è risultato essere molto diverso da ciò che
avevo in mente. Ho impiegato parecchio per scrivere questo libro. Alla fin
fine ci ho lavorato per quasi quindici anni. I pensieri che contiene, infatti,
hanno richiesto molto tempo per essere pensati. A volte le ruote girano
lentamente. Il testo è nato dalla mia vita con un lupo, ma per certi versi ho
ancora la concreta sensazione di non capire che cosa sia.
In un certo senso, è un'autobiografia. Tutti i fatti qui descritti sono
successi. Sono successi a me. Ma sotto molti altri aspetti non è
un'autobiografia, o perlomeno non una buona autobiografia. Se qui c'è un
protagonista, quello non sono certo io. Io sono solo un'insignificante
comparsa che si aggira goffamente in secondo piano. Le buone
autobiografie sono popolate di comprimari, mentre qui tali personaggi si
caratterizzano sostanzialmente per la loro assenza: ci sono forse i fantasmi
delle altre persone della mia vita, ma questo è tutto. Per proteggere la
privacy di questi fantasmi, poiché non so se sarebbero entusiasti di essere
citati, ne ho cambiato i nomi. E in presenza di altre cose che desidero
proteggere scopro di essere stato molto evasivo nei dettagli relativi a tempi
e luoghi. Le buone autobiografie sono particolareggiate ed esaurienti. Qui,
invece, i dettagli sono scarsi e la memoria è selettiva. Il testo si basa su ciò
che ho imparato dalla mia vita con Brenin ed è organizzato intorno a quelle
lezioni. Di conseguenza mi sono concentrato perlopiù su quegli eventi della
nostra vita in comune che risultavano pertinenti ai pensieri che volevo
sviluppare. Altri episodi, alcuni significativi, sono stati ignorati e presto
svaniranno nel tempo. Quando specifici dettagli di avvenimenti, persone o
storie minacciavano di soverchiare i pensieri che desideravo sviluppare, li
ho eliminati implacabilmente.
Ma se questo libro non è la mia storia personale, alla fine non è nemmeno
la storia di Brenin. Naturalmente il testo ruota intorno a varie vicende
avvenute nel corso della nostra vita in comune, ma solo raramente cerco di
capire che cosa stesse accadendo nella mente di Brenin in quei momenti.
Malgrado una convivenza più che decennale, non sono sicuro di avere la
competenza per esprimere giudizi del genere, se non nei casi più semplici. E
molti degli avvenimenti che racconto e dei temi di cui discuto non sono
affatto semplici. Sono fermamente convinto che in queste pagine Brenin sia
una presenza concreta e dominante, ma vi compare anche in un modo del
tutto diverso: come un simbolo o una metafora di una parte di me, una parte
che, forse, non c'è più. Così a volte mi abbandono a discorsi metaforici su
ciò che il lupo «sa». Se venissero intese come una valutazione empirica
sull'effettivo contenuto della mente di Brenin, tali affermazioni sarebbero
ridicolmente antropomorfe. Ma, ve l'assicuro, non vanno intese in questo
senso. Così come, quando parlo delle lezioni che ho imparato da Brenin, si
tratta di lezioni viscerali e fondamentalmente non cognitive. Sono state
apprese non dallo studio di Brenin, ma dal fatto che lui e io abbiamo
percorso insieme il cammino delle nostre vite. E molte di quelle lezioni le
ho capite solo dopo che Brenin se n'era andato.
Questo libro non è neppure un testo di filosofia, almeno non nel senso
stretto che sono stato abituato a considerare e che i miei colleghi
approverebbero. Ci sono ragionamenti, ma non c'è alcuna ordinata
progressione dalle premesse alla conclusione. La vita è troppo scivolosa per
premesse e conclusioni. Sono colpito, invece, dal sovrapporsi degli
argomenti di discussione. Sono colpito da come un tema che avevo deciso
di trattare e di collocare in un determinato capitolo riesca a riproporsi con
forza in seguito, in una forma nuova e diversa. A quanto pare, questa è una
conseguenza della natura dell'indagine. Raramente la vita si concede di
occuparsi di se stessa e di darsi un ordine.
I pensieri che informano ciò che ho scritto sono miei, ma al tempo stesso,
e in un senso molto importante, non lo sono. E non perché siano di qualcun
altro, anche se è chiara l'influenza di pensatori come Nietzsche, Heidegger,
Camus, Kundera e Richard Taylor. Piuttosto, e ancora una volta devo
ricorrere alla metafora, credo che certi pensieri possano emergere solo nello
spazio tra un lupo e un uomo.
Nei primi tempi della nostra convivenza, Brenin e io avevamo l'abitudine
di trascorrere qualche weekend a Little River Canyon, nell'angolo
nordorientale dell'Alabama, dove montavamo (illegalmente) una tenda.
Passavamo il tempo rabbrividendo per il freddo e ululando alla luna. Il
canyon era stretto e profondo, e solo con riluttanza il sole si apriva
faticosamente la strada tra le fitte betulle e le querce dei druidi, e una volta
che aveva superato il margine occidentale del canyon, le ombre si
congelavano in un blocco compatto. Dopo circa un'ora di cammino lungo
un sentiero abbandonato, Brenin e io entravamo nella radura. Se avevamo
calcolato bene i tempi, questo accadeva nel momento in cui il sole dava il
suo bacio d'addio al canyon e una luce dorata si rifletteva in quello spazio
aperto. E gli alberi, in gran parte nascosti dalla penombra ormai da un'ora, si
stagliavano in tutto il loro antico e potente splendore. La radura è lo spazio
che permette agli alberi di emergere dall'oscurità alla luce. I pensieri che
danno forma a ciò che ho scritto sono emersi in uno spazio che non esiste
più, e non sarebbero stati possibili - almeno per me - senza quello spazio. Il
lupo non c'è più, e quindi non c'è più nemmeno quello spazio. Quando
rileggo questo libro, rimango colpito da quanto mi risultino estranei i
pensieri che contiene. Il fatto che sia stato io a pensarli è per me una strana
scoperta. Questi non sono pensieri miei perché, pur credendo in essi e
ritenendoli veri, non sarei più capace di pensarli. Questi sono i pensieri della
radura. Sono i pensieri che esistono solo nello spazio tra un lupo e un uomo.
Due. Fratello lupo
Brenin non stava mai sdraiato o accucciato nel retro della mia jeep. Gli
piaceva sempre vedere che cosa stava arrivando. Una volta avevamo
viaggiato in auto da Tuscaloosa, in Alabama, fino a Miami - circa 1300
chilometri - e ritorno, e Brenin era rimasto in piedi per tutto il tragitto,
oscurando con la sua ingombrante mole buona parte del sole e tutto il
traffico alle nostre spalle. Ma quella volta, durante il breve viaggio fino a
Béziers, non rimase in piedi: non ce la faceva. E fu allora che capii che
ormai non c'era più niente da fare. Lo stavo portando nel luogo dove
sarebbe morto. Mi ero detto che se si fosse alzato in piedi, anche solo per
una parte del viaggio, mi sarei concesso un altro giorno: altre ventiquattr'ore
perché accadesse un miracolo. Ma adesso sapevo che era finita. Quello che
era stato il mio amico per gli ultimi undici anni se ne sarebbe andato. E io
non sapevo che tipo di persona avrebbe lasciato dietro di sé.
Il buio inverno francese non avrebbe potuto contrastare di più con quella
luminosa serata in Alabama, all'inizio di maggio, poco più di dieci anni
prima, quando avevo portato nella mia casa e nel mio mondo un Brenin di
sei settimane. Nel giro di due minuti dal suo arrivo - e non sto affatto
esagerando - aveva sfilato dalle guide le tende (di entrambe le finestre!) del
soggiorno e le aveva gettate a terra. Poi, mentre io cercavo di riappenderle,
aveva trovato la strada per arrivare in giardino e sotto la casa. Sul retro
l'edificio era rialzato da terra ed era possibile accedere allo spazio
sottostante attraverso una porta in un muro di mattoni, porta che ovviamente
avevo lasciato socchiusa.
Brenin riuscì ad andare sotto la casa e poi procedette - metodicamente,
meticolosamente e, soprattutto, rapidamente - a staccare e strappare ognuno
dei flessibili tubi rivestiti di materiale isolante che convogliavano l'aria
fredda dalle macchine del condizionatore alla casa attraverso varie
bocchette nel pavimento. Era l'atteggiamento caratteristico di Brenin - il suo
«marchio di fabbrica» - verso tutto ciò che era nuovo e sconosciuto. Gli
piaceva vedere che cosa sarebbe successo. Esplorava, valutava. E poi
distruggeva. Era mio da un'ora e mi era già costato mille dollari:
cinquecento per comprarlo e cinquecento per riparare l'impianto dell'aria
condizionata. Una cifra che, a quei tempi, era pari a circa un ventesimo del
mio stipendio lordo annuo. Questo tipo di schema si sarebbe ripetuto, in
modi spesso innovativi e fantasiosi, per tutti gli anni della nostra
convivenza. I lupi non sono economici.
Perciò, se state pensando di acquistarne uno - o anche solo un incrocio
lupo- cane -, la prima cosa che voglio dirvi è: non fatelo! Non fatelo mai,
non pensateci neppure. I lupi non sono cani. Ma se persistete scioccamente
in questa idea, allora devo avvertirvi che la vostra vita sta per cambiare per
sempre.
Era il mio primo lavoro e lo facevo da un paio d'anni: assistente di
filosofia all'università dell'Alabama, in una città che si chiama Tuscaloosa.
Tuscaloosa è un termine degli indiani choctaw che significa «Guerriero
nero» e la città è attraversata dall'imponente Black Warrior River, il «fiume
del Guerriero nero». Tuscaloosa è nota soprattutto per la sua squadra
universitaria di football, la Crimson Tide, che i membri della comunità
locale sostengono con un fervore più che religioso, anche se non ci vanno
leggeri neppure con la religione. Penso che sia giusto affermare che sono
molto più sospettosi nei confronti della filosofia, e chi può biasimarli? La
vita era piacevole. Mi divertivo fin troppo a Tuscaloosa. Ma ero cresciuto in
compagnia dei cani - perlopiù cani grossi, come gli alani - e ne sentivo la
mancanza. E così un pomeriggio mi trovai a leggere gli annunci economici
del «Tuscaloosa News».
Per buona parte della loro relativamente giovane vita, gli Stati Uniti
hanno perseguito una politica di sistematica eliminazione dei lupi: armi da
fuoco, veleno, trappole, qualsiasi mezzo venisse ritenuto necessario. Il
risultato è che non ci sono virtualmente più lupi selvatici in libertà nei
quarantotto Stati continentali. Ora che questa politica è stata abbandonata, i
lupi sono ricomparsi in alcune aree del Wyoming, del Montana, del
Minnesota e in qualche isola dei Grandi Laghi: Isle Royale, al largo della
costa settentrionale del Michigan è l'esempio più famoso, grazie soprattutto
alle pionieristiche ricerche sui lupi ivi effettuate dal naturalista David Mech.
Di recente, tra le vibranti proteste degli allevatori, sono stati reintrodotti lupi
addirittura a Yellowstone, il più famoso parco naturale americano.
Questa rinascita della popolazione dei lupi, tuttavia, non ha ancora
raggiunto l'Alabama o, in generale, gli Stati del Sud. Ci sono moltissimi
coyote. E ci sono alcuni lupi rossi nelle paludi della Louisiana e del Texas
orientale, anche se nessuno sa bene che cosa siano: potrebbero benissimo
essere il risultato di una storica ibridazione lupo- coyote. Ma i lupi delle
foreste, o lupi grigi come vengono a volte chiamati (non correttamente, dato
che possono essere anche neri, bianchi e marroni), sono un ricordo remoto
nel Sud degli Stati Uniti.
Perciò rimasi piuttosto sorpreso quando lo sguardo mi cadde su un
particolare annuncio: «Vendonsi cuccioli di lupo, 96 per cento». Dopo una
breve telefonata, saltai in auto e puntai verso Birmingham, un viaggio di
circa un'ora in direzione nordest, non sapendo bene che cosa mi aspettassi
da quella spedizione. E fu così che, poco dopo, mi ritrovai faccia a faccia e
occhi negli occhi con il lupo più grosso di cui avessi mai sentito parlare, o
che avessi mai visto. Il proprietario mi accompagnò sul retro della casa per
mostrarmi la stalla e il recinto degli animali. Quando il lupo padre, che si
chiamava Yukon, ci sentì arrivare balzò contro la porta della stalla, proprio
mentre giungevamo lì davanti, dando l'impressione di essersi materializzato
dal nulla.
Era enorme, imponente e, ritto sugli arti posteriori, un po’ più alto di me.
Dovetti alzare lo sguardo per osservarne il muso e gli strani occhi gialli. Ma
furono le sue zampe a rimanermi indelebilmente impresse nella memoria.
La gente non si rende conto - di sicuro non me ne rendevo conto io - di
quanto siano grandi le zampe dei lupi. Molto più di quelle dei cani. Furono
le zampe ad annunciare l'arrivo di Yukon e la prima cosa che vidi quando
saltò per sporgersi al di sopra della porta della stalla. E adesso pendevano
dalla sommità della porta, molto più grandi dei miei pugni, come guanti da
baseball pelosi.
C'è una domanda che la gente mi rivolge spesso, non su questo specifico
episodio - è la prima volta che ne parlo con qualcuno -, ma in generale sul
fatto di possedere un lupo: non hai mai paura di lui? La risposta,
naturalmente, è no. Mi piacerebbe pensare che rispondo così perché sono
una persona eccezionalmente coraggiosa, ma è un'ipotesi che non
reggerebbe mai di fronte alla grande quantità di prove contrarie. Prima di
salire su un aereo, per esempio, ho bisogno di farmi parecchi robusti
bicchierini. Perciò, disgraziatamente, credo che l'attribuzione di un coraggio
buono per tutte le occasioni non sia sostenibile. In presenza dei cani, però,
sono molto rilassato. E ciò si deve in gran parte alla mia educazione: sono il
prodotto disfunzionale di una famiglia piuttosto disfunzionale. Per fortuna,
e per quello che posso dire, tale disfunzionalità era limitata alle nostre
interazioni con i cani.
Quando avevo due o tre anni, facevamo un gioco con Boots, il nostro
labrador. Boots si sdraiava e io mi sedevo a cavalcioni su di lui, afferrando
il collare. A quel punto mio padre lo chiamava e Boots, che da giovane era
veloce come un fulmine, in un istante scattava in piedi e si metteva a
correre.
Il mio compito, e lo scopo del gioco, consisteva nel rimanere aggrappato
al suo collare e cavalcare sulla sua groppa. Non ci riuscivo mai. Era come se
io fossi un set di piatti, posate e bicchieri sulla tavola apparecchiata e
qualcuno mi strappasse la tovaglia da sotto. A volte la tecnica da mago
canino di Boots era così precisa che mi ritrovavo, con lo sguardo confuso,
seduto esattamente nel punto in cui lui un attimo prima se ne stava disteso.
Altre volte Boots era un po’ meno preciso e io ruzzolavo a terra. Ma in quel
gioco qualsiasi dolore fisico veniva trattato come la piccola seccatura che in
effetti era e io mi rialzavo allegramente, supplicando di poterci riprovare
ancora. Probabilmente oggi, nella nostra cultura cronicamente avversa al
rischio e nevrotica al solo pensiero di fratture infantili, un gioco del genere
non sarebbe possibile. Quasi certamente qualcuno telefonerebbe ai servizi
sociali per l'infanzia, forse alla protezione animali, o magari a entrambi. Ma
io so che detestai il giorno in cui mio padre mi disse che ero diventato
troppo grosso e pesante per continuare quel gioco con Boots.
Se guardo al mio passato, mi rendo conto che in fatto di cani la mia
famiglia, e di conseguenza io, non siamo del tutto normali. Spesso
prendevamo alani dai canili pubblici. A volte erano animali adorabili, altre
volte erano decisamente psicotici. Blue, un alano a cui con scarsa
immaginazione era stato imposto - ma non da noi - quel nome a causa del
suo colore, è un ottimo esempio a tal proposito. Blue aveva circa tre anni,
quando i miei genitori lo salvarono. E non fu difficile capire perché si
trovasse in un canile. Blue aveva un hobby: mordere in modo casuale e
indiscriminato persone e altri animali. In realtà non è del tutto esatto: i
morsi non erano affatto casuali o indiscriminati. Blue aveva - diciamo così diverse idiosincrasie. Una era quella di non permettere a nessuno di uscire
dalla stanza in cui si trovava lui. Se volevi andartene, doveva sempre esserci
qualcuno che distraeva Blue. Naturalmente se questo qualcuno se ne fosse
voluto andare, avrebbe avuto bisogno a propria volta di un'altra persona che
distraesse l'alano. La grande ruota della vita di Blue girava così. Se ti
dimenticavi di distrarlo adeguatamente prima di lasciare la stanza, il
risultato era una cicatrice permanente nel posteriore. Chiedete a mio fratello
Jon.
L'anomalia della mia famiglia si manifestava non solo nella disponibilità
ad accettare le idiosincrasie di Blue, invece di spedirlo dal veterinario con
un biglietto di sola andata, come avrebbe fatto qualsiasi famiglia normale,
ma anche e soprattutto nel modo in cui consideravano questo aspetto
abbastanza irritante della personalità dell'alano come fonte di grande ilarità,
anzi, come un gioco piuttosto divertente. La maggior parte della gente
probabilmente avrebbe pensato, a ragione, che Blue era un costante pericolo
per gli arti e forse per la vita e che, tutto sommato, il mondo sarebbe stato
migliore senza di lui. Ma ai miei familiari quel gioco piaceva. Credo che
tutti loro abbiano ancora le cicatrici delle idiosincrasie di Blue, e non solo
nel posteriore. Blue aveva anche altre idiosincrasie. Io fui l'unico a
sfuggirgli, ma solo perché, quando lui entrò in scena, io ero già uscito di
casa per frequentare l'università. In ogni caso le cicatrici erano viste non
come motivo di compassione o preoccupazione, ma come occasioni di
generali prese in giro e benevola derisione.
La pazzia, naturalmente, è una caratteristica di famiglia ed era forse
troppo aspettarsi che io ne fossi esente. Qualche anno fa, in un paesino
francese, mi trovai impegnato in un gioco quotidiano con una femmina di
Dogo argentino che abitava vicino a casa mia. Il dogo è un cane bianco
grande e possente, un po’ la versione sovradimensionata del pit bull, e in
Gran Bretagna è stato messo al bando dalla legge sulle razze canine
pericolose. Ogni volta che mi vedeva, la cucciola di dogo si fiondava
eccitata contro la recinzione del suo giardino e si drizzava sulle zampe
posteriori perché la accarezzassi. Crescendo, continuò a comportarsi nello
stesso modo. Ma a un certo punto evidentemente decise che, tutto sommato,
poteva essere una buona idea anche quella di mordermi. Per mia fortuna, i
dogo sono grandi e grossi, ma non veloci. E neppure particolarmente
intelligenti: potevo quasi vedere le rotelle che le giravano dentro la testa
mentre valutava le possibilità e le conseguenze di un eventuale morso. E
così tutti i giorni ripetevamo lo stesso gioco. Io passavo davanti al giardino,
lei correva alla recinzione, io le davo qualche colpetto sulla testa e lei si
godeva le coccole per alcuni secondi, annusandomi la mano e
scodinzolando allegramente. Ma poi all'improvviso irrigidiva il corpo e
contraeva la bocca. E poi scattava all'attacco. Se devo essere sincero, credo
che i suoi fossero tentativi poco convinti. Io le piacevo abbastanza, ma lei si
sentiva obbligata a mordermi a causa dei soggetti con cui mi accompagnavo
(come vedremo, aveva buone ragioni per trovare poco simpatiche le mie
frequentazioni, in particolare una di esse). Io ritraevo la mano con tempismo
perfetto, lei richiudeva le fauci a vuoto e io la salutavo con un à plus tard,
augurandole miglior fortuna per l'indomani. Non mi piace pensare che la
stavo tormentando. Era solo un gioco e io ero davvero curioso di vedere
quanto tempo ci sarebbe voluto prima che smettesse di cercare di mordermi.
Non smise mai.
Comunque sia, non ho mai avuto paura dei cani. E questa confidenza si è
estesa con naturalezza anche ai lupi. Salutai Yukon come avrei salutato un
alano mai visto prima: in modo rilassato e amichevole, ma rispettando
comunque le consuete regole. Yukon risultò non assomigliare affatto a Blue
e neppure alla mia amica dogo. Era un lupo di buon carattere, fiducioso e
amichevole. Ma i fraintendimenti possono verificarsi anche con gli animali
migliori. La ragione più tipica per cui un cane morde - e sospetto che lo
stesso valga per i lupi - è l'avere perso di vista la mano di chi gli si avvicina.
Le persone allungano la mano oltre il muso del cane per dargli un colpetto
nella zona posteriore della testa o sul collo. Perdendo di vista la mano, il
cane si innervosisce, sospetta un possibile attacco e, di conseguenza, morde.
È un morso dovuto alla paura, il tipo di morso più comune. Così permisi a
Yukon di annusarmi la mano e gli feci qualche coccola sulla parte anteriore
del collo e sul petto, finché non si abituò alla mia presenza. Andammo
subito d'amore e d'accordo.
La madre di Brenin si chiamava Sitka, come un particolare tipo di abete
rosso, credo. Era alta come Yukon, ma più slanciata e non certo così
massiccia. Con il corpo lungo e snello, aveva più l'aria del lupo, perlomeno
stando alle foto di lupi che avevo visto. Esistono numerose sottospecie di
lupi. Sitka, mi venne detto, era un lupo della tundra dell'Alaska. Yukon,
invece, era un lupo della valle del Mackenzie, nel Nordovest del Canada. Le
loro diverse caratteristiche fisiche riflettevano l'appartenenza alle rispettive
sottospecie.
Sitka era troppo occupata con i sei orsacchiotti che le scorrazzavano tra le
zampe per dedicarmi molta attenzione. «Orsacchiotti» è il termine migliore
che mi viene in mente per descrivere quelle sei creature: rotonde, morbide,
pelose e prive di spigoli. Alcuni erano grigi e altri marroni, tre erano maschi
e tre femmine. La mia intenzione originaria era quella di dare solo
un'occhiata ai cuccioli e poi tornarmene a casa e riflettere attentamente e
razionalmente sulla domanda se fossi davvero pronto ad assumermi la
responsabilità di un lupo, e così via. Ma non appena vidi i cuccioli, capii
subito che me ne sarei portato a casa uno. Quel giorno stesso. Anzi, mi
sembrò di non essere abbastanza veloce a estrarre dalla tasca il libretto degli
assegni. E quando l'allevatore mi informò che non accettava assegni, mi
sembrò di non guidare abbastanza in fretta verso il più vicino bancomat per
procurarmi i contanti.
Scegliere il cucciolo fu più facile di quanto avessi pensato. La cosa
fondamentale era che volevo un maschio. Ce n'erano tre. Il più grosso dei
maschi - in realtà il più grosso dell'intera cucciolata - era grigio e, intuivo,
sarebbe diventato la copia esatta del padre. Sapevo abbastanza di cani da
rendermi conto che sarebbe stato un animale problematico. Senza paura,
energico, dominante sui fratelli e sulle sorelle, era chiaramente destinato a
diventare il maschio alfa e avrebbe richiesto un supplemento di impegno e
di controllo. Ripensai a Blue e, visto che quello sarebbe stato il mio primo
lupo, decisi che la prudenza doveva superare il coraggio. Scelsi quindi il
secondo cucciolo più grosso. Era marrone e il suo colore mi faceva pensare
a un piccolo leone. Di conseguenza lo chiamai Brenin, che in gallese
significa «re». Senza dubbio si sarebbe sentito mortificato, se avesse saputo
che gli era stato dato un nome da felino.
Ma non aveva proprio niente del felino. Sembrava piuttosto uno di quei
cuccioli di grizzly che si vedono su Discovery Channel mentre seguono la
madre in giro per il Denali National Park in Alaska. All'età di sei settimane
Brenin era marrone con una spruzzata di nero, ma con la pancia chiara, una
pennellata color crema che partiva dalla punta della coda e arrivava fin sotto
il muso. E, come un orsacchiotto, era massiccio: grosse zampe, grossa
ossatura degli arti e grossa testa. Gli occhi erano di un giallo molto scuro,
quasi color miele, una caratteristica che non cambiò mai. Non direi che
fosse «socievole», almeno non nel senso in cui lo sono i cuccioli di cane. E
non era, neppure con uno sforzo di immaginazione, entusiasta, esuberante o
ansioso di piacere. Il suo tratto comportamentale dominante era invece il
sospetto, anche questa una caratteristica che non sarebbe mai cambiata:
tranne che nei miei confronti.
È strano. Ricordo tutti questi particolari su Brenin, Yukon e Sitka.
Ricordo di avere sollevato Brenin all'altezza del mio viso e di averlo
guardato in quei suoi occhi gialli. Ricordo la sensazione fisica che mi diede,
con la sua soffice pelliccia di cucciolo, mentre lo tenevo tra le mani. Vedo
ancora chiaramente Yukon che, ritto sugli arti posteriori, mi fissa, lasciando
dondolare le grandi zampe dalla sommità della porta della stalla. Vedo i
fratelli e le sorelle di Brenin che scorrazzano nel recinto, ruzzolano l'uno
sull'altro e si rialzano allegri. Dell'uomo che mi ha venduto Brenin, invece,
non riesco a ricordare praticamente nulla. Era già iniziato un processo che si
sarebbe accentuato con il trascorrere degli anni: stavo cominciando a far
passare in secondo piano gli esseri umani. Un lupo assume il controllo della
tua vita in un modo che un cane raramente riesce a fare. E a poco a poco la
compagnia degli uomini diventa sempre meno importante. Ricordo i dettagli
di Brenin, dei suoi genitori e dei suoi fratelli: che aspetto avevano, che
sensazione fisica davano, che cosa facevano, i versi che emettevano. Riesco
perfino a ricordare il loro odore. I minimi particolari, in tutta la loro
vivacità, complessità e ricchezza, sono ancor oggi chiari nella mia mente
come lo erano allora. Del proprietario dei lupi, invece, ricordo solo i tratti
generici, l'essenziale. Rammento la sua storia - almeno credo -, ma non
ricordo l'uomo.
Si era trasferito in Alabama dall'Alaska, portando con sé una coppia di
lupi da riproduzione. Tuttavia è contro la legge - non so bene se statale o
federale - acquistare, vendere o possedere lupi purosangue. È permesso
acquistare, vendere e possedere incroci lupo- cane e per legge la più alta
percentuale di lupo consentita, rispetto al cane, è il 96 per cento.
L'allevatore mi assicurò che a tutti gli effetti erano lupi, non incroci lupocane. Dato che fino a poche ore prima non avevo neppure avuto idea di
poter possedere un lupo- cane, in realtà non me ne importava. Gli diedi i
cinquecento dollari che avevo prelevato al bancomat, in pratica quasi
svuotando il mio conto corrente, e portai Brenin a casa quel pomeriggio
stesso. Dopodiché lui e io cominciammo a definire i termini del nostro
rapporto.
Dopo l'iniziale impeto distruttivo, che durò circa quindici minuti, Brenin
cadde in una profonda depressione. Si rintanò sotto la mia scrivania e si
rifiutò di uscire e di mangiare. La cosa durò un paio di giorni. Pensai che si
sentisse distrutto dalla perdita dei fratelli e delle sorelle. Mi dispiaceva
tantissimo per lui e mi sentivo molto in colpa. Avrei voluto potergli
comprare un fratello o una sorella perché gli tenesse compagnia, ma
semplicemente non avevo i soldi. Nel giro di due o tre giorni, comunque,
l'umore di Brenin cominciò a migliorare. E fu allora che la prima regola del
nostro reciproco accordo divenne chiara, anzi molto chiara. La regola era
che Brenin non doveva mai, in nessuna circostanza e per nessuna ragione,
essere lasciato da solo in casa. Qualunque deroga a questa regola
comportava conseguenze terribili per la casa e per il suo contenuto. Il
destino toccato alle tende e ai tubi dell'aria condizionata era solo un
modesto assaggio delle reali capacità di Brenin al riguardo. Le suddette
conseguenze includevano la distruzione di tutto il mobilio e dei tappeti, per
i quali, in particolare, era prevista anche l'opzione dell'insozzamento. Ho
imparato che i lupi si annoiano molto, molto in fretta: trenta secondi da soli
in genere sono fin troppi. Quando si annoiava, Brenin masticava cose o ci
faceva la pipì sopra, oppure le masticava e poi ci faceva la pipì sopra. Molto
raramente, arrivava perfino a fare la pipì sugli oggetti per poi masticarli, ma
credo che questo succedesse perché, in preda all'eccitazione, non si
ricordava più a che punto era arrivato nella sequenza delle operazioni. In
ogni caso la conclusione era che, ovunque io andassi, Brenin doveva venire
con me.
Naturalmente la regola del «dove vai tu, vengo anch'io», quando l"«io» in
questione è un lupo, preclude quasi tutte le attività remunerative. Questa è
solo una delle tante ragioni per non diventare mai proprietari di un lupo. Io
però ero fortunato. Tanto per cominciare, facevo il professore universitario
e non dovevo comunque presentarmi al lavoro molto spesso. Inoltre Brenin
arrivò durante la pausa estiva universitaria di tre mesi, per cui in realtà al
lavoro non dovevo andarci per niente. Ebbi quindi tutto il tempo per
rendermi adeguatamente conto della grandissima passione di Brenin per la
distruzione e per prepararlo a venire al lavoro con me, visto che non potevo
in alcun modo evitarlo.
C'è chi dice che non è possibile addestrare i lupi. Non è così: è possibile
addestrare quasi qualunque animale, se si trova il sistema giusto. È questa la
cosa difficile. Con un lupo ci sono moltissimi modi per fallire, ma, per
quello che ne so, ce n'è solo uno per avere successo. Ciò, comunque, è quasi
altrettanto vero con i cani. Forse l'idea sbagliata più comune è credere che
l'addestramento abbia qualcosa a che fare con l'ego. L'addestramento viene
visto come una battaglia di volontà, nella quale il cane dev'essere costretto a
adeguarsi. L'errore in questo caso consiste nel considerare l'addestramento
come un fatto troppo personale. Il padrone interpreta qualsiasi rifiuto da
parte del cane come un affronto personale, un insulto alla propria virilità (in
genere è l'uomo a vedere l'addestramento in questi termini). E a quel punto,
naturalmente, si arrabbia. La prima regola nell'addestramento dei cani è, o
dovrebbe essere, tenere presente che non c'è nulla di personale.
L'addestramento non è una battaglia di volontà: per chi la pensa così il
risultato sarà disastroso. Se si cerca di addestrarlo in tal modo, con ogni
probabilità un grosso cane aggressivo finirà per diventare nient'affatto
simpatico.
L'errore opposto è pensare che l'obbedienza dell'animale si possa ottenere
non con il dominio, ma con le ricompense. Le ricompense possono
assumere forme diverse. Alcuni lanciano ossessivamente prelibatezze in
bocca al cane per premiarlo anche dopo il più semplice dei compiti. Il
risultato più ovvio sarà un cane grasso che si rifiuterà di obbedire al suo
padrone quando sospetterà che non ci siano bocconcini in vista, o quando
sarà distratto da qualcosa - un gatto, un altro cane, un podista - che gli
sembrerà più interessante del cibo. Più spesso, però, la ricompensa si
trasforma in una serie di insulsi complimenti che il proprietario rivolge al
cane - «Bravo cagnone», «Che cane intelligente sei!», «Bravo, così», «A
cuccia», «Che bravo cane sei!» -accompagnandoli con fastidiosi, piccoli
strappi al guinzaglio che, secondo lui, servono a rafforzare il messaggio.
Questo è esattamente il modo di non addestrare un cane e non ha alcuna
probabilità di funzionare nemmeno con un lupo. Se parlate in continuazione
al vostro cane o gli tirate blandamente il guinzaglio, lui non avrà alcun
bisogno di guardarvi. Anzi, non avrà alcun motivo di interessarsi a ciò che
state facendo. Potrà fare quello che gli pare nella certezza che voi gli farete
sapere che cosa sta succedendo... e che lui potrà, a sua scelta, agire di
conseguenza oppure infischiarsene.
Le persone convinte che l'obbedienza dei cani possa essere comprata
pensano - quante volte l'ho sentito dire! - che fondamentalmente l'animale
desideri comportarsi come il suo «padrone» vuole, desideri sempre
compiacerlo, e abbia bisogno soltanto che gli si spieghi con precisione come
farlo. Naturalmente è una sciocchezza. Il vostro cane non desidera obbedirvi
più di quanto voi desideriate obbedire a un'altra persona. Perché dovrebbe?
La chiave per addestrare il vostro cane è riuscire a convincerlo di non avere
scelta. Questo non perché l'animale debba sentirsi lo sconfitto in una
battaglia di volontà, ma perché voi dovete portare nel vostro addestramento
un atteggiamento di calma, ma inesorabile inevitabilità. In una battaglia di
volontà voi dite al lupo: tu farai quello che ti dico, non ti do altra possibilità.
L'atteggiamento con cui addestrare un lupo, invece, è: tu farai quello che la
situazione esige, la situazione non consente altre opzioni. Quello a cui
reagisci non sono io, è il mondo. Magari sarà una magra consolazione per il
lupo, ma questo approccio di sicuro contribuirà ad assegnare all'addestratore
il suo giusto ruolo: non un'autorità dominante e arbitraria i cui ordini
devono essere eseguiti a tutti i costi, ma un educatore che permette al lupo
di capire che cosa il mondo vuole da lui. Il metodo Koehler è, tra tutti i
metodi di addestramento, quello che ha elevato l'atteggiamento di cui parlo
a forma d'arte.
Quando avevo sei o sette anni, il sabato mattina andavo al cinema con i
miei amici. Mia madre mi dava dieci penny e, in compagnia degli altri
ragazzini, mi facevo tre o quattro chilometri a piedi fino in città. Spendevo
cinque penny per il biglietto del cinema e altri tre e mezzo per una lattina di
MacCola, che veniva venduta non da McDonald's, che all'epoca non era
ancora arrivato nel Galles, ma da MacFisheries, una catena di pescherie. Di
quei giorni ricordo un solo film e una sola scena di quel film. Il film è
Robinson nell'isola dei corsari e la scena è quella in cui le avances piuttosto
sgradite di una tigre vengono respinte dai due alani della famiglia. La
sequenza ovviamente mi fece una grande impressione, senza dubbio perché
ero cresciuto in compagnia di alani. La scena era stata realizzata con l'aiuto
di un addestratore di animali, William Koehler. Il mio io di sei anni non
avrebbe mai pensato - ma ne sarebbe stato senza dubbio contento - che
vent'anni dopo avrei utilizzato i sistemi di Koehler per addestrare un lupo.
Questo accadde grazie a una delle fortuite coincidenze che hanno
costellato la mia vita. Pochi mesi prima dell'arrivo di Brenin, nella
biblioteca dell'università dell'Alabama, mi ero imbattuto in un libro: Adam's
Task di Vicki Hearne. La Hearne era un'addestratrice di animali che
coniugava la sua professione con un interesse amatoriale per la filosofia.
Non ci sono molte persone del genere in giro. Va detto che valeva
sicuramente di più come addestratrice che come filosofa, in quanto la parte
filosofica del libro sembrava consistere perlopiù in una versione piuttosto
confusa della filosofia del linguaggio sviluppata dall'austriaco Ludwig
Wittgenstein. Ciononostante, trovai il testo interessante e suggestivo. Se per
quanto riguardava la filosofia del linguaggio la Hearne sembrava avere le
idee non troppo chiare, su un punto, invece, le aveva chiarissime: William
Koehler era di gran lunga il migliore addestratore di cani. Perciò, quando
Brenin entrò in scena, sapevo già dove indirizzarmi: me lo imponeva se non
altro la solidarietà tra filosofi.
Detto tra noi, Koehler era un po’ uno psicopatico. E, in alcune occasioni,
il suo metodo di addestramento comporta certi eccessi che personalmente
non adotterei mai. Per esempio, se il vostro cane continua a scavare buche
in giardino, in base alle istruzioni di Koehler bisogna riempire la buca di
acqua e quindi tuffarvi la testa dell'animale. E poi - attenzione! - ripetere
l'operazione per cinque giorni, indipendentemente dal fatto che il cane abbia
scavato altre buche oppure no. L'idea è suscitare nell'animale una forte
avversione per le buche. Il metodo si basa su solidi principi
comportamentali e quasi certamente funziona. È presumibilmente il tipo di
metodo che ad Abu Ghraib i militari americani hanno adottato per torturare
i rivoltosi e magari anche qualche sfortunato spettatore. (Nel libro di
Koehler non ho trovato alcun riferimento al waterboarding applicato ai cani,
ma sospetto che l'avrebbe approvato.)
Il consiglio di Koehler mi sarebbe stato certamente d'aiuto nella fase di
scavo delle tane di Brenin - una «fase» durata quasi quattro anni -, durante
la quale il mio giardino, e non solo il mio, venne trasformato in qualcosa di
simile alla Somme. Ma non ho mai avuto il coraggio di seguirlo: ho sempre
tenuto molto di più a Brenin che al giardino. E in ogni caso quello scenario
da guerra di trincea aveva un certo fascino, che dopo un po’ arrivai ad
apprezzare.
Tuttavia, eliminati gli eccessi, scoprirete che il metodo Koehler, in
generale, si basa su un principio molto semplice ed efficace: il vostro cane/
lupo dev'essere costretto a guardarvi. La chiave dell'addestramento di
Brenin - e sarò eternamente grato a Koehler per avere avuto ragione su
questo punto - fu di convincerlo, in modo calmo, ma inesorabile, che
doveva guardarmi. Fare in modo che l'animale guardi quello che state
facendo, e quindi capisca da voi che cosa deve fare, è la pietra angolare di
ogni regime di addestramento, che l'animale sia un lupo o un cane. Ma è
particolarmente importante nel caso di un lupo, con il quale è più difficile
riuscire nell'impresa. Per i cani è un comportamento naturale, ma i lupi
devono essere persuasi a adottarlo. Le ragioni di questa differenza stanno
nelle rispettive storie.
Negli ultimi decenni sono stati effettuati diversi studi per stabilire se sia
più intelligente il lupo o il cane, studi che, a mio avviso, convergono su
un'unica risposta: nessuno dei due. L'intelligenza dei lupi e quella dei cani
sono diverse perché sono state plasmate da ambienti diversi e sono, quindi,
la risposta a necessità ed esigenze diverse. In linea di massima, il quadro è il
seguente: i lupi se la cavano meglio dei cani in azioni legate alla soluzione
di problemi, mentre i cani se la cavano meglio dei lupi in azioni legate
all'addestramento.
Un'azione legata alla soluzione di problemi implica che l'animale si
impegni in una qualche forma di ragionamento mezzo- fine. Per esempio,
Harry Frank, professore di psicologia all'università del Michigan- Flint,
riferisce che uno dei suoi lupi aveva imparato ad aprire la porta per uscire
dal canile nel recinto esterno. La maniglia doveva essere spinta verso la
porta e poi ruotata. Frank afferma che un cane - un Alaskan Malamute - che
viveva nella stessa struttura, pur avendo osservato quell'operazione
parecchie volte al giorno per sei anni, non aveva mai imparato a farla. Un
incrocio lupo- malamute acquisì la tecnica dopo due settimane. Ma una lupa
imparò ad aprire la porta dopo averlo visto fare dall'incrocio una sola volta,
e non adottò la stessa tecnica: l'incrocio si serviva del muso, lei delle zampe.
Ciò sembrerebbe dimostrare che la lupa aveva capito la natura del problema
e quello che si doveva fare per risolverlo, e che non stava semplicemente
imitando il comportamento dell'incrocio.
I test hanno confermato che i lupi sono superiori ai cani in questo genere
di ragionamento mezzo- fine. I cani però risultano superiori ai lupi nelle
prove che richiedono istruzione o addestramento. In un test di questo tipo,
per esempio, ai cani e ai lupi veniva richiesto di effettuare una svolta a
destra ogni volta che una luce lampeggiava. I cani potevano essere
addestrati a farlo, ma i lupi evidentemente no, almeno non per la durata dei
test.
Nel caso dell'uscita dal canile il problema da risolvere è di tipo
meccanico. Il fine desiderato è uscire nel recinto e c'è un unico mezzo per
raggiungerlo: la maniglia della porta dev'essere manovrata nel modo e
nell'ordine giusto. Nel test di addestramento, invece, non c'è alcuna
relazione meccanica tra la luce lampeggiante e la svolta a destra. Perché a
destra e non a sinistra? E perché una svolta? Il collegamento tra la luce
lampeggiante e il conseguente comportamento richiesto è del tutto
arbitrario.
È facile individuare il motivo di questa differenza tra lupi e cani. I lupi
vivono in un mondo meccanico. Per esempio, se c'è un albero caduto in
equilibrio precario su un masso, il lupo riesce a capire che camminarci sotto
è una cattiva idea. Ciò succede perché, in passato, i lupi che non riuscivano
a capirlo erano di gran lunga più esposti degli altri a incidenti causati dalla
caduta di oggetti. Di conseguenza i lupi che non capivano il rapporto tra
l'albero, il masso e il possibile pericolo avevano meno probabilità di
trasmettere il loro patrimonio genetico di quelli che invece lo capivano. In
questo senso, l'ambiente del lupo seleziona in base all'intelligenza
meccanica.
Prendiamo ora in esame il mondo del cane. Il cane vive in quello che per
lui è un mondo magico, non meccanico. Quando sono in viaggio per lavoro,
telefono a casa per parlare con mia moglie, Emma. La nostra Nina, un
incrocio tra un pastore tedesco e un malamute, si eccita moltissimo quando
sente la mia voce e comincia ad abbaiare e a saltare per tutta la casa. E se
Emma le porge il ricevitore, lei lo lecca con entusiasmo. I cani si trovano a
loro agio con la magia. Chi avrebbe mai pensato che la voce del maschio
alfa del branco potesse materializzarsi dal nulla ogni volta che qualcuno
solleva quel coso dalla forma strana sulla scrivania? E chi avrebbe mai
pensato che toccare un interruttore sulla parete potesse trasformare il buio in
luce? Il mondo del cane non ha senso meccanico. E, anche se l'avesse, i
mezzi per controllarlo esulano dalle possibilità del cane, il quale non può
arrivare all'interruttore, non sa digitare un numero di telefono e non sa
inserire una chiave nella serratura.
A questo punto devo stare attento a non lasciarmi trasportare
dall'entusiasmo, altrimenti correreste il rischio di una conferenza sulla
embodied and embedded cognition, la cognizione incorporata e inclusa. In
ambito professionale la mia notorietà è forse legata al fatto che sono uno
degli artefici di una visione della mente che la considera sostanzialmente
incorporata e inclusa nel mondo che la circonda. Le attività mentali non
hanno meramente luogo nella nostra testa, non sono meri processi cerebrali,
ma coinvolgono anche le attività che svolgiamo nel mondo: in particolare la
manipolazione, la trasformazione e lo sfruttamento di strutture ambientali
pertinenti. E la conferenza a questo punto è già in pieno svolgimento.
Precursore di questa visione fu lo psicologo sovietico Lev Vygotskij che,
con il collega Anton Luria, dimostrò quanto i processi del ricordo e altre
attività mentali fossero cambiati con lo sviluppo di uno dispositivo esterno
per lo stoccaggio delle informazioni. La notevole memoria naturale delle
culture primitive si indebolisce a mano a mano che ci si affida sempre di più
alla scrittura come mezzo per conservare i propri ricordi. Nella cronologia
dell'evoluzione lo sviluppo della scrittura è ovviamente un fenomeno molto
recente, il cui effetto sulla memoria e su altre attività mentali è stato,
nondimeno, molto profondo.
Per farla breve, il cane è stato incluso in un ambiente molto diverso da
quello del lupo e di conseguenza i suoi processi psicologici e le sue capacità
si sono sviluppati in modi molto diversi. In particolare, il cane è stato
costretto a contare su di noi e, cosa ancora più importante, ha sviluppato la
capacità di usarci per risolvere i suoi problemi, cognitivi e non. Per i cani
noi siamo utili dispositivi per l'elaborazione delle informazioni. Noi uomini
siamo parte della mente estesa del cane. Che cosa fa un cane quando si
trova di fronte a un problema meccanico che non riesce a risolvere? Si
procura il nostro aiuto. Proprio mentre sto scrivendo questa frase, mi viene
offerto un esempio, semplice, ma efficace, di questo principio. Nina vuole
uscire in giardino. Non essendo capace di aprire la porta, le si piazza
davanti e mi guarda. Se non l'avessi notata, avrebbe emesso un piccolo
guaito. Ragazza intelligente! L'ambiente del lupo seleziona in base
all'intelligenza meccanica. Ma l'ambiente del cane seleziona in base alla
capacità di usare noi uomini. E per usarci i cani devono essere in grado di
leggerci. Quando un cane intelligente deve affrontare un problema
insolubile, la prima cosa che fa è guardare il volto del suo padrone:
culturalmente inserito in un mondo di magia, trova la cosa naturale. Ma a un
lupo non succede la stessa cosa. La chiave per addestrare un lupo è
convincerlo a fare qualcosa.
Naturalmente tutto ciò è una razionalizzazione a posteriori. All'epoca non
ne sapevo niente. Brenin era già un vecchio lupo, quando ho pubblicato il
mio primo libro su tali argomenti. E sto ancora cercando di affinare questa
visione. Ma è interessante notare come una teoria che avrei sviluppato solo
molti anni dopo mi abbia consentito di capire esattamente la ragione per cui
il metodo che avevo scelto per addestrare il mio lupo era stato così efficace.
E non posso fare a meno di ritenere che il processo di addestramento mi
abbia fatto pensare, a un livello inconscio, nel modo che poi mi ha
consentito di sviluppare la teoria. Se le cose stanno così, potrebbe trattarsi di
una di quelle coincidenze fortuite di cui parlavo.
Seguendo il metodo Koehler, dunque, cominciai l'addestramento di
Brenin comprando una corda di cinque metri, che adattai a guinzaglio.
Brenin e io andavamo nel grande giardino dietro casa, dove piazzavo tre
segnali ben visibili: in questo caso, lunghi paletti di legno conficcati nel
terreno. Fissavo la corda al collare a strozzo di Brenin. Non permettete a
nessuno di dirvi che i collari a strozzo sono crudeli: al contrario, sono
essenziali per un addestramento efficace perché comunicano al cane
esattamente ciò che gli viene richiesto. Il messaggio trasmesso dai collari
normali è di gran lunga meno preciso e, conseguentemente, l'addestramento
richiederebbe più tempo. Camminavo passando da un paletto all'altro, che
sceglievo a caso e decidendo di volta in volta i tempi. Lo facevo rimanendo
impassibile, senza guardare Brenin o perfino ignorandone la presenza.
Per realizzare un programma di addestramento intelligente e riuscito
dovete mettervi sempre nei panni del vostro cane. È ironico, e per me assai
divertente, che alcuni filosofi continuino a chiedersi se gli animali abbiano
una mente, se possano pensare, credere, ragionare, addirittura provare
sentimenti. Una volta o l'altra dovrebbero alzare il naso dai loro libri e
provare a addestrare un cane. Il programma di addestramento vi sorprenderà
sempre con qualcosa di inaspettato. Il vostro cane non farà ciò che si
suppone faccia e voi non riuscirete a trovare la risposta nel libro, neppure in
un testo approfondito ed esauriente come quello di Koehler. A quel punto
non vi resterà che provare a pensare come il vostro cane. E se lo farete, in
genere riuscirete a capire quello che dovete fare.
Mettetevi nei panni di Brenin. Se si lancia in una direzione, ha a
disposizione cinque metri di corda per correre a perdifiato, ma poi viene
strattonato e bloccato bruscamente. L'effetto risulta esasperato se lui scatta
nella direzione opposta a quella in cui io sto camminando. Presto, molto
presto, lui si rende conto che, se vuole evitare questa esperienza sgradevole,
deve stare attento a dove sto andando. All'inizio cerca di osservarmi dalla
distanza limite del guinzaglio. Ma questo lo espone alla possibilità che io
effettui una brusca svolta, allontanandomi da lui, cosa che poi faccio. Così
Brenin mi si avvicina. Adesso cerca di camminare poco più avanti di me,
ma abbastanza indietro da poter vedere con la coda dell'occhio che cosa sto
facendo. Questo, a quanto pare, è assolutamente tipico. Ho corretto tale
comportamento andandogli improvvisamente addosso e colpendolo nelle
costole con un ginocchio, non con cattiveria ma con impassibilità. A questo
punto Brenin comincia a camminarmi dietro: ragazzo intelligente. Ho
corretto anche questo comportamento fermandomi di colpo e camminando
all'indietro, possibilmente pestandogli le zampe. Comprensibilmente, adesso
Brenin cerca di camminare restando il più lontano possibile da me. Ma si
ritrova di nuovo alla massima estensione del guinzaglio, o quasi, e ciò lo
espone a una mia brusca svolta, che naturalmente effettuo subito. E così
siamo di nuovo al punto di partenza. Tutto questo viene eseguito in silenzio
e tranquillamente. È questo l'aspetto calmo, ma inesorabile, del metodo
Koehler. Non c'è niente di personale negli errori di un lupo e non dovete
mai arrabbiarvi con lui.
In breve Brenin esaurisce tutti i modi possibili per non collaborare con
me. Non gli resta che la collaborazione. E così finalmente cammina al mio
fianco.
Alcuni - tra cui dei possessori di lupi - mi dicevano che era impossibile
insegnare a un lupo a camminare al guinzaglio. Si trattava di quel genere di
persone che tengono il proprio lupo, o incrocio lupo- cane o cane, rinchiuso
in un recinto nel giardino dietro casa. E questo, sono convinto, è un atto
criminale per il quale sarebbe opportuna una pena detentiva (cosa che
senz'altro aiuterebbe quelle persone a mettersi nei panni del loro lupo). Io,
in realtà, impiegai non più di due minuti per convincere Brenin a
camminare al guinzaglio. Altri mi dicevano che era impossibile insegnare a
un lupo a camminare al fianco del padrone. Io ci impiegai dieci minuti.
Quando ci fummo impadroniti entrambi delle tecniche fondamentali della
passeggiata al guinzaglio, insegnare a Brenin a camminare senza fu
sorprendentemente facile, perché - cosa fondamentale - lui capiva già quello
che ci si aspettava facesse. All'inizio lavorammo con il guinzaglio ancora
attaccato al collo di Brenin, ma senza che io lo tenessi. Poi, superata con
successo tale fase, passammo all'eliminazione totale del guinzaglio. A
questo punto l'uso di un collare a scaletta è essenziale. Si tratta di una
versione più piccola del collare a strozzo, anche se io in effetti mi servii di
un collare a strozzo per cani di piccola taglia. Se Brenin si allontanava dal
mio fianco, io facevo tintinnare il collare e poi glielo scagliavo contro. Il
dolore del colpo era notevole, ma svaniva in fretta. E, ovviamente, non
provocava alcun danno permanente. Come faccio a saperlo? Perché,
essendo un po’ diffidente su questa parte del metodo Koehler, prima di
metterla in pratica chiesi a un amico di colpirmi due o tre volte con il
collare. In pochissimo tempo Brenin arrivò ad associare il tintinnio del
collare alla successiva esperienza spiacevole e non ci fu più bisogno di
colpirlo. Impiegai quattro giorni (due lezioni di trenta minuti al giorno) a
addestrarlo a camminare al mio fianco senza guinzaglio.
Insegnai a Brenin solo ciò che ritenevo avesse bisogno di sapere. Non vidi
mai motivo di insegnargli esercizi particolari. Se non aveva voglia di
distendersi a pancia in su, perché avrei dovuto imporgli di farlo? Non mi
presi neppure il disturbo di insegnargli a obbedire all'ordine di mettersi a
sedere: che stesse in piedi o seduto, per quanto mi riguardava, era una sua
decisione personale. Camminare al mio fianco divenne rapidamente il suo
comportamento standard. C'erano solo altre quattro cose che doveva sapere:
Vai pure e annusa in giro: «Go on!», vai. Rimani dove sei: «Stay!»,
fermo. Vieni da me: «Here!», qui.
E la più importante di tutte: Non toccare: «Out!», proibito.
Pronunciavo ogni comando con voce gutturale, come un ringhio. In
seguito lavorammo sugli schiocchi delle dita e sui segnali con le mani. Per
la fine dell'estate Brenin era abbastanza - non direi completamente, ma
quasi - padrone di questo basilare linguaggio verbale e non verbale.
Sono eccessivamente compiaciuto di ciò, lo so. Ma l'addestramento è
stato il più grande regalo che io abbia mai fatto a Brenin, un esempio
luminoso di una delle poche cose che ho fatto davvero bene in vita mia.
Alcuni pensano che addestrare cani - e, a maggior ragione, lupi - sia
crudele, come se si spezzasse la loro vitalità o li si costringesse a una
permanente sottomissione. Ma lungi dal sentire la propria vitalità spezzata,
quando un cane o un lupo sa con esattezza che cosa ci si aspetta e che cosa
non ci si aspetta da lui, la sua sicurezza di sé e, quindi, la sua compostezza
aumentano enormemente. È una dura verità il fatto che, come disse
Friedrich Nietzsche, coloro che non sanno darsi disciplina troveranno
qualcun altro che lo farà per loro. E, nei confronti di Brenin, avevo la
responsabilità di essere quel qualcuno. Ma il rapporto tra disciplina e libertà
è profondo e importante: lungi dall'essere il contrario della libertà, la
disciplina è ciò che rende possibili le più alte forme di libertà. Senza
disciplina non c'è autentica libertà, c'è solo licenza.
Nei dieci anni seguenti a volte, durante le nostre passeggiate, ci capitava
di incontrare persone che tenevano costantemente al guinzaglio il proprio
cane - e spesso si trattava di cani molto simili ai lupi, come gli husky o i
malamute -sostenendo che altrimenti l'animale si sarebbe allontanato di
corsa e non sarebbero più riusciti a rimettergli il guinzaglio o addirittura a
rivederlo. Può darsi che fosse vero. Ma di sicuro non doveva essere
necessariamente così. In seguito, all'epoca in cui vivevamo in Irlanda,
Brenin e io passeggiavamo tutti i giorni in campi dove pascolavano greggi
di pecore. Brenin era senza guinzaglio. Devo ammettere che la prima volta
ero un po’ nervoso, anche se forse non quanto lo erano le pecore. Per tutta
la durata della nostra convivenza non ho mai dovuto alzare la voce con
Brenin né ho mai dovuto picchiarlo. Se c'è una cosa di cui sono sicuro, è
che se un lupo può essere addestrato a ignorare totalmente la sua preda
archetipica, allora qualsiasi cane può essere addestrato a venire da voi
quando lo chiamate.
Come vedrete, Brenin avrebbe vissuto quella che, per un lupo, è quasi
certamente una vita senza precedenti. Questo perché, avendone la
possibilità, l'ho sempre portato con me ovunque andassi. Devo ammettere
che la motivazione iniziale è stata la capacità di Brenin di distruggere la
casa se l'avessi lasciato incustodito per una sola mattina mentre facevo
lezione. Ma la possibilità di vivere insieme in modo significativo - invece di
rinchiudere Brenin nel giardino sul retro e dimenticarmelo là - è stata
garantita dal fatto che il mio lupo aveva imparato un linguaggio. Tale
linguaggio ha dato alla sua vita una struttura che altrimenti non avrebbe
potuto avere e, di conseguenza, ha rivelato una serie di possibilità che
altrimenti la sua vita non avrebbe avuto. Bre-nin ha appreso un linguaggio
e, dato che avrebbe vissuto in un mondo umano, più magico che meccanico,
quel linguaggio l'ha reso libero.
Una vita senza precedenti, è ovvio, non è necessariamente una buona vita.
Talvolta mi è stato chiesto: come hai potuto fare una cosa del genere? Come
avevo potuto togliere un animale dal suo ambiente naturale e costringerlo a
vivere una vita che lui doveva trovare del tutto innaturale? Era quasi sempre
un particolare tipo di persona a rivolgermi questa domanda: un accademico
liberal della classe media, con pretese ecologiste e nessuna esperienza o
conoscenza sul possesso di cani. Ma screditare la persona che pone la
domanda, piuttosto che considerare la domanda in sé, è ciò che in filosofia
viene definita «fallacia ad hominem». La domanda in sé è interessante e
dev'essere affrontata.
Prima di tutto potrei sottolineare, penso, che Brenin era nato in cattività e
che, senza l'indispensabile addestramento da parte dei genitori, sarebbe
rapidamente morto, se fosse stato «liberato» nel suo ambiente naturale. Ma
questa risposta non mi porta molto lontano. Pagando denaro in cambio di
Brenin, io perpetuavo un sistema che vedeva allevare lupi in cattività, lupi
che venivano quindi privati della possibilità di agire come la natura aveva
inteso. Perciò la domanda è: come potevo giustificare un'azione simile?
Credo che alla base di tale interrogativo ci sia questa convinzione: un
lupo può sentirsi davvero felice o realizzato solo facendo ciò che la natura si
prefiggeva che facesse, e cioè impegnarsi nei suoi comportamenti naturali,
come cacciare e interagire con gli altri membri del branco. Tale asserzione
può sembrare vera fino all'ovvietà, ma in realtà è difficile da definire. C'è
innanzitutto l'idea piuttosto complessa di ciò che la natura si prefiggeva.
Che cosa si prefigge la natura per un lupo? O, peraltro, che cosa si prefigge
la natura per un umano? O addirittura, in che senso la natura può prefiggersi
qualcosa? Nella teoria dell'evoluzione a volte parliamo, metaforicamente, di
ciò che la natura si prefigge, ma il discorso in sostanza si riduce a questo: la
natura «si prefigge» che le creature trasmettano i loro geni. L'unico senso
concreto che può essere attribuito all'idea delle intenzioni della natura si
fonda sul concetto di successo genetico.
La caccia e la vita nel branco sono strategie usate da animali come i lupi
al fine di soddisfare questo fondamentale imperativo biologico. Perfino i
lupi, tuttavia, possono adottare strategie diverse. A un certo punto della loro
storia, per ragioni ancora poco chiare, alcuni lupi si aggregarono ai gruppi
umani e diventarono cani. Nella misura in cui la natura può avere
intenzioni, questa fu una delle sue intenzioni, né più né meno del fatto che i
lupi restassero lupi.
C'è un utile trucco che ho imparato dalla filosofia: quando qualcuno fa
un'asserzione, cerca di capire quali sono i presupposti di tale asserzione.
Perciò, se qualcuno sostiene che i lupi possono essere felici solo
impegnandosi in comportamenti naturali come cacciare e interagire con il
branco, quali sono i presupposti di questa affermazione? Io credo che, se
esaminiamo i presupposti, ciò che troviamo, almeno nella maggior parte dei
casi, sono espressioni dell'arroganza umana.
Jean- Paul Sartre tentò di definire l'idea dell'essere umano affermando che
per l'uomo, e per l'uomo soltanto, l'esistenza precede l'essenza. È questo il
principio alla base del movimento filosofico che diventò famoso come
esistenzialismo. L'essere dell'uomo, sosteneva Sartre, è essere- per- sé, a
differenza dell'essere di qualsiasi altra cosa, che è meramente essere- in- sé.
Per dirla con Sartre, l'uomo è il solo essere che possiede il proprio poter
essere. Ciò che intendeva dire è che l'uomo deve scegliere come vivere la
propria vita e non può contare su regole o principi predati - religiosi, morali,
scientifici o altro - che gli dicano come farlo. Adottare un particolare
principio, una morale o una religione, per esempio, è un'espressione di
scelta. Per cui, a prescindere da quello che fate e da come vivete, in ultima
analisi si tratterà sempre di un'espressione della vostra volontà. L'uomo,
secondo Sartre, è condannato a essere libero.
L'altra faccia della medaglia è che, per Sartre, tutto il resto non è libero.
Le altre cose, perfino altre cose viventi, possono fare solo ciò che sono state
progettate a fare. Se millenni di evoluzione hanno fatto dei lupi animali
cacciatori che vivono in branco, allora quella per loro sarà l'unica forma di
vita praticabile. Un lupo non possiede un proprio poter essere. Un lupo può
essere solo quello che è. Il presupposto implicito nella nostra domanda come hai potuto fare questo a Brenin? - allora è questo: per un lupo,
l'essenza precede l'esistenza.
Naturalmente non è chiaro se Sartre avesse ragione sulla libertà umana.
Ma ciò che mi interessa è quest'idea più generale di flessibilità esistenziale.
Perché l'uomo, e l'uomo soltanto, dovrebbe essere in grado di vivere la
propria vita in una miriade di modi diversi, mentre ogni altra creatura è
condannata a essere schiava del suo retaggio biologico, una mera serva della
sua storia naturale? Su che cosa può basarsi questa idea, se non su una
forma residua di arroganza umana? Un paio di anni fa, la sera prima di un
volo all'alba per Atene, me ne stavo seduto nel giardino del bar di un
albergo non lontano dall'aeroporto di Gatwick. A un certo punto mi si
avvicinò una volpe, si sedette come un cane a circa un metro da me e
aspettò paziente che le lanciassi qualche pezzetto di cibo, cosa che
naturalmente feci. La cameriera mi informò che la volpe era ormai
un'istituzione di quell'albergo e, a quanto pareva, anche di altri. Provate a
dire a quella volpe che deve impegnarsi nel suo comportamento naturale di
dare la caccia ai topi. Provate a spiegarle che la sua essenza precede la sua
esistenza e che, a differenza di me, non possiede il suo poter essere.
Sminuiamo la volpe, se pensiamo che il suo comportamento naturale si
limiti alla caccia ai topi. Sminuiamo la sua intelligenza e la sua
intraprendenza, se adottiamo una concezione così restrittiva del suo essere,
per dirla con Sar-tre. La cosa naturale per la volpe è il continuo
cambiamento di pari passo con le vicissitudini della storia e della fortuna. E,
di conseguenza, anche questo è l'essere della volpe, ciò che la volpe è.
Non possiamo, è ovvio, liquidare semplicemente i vincoli della storia
naturale. La volpe non sarebbe né felice, né realizzata, se dovesse stare
seduta giorno dopo giorno dentro una gabbia. Né lo sarebbe un lupo. Né lo
sarei io. Tutti noi abbiamo certi bisogni basilari lasciatici in eredità dalla
nostra storia. Ma sarebbe un non sequitur supporre che il lupo e la volpe
siano mere marionette biologiche i cui fili vengono manovrati dalla loro
storia. La loro essenza può vincolare la loro esistenza, ma non può fissarla o
determinarla. Questo vale per la volpe e per il lupo, così come per noi esseri
umani. Nella vita ognuno di noi gioca la mano di carte che gli è stata data.
A volte è così brutta che non possiamo utilizzarla in alcun modo. Ma a volte
non lo è e, in quel caso, possiamo giocarla bene o male. La mano toccata
alla volpe era un rapido sconfinamento urbano da quello che ci piace
pensare come il suo habitat naturale (anche se credo che sia passato molto,
molto tempo da quando questa espressione aveva un significato reale).
Penso che la mia amica volpe stesse giocando la sua mano piuttosto bene, a
giudicare dal modo in cui si spostava da un tavolo all'altro - fermandosi
però solo là dove c'era da mangiare - e si sedeva ad aspettare pazientemente
finché non riceveva l'inevitabile offerta di cibo.
Anche a Brenin è toccata una mano particolare e io credo che l'abbia
giocata molto bene. La mano, comunque, non era poi così male. Brenin
sarebbe potuto finire - come molti lupi e incroci di lupo affidati a padroni
incapaci di gestirli -in una gabbia nel cortile dietro casa. Invece ha avuto
una vita varia e, mi piace pensare, stimolante. Ho fatto in modo che potesse
fare almeno una lunga passeggiata ogni giorno, e il suo addestramento gli
ha permesso di evitare il guinzaglio. Quando le circostanze lo consentivano,
ho fatto sì che avesse la possibilità di impegnarsi in comportamenti naturali,
come cacciare e interagire con altri canidi. Ho fatto del mio meglio perché
non si annoiasse mai, nonostante dovesse assistere alle mie lezioni.
Supporre che Brenin non fosse felice solo perché non faceva quello che
fanno i lupi in natura è poco più di una banale forma di arroganza umana e
sminuisce la sua intelligenza e flessibilità.
Brenin, naturalmente, seguiva le orme dei suoi antenati di circa
quindicimila anni fa rispondendo al richiamo degli esseri civilizzati che
spinse quegli antenati a un rapporto simbiotico, e forse indistruttibile, con la
più potente e crudele delle grandi scimmie. In termini di successo genetico
basta pensare al numero di lupi oggi nel mondo rispetto al numero di cani approssimativamente 400.000 contro 400 milioni - per rendersi conto che si
trattò di una strategia straordinariamente efficace. E supporre che far ciò sia
innaturale per un lupo tradisce una visione abbastanza superficiale di quello
che è naturale. Se a questo si aggiungono l'aspettativa di vita piuttosto breve
dei lupi nel loro ambiente naturale - sette anni sono già tanti - e il tipo di
morte solitamente molto sgradevole che gli tocca, allora forse il richiamo
degli esseri civilizzati non è stato un disastro totale.
Credo che il metodo Koehler che ho usato per addestrare Brenin abbia in
definitiva avuto tanto successo perché rispecchia una certa visione della
natura esistenziale dei cani e dei loro fratelli selvatici, un aspetto forse
nascosto dalla mia caricaturale sottolineatura di certi suoi eccessi. Ciò che
anima il metodo Koehler è una sorta di fede. È la fede nell'idea che l'essenza
di un cane, o di un lupo, non precede la sua esistenza. È la fede nell'idea che
un cane, o un lupo, possiede il suo poter essere esattamente come un uomo.
Per questo bisogna accordare a qualsiasi cane, o lupo, un certo tipo di
rispetto e, conseguentemente, un certo tipo di diritto: un diritto morale. Per
dirlo con le parole di Koehler, è «il diritto alle conseguenze delle sue
azioni». Un lupo non è un burattino di carne che segue ciecamente i dettami
della sua eredità biologica, perlomeno non lo è più di quanto lo siano gli
esseri umani. Un lupo è adattabile, anche se non infinitamente adattabile
(ma chi o che cosa lo è?). Un lupo, non meno di un uomo, può giocare la
mano che gli è stata data. E, ciò che è più importante, voi potete aiutarlo a
giocarla. E a mano a mano che migliora nel gioco, il lupo diventa sempre
più sicuro di sé. Gli piace quello che impara e vuole imparare di più.
Diventa più forte e, di conseguenza, più felice.
Brenin era uno schiavo? Era uno schiavo perché io avevo stabilito i
parametri della sua educazione, determinando così i contorni del suo agire
futuro? Sette anni di scuola secondaria unificata, seguiti da tre anni
all'università di Manchester e da due a quella di Oxford - anni in cui i
parametri della mia educazione sono stati senza dubbio stabiliti da altri hanno fatto di me uno schiavo? Se Brenin è stato uno schiavo, allora lo sono
stato anch'io. Ma, se è così, che cosa significa la parola «schiavo»? Se tutti
noi siamo schiavi, chi è il padrone? E se non c'è un padrone, allora chi è lo
schiavo?
Forse questa argomentazione non è solida quanto credo. Forse il mio
giudizio è offuscato da tutto ciò che Brenin ha fatto per me. Ci sono persone
che adottano un cane e, dopo che la novità si è esaurita, sostanzialmente lo
piantano nel giardino dietro casa e se ne dimenticano. A quel punto il cane
diventa solo un noioso dovere. Bisogna dargli da mangiare e da bere e
questa è la sola interazione tra proprietario e cane: un compito tedioso,
qualcosa che il proprietario non ha voglia di fare, ma che ritiene suo dovere
fare. Alcuni pensano perfino di essere buoni padroni perché danno
regolarmente da mangiare e da bere ai loro animali. Se è così che la pensate,
perché prendersi il disturbo di avere un cane? Non ne ricaverete nulla, se
non l'irritazione quotidiana di dover fare qualcosa che in realtà non avete
voglia di fare. Quando, invece, un cane vive in casa con voi, quando si
inserisce nella vostra vita in modo così completo da diventarne parte, allora
si scopre la gioia. Quello con un cane è come un qualsiasi altro rapporto: ne
ricaverete solo ciò che sarete disposti a mettervi dentro, a lasciarvi entrare.
Lo stesso vale per un lupo. Ma poiché un lupo non è un cane - poiché un
lupo ha eccentricità che un cane non ha - dovrete impegnarvi molto più
duramente per farlo entrare nella vostra vita.
Brenin e io siamo stati inseparabili per undici anni. Cambiavano le case,
cambiava il lavoro, cambiavano i paesi e addirittura i continenti, e gli altri
miei rapporti andavano e venivano - perlopiù andavano -, ma Brenin c'era
sempre: a casa, sul lavoro, nel tempo libero. Era la prima cosa che vedevo la
mattina quando mi svegliavo, soprattutto perché era lui a svegliarmi verso
l'alba, con una grande leccata umida sulla faccia: un'incombente presenza
fatta di alito pesante e lingua ruvida, incorniciata dalla luce incerta del
primo mattino. Questo nei giorni buoni. In quelli cattivi mi svegliava
facendomi cadere in faccia il volatile che aveva catturato e ucciso in
giardino. (Prima regola della convivenza con un lupo: aspettarsi sempre
l'inaspettato.) La mattina si sdraiava sotto la scrivania mentre io scrivevo.
Passeggiava o correva con me quasi ogni giorno. Nel pomeriggio stava in
classe con me mentre facevo lezione. E la sera rimaneva seduto a tenermi
compagnia mentre bevevo il mio Jack Daniel's.
Mi faceva piacere averlo vicino, questo è certo. Ma non c'era solo questo.
Molto di ciò che ho imparato su come vivere e comportarmi l'ho imparato
durante quegli undici anni. Molto di ciò che so della vita e del suo
significato l'ho imparato da Brenin. Che cosa significa essere un uomo io
l'ho imparato da un lupo. E Brenin si è inserito in modo così totale in ogni
sfaccettatura della mia vita, le nostre vite sono diventate così saldamente
intrecciate che sono arrivato a comprendere, perfino a definire, me stesso
nei termini del mio rapporto con lui.
C'è chi sostiene che tenere un animale da compagnia sia sbagliato perché
l'animale diventa una tua proprietà. Tecnicamente suppongo che sia vero. In
un qualche senso legale si potrebbe dire che sono stato il proprietario di
Bre-nin, anche se, dato che per buona parte della sua vita non ho mai avuto
alcun tipo di documento che lo comprovasse, non si capisce come avrei
potuto dimostrarlo in un'aula di tribunale. In ogni caso tale obiezione non
mi ha mai convinto perché, in realtà, si tratta di un non sequitur. Presuppone
che, se sei il proprietario di qualcosa in senso legale, allora questo è l'unico
rapporto che potrai mai avere con quel qualcosa, o, quantomeno, la
proprietà sarà il rapporto dominante che avrai con esso. In effetti, però, ci
sono scarsi motivi per crederlo.
Fondamentalmente, Brenin non era una mia proprietà e di certo non era il
mio animale da compagnia. Era mio fratello. A volte, e sotto certi aspetti,
era il mio fratello minore. In quelle occasioni, e per quei particolari aspetti,
io ero il suo tutore e lo proteggevo da un mondo che lui non capiva e che
non si fidava di lui. In quelle occasioni dovevo decidere che cosa dovevamo
fare e imporre la mia decisione, che Brenin fosse d'accordo oppure no. A
questo punto alcuni miei amici del movimento per i diritti degli animali
cominceranno a lamentarsi degli impari rapporti di potere e del fatto che,
siccome non poteva dare il suo consenso alle mie decisioni, Brenin era di
fatto mio prigioniero. Ma anche in questo caso l'accusa non sembra molto
plausibile. Immaginate che questo mio fratello sia un uomo anziché un lupo.
Se fosse troppo giovane per capire il mondo e le conseguenze delle sue
azioni in quel mondo, non potrei semplicemente abbandonarlo a tali
conseguenze. Come abbiamo visto, Koehler sostiene il diritto del cane alle
conseguenze delle sue azioni. Sono d'accordo, ma, naturalmente, non si
tratta di un diritto assoluto. È ciò che i filosofi definiscono un «diritto prima
facie», un diritto, cioè, che può essere annullato in determinate circostanze.
Se il vostro cane stesse per finire sotto un'auto, magari per avere ignorato le
vostre istruzioni, non gli permettereste semplicemente di subire le
conseguenze delle sue azioni. Al contrario, fareste del vostro meglio per
evitargliele. Esattamente come se sotto l'auto stesse per finire il vostro
fratello più piccolo. Nei limiti imposti dal buonsenso e dalle regole generali
del vivere civile, e quando le conseguenze non fossero troppo gravi o
debilitanti, permetterei al mio fratello minore di subire le conseguenze delle
sue azioni, o di goderne, perché solo così potrebbe imparare. Ma in altre
circostanze sarei tenuto a proteggerlo nel miglior modo possibile, anche se
lui non accettasse la mia protezione. Dire che questo lo renderebbe mio
prigioniero è, a mio parere, il risultato di una determinazione
eccessivamente emotiva a ignorare la distinzione fra tutela e prigionia.
Il concetto di tutela, piuttosto che quello di proprietà, sembra offrire il
modo più plausibile di comprendere il rapporto primario tra le persone
(perlomeno quelle perbene) e i loro compagni animali. Ma, con Brenin
neppure questo concetto sembra funzionare del tutto. E ciò lo ha distinto, e
in modo deciso, da qualsiasi cane abbia mai conosciuto. Solo alcune volte, e
in determinate circostanze, Brenin è stato il mio fratello minore. Altre volte,
e in altre circostanze, è stato il mio fratello maggiore: un fratello che
ammiravo e che, soprattutto, avrei voluto emulare. Come vedremo, non è
stato un compito facile e non sono mai arrivato a realizzarne più di una
frazione. Ma è stato quel tentativo, e il conseguente sforzo, a plasmarmi. La
persona che sono diventato - di questo sono assolutamente convinto - è
migliore di quella che sarei stato senza di lui. E non si può chiedere di più a
un fratello maggiore.
Ci sono modi diversi di ricordare. Quando pensiamo alla memoria,
tendiamo a tralasciare ciò che è più importante a favore di ciò che è più
evidente. Un uccello non vola perché sbatte le ali: tale azione è solo la forza
propulsiva. I veri principi del volo vanno ricercati nella forma delle, ali e
nelle conseguenti differenze della pressione dell'aria che fluisce sulla
superficie superiore e su quella inferiore delle ali stesse. Ma nei primi
tentativi di volo umano, abbiamo tralasciato ciò che era più importante a
favore di ciò che era più evidente: abbiamo costruito macchine che
sbattevano le ali. La nostra comprensione della memoria è simile. Pensiamo
alla memoria come a esperienze coscienti grazie alle quali ricordiamo eventi
o episodi passati. Gli psicologi la definiscono «memoria episodica».
La memoria episodica, credo, è solo lo sbattere delle ali ed è sempre la
prima a tradirci. Non è particolarmente affidabile nella maggior parte dei
casi - decenni di ricerche psicologiche convergono su questa conclusione ed è la prima a sbiadire quando il nostro cervello inizia la sua lunga, ma
inesorabile discesa nell'indolenza, come lo sbattere delle ali di un uccello
che sfuma gradualmente in lontananza.
Ma c'è un altro modo di ricordare, più profondo e più importante: una
forma di memoria a cui nessuno ha mai neppure pensato di dare dignità con
un nome. È la memoria di un passato che si è scritto su di voi, nel vostro
carattere e nella vita con la quale quel carattere ha rapporti. Non siete,
almeno non di solito, coscienti di tali ricordi; spesso sono cose di cui non è
neppure possibile essere coscienti. Ma sono questi ricordi, più di qualsiasi
altra cosa, a rendervi ciò che siete. Si manifestano nelle decisioni che
prendete, nelle azioni che fate e quindi nella vita che vivete.
È nella nostra vita e non, fondamentalmente, nelle nostre esperienze
coscienti che troviamo i ricordi di coloro che non ci sono più. La nostra
consapevolezza è volubile e non degna del compito di ricordare. Il modo
più importante di ricordare qualcuno è essere la persona che quel qualcuno
ci ha reso, almeno in parte, e vivere la vita che quel qualcuno ha contribuito
a plasmare. A volte il qualcuno in questione non è degno di essere ricordato.
In questo caso il nostro compito esistenziale più importante è cancellarlo dal
racconto della nostra vita. Ma quando è degno di essere ricordato, allora
essere la persona che lui ha contribuito a formare e vivere la vita che lui ha
contribuito a modellare non sono solo il modo in cui lo ricordiamo: sono il
modo in cui lo onoriamo.
Io ricorderò sempre il mio fratello lupo.
Tre. Decisamente non civilizzato
A fine agosto Brenin e io ci presentammo all'università dell'Alabama per
la nostra prima lezione insieme. L'estate l'aveva visto crescere in fretta, forte
e robusto. Da orsacchiotto paffuto Brenin si era trasformato in un lupo
lungo, slanciato e spigoloso. Anche se non aveva ancora sei mesi, era già
alto quasi ottanta centimetri al garrese e pesava circa trentacinque chili. Ero
solito pesarlo prendendolo in braccio, con suo grande disappunto, e salendo
sulla bilancia del bagno. Ma i giorni in cui potevo seguire questa procedura
stavano per finire, non tanto perché non riuscissi più a sollevarlo, quanto
perché, presi insieme, stavamo diventando troppo pesanti per la bilancia. I
colori di Brenin erano rimasti gli stessi: marrone spruzzato di nero e panna
(per la pancia). Dai genitori aveva ereditato le grosse zampe tipo racchette
da neve e dava sempre l'impressione di inciamparci sopra. Non successe
mai. C'era una riga nera che gli scendeva dalla testa verso il naso, in mezzo
agli occhi, che erano ancora color miele e che a quel punto avevano assunto
la forma allungata e socchiusa tipica dei lupi. In quel primo periodo non
riusciva quasi a controllare la forza che doveva pervadergli tutto il corpo.
L'avevo soprannominato «Buffalo Boy» perché aveva l'abitudine di
lanciarsi a tutta velocità in corse folli dentro casa, facendo cadere qualsiasi
oggetto che non fosse avvitato al pavimento (e anche alcuni che lo erano).
Durante l'estate le nostre uscite da casa si erano lentamente trasformate in
qualcosa al limite del rituale. Io annunciavo la partenza dicendo:
«Andiamo», il che per Brenin costituiva il segnale d'inizio del suo pezzo
forte: l'acrobazia sulla parete del soggiorno. Il suo metodo consisteva nel
correre verso il divano, saltarci sopra e poi continuare la corsa sulla parete.
Arrivato alla massima altezza possibile, ruotava le zampe posteriori e
scendeva, sempre di corsa. Era la stessa storia ogni volta che uscivamo.
Spesso Brenin si esibiva nel suo numero prima ancora che dicessi qualcosa,
come se volesse farmi sapere che c'erano persone che dovevamo vedere e
posti in cui dovevamo andare. Quindi posso dire che fu con una certa
trepidazione che quel giorno mi diressi verso l'università per la nostra prima
lezione.
In realtà, quella mattina non si verificarono grandi disastri. Prima di
entrare, avevo stancato Brenin con una lunga passeggiata e, dopo che si fu
abituato alla presenza di altre persone nell'aula, si sdraiò sotto la cattedra e
si mise a dormire. Poi però si svegliò e cominciò a mordermi i sandali, più o
meno nel momento in cui stavo spiegando i motivi per cui Cartesio dubitava
dell'esistenza del mondo esterno. Ma tutti, credo, accettarono con piacere la
distrazione.
Le cose tuttavia non andarono sempre lisce. Ogni tanto capitò un
contrattempo. Dopo qualche settimana Brenin cominciò a concedersi una
sessione di ululati post- sonnellino a metà lezione, forse per manifestare la
sua generale insoddisfazione per il modo in cui la lezione stava procedendo.
Una rapida occhiata in direzione degli studenti mi confermava che sapevano
esattamente a che cosa alludeva il mio lupo. Altre volte Brenin decideva di
sgranchirsi le zampe e cominciava a vagare su e giù tra le corsie, annusando
in giro. Un giorno in cui si sentiva particolarmente audace, o affamato, o
tutte e due le cose, vidi la sua testa scomparire dentro lo zaino di una
studentessa - una persona che, bisogna dire, era perlopiù abbastanza nervosa
in presenza dei cani -e riemergere pochi secondi dopo con il suo pranzo.
Temendo una potenziale ondata di richieste di risarcimento danni da parte
di studenti affamati, mi vidi quindi costretto a inserire una particolare
clausola nel programma che consegnavo agli studenti all'inizio del corso: tre
frasi che, sono certo, non erano mai comparse prima in alcun programma di
filosofia. Subito dopo i paragrafi riguardanti i testi da leggere e i metodi di
valutazione, ce n'era uno che diceva:
Attenzione: per favore, non badate al lupo. Non vi farà alcun male.
Tuttavia, se avete cibo nello zaino, assicuratevi che lo zaino sia
ermeticamente chiuso.
Se ci ripenso, mi sembra un miracolo il fatto che non ci siano mai state
lamentele, né tanto meno denunce.
Nel pomeriggio mi spogliavo dei panni di docente per indossare quelli di
studente. Quando ero arrivato in Alabama, avevo ventiquattro anni ed ero
più giovane di molti dei miei studenti. A Oxford avevo conseguito il PhD in
poco più di diciotto mesi, un tempo insolitamente breve, forse addirittura un
caso unico. Ma negli Stati Uniti il sistema è molto diverso. C'è una lunga,
faticosa marcia di cinque anni - minimo - prima di conseguire il dottorato. E
poiché occorre più tempo - più di quattro anni, invece di tre - anche per
raggiungere la laurea di primo grado, questo significa che la maggior parte
degli americani entra a fare parte del personale accademico solo intorno ai
trent'anni. E questo, dalla mia prospettiva, era decisamente antiquato. Dato
che metà degli studenti erano comunque più vecchi di me, se volevo
cercarmi degli amici, erano loro, piuttosto che i colleghi accademici, a
costituire il mio naturale bacino. E non era poi un male: gli studenti si
divertono molto di più.
Così, quando ero arrivato in Alabama, per farmi una vita sociale ricorsi a
una strategia sperimentata e consolidata: gli sport di squadra. In Gran
Bretagna avevo giocato a rugby a un livello abbastanza alto. Come la
maggior parte delle università americane, anche quella dell'Alabama aveva
una propria squadra di rugby - molto buona, secondo gli standard locali - e,
grazie a una vistosa mancanza di rigore da parte della Usa Rugby Football
Union nelle procedure di verifica dei requisiti (vale a dire che non c'era
alcuna verifica), ero riuscito a farmi passare per studente e a giocare nella
squadra. Quando un paio di anni dopo era entrato in scena Brenin,
naturalmente avevo cominciato a portarlo con me agli allenamenti. E così,
quasi tutti i pomeriggi infrasettimanali, ci ritrovavamo entrambi a Bliss
Field, ai margini dell'enorme complesso sportivo dell'università.
Nei weekend c'era sempre una partita contro questa o quella università, in
casa o in trasferta. Brenin ci accompagnava in tutti i nostri viaggi.
Ovviamente gli hotel in quella parte del mondo sono, quasi senza eccezione,
ostili ai cani, per non parlare dei lupi. Era, invece, facile introdurre di
nascosto Brenin nei motel. In un motel si parcheggia l'auto davanti alla
porta della camera, per cui, se la reception non affacciava proprio sul
parcheggio, l'atto di introduzione abusiva del lupo in genere passava
inosservato. E, così, citate un qualsiasi grande campus universitario in
Alabama, Georgia, Florida, Louisiana, Carolina del Sud o Tennessee e ci
sono buone probabilità che Brenin ci sia stato per una partita di rugby e per
la festa del dopopartita. Ha mangiato calamari in Bourbon Street a New
Orleans in una tiepida sera d'inizio settembre. E stato a Daytona Beach
durante una vacanza di primavera. A Baton Rouge c'è la sede di
un'associazione universitaria femminile che lui conosceva in lungo e in
largo. Nella periferia ovest di Atlanta c'è uno strip club a buon mercato che
lui ha visitato in numerose occasioni. È andato perfino a Las Vegas, per
gentile concessione dell'annuale torneo di rugby Midnight Sevens, così
chiamato perché le partite si giocano di notte.
I miei compagni di squadra si resero ben presto conto di qualcosa che per
loro era molto importante: Brenin era una calamita per attirare le ragazze. In
realtà loro usavano un'espressione leggermente diversa, più colorita, ma
irripetibile in questo contesto. Comunque si volesse definire la cosa, la
convinzione generale era che, se ti trovavi a una festa dopo la partita e avevi
un grosso lupo accanto a te, in men che non si dica un'attraente
rappresentante del gentil sesso (le fan del rugby erano note come rugger
huggers) si sarebbe avvicinata per dirti: «Adoro il tuo cane [sic]». E questo
dava la possibilità di un aggancio senza il solito lavoro preparatorio. La
presenza di Brenin al proprio fianco diventò così il premio per il giocatore
che quel giorno si era maggiormente distinto in campo: l'Mvp, il Most
Valued Player, come lo chiamano da quelle parti. Io ero escluso da questa
«gara» con la scusa che potevo usare Brenin per quei particolari scopi in
qualsiasi momento, o almeno così si supponeva.
Durante il periodo delle lezioni partivamo per simili trasferte quasi un
weekend sì e uno no: ci mettevamo in viaggio il venerdì pomeriggio,
percorrevamo fino a millecinquecento chilometri tra andata e ritorno,
giocavamo a rugby, ci sbronzavamo, crollavamo a dormire in un motel da
due soldi e poi rientravamo la domenica pomeriggio, spesso ancora
ubriachi, sempre esausti, ma molto felici. Negli altri weekend c'erano le
partite in casa, nelle quali il copione era lo stesso, con l'esclusione del
viaggio in auto. E questa fu più o meno la nostra vita - mia e di Buffalo Boy
- per i primi quattro anni della nostra convivenza.
I lupi giocano, ma non come i cani. I cani stanno ai lupi come i cuccioli
stanno ai cani adulti. E il gioco dei cani è il risultato del comportamento
infantile che si è radicato in loro in quindicimila anni. Scagli lontano un
bastoncino per il tuo cane e quasi sicuramente lui, o lei, scatterà per correre
a recuperarlo in un impeto di eccitazione frenetica. Nina, che vi ho già
presentato, ha la passione dei bastoncini e, se le venisse permesso,
correrebbe a recuperarli fino a crollare sfinita. Cercai più volte di
convincere Brenin delle delizie della caccia al bastoncino, alla palla e al
frisbee. Lui mi guardava come se fossi stato pazzo, con un'espressione
facile da interpretare: andarlo a prendere? Dici sul serio? Se ci tieni tanto,
perché non vai a riprendertelo tu? Anzi, se ci tieni tanto, perché l'hai gettato
via?
Quando giocano, i lupi spesso terrorizzano gli esseri umani presenti, i
quali non riescono a vedere la differenza tra il loro gioco e la lotta. Me ne
sono reso conto solo anni più tardi, quando ho visto Brenin giocare con sua
figlia Tess e con Nina, che lui aveva abituato a essere - a parte la passione
per la caccia al bastoncino - tanto lupo quanto cane. Ciò che all'epoca a me
sembrava naturale negli altri suscitava grida di allarme. Per Brenin giocare
consisteva nell'afferrare l'altro animale per il collo e inchiodarlo a terra. A
quel punto cominciava a scuoterlo violentemente avanti e indietro, come
una bambola di pezza, il tutto con il sottofondo di una cacofonia di ringhi e
grugniti sinistri. Poi lasciava che il suo compagno si liberasse e facesse a lui
più o meno la stessa cosa. Questo era il gioco. Io non so perché i lupi
giochino in modo così duro, ma lo fanno. Sono i ringhi e i grugniti a
scoprire il gioco: è uno dei meccanismi di cui i lupi si servono per
assicurare al compagno che stanno ancora giocando, dato che i
comportamenti sono così simili alla lotta da poter essere facilmente
fraintesi. Come ebbi modo di scoprire, quando i lupi lottano sul serio, lo
fanno in un silenzio totale e spaventoso.
Naturalmente queste sono tutte cose ben note a un lupo, ma non
necessariamente a un cane. Così i giovanili tentativi di Brenin di iniziare il
gioco con i cani si risolvevano in genere in un disastro, con il cane che lo
attaccava o guaiva terrorizzato. Il povero Brenin deve avere trovato
incomprensibili entrambe le reazioni. C'è stato però un cane che lo ha
accettato totalmente. Era un grosso, irriducibile pit bull di nome Rugger, a
cui il gioco duro piaceva.
Per essere un pit bull, Rugger era enorme - pesava più di quaranta chili - e
apparteneva a qualcuno che, per essere un uomo, era altrettanto enorme:
Matt, uno degli avanti di seconda linea della mia squadra di rugby. I pit bull
hanno una cattiva reputazione, ma non sono intrinsecamente cattivi. Di
norma sono le persone a renderli cattivi. Noi uomini amiamo molto l'idea di
essere tutti diversi: la nostra individualità fa parte del nostro fascino unico,
come amiamo raccontarci. Ma in realtà, sospetto, l'individualità ha poco a
che fare con l'unicità umana. I cani sono tutti diversi. Alcuni sono adorabili,
altri sono cattivi. Questi ultimi sono tali perlopiù in conseguenza di
sfortunate condizioni di allevamento. Sono sicuro che questo fosse il caso
del nostro Blue, l'alano psicotico, nei suoi primi tre anni di vita. Ma sono
altresì convinto che alcuni cani semplicemente nascano cattivi. Come alcuni
esseri umani, sono cattivi per natura. Mi preme sottolineare che sto parlando
di singoli cani, non di razze. In base alla mia esperienza, c'è un tenue
rapporto tra la razza di un cane e il suo temperamento, ma niente di più.
Non c'era nulla di molto sbagliato in Rugger dato che non c'era nulla di
molto sbagliato in Matt. Ma affermare che Rug-ger abbia sempre accettato
Brenin non sarebbe la verità. Rug-ger era di qualche anno più vecchio e,
finché Brenin era ancora un cucciolo, lo disprezzava. Poi, come vedremo,
quando Brenin superò i diciotto mesi, tra loro sarebbe sorta una nuova serie
di problemi. Ci fu, comunque, una finestra di circa un anno durante la quale
furono ottimi amici. Quasi tutti i pomeriggi infrasettimanali il nostro
allenamento veniva distratto dalle stupefacenti, acrobatiche esibizioni di
finta lotta che quei due inscenavano su un lato del campo da gioco.
Ma quando Brenin compì diciotto mesi, il suo atteggiamento nei confronti
dei cani cominciò a cambiare. Se il cane era una femmina e non era stata
sterilizzata, allora lui cercava invariabilmente di saltarle addosso, a
prescindere dalla differenza di stazza (un gran numero di West Highlands e
Yorkshire traumatizzate e di padroni altrettanto traumatizzati impararono
rapidamente a evitare il Bliss Field nei pomeriggi infrasettimanali). Ma il
vero problema erano i maschi. Con loro l'atteggiamento di Brenin era di
sprezzante indifferenza o, se giudicava il cane abbastanza grosso da
rappresentare una minaccia, di esplicita ostilità. Perlopiù non accadeva
nulla, perché Brenin era ben addestrato, molto obbediente e non avrebbe
mai avvicinato altri cani senza il mio permesso. Ogni tanto, però, erano loro
ad avvicinarlo, in genere con un bagliore sinistro negli occhi, e allora la
situazione degenerava.
Rugger era sicuramente abbastanza grosso da costituire una minaccia.
Anzi, era difficile immaginare un cane dall'aspetto più minaccioso e
impressionante di Rugger. Quando Brenin raggiunse la maturità, i due
ricominciarono a detestarsi e durante gli allenamenti li vedevamo non più
giocare, ma camminare impettiti uno davanti all'altro, con le gambe rigide e
il pelo dritto. Matt e io li tenevamo diligentemente separati, ma ogni tanto
capitava l'inevitabile svista. Un sabato pomeriggio, durante gli allenamenti
prepartita, Rugger riuscì a liberarsi dalla catena che lo legava al pick-up di
Matt. Io stavo facendo stretching in mezzo al campo e così fui testimone
dello scontro da una distanza di circa trenta metri. Rugger partì alla carica
contro Bre-nin: basso, tarchiato, tutto muscoli e aggressività. Brenin aspettò
fino all'ultimo secondo, poi spiccò un salto di lato. Adesso era posizionato
dietro l'avversario, saltò sulla schiena di Rugger e cominciò a mordergli
collo e testa. Nel giro di qualche istante un orecchio di Rugger era stato
strappato via quasi per intero e il sangue gli colava dal muso, dal collo e dal
costato. Mentre si svolgeva questa scena orribile, io ero scattato dalla metà
campo. In preda alla paura e allo sgomento, mi tuffai istintivamente nella
mischia e cercai di staccare Brenin dal pit bull. Fu un errore, di quelli
potenzialmente fatali. Rugger approfittò della momentanea tregua per
attaccarsi implacabile alla gola di Brenin.
Fu così che imparai la mia prima, preziosa lezione di intervento nelle lotte
tra canidi. Non staccate mai il vostro lupo da un pit bull. La seconda lezione
fu che se un pit bull tiene il vostro lupo per la gola, probabilmente perché
siete stati così stupidi da trascinare via il lupo, c'è un solo modo per fare
desistere il pit bull. Lasciate perdere l'idea di cercare di aprirgli a forza le
fauci: non funziona. E lasciate perdere anche l'idea di prenderlo
ripetutamente a calci nelle costole: non funziona neppure questo. Invece,
buttategli dell'acqua sul muso. L'unico modo di interrompere un'azione
istintiva - quale è per il pit bull attaccarsi con le fauci - è indurre una
reazione istintiva, e l'acqua di solito funziona. Per fortuna Matt aveva
imparato questa lezione prima di me.
La terza lezione è quella che appresi in occasione di successivi
combattimenti: se dovete trascinare via il vostro lupo che sta lottando con
un cane, afferratelo per la coda o per i fianchi, mai - sottolineo, mai - per il
collo. In questo caso, infatti, se il cane non è del tutto traumatizzato - e il
tipo di cane che solitamente attaccava Brenin non era di quelli che si
traumatizzavano facilmente - continuerà ad attaccare anche mentre le vostre
mani si trovano vicino alla gola del vostro animale, il che è una pessima
cosa. Sulle mani e sugli avambracci ho ancora il patchwork di cicatrici che
mi sono procurato durante il lungo e doloroso processo di perfezionamento
della mia tecnica d'intervento.
Non vorrei ingigantire la propensione di Brenin alla lotta. Potrei contare il
numero di episodi significativi sulle dita di una mano sola... e sono grato di
avere ancora tutte le dita necessarie per dimostrarlo. Brenin non ha mai
provocato gravi danni all'avversario, nulla a cui non si potesse porre
rimedio con qualche punto di sutura qua e là. Perfino Rugger, una volta
rattoppato, si è ripreso benissimo. Ma tutto questo, ne sono certo, è stato
possibile solo perché io ero sempre presente, pronto a staccare Brenin
dall'avversario. Inoltre era raro che fosse il mio lupo ad aprire le ostilità,
anche se forse ciò era dovuto al fatto che, dato il suo addestramento, non ne
aveva quasi mai l'opportunità. E anche nel caso in cui un cane gli si fosse
avvicinato mentre ero distratto, la lotta veniva facilmente evitata. Bastava
che il cane lanciasse qualche segnale convenzionale di sottomissione o di
mortificazione. In pratica tutti gli scontri di Brenin sono avvenuti con cani
grossi e aggressivi - pit bull e Rottweiler, perlopiù - che erano sfuggiti ai
padroni e non avevano la minima intenzione di sottomettersi a lui.
Il problema non era l'entusiasmo di Brenin per il combattimento. Era il
suo atteggiamento. Se scoppiava una zuffa, io dovevo buttarmi tra i
contendenti e cercare di far cessare le ostilità. E per evitare che si ripetesse
l'incidente di Rugger, dovevo cercare di afferrare contemporaneamente
entrambi gli animali. Il che non era affatto facile. Ma dovevo farlo, perché
fino a quando il cane avesse continuato a combattere, Brenin avrebbe
continuato a combattere. E se Brenin avesse continuato a combattere, il
cane sarebbe morto. La velocità del lupo era accecante, la sua ferocia
sbalorditiva. Era difficile conciliare quel Brenin con l'animale che ogni
mattina mi svegliava stampandomi in faccia una grande leccata umida, o
che, parecchie volte al giorno, cercava di salirmi in grembo in cerca di
coccole. Ma io non potevo permettermi di dimenticare che Brenin era sia
l'uno sia l'altro.
Alcune persone sostengono che per i lupi, o anche per gli incroci canelupo, non c'è posto in una società civilizzata. Dopo molti anni di riflessione,
sono arrivato alla conclusione che è vero. Ma non per le ragioni che quelle
persone pensano. Brenin era un animale pericoloso: è un dato di fatto che
non si può nascondere. Era del tutto indifferente agli esseri umani al di fuori
del suo padrone... e devo dire che questo, segretamente ed egoisticamente,
mi faceva moltissimo piacere. Se una persona diversa da me cercava di
parlargli, o lo accarezzava come si fa di solito con i cani, Brenin la guardava
imperscrutabilmente per qualche secondo e poi se ne andava. Ma, nelle
giuste circostanze, avrebbe potuto uccidere il vostro cane in modo rapido ed
efficace. Tuttavia non è perché era così pericoloso che non c'era posto per
Brenin in una società civilizzata. La vera ragione è che non era, neanche
lontanamente, abbastanza pericoloso e abbastanza sgradevole. La
civilizzazione, io credo, è possibile solo per animali molto sgradevoli. Solo
una scimmia può essere davvero civilizzata.
Una sera - Brenin aveva circa un anno - mi ritrovai seduto davanti alla
tivù con la cena tipica di tutti gli scapoli americani che si rispettino: un
piatto di glutammato di sodio al microonde, noto come il «pasto
dell'affamato». Sdraiato accanto a me, Brenin osservava la scena come un
falco, nel caso in cui dal piatto fosse caduto qualcosa. Il telefono squillò e
andai a rispondere, lasciando il piatto sul tavolino. Avete presente quando
Wile Coyote insegue Bip Bip e, correndo a tutta velocità, supera il bordo
del precipizio? Pensate all'istante successivo, al momento in cui si rende
conto che è successo qualcosa di terribile, ma non sa bene cosa, al momento
che precede il suo disperato, ma inutile tentativo di risalita. Wile Coyote è
in piedi a mezz'aria, paralizzato, con un'espressione che passa gradualmente
dall'entusiasmo alla confusione e infine alla disperazione per l'imminente
catastrofe. Era quello il genere di scena che mi aspettava quando rientrai
nella stanza. Brenin, dopo aver divorato il mio «pasto dell'affamato», si
stava dirigendo veloce verso la sua cuccia dall'altra parte della stanza. Il mio
ritorno, sgradito ma non del tutto inatteso, lo immobilizzò a metà di un
passo: una zampa davanti all'altra, il muso rivolto verso di me e
un'espressione che gradualmente diventò di apprensione alla Wile Coyote.
A volte, subito prima di precipitare nell'abisso, Wile mostra un cartello con
la scritta YIKES! (Accidenti!). Sono sicuro che, se avesse avuto a
disposizione quel cartello, Brenin avrebbe fatto la stessa cosa.
Wittgenstein una volta disse che, se un leone potesse parlare, noi non
potremmo capirlo. Wittgenstein era senza dubbio un genio, ma, diciamo la
verità, non ne sapeva molto di leoni. Un lupo parla con il corpo ed era
chiaro che cosa stava dicendo il corpo di Brenin: beccato! Si potrebbe
pensare che, forse, gli sarebbe convenuto assumere un atteggiamento più
indifferente, addirittura noncurante, nei confronti del suo ladrocinio: io non
so niente del tuo piatto. Non sono stato io. Era già vuoto, quando sono
arrivato. O magari addirittura: hai mangiato tutto tu prima di andartene,
vecchio bastardo rintronato. Ma i lupi non fanno così. Possono parlare. E,
cosa più importante, noi possiamo capirli. Quello che i lupi non sanno fare è
mentire. È per questo che non c'è posto per loro in una società civilizzata.
Un lupo non può mentirci, né può farlo un cane. Ecco perché crediamo di
essere migliori di loro.
È noto che, in rapporto alle dimensioni corporee, le scimmie hanno un
cervello più grande di quello dei lupi; la differenza è circa del 20 per cento.
L'inevitabile conclusione che traiamo da questo dato è che le scimmie sono
più intelligenti dei lupi: l'intelligenza scimmiesca è superiore a quella
lupesca. Tale conclusione è non tanto falsa quanto semplicistica. L'idea
della superiorità è ellittica. Se X è superiore a Y, lo è sempre sotto un
aspetto o l'altro. Perciò, se l'intelligenza scimmiesca è realmente superiore a
quella lupesca, dovremmo chiederci: sotto quale aspetto? E, per rispondere
a questa domanda, dobbiamo capire in che modo le scimmie hanno
acquisito un cervello più grosso e qual è il prezzo che hanno pagato.
Un tempo si riteneva che l'intelligenza consistesse semplicemente nella
capacità di affrontare il mondo naturale. Può darsi, per esempio, che uno
scimpanzé scopra che, infilando un rametto in un formicaio, riesce a estrarre
le formiche e a mangiarsele senza farsi mordere. È un esempio di quella che
in precedenza ho definito «intelligenza meccanica». Il mondo presenta un
problema allo scimpanzé - procacciarsi cibo senza farsi mordere - e lo
scimpanzé lo risolve in un modo meccanicamente intelligente.
L'intelligenza meccanica consiste nel comprendere il rapporto tra le cose in questo caso tra il rametto e il probabile comportamento delle formiche - e
utilizzare tale comprensione per favorire i propri scopi. Come abbiamo
visto, i lupi sono creature meccanicamente intelligenti, forse non quanto le
scimmie, ma più dei cani.
Comunque il cervello delle creature sociali è, in genere, più grosso di
quello delle creature solitarie. Come mai? Il mondo pone i medesimi
problemi meccanici a tutte le creature, sociali e non. Che tu sia una tigre, un
lupo o una scimmia, ti si presenterà lo stesso tipo di problema meccanico.
La conclusione che dovremmo trarre, a quanto pare, è che l'intelligenza
meccanica non è ciò che stimola l'aumento delle dimensioni del cervello. È
l'osservazione che sta alla base di quella che Andrew Whiten e Richard
Byrne, primatologi dell'università di St Andrews, hanno definito «ipotesi
dell'intelligenza machiavellica». L'aumento delle dimensioni del cervello e
la conseguente maggiore intelligenza sono stimolati non dalle richieste del
mondo meccanico, ma da quelle del mondo sociale.
Ora dobbiamo stare attenti a non mettere il carro davanti ai buoi. Si
potrebbe pensare, per esempio, che siano stati il cervello più grosso e la
conseguente maggiore intelligenza a far sì che alcune creature si rendessero
conto che se la sarebbero cavata molto meglio in gruppo, in quanto il
gruppo avrebbe garantito loro appoggio e protezione comuni. Cioè, queste
creature sono diventate animali sociali perché erano più intelligenti.
Secondo l'ipotesi dell'intelligenza machiavellica, è vero invece il contrario:
sono diventate più intelligenti perché erano animali sociali. L'aumento delle
dimensioni del cervello non è la causa della vita di gruppo di certi animali: è
l'effetto della loro vita di gruppo. Gli animali sociali devono essere in grado
di fare cose che gli animali solitari non fanno. L'intelligenza meccanica può
consistere nel comprendere i rapporti tra le cose, ma gli animali sociali
hanno bisogno di qualcosa di più: hanno bisogno di comprendere i rapporti
con altre creature simili a loro. E questa è l'intelligenza sociale.
Per esempio, una scimmia, o un lupo, ha bisogno di tenersi al corrente
delle dinamiche interne al proprio gruppo. Deve sapere chi è chi e deve
ricordare chi gli è superiore e chi subordinato. Se non lo facesse, non si
comporterebbe in modo adeguato e, di conseguenza, avrebbe a soffrirne.
Anche molti insetti - formiche, api, ecc. - devono riuscire in questo compito,
ma lo fanno rilasciando e ricevendo messaggi chimici: è questa la strategia
che l'evoluzione ha lasciato loro in eredità. Ma nei mammiferi sociali è stata
usata una diversa strategia: un aumento di intelligenza di un certo tipo.
Secondo l'ipotesi dell'intelligenza machiavellica, sono la natura sociale degli
animali e la necessità di tenersi al corrente delle relazioni sociali a stimolare
l'aumento delle dimensioni e delle capacità del cervello, non il contrario.
Questo è un tratto che, più o meno, scimmie e lupi hanno in comune.
Tuttavia a un certo punto, molto, molto tempo fa, le scimmie hanno
imboccato un sentiero evolutivo che i lupi non hanno seguito. E le ragioni di
questi percorsi diversi sono, per la maggior parte degli esperti,
assolutamente oscure. Vivere in gruppo comporta sia nuove possibilità sia
concomitanti esigenze: possibilità che le creature solitarie non avevano mai
avuto ed esigenze che non avevano mai dovuto soddisfare. La prima
possibilità consiste nel manipolare e sfruttare i propri compagni, acquisendo
così tutti i benefici della vita di gruppo e sostenendone in misura minore i
costi. Manipolazione e sfruttamento si basano su una capacità d'inganno: il
principale e più efficace modo per manipolare i propri compagni è
ingannarli. La prima esigenza della vita di gruppo, perlomeno se vivi in un
simile gruppo, è una conseguenza di ciò. Poiché per una scimmia non
sarebbe bene ritrovarsi a pagare più costi e a ricavare meno benefici delle
altre scimmie, la vita di gruppo le richiederà di diventare abbastanza furba
da capire quando la stanno ingannando. La conseguenza è un incremento
dell'intelligenza,
stimolato
dall'imperativo
di
ingannare
e,
contemporaneamente, di non essere ingannata. Nella storia evolutiva delle
scimmie la crescente capacità di imbrogliare procede di pari passo con la
crescente capacità di individuare l'imbroglio (quest'ultima, per necessità,
appena un po’ superiore alla prima).
C'è un'altra possibilità offerta dalla vita di gruppo: formare alleanze con i
propri pari. Nella società delle scimmie le alleanze permettono di usare
alcuni membri del gruppo per formare una coalizione contro altri membri
del medesimo gruppo. Per riuscirci, bisogna essere capaci di complottare, il
che, però, comporta un'altra esigenza. Non è bene - non favorisce il
benessere né le prospettive a lungo termine - essere oggetto di complotti
altrui, vittima di una alleanza dopo l'altra. Se altri tramano costantemente
contro di te e tu vuoi continuare a fare parte del gruppo, allora devi tramare
costantemente contro di loro. Vivere in certi tipi di gruppo comporta la
necessità di essere artefici di complotto almeno tanto quanto se ne è vittime.
In questi gruppi la capacità di tramare implica la necessità di tramare.
Complotto e inganno sono il nucleo dell'intelligenza sociale di cui sono
dotate le scimmie. Per qualche ragione, i lupi non hanno mai preso questa
strada. Nel branco si complotta e si inganna pochissimo. Alcune prove
sembrerebbero suggerire che i cani abbiano la capacità di creare primitive
forme di alleanza, singolarmente di poco conto. Ma tali prove non sono
conclusive. E, in ogni caso, una cosa è certa: per quanto riguarda questo
genere di capacità - complotto e inganno -, i cani e i lupi sono come
bambini a paragone delle grandi scimmie. Nessuno sa spiegare perché le
scimmie hanno adottato questa strategia e i lupi no. Ma, anche se non
sappiamo perché è successo, una cosa è assolutamente evidente: è successo.
Naturalmente questa forma di intelligenza raggiunge la sua apoteosi nel re
delle scimmie: l'Homo sapiens. Quando parliamo della superiore
intelligenza delle scimmie, della superiorità dell'intelligenza scimmiesca
rispetto a quella lupesca, dovremmo tenere ben presenti i termini del
paragone: le scimmie sono più intelligenti dei lupi perché, in definitiva,
sanno complottare e ingannare meglio dei lupi. È da questo che deriva la
differenza tra l'intelligenza delle scimmie e quella dei lupi.
Ma noi siamo scimmie e possiamo fare cose che i lupi non si sognano
nemmeno. Possiamo creare arte, letteratura, cultura, scienza, possiamo
scoprire la verità delle cose. Non ci sono lupi- Einstein, né lupi- Mozart e
neppure lupi- Shakespeare. E, più modestamente, Brenin non avrebbe mai
potuto scrivere il libro che state leggendo: solo una scimmia poteva farlo.
Ciò, naturalmente, è vero, ma dobbiamo ricordare qual è l'origine di tutto
questo. La nostra intelligenza scientifica e artistica è un sottoprodotto
dell'intelligenza sociale. E la nostra intelligenza sociale consiste nella nostra
capacità di essere artefici di complotti e inganni più di quanto ne siamo
vittime. Ciò non significa che l'intelligenza scientifica e creativa si riduce
semplicemente al complotto e all'inganno. Presumibilmente complotti e
inganni erano l'ultima cosa che Beethoven aveva in mente quando
componeva l'Eroica, e non erano presenti neppure in forma inconscia,
condizionando in modo nascosto il suo comportamento. Non sto certo
proponendo una spiegazione ridicolmente riduzionista delle capacità
compositive di Beethoven. Il punto è, a mio avviso, che Beethoven fu in
grado di comporre l'Eroica solo perché lui era il prodotto di una lunga storia
naturale incentrata sulla capacità di ingannare più di quanto si sia ingannati
e di complottare più di quanto si sia vittime di complotti.
Saremmo ingiusti nei confronti delle altre creature e renderemmo un
cattivo servizio a noi stessi, se dimenticassimo da dove arriva la nostra
intelligenza. Non è arrivata gratuitamente. Nel nostro remoto passato
evolutivo abbiamo imboccato una determinata strada, una strada che i lupi,
per qualche ragione, non hanno preso. Non possiamo essere né biasimati né
apprezzati per la strada che abbiamo imboccato. Non c'era scelta.
Nell'evoluzione non c'è mai scelta. Ci sono però delle conseguenze. La
nostra sofisticata complessità, la nostra arte, la nostra cultura, la nostra
scienza, le nostre verità, la nostra, come ci piace considerarla, grandezza:
tutto questo l'abbiamo acquistato e la moneta sono stati il complotto e
l'inganno. Al centro della nostra intelligenza superiore ci sono
macchinazione e falsità, come vermi annidati nel cuore di una mela.
Questo potrebbe sembrare un ritratto intenzionalmente parziale della
peculiarità umana. Forse è vero che abbiamo una naturale tendenza al
complotto e alla doppiezza. Ma di sicuro abbiamo anche caratteristiche più
attraenti, no? Che dire dell'amore, dell'empatia, dell'altruismo?
Naturalmente non contesto il fatto che gli uomini siano capaci anche di tali
sentimenti. Se è per questo, ne sono capaci anche le grandi scimmie. Ma,
per quanto riguarda gli esseri umani, io sto cercando di identificare non solo
ciò che è vero, ma ciò che li distingue dalle altre creature. E l'idea che solo
gli umani possiedano questo genere di caratteristiche più positive è difficile
da sostenere.
Tanto per cominciare, c'è la grande abbondanza di prove empiriche che
suggerisce - a tutti, salvo che al più ottuso dei comportamentalisti - che tutti
i mammiferi sociali sono capaci di profondi sentimenti d'affetto reciproco.
Quando i lupi o i coyote si ritrovano, dopo essere andati separatamente a
caccia, si corrono incontro galoppando a tutta velocità, guaendo, uggiolando
e agitando freneticamente la coda. E poi si leccano il muso a vicenda e si
rotolano a terra, scalciando in aria. I cani selvatici africani sono altrettanto
espansivi: le loro cerimonie di saluto comportano cacofonie di grida,
frenetici scuotimenti della coda, salti e balzi smodati. Quando si riuniscono,
gli elefanti sbattono le orecchie, ruotano su se stessi ed emettono un sonoro
barrito di saluto. In tutti i casi, a meno che non siate stretti nella morsa di
un'indifendibile ideologia comportamentalista - un'ideologia che insistete ad
applicare agli altri animali, ma vi rifiutate di applicare agli uomini - l'ovvia
conclusione è che questi animali provano un sincero affetto reciproco, che
gradiscono la compagnia dei loro simili e che sono felici di rivedersi.
Altrettanto convincenti sono le prove del dolore, e più si effettuano studi
sul campo, più tali prove diventano convincenti. Mare Bekoff, nel suo Dalla
parte degli animali, descrive un episodio nella vita di un branco di coyote da
lui studiato nel parco nazionale del Grand Teton, nel Wyoming:
Un giorno Mamma lasciò il branco e non vi fece mai più ritorno. Era
scomparsa. Il branco attese con impazienza per giorni e giorni: alcuni
coyote passeggiavano su e giù come padri in attesa, mentre altri compivano
brevi escursioni per poi tornare a mani vuote. Si spostavano seguendo la
direzione che aveva preso lei, annusavano i posti in cui forse lei era passata
e ululavano come se volessero richiamarla a casa. Per più di una settimana
sembrava che un po’ della vitalità del branco fosse scomparsa: la sua
famiglia sentiva la mancanza di Mamma. Credo che i coyote avrebbero
pianto se avessero potuto.
Sono state osservate volpi seppellire il compagno morto. Tre elefanti
maschi sono stati visti vegliare il corpo di una vecchia femmina uccisa dai
bracconieri per impadronirsi delle zanne: le rimasero accanto per tre giorni,
toccandola e cercando di farla rialzare. Il famoso naturalista Ernest
Thompson Se- ton una volta usò il dolore che un lupo maschio, Lobo,
provava per la perdita della sua compagna per intrappolarlo e ucciderlo.
Seton, cacciatore di lupi prima di diventare scrittore, aveva sparso l'odore
della compagna di Lobo, Bianca, trascinandone il corpo lungo una serie di
trappole. Lobo era tornato dalla sua amata solo per essere ucciso da Seton.
Potreste dire che questi sono solo aneddoti. Forse, ma gli aneddoti sono
ormai migliaia e il loro numero aumenta ogni giorno, e ciò escludendo le
storie che i proprietari di animali domestici potrebbero raccontare sui loro
compagni. Inoltre, per dirla con Bekoff, una volta che hai abbastanza
aneddoti, questi diventano qualcosa di molto diverso: diventano dati.
Secondo qualsiasi ragionevole interpretazione dell'avverbio «abbastanza», il
punto di transizione è già stato superato da tempo.
Basta solo leggere il meraviglioso lavoro di Jane Goodall per capire che i
sentimenti di affetto, empatia e perfino amore sono comuni nelle scimmie.
E quando, per esempio, nel Popolo degli scimpanzé la Goodall descrive il
rapido e penoso declino del giovane scimpanzé Flint in seguito alla morte
della madre Flo, non si può, se si ha anche solo mezzo cuore, non
commuoversi. Ma le prove dell'esistenza di questo tipo di emozioni in altri
mammiferi sono altrettanto solide. Affetto, empatia e amore: lungi
dall'essere tratti unicamente umani, o anche solo unicamente scimmieschi,
sono comuni a tutto il mondo dei mammiferi sociali.
Ci sono, in realtà, buone ragioni teoriche perché sia così, ragioni che
vennero esposte per la prima volta da Charles Darwin. Qualsiasi gruppo
sociale ha bisogno di qualcosa che lo tenga unito: una forma di collante
sociale. Per gli insetti sociali il collante consiste sia nei feromoni che gli
insetti usano per comunicare tra loro sia nel fatto che ogni insetto è una
cellula individuale più che un organismo individuale, una cellula il cui
benessere e perfino la cui identità sono indissolubilmente legati all'alveare o
all'organismo colonia. Ma, con i mammiferi, pare che l'evoluzione abbia
usato una strategia molto diversa, una strategia che ha comportato lo
sviluppo di quelli che, secondo Darwin, erano i sentimenti sociali: affetto,
empatia e perfino amore. Ciò che tiene insieme un branco di lupi, di coyote
o di cani africani è esattamente ciò che tiene insieme una colonia di
scimpanzé o una famiglia umana. È questo che abbiamo tutti in comune.
Io, però, sono interessato non a quanto tutti abbiamo in comune, ma a ciò
che distingue noi uomini dalle altre creature. E la maggior parte di noi
accetta l'idea - anzi, insiste nell'affermare - che sia la nostra tanto decantata
intelligenza a distinguerci dalle «stupide bestie». Se così è, allora dobbiamo
renderci conto che questa intelligenza non ci è arrivata gratuitamente. E
arrivata perché, molto tempo fa, i nostri antenati hanno imboccato un
sentiero diverso da quello preso da altri animali sociali, e quel sentiero era
lastricato di duplicità e complotti.
Questa spiegazione generale dell'intelligenza umana non è messa
seriamente in dubbio. Nel suo La politica degli scimpanzé Frans de Waal
riporta un classico studio sulla colonia di scimpanzé dello zoo di Arnhem e
dimostra alcune complessità delle dinamiche di gruppo di questi animali.
Tre maschi della colonia erano sempre in competizione tra loro per la
leadership del gruppo. All'inizio dello studio la posizione alfa era detenuta
da Yeroen. Uno dei fattori determinanti per il mantenimento della sua
leadership era l'appoggio delle femmine. Il lungo, e alla fine riuscito,
tentativo di Luit di detronizzare Yeroen si basò sull'erosione di tale
appoggio. Prima di dare inizio alla sua sfida, Luit aveva occupato una
posizione relativamente periferica nella colonia, costretto da Yeroen a
tenersi un po’ in disparte dal resto del gruppo. Il cambiamento decisivo in
questa dinamica si verificò quando Nikkie, un maschio più giovane, diventò
sufficientemente adulto da potersi alleare con Luit. Insieme, i due si
impegnarono in una politica di «punizione» - cioè botte - nei confronti delle
femmine, non per il gusto di farlo, ma allo scopo di dimostrare l'incapacità
di Yeroen di proteggerle. Dopo circa quattro mesi di questa politica, le
femmine cominciarono a sostenere Luit, quasi certamente perché non ne
potevano più delle punizioni che subivano di continuo dai due giovani
maschi e a causa dell'incapacità di Yeroen di porre fine alla situazione.
In seguito alla sua ascesa al potere Luit modificò rapidamente il proprio
approccio. Come leader, adesso doveva cambiare atteggiamento nei
confronti sia delle femmine sia degli altri maschi. Con le prime, confidando
nel loro generale consenso, adottò il ruolo dell'imparziale tutore della pace.
Con i maschi, invece, diventò il paladino dei perdenti: quando interveniva
in un conflitto tra due maschi, in genere appoggiava il più debole. E quindi,
anche se la sua ascesa al ruolo di leader era avvenuta con l'aiuto di Nikkie,
di norma si schierava sempre con l'avversario dell'ex alleato. Era una
politica sensata. Il vincitore di un conflitto tra due maschi avrebbe potuto
essere abbastanza forte da sfidare direttamente l'autorità di Luit. Non così il
perdente. E, schierandosi con il perdente, Luit inoltre aumentava le
probabilità di ottenerne l'appoggio in eventuali, futuri conflitti. In altre
parole, le esigenze della leadership gli imponevano di stringere alleanze con
coloro che non potevano sfidare la sua autorità per proteggere se stesso da
quelli che invece erano in grado di farlo.
In seguito Yeroen e Nikkie si allearono e deposero Luit. Nikkie diventò
formalmente il nuovo leader, ma il potere reale sembrava appartenere a
Yeroen. Anzi, dopo l'ascesa del nuovo capo, Yeroen lavorò contro di lui con
tale efficacia da far dubitare che Nikkie avesse mai avuto realmente il
controllo del gruppo. Stupidamente, Nikkie perseguiva una politica di
sostegno dei vincitori nei conflitti e la pace veniva mantenuta da Yeroen.
Per esempio, quando Nikkie si accingeva a intervenire in un confronto tra
due femmine, spesso Yeroen assumeva un atteggiamento minaccioso e,
forse aiutato dalle due femmine, lo cacciava via. Perché Nikkie sopportava
situazioni del genere? Non aveva scelta: aveva bisogno di Yeroen per tenere
sotto controllo Luit. Così Nikkie fu un leader che le femmine non
accettarono mai. Anzi, veniva regolarmente attaccato da alleanze femminili.
Yeroen, viceversa, si alleò con le femmine allo scopo di mantenere la
pressione su Nikkie e si alleò con Nikkie per tenere sotto controllo Luit. È
abbastanza chiaro chi deteneva il vero potere.
La superiore intelligenza di Yeroen, rispetto sia a Luit sia a Nikkie,
consisteva quindi nella capacità di stringere molteplici alleanze per
molteplici scopi: un'alleanza per tenere sotto controllo Nikkie, un'altra
alleanza per tenere sotto controllo Luit. L'alleanza tra Luit e Nikkie, in
confronto, sembra rozza. Per essere davvero uno scimpanzé di successo per esibire l'intelligenza scimmiesca al suo meglio -bisogna saper cospirare
non solo contro un unico individuo, ma contro molti. E gli scimpanzé di
maggior successo sono quelli che sanno cospirare con gli stessi individui
contro i quali cospirano.
Oltre al tipo di complotto messo in atto da Yeroen e Luit, quello che si
manifesta in alleanze instabili e costantemente mutevoli, anche l'inganno
risulta avere un ruolo centrale in tutti gli studi classici sul comportamento
delle scimmie. In un autorevole studio («The manipulation of attention in
primate tactical deception», pubblicato nel loro libro Machiavellian
Intelligence) Whiten e Byrne individuano non meno di tredici diversi tipi di
inganno comunemente impiegati dalle scimmie. Non occorrerà entrare nei
dettagli di ogni singolo tipo: alcuni esempi rappresentativi daranno un'idea
sufficientemente chiara.
Uno scimpanzé o babbuino subordinato nasconde spesso il proprio pene
eretto a un maschio dominante (mentre lo esibisce deliberatamente a una
femmina). A questo scopo appoggia il braccio più vicino al maschio
dominante sul proprio ginocchio e lascia penzolare mollemente la mano
verso il basso. Intanto continua a lanciare sguardi furtivi all'altro maschio.
Credo che questo esempio mi piaccia per la sua natura deliziosamente
sordida: solo nelle scimmie troviamo questa inimitabile combinazione di
astuzia e lascivia. Si tratta di una forma di inganno cui Whiten e Byrne si
riferiscono con il termine «occultamento». Risultato frequente di questo
esempio di occultamento è un ulteriore occultamento: il maschio e la
femmina si nascondono dietro un masso o un albero e copulano di nascosto.
Ed ecco un esempio di un diverso tipo di occultamento, che Whiten e
Byrne chiamano «inibizione dell'interesse». Un gruppo di babbuini sta
percorrendo uno stretto sentiero. La femmina S nota su un albero una
macchia seminascosta di loranto, una pianta cespugliosa che piace molto ai
babbuini. Senza guardare i compagni, S si siede su un lato del sentiero e
comincia a spulciarsi con impegno. Gli altri babbuini le passano davanti e,
non appena sono fuori dalla vista, S salta sull'albero e si mangia il loranto. È
l'equivalente da babbuino di quando fingi di doverti allacciare la stringa di
una scarpa mentre, in realtà, hai notato una banconota da venti sterline per
terra.
È facile capire la relazione tra la formazione di alleanze e l'inganno da un
lato e l'aumento dell'intelligenza dall'altro. Entrambe le forme di
comportamento richiedono la capacità di comprendere non solo il mondo,
ma anche, ed è un punto cruciale, la mente dell'altro. Alla base dei due
comportamenti c'è la capacità di vedere, capire o prevedere come il mondo
appare a chiunque altro.
Prendiamo in esame il nostro scimpanzé lascivo che nasconde il proprio
pene al maschio dominante, mentre lo esibisce a una femmina. Per fare
questo, lo scimpanzé deve avere un'idea della prospettiva del dominante. In
altri termini, deve capire che il maschio dominante può vedere, che ciò che
può vedere non è necessariamente quello che possono vedere altri
scimpanzé e che ciò che il dominante può vedere dipende dalla sua
posizione in rapporto agli altri scimpanzé. Questo significa che, per riuscire
nell'occultamento, uno scimpanzé deve avere almeno un'idea di ciò che
accade nella mente dei suoi simili. Quando i primatologi parlano delle
impressionanti capacità di «lettura del pensiero» delle scimmie, è a questo
che si riferiscono.
Il livello di sofisticatezza delle capacità di lettura del pensiero sale di un
paio di tacche nel nostro secondo esempio di inganno. Per inibire il proprio
interesse o attenzione, la babbuina S deve avere l'idea non solo che altri
potrebbero notare il loranto, ma anche che altri potrebbero accorgersi che lei
sta guardando la pianta. Cioè, S si rende conto che altri potrebbero capire
che lei vede qualcosa di significativo su quell'albero. Quando S nota il
loranto, si tratta di quella che è nota come «rappresentazione di primo
livello»: S si è formata una rappresentazione visiva del mondo. Se un suo
compagno capisce che S sta osservando qualcosa di interessante, il
compagno in questione si è formato una rappresentazione della
rappresentazione del mondo di S. È la rappresentazione di secondo livello:
la rappresentazione di una rappresentazione. Comunque, quando S si rende
conto che altri potrebbero capire che ha visto qualcosa di interessante,
abbiamo una rappresentazione di una rappresentazione di una
rappresentazione. Una rappresentazione di terzo livello.
Ecco, ancora una volta grazie a Whiten e Byrne, un caso addirittura più
notevole. Uno scimpanzé - chiamiamolo «1» -sta per mangiare delle
banane, contenute in una scatola metallica che viene aperta in disparte.
Mentre la scatola sta per essere scoperchiata, compare un secondo
scimpanzé, chiamiamolo «2». 1 richiude subito la scatola e va sedersi
qualche metro più in là. 2 si allontana dalla zona, ma si nasconde dietro un
albero per osservare 1. E, non appena quest'ultimo riapre la scatola, 2 lo
attacca e gli sottrae le banane. 1 riesce a vedere che 2 riesce a vederlo
guardare - rappresentazione di terzo livello -, ma 2 riesce a vedere che 1
riesce a vedere che lui riesce a vederlo guardare. Questo sembra essere un
caso davvero notevole di rappresentazione di quarto livello.
Lo stesso tipo di capacità di capire la mente di altri può essere facilmente
rilevato quando le scimmie formano alleanze con e contro altri individui. La
chiave di ogni coalizione di successo, anche la più semplice, non è solo
capire come le vostre azioni si ripercuoteranno sugli altri: è altrettanto
importante capire che tipo di reazione le vostre azioni susciteranno in altri.
In pratica, occorre comprendere la relazione tra ciò che fate e ciò che altri
faranno a causa di quello che fate: pensate alla campagna di violenza di Luit
e Nikkie contro le femmine della colonia. E capire questo significa capire
come ciò che fate crei i presupposti di ciò che altri fanno. In questo senso, la
costituzione di alleanze di successo, anche le più semplici, comporta la
comprensione della mente delle altre scimmie.
In breve, la maggiore intelligenza che riscontriamo nei primati, ma, a
quanto pare, non in altre creature sociali, è il risultato di due imperativi
gemelli: complottare contro gli altri più di quanto gli altri complottino
contro di te e ingannare gli altri più di quanto gli altri ingannino te. La
natura dell'intelligenza scimmiesca è irrimediabilmente plasmata da questi
imperativi. Siamo diventati più intelligenti per poter comprendere meglio la
mente dei nostri simili, in modo da ingannarli e usarli per i nostri scopi, il
che è proprio quello che i nostri simili cercavano di fare a noi, naturalmente.
Tutto il resto - la nostra straordinaria comprensione del mondo naturale, la
nostra creatività intellettuale e artistica - è venuto dopo e solo come
conseguenza.
Finora, però, abbiamo lasciato senza risposta la domanda più interessante.
Anzi, non abbiamo neppure formulato la domanda più interessante. Perché i
lupi hanno ignorato la strada verso l'intelligenza intrapresa invece dalle
scimmie con tanta efficacia? A questo punto gli esperti si stringono nelle
spalle. Alcuni hanno suggerito che ciò potrebbe avere a che fare con la
dimensione del gruppo. Ma è poco più che un accenno di risposta, dato che
nessuno ha mai chiarito il nesso tra la dimensione del gruppo e la necessità
di complotti e inganni. Io ho un'idea diversa, un'ipotesi che striscia fuori in
modo timido, ma nondimeno avvertibile, da entrambi i lati di quasi ogni
riga mai scritta nella letteratura sui primati.
Luit sta facendo delle avances a una femmina, mentre Nikkie, che in
questo momento è ufficialmente il maschio alfa, se ne sta disteso sull'erba a
una cinquantina di metri di distanza. La tecnica di seduzione di Luit è
prevedibile: fa l'esibizionista con la femmina mostrandole il pene eretto,
attento però a rivolgere la schiena a Nikkie, in modo che non possa vedere
che cosa sta succedendo. Sospettoso, Nikkie si alza. Lentamente, Luit si
allontana di pochi passi dalla femmina e si siede, sempre rivolgendo la
schiena a Nikkie: non vuole che il leader pensi che si è spostato solo perché
si è accorto del suo arrivo. Ciononostante, Nikkie avanza adagio verso Luit
e, lungo il percorso, raccoglie una grossa pietra da terra. Luit ogni tanto
lancia sguardi furtivi per controllare l'avanzata di Nikkie e poi abbassa lo
sguardo sul proprio pene, che sta perdendo gradualmente l'erezione. Solo
quando il pene è flaccido, Luit si gira e va incontro a Nikkie. Poi, in una
notevole dimostrazione della sua grinta, dà un'annusata sprezzante alla
pietra prima di allontanarsi e lasciare Nikkie da solo con la femmina.
Perché abbiamo seguito un percorso evolutivo che i lupi hanno invece
ignorato? Episodi come quello appena citato - e ce ne sono molti - ci
forniscono una risposta inequivocabile: sesso e violenza. È questo che ha
fatto di noi gli uomini e le donne che siamo oggi. Un lupo fortunato - un
maschio alfa o una femmina alfa - ha la possibilità di accoppiarsi solo una o
due volte all'anno. Molti lupi non fanno mai sesso, senza per questo dare
alcun segno evidente di sentirne la mancanza o di dispiacersi della forzata
astinenza. Da scimmia quale sono, non riesco assolutamente a riflettere in
modo oggettivo sulle questioni sessuali, ma immaginate un etologo
proveniente da Marte, impegnato in uno studio comparativo delle vite
sessuali dei lupi e degli uomini. Non arriverebbe forse alla conclusione che
l'atteggiamento del lupo nei confronti del sesso è, per molti versi,
fondamentalmente sano e misurato? Al lupo piace fare sesso quando può
farlo, ma non ne sente la mancanza quando non può. Se sostituissimo il lupo
con l'uomo e il sesso con l'alcol, potremmo sostenere che l'uomo è riuscito a
sviluppare un atteggiamento sano, destreggiandosi efficacemente tra un
abbandono eccessivo e un'astinenza repressiva. Ma per noi uomini è
impossibile pensare al sesso in questi termini. Siamo costretti a ritenere che
sia naturale e sano sentire la mancanza del sesso quando non possiamo
farlo. La pensiamo così perché siamo scimmie. Se paragonata al lupo, la
scimmia è sesso- dipendente.
È interessante chiedersi perché le cose stiano così. Forse i lupi
semplicemente non sanno che cosa si perdono. O almeno questo è ciò che la
scimmia che è in me vuole pensare. Le lupe hanno un solo ciclo riproduttivo
all'anno: l'intero ciclo dura circa tre settimane e la lupa è fertile soltanto
durante la settimana centrale. In qualsiasi branco, in genere solo la femmina
alfa potrà riprodursi. Le ragioni di questo meccanismo non sono chiare.
Alcuni ricercatori suggeriscono che sia una forma di stress sociale
determinata dal loro status che impedisce alle femmine subordinate di
entrare nel ciclo riproduttivo. Ma si tratta solo di un'ipotesi.
Per contro, le scimmie sanno benissimo che cosa si perdono. Povero,
giovane Brenin, con i suoi tentativi maldestri ed eternamente frustrati di
accoppiarsi con qualsiasi cagna della contea di Tuscaloosa, con il suo rifiuto
di discriminare in base a razza o dimensioni, con il suo totale disprezzo dei
vincoli imposti dalla semplice possibilità fisica... Non aveva ancora
imparato a padroneggiare quel sano e misurato atteggiamento nei confronti
del sesso tanto lodato dal nostro immaginario etologo marziano. Brenin
deve avere avuto il sospetto che si stesse perdendo qualcosa: altrimenti che
senso avrebbero avuto tutti quegli sforzi? Ma, a causa della mia costante
vigilanza, non gli è stato consentito sapere che cosa esattamente si stesse
perdendo, e avrebbe continuato a non saperlo per molti anni a venire.
Naturalmente, quando uno sa che cosa si sta perdendo, arriva a separare il
sesso dalla riproduzione in un modo che Brenin non è stato in grado di fare.
Brenin era motivato da un cieco impulso genetico, non dalla
consapevolezza del piacere che ne sarebbe derivato, dato che non l'aveva
mai provato. Ma noi scimmie sappiamo tutto del piacere. Per il lupo il
piacere è una conseguenza dell'istinto di riproduzione. La scimmia ha
invertito questo rapporto, per cui la riproduzione è un'occasionale, e a volte
inopportuna, conseguenza della ricerca del piacere. Naturalmente non c'è
niente di male in questa inversione scimmiesca. Specie diverse agiscono
secondo concezioni diverse del rapporto tra riproduzione e piacere. Ma non
c'è necessariamente qualcosa di buono in nessuna delle due cose.
L'inversione scimmiesca, comunque, comporta una conseguenza evidente.
La motivazione che spinge a complottare e a ingannare sarà di gran lunga
più forte per le scimmie che per i lupi. Complotti e inganni sono i mezzi di
cui la scimmia si serve per soddisfare la brama dovuta all'inversione
scimmiesca. Il che non significa che i primati non possano complottare e
ingannare per motivi diversi dal sesso: abbiamo visto come la babbuina S si
sia servita dell'inganno per procacciarsi una saporita porzione di loranto.
Noi, però, stiamo cercando di capire sotto quale aspetto le scimmie sono
diverse dai lupi. Un lupo può essere attratto da una porzione di cibo
nascosto esattamente come una scimmia, ma, a differenza della scimmia,
non cercherà di ottenerla con l'inganno. La conclusione, quindi, sembra
essere che le capacità di ingannare della scimmia sono state acquisite in un
diverso contesto e per una diversa ragione. A mio avviso, quel contesto e
quella ragione sono, in parte, forniti dall'inversione scimmiesca del rapporto
piacere- successo riproduttivo.
La storia del pensiero umano - e non solo del pensiero occidentale - è
organizzata intorno a una distinzione tra razionalità o intelligenza da un lato
e piacere o godimento dall'altro. Gli ultimi due elementi vengono relegati
tra i desideri di base o brutali. È la nostra intelligenza o razionalità a
renderci umani e a distinguerci dal resto della natura. Tuttavia io credo che
razionalità e piacere siano molto più intimamente collegati di quanto siamo
stati disposti ad ammettere. La nostra razionalità è, in parte, una
conseguenza della nostra spinta a procurarci il piacere.
Come le motivazioni che spingono a complottare e ingannare sono più
forti per le scimmie che per i lupi, così lo sono anche i rischi. Nikkie non si
accingeva a rimproverare benevolmente Luit: aveva raccolto una grossa
pietra per colpirlo più duramente di quanto gli avrebbero consentito le mani
nude. Ciò che viene spesso tralasciato nel dibattito sui notevoli complotti e
inganni orditi dalle scimmie è un certo tipo di malignità nei metodi usati per
mettere in atto tali complotti. La malignità non ha alcuno spazio nella vita
dei lupi.
Il combattimento tra Brenin e Rugger è stato un'esplosione impulsiva e
improvvisa. Non voglio dire che non si sarebbero uccisi, se ne avessero
avuto la possibilità. Non so con certezza se lo scontro si sarebbe concluso
con la morte, nel caso in cui fosse continuato, ma se fosse andato a finire
così, non ne sarei rimasto sorpreso. Tuttavia, se la conseguenza fosse stata
la morte, non sarebbe stato un risultato voluto. Brenin e Rugger avevano
semplicemente perso la testa. La loro reciproca violenza è stata frutto di un
raptus. È stata un crimine passionale.
Supponiamo che Benin e Rugger, Nikkie e Luit fossero state persone.
Come se la sarebbero cavata in un'aula di tribunale? Brenin e Rugger
sarebbero stati condannati per avere perso il controllo. E se Nikkie si fosse
semplicemente infuriato vedendo Luit esercitare il suo fascino sulla
femmina e lo avesse aggredito sul posto, gli sarebbe stata inflitta una
condanna molto simile. Ma, mentre si avvicinava a Luit, Nikkie si era
fermato per raccogliere una pietra. Se avesse effettivamente attaccato Luit e qualsiasi chiaro segnale di imprudenza da parte di Luit sarebbe stato senza
dubbio sufficiente per scatenare la sua reazione -, la sentenza, giustamente,
sarebbe stata molto più dura. Raccogliere il sasso da terra prova
l'intenzione: per la legge questo basta a dimostrare la premeditazione.
Nikkie avrebbe commesso il suo reato a sangue freddo, non in preda a un
raptus. Con un giudice ragionevolmente comprensivo, il vincitore del
combattimento tra Brenin e Rugger, in caso di morte del perdente, sarebbe
stato condannato per omicidio preterintenzionale.
Ma Nikkie, con la sua pietra in mano, sarebbe stato condannato per
omicidio premeditato. A mio parere, la differenza tra la malignità dei lupi e
quella delle scimmie è sostanzialmente la stessa che esiste tra l'omicidio
preterintenzionale e l'omicidio premeditato.
La premeditazione permea così tante interazioni scimmiesche che non si
può fare a meno di concludere che si tratta di una caratteristica endemica
del carattere dei primati. Anzi, forse il più grande contributo delle scimmie
al mondo - il solo contributo determinante per il quale saranno ricordate
sempre - è l'invenzione della premeditazione. Se il capovolgimento del
rapporto tra riproduzione e piacere è l'inversione scimmiesca, allora
possiamo definire la premeditazione come l'invenzione scimmiesca.
Complotti e inganni diventano molto più importanti, se bisogna
confrontarsi con una creatura capace di premeditazione. Mettetevi nei panni
di Luit, mentre Nikkie gli si avvicina con un'arma in mano. Se Luit fosse
stato un lupo, la situazione per lui sarebbe stata molto più facile. Il maschio
dominante avrebbe potuto attaccarlo, ma Luit avrebbe potuto evitare con
facilità una severa punizione semplicemente sottomettendosi. Ma Nikkie, se
non fosse caduto nell'inganno di Luit, avrebbe picchiato il rivale senza
pietà, quali che fossero state le conseguenze. Luit avrebbe potuto scusarsi
con umiltà, o manifestare in tutti i modi il proprio sincero rimorso, ma il
risultato sarebbe stato lo stesso. Un lupo dimentica e perdona in fretta. Ma
una scimmia è spinta dalla premeditazione e non si intenerisce facilmente.
La scimmia è spietata nei confronti dei suoi simili come il lupo non è e non
potrebbe mai essere.
Immanuel Kant scrisse che due cose gli riempivano l'animo di sempre
nuovo, crescente stupore e timore reverenziale: il cielo stellato sopra di lui e
la legge morale dentro di lui. Kant non era certamente atipico. Un breve
esame della storia del pensiero umano dimostra che diamo valore
soprattutto a due cose. La prima è la nostra intelligenza: quella che ci
consente di capire, tra le altre cose, il funzionamento del cielo stellato sopra
di noi. La seconda è il nostro senso morale: il senso di ciò che è giusto e di
ciò che è sbagliato, di ciò che è buono e di ciò che è cattivo, il senso che ci
rivela il contenuto della legge morale. La nostra intelligenza e la nostra
moralità, crediamo, ci distinguono da tutti gli altri animali. E abbiamo
ragione.
Tuttavia razionalità e moralità non ci sono arrivate completamente
formate come Venere che esce dal mare. La nostra razionalità è certamente
notevole e unica, ma è anche una sovrastruttura eretta sulle fondamenta
della violenza e del desiderio di conseguire il piacere. In Nikkie troviamo
anche, in forma nascente, vaghissime indicazioni di un senso morale: un
primitivo senso di giustizia. Luit ha evitato un grave pestaggio perché
Nikkie non è riuscito a trovare un motivo per agire contro di lui. Ma non è
un caso che un senso della giustizia si sia inizialmente sviluppato in una
scimmia. Se l'attacco di una scimmia a un suo simile è attuato con
premeditazione e non può essere deviato da gesti rituali di conciliazione da
parte della vittima, allora è importante che aggressioni di questo genere non
si verifichino troppo spesso. In caso contrario la comunità si disintegrerebbe
rapidamente. E così, a causa del carattere violento e maligno, nella scimmia
troviamo quantomeno l'inizio di un tipo di sensibilità. C'è una parte di
Nikkie che riconosce, anche se vagamente, che un attacco a Luit deve avere
un movente, fornito dalla presenza di prove adeguate. Tali prove
giustificano l'attacco e lo autorizzano. Movente, prove, giustificazione,
autorizzazione: solo un animale davvero cattivo ha bisogno di questi
concetti. Più l'animale è sgradevole, più è maligno, più è chiuso alla
possibilità di conciliazione, più ha bisogno di un senso della giustizia. La
scimmia è unica, sola in tutta la natura: solo lei è abbastanza sgradevole da
essere diventata un animale morale.
Il meglio di noi ha origine dal peggio. Non è necessariamente un male.
Ma è qualcosa che forse faremmo bene a tenere sempre presente.
Quattro. La Bella e la Bestia
Quando Brenin era un giovane lupo, il suo gioco preferito consisteva nel
rubare i cuscini del divano o della poltrona. Se io mi trovavo in un'altra
stanza, se magari stavo lavorando nello studio, Brenin compariva sulla
soglia con il cuscino in bocca, e, appena capiva che l'avevo visto, si lanciava
in una folle corsa per tutta la casa, in soggiorno, in cucina e infine in
giardino, sempre con me alle calcagna. Era un gioco d'inseguimento e
poteva continuare per un bel po'. Nel corso dell'addestramento gli avevo già
insegnato a lasciare cadere gli oggetti - era una delle funzioni del comando
«Out!» -, per cui avrei potuto ordinargli di mollare il cuscino in qualunque
momento. Ma non ne avevo il cuore e comunque il gioco era troppo
divertente. E così Brenin zigzagava sfrecciando per tutto il giardino, con le
orecchie appiattite, la coda bassa e gli occhi scintillanti di eccitazione,
mentre io gli correvo dietro, chiamandolo invano. Fino all'età di tre mesi
circa, Brenin era abbastanza facile da raggiungere e acchiappare, per cui
facevo solo finta che fosse troppo veloce per me. Ma la finzione si
trasformò gradualmente in realtà. Non passò molto tempo prima che Brenin
cominciasse a esibirsi in piccole finte: accennava ad andare in una direzione
per poi invece scattare nell'altra. Quando capii il trucco, lui passò alle
doppie finte. Con il tempo il gioco diventò un veloce, confuso susseguirsi di
finte, doppie finte e triple finte: finte annidate dentro altre finte.
Sono sicuro che, quando era in forma e nel pieno del gioco, Brenin non
avesse idea di cosa avrebbe fatto l'istante successivo. E di conseguenza non
ne avevo la più pallida idea neppure io. Naturalmente questo allenamento al
dribbling ebbe grandi effetti sulle mie abilità rugbistiche. Avevo sempre
basato il mio gioco sull'idea di travolgere l'avversario e passarci sopra
piuttosto che aggirarlo. La cosa funzionava bene in Gran Bretagna, ma non
altrettanto negli Usa, dove in genere la popolazione è molto più grande e
grossa e cresce giocando a football, sport in cui il placcaggio è feroce. Gli
americani, però, si lasciano confondere molto più facilmente e, con tutte
quelle lezioni di Brenin, diventai un asso del dribbling negli Stati Uniti
sudorientali.
Il fatto che non riuscissi più a prenderlo suscitò in Bre-nin una certa
sfrontatezza, che lui espresse in una prima variante del gioco. Dopo avermi
adeguatamente sfinito, mi si piazzava davanti e lasciava cadere il cuscino a
metà strada tra noi. «Dai!» era il messaggio. «Prendilo!». Appena mi
chinavo per afferrarlo, Brenin spiccava un balzo, azzannava il cuscino e
l'inseguimento ricominciava da capo. Per quanto fossi veloce nel chinarmi
per afferrare il cuscino, Brenin era sempre un po’ più veloce di me. La sua
era un'abilità che poteva essere utilmente impiegata per altri scopi: una volta
si esibì nello stesso gioco con un pollo appena cotto che aveva rubato in
cucina durante una mia momentanea distrazione. Avrei potuto ordinargli di
posarlo, naturalmente. Ma a quale scopo? Non avevo una gran voglia di
quel pollo dopo che Brenin se l'era tenuto in bocca, e così passammo a
giocare all'inseguimento.
Alcuni istruttori professionisti guarderebbero il nostro gioco con orrore.
Lo so perché me l'hanno detto. L'obiezione che muovevano era duplice. In
primo luogo, era probabile che il gioco, per la sua stessa natura, rendesse
Brenin più eccitabile, caratteristica che è meglio non incoraggiare in un
lupo. In secondo luogo, i miei costanti fallimenti nel raggiungerlo e
bloccarlo potevano indurlo a concludere di essermi fisicamente superiore e,
di conseguenza, spingerlo a sfidarmi per lo status di alfa. Forse erano timori
legittimi, ma con Brenin non si concretizzarono mai. E questo, ritengo,
perché i giochi si svolgevano sempre secondo un rituale ben definito, che
aveva un inizio e una fine molto precisi. Se ero in soggiorno, non
permettevo mai a Brenin di prendere i cuscini. I suoi tentativi venivano
repressi da un deciso «Out!». Questo gli comunicava che il gioco era
qualcosa che poteva essere fatto solo in determinati momenti. E il gioco
aveva sempre una conclusione chiara. Io dicevo: «Ok, adesso basta» e gli
ordinavo di portarmi il cuscino. A quel punto rientravamo in casa e gli davo
una piccola prelibatezza, cosa che rafforzava il concetto di fine del gioco e,
allo stesso tempo, gli faceva associare la fine a qualcosa di buono.
Tutto questo funzionò benissimo per un certo tempo. Ma, intorno ai nove
mesi, Brenin decise di portare il gioco a un livello più avanzato. Una
mattina, mentre stavo scrivendo nello studio, sentii una successione di tonfi
rumorosi provenire dal soggiorno. Non contento di portare in giardino i
cuscini, Brenin aveva deciso che poteva essere una buona idea portare fuori
anche la poltrona. E i tonfi erano provocati dalla poltrona che cozzava
contro il telaio della porta mentre Brenin cercava di farla passare. Fu allora
che mi resi conto che si rendeva necessario un approccio più radicale al
problema del suo intrattenimento, un approccio basato sulla premessa che,
tutto considerato, sarebbe stato meglio per tutti e due se Brenin fosse stato
costantemente esausto. E così cominciammo a correre insieme.
Cercare di tenere un lupo sotto controllo assicurandosi che sia
costantemente esausto è un approccio, ma un attimo di riflessione vi dirà
che non è molto astuto. Certo, inizialmente le nostre corse stancarono
Brenin. E anche me, ma questo aveva meno importanza, dato che non ero io
quello che cercava di trascinare i mobili in giardino. Brenin, d'altra parte,
diventava sempre più robusto e quindi sempre più in grado di provocare
disastri in casa in qualsiasi momento. In breve tempo arrivò a considerare
come blande sgambate quelle corse che all'inizio lo facevano crollare in un
sonno esausto per il resto della giornata. E così le corse divennero, per
necessità, sempre più lunghe. Ma, naturalmente, Brenin divenne sempre più
allenato, cosicché potete forse immaginare che piega stava prendendo la
situazione. La bicicletta avrebbe potuto essere un'opzione. Ma all'epoca la
gente in Alabama non apprezzava molto le biciclette, come scoprii in
occasione di un incidente che coinvolse me, la mia bicicletta e alcuni
bifolchi reazionari sbronzi, completi di mazza da baseball e pick-up, un
incidente nel quale rimasi quasi decapitato. In Alabama, a quei tempi, solo i
piscialetto sinistroidi, comunisti e hippie viaggiavano grazie
all'autopropulsione. E così l'opzione della bicicletta non era troppo allettante
per me.
Quindi continuai a correre, e Brenin continuò a correre con me. E tutti e
due diventammo più forti, più snelli e più duri. Questa pragmatica foga per
la mia recentemente scoperta forma fisica, però, si trasformò presto in
qualcos'altro. Durante le nostre corse mi resi conto di una realtà profonda
che induceva umiltà: ero in presenza di una creatura che, sotto la maggior
parte degli aspetti, era indubbiamente, palesemente, irrimediabilmente e
categoricamente superiore a me. Quello fu un momento di svolta nella mia
vita. Io sono un tipo sicuro di sé. Se la gente non pensa che sia arrogante ma forse lo pensa - è solo perché sono bravo a nasconderlo. Non ricordavo
di essermi mai sentito così in presenza di un essere umano. Non era
assolutamente da me. Ma adesso mi accorgevo che avrei voluto essere meno
me stesso e più Brenin.
La mia presa di coscienza fu fondamentalmente di tipo estetico. Quando
correvamo, Brenin scivolava sul terreno con un'eleganza e un'economia di
movimenti che non avevo mai visto in un cane. Quando un cane trotta, per
quanto raffinata ed efficiente sia la sua andatura, c'è sempre una piccola
componente verticale nel movimento delle zampe. Se avete un cane,
osservatelo attentamente la prossima volta che lo portate fuori. Quando le
zampe si spostano in avanti, si muovono anche in su e in giù, magari solo
leggermente. E questo movimento delle zampe si trasmette alla linea delle
spalle e del dorso: se guardate bene, li vedrete alzarsi e abbassarsi mentre
l'animale avanza. A seconda del tipo di cane, tale movimento può essere
evidente o quasi impercettibile, ma c'è sempre, se guardate con attenzione.
In Brenin non lo si vedeva affatto. Per spingersi avanti, un lupo usa le
caviglie e le grandi zampe. Ne consegue che c'è molto meno movimento
negli arti, che restano diritti e si muovono avanti e indietro, ma non in su e
giù. Perciò, quando Brenin correva, spalle e dorso restavano piatti e
orizzontali. Visto da lontano, dava l'impressione di galleggiare a qualche
centimetro da terra. Quando era particolarmente felice, o soddisfatto di sé, si
esibiva in balzi esagerati. Ma la sua andatura di default era lo
«scivolamento». Brenin ormai se n'è andato e, quando cerco di
visualizzarlo, è difficile dare al quadro i dettagli necessari perché diventi
una rappresentazione viva e concreta. Ma l'essenza di Brenin c'è ancora per
me. Posso ancora vederlo: il lupo spettrale nella foschia del primo mattino
dell'Alabama, che scivola senza sforzo sul terreno, silenzioso, fluido e
sereno.
Il contrasto con la scimmia ansimante e rumorosa che gli correva accanto
con il passo pesante non avrebbe potuto essere più pronunciato e
deprimente. Avrei voluto correre con lunghe falcate silenziose. Avrei voluto
galleggiare anch'io a qualche centimetro da terra, ma per quanto diventassi
bravo nella corsa - e diventai molto bravo - ciò non accadde mai. Aristotele
distingueva tra l'anima delle piante e quella degli animali. Le piante,
sosteneva, hanno meramente un'anima vegetativa, la cui funzione consiste
nell'assimilare, elaborare ed espellere cibo. Gli animali, invece, hanno
un'anima sensitiva, che comprende la sensibilità e il movimento. Il fatto che
Aristotele caratterizzasse l'anima degli animali in termini di movimento non
era casuale, credo. Contrariamente a quanto mi è stato insegnato da
studente, non credo che il filosofo greco volesse dire semplicemente che gli
animali si muovono e le piante no.
In genere non gli piacevano le banalità. Io penso piuttosto che, se volete
capire l'anima del lupo - l'essenza del lupo -, allora dovete osservare il modo
in cui il lupo si muove. Ed è con tristezza e rimpianto che sono arrivato a
capire che il goffo e sgraziato agitarsi della scimmia è l'espressione della
goffa e sgraziata anima che c'è dentro di lei.
Nonostante questo caso piuttosto sfortunato di invidia della specie, la mia
trasformazione fisica progredì velocemente. A un anno Brenin era alto
ottantasei centimetri al garrese e pesava cinquantaquattro chili. Diventando
adulto, sarebbe cresciuto di un altro paio di centimetri e di altri quattordici
chili. Era incredibilmente forte. E quindi io dovevo diventare più forte. Da
un lato, non potevo permettergli di sfidarmi per lo status di alfa e, dall'altro,
avevo la responsabilità di mantenerlo sotto controllo in presenza di cani.
Incidenti come quello con Rugger erano rari soprattutto perché Brenin
faceva quello che gli dicevo di fare. Ed ero deciso a continuare così. Perciò
quattro o cinque volte alla settimana lasciavo Brenin a qualcuno per un paio
d'ore, andavo in palestra e mi allenavo più di quanto avessi mai fatto in vita
mia. E così a ventisette anni - Brenin ne aveva uno - pesavo novanta chili
per un metro e settantacinque (nessun cambiamento nell'altezza dopo i
dodici anni). La mia percentuale di grasso corporeo era dell'otto per cento. E
alla panca riuscivo a sollevare centoquarantatré chili.
In piedi riuscivo a sollevarne almeno cinquantacinque. Lo so non perché
lo facessi in palestra, ma a causa del metodo di cui mi servivo per separare
Brenin dai cani. Le lotte vere, come ho detto, erano rare. Ma ero diventato
abbastanza bravo a prevedere quando stava per iniziare un combattimento.
A quel punto afferravo Brenin ai lati del collo e lo sollevavo, portando la
sua faccia a livello della mia. Lo fissavo negli occhi ambrati e gli
sussurravo: «Vuoi vedertela con me, figliolo?». So che la frase suona
terribilmente da macho, e immagino che lo fosse. Se andate in palestra
cinque giorni alla settimana, una settimana dopo l'altra, avrete un mucchio
di testosterone che vi scorre dentro. Ma, oltre al machismo, c'era del
metodo. I lupi trasportano i loro cuccioli tenendoli per la collottola. Così, i
piccoli smettono di divincolarsi e si lasciano portare tranquillamente.
Sollevando Brenin per il collo, rafforzavo il fatto che nel nostro rapporto io
ero suo padre e che quindi lui doveva smettere di divincolarsi e protestare.
Credo che Brenin sapesse benissimo che cosa stava succedendo: io gli
presentavo uno scenario facilmente comprensibile, che comportava la fine
di qualunque cosa avesse avuto in mente. In realtà il metodo funzionava
solo con la sua attiva complicità. Ritto sulle zampe posteriori, era alto
almeno quanto me. Di conseguenza potevo alzarlo davvero da terra solo
perché, quando lo afferravo per il collo e cominciavo a sollevarlo, lui
piegava le zampe posteriori sotto di sé, come un coniglio estratto dal
cappello di un prestigiatore.
Un pomeriggio, durante la lunga, calda e umidissima estate dell'Alabama,
decisi di andare a correre. Decisi anche, fatto insolito, di lasciare a casa
Brenin. Nei due o tre giorni precedenti non era stato benissimo e non volevo
mettere a repentaglio la sua salute a causa del caldo e dell'umidità. Brenin
disapprovò con forza la mia decisione ed espresse con chiarezza il suo
disappunto. Lo lasciai a casa sotto la sorveglianza di un'amica.
Dopo una serie piuttosto breve di tentativi ed errori Brenin riuscì ad aprire
il cancello del giardino - in pratica scardinandolo - e si lanciò al mio
inseguimento. Dato che non avevamo un percorso fisso - lo cambiavamo
ogni giorno - immagino che abbia seguito il mio odore. Stavo correndo da
dieci minuti quando sentii uno stridore di freni e, subito dopo, un sonoro e
sgradevole tonfo. Mi voltai e vidi Brenin a terra, investito da uno Chevrolet
Blazer, che, per quelli di voi che non sono americani, è un Suv. La versione
europea è la Opel Frontera, ma il Blazer, essendo americano, è più grosso.
Un momento prima mi era passato accanto alla velocità di settanta- ottanta
chilometri all'ora. Brenin rimase disteso ululando per alcuni secondi,
durante i quali mi si fermò il cuore, e poi si rialzò e corse nel bosco che
fiancheggiava la strada. Ci misi quasi un'ora per trovarlo. Ma, quando ci
riuscii, vidi che stava sostanzialmente bene. Jennifer, la nostra veterinaria,
mi confermò che c'erano solo pochi tagli e qualche abrasione, ma nessuna
frattura. E in un giorno o due Brenin tornò alla normalità. In effetti se la
cavò molto peggio il Suv.
Se quell'auto avesse investito me, mi avrebbe ucciso. Bre-nin, invece,
guarì dalle ferite in pochi giorni. E, psicologicamente, non sembrava esserci
alcuna cicatrice. Il giorno dopo l'incidente Brenin mi stava già tormentando
perché lo portassi a correre e in seguito non diede mai segni di paura delle
auto che gli sfrecciavano accanto in strada. Era un animale molto forte e
sicuro di sé, fisicamente e psicologicamente. Voglio che lo teniate bene in
mente quando leggerete la prossima storia.
Stavamo di nuovo correndo, ma questa volta qualche anno dopo. Ci
eravamo trasferiti in Irlanda, precisamente a Cork, e correvamo insieme
lungo la riva del fiume Lee. Dopo esserci lasciati alle spalle il Lee Valley
Park, puntammo verso i campi popolati di mucche che fiancheggiano il
fiume. La maggior parte della gente pensa alle mucche come a creature
stolide e ottuse, la cui vita trascorre in un grigiore di immobilità,
ruminazione e sguardi persi nel vuoto. Brenin e io, però, sapevamo che le
cose stavano diversamente. Ogni tanto, quando c'è il sole giusto e il vento
porta con sé la promessa dell'estate, le mucche dimenticano quello che sono
- quello che millenni di allevamento selettivo le hanno fatte diventare - e
ballano e cantano, festeggiando la gioia di essere vive in una giornata
simile.
Le mucche sembravano provare per Brenin una straordinaria simpatia,
sentimento chiaramente contraccambiato. In giornate primaverili come
quella descritta, non appena ci vedevano ci correvano incontro dagli angoli
più lontani dei campi, muggendo il loro saluto. Sospetto che si
comportassero così perché erano state da poco separate a forza dai loro
vitelli - erano vacche da latte - e probabilmente scambiavano Brenin per un
loro simile, un giovane figliol prodigo tornato alla verde erba di casa. E
forse Brenin pensava che l'avessero preso per un dio: il dio delle mucche.
Comunque stessero le cose, trottava da loro e a ognuna dava una leccata sul
grosso naso bagnato. I cani potevano anche non piacergli, ma delle mucche
era entusiasta.
In quei campi c'erano recinzioni elettrificate per evitare che gli animali
sconfinassero. Sulla via del ritorno, a un certo punto afferrai saldamente il
collare di Brenin, dato che avevo visto, poco più avanti, il sanbernardo
Paco. Brenin era ancora ufficialmente ostile a tutti i grossi cani maschi, e
non mi andava molto l'idea di dovere intervenire per separare quei due.
Mentre stringevo il collare, ci chinammo sotto una delle recinzioni
elettrificate, che sfiorai con un gomito. La scossa si trasmise a Brenin, il
quale schizzò via di corsa in modo così poco dignitoso da ricordare più un
gatto scottato che il dio delle mucche, sfrecciando davanti a un Paco
piuttosto perplesso. Si fermò solo quando arrivò alla nostra auto, distante
circa tre chilometri. Era là che mi aspettava, quando lo raggiunsi, ansioso e
senza fiato. Avevamo fatto quel percorso quasi tutti i giorni, con la pioggia
o con il sole, per buona parte di un anno. Ma Brenin non volle più tornarci.
Si rifiutò categoricamente e non cambiò idea nonostante i miei tentativi di
convincerlo con la supplica, la corruzione o la coercizione. Ecco quanto è
terribile l'elettricità per i lupi. Ecco quanto devono odiarla.
Forse potreste pensare che Brenin stesse recitando un po'. Dopotutto si era
trattato solo di una leggera scossa elettrica. Se siete tentati di vederla così,
pensate al Blazer. Tutto sommato, sembra proprio che per Brenin subire una
piccola scossa fosse molto peggio che essere investito da un Suv.
Se volete vedere la malvagità umana in tutta la sua purezza, ingegnosità e
disinvoltura, la troverete in uno shuttlebox. È uno strumento di tortura
inventato da R. Solomon, L. Kamin e L. Wynne, psicologi di Harvard.
Consiste in una gabbia divisa in due scomparti da una barriera. Il pavimento
di entrambi gli scomparti è costituito da una griglia elettrificata. Solomon e
i suoi collaboratori mettevano un cane in uno dei due scomparti e poi gli
applicavano una forte scossa elettrica alle zampe. Istintivamente, il cane
saltava da uno scomparto all'altro. La procedura veniva ripetuta parecchie
centinaia di volte nel corso di un esperimento tipico. Di volta in volta, però,
il salto diventava più difficile, perché gli sperimentatori alzavano
gradualmente la barriera. Alla fine il cane non riusciva più a saltare e si
lasciava cadere sulla griglia elettrificata: un rottame ansimante, ululante e in
preda agli spasmi. In una variante gli sperimentatori facevano passare la
corrente nel pavimento di entrambi gli scomparti. Ovunque fosse saltato, il
cane avrebbe comunque subito una scossa. Ciononostante, dato che il dolore
provocato dalla scossa era intenso, il cane cercava di scappare, per quanto il
tentativo fosse vano. E così saltava da una griglia elettrificata all'altra. I
ricercatori, nella documentazione dell'esperimento, riferirono che il cane
emetteva «un acuto grido anticipatorio che si trasformava in un guaito
quando atterrava sulla griglia elettrificata». Il risultato finale era lo stesso.
Esausto, il cane giaceva sul pavimento urinando, defecando, guaendo,
tremando. Dopo alcuni giorni - da dieci a dodici - di esperimenti di questo
genere, l'animale smetteva di resistere alla scossa elettrica.
Se fossero stati scoperti a fare cose simili nell'intimità delle loro case,
Solomon, Kamin e Wynne sarebbero stati incriminati, multati e
probabilmente avrebbero avuto la proibizione di tenere animali da
compagnia per un periodo dai cinque ai dieci anni. Sarebbero dovuti andare
in carcere. Ma siccome, invece, svolgevano quel lavoro in un laboratorio di
Harvard, furono ricompensati con gli equivoci simboli del successo
accademico: stile di vita piacevole, generoso stipendio, adorazione degli
studenti e gelosia dei colleghi. Torturare cani fu ciò che fece fare carriera a
tutti loro e generò un'intera dinastia di imitatori. Quel tipo di esperimenti
continuò per più di tre decenni. L'epigono più famoso, Martin Seligman, è
stato un recente presidente dell'American Psychological Association.
Seligman adesso non fa più cose del genere. Il suo argomento di studio
adesso è la felicità. Naturalmente i cani non figurano mai in esperimenti che
li rendono felici. A loro è consentito trovarsi soltanto negli esperimenti
orrendi.
Perché veniva permessa quella tortura? Perché si pensava che costituisse
una valida ricerca? Gli esperimenti furono pensati per dimostrare il modello
della cosiddetta «impotenza appresa» usato per spiegare la depressione:
l'idea era che la depressione fosse qualcosa che poteva essere imparata. Per
un po’ gli psicologi l'accettarono come un risultato di grande importanza.
Tuttavia nessun essere umano trasse mai alcun beneficio da quegli
esperimenti. In seguito - dopo trent'anni di elettrocuzioni di cani e altri
animali vari - si giunse alla conclusione che il modello non reggeva affatto a
un approfondito esame critico.
Io credo che in quegli esperimenti si possa vedere un istruttivo distillato
della malvagità umana.
Il male ha passato un brutto momento successivamente.
Non nel senso che non ce n'è più molto in giro - anzi, è vero il contrario -,
ma nel senso che molte persone, ritenute intelligenti, sono restie ad
ammetterne l'esistenza. Pensano al male come a un'antiquata reliquia
medievale: una forza soprannaturale emanata dal Demonio, il quale svolge
la sua diabolica opera insinuando il male nel cuore degli uomini e delle
donne. È per questo che oggi tendiamo a mettere la parola «male» tra
virgolette. Ciò che chiamiamo «male» è un problema medico - il risultato di
qualche forma di malattia mentale - o un problema sociale, il risultato di
questo o quel malessere della società. Le conseguenze sono due. In primo
luogo, il «male» è qualcosa che esiste solo ai margini della società, nei
soggetti psicologicamente o socialmente svantaggiati. In secondo luogo, il
male non è mai colpa di qualcuno. Se un individuo compie atti che
potremmo essere tentati di definire «malvagi», non può essere ritenuto
responsabile di ciò che fa. O è mentalmente malato, oppure le condizioni
sociali non gli hanno dato alcuna possibilità. Potrà essere clinicamente o
socialmente disfunzionale, ma non moralmente malvagio. Il male non è mai
ciò che sembra essere: è sempre qualcos'altro.
Io credo che questo sia del tutto sbagliato. La moderna, e apparentemente
illuminata, concezione del male ha smarrito qualcosa di davvero importante.
Non voglio certo difendere il concetto medievale di male come forza
soprannaturale. Ma i due pilastri su cui poggia la moderna concezione del
male - e cioè che il male esiste solo ai margini della società e non è mai
realmente colpa di qualcuno - non possono a mio avviso essere accettati.
Voglio proporvi invece una descrizione del male ingannevolmente
semplice. Primo, il male consiste in cose molto malvagie. Secondo, gli
individui malvagi sono coloro che fanno cose molto cattive a causa di una
loro mancanza di qualche tipo.
Cominciamo cercando di capire come mai siamo diventati così diffidenti
dell'idea del male. La moderna diffidenza nei confronti del male si basa sul
presupposto che le azioni malvagie richiedano individui malvagi e che gli
individui malvagi debbano agire spinti da motivazioni malvagie. E se uno
non ha alcun controllo sulle proprie motivazioni - perché è malato o
socialmente disadattato - ne consegue che non ha alcun controllo sulle
proprie azioni. Questo collegamento tra azioni malvagie e motivazioni
malvagie non è casuale. Risale alla distinzione medievale tra male morale e
male naturale. Filosofi medievali come Tom maso d'Aquino osservavano
che il male - al quale pensavano come a dolore, sofferenza e fenomeni
collegati - poteva avere due diverse cause: gli eventi naturali e l'azione
umana. Terremoti, inondazioni, uragani, malattie, siccità e così via possono
provocare gravi e prolungate sofferenze: era questo che i filosofi dell'epoca
definivano «male naturale». E lo distinguevano dal dolore e dalla sofferenza
causati dall'azione umana - il male provocato dagli uomini - che
chiamavano «male morale». Ma l'idea dell'azione - dell'agire - comporta
l'idea di una motivazione o intenzione. Un terremoto non ha motivazioni.
Non agisce. Semplicemente accade. Gli uomini, per contro, possono agire,
possono fare cose. Ma fare qualcosa - e non meramente lasciare che accada
- richiede di agire con una motivazione. Cadere dalle scale non è qualcosa
che si fa: è qualcosa che succede. Le vere azioni richiedono motivazioni. Si
è quindi arrivati alla conclusione (anche se non strettamente conseguente)
che è malvagio colui che agisce spinto da motivazioni malvagie.
Il risultato è un concetto altamente intellettualizzato del male morale. Un
valido esempio è fornito da Colin McGinn, un amico e uno dei migliori
filosofi attuali, secondo il quale il male morale è essenzialmente una sorta di
Schadenfreude, un trarre piacere dal dolore, dalla sofferenza o dalla
disgrazia altrui (anche se, a dire il vero, non credo che McGinn intendesse
questa definizione come una descrizione generale del male morale). Può
sembrare un buon sistema per capire il male. Di sicuro è male trarre piacere
dal dolore, dalla sofferenza o dalla disgrazia di qualcun altro, no? E di
sicuro un individuo che prova piacere per le sofferenze altrui è un ottimo
esempio di persona malvagia, no? In realtà io non credo affatto che questa
idea possa funzionare.
Una ragazzina è vittima di prolungati abusi, regolarmente stuprata dal
padre fin da bambina. Inorriditi, potreste chiedere - come ho fatto io - che
cosa facesse la madre in quella situazione. Non si rendeva conto di ciò che
stava succedendo? La risposta della ragazzina mi ha raggelato fino alle ossa,
e continua tuttora a raggelarmi, quando ci ripenso. Quando il padre tornava
a casa ubriaco, violento e pronto a picchiare - un fatto abituale nella vita
della famiglia -, la madre le diceva, così ha riferito la ragazza, di andare da
lui e tenerlo buono. Ogni volta che voglio fissarmi bene in mente
un'immagine della malvagità umana, mi basta pensare alla donna che diceva
a sua figlia di «andare da lui e tenerlo buono».
Ci sono due manifestazioni di malvagità in questa storia: i ripetuti episodi
di stupro da parte del padre e la complicità attiva della madre. E non è facile
stabilire quale sia la peggiore. La madre era una vittima, senza dubbio, ma
era per questo meno malvagia? Usava il corpo della figlia, la sua innocenza
e quasi certamente ogni sua prospettiva di futura felicità per comprarsi un
attimo di sollievo dal mostruoso marito. Dobbiamo presumere che la sua
malvagità fosse alimentata dal terrore, e non da una sorta di piacere per la
sofferenza e la disgrazia della figlia, ma questo non cambia il fatto che le
sue azioni erano tra le più malvagie che si possano immaginare. Pensate a
questo, quando vi dite che le vittime non possono essere malvagie. Se né il
padre né la madre di quella ragazza erano malvagi, è difficile immaginare
qualcuno che possa esserlo.
Comunque, né nel caso della madre né in quello del padre il male può
essere adeguatamente compreso in termini di motivazioni, perlomeno non
del tipo ritenuto decisivo da McGinn. Chi può sapere quali erano le
motivazioni del padre? Forse capiva che quello che stava facendo era male,
forse no. Supponiamo di no. Supponiamo che ritenesse lo stupro della figlia
un aspetto del tutto naturale della vita familiare, magari perché era cresciuto
in una situazione analoga. Forse pensava semplicemente che fosse così che
si faceva. Forse, come padre che aveva messo al mondo la figlia, era
convinto che fosse suo diritto averne il dominio assoluto: il diritto del
creatore sulla propria creatura. Forse credeva di farle addirittura un favore,
preparandola, nel modo più educativo possibile, alla sua futura vita
sessuale.
Tutto quello che posso dire è: a chi interessa che cosa pensava? Non c'è
alcun bisogno di speculare sulle sue motivazioni. Anche se lui pensava di
non fare niente di male - perfino se pensava di fare bene - la sua malvagità
non ne risulta affatto diminuita. Le sue azioni restano tra le più malvagie
che si possano immaginare.
Si può essere malvagi - come lo era la madre - perché si viene meno al
proprio dovere di protezione, e il terrore che si prova è irrilevante. Si può
essere malvagi - come il padre nella nostra ricostruzione totalmente
speculativa delle sue motivazioni - perché si è irrimediabilmente stupidi.
Ma in nessuno dei due casi il male che uno fa ha qualcosa a che vedere con
il trarre piacere dal dolore, dalla sofferenza o dalla disgrazia altrui. La
malignità deliberata, a mio parere, ha ben poco a che vedere con l'essenza
del male. Con questo non voglio dire che tale malignità non abbia un ruolo
nella perpetrazione di atti malvagi: in alcuni casi è chiaramente così. Sono
convinto però che casi del genere siano relativamente rari.
Ora spostiamoci avanti di qualche anno, almeno nella nostra
immaginazione: dalle sofferenze della figlia alla condanna dei genitori.
Supponiamo che, a un certo punto, padre e madre siano stati arrestati e
puniti (se poi la punizione possa mai essere sufficiente è tema di
discussione). Non so bene quali possano essere state le reazioni emotive
della figlia in quelle circostanze. Probabilmente un po’ confuse, direi. Ma
supponiamo di no. Supponiamo che la ragazza fosse assolutamente
contenta. Supponiamo, inoltre, che fosse contenta non perché pensava che
la lunga detenzione potesse riabilitare i genitori - finalmente avrebbero
ricevuto l'aiuto di cui avevano bisogno - né perché, se non altro, adesso loro
non avrebbero potuto fare a nessun altro quello che avevano fatto a lei, né
per l'effetto deterrente che la condanna avrebbe avuto su altri pedofili.
Supponiamo che fosse contenta per una ragione molto più semplice e
basilare: la vendetta.
Immaginiamo che sperasse che la punizione del padre non sarebbe stata
semplicemente la perdita della libertà. Immaginiamo che sperasse che lui si
sarebbe ritrovato in cella insieme a un tizio grande e grosso con una certa
predilezione per la sodomia e lo stupro, in modo da avere «un assaggio della
sua stessa medicina». Sarebbe una speranza malvagia? La ragazza sarebbe
una persona malvagia per il fatto di nutrire tale speranza? Io credo di no.
Penso che il suo desiderio di vendetta possa essere spiacevole. Può essere la
spia di cicatrici psicologiche permanenti, che portano a un'incapacità di
andare davvero avanti con la propria vita. Può darsi. Ma, date le circostanze,
sarebbe difficile affermare che la ragazza è malvagia. Godere delle
disgrazie di persone malvagie - quando hai sofferto personalmente per causa
loro - può non essere un fulgido esempio di maturità e sviluppo morale. Ma
è ben diverso dall'essere una persona malvagia.
Quindi, ritengo che la Schadenfreude non sia una condizione né
necessaria né sufficiente per essere un individuo malvagio. Non è necessaria
perché potete essere malvagi anche se non traete piacere dal dolore, dalla
sofferenza o dalla disgrazia altrui. Potete essere malvagi, come lo era la
madre, perché non fate il vostro dovere. E potete essere malvagi, come lo
era il padre nella nostra ricostruzione delle sue motivazioni - speculativa e
presumibilmente controfattuale - perché avete delle convinzioni
fondamentalmente stupide. La Schadenfreude non basta per essere una
persona malvagia. Godere del dolore di altri, se malvagi e specialmente se
avete sofferto per causa loro, non vi rende automaticamente malvagi.
Molte persone inorridirebbero se mettessi gli esperimenti di Solomon,
Kamin e Wynne sullo stesso piano del caso della ragazza violentata, come
se ciò in qualche modo sminuisse la sofferenza di quest'ultima. Ma una
simile reazione non ha fondamento nella logica. I due casi sono simili,
perché alla base di entrambi c'è l'esistenza di cose molto cattive: dolore e
sofferenza a un livello che la maggior parte di noi non è neppure in grado di
immaginare. E queste cose molto cattive sono il risultato di un certo tipo di
mancanza da parte di coloro che le hanno perpetrate: si tratta, in ultima
analisi, del mancato adempimento del dovere. Ma ci sono due tipi diversi di
dovere coinvolti.
Da un lato c'è un mancato adempimento del proprio dovere morale. Il
particolare dovere in questione consiste nel proteggere gli indifesi da coloro
che li giudicano inferiori e perciò sacrificabili. Se questo non è un obbligo
morale basilare, è difficile immaginare che cosa possa esserlo. La madre era
colpevole di questa mancanza e, nelle circostanze date, il suo indubbio
terrore del marito può mitigare, ma non cancellare la sua colpa.
C'è tuttavia un altro tipo di dovere coinvolto: quello che i filosofi
chiamano «dovere epistemico». È il dovere di sottoporre le proprie
convinzioni a un adeguato esame critico: verificare, cioè, se tali convinzioni
sono giustificate dalle prove disponibili e almeno tentare di accertare se
esistano o no prove che le controbilancino. Oggi abbiamo scarsa
considerazione per il dovere epistemico: è accettato in misura talmente
limitata che la maggior parte della gente non lo considererebbe neppure
come un dovere (e questo, di per sé, è una mancanza di dovere epistemico).
Nella nostra - forse implausibile - ricostruzione delle sue motivazioni, il
padre era colpevole di questo tipo di mancanza.
Constatiamo analoghe mancanze nel caso di Solomon, Kamin e Wynne e
dei loro numerosi epigoni. Troviamo, naturalmente, opinioni ridicole e
ingiustificate: la convinzione, per esempio, che torturare cani con
l'elettricità possa rivelare qualcosa di interessante sulla natura della
depressione umana, con tutte le sue molteplici cause, eziologie e sindromi.
Anche in loro rileviamo una deroga a un dovere morale, quello di
proteggere una creatura indifesa e cosciente dal tipo di sofferenza che la
maggior parte di noi, grazie a Dio, non può neppure immaginare.
Noi uomini non riusciamo a vedere il male nel mondo perché siamo
talmente distratti da motivazioni abbaglianti e ammiccanti da non notare la
bruttezza che c'è sotto. Essere distratti in questo modo è una mancanza
esclusivamente umana. Ogni volta che guarderemo con attenzione il male,
in tutte le sue varie forme e apparenze, troveremo a guardarci di rimando il
mancato adempimento del dovere epistemico e del dovere morale. Il male è
il risultato dell'esplicita intenzione di causare dolore e sofferenza, e provare
piacere nel farlo è una rara eccezione.
Tutto questo comporta una conseguenza notevole: ci sono più atti malvagi
e più individui malvagi di quanti ci piaccia immaginare o ammettere.
Quando pensiamo al male in termini di malattia o di fallimento sociale,
consideriamo il male come eccezionale, qualcosa che risiede ai margini
della società. Ma, in realtà, il male pervade l'intera società. Si insinua in
padri che abusano delle figlie e in madri complici. Ma anche in privilegiati e
felici psicologi di Harvard, presunti esperti nel campo della salute mentale,
che, possiamo supporre, agivano spinti dalle migliori intenzioni nei
confronti dell'umanità. Io ho commesso azioni malvagie, molte. E lo stesso
avete fatto voi. Il male è quotidiano, è un luogo comune. È banale.
Nel suo brillante studio sul processo di Adolf Eichmann, Hannah Arendt
introduce l'idea della banalità del male. La Arendt sostiene che i crimini
commessi da Eichmann nella sua veste di funzionario responsabile dello
sterminio sistematico degli ebrei da parte del regime nazista non scaturivano
da un suo desiderio di infliggere dolore o degradazione ai suoi prigionieri.
Eichmann non provava un simile desiderio. Piuttosto, secondo la Arendt,
quei crimini erano determinati dall'incapacità di Eichmann di identificarsi
con le sue vittime e di sottoporre le sue convinzioni e i suoi valori
all'adeguato esame critico. Concordo con la Arendt sul fatto che il male è
banale. Ma è la nostra non volontà, piuttosto che la nostra incapacità, a
renderlo tale. Non c'era una generale incapacità da parte di Solomon, Kamin
e Wynne di sottoporre le loro convinzioni a un esame critico.
Semplicemente loro non volevano farlo. Non c'era l'incapacità di evitare a
quei cani ulteriori torture. Semplicemente loro non volevano farlo.
Immanuel Kant disse, correttamente, che il dovere implica il potere. Dire
a qualcuno che deve fare qualcosa implica l'idea che quel qualcuno possa
farla. Per contro, dire a qualcuno che non deve fare qualcosa implica l'idea
che quel qualcuno possa non farla. Se definiamo la banalità del male in
termini di incapacità, ci garantiamo una scusa fin troppo comoda: non
potevamo fare le cose in un modo diverso da come le abbiamo fatte.
L'incapacità elimina la colpevolezza. E io penso che noi non possiamo
essere assolti così facilmente.
Il mancato adempimento del proprio dovere, sia morale sia epistemico una mancanza che si fonda sulla non volontà piuttosto che sull'incapacità - è
alla base della maggior parte del male nel mondo. C'è tuttavia un ulteriore
ingrediente del male, senza il quale il mancato adempimento del dovere di
cui parliamo non avrebbe rilevanza: l'impotenza della vittima.
Avrete forse notato che il senso generale di questo capitolo non è del tutto
in sintonia con il discorso sull'unicità delle scimmie del capitolo precedente,
dove sostenevo che l'unico, indiscutibile contributo delle scimmie al mondo
è quella sorta di premeditazione che anima i loro rapporti. Ciò naturalmente
porterebbe a concludere che il male tipicamente umano sia il risultato di una
malignità deliberata. E tuttavia in questo capitolo ho sostenuto che quasi
tutto il male prodotto dagli uomini deriva non da intenzioni malvagie, ma
dalla non volontà di compiere il proprio dovere morale ed epistemico. Ma
siamo solo a metà del nostro rapporto sul male e c'è ancora molto tempo per
introdurre nel gioco l'invenzione scimmiesca. La malignità deliberata ha
effettivamente un ruolo cruciale nel male umano; non tanto nella
perpetrazione degli atti, quanto nella preparazione del terreno su cui tali atti
potranno essere compiuti. La malignità delle scimmie - e in particolare delle
scimmie umane - si rileva nella creazione dell'impotenza. In questo, le
scimmie umane progettano la possibilità del male.
I cani erano tanto impotenti quanto era impotente la ragazzina violentata.
I bambini sono naturalmente impotenti, ma i cani sono stati creati per
esserlo. Solomon, Kamin e Wynne pensavano a se stessi come a ricercatori
che studiavano il fenomeno dell'impotenza appresa e intanto si rendevano
complici nell'arte di creare l'impotenza. Potrà sembrare ironico, ma qui non
c'è alcuna ironia, c'è solo intenzione. Per studiare l'impotenza negli uomini
dovevano prima costruirla in un animale.
Nell'Insostenibile leggerezza dell'essere lo scrittore ceco Milan Kundera
dice qualcosa sulla natura della bontà umana che considero giustissimo e di
fondamentale importanza:
La vera bontà dell'uomo si può manifestare in tutta purezza e libertà solo
nei confronti di chi non rappresenta alcuna forza. Il vero esame morale
dell'umanità, l'esame fondamentale (posto così in profondità da sfuggire al
nostro sguardo), è il suo rapporto con coloro che sono alla sua mercé: gli
animali. E qui sta il fondamentale fallimento dell'uomo, tanto fondamentale
che da esso derivano tutti gli altri.
Se noi uomini diamo un peso così sproporzionato alle motivazioni e se
queste sono solo maschere che nascondono una brutta verità, allora, per
comprendere la bontà umana, dobbiamo eliminare quelle motivazioni.
Quando l'altro «non rappresenta alcuna forza», ovvero non ha potere, non si
ha alcuna motivazione egoistica per trattarlo con civiltà o rispetto. Costui
non può né aiutare né ostacolare. Non lo si teme e non si desidera il suo
aiuto. In questa situazione, l'unica motivazione per trattarlo con civiltà e
rispetto è di carattere morale: lo si tratta così perché è la cosa giusta da fare.
E la si fa perché ciò rientra nel genere di persona che si è.
Io giudico sempre le persone dal modo in cui trattano quelli più deboli di
loro. Giudico il ricco cliente di un ristorante da come tratta i camerieri che
lo servono. Giudico il capufficio da come tratta i suoi impiegati. Si scopre
molto di una persona in tal modo. Ma nemmeno in questo caso il test è
assolutamente preciso. Il cameriere insultato può sputare, o peggio, nella
minestra del cliente. Gli impiegati possono lavorare in modo sciatto,
mettendo così nei guai il loro capo con i suoi capi. Scoprite qualcosa di
importante sulle persone vedendo come trattano quelli che sono più deboli
di loro. Ma scoprite ancora di più quando vedete come trattano chi «non
rappresenta alcuna forza», gli impotenti. E, come sottolinea Kundera, i
candidati più ovvi a questo status sono gli animali.
Abbastanza ironicamente, per essere una creatura tradizionalmente usata
come simbolo del lato oscuro dell'animo umano, Brenin usciva piuttosto
bene dall'esame di Kundera. I suoi combattimenti, pur feroci e cruenti,
coinvolgevano sempre un avversario grosso, aggressivo e violento quanto
lui. In altre parole, un cane che Brenin percepiva come una minaccia, reale
o potenziale. Conoscevo molti cani del genere: appartenevano ai miei
compagni della squadra di rugby o a loro amici. Alcuni di questi cani
avrebbero fracassato una vetrata a testate, se avessero pensato che dall'altra
parte avrebbero avuto la possibilità di azzuffarsi come si deve. Erano - e
questa è la semplice, obiettiva verità - autentiche o potenziali minacce.
Brenin trattava i cani palesemente più deboli di lui con indifferenza, o con
una bizzarra gentilezza. Ricordo un labrador di sei mesi che si lanciò di
corsa verso di lui da lontano, con il padrone che gli correva dietro
all'impazzata; nella sua eccitazione, il cucciolo di labrador saltò addosso a
Brenin, il quale detestava cose del genere. Ma non poteva farci niente. Alla
fine si mise in bocca tutta la testa del labrador e la tenne delicatamente in
posizione, cercando di immobilizzare il cucciolo. Avreste dovuto vedere la
faccia del padrone del cane! Può darsi che mi stia lasciando fuorviare
dall'alone roseo della nostalgia ma, per quello che posso ricordare, penso
che Brenin esca dall'esame di Kundera con una reputazione morale
ragionevolmente intatta.
Come la vera bontà umana può manifestarsi solo in relazione a coloro che
non hanno potere, così la debolezza - o almeno una relativa debolezza - è
una condizione necessaria della malvagità umana. Ed è qui, io credo, che
troviamo la fondamentale mancanza degli esseri umani. Gli uomini sono gli
animali che costruiscono la debolezza. Prendiamo i lupi e li trasformiamo in
cani. Prendiamo i bufali e li trasformiamo in buoi. Prendiamo gli stalloni e
ne facciamo dei castrati. Indeboliamo le cose in modo da poterle usare. In
questo siamo assolutamente unici nel mondo animale. La ragazzina stuprata
era naturalmente impotente. Ma i cani di Solomon, Kamin e Wynne erano il
prodotto di migliaia di anni di un'ingegneria sociale e genetica che li aveva
portati, dopo molto tempo ma inesorabilmente, dentro una gabbia
elettrificata.
Gli uomini non sono gli unici che trattano male i deboli o gli indifesi.
Tutti gli animali sfruttano i deboli, anche se in genere non hanno scelta. Un
branco di lupi metterà in scena numerosi finti attacchi a una mandria di
caribù proprio per cercare in uno dei suoi membri eventuali segni di
debolezza e, dopo averli trovati, concentrerà tutte le sue energie su quel
membro. Una lupa arriverà a uccidere il proprio cucciolo, se percepirà in lui
segni di debolezza inconsueti. La vita è un processo profondamente
sgradevole che separa il debole dal forte. La vita è profondamente crudele.
Ciò che è caratteristico degli uomini, però, è che hanno preso la crudeltà
della vita, l'hanno perfezionata e poi intensificata. Hanno portato la crudeltà
della vita a un livello superiore. Se volessimo definire gli uomini con una
sola frase, potremmo dire che: gli uomini sono quegli animali che
progettano la possibilità del male.
Non è un caso se siamo animali di questo genere. Nella scimmia, come
abbiamo visto, l'intelligenza sociale viene per prima. Noi siamo così bravi
nel creare la debolezza negli altri animali perché siamo stati prima di tutto
capaci di crearcela reciprocamente. Una scimmia complotta e inganna nel
tentativo di indebolire gli individui più forti di lei. La scimmia che c'è in noi
è sempre attenta alla possibilità di indebolire i suoi simili. È sempre alla
ricerca di un'opportunità per praticare il male.
Il punto è che ciò che è fatto è reso. Non è possibile vedere gli altri come
opportunità da sfruttare, come portatori di debolezze da svelare, senza che
ciò prima o poi ci si ritorca contro e modifichi in misura decisiva il modo in
cui pensiamo a noi stessi. Io vedo implicitamente me stesso come portatore
di debolezze da svelare perché, per tutta la vita, ho visto gli altri in questi
termini. La debolezza che creiamo in noi stessi consiste, fondamentalmente,
in un certo modo di pensare a noi stessi e alle azioni malvagie che
commettiamo. Piagnucoliamo le nostre scuse, frigniamo le nostre
circostanze attenuanti: non potevamo fare diversamente, diciamo a noi
stessi e a chiunque altro sia disposto ad ascoltarci. Forse è vero. Ma la
nostra debolezza consiste nel pensare che questo abbia importanza. Un lupo
non cerca scuse. Un lupo fa quello che fa - forse quello che deve fare - e ne
accetta le conseguenze.
L'idea che il male sia una condizione patologica, o il risultato di un
malessere sociale, è in definitiva una conseguenza del fatto che abbiamo
progettato in noi stessi quell'impotenza che abbiamo accuratamente
costruito in altri. Non siamo più, pensiamo, nemmeno soggetti degni di
valutazione morale. Se siamo cattivi, o se siamo buoni, si tratta di
qualcos'altro, qualcosa che deve essere spiegato in termini diversi, non
morali, qualcosa che esula dal nostro controllo. Giustificare il nostro status
morale, scusare la nostra colpevolezza nella creazione del male, è questa la
manifestazione definitiva della creazione del male, la più chiara espressione
possibile della debolezza che abbiamo alacremente assemblato nella nostra
stessa anima. Pensare alla moralità come a qualcos'altro è un segno di
debolezza così tangibile che può sfuggire solo a un essere umano. Non
siamo più abbastanza forti per vivere senza scuse. Non siamo più
abbastanza forti nemmeno per avere il coraggio delle nostre convinzioni.
L'universo, ci viene detto, è cominciato con un big bang, a cui è seguita
una rapida espansione: da un punto di singolarità inconcepibilmente piccolo
a un cosmo inconcepibilmente vasto e in continua espansione. A un certo
punto il cosmo si è raffreddato abbastanza perché si formasse la materia,
portando al noto dualismo dell'universo attuale: materia e spazio. La materia
si è condensata ulteriormente, formando stelle distinte e, più tardi, pianeti.
Su alcuni pianeti - almeno su quello che conosciamo, ma presumibilmente
anche altrove - ha cominciato a formarsi la vita. In origine la vita consisteva
in semplici molecole organiche che fluttuavano in un brodo di costituenti
ancora più semplici. Poi però quelle molecole hanno cominciato a disputarsi
gli atomi liberi del brodo. La crescente complessità di una singola molecola
si realizzava solo a spese della stagnazione o della scomparsa di altre. Fin
dal suo inizio la vita è stata un gioco a somma zero. Alcune molecole,
perciò, si sono specializzate nell'individuare la debolezza nelle molecole che
le circondavano. Sono diventate carnivori molecolari, sfruttando le
debolezze che scoprivano, demolendo molecole e appropriandosi dei loro
atomi costituenti. E il processo è proseguito a cascata per miliardi di anni,
producendo progressivamente molecole viventi sempre più complesse.
Naturalmente in tutto ciò l'universo non aveva voce in capitolo: in esso le
cose semplicemente accadevano, per quanto ne sappiamo senza alcuna
direttiva o controllo generale. Ma dopo circa quattro miliardi di anni è
successo qualcosa di inaspettato e piuttosto impressionante: l'universo è
diventato capace di farsi domande. Minuscole parti dell'universo sono state
in grado di farsi domande su se stesse, su altre parti dell'universo e
addirittura sull'universo nel suo insieme. A un certo punto, un giorno nei
primi anni Novanta del XX secolo, due dei prodotti di tale processo - uno
dei quali appassionato di domande del genere - si sono trovati a correre
insieme in una fresca mattina d'inizio estate in Alabama. E una piccola parte
dell'universo, una parte che ansimava e arrancava con passo pesante e
sgraziato lungo le strade di Tuscaloosa, si è chiesta: ne è valsa la pena?
Dopo quattro miliardi di anni di sviluppo cieco e sconsiderato, l'universo è
arrivato a contenere me. Ne è valsa la pena? E poi una domanda
comparativa: dopo quattro miliardi di anni di sviluppo cieco e sconsiderato,
l'universo era arrivato a contenere anche Brenin. Chi dei due è valso di più
la pena?
Tra noi due, presumo, ero io l'unico in grado di formulare domande simili.
Questo fa di me un prodotto dell'universo che valeva di più la pena
produrre? Gli uomini hanno sempre pensato di sì. Secondo il filosofo
tedesco del XX secolo Martin Heidegger, il tratto distintivo dell'uomo - e,
per estensione, il suo valore - consiste nel fatto che l'uomo è un essere per il
quale il suo stesso esserci è «in questione»; l'uomo, cioè, è il tipo di creatura
che può formulare domande come: «Che cosa sono io?» e «Ne valevo la
pena?». È la nostra razionalità, in senso lato, che ci rende migliori degli altri
animali. Ma è davvero difficile capire che cosa significhi «migliore». Io ero
migliore nel districarmi tra complessi problemi logici o concettuali,
perlomeno nelle giornate buone e dopo la mia prima dose di caffeina del
mattino. Ma Brenin era migliore nella corsa. Quale di queste due abilità è
migliore?
Un modo, forse il più ovvio, di intendere il termine «migliore» è come
sinonimo di «più utile». Ma, in tal caso, «migliore» è necessariamente
relativo alla creatura in questione. Ciò che è utile per me non è
necessariamente ciò che è utile per Brenin e viceversa. Per Brenin è utile
correre velocemente e cambiare direzione in pochissimo spazio, che è il
modo in cui, almeno nel suo ambiente ancestrale, poteva catturare ciò che
aveva bisogno di mangiare. Per me, però, abilità del genere sono molto
meno utili. Ogni animale porta con sé la propria forma di vita, e quali abilità
siano migliori o più utili dipende da quella particolare forma di vita.
Lo stesso vale quando tentiamo di intendere «migliore» in termini di
eccellenza. Da scimmia ambiziosa e subdolamente competitiva quale sono,
immagino di avere sempre lottato per raggiungere l'eccellenza... bè, magari
non sempre, ma perlomeno nel recente passato. Per me l'eccellenza
comporta l'abilità di cercare di risolvere difficili problemi concettuali e di
registrare su carta i risultati delle mie elucubrazioni. Secondo una lunga
tradizione di pensiero, stimolata da Platone, la razionalità è l'eccellenza
peculiare dell'uomo, il che però non fa che ribadire che l'idea di eccellenza è
relativa alla forma di vita di un determinato animale. L'eccellenza per il
ghepardo consiste nella velocità, perché è la velocità ciò in cui si specializza
il ghepardo.
L'eccellenza per il lupo consiste, tra l'altro, in un certo tipo di resistenza
che lo vede in grado di correre per trenta chilometri all'inseguimento della
preda. Che cosa è eccellente dipende da ciò che si è.
La razionalità è migliore della velocità o della resistenza: è questo che
siamo tentati, forse irresistibilmente, di dire. Ma su quali basi possiamo
giustificare questa affermazione? Non esiste un senso oggettivo di
«migliore» che ci consenta di farlo. Detto questo, il termine «migliore»
perde il suo significato. Esiste semplicemente ciò che è meglio per un uomo
e ciò che è meglio per un lupo. Non c'è uno standard comune in base al
quale i diversi modi di intendere «migliore» possano essere valutati.
Per noi uomini è una cosa difficile da capire perché troviamo molto
difficile essere obiettivi su noi stessi. E perfino io non riesco del tutto a
scrollarmi di dosso il sospetto che ci sia qualcosa che mi sfugge. Perciò,
ecco un esercizio di obiettività. I filosofi medievali usavano un'espressione
che mi pare bella e al tempo stesso importante: sub specie aeternitatis, «dal
punto di vista dell'eternità». Dal punto di vista dell'eternità, ti vedi solo
come un granello tra altri granelli nella sterminata oscurità stellata
dell'universo. Dal punto di vista dell'eternità, noi esseri umani siamo solo
una specie tra le altre, una specie che è qui da non molto tempo e che dà
segnali di non rimanerci ancora troppo a lungo. Che cosa importa all'eternità
della mia abilità di risolvere complessi problemi concettuali? Perché
all'eternità questo dovrebbe importare più della capacità di Brenin di correre
come se stesse galleggiando ad alcuni centimetri da terra? L'idea che
all'eternità le mie capacità importino più di altre è un concetto meschino.
Se non possiamo giudicare gli altri animali - se non c'è alcun contenuto
coerente nell'idea che siamo obiettivamente migliori di loro - possiamo
nondimeno ammirarli. E la nostra ammirazione sarà pervasa e guidata dal
riconoscimento, per quanto confuso, che hanno qualcosa che a noi manca.
Spesso, forse addirittura tipicamente, quello che più ammiriamo negli altri è
ciò che riteniamo ci manchi. Quindi che cos'era ciò che mancava a questa
scimmia e che ammirava tanto nel lupo che le correva accanto?
C'era, naturalmente, un certo tipo di bellezza che non potrei in alcun
modo emulare. Il lupo è arte nella sua forma più alta e non ci si può trovare
in sua presenza senza che ciò sollevi lo spirito. Per quanto potessi essere di
cattivo umore quando cominciavamo la nostra corsa quotidiana, l'essere
testimone di quella bellezza silenziosa ed elegante mi faceva sempre sentire
meglio. Mi faceva sentire vivo. Cosa ancora più importante, è difficile stare
vicino a una tale bellezza senza volere essere un po’ più simile a lei.
Ma se l'arte del lupo era qualcosa che non potevo emulare, sotto c'era
qualcos'altro: una forza a cui potevo almeno tentare di avvicinarmi. La
scimmia che sono è una creatura goffa e sgraziata specializzata in
debolezza, una debolezza che crea negli altri e una debolezza da cui in
ultima analisi è affetta. È questa debolezza che permette al male - al male
morale - di prendere piede nel mondo. L'arte del lupo è fondata sulla sua
forza.
Un giorno portai come al solito Brenin con me all'allenamento di rugby.
Aveva circa due mesi ed era il periodo in cui aveva preso l'abitudine di
tormentare Rugger, al quale non era per niente simpatico. Dopo un po’
Rugger perse la pazienza, afferrò Brenin per il collo e lo inchiodò a terra.
Va ascritto a suo grande merito il fatto di essersi limitato a questo. Avrebbe
potuto spezzare il piccolo collo di Brenin come un ramoscello. Perfino un
pit bull può superare l'esame di Kundera. Ma è stata la reazione di Brenin
quella che mi rimarrà per sempre dentro. La maggior parte dei cuccioli si
sarebbe messa a guaire per lo shock e il terrore. Brenin ringhiò. E non era il
brontolio di un cucciolo, ma un ringhio profondo, calmo e sonoro in
contrasto con la sua tenera età. Questa è forza. Ed è questo che ho sempre
cercato di portare con me e che spero di portare con me per sempre. In
quanto scimmia, non sarò all'altezza, ma ho l'obbligo, l'obbligo morale, di
non dimenticarlo mai e di emularlo per quanto mi è possibile. Se solo
riuscirò a essere forte quanto un cucciolo di lupo di due mesi, allora sarò un
terreno dove il male morale non crescerà.
Una scimmia sarebbe scappata di corsa per andare a tramare la sua
rivincita, per escogitare modi di creare debolezza in quelli che, più forti di
lei, l'avevano umiliata. E, una volta completata tale operazione, si può fare il
male. Io sono una scimmia per un incidente di nascita. Ma nei miei
momenti migliori sono un cucciolo di lupo e ringhio la mia sfida al pit bull
che mi ha inchiodato a terra. Il mio ringhio è riconoscere il fatto che sta per
arrivare il dolore, perché il dolore è la natura della vita. E ammettere che
sono solo un cucciolo e che, in qualsiasi momento, il pit bull della vita può
spezzarmi il collo come un ramoscello. Ma è anche l'espressione della mia
volontà di non cedere, succeda quel che succeda.
Avevo un collega piuttosto insolito nell'ambiente dei filosofi, in quanto
era credente. Aveva l'abitudine di dire ai suoi studenti: quando la merda
finirà nel ventilatore, allora crederete. Forse è davvero questo che succede.
Quando la merda colpisce il ventilatore, la gente cerca Dio. Quando la
merda colpisce il mio ventilatore, io penso a un piccolo cucciolo di lupo.
Cinque. L'ingannatore
Una storia racconta di un lupo che viveva a Gubbio e del suo incontro con
Francesco d'Assisi. Il lupo terrorizzava da tempo gli abitanti della cittadina,
i quali chiesero a san Francesco di convincerlo a desistere. Così un giorno il
lupo e il santo si incontrarono fuori dalle mura della città e giunsero a un
accordo: un contratto debitamente ufficializzato dal notaio locale. Il lupo
promise di smettere di terrorizzare la gente e di lasciare in pace il bestiame.
Gli abitanti di Gubbio, in cambio, promisero di dargli da mangiare e di
permettergli di andarsene in giro per la città a suo piacere. Questa storia mi
diverte, perché ero arrivato, in modo del tutto indipendente, a un accordo
praticamente identico con Brenin. In specifico, la versione del contratto
stipulato con il giovane Brenin era più o meno la seguente:
Okay, Brenin, io ti porterò con me ovunque andrò: alle lezioni,
all'allenamento di rugby dopo le lezioni e alle partite durante i weekend, che
siano in casa o in trasferta. Se andrò a fare spese, potrai venire anche tu, ma
dovrai aspettarmi in auto (farò presto!). E, no, non ti lascerò in macchina
nelle ore più calde della giornata, perciò è una fortuna che abbiamo un
supermercato aperto ventiquattr'ore su ventiquattro proprio in fondo alla
strada. Mi assicurerò che tu possa fare ogni giorno una passeggiata lunga e
interessante e, se andrò a correre, potrai venire anche tu. Riceverai un buon
pasto nutriente tutti i giorni. E quando alla sera andrai a dormire, sarai
adeguatamente esausto dopo un'altra meravigliosa giornata di divertimenti e
novità. Ed eccoti un'altra informazione, di cui al momento non sono ancora
consapevole, ma che diventerà dolorosamente evidente nel corso degli anni:
ogni casa che comprerò mi costerà almeno cinquantamila dollari più di
quanto altrimenti mi sarebbe costata solo perché dovrà avere un giardino di
dimensioni sufficienti per permetterti di correre in giro. Da parte tua, tu non
dovrai distruggere quella casa. È tutto ciò che chiedo. Mi rendo conto che a
volte potrai essere irresistibilmente tentato da un «pasto dell'affamato»
lasciato imprudentemente alla tua portata. Cose che capitano. Non ho
intenzione di insistere troppo o di tormentarti per cose di questo genere.
Quello che ti chiedo davvero è di lasciare in pace la maledetta casa. Questo
significa non distruggere gli oggetti ivi contenuti. E anche se mi rendo
conto che sei un giovane lupo e che gli incidenti possono capitare,
specialmente di notte, per favore cerca di non fare la pipì sui tappeti.
Se sostituite la mia casa con la città di Gubbio e me con san Francesco, le
due storie coincidono quasi perfettamente. Ma, a differenza di san
Francesco, io non ho rispettato il contratto e ancora oggi, più di dieci anni
dopo, questo pensiero mi disturba.
L'Alabama è stata sostanzialmente una festa durata sette anni. Nella vita
sono stato fortunato sotto molti aspetti. E uno di questi è stato avere la
possibilità di vivere, in tutti gli elementi essenziali (vale a dire feste,
sbronze, sport di vario genere), la vita dello studente universitario per due
volte. La seconda volta è stata molto più divertente, forse perché avevo i
soldi. O forse perché, come la gioventù è sprecata per i giovani, così la vita
dello studente è sprecata per gli studenti. Chi lo sa?
I nostri giorni sregolati cambiarono irrevocabilmente quando Brenin
compì quattro anni e io trenta. A dire la verità, tutti e due stavamo
diventando forse un po’ troppo vecchi per quella vita. Quando avevo
accettato l'incarico in Alabama avevo ventiquattro anni. Vivere la vita dello
studente quando hai ventiquattro anni è una cosa, ma puoi continuare solo
per un certo tempo ad andare ai party studenteschi delle partite di rugby
prima che la cosa diventi dapprima un po’ triste e poi un po’ disgustosa.
Tuttavia la causa immediata del nostro trasferimento non fu il mio
invecchiamento, ma quello di mio padre. Aveva un attacco di polmonite
dopo l'altro. Avendo il sospetto, sempre più forte, che stesse per morire,
ritenevo di dovermi avvicinare a casa. Naturalmente il vecchio bastardo si
riprese completamente. A tutt'oggi è ancora in circolazione. Ma ormai era
troppo tardi: i giorni di festa a base di barilotti di birra e rugger huggers in
abiti succinti erano ormai alle mie spalle.
Fu comunque la decisione migliore che abbia mai preso, anche se
all'epoca non mi sembrò tale. Avevo una questione aperta con la filosofia.
La vita dissoluta, ma assai piacevole, che conducevo in Alabama aveva
provocato un totale inaridimento dei miei scritti e delle mie pubblicazioni.
Era ovvio che non ero abbastanza disciplinato da ignorare le evidenti
tentazioni che mi circondavano, perciò dovevo cambiare vita. Di
conseguenza, per il mio ritorno al di là dell'Atlantico, decisi di trovarmi un
posto davvero tranquillo, dove ci fosse anche un po’ di campagna per
Brenin. Ma l'elemento decisivo era che avevo bisogno di un luogo dove non
ci fosse assolutamente, tassativamente niente da fare, a parte scrivere. Per
cui ci trasferimmo in Irlanda e cominciai a lavorare come docente
all'University College Cork. Dimenticavo, ci fu un altro fattore significativo
che influenzò la mia decisione: Cork fu l'unico posto abbastanza disperato
da offrirmi effettivamente un lavoro. È questo che succede a chi trascorre
sette anni in una festa continua.
Il problema era che Brenin, per volontà del governo irlandese, doveva
passare sei mesi rinchiuso nel centro di detenzione di Lissadell a Swords,
poco a nord di Dublino. Ciò succedeva prima dell'introduzione dei
passaporti degli animali domestici e Brenin dovette andare in quarantena
per sei mesi. Era un sistema indicibilmente stupido e crudele, messo a punto
prima della scoperta del vaccino contro la rabbia. Gran Bretagna e Irlanda ci
hanno messo quasi un secolo per adeguarsi a questo «recente» sviluppo
della medicina. Brenin veniva sottoposto a vaccinazioni antirabbiche
annuali fin da cucciolo e la presenza degli anticorpi nel suo sangue era
facilmente dimostrabile. Ciononostante, come migliaia di cani nelle stesse
condizioni, dovette scontare la sua pena.
Non so per Brenin, ma per me quella fu la cosa più difficile che abbia mai
dovuto fare. E per molte notti in quei sei mesi mi addormentai piangendo. A
tutt'oggi non so se feci la cosa giusta per lui: sei mesi sono un periodo molto
lungo nella vita di un lupo. Ma se c'era una cosa che distingueva Brenin dal
canide medio era la grande sicurezza di sé. Era sempre stato così, perfino da
cucciolo. Niente lo turbava davvero. Lo avete già notato nei suoi incontri
con il pit bull Rugger. Sospetto che abbia scontato il suo periodo di
detenzione con disinvoltura. In effetti lo affrontò con notevole aplomb e
senza alcuna delle evidenti difficoltà psicologiche che segnano molti cani
trattenuti in quarantena.
In realtà il regime di Lissadell era piuttosto blando. La signora Majella, la
direttrice, si era affezionata a Brenin e la cosa era molto comprensibile, dato
che il mio era di gran lunga il «cane» più bello che avesse mai onorato
l'Irlanda con la sua presenza. All'epoca veniva fatto passare per un
malamute - questo era ciò che avevo dichiarato sul modulo d'importazione dato che in Irlanda lo status giuridico dei lupi è incerto. A quell'epoca i
malamute erano ancora sconosciuti in Irlanda e perfino i veterinari non
sapevano bene quale aspetto dovessero avere. La Majella accordò a Brenin
vari privilegi, in virtù della sua straordinaria bellezza e del suo
comportamento educato e piacevole. Il più importante di tali privilegi era
una corsa lungo l'intera struttura quasi tutte le mattine. Brenin, a quanto
pare, utilizzava quel tempo per imporre la propria autorità sugli altri
«detenuti», soprattutto urinando davanti alle loro gabbie. Io andavo a
trovarlo una volta alla settimana - a quei tempi, un viaggio andata- ritorno di
dieci ore su quelle assurde strade irlandesi - e passeggiavamo insieme per
qualche ora nel complesso. In seguito i privilegi di Brenin vennero ridotti a
causa di una furtiva, ma nondimeno incauta, razzolata nella borsa della
spesa della Majella con conseguente rapido furto di un pollo congelato. Ma
a quel punto stava già per essere rilasciato.
Quando mi venne restituito, feci del mio meglio per risarcirlo. Questo
significò lunghe corse quotidiane. Passammo l'estate della sua liberazione Brenin fu rilasciato in giugno - nel Galles occidentale, a casa dei miei
genitori. Bè, non proprio a casa: ci venne assegnata la roulotte in fondo al
giardino, dato che Brenin aveva preso subito in antipatia Bonnie e Blue, i
due alani di famiglia. In effetti, entro poche ore dal nostro arrivo, aveva
cercato di uccidere Blue in diverse occasioni. Trascorrevamo le giornate
correndo lungo le magnifiche spiagge di Freshwater West, Broadhaven
South e Barafundle, la preferita di Brenin. Nelle dune dietro Barafundle
c'erano miliardi di conigli e fu lì che Brenin cominciò a imparare qualcosa
che non avevo potuto lasciargli fare in Alabama a causa dei serpenti:
cacciare.
Alla fine dell'estate ci trasferimmo in Irlanda. Per il primo anno abitammo
a Bishopstown, un sobborgo all'estrema periferia occidentale della città di
Cork. Cercai di rendere la vita di Brenin più simile possibile a quella in
Alabama. Così andavamo a correre tutti i giorni, di solito al Lee Valley Park
e nei campi confinanti. Oppure al Powdermills Park a Ballincollig. Nei
weekend ci spostavamo: la spiaggia di Inchydoney; Glengarra Woods, oltre
Mitchelstown sulla strada per Dublino; la passeggiata sulle scogliere di
Ballycotton e molti altri posti. Più o meno a quell'epoca cominciai a fare
surf e un paio di giorni alla settimana, onde permettendo, scendevamo sulla
ventosa spiaggia di Garrettstown, dove Brenin sguazzava in acqua, mentre
io cercavo di restare in equilibrio sulla tavola. La quarantena poteva essere
stata dura, ma per Brenin l'Irlanda era un posto molto migliore dell'Alabama
e, grazie a san Patrizio, non dovevamo neppure preoccuparci dei serpenti.
Il fatto che una cosa sia inevitabile non la rende necessariamente meno
spiacevole. Io sapevo di dover riattraversare l'Atlantico per tornare a casa.
Sapevo che Brenin sarebbe dovuto andare in quarantena. Sapevo che in
Europa avrebbe avuto una vita molto migliore, in un clima e in una
campagna di gran lunga più adatti a lui. Ma non riesco ancora a liberarmi
dall'orrore di quel giorno d'inizio dicembre quando lo portai ad Atlanta per
caricarlo su un aereo. Ho ancora l'incubo ricorrente di quell'episodio e mi
sveglio di colpo, devastato. All'inizio sono triste perché nel sogno sto
tradendo Brenin. E poi mi ricordo che è morto. La storia di san Francesco e
del contratto con il lupo di Gubbio è una storia a lieto fine perché il
contratto viene rispettato. Ma c'è anche un'altra storia, molto più cupa, che
riguarda un lupo e un contratto, una storia sulle terribili conseguenze della
rottura del patto.
Fenrisulfr, il gigantesco lupo della mitologia norrena, crebbe in
circostanze familiari piuttosto infelici. Suo fratello Jòrmungandr, il serpente
di Midgard, venne inabissato sul fondo dell'oceano da Odino senza alcun
motivo, o perlomeno un motivo che potesse reggere in un tribunale. Sua
sorella Hel venne esiliata nella terra dei morti solo in base alla parola di una
megera di dubbia sanità mentale, ma di dimostrabile malignità. Così,
presumibilmente, la prima lezione sugli dèi che dovremmo imparare è
molto semplice: non ci si può fidare di loro. In realtà Fenrisulfr non aveva
mai dato agli dèi una ragione specifica per diffidare di lui. Al contrario, se si
tiene presente che era un lupo gigantesco il cui destino - si diceva - sarebbe
stato quello di inghiottire il sole nel giorno del Ragnaròk, cioè alla fine del
mondo, fino a quel momento aveva condotto una vita di assoluta
moderazione. Ma a mano a mano che diventava più grosso, gli dèi
cominciarono ad avere paura di lui e la loro soluzione, tipicamente priva di
immaginazione, consistette nell'incatenarlo e dimenticarsi di lui. Dapprima
fabbricarono una catena chiamata Loedingr, che però non riuscì a trattenerlo
a lungo. Allora fabbricarono Dromi, un'altra catena di ferro, due volte più
resistente di Loedingr, ma Fenrisulfr spezzò anche quella. A quel punto gli
dèi fecero approntare dai loro gnomi una terza catena, fatta con il rumore
del passo di un gatto, i peli della barba di una donna, le radici di una
montagna, i tendini di un orso, il respiro di un pesce e la saliva di un
uccello.
Ed ecco la seconda lezione sugli dèi che dovremmo imparare, una lezione
che, in un modo ragionevolmente diretto, spiega la prima. Gli dèi non sono
particolarmente stupidi, anche se alcuni di loro, diciamocelo, non brillano
per acume. Né sono necessariamente cattivi e maligni, anche se molti di
loro lo sono. Piuttosto, sono caratterizzati da una certa incapacità di capire
la mente degli altri. Gli dèi non hanno alcuna teoria della mente e sono
congenitamente incapaci di mettersi nei panni degli altri. Non conoscono
l'empatia. Per dirla in modo brutale, forse la definizione più sicura degli dèi
è che sono tutti sociopatici.
Pensavano davvero che Fenrisulfr ci sarebbe cascato? Non aveva mai
dato segni di essere un lupo particolarmente ottuso. Però loro lo hanno
messo alla prova con due catene, le più pesanti e robuste che siano mai state
forgiate. Queste non hanno funzionato e allora gli hanno dato qualcosa che
assomigliava a un nastro di seta. Non immaginavano che lui si sarebbe reso
conto che c'era sotto qualcosa? Sospettoso, Fenrisulfr chiese spiegazioni.
No, no, gli assicurano, non c'è nessun trucco. Te lo giuro sulla vita di mia
madre, si racconta che abbia detto Odino, forse immaginando di fare una
sottile battuta per pochi intimi (sua madre Bestia era una gigantessa di
ghiaccio), il che confermerebbe l'ampia mole di prove testuali che
suggeriscono come la sottigliezza non sia mai stata il forte di Odino.
A questo punto la versione ufficiale degli eventi è più o meno la seguente:
per dimostrare la buonafede divina, Tyr, il più audace degli dèi, si offrì di
infilare la mano tra le fauci di Fenrisulfr, e così sacrificò nobilmente la
propria estremità destra per il superiore bene comune. Ma naturalmente la
mitologia è scritta dai vincitori. Forse ho passato troppo tempo in
compagnia di un lupo, ma questa versione ufficiale della storia non mi è mai
sembrata molto convincente. Anzi, ritengo che mostri tutti i segni
caratteristici di un racconto inventato in seguito da Tyr e da lui
ostinatamente ribadito. Non si può fare a meno di sospettare che Tyr fosse
non il più audace, ma il più degenerato e crudele degli dèi. E considerando
il suo generalmente riconosciuto, ma perlopiù inspiegato, interesse per
l'educazione di Fenrisulfr, è purtroppo possibile che il lupo avesse trascorso
i primi anni di vita, da quand'era cucciolo, soffrendo, in un modo o
nell'altro, per mano di Tyr. E, se è così, Fenrisulfr doveva averlo messo al
primo posto nel suo elenco di cose da azzannare. E non si può fare a meno
di sospettare che Tyr non si fosse offerto volontario per infilare la mano
nella gigantesca bocca del lupo. Potrebbe essere stato Odino a ordinarglielo,
minacciandolo di terribili e prolungate sofferenze se si fosse rifiutato. Nel
qual caso possiamo immaginare l'espressione sulla faccia di Tyr quando
trovò il coraggio di fare quello che Odino gli aveva ordinato, o piuttosto il
coraggio di non opporsi agli altri dèi che gli cacciarono a forza la mano tra
le fauci del lupo. Fenrisulfr strizzò l'occhio a Tyr e quasi certamente il più
audace tra gli dèi se la fece addosso.
Forse valeva la pena azzannare la mano di Tyr. Forse Fen-risulfr era più
che disposto a giocare il gioco degli dèi. Non era ancora il suo momento, né
lo sarebbe stato per molti anni a venire. Narra la leggenda che quando il suo
momento arrivò, nel giorno del Ragnaròk, Fenrisulfr era diventato così
enorme che la mascella superiore toccava il cielo e quella inferiore la terra.
Ma doveva passare ancora molto tempo. E Fenrisulfr era un lupo molto
sicuro di sé. Poteva scontare la sua pena senza il minimo problema. Infatti
la scontò incatenato a una roccia, chiamata «urlo», sull'isola di Lyngvi.
Naturalmente Tyr volle vendicarsi e così, non contento di tenere incatenato
il lupo sino alla fine dei tempi, per completare trionfalmente l'opera gli
conficcò una spada tra le fauci, da cui cominciò a colare la saliva, formando
un fiume al quale venne dato il nome «speranza». E la catena che tenne
prigioniero Fenrisulfr fino al Ragnaròk venne chiamata Gleipnir,
l'ingannatore.
Naturalmente la tragedia di questa storia è che nessuno sa come si sarebbe
comportato Fenrisulfr se non fosse stato trattato in modo così tremendo. È
noto che il giorno del Ragnaròk si schierò con i giganti contro gli dèi e si
vendicò di Odino facendolo a pezzi. Ma chi può sapere con chi si sarebbe
schierato se gli dèi non avessero tradito la parola che gli avevano dato? E
dopo aver tradito la loro parola, che diritto avevano gli dèi di aspettarsi
l'appoggio di Fenrisulfr?
L'orrore di quel viaggio in auto fino ad Atlanta non era dovuto alla
consapevolezza che Brenin mi sarebbe mancato tanto. Era dovuto al fatto
che non sapevo con chi si sarebbe schierato quando l'avrei rivisto. Sarebbe
stato dalla parte degli dèi o da quella dei giganti? E che diritto avevano gli
dèi - se posso, modestamente e vi assicuro sarcasticamente, metterla così di aspettarsi il suo appoggio dopo il tradimento?
In alcune versioni del mito, gli dèi capiscono l'inevitabilità delle loro
azioni. Sanno che non hanno scelta nell'incatenare Fenrisulfr. Sanno che
dovranno essere sconfitti al Ragnaròk: il tempo degli dèi finirà e dovrà
essere sostituito da un'età di giganti. Sanno che tenere incatenato Fenrisulfr
e il fatto che il lupo si schiererà con i giganti sono elementi necessari per la
loro sconfitta. Sanno che ciò che fanno deve essere fatto. Ma sapere che ciò
che fai è necessario non ti libera dal peso schiacciante del farlo davvero.
Salutare Brenin quel giorno ad Atlanta mi spezzò il cuore perché non
sapevo se lui - Brenin, il mio Buffalo Boy - sarebbe stato ancora lì quando
l'avrei rivisto, o se sarebbe stato sostituito da un altro lupo che viveva
dentro la sua pelle.
Con il senno di poi, immagino che per un filosofo sia naturale, e forse
tristemente prevedibile, pensare alla formazione del nostro piccolo Stato di
due individui in termini contrattuali. Il concetto di contratto sociale ha
giocato un ruolo di primo piano nella storia del pensiero occidentale.
Il suo principale progenitore fu il filosofo inglese del XVII secolo
Thomas Hobbes.
Per Hobbes la natura era sgradevole, «rossa di zanne e di artigli» (come
l'avrebbe poi definita Alfred Tennyson). Gli uomini un tempo vivevano in
uno stato di natura, il che significava sostanzialmente una guerra di tutti
contro tutti. Nessuno era al sicuro e di nessuno ci si poteva fidare. Non
erano possibili né amicizia, né collaborazione. Vivevamo come animali, o
come Hobbes riteneva che vivessero gli animali, e di conseguenza la nostra
vita era, in genere, solitaria, misera, crudele, brutale e breve.
E così, sosteneva Hobbes, stipulammo un contratto, un accordo.
L'accordo, in sostanza, era questo: tu accetti di rispettare la vita, la libertà e
le proprietà degli altri a condizione che gli altri, a loro volta, accettino di
rispettare la tua vita, la tua libertà e le tue proprietà. Quindi tu accetti di non
uccidere gli altri e gli altri accettano di non uccidere te. Accetti di non
rendere schiavi gli altri e gli altri accettano di non rendere schiavo te.
Accetti di non rubare le case e le proprietà degli altri e gli altri accettano di
non rubare la tua casa e le tue proprietà. La società si fonda su un principio
del tipo «tu gratti la schiena a me e io la gratto a te». O, quantomeno, «tu
eviti di piantare un coltello nella schiena a me e io evito di piantare un
coltello nella schiena a te».
Hobbes si riferiva alla transizione dallo stato selvaggio - per come lui
l'intendeva - alla civilizzazione. Il contratto è ciò che facilita tale
transizione. Se accetti il contratto, allora accetti anche alcune limitazioni
alla tua libertà. E la ragione per cui lo fai è perché, come risultato, avrai una
vita migliore. È questo lo scopo e la ragione d'essere della società, lo scopo
e la ragione d'essere della moralità.
Sfortunatamente, la storia di Hobbes su come ci siamo elevati al di sopra
della natura rossa e cruda, trasformandoci così da selvaggi in soggetti
civilizzati, presenta dei buchi attraverso i quali un Brenin adulto di oltre
sessanta chili sarebbe potuto passare comodamente. Prima del contratto, per
come la racconta Hobbes, eravamo selvaggi: eravamo natura rossa e cruda,
e la nostra vita era solitaria, misera, ecc. Dopo il contratto, ci siamo
civilizzati e, di conseguenza, la nostra vita è molto migliorata.
Una domanda che, a quanto pare, non passò mai per la mente di Hobbes è
la seguente: come si riesce a portare al tavolo dei negoziati quelli che sono
autenticamente rossi di zanne e artigli? E, cosa ancora più rilevante: che
cosa succede, una volta che ce li hai portati? Se prima del contratto eravamo
tutti così crudeli e brutali come sostiene Hobbes, non avremmo sfruttato la
riunione necessaria per la stesura del patto come una preziosa occasione per
massacrare un paio di rivali o, in alternativa, per imporre la nostra autorità
sulla concorrenza? La situazione contrattuale sarebbe stata un disastro, un
bagno di sangue. La vita sarebbe diventata ancora più misera e solitaria, più
crudele e brutale e, senza ombra di dubbio, più breve. È questo il problema:
i contratti sono possibili solo tra persone civilizzate. Quindi non può essere
stato un contratto ciò che ha civilizzato gli uomini in primo luogo.
Nonostante l'evidente verità che la civilizzazione umana non avrebbe mai
potuto essere fondata su un contratto, alcuni filosofi sostengono che è utile
pensare alla civilizzazione come se fosse stata creata in quel modo. L'idea è
che possiamo capire come sarebbe una società equa - una giusta
civilizzazione - immaginando che la gente abbia deciso di vivere in
conformità alle regole di un contratto e poi individuando tali regole. Un
tempo la pensavo così anch'io, ma adesso non più. Oggi ritengo che
l'importanza del contratto sia in ciò che rivela di noi e, ancora una volta, si
tratta di una sfaccettatura molto poco lusinghiera della natura umana.
A volte è importante non ciò che una teoria dice, ma ciò che dimostra.
Una teoria sarà sempre basata su determinati presupposti, alcuni dei quali
possono essere espliciti: l'autore della teoria può esserne consapevole e
riconoscerli. Ma ci sono sempre presupposti che non vengono resi espliciti.
Alcuni possono non essere mai resi espliciti. Il compito del filosofo, quindi,
è in sostanza di tipo archeologico. Invece di scavare nel terreno, scava più
in profondità nella teoria, scoprendo, per quanto gli consentono talento e
perseveranza, i presupposti nascosti sui quali è stata basata la teoria in
discussione. E questo è ciò che la teoria dimostra e che a volte è molto più
importante di ciò che dice.
Che cosa dimostra la teoria del contratto sociale? Dovrebbe essere la
storia dei fondamenti e della legittimità della moralità e della civilizzazione.
La domanda è: di che cosa si tratta realmente? La risposta è: di due
elementi. Uno è più evidente dell'altro, ma nessuno dei due è molto
lusinghiero.
Il primo elemento dimostrato dalla teoria del contratto sociale è
l'ossessione tipicamente umana - o più esattamente scimmiesca - per il
potere. La teoria ha una conseguenza evidente: non hai alcun obbligo
morale nei confronti di chiunque sia significativamente più debole di te. Si
stipula un contratto con qualcuno per una di queste due ragioni: perché quel
qualcuno può aiutarti o perché può nuocerti. Hai bisogno di aiuto? Nessun
problema: gli altri ti aiuteranno, se prometti di aiutarli quando ne avranno
bisogno. Vuoi salvaguardarti dall'omicidio, dalle aggressioni e dalla
riduzione in schiavitù? Di nuovo, nessun problema: gli altri accetteranno di
non farti niente del genere, se accetterai di non farlo a loro. Ma questo
significa che hai motivo di stipulare un contratto solo con chi può aiutarti o
nuocerti. Tutta l'idea di un contratto ha senso solo presupponendo
un'equivalenza di potere, almeno approssimativa, tra i contraenti. Questo è
un concetto sul quale in pratica concordano tutti coloro che credono nel
contratto. La conseguenza è che chiunque sia molto più debole di te chiunque non possa aiutarti o farti del male - resta al di fuori della sfera
d'interesse e di applicazione del contratto.
Però ricorderete che il contratto dovrebbe fornire la ragion d'essere della
civilizzazione, della società e della moralità. Coloro che non rientrano
nell'ambito del contratto non rientrano neppure nell'ambito della
civilizzazione. Sono fuori dai confini della moralità. Non ci sono obblighi
morali nei confronti di chi è molto più debole. Questa è la conseguenza
della visione contrattuale della civilizzazione. Lo scopo della moralità è
raccogliere più potere: ecco il primo elemento che la teoria del contratto
sociale dimostra, il primo presupposto su cui si basa la teoria stessa. Stato
selvaggio o civilizzazione: quale delle due condizioni è veramente «rossa di
zanne e di artigli»?
Se scaviamo più in profondità, troviamo il secondo presupposto
sottaciuto. Il contratto si basa su un sacrificio deliberato in vista di un
guadagno previsto. Rinunci a qualcosa solo perché ti aspetti di ottenere
qualcosa di meglio in cambio. Vendi la tua libertà per avere protezione,
perché per te la protezione vale di più della libertà. Perché ti venga garantita
la protezione del contratto, perché altri proteggano i tuoi interessi, devi
essere disposto a proteggere gli interessi altrui. E questo può costarti tempo,
energia, denaro, sicurezza, forse addirittura la vita. I sacrifici che fai per
ottenere la protezione del contratto non sono sempre di poco conto, a volte
sono significativi. Li fai solo perché credi che, in cambio, avrai di più.
Ma ecco la scappatoia. Non sei realmente costretto a vendere la tua
libertà. Non devi compiere davvero tutti quei sacrifici. La cosa
fondamentale non è che tu faccia i sacrifici, ma è che gli altri credano che tu
li faccia. Ti guarderò le spalle, dichiari, se tu farai lo stesso per me. Ma che
tu guardi o no le spalle dell'altro non ha importanza. Quello che conta è che
l'altro, o gli altri, lo credano. L'autenticità del tuo sacrificio è irrilevante. Nel
contratto l'immagine è tutto. Se riesci a ottenere i vantaggi del contratto
senza compiere i sacrifici previsti, sarai chiaramente in una posizione di
vantaggio rispetto al povero fesso che sacrifica davvero tempo, energia,
denaro e sicurezza. Il contratto, per sua stessa natura, premia l'inganno. È
una caratteristica profonda, strutturale del contratto. Se riesci a ingannare,
avrai i benefici del contratto senza pagarne i costi.
Gli imbroglioni non prosperano mai, ci diciamo. Ma la scimmia che c'è in
noi sa che non è vero. Quelli che non prosperano sono gli imbroglioni goffi
e maldestri, che si fanno scoprire e devono subire le conseguenze delle loro
azioni. Vengono banditi, esclusi, disprezzati. Ma ciò che noi scimmie
disprezziamo è la goffaggine dei loro tentativi, l'inettitudine, la mancanza di
astuzia. La scimmia dentro di noi non disprezza l'imbroglio in quanto tale:
al contrario, l'ammira. Il contratto non premia l'inganno: premia l'inganno
abile.
Il contratto dovrebbe essere ciò che ci rende esseri umani civilizzati, ma
comporta anche una spinta costante verso l'inganno. Quello che ci ha reso
civilizzati ci ha anche trasformato in ingannatori. Al tempo stesso, però, il
contratto può funzionare solo se l'inganno è l'eccezione e non la regola. Se
tutti riuscissero sempre a ingannare tutti gli altri, svanirebbe qualsiasi
possibilità di ordine o coesione sociale. Di conseguenza il contratto ci ha
trasformati anche in scopritori di inganni. La spinta a diventare ingannatori
sempre più abili è accompagnata dall'abilità di diventare scopritori di
inganni sempre più abili. La civilizzazione umana, e in ultima analisi
l'intelligenza umana, sono i prodotti di una specie di corsa agli armamenti e
le principali testate nucleari sono le menzogne. Se sei civilizzato e non sei
un bugiardo, probabilmente è perché non sei un bravo bugiardo.
Tutto questo che cosa ci dice di noi stessi? Che tipo di animale
penserebbe al suo bene più prezioso, la moralità, come a qualcosa di basato
su un contratto? Che tipo di animale riterrebbe che possiamo capire come
sarebbe una società giusta e onesta pensandola in termini di un ipotetico
contratto accettato dai suoi membri? Per un lupo, ma a quanto pare non per
una scimmia, la risposta sarebbe ovvia: un ingannatore.
Una volta scrissi un libro sul contratto sociale. L'ispirazione mi venne da
Brenin, intento a fare ciò che faceva meglio. Era l'epoca del nostro primo
Natale insieme in Irlanda e stavamo andando a trovare i miei genitori nel
Galles, dove Brenin era sempre felice di tornare nonostante alcune ne
profonde divergenze d'opinione con Bonnie e Blue. Mia madre assecondava
i suoi capricci molto più di me era stato così che Brenin aveva scoperto per
la prima volta le meraviglie del formaggio. Il formaggio, mi ero reso conto,
era di gran lunga il suo cibo preferito ed eclissava decisamente la carne che
compravo per lui. Quando mia madre cucinava qualcosa che richiedeva il
formaggio, la presenza di Brenin in cucina era fuori discussione. Se ne stava
seduto vicino a lei, emettendo un suono che è difficile da descrivere, dato
che nessun cane lo fa. Era una breve, secca sequenza di qualcosa a metà tra
un guaito e un ululato. I lupi non abbaiano; abbaiare è un comportamento da
cucciolo e sostanzialmente significa «Vieni a proteggermi. Qui sta
succedendo qualcosa e io non capisco bene cosa». Brenin non abbaiava
anche se, di tanto in tanto, ululava. Ma quando si eccitava - e il formaggio
aveva sempre questo effetto su di lui - emetteva una serie di «ohè, ohè, ohè,
ohè, ohè...» che accompagnava con un occasionale salto e con una cosa che
non gli avevo mai visto fare prima e che non immaginavo avrebbe mai
fatto: drizzarsi sulle zampe posteriori ed elemosinare. Alla fine mia madre
gli lanciava un pezzetto di formaggio e l'intero processo ricominciava.
Questo cerimoniale lo intratteneva per ore, se la preparazione del pasto
durava abbastanza a lungo. Dopo un po’ l'attività culinaria diventò
marginale: la sola presenza di mia madre nei pressi del frigorifero era
sufficiente a scatenarlo.
Quel Natale viaggiavamo con la Irish Ferries, da Rosslare a Pembroke. La
traversata in traghetto durava in genere circa quattro ore. Avevo lasciato
Brenin in macchina, altrimenti avrei dovuto rinchiuderlo in una delle gabbie
nel ponte auto: non gli era permesso stare di sopra con me. L'avevo già
lasciato dentro l'auto parecchie volte in precedenza e non c'erano mai state
conseguenze negative. In genere, prima di imbarcarci, gli facevo fare una
lunga passeggiata sulla spiaggia di Rosslare, in modo da stancarlo un po'. In
quell'occasione, però, circa dieci minuti prima di attraccare a Pembroke,
mentre risalivamo il canale navigabile di Milford Haven, alzai lo sguardo
dal libro che stavo leggendo e vidi Brenin che trottava allegramente nel
salone passeggeri superiore, in direzione del ristorante. Nella sua scia
c'erano diversi dipendenti della Irish Ferries che fingevano di volerlo
catturare, ma che in realtà si tenevano a distanza di sicurezza. Gridai il suo
nome e Brenin, come nel già citato incidente del «pasto dell'affamato» di
cinque anni prima, si immobilizzò di colpo a metà di un passo e si voltò
verso di me, assumendo lentamente l'espressione di Wile Coyote quando
capisce che gli è andata male.
Avevo lasciato il finestrino dell'auto leggermente socchiuso in modo che
Brenin avesse un po’ d'aria. A un certo punto, durante la traversata, lui era
riuscito ad abbassare il vetro a forza ed era uscito. Teoricamente il ponte
auto doveva essere chiuso a chiave, ma immagino che lo avessero aperto
mentre viaggiavamo lungo il canale, cosa che aveva consentito a Brenin di
scappare. Poi in qualche modo aveva trovato la strada per arrivare al salone
passeggeri superiore, salendo quattro rampe di scale, forse per cercarmi,
oppure, più probabilmente, per seguire l'odore del cibo. Tremo al pensiero
di quello che sarebbe potuto succedere se ce l'avesse fatta a raggiungere il
ristorante. Ricordavo fin troppo bene che cosa capitava durante le lezioni se
uno studente dimenticava di chiudere ermeticamente lo zaino che conteneva
qualcosa da mangiare. Mi immaginavo i clienti urlanti che si precipitavano
fuori dal ristorante del traghetto, mentre Brenin, con le zampe sul tavolo,
divorava serenamente il cibo abbandonato, cominciando dai piatti a base di
formaggio.
Nella traversata di ritorno, dopo Natale, decisi di prevenire qualsiasi
possibile strage al ristorante assicurandomi che questa volta i finestrini della
macchina fossero aperti solo per una fessura. Come risultò poi, si trattò di
un grave errore di giudizio da parte mia. Brenin fece a pezzi l'auto,
letteralmente. Ora che lui ebbe finito la sua opera e io venni avvertito di
quello che stava succedendo, nell'abitacolo non era rimasto più niente di
riconoscibile come parte di una vettura. I sedili erano stati sventrati, le
cinture di sicurezza erano completamente masticate e dal tettuccio strappato
fuoriusciva tutta l'imbottitura, con il risultato che era quasi impossibile
vedere fuori. Inoltre Brenin era riuscito ad aprire un grosso sacchetto di cibo
per cani, sparpagliandone il contenuto in ogni angolo e fessura dell'auto.
Venni chiamato giù nel ponte auto dal personale del traghetto,
terribilmente divertito, e fissai incredulo per alcuni minuti l'interno della
mia auto, o ciò che ne rimaneva. Notai che l'addetto al ponte auto aveva con
sé un coltello e gli chiesi se poteva prestarmelo: dovevo tagliare i brandelli
penzolanti del tettuccio, se volevo avere una speranza di vedere la strada
tentando di guidare verso a casa. L'uomo mi sembrò stranamente riluttante a
separarsi dal suo coltello e, interrogato, rispose che pensava che volessi
uccidere Brenin. Figuriamoci! Gli spiegai - evidentemente lo shock fa
scattare in me la molla del conferenziere - che, pur non essendo troppo
entusiasta di come erano andate le cose, non potevo ritenerne Brenin
responsabile. Brenin non era il tipo di creatura che poteva essere considerata
moralmente responsabile, dichiarai al ridacchiante addetto al ponte auto.
Brenin era ciò che si definisce un paziente morale, ma non un agente
morale. Non capiva che cosa stava facendo e quindi non capiva che era
sbagliato. Aveva voluto semplicemente uscire dall'auto. Come altri animali,
Brenin era il tipo di creatura che ha dei diritti - un diritto a un certo tipo di
trattamento e stile di vita -, ma non ha concomitanti responsabilità. Poi feci
l'unica cosa che un filosofo che si rispetti può fare in circostanze del genere:
andai a casa e ci scrissi sopra un libro.
L'idea di base era trovare un modo per includere gli animali nel contratto
sociale, rendendo il contratto più equo. Immaginate di fare parte di un
gruppo che ha appena ordinato una pizza. Come fate a essere sicuri che
ognuno di voi riceva una fetta delle giuste dimensioni? Ecco un sistema
semplice: lasciate che sia un membro del gruppo a tagliare la pizza, ma fate
in modo che riceva la sua fetta tra gli ultimi. Se chi taglia non sa quale fetta
gli toccherà, non potrà organizzare le cose a proprio favore. Non avrà altra
scelta che tagliare la pizza equamente. Immaginiamo adesso che la pizza sia
la società. Come fate a essere sicuri che la società nella quale vivete sia
equa? Così come ci siamo assicurati un'equa suddivisione della pizza
facendo sì che chi tagliava non sapesse quale fetta gli sarebbe toccata,
potremmo garantirci una società equa consentendo a una persona di
scegliere come dovrà essere organizzata quella società, ma facendo in modo
che, nel momento della scelta, non sappia chi farà parte di quella società.
Questo fantasioso espediente venne sviluppato per la prima volta da un
filosofo di Harvard, John Rawls, morto nel 2002, il quale parlò di
«posizione originaria».
Rawls usava la posizione originaria come un modo per rendere il
contratto più giusto: per lui la giustizia sociale si riduceva all'equità. La mia
tesi era che Rawls, nel suo sviluppo della posizione originaria, avesse
tralasciato una fonte di iniquità. Rawls, infatti, insiste nell'escludere la
conoscenza di chi siete e di ciò che per voi ha valore, quando decidete come
dev'essere organizzata la società. Non sapete se sarete maschio o femmina,
bianco o nero, ricco o povero, intelligente o stupido e così via. E non sapete
neppure se sarete un credente o un ateo, un altruista o un egoista, e così via.
Ma Rawls ammette comunque che sapete che cosa siete e che cosa potete
fare: sapete che siete esseri umani e sapete che siete razionali. La mia
posizione era che, se si voleva rendere il contratto davvero equo, si doveva
escludere anche quest'ultima conoscenza. Inoltre sostenevo che Rawls fosse
implicitamente impegnato a escludere tale conoscenza, anche se riteneva di
non esserlo. Il risultato fu lo sviluppo di una forma di contrattualismo
rawlsiano che Rawls avrebbe detestato. I vantaggi, però, consistevano
nell'inclusione nel contratto non solo degli animali, ma anche di categorie
umane che la versione tradizionale del contratto escludeva: i neonati, i
vecchi, i malati di mente. In breve: i deboli.
Il libro che risultò da queste riflessioni è Animai Rights: A Philosophical
Defence. Se riuscite a trovare una prima edizione, vedrete Brenin in
copertina. Non fu il mio primo libro, ma fu quello che rimise in moto la mia
carriera dopo i sette anni di festa in Alabama. E l'unico prezzo che dovetti
pagare furono un'insignificante automobile e una vita senza carne.
Questa fu la vera punta velenosa dell'impeto distruttivo di Brenin quel
giorno. Naturalmente la lezione non sarebbe stata assimilata se io non avessi
già avuto in mente il tema della visione socio- contrattuale della moralità:
all'epoca tenevo un corso per laureati proprio su questo argomento.
Ma quello sfortunato concorso di cause comportò un deprimente futuro da
vegetariano. Se ero nella posizione originaria - la mia nuova, più equa
versione della posizione originaria - non potevo certo scegliere un mondo
dove ci sono animali fatti nascere e allevati per la loro carne. Si tratta di
animali che vivono una vita miserabile e subiscono una morte orribile. E
dato che la conoscenza della propria specie dev'essere esclusa dietro il «velo
dell'ignoranza», per quello che so nella posizione originaria potrei essere
uno di quegli animali. Per chi si trova nella posizione originaria sarebbe
irrazionale scegliere un mondo del genere. Quindi un mondo del genere è
immorale. Il che, dal mio punto di vista, era una sfortuna, dato che sento la
mancanza di bistecche succulente e pollo fritto. Ma a volte la moralità tende
a essere scomoda. Per un po’ sono stato addirittura vegano e, moralmente
parlando, dovrei esserlo ancora: è l'unica posizione morale coerente
riguardo agli animali. Ma come non sono malvagio quanto potrei essere,
così non sono neppure buono quanto potrei essere. Tentai comunque di
rivalermi su Brenin facendo diventare vegetariano anche lui, ma non ne
volle sapere. Si rifiutava di mangiare il pasto vegetariano per cani che gli
mettevo davanti, punto e basta. E chi poteva biasimarlo? Se avessi condito il
tutto con una scatoletta di carne le cose sarebbero andate diversamente, ma
questo avrebbe significato vanificare lo scopo dell'operazione. Alla fine
arrivammo a un compromesso: io diventai vegetariano, Brenin passò a una
dieta a base di pesce. Gli preparavo un pasto secco vegetariano al quale
mescolavo una scatoletta di tonno - ovviamente di una marca rispettosa dei
delfini e mai tonno pinna gialla a causa dei livelli di mercurio - e, a volte,
aggiungevo qualche pezzetto di formaggio. Spero che Brenin non abbia
sentito la mancanza della carne quanto la sentivo io (anzi, quanto la sento
ancora). Ho comunque il sospetto che in realtà preferisse la sua nuova dieta,
specialmente nei giorni in cui aggiungevo il formaggio. In caso contrario...
bè, allora forse avrebbe dovuto pensarci prima di mangiarsi la mia auto. E al
diavolo tutto ciò che dissi all'addetto al ponte auto!
Fu immorale da parte mia imporre a Brenin quella dieta? C'è chi mi ha
detto di sì. Ma considerate l'alternativa. Un paio di tazze di cibo secco per
cani a base di carne più una scatoletta di carne al giorno avrebbero
significato parecchie mucche nel corso di tutta la sua vita, pur tenendo
conto del fatto che la quantità di carne presente nel cibo secco per cani con
ogni probabilità non si avvicina neppure lontanamente a quella dichiarata. A
Brenin il nuovo cibo sembrava piacere molto e lo divorava con lo stesso
entusiasmo di prima. E io sono abbastanza sicuro che una scatoletta di
tonno abbia un sapore di gran lunga migliore di una scatoletta di carne per
cani. Quindi la nuova dieta poteva essere adottata con inconvenienti minimi,
o addirittura nulli, per Brenin e non comportava la morte di numerose
mucche. Se Brenin si fosse rifiutato di mangiare, o avesse mangiato meno,
se avesse perso peso o dato segni di malessere, sarebbe stata tutta un'altra
storia. Ma, in breve, la scelta era tra l'interesse relativamente blando di
Brenin e l'interesse vitale delle mucche. Questo, in sostanza, è l'argomento
morale a favore del vegetarianismo: l'interesse vitale degli animali a evitare
vite miserabili e morti atroci ha un peso assai maggiore dell'interesse
relativamente blando che gli esseri umani nutrono per i piaceri del palato.
Naturalmente, dato che Brenin seguiva una dieta a base di pesce e non era
vegetariano, il nuovo regime alimentare non era molto tenero con i tonni.
Ma i tonni hanno una vita molto migliore delle mucche. O almeno così mi
dicevo.
Il contratto, come ho cercato di dimostrare, verte in realtà su due punti:
potere e inganno. Il mio libro, come quasi tutto ciò che è stato scritto
sull'argomento in anni recenti, tratta del modo in cui minimizzare l'impatto
delle disparità di potere sul processo decisionale morale. Ma questo non
affronta il vero problema. Non si può tentare di correggere ciò che è
davvero sbagliato nel contratto cercando semplicemente di rendere più equo
il contratto stesso. Il vero problema sono l'inganno e quel che sta alla base
dell'inganno, ovvero il calcolo. Io credo che il contratto sia un espediente
inventato dalle scimmie per regolare le interazioni tra scimmie.
Pensare a ciò che è giusto e sbagliato attraverso il prisma del contratto ci
dà, in sostanza, una visione della moralità come qualcosa concepito per
persone tra loro estranee: scopo della moralità è regolare le interazioni tra
individui che si conoscono a malapena e che non si piacciono
particolarmente. E se pensiamo la moralità in questi termini, arriveremo
naturalmente all'idea che la giustizia - l'equità - è la virtù morale primaria: la
«prima virtù», per usare la definizione di Rawls, delle istituzioni sociali.
Moralmente parlando, come dovrebbero interagire persone estranee, se non
con equità?
Tuttavia, oltre a una moralità per persone estranee, c'è anche una moralità
per i componenti del branco. Hobbes pensava alla natura come «rossa di
zanne e di artigli». Quando io penso alla natura, penso al Brenin di sei
settimane il giorno in cui lo portai a casa: un grosso, soffice orsacchiotto
distruttivo. Perché quello era Brenin prima del nostro accordo, prima che io
lo portassi nella mia civiltà. La natura non è più rossa e cruda di ciò che
chiamiamo civiltà, e non c'è alcuna guerra di tutti contro tutti. La vita dei
lupi può essere breve, ma può esserlo anche la nostra. I lupi non sono
solitari e sono poveri solo secondo i nostri parametri.
Dopo avere trascorso più o meno un'ora in casa con Brenin quel
pomeriggio di maggio, amavo già la piccola, morbida nemesi di tende e
impianti dell'aria condizionata. L'avrei sempre amata. Brenin, ovviamente,
non era certo in posizione di potermi aiutare, poteva nuocermi - come aveva
già fatto - solo nel portafoglio e non c'era nulla che potessi fare per
modificare la situazione. Se mai ci fu un contratto tra noi, allora fu del tutto
marginale e si basò su una moralità più essenziale e viscerale. Una moralità
che predicava non la giustizia, ma la lealtà.
La decisione di far convertire Brenin a una dieta a base di pesce fu
insolita da questo punto di vista, dato che si trattò di una delle poche
occasioni in cui misi gli interessi di animali che non avevo mai visto né
avrei mai visto al di sopra e al di là degli interessi del mio lupo. In quel caso
privilegiai la giustizia rispetto alla lealtà. Devo ammettere che lo feci solo
perché ero arrivato alla conclusione che, nel caso particolare, le esigenze
della lealtà erano molto blande - Brenin poteva seguire la nuova dieta con
inconvenienti minimi, o addirittura nulli - mentre le esigenze della giustizia
erano assolutamente inequivocabili. Ma situazioni del genere, come dicevo,
erano rare. Come mi piace dire ai miei studenti quando discutiamo di
dilemmi morali, se vi foste mai trovati in una condizione «da scialuppa di
salvataggio» con me e Brenin, bè, avreste avuto una sfortuna nera. Loro
pensano che io scherzi.
Uno dei compiti più difficili per quanto riguarda la moralità è bilanciare
le esigenze degli estranei con quelle del branco, le richieste della giustizia
con l'insistente richiamo della lealtà. È chiaro che la filosofia, per gran parte
della sua storia, ha enfatizzato il concetto secondo il quale la moralità è per
gli estranei. Credo che questo non sia un caso, ma una conseguenza del
nostro pedigree scimmiesco. Se pensate alla società come a un insieme di
estranei, penserete alla moralità come a una forma di calcolo mediante il
quale tentiamo di capire quale sarà per tutte le parti interessate il miglior
risultato, secondo un qualche standard di «migliore». E il calcolo è la cosa
in cui la scimmia che è in noi riesce meglio. Noi non guardiamo le scimmie
nostre simili, le teniamo d'occhio. Complottiamo, cospiriamo, calcoliamo le
probabilità, valutiamo le possibilità e intanto aspettiamo l'occasione giusta
per avvantaggiarci. I rapporti più importanti della nostra vita vengono
valutati in termini di surplus e deficit, profitti e perdite. Che cos'hai fatto per
me di recente? Mi soddisfi? Che cosa ci guadagno, stando insieme a te, e
che cosa ci perdo? Posso trovare di meglio? Il calcolo nei confronti della
società nel suo insieme - calcolo morale più che prudenziale - è
semplicemente un'estensione di questa abilità di base. Per noi scimmie è
naturale pensare in termini contrattuali, perché il contratto altro non è che
un sacrificio deliberato in vista di un guadagno previsto. L'idea del contratto
è solo la codificazione - l'esplicitazione - di qualcosa che si nasconde dentro
di noi, in profondità. Il calcolo è al centro del contratto e nel cuore della
scimmia che è in noi. Il contratto è un'invenzione delle scimmie per le
scimmie e non può dire assolutamente nulla sul rapporto tra una scimmia e
un lupo.
Perché noi, o almeno alcuni di noi, amiamo i nostri cani? Perché io amavo
Brenin? Mi piace pensare - e qui devo scivolare di nuovo nella metafora che i nostri cani risvegliano qualcosa nei recessi più profondi di una parte a
lungo dimenticata della nostra anima, dove sopravvive un noi più antico,
una parte di noi che esisteva prima che diventassimo scimmie. E il lupo che
eravamo un tempo. È il lupo che sa che la felicità non può essere trovata nel
calcolo. Sa che nessun rapporto autenticamente significativo può basarsi su
un contratto. Prima di tutto c'è la lealtà. E dobbiamo rispettarla, cadesse il
mondo. Calcoli e contratti vengono sempre dopo, come la parte scimmiesca
della nostra anima viene dopo quella lupesca.
Sei. La ricerca della felicità e i conigli
Nel periodo irlandese Brenin era nel fiore degli anni. Era diventato
davvero massiccio: alto novanta centimetri al garrese, pesava circa
sessantotto chili. Era alto quanto gli alani con cui ero cresciuto, ma aveva
una struttura molto più possente. Gli arti, lunghi come quelli della madre,
terminavano in zampe grandi quanto i miei pugni, ma Brenin si era anche
irrobustito e la stazza ormai era quella del padre. La testa era un largo cuneo
tra le grosse spalle. Il torace era lungo e i fianchi erano snelli. Più di
qualsiasi altra cosa, Brenin mi faceva pensare a un toro. In effetti, quando
pensavo a quanto era cambiato dai suoi giorni da cucciolo in Alabama, mi
veniva sempre alla mente la poesia di Dylan Thomas Lament, con il
racconto della trasformazione dell'uomo da giovane vitello a toro. La riga
nera che in gioventù gli scendeva sul muso era sbiadita, ma era ancora
visibile in mezzo agli stessi strani occhi dal taglio allungato. Non ho molte
fotografie di Brenin - all'epoca non ne facevo -, ma quando penso a lui e
cerco di fissare la sua immagine nella mente, vedo dei triangoli. In primo
piano, nella mia coscienza, ci sono sempre triangoli in movimento: il
triangolo della testa e del muso, i triangoli delle orecchie, il triangolo del
torace visto lateralmente, che declina dalle spalle alla coda, il triangolo del
busto visto di fronte, che si assottiglia negli arti fino alle zampe. E la linea
nera del muso e gli occhi gialli a mandorla erano il punto focale intorno al
quale erano organizzati tutti quei triangoli.
Abitavamo a Cork da circa un anno, quando decisi che Brenin aveva
bisogno di un amico, uno che avesse più gambe di me e un naso più freddo
del mio. Sfogliando il «Cork Examiner» - proprio come cinque anni prima
avevo sfogliato il «Tuscaloosa News» - notai un annuncio che parlava di
«malamute». La cosa era sorprendente e, al tempo stesso, inquietante. Il
malamute è un cane artico da slitta, simile all'hu-sky, ma molto più alto e
massiccio. Il fatto più importante, però, era che «malamute» era ancora
ufficialmente l'identità di copertura di Brenin: era questo che raccontavo a
tutti quelli che mi chiedevano di che razza fosse. Gli irlandesi, per una
qualche ragione, sono terrorizzati dai cani grandi e grossi. Se qualcuno
avesse scoperto che Brenin era un lupo, probabilmente ci avrebbero espulsi
subito dal paese, o peggio. C'era un negozio all'angolo dove avevo
l'abitudine di fermarmi con Brenin durante la camminata quotidiana per
andare al lavoro. Un giorno vidi che sulla locandina del quotidiano davanti
al negozio spiccava il titolo Lupo. Si trattava della storia molto triste di un
incrocio di lupo (piuttosto piccolo) che era scappato di casa e vagava nelle
campagne dell'Irlanda del Nord. Anche se la notizia riguardava il Nord
dell'isola, i mass media irlandesi erano in fibrillazione, e lo era anche la
donna che mi vendette la quotidiana lattina di Coca- Cola e un sandwich al
formaggio. Si lanciò nelle solite chiacchiere disinformate, declamate senza
rivolgere neppure un'occhiata a Brenin, al quale era del tutto abituata.
Bisogna pensare ai bambini. Quei lupi dovrebbero essere proibiti. Sono dei
killer. Alla fine il lupo venne effettivamente ucciso a fucilate da un
contadino al quale si era avvicinato, forse in cerca di cibo. E i bottegai e i
bambini di Erin poterono di nuovo dormire sonni tranquilli. Quindi Brenin,
come Clark Kent, aveva ottime ragioni per mantenere segreta la sua vera
identità. «Malamute» era il modo che avevo escogitato per riuscirci. I
malamute erano virtualmente sconosciuti in Irlanda e io speravo che le cose
restassero così.
Il giorno dopo ci vide raggiungere in auto un paesino poco lontano da
Ennis, nella contea di Clare, un viaggio di tre ore circa. Il padre della
cucciolata risultò essere davvero un malamute: un massiccio esemplare
marrone grosso quasi quanto Brenin, il quale inevitabilmente lo odiò subito.
La madre, però, non era affatto un malamute, ma un piccolo pastore
tedesco, forse il più brutto pastore tedesco che avessi mai visto.
In base alla mia esperienza, quando i genitori sono male assortiti, i
cuccioli crescendo finiscono sempre con l'assomigliare al più brutto dei due.
Per cui decisi che non ne volevo sapere. Ma, quando vidi i cuccioli, cambiai
idea. Erano rinchiusi in un garage, sporchi e pieni di pulci. Decisi che
dovevo salvarne uno e scelsi la femmina più robusta. Non so resistere ai
cuccioli. Ciononostante, guidai verso casa con una sensazione decisamente
sgradevole nello stomaco. Splendido, pensavo, eccomi incastrato con un
brutto pastore tedesco per i prossimi dieci anni o giù di lì. Ma quella si
sarebbe rivelata una settimana fortunata. Crescendo, la cucciola sarebbe
diventata la cagna più simpatica, coraggiosa e intelligente che si potesse
desiderare. E, per quello che conta, nient'affatto brutta. La chiamai Nina,
diminutivo di Karenina, da Karenin, il cane dell'Insostenibile leggerezza
dell'essere (uno dei miei libri preferiti), un nome di inequivocabili
ascendenze tolstoiane.
Avevo voluto Nina soprattutto perché Brenin avesse un po’ di compagnia
canina. Ma lui, all'inizio, non apprezzò molto l'iniziativa. Da cucciola, lei lo
tormentava continuamente, non lo lasciava in pace un momento. In un
lampo imparò a sfruttare il retaggio selvatico di Brenin contro di lui,
scoprendo come fargli rigurgitare il cibo. Pochi secondi di frenetiche leccate
sul muso - Brenin cercava di scostare la testa, ma lei era implacabile bastavano a far tornare su il pasto, che Nina divorava deliziata: una scena
che riusciva a essere commovente e rivoltante al tempo stesso. Nina diventò
ben presto una cucciola molto grassa e Brenin un lupo molto magro. Dopo
qualche tempo Brenin si trovò una zona del giardino dove Nina non poteva
arrivare, dato che bisognava saltare su un terrapieno alto più di un metro.
Prese l'abitudine di starsene lassù per ore, soprattutto dopo mangiato, con
Nina che saltava e guaiva inutilmente di sotto. La tregua durò solo poche
settimane - dopo un po’ Nina crebbe abbastanza da riuscire a raggiungerlo -,
ma diede comunque a Brenin il tempo di recuperare il peso che aveva perso.
Tuttavia, malgrado il tormento continuo, Brenin era molto protettivo nei
confronti di Nina e non permetteva a nessuno - cani o uomini - di
avvicinarsi a lei. E questo mi porta al secondo colpo di fortuna di quella
settimana. Una notte, pochi giorni dopo l'arrivo di Nina, verso mezzanotte
ci fu un rumore nel giardino sul retro. Il giardino era circondato su tutti i lati
da una staccionata alta due metri e mezzo, forse più, ed era impossibile
entrare per caso. Io non sentii il rumore, ma Brenin sì: scattò in piedi, corse
alla finestra e si alzò sugli arti posteriori, appoggiando le zampe anteriori
sul davanzale. Quando lo feci uscire, corse verso il terrapieno in fondo al
giardino, il posto dove aveva l'abitudine di nascondersi per sfuggire a Nina,
sparì dietro un albero e ricomparve trascinando un uomo, che poi bloccò a
terra. Esito a raccontare il seguito, dato che in effetti non ne esco molto
bene. A mia difesa, posso solo dire che avevo vissuto negli Stati Uniti così a
lungo da avere ancora una mentalità americana. Oh, mio Dio, pensai, e se
ha una pistola? Sparerà al mio lupo! Così corsi anch'io in giardino e
cominciai a prendere a calci lo sconosciuto, urlando: «Non muoverti,
bastardo!» e altri «americanismi» del genere. Ma, naturalmente, il bastardo
si muoveva: è difficile non farlo, quando ti ritrovi con un lupo alla gola e un
pazzo che ti prende a calci urlando parolacce. Poi la situazione si calmò.
Immobilizzai l'uomo - un tizio grosso, più o meno della mia età, che
avrebbe potuto verosimilmente crearmi dei problemi, se fossi stato da solo con una presa Nelson in piena regola: un braccio dietro la schiena, l'altro
piegato sopra la spalla. «Che cosa ci fai nel mio giardino?» gli chiesi.
«Niente...» balbettò lui. Così lo condussi fuori dalla mia proprietà e lo buttai
in strada.
All'epoca non avevo il telefono, per cui non avrei potuto chiamare la
polizia. Ma non appena la scarica di adrenalina si esaurì, cominciai a
rendermi conto che quella sarebbe stata comunque una cattiva idea.
L'enormità di quello che avevo appena fatto cominciò a farsi strada nel mio
cervello. Se fossimo stati in America e Brenin e io avessimo bloccato un
intruso in quel modo, avremmo quasi sicuramente ricevuto le
congratulazioni dei vicini di casa e anche della polizia. Ma pensavo che non
sarebbe andata così in Irlanda, dove tendono a disapprovare l'utilizzo di un
lupo per infierire sugli intrusi. Fortunatamente era una fredda notte di fine
ottobre e lo sconosciuto indossava un giaccone pesante. Ritenevo che
Brenin non fosse riuscito a procurargli gravi danni attraverso il tessuto, o
perlomeno non avevo visto sangue, quando avevo buttato fuori l'uomo.
Comunque conclusi che, tutto considerato, quello poteva non essere un
brutto momento per far levare le tende a Brenin rapidamente. Forse la mia
era una reazione esagerata, ma l'incidente dell'incrocio di lupo nel Nord mi
aveva reso più che leggermente paranoico. Così decisi di portare Brenin dai
miei genitori per qualche settimana, finché le acque non si fossero calmate.
Preparai in fretta una borsa e mi accinsi a una nottata in auto con Brenin e
Nina fino a Rosslare, dove ci saremmo imbarcati sul traghetto delle nove
del mattino per metterci al sicuro fuori dal paese prima che le guardie - la
Garda Siochana, la polizia irlandese - ci trovassero.
Poi qualcuno bussò alla porta. Le guardie erano già arrivate! Scostai la
tenda e sbirciai in direzione della porta d'ingresso, mentre nella mente mi
sfrecciavano pensieri del tipo: come ci si deve comportare esattamente in
una situazione di assedio? Anzi, come si organizza una situazione d'assedio
quando non si ha una pistola? O, se è per questo, nemmeno un ostaggio?
Risultò che non c'era bisogno di preoccuparsi: era la vicina della porta
accanto, la quale mi informò che l'uomo che Brenin e io avevamo aggredito
era suo marito, da cui era separata. La donna mi raccontò che ogni tanto - di
solito dopo essersi ubriacato - l'ex marito andava da lei per picchiarla.
Meglio ancora, almeno dal punto di vista mio e del mio lupo, mi riferì che
c'era una diffida del tribunale per cui l'uomo doveva restare a una distanza
di almeno trenta metri da casa sua (questo provvedimento non era servito a
molto, a quanto pareva). Pensai, allora, che le probabilità che l'uomo si
rivolgesse alla polizia fossero piuttosto scarse e decisi di sospendere la
nostra fuga notturna verso Rosslare.
Ancora oggi non riesco a capacitarmi della fortuna che ho avuto quella
notte. Certo, chiunque si fosse aggirato nel mio giardino a mezzanotte non
poteva avere buone intenzioni. Ma, anche così, ci avreste mai voluti come
vostri vicini di casa? «E se ci fosse stato un bambino in giardino?» avrebbe
detto la signora del negozio all'angolo. Io tendo a pensare che sarebbe
andato tutto bene. In vita sua, Brenin non ha avuto molte occasioni di
incontrare bambini, ma, quando è capitato, li ha sempre trattati con una
delicatezza e un riguardo che non mancavano mai di colpirmi. Di sicuro,
dopo quella notte, fece amicizia con il ragazzino della porta accanto e sia lui
sia la madre gli si affezionarono molto.
L'episodio, comunque, mi costrinse a rendermi conto di qualcosa che,
ripensandoci adesso, si agitava nella mia mente preconscia già da qualche
tempo. Brenin e io eravamo un po’ troppo estrosi e, di conseguenza, un po’
troppo pericolosi. Se fossimo stati cowboy, la gente ci avrebbe descritti
come due dal grilletto facile. È questo che mi viene in mente, quando
ripenso al mio comportamento di quella notte. Ero stato fin troppo veloce a
buttarmi nella mischia e i miei piedi erano stati un po’ troppo ansiosi di
aiutare i denti digrignati di Brenin. Il nostro senso di reciproca lealtà era
ormai di gran lunga superiore al nostro senso di giustizia nei confronti degli
altri. Eravamo diventati un branco, uno Stato di due individui. E di quelli
che ne stavano fuori non ci importava quanto avrebbe dovuto.
Dopo questo incidente, molti di voi potrebbero pensare che per Brenin
non ci fosse posto in una società civilizzata.
Può darsi che abbiate ragione, ma se è così, io aggiungerei una
precisazione: non c'era posto neppure per me. Quella notte segnò l'inizio del
nostro graduale ritiro dal mondo degli uomini. Quel mondo - e su questo
voglio essere sincero - aveva cominciato a disgustarmi. Mi disgustava che
nei confronti di Brenin ci fosse una politica dello sparare per uccidere. Mi
disgustava dovere essere un uomo in fuga, sempre pronto a fare i bagagli e a
prendere il volo. Naturalmente quei pensieri erano reazioni eccessive e
melodrammatiche. In realtà erano scuse che mi consentivano di fare
qualcosa che volevo fare comunque. Il vero cambiamento non era nel
mondo, ma in me. Dal socievole animale da feste dei miei giorni in
Alabama ero diventato qualcosa di molto diverso: un solitario, un
disadattato, un misantropo. Ero uno che si sentiva estraneo. Ero disgustato
dagli uomini. Avevo bisogno di togliermi la loro puzza dalle narici.
Lasciammo Cork qualche mese dopo. La vicina della porta accanto e suo
figlio furono molto dispiaciuti della nostra partenza. Quando un cane grosso
e malvagio ti rende la vita un inferno e la tua civilizzazione non fa niente in
proposito, allora a volte ciò di cui hai bisogno è un cane ancora più grosso e
più cattivo che ti guardi le spalle.
Acquistai una casa - una tipica casetta del custode - sulla penisola di
Knockduff, a pochi chilometri dalla città di Kinsale sulla costa meridionale
dell'Irlanda e a circa trenta chilometri da Cork. Mi piacerebbe poter dire che
mi innamorai del posto non appena lo vidi, ma la verità è che era già da un
po’ che cercavo casa e le trattative finivano sempre per andare a monte
all'ultimo minuto, perlopiù a causa dell'indecisione dei venditori. Così
quando vidi la casa di Kinsale, e dopo averla studiata per meno di due
minuti, la mia reazione fu: va benissimo. Feci la mia offerta e me la vidi
accettare nel giro di dieci minuti. L'edificio era, come ho detto, una casetta
del custode costruita nel XVIII secolo, con muri di pietra spessi quasi un
metro verniciati di bianco e pietra a vista intorno alle porte e alle finestre.
Aveva «porte da stalla» marroni - quelle porte divise in due parti, superiore
e inferiore, che si possono aprire separatamente -sia davanti sia dietro e, a
causa dello spessore dei muri, i davanzali delle finestre erano profondi
novanta centimetri. Al minimo rumore proveniente dall'esterno Brenin e
Nina si affacciavano alle porte da stalla, ritti sulle zampe posteriori, facendo
penzolare all'esterno le grosse zampe anteriori. Oppure, se le porte erano
chiuse, saltavano sui davanzali e guardavano fuori con aria minacciosa.
Erano sicuramente il miglior deterrente del mondo per i ladri. Anzi, in realtà
erano un deterrente per tutti. Abbastanza comprensibilmente, Colm il
postino era un po’ riluttante a scendere dal suo furgone, per cui se ne stava
chiuso dentro e suonava il clacson finché non gli davo il via libera. In
seguito installai una cassetta per le lettere dove poteva depositare la posta
senza dovere scendere dal suo rifugio mobile.
La sostanza della casa si può riassumere in due parole: minuscola ed
essenziale. Credo che perfino Brenin e Nina la trovassero un po’ primitiva.
C'erano cinque stanze in tutto - soggiorno, bagno, due camere da letto e una
cucina -, ognuna delle quali molto piccola. Per un capriccio della storia o di
una mente bizzarra, il bagno era il locale più ampio di tutti. C'era un sistema
di riscaldamento centralizzato che funzionava quando gli pareva e, quando
non gli pareva, dovevo uscire a controllare la caldaia e contrattare il
permesso di riparare il guasto con la famiglia di topi che aveva deciso di
stabilirsi nel locale caldaia (un problema, quest'ultimo, che Brenin e Nina
mi risolsero molto rapidamente). Era la mia prima casa di proprietà. La
gente pensava che fossi pazzo: il prezzo che avevo pagato per
quell'abitazione minuscola, umida e piena di spifferi era considerato
eccessivo, perfino per una zona alla moda come quella di Kinsale, «la
capitale gastronomica d'Irlanda», dove decine di ristoranti d'élite avevano
inspiegabilmente deciso di insediarsi. Ma non dovevo preoccuparmi. Per
com'era il mercato immobiliare irlandese in quel periodo, avrei potuto
comprare un pollaio e farci ancora un mucchio di soldi.
Ma era la posizione ciò che mi piaceva davvero. Inoltre, la residenza
principale, cui la mia abitazione era annessa, era abbandonata e questo
significava che Brenin, Nina e io avevamo quasi un centinaio di ettari di
campagna ondulata dove correre ogni giorno. Dovevamo solo uscire dalla
porta per ritrovarci in mezzo a campi di orzo a perdita d'occhio. I campi
declinavano verso una zona boscosa, oltre la quale c'era il mare. Brenin e
Nina scoprirono in fretta che dove c'è orzo ci sono sempre topi. E
scoprirono in fretta anche che, per individuare i topi nell'orzo, c'è bisogno di
una visione sinottica. Per ottenerla, bisogna saltare. I salti spaventano i topi
e li fanno correre in tutte le direzioni. Dal loro punto di osservazione
temporaneamente sopraelevato, Brenin e Nina riuscivano a distinguere il
movimento nell'orzo e quindi ad avventarsi sulla preda. Tutto ciò che
potevo vedere di quei due erano gli occasionali balzi in aria, seguiti subito
dopo da una nuova immersione; sembravano salmoni che saltavano fuori da
un mare d'orzo. Penso che sia impossibile assistere a una tale
manifestazione di gioia senza sentirsi sollevare il morale, anche se i topi
magari erano di parere diverso.
I campi di orzo scendevano verso il bosco, ai margini del quale c'era una
conigliera. Qui il comportamento di Bre-nin e Nina cambiava: dai salti
passavano all'avvicinamento furtivo, cercando di sorprendere qualche
incauto coniglio che si scaldava al sole. In ciò Brenin era molto più abile di
Nina, che di solito mandava a monte il gioco scattando troppo presto
all'attacco. E di questo le ero molto grato. Dopo aver scritto il libro Animai
Rights, ero ufficialmente, e pubblicamente, contro l'uccisione di animali per
sport o alimentazione; ero contrario perfino all'eliminazione dei topi, anche
se tendevo a chiudere un occhio quando si stabilivano nel mio locale
caldaia. A quanto pareva, avevo una posizione molto più equivoca riguardo
al tema della violenza nei confronti di intrusi notturni che picchiavano le
mogli. Ma ero in ogni caso contrario alla crudeltà verso gli animali.
Incredibilmente, ero diventato ancora più bizzarro di quanto fossi stato in
precedenza: un vegetariano moralista, il più strano degli strani, condannato
a vivere il resto della sua disgraziata esistenza senza il piacere gustativo
della carne animale. E, come ricordavo sempre a Brenin dopo che gli avevo
mandato a monte questo o quel trucco acchiappaconigli, era tutta colpa sua.
Quando avevo lasciato l'Alabama per l'Irlanda, il mio piano era stato
trovarmi una casa in campagna il più lontano possibile dalla civiltà, un
posto dove non ci fosse assolutamente niente da fare, a parte scrivere. E,
perlopiù, mi attenni a quel piano. Ci furono delle fidanzate, ma entrarono e
uscirono dalla mia vita con una puntualità su cui si sarebbe potuto regolare
l'orologio e un'inevitabilità su cui si sarebbe potuto scommettere l'ultimo
dollaro rimasto in tasca. Presumo che entrassero nella mia vita perché ero
gentile e spiritoso - almeno quando mi prendevo il disturbo di esserlo - e
ancora insolitamente attraente, perlomeno per un accademico, con una
faccia non ancora rovinata da anni di alcol. Ne uscivano perché capivano
ben presto che non provavo un grande interesse per loro e che le vedevo
quasi solo come un comodo sfogo sessuale. Non ero assolutamente nello
stato d'animo giusto per condividere la mia vita con altri esseri umani.
Avevo altri pensieri.
La verità, suppongo, è che per natura sono sempre stato un misantropo.
Non ne vado orgoglioso e non si tratta di un aspetto del mio carattere che io
cerchi, o abbia cercato, di coltivare. Ma c'è, ed è inequivocabile. Con poche
eccezioni, i miei rapporti con gli altri sono sempre stati permeati dalla
sensazione - una vaga, tetra consapevolezza - che quello che sto facendo è
solo ammazzare il tempo. Era stato per questo che l'alcol si era insinuato
nella mia vita la prima volta. Dovevo sempre ubriacarmi per poter stare in
compagnia di amici, in Galles come a Manchester, a Oxford come in
Alabama. Non voglio dire che non mi divertissi: al contrario, me la
spassavo sul serio. Ma sono abbastanza sicuro che senza alcol sarebbe stato
diverso. E chi vi parla non è un borioso accademico disposto a frequentare
solo quelli che considera intellettualmente suoi pari. Gli accademici mi
annoiano addirittura di più. La colpa non è di nessuna delle persone che ho
definito miei amici. È mia. In me manca qualcosa. E negli anni sono
arrivato lentamente a capire che le scelte che ho fatto, e la vita che ho
vissuto, sono state una conseguenza di questa mancanza. Ciò che mi
caratterizza nel modo più significativo, credo, è quello che mi manca.
La carriera che ho scelto è quasi certamente un'espressione di questa
mancanza. Con la possibile eccezione delle più alte sfere della matematica
pura o della fisica teorica, è difficile immaginare qualcosa di più inumano
della filosofia. Il culto della logica in tutta la sua fredda purezza cristallina,
la determinazione a superare le vette brulle e ghiacciate della teoria e
dell'astrazione: essere filosofo significa essere esistenzialmente sradicato.
Quando penso a un filosofo, penso sempre a Bertrand Russell, seduto tutto
il giorno - tutti i giorni per cinque anni - alla British Library, intento a
scrivere i Principia mathematica, un tentativo incredibilmente difficile,
ingegnoso e probabilmente non riuscito di derivare la matematica dalla
teoria degli insiemi. Russell impiegò ottantasei pagine per dimostrare,
utilizzando solo l'apparato della teoria degli insiemi, l'affermazione - che
definì con ironia «occasionalmente utile» - per cui uno più uno fa due.
Potete quindi immaginare quanto sia lungo il libro. Oppure penso a
Nietzsche, uno zoppo itinerante che vagava da un paese all'altro, senza
amici, senza famiglia, senza soldi; e penso al suo lavoro che, dopo un inizio
promettente, gli procurò solo emarginazione e derisione. E pensate al prezzo
che pagarono. Intellettualmente, Russell non fu più lo stesso. E Nietzsche
precipitò nella follia, anche se bisogna ammettere che forse in ciò giocò un
ruolo anche la sifilide. La filosofia inaridisce. Ai filosofi bisognerebbe
porgere condoglianze piuttosto che incoraggiamenti.
Perciò sospetto che dentro di me ci sia sempre stato un misantropo in
attesa della sua opportunità. In gioventù era stato tenuto ben rinchiuso nella
sua gabbia, ma l'arrivo in Irlanda segnò il suo momento. Dato che in
matematica ero una frana - un anno d'ingegneria a Manchester lo aveva
dimostrato in modo definitivo - la filosofia era probabilmente l'unica
carriera che mi consentisse di curare adeguatamente l'aspirante misantropo.
Il mio autoimposto esilio dal mondo degli uomini era semplicemente una
logica estensione di questa realtà. E Brenin - il grosso lupo cattivo - diventò
l'espressione simbolica di quell'esilio. Brenin non era solo il mio migliore e
unico amico. Stavo cominciando a capire me stesso nei termini di ciò che
lui rappresentava: il rifiuto di un mondo umano di calore e amicizia e
l'abbraccio di un mondo di ghiaccio e astrazione. Ero diventato un uomo
dell'Artico. La mia piccola casa in campagna - la mia casa gelida e piena di
spifferi - con un impianto di riscaldamento che raramente funzionava, e che
non scaldava neppure quando funzionava, era il guscio fisico ideale per il
mio nuovo distacco emotivo.
I miei genitori, che Dio li benedica, erano terribilmente preoccupati per
me. Il ritornello costante durante le mie sempre più rare visite a casa era:
come puoi essere felice vivendo in questo modo?
Secondo molti filosofi la felicità ha un valore intrinseco. Quello che
intendono dire è che la felicità ha valore di per sé, non per qualche altro
fine. Quasi tutto ciò che apprezziamo lo consideriamo prezioso in virtù di
quello che può fare per noi o che può farci ottenere. Apprezziamo il denaro,
per esempio, solo per le cose che possiamo acquistare con esso: cibo, casa,
sicurezza, forse - pensano alcuni di noi - addirittura la felicità. Apprezziamo
la medicina non di per sé, ma per il ruolo che può giocare nel favorire il
recupero della salute. Denaro e medicina hanno un valore strumentale, ma
non un valore intrinseco. Alcuni filosofi ritengono che solo la felicità abbia
un valore intrinseco: la felicità è l'unica cosa che apprezziamo di per sé e
non in virtù di ciò che potrebbe farci ottenere.
Da quei giorni alla fine degli anni Novanta, quando i miei genitori si
preoccupavano per me, la felicità ha acquisito un profilo molto più alto, non
tanto nella filosofia, quanto nella cultura più in generale. È diventata
addirittura un grosso affare. Milioni di ettari di foresta sono stati sacrificati
sul suo altare per fornire tutti quei libri che ci spiegano come fare
funzionare il trucco della felicità. Alcuni governi sono entrati nel giro,
sponsorizzando studi che ci dicono che, pur essendo materialmente molto
più ricchi dei nostri antenati, non siamo più felici di loro: per qualsiasi
governo è molto utile dimostrare che il denaro non può comprare la felicità.
Alla fine, e inevitabilmente, sono saltati a bordo anche gli accademici, i
quali sanno riconoscere una miniera d'oro non appena ne fiutano l'odore:
fermano le persone per strada - o meglio, costringono i loro laureandi a
fermarle - per rivolgere domande impertinenti come: «Quando vi sentite più
felici?». Riservatezza e discrezione, naturalmente, non sono tenute in
grande considerazione nel pantheon delle virtù occidentali d'inizio XXI
secolo e molti rispondono davvero a questa domanda. A quanto pare - e
questo è un dato su cui concordano tutti gli studi - gli intervistati sono più
felici quando fanno sesso e più infelici quando parlano con il loro capo. E se
fanno sesso con il capo mentre gli, o le, parlano, non è chiaro che cosa
possano essere: opportunisti dolceamari, forse.
Che cosa dobbiamo pensare che sia la felicità, se alla domanda «Quando
ti senti più felice?» rispondiamo «Quando faccio sesso»? Dobbiamo pensare
alla felicità come a una sensazione; nello specifico, una sensazione di
piacere, perché è questo che produce l'attività sessuale, se la state svolgendo
anche solo minimamente bene. In modo analogo, è presumibile che
l'infelicità derivante dal colloquio con il vostro capo abbia qualcosa a che
fare con le sensazioni di disagio e preoccupazione, o forse di nausea e
disprezzo che tale colloquio comporta. Felicità e infelicità si riducono
quindi a sensazioni di un certo tipo. Supponiamo di combinare questa idea
con l'affermazione dei filosofi in base alla quale la felicità ha un valore
intrinseco: probabilmente la felicità è l'unica cosa della vita che vogliamo di
per sé e non in vista di qualcos'altro. Arriviamo così a una semplice
conclusione: nella vita la cosa più importante è sentirsi in un certo modo. La
qualità della vostra vita, che stia andando bene o male, dipende dalle
sensazioni che provate.
Un modo utile di caratterizzare gli esseri umani è un particolare tipo di
dipendente o «drogato». Con la possibile eccezione di alcune delle grandi
scimmie, ciò non vale per nessun altro animale. Gli uomini, in generale, non
sono drogati di farmaci, anche se ovviamente alcuni lo sono. Sono però
drogati di felicità. I drogati di felicità condividono con i loro banali cugini
drogati di farmaci una brama insistente per qualcosa che in realtà non fa
loro molto bene e che comunque non è poi così importante. Ma, in un certo
senso molto evidente, i drogati di felicità sono peggiori. Un drogato di
farmaci ha una concezione sbagliata di dove trovare la felicità. Il drogato di
felicità ha una concezione sbagliata di che cos'è la felicità. Entrambi sono
accomunati dall'incapacità di capire che cosa importa di più nella vita.
I drogati di felicità sono di tutte le forme e dimensioni e provengono da
ogni classe sociale. Non presentano segni sulle braccia, sulle gambe o sui
piedi che consentano di identificarli. Non hanno bisogno di bucarsi o di
sniffare. Alcuni appartengono alla fascia dei diciotto- trentenni drogati di
felicità. Il venerdì e il sabato sera escono di casa, vanno in centro, si
sbronzano e/ o si strafanno, fanno sesso o, se questo non funziona (e magari
anche se funziona), fanno a pugni. Poi, una o due volte all'anno, se ne vanno
a Ibiza, Corfù, Creta, Cancun o dovunque sia di moda andare quell'anno, e
fanno esattamente le stesse cose, solo con un po’ più di impegno. Questa,
per loro, è la felicità. La felicità è il piacere, e il piacere è l'unica cosa che
conta.
Non è necessario avere tra i diciotto e i trent'anni per appartenere alla
fascia dei diciotto- trentenni drogati di felicità: chiunque abbia familiarità
con i dati demografici dei centri urbani il sabato sera o con i voli charter per
Corfù può confermarvelo. Alcuni esseri umani restano nella fascia dei
diciotto- trentenni drogati di felicità per tutta la vita. Altri, invece, a mano a
mano che diventano più vecchi, più lenti e più deboli, diventano anche,
secondo loro, più sofisticati. Per prima cosa, estendono il loro concetto di
felicità oltre le sensazioni di felicità, puramente edonistiche e decadenti, che
caratterizzavano i diciotto- trentenni. Per i maturi sofisticati la felicità non
consiste solo, o prevalentemente, nelle sensazioni procurate dal sesso, dalle
droghe e dall'alcol. Ormai sanno riconoscere sensazioni più importanti.
L'inequivocabile, anche se spesso debilitante, piacere associato al bere un
fiume di birra viene sostituito dal più sottile brivido di piacere prodotto da
un paio di bicchieri di un buon vino. L'eccitante piacere del fare sesso con
persone che si conoscono a malapena viene sostituito da quello più raffinato
di una relazione «seria» che, in termini di attività sessuale, praticamente
rasenta il rapporto fraterno. Il desiderio di «bruciare, bruciare, bruciare
come favolosi fuochi artificiali color giallo che esplodono come ragni
traverso le stelle», per dirla con Kerouac, è sostituito dal sofisticato calore
che dà l'osservare i propri figli piccoli sbavare o balbettare qualcosa, che
potrebbe essere o non essere la loro prima parola.
Questa crescente sofisticatezza è caratterizzata da un ampliamento dei tipi
di sensazioni che gli esseri umani sono disposti ad ascrivere alla categoria
della felicità. Ma l'ampliamento in questione avviene comunque sulla base
del modello originale. Qualsiasi altra cosa la felicità sia, è comunque una
sensazione di qualche tipo. È questo che definisce gli uomini: la perenne e
vana ricerca di sensazioni. Un tratto che non si riscontra in nessun altro
animale. Solo gli uomini pensano che le sensazioni siano così importanti.
Una conseguenza di questa ossessiva concentrazione sulle sensazioni è
che gli esseri umani tendono alla nevrosi, che si manifesta quando
l'attenzione si sposta dalla produzione di sensazioni all'analisi delle stesse.
Sei davvero felice del modo in cui sta andando la tua vita? Il tuo partner
capisce adeguatamente le tue necessità? Ti senti davvero realizzato
crescendo i tuoi figli? Naturalmente non c'è nulla di sbagliato nell'esaminare
la propria vita. La vita è tutto ciò che abbiamo e vivere una buona vita è la
cosa più importante di tutte. Ma ciò che caratterizza gli esseri umani è una
perversa interpretazione della forma che questo esame deve assumere: noi
crediamo che esaminare la nostra vita coincida con l'esaminare le nostre
sensazioni. E quando esaminiamo le nostre sensazioni, quando guardiamo
dentro di noi e vediamo che cosa c'è e che cosa non c'è, la risposta cui
arriviamo è spesso negativa. Non proviamo le sensazioni che vorremmo
provare o che pensiamo di dover provare. E allora che cosa facciamo? Da
bravi drogati di felicità quali siamo andiamo in cerca della prossima dose:
un bel ragazzo o una bella ragazza con cui divertirci, un'auto nuova, una
nuova casa, una nuova vita, un nuovo qualsiasi cosa. Per il drogato la
felicità viene sempre con il nuovo ed esotico, piuttosto che con il vecchio e
familiare. E quando tutto il resto fallisce - e spesso succede - allora c'è un
esercito di professionisti assai ben pagati che saranno felicissimi di
spiegarci come procurarci la prossima dose.
In breve, forse la caratterizzazione più chiara e semplice della specie
umana è la seguente: gli uomini sono quegli animali che venerano le
sensazioni.
Non fraintendetemi. Non ho niente contro le sensazioni o il sesso. E
neppure Brenin, a quanto pareva. Una sera di maggio, durante le due
settimane più calde che abbia mai trascorso in Irlanda, Brenin scomparve.
Fu l'unica volta che fece una cosa del genere. L'avevo fatto uscire in
giardino con Nina, mi ero voltato per un istante e lui non c'era più. Vidi la
sua coda sparire al di là del muro, un muro di pietra alto quasi due metri.
Non mi sorprese il fatto che fosse riuscito a scalarlo. Mi sorprese che avesse
voluto farlo. Non aveva mai dato segni di volere scappare prima di allora.
Quando uscii in strada, Brenin si era già dileguato. Feci salire Nina sulla
jeep e cominciammo a cercarlo. Lo sorprendemmo a diversi chilometri di
distanza in fondo alla strada, in flagrante delicto con una femmina bianca di
pastore tedesco. I padroni si infuriarono, anche se, a mio modesto parere,
non ci si può aspettare niente di buono se si lascia incustodita in giardino
una cagna in calore.
Per loro, comunque, tutto si risolse benissimo: in seguito guadagnarono
una fortuna vendendo i cuccioli. A quel punto Brenin era ormai famoso
nella zona di Kinsale e non mancava gente disposta a pagare qualsiasi cifra
per uno dei suoi cuccioli. Per quanto mi riguardava, mi trovai gravato di un
altro cane, perché non potei evitare di prendere almeno uno dei rampolli del
mio lupo. Non avevo fatto castrare Brenin perché non ne avevo avuto il
coraggio, un atteggiamento scontatamente virile da parte mia. Gli occhi
degli uomini si riempiono di lacrime al solo pensiero di castrare i propri
cani. Ma siamo pronti a fare sterilizzare le cagne in un batter d'occhio,
anche se si tratta di un intervento molto più serio e invasivo. È per questo,
naturalmente, che non dovevo preoccuparmi per Brenin e Nina: avevo fatto
sterilizzare la povera Nina non appena i veterinari mi avevano detto che si
poteva procedere in tutta sicurezza. Avevo bisogno di un altro cane come di
un buco in testa. Per come stavano le cose, Brenin e Nina riuscivano a
malapena a stare tutti e due nel retro della jeep, nonostante avessi eliminato
i sedili. Un terzo cane avrebbe dovuto sedersi davanti, accanto a me (ed è
esattamente quello che successe). E così, circa tre mesi e mezzo dopo, il
nostro branco acquisì un altro membro: una figlia di Brenin. La chiamai
Tess.
Ero gravato anche da un dilemma morale, più grave dei prevedibili
inconvenienti provocati da un terzo cane. Non avevo mai fatto accoppiare
Brenin, malgrado diverse proposte di altri proprietari di lupi o di incroci di
lupo, perché sapevo come sarebbero stati i suoi figli: come lui. Ricordavo
molto bene com'era stato da cucciolo e sapevo che quasi nessuno sarebbe
stato in condizione di passare con gli eventuali figli di Brenin tutto il tempo
che io avevo trascorso con lui. Di conseguenza ritenevo che le cose
sarebbero andate molto male per i suoi piccoli. È un pensiero che mi
perseguita ancora oggi. Spero che i figli di Brenin - ormai saranno vecchi
cani - stiano tutti bene. Prego che abbiano avuto una buona vita. Ma temo
che non per tutti loro sia stato così. E questo mi rattrista molto.
Forse perché scarsamente preoccupato delle conseguenze, Brenin
sembrava avere apprezzato la sua escursione sessuale. E nei giorni seguenti
fece numerosi tentativi per riuscire a ripetere l'esperienza. Ma non gli
permisi più di scappare e la notte lo sentivo piangere fino a quando si
addormentava. Perciò, chissà, se Brenin avesse potuto partecipare a uno di
quei sondaggi sulla felicità, alla domanda «Quando ti senti più felice?»
forse avrebbe risposto: «Quando faccio sesso». In tal caso sarebbe stato un
vero peccato, perché Brenin sarebbe stato davvero felice solo una volta in
tutta la vita. Naturalmente, se fosse cresciuto nel suo ambiente naturale, con
ogni probabilità sarebbe stato ancor meno felice: a meno che non fosse stato
il maschio alfa del branco, non gli sarebbe mai stato concesso di
accoppiarsi, neppure una volta.
Comunque, sospetto che ciò che a un lupo importa davvero non sia il
sesso né siano sensazioni di qualsiasi tipo. Diversamente dagli uomini, i
lupi non vanno a caccia di sensazioni. Vanno a caccia di conigli.
La gente mi chiedeva spesso se Brenin era felice. Quello che in realtà
intendevano chiedere era: come hai potuto - tu, brutto bastardo crudele e
irresponsabile - strappare un lupo al suo ambiente naturale e costringerlo a
una vita artificiale, prigioniero della cultura e dei costumi umani? Ho già
parlato di questo aspetto. Ma supponiamo che l'obiezione sia giustificata. Se
lo è, allora dovremmo pensare che Brenin fosse al massimo della felicità
quando faceva ciò che per lui era naturale. Il sesso potrebbe rientrare in
questo discorso. Ma anche la caccia.
Passavo molto tempo osservando Brenin cacciare, cercando di scoprire
che cosa, eventualmente, provasse in quei momenti. Che cosa sentiva
mentre faceva la posta a un coniglio?
I conigli sono veloci e sfuggenti e possono cambiare direzione in un
lampo. A tutta potenza e in linea retta, Brenin era più veloce di loro, ma non
aveva le mosse del coniglio medio. Per cui doveva appostarsi. E l'essenza
dell'appostamento consiste nell'effettuare una sorta di riallineamento della
situazione in cui ci si trova. Appostamento significa far sì che il mondo
favorisca i propri punti di forza e resti indifferente a quelli della preda. È un
processo arduo e, sospetto, molto più spiacevole che piacevole.
La pazienza di Brenin era stupefacente. Per buona parte del tempo se ne
stava disteso a terra, con il naso e le zampe anteriori puntati verso il
coniglio, e i muscoli tesi e pronti a scattare. Non appena il coniglio veniva
distratto da qualcosa, gli si avvicinava di qualche centimetro per poi
riacquattarsi, di nuovo immobile fino alla successiva occasione di
movimento. Non era chiaro quanto questo processo, se indisturbato, sarebbe
potuto continuare, ma ho visto Brenin protrarlo per almeno quindici minuti.
Brenin cercava di creare una situazione in cui i suoi punti di forza - la
sorpresa e una velocità incredibile sulla breve distanza - prevalessero sulla
capacità del coniglio di cambiare direzione di colpo e in uno spazio ristretto.
Di solito, e per fortuna, il coniglio scappava spaventato molto prima del
momento dell'attacco. Quando capiva che il gioco era finito, Brenin si
sfogava in un'incredibile esplosione di attività repressa e posticipata. Quasi
sempre si ritrovava a mani vuote.
Se quelli erano i momenti in cui Brenin era felice, allora che cos'era per
lui la felicità? C'erano l'agonia della tensione, la forzata rigidità del corpo e
della mente, l'inevitabile conflitto tra il forte desiderio di attaccare e la
consapevolezza che ciò si sarebbe potuto risolvere in un disastro. Brenin era
costretto a negarsi in continuazione quello che desiderava di più. La
tormentosa tensione veniva alleviata, ma solo in parte, dalle brevi avanzate
furtive e poi, quando Brenin si immobilizzava di nuovo, il processo
ricominciava da capo. Se questa è felicità, allora è più simile all'agonia che
all'estasi.
Qualcuno potrebbe osservare che forse Brenin era felice solo quando
catturava il coniglio. Spero di no, perché ci riusciva raramente. Ma il suo
comportamento indicava con chiarezza qualcos'altro. Che avesse avuto
successo o no, subito dopo la caccia, invariabilmente, lui correva da me con
gli occhi scintillanti e mi saltava addosso eccitato. Quello, ne sono sicuro,
era un lupo felice e, se questo è vero, la sua felicità aveva poco a che fare
con il piacere di azzannare la carne del coniglio.
La caccia di Brenin mi ricordava più di qualsiasi altra cosa ciò che facevo
nell'altra parte della mia vita: il filosofo. Io facevo la posta non ai conigli,
ma ai pensieri. Brenin tendeva agguati a conigli che per lui erano spesso
troppo difficili da catturare. Io tendevo agguati a pensieri che per me erano
troppo difficili da pensare. È possibile, se ci si sforza abbastanza,
costringersi a pensare cose che in precedenza non si era in grado di pensare,
proprio perché troppo difficili. Ma è un processo molto sgradevole. E
doloroso. Prima c'è il lungo, inquieto disagio che si prova dibattendosi in un
settore che, semplicemente, è troppo impegnativo: le acque salmastre e
melmose di una palude dove non è possibile trovare punti di riferimento, né
un punto d'approdo sulla terraferma. Poi, magari dopo molte settimane o
mesi, il pensiero comincia ad arrivare, comincia a essere pensato. È a quel
punto che inizia l'appostamento. Il pensiero è come un groppo in gola, che
si sente salire lentamente, adagio e, con lui, sale anche la dolce promessa
del sollievo. Poi, però, ci si rende conto che si tratta di un vicolo cieco e il
groppo, il blocco, scende di nuovo nello stomaco e si cementa dentro, duro,
ostinato e sgradevole, come un cattivo pasto. Magari, dopo un po', si
intravede una strada nuova e la speranza rinasce, ma il pensiero non è
ancora pronto e si inabissa di nuovo. Non si può costringere un pensiero a
farsi pensare più di quanto si possa costringere un coniglio a farsi catturare.
Il pensiero arriverà - e il coniglio verrà catturato - solo al momento giusto.
Tuttavia non si può neppure ignorare il pensiero e limitarsi semplicemente
ad aspettarlo: bisogna mantenere alta la pressione su di esso, altrimenti non
arriverà mai. E alla fine, se si è fortunati e diligenti, il pensiero arriva e a
quel punto uno è in grado di pensare qualcosa che prima per lui era troppo
difficile da pensare. Il sollievo è innegabile, ma non è questo il punto.
Presto si passerà al pensiero successivo e tutto il penoso processo
ricomincerà.
La felicità non è solo piacevole: è anche profondamente spiacevole. Lo è
per me e credo che lo sia stato anche per Brenin. E non voglio con ciò
riferirmi a quello che la saggezza popolare dice, e cioè che non si possono
apprezzare i momenti belli se non si sono sperimentati anche quelli brutti.
Questa è una cosa che tutti sanno. La saggezza popolare sostiene una
dipendenza causale tra l'apprezzamento del buono e l'esperienza del cattivo.
Se non avete vissuto cose sgradevoli, non saprete riconoscere quelle
gradevoli quando vi capiteranno. Non è questo che intendo, quando dico
che la felicità è spiacevole. Ciò che sostengo è che la felicità è di per sé in
parte spiacevole. È una verità inevitabile, la felicità non potrebbe essere tale
in nessun altro modo. Nella felicità, gli aspetti piacevoli e quelli spiacevoli
formano un tutto indissolubile. Non posso essere separati senza che tutto
crolli.
A Brenin piaceva azzuffarsi. Credo che fosse felice quando combatteva.
Ed è un peccato, perché non glielo permettevo mai. Feci del mio meglio per
eliminare questo aspetto della sua personalità, ma non ci riuscii mai
davvero. Fu solo quando Brenin diventò vecchio e debole che mi sentii di
lasciargli avvicinare grossi cani maschi. Ma anche se si trattava di un
aspetto del suo carattere che non potevo in alcun modo lodare, potevo però
comprenderlo.
Da ragazzo ero un pugile dilettante piuttosto in gamba e di quando in
quando sfruttavo questa abilità per integrare le mie entrate di studente.
Venivano organizzati incontri clandestini in luoghi segreti, mai gli stessi, in
posti come Ancoats e Moss Side, anche se cercavo di stare alla larga da
quest'ultimo: troppi ragazzi neri, troppo bravi e veloci. Si versavano
cinquanta sterline per l'iscrizione e poi si combatteva diverse volte nel corso
della serata (perlomeno se si era fortunati).
Se uno vinceva il primo incontro, si riprendeva le sue cinquanta sterline.
Se vinceva il secondo, raddoppiava la cifra. Un terzo combattimento vinto
permetteva di arrivare a duecento sterline, una somma che a quei tempi mi
consentiva di tirare avanti per parecchi mesi. Ma non appena uno perdeva,
era fuori. Il mio obiettivo era tentare di vincere tre incontri. Poi, al quarto,
me la filavo: incassavo la sconfitta e cercavo di andarmene a casa senza
troppi danni, prima di dover incontrare in seguito i pugili più bravi.
Il pubblico, ovviamente, non gradiva e manifestava il proprio malcontento
nel modo più tradizionale con boati, minacce e insinuazioni sui miei
antenati e sulla mia sessualità. Tuttavia ciò che ricordo meglio non è questo,
ma sono i miei passi per arrivare fino al ring. Il pubblico gridava perché
voleva sangue e io ero così spaventato che il mio campo visivo si
restringeva a uno stretto tunnel. Le gambe erano molli e difficili da
controllare. Il respiro era affannoso e penoso. Non vomitavo solo perché
avevo appena finito di vomitare. Queste sensazioni e reazioni perduravano
durante tutti i preliminari. Ma poi, quando mi alzavo in piedi nel mio angolo
del ring e guardavo l'avversario, poco prima dell'inizio dell'incontro e
quando ormai ogni possibilità di fuga era svanita, mi sentivo attraversare da
una meravigliosa sensazione di calma che partiva dalle dita dei piedi e delle
mani e mi investiva a ondate.
Era una calma strana, perché la paura non se n'era andata, ma
semplicemente non aveva più importanza. Quando combattevo, ero isolato
all'interno di una dorata bolla di concentrazione. La paura c'era sempre, ma
era una paura tranquilla e positiva, alla quale si accompagnava una certa
esultanza difficile da spiegare. L'esultanza nasceva dal fare qualcosa che
sapevo fare bene, con la consapevolezza, però, che non potevo permettermi
di oltrepassare nemmeno per un attimo i limiti delle mie capacità. Era una
sorta di perspicacia: ecco come forse potrei descrivere quell'esultanza nel
modo migliore.
Il combattimento non aveva mai niente di personale.
All'interno della propria bolla dorata non si prova alcuna animosità. È uno
sforzo impersonale, intellettuale. Il termine «intellettuale» può sembrare
strano in questo contesto, ma lo uso perché la boxe comporta un certo grado
di sapienza. È una sapienza propria ed esclusiva del pugilato, che non si può
acquisire in nessun altro modo. Un pugile sa esattamente per quanto tempo
il suo avversario terrà la mano fuori dopo avere sferrato un colpo, e lo sa
anche se non gli vede la mano. Sa come muove i piedi quando parte con un
diretto destro, e lo sa anche se non gli guarda i piedi. Dentro la sua bolla di
concentrazione, e ai limiti delle sue capacità fisiche ed emotive, il pugile sa
cose che altrimenti non saprebbe. Dopo il colpo, il suo avversario ha tenuto
la mano fuori per un secondo di troppo, così lui sposta la testa di lato e
risponde con un diretto sinistro all'interno del suo braccio (quelli di voi che
capiscono che cosa sto dicendo saranno in grado di dedurre da questa
descrizione che ero un mancino, almeno presumendo un avversario
regolare). Se il suo diretto va a segno e colpisce la mascella dell'avversario,
un bel colpo netto e pulito, allora il pugile prova esultanza. E non perché
odia l'avversario: al contrario, nella sua bolla di concentrazione non sente
niente, né per lui né contro di lui. Prova esultanza perché è freddamente,
serenamente terrorizzato. Combattere sul ring è conoscere non solo il
proprio avversario, ma anche la propria condizione esistenziale: è sapere
che si è in precario equilibrio sull'orlo di un precipizio e che una mossa falsa
in un senso o nell'altro provocherà il disastro.
Quando la vita è nel suo momento più viscerale, e quindi anche più vivo,
non è possibile separare l'esultanza dal terrore. La consapevolezza che il
disastro incombe su ogni mossa non solo rende possibili le forme più
potenti di esultanza, ma si fonde con quell'esultanza, ne diventa parte.
Terrore ed esultanza sono due facce della stessa medaglia: due aspetti della
stessa Gestalt. L'esultanza non è mai solo piacevole: è per forza anche
profondamente spiacevole.
Una teodicea è il tentativo di trovare una ragione per la spiacevolezza
della vita. Come suggerisce l'etimologia, la teodicea tradizionalmente si
richiama a Dio: Egli opera in modi misteriosi, ci mette alla prova, ci ha dato
il libero arbitrio e così via. Ma esistono anche quelle che potremmo definire
«teodicee senza Dio»: la più famosa, forse, è quella di Nietzsche, che
vedeva il dolore e la sofferenza come mezzi necessari per diventare più
forti. Tutte le teodicee sono, in ultima analisi, atti di fede. E lo sono perché
tutte comportano, esplicitamente o implicitamente, l'idea che la vita ha un
obiettivo o uno scopo. La vita ha un significato e l'obiettivo di una teodicea
è identificare dove, in questo contesto, debbano collocarsi la paura, il dolore
e le sofferenze. Uno dei compiti più difficili non è imparare che la vita non
ha alcun significato, è capire perché l'idea che ce l'abbia - o debba avercelo ci distoglie da ciò che è davvero importante.
Non sto cercando di giustificare dolore e sofferenza. Non sto cercando di
proporre una teodicea. La vita non ha alcun significato, almeno non nel
modo che la gente di solito pensa, e quindi dolore e sofferenza non
contribuiscono a quel significato. Ciononostante dovevo imparare ben
presto che la vita può avere valore, e può averlo a causa di certe cose che in
essa accadono. Starmene seduto nell'erba alta a guardare Brenin che faceva
la posta ai conigli mi ha insegnato che nella vita è importante assicurarsi di
dare la caccia ai conigli, non alle sensazioni. La parte migliore della nostra
vita - i momenti in cui siamo, come suol dirsi, al culmine della felicità - è
piacevole e, al tempo stesso, profondamente spiacevole. La felicità non è
una sensazione: è un modo di essere. Se ci concentriamo sulle sensazioni,
perdiamo di vista il punto essenziale. Ma stavo per imparare un'ulteriore
lezione. A volte i momenti più brutti della nostra vita sono quelli che hanno
il maggior valore. E possono avere il maggior valore solo perché sono i più
brutti. Erano molti i momenti brutti che stavano per arrivare.
Sette. Una stagione all'inferno
Dopo circa cinque anni in Irlanda la nostra vita si era stabilizzata in una
routine prevedibile e, dal punto di vista della mia carriera, redditizia. La
mattina mi alzavo quando ne avevo voglia e andavo a correre con Brenin e
le due cagne, attraverso i campi e giù fino al mare. Dopodiché raggiungevo
Cork in auto, sbrigavo gli eventuali impegni di lavoro e andavo in palestra.
In genere rientravo a casa verso le sei di sera e cominciavo a scrivere,
continuando fin verso le due del mattino.
Dopo l'arrivo di Nina avevo deciso di lasciare Brenin a casa quando
andavo al lavoro. A quel punto la sua giovanile distruttività era
notevolmente diminuita. Devo ammettere che Nina faceva del suo meglio
per colmare la lacuna, ma, anche al suo peggio, la sua ingegnosità e il suo
potere distruttivi non erano assolutamente paragonabili a quelli di Brenin, il
quale non era affatto contento di essere lasciato a casa. E a me mancava la
sua presenza in ufficio e in aula. A volte, nel pieno di una lezione, spostavo
lo sguardo nell'angolo della sala, aspettandomi di vederlo, e avvertivo
sempre una scossa di sorpresa prima di ricordarmi che era a casa. Ma
pensavo che sarebbe stato molto ingiusto lasciare Nina da sola, giovane
com'era, specie considerando che avrebbe visto Brenin e me partire insieme
in auto. Quando arrivò Tess, tuttavia, toccò a lei restare a tenere compagnia
a Nina e rientrò in vigore la vecchia abitudine di portare Brenin con me
dappertutto.
Tess, essendo un lupo solo per metà, probabilmente era distruttiva la metà
di quanto era stato il giovane Brenin. Ma era più che sufficiente. Si mangiò
praticamente tutto quello che c'era in casa. Le preziose sedie antiche che
mia nonna mi aveva lasciato in eredità resistettero solo poche settimane alla
sua dentizione. La parete che separava la cucina dal ripostiglio era un muro
a secco, ma Tess riuscì ad aprirsi un varco a morsi in un solo pomeriggio,
forse nel tentativo, entusiasta ma vano, di raggiungere la libertà del giardino
sul retro. Aveva ereditato la passione del giovane Brenin per le tende.
Imparò rapidamente come aprire le credenze della cucina al fine di
divorarne il contenuto: che fosse commestibile o meno, per lei faceva poca
differenza. Quando installai sugli sportelli dei fermi a prova di bambino, si
mangiò anche quelli. Alla fine smise di perdere tempo e cominciò a
prendere a morsi direttamente le credenze. Persi i documenti di proprietà
della casa durante una di queste demolizioni pomeridiane: Tess se li era
mangiati. Almeno credo che sia stata Tess. Dato che a casa restavano in
due, non potevo mai attribuire le colpe con sicurezza. In ogni caso, ero
fregato. Non potevo certo portare tutti e tre a lezione con me.
Quando tornavo a casa la sera, dopo avere tristemente esaminato le
macerie dei festeggiamenti pomeridiani, cominciavo a scrivere. Tenevo
sempre a portata di mano una bottiglia di Jack, di Jim o di Paddy mentre
lavoravo e, dato che in genere scrivevo per circa otto ore, non capitava
spesso che mi ricordassi di andare a letto. Il risultato fu che dopo cinque
anni d'Irlanda, nonostante mi fossi ubriacato quasi tutte le sere, avevo scritto
sei o sette libri su argomenti che andavano dalla natura della mente e della
coscienza al valore della natura e ai diritti degli animali. E, a quanto pareva,
i libri non erano poi da buttare. Con mia sorpresa, vennero recensiti su tutte
le riviste giuste. E con mio totale stupore, quasi tutte le recensioni furono
molto positive. Istituzioni che non mi avrebbero toccato neppure con una
pertica all'epoca in cui me n'ero andato dall'Alabama, adesso cominciavano
a offrirmi incarichi.
All'inizio resistetti all'idea di trasferirmi, perché non volevo privare
Brenin e le due cagne della campagna che a loro piaceva tanto. Ma poi dato che passare da un estremo all'altro sembra essere un tema costante
della mia vita -pensai che avremmo potuto provare Londra per un anno e
vedere come andava. Presi un'aspettativa da Cork e accettai un'offerta del
Birkbeck College dell'università di Londra.
Ero un po’ in ansia sugli aspetti pratici del trasferimento. Dopo avere letto
le ultime due o tre pagine, mi affittereste la vostra casa? L'affittereste a uno
scrittore alcolista con tre cani selvatici e terribilmente distruttivi al seguito?
Dovreste essere pazzi. Perciò la prima regola per affittare casa a Londra,
quando si ha in programma di trasferirsi con un lupo e mezzo e un cane e
mezzo al seguito, è ovvia: fingere. «Sì, ho un cagnolino. Nessun problema,
vero?» Non è tanto una menzogna quanto il contrario di un'iperbole... è
un"«ipobole», se volete. È una minimizzazione a effetto, dove l'effetto è che
alla fine troverete qualcuno che vi affitterà una casa. E va bene, è una
menzogna. Comunque poi si prosegue con qualche domanda in tono casuale
sul domicilio del padrone: «Il padrone di casa abita da queste parti? In
Kenia? Perfetto, la prendo!».
Così, poco prima di Natale, caricai Brenin e le «ragazze» sulla jeep Brenin e Tess dietro e Nina davanti, dove le piaceva stare -, prendemmo il
traghetto per la Gran Bretagna, passammo il Natale con i miei genitori e poi
ripartimmo per Londra. Dopo il disgraziato episodio di Brenin con l'Irish
Ferries, ero passato alla Stena, soprattutto perché questa compagnia dispone
di grandi gabbie di legno dentro le quali sistemare i cani durante la
traversata. A Brenin, però, non piaceva per niente starsene rinchiuso durante
il viaggio e in genere manifestava il suo disappunto demolendo la gabbia.
Ogni volta che scendevo alla fine della traversata, lui stava invariabilmente
correndo indisturbato sul ponte auto, accompagnato dal coro di guaiti e
ululati delle «ragazze», che invece non erano riuscite a liberarsi. Una volta,
dopo alcuni viaggi con la Stena, al termine della traversata scesi e trovai un
riconoscente falegname che stava lavorando su alcune delle gabbie
danneggiate. Era chiaramente felice di conoscere l'uomo che gli stava
procurando tutti quegli straordinari. E, a mio avviso, riassunse con molta
precisione la situazione generale: «Non so perché non gli permettano di
salire di sopra con lei: è molto più pulito di metà dei passeggeri!». In ogni
caso, come potete immaginare, mi auguravo di non dover fare altre
traversate nell'immediato futuro. In caso contrario, sono abbastanza sicuro
che la Stena ci avrebbe comunque proibito l'accesso a bordo.
Ero andato a Londra qualche settimana prima, lasciando per un giorno
Brenin e le «ragazze» con i miei genitori, ed ero riuscito a trovare un
piccolo cottage con due camere da letto a due passi dal Wimbledon
Common. Avevo deciso che i 450 ettari di parco, o i 1600 ettari di parco, se
si contava anche l'adiacente Richmond Park - brulicanti di animaletti pelosi
il cui unico scopo nella vita era quello di essere cacciati - avrebbero
completamente soddisfatto Brenin e le due cagne. E così fu.
Dato che avevo bisogno di sfinirli prima di osare avventurarmi al lavoro,
ogni mattina presto andavamo a correre, attraverso il terreno boscoso del
parco e il London Scottish Golf Club, probabilmente l'unico campo da golf
del mondo in cui i cani hanno diritto di transito. Era un percorso di otto
chilometri circa, ma Brenin e le ragazze ne facevano tre volte tanti perché
non appena vedevano uno scoiattolo, scattavano di corsa all'inseguimento
nel bosco. Anzi, il contatto visivo non era neppure necessario: un fruscio nel
sottobosco era sufficiente a scatenarli. Per fortuna gli scoiattoli sono veloci
e Brenin cominciava a perdere un po’ del suo impeto. Quanto a Nina e a
Tess, non hanno mai raggiunto il suo grado di abilità nella caccia. Per cui il
tasso di mortalità di scoiattoli e conigli derivante dalle nostre escursioni
quotidiane fu molto basso. Nell'anno trascorso a Londra riuscirono a
uccidere un solo scoiattolo, mi pare: un danno collaterale che mi sembra
accettabile alla luce dell'immenso divertimento che diede a quei tre. Dopo
ogni caccia, correvano di nuovo da me, ansimanti e con gli occhi
scintillanti, e io dicevo: «Ehi, è questo il modo di comportarsi dei cani
dell'uomo che ha scritto Animate Like Us?».
Quando tornavamo alla jeep, erano tutti e tre distrutti, ma specialmente
Brenin, che ormai stava scivolando dolcemente dalla mezza età alla
vecchiaia. Dormiva per quasi tutto il resto della giornata. Portarlo con me
alle lezioni non era un'opzione praticabile, perché non credo che alla sua età
si sarebbe adattato facilmente ai misteri e alle vicissitudini della
metropolitana londinese. Quando lasciavo i tre a casa, davo a ognuno di loro
un grosso osso cotto che avevo comprato al negozio per animali sulla
Broadway. Era una parziale e temporanea deroga alla dieta a base di pesce,
dettata dalla superiore necessità di salvare dall'annientamento la casa in
affitto. In un anno spesi una fortuna - quelle ossa costavano circa cinque
sterline l'una -, ma probabilmente meno che se avessi dovuto acquistare una
nuova cucina al padrone di casa. Incredibilmente, nell'anno passato a
Londra, le «ragazze» non provocarono alcun danno. Quando ce ne
andammo, feci lavare i tappeti e vi giuro che nessuno avrebbe mai potuto
immaginare che là dentro avessero abitato dei cani. Non so se questo
accadde perché Nina e Tess erano maturate proprio nel momento giusto.
Forse le ossa cotte le avevano intrattenute. O forse era stato Brenin a tenerle
in riga. Comunque fosse, non mi feci domande e attribuii la cosa alla
fortuna di tutta la mia vita.
E così, grazie a Dio, non c'erano più ritorni a casa con l'abituale
constatazione di disastri e demolizioni. Una volta, però, rientrai e mi trovai
davanti una scena estremamente comica, che in seguito chiamai «la notte
dei tre cani grassi». Il titolo è impreciso, ma suona meglio della «notte dei
due cani grassi e del lupo grasso». Fu colpa mia. Al Birkbeck i corsi si
tenevano solo di sera. E quella volta, dopo la lezione, avevo (insolitamente)
accettato di incontrare qualche amico all'Ulu - il bar dell'unione studenti
dell'università di Londra - per un paio di pinte tranquille. Finii per tornare a
casa con l'ultima corsa della metropolitana e rientrai a un'ora imprecisata
dopo mezzanotte.
I tre erano riusciti ad aprire la porta della dispensa, dove conservavo le
loro provviste, e si erano mangiati un sacco da venti chili di cibo secco per
cani. Quando entrai in casa, mezzo ubriaco, tentarono di esibirsi nella
tradizionale danza di scuse e riconciliazione che eseguivano sempre quando
sapevano di aver fatto qualcosa di cui non sarei stato affatto contento. Il rito
consisteva nel trottare verso di me con le orecchie appiattite, il capo chino e
il naso praticamente sul pavimento. E poi agitavano la coda in modo così
esagerato che in realtà era tutto il corpo a scuotersi. Nina e Tess avevano
eseguito questo balletto per buona parte della loro vita, quasi
quotidianamente. E lo stesso Brenin aveva una certa familiarità con tale
procedura. Quella notte, però, lo spettacolo fu molto diverso: tutti e tre
erano semplicemente troppo gonfi per esibirsi con un minimo di credibilità.
Provarono a trottare verso di me, ma riuscirono solo a fare pochi passi
barcollanti e poco convinti. Cercarono anche di offrirmi il solito,
conciliatorio scuotimento del corpo, cosa difficile da fare quando il corpo è
tanto largo quanto lungo: non resta niente da scuotere. Così rinunciarono
subito e collassarono sul pavimento. Se fossi stato anche solo semisobrio,
naturalmente mi sarei preoccupato che non si fossero provocati danni
permanenti. Ma viste le mie condizioni, scoppiai a ridere e me ne andai a
letto.
La mattina seguente domandai: «Andiamo a fare una passeggiata?»,
l'inizio del nostro rituale quotidiano al quale di norma i tre reagivano
correndo e saltando per tutta la casa, abbaiando e, a volte, spingendomi con
il naso perché mi sbrigassi. Per la prima volta non ci fu alcuna reazione. Le
teste rimasero saldamente incollate al pavimento. Sollevarono per un attimo
lo sguardo, ma credo solo per implorarmi di non costringerli a fare niente
nelle condizioni in cui si trovavano. Penso che ciò che stavano passando
quella mattina fosse qualcosa di molto simile a un doposbornia canino.
Io potevo capirli. Così lasciai che smaltissero la sbornia dormendo tutto il
giorno. Di certo loro non avrebbero fatto la stessa cosa per me, se i ruoli
fossero stati invertiti.
Jean- Michel era un uomo allegro e simpatico sui sessantacinque anni. Si
godeva la vita. Beveva troppo brandy e fumava troppi sigari. Ma forse il più
grande divertimento della sua vita era la pesca; fu per questo che lo
conobbi, dato che aveva l'abitudine di pescare sulla spiaggia dove abitavo
io. Arrivava al lavoro invariabilmente in ritardo, e non lieve: era sempre un
gravissimo ritardo. Ma questo non ha molta importanza nel Sud della
Francia, dove essere in ritardo è uno stile di vita. E comunque si trattava del
suo lavoro. Quel lavoro era un ambulatorio veterinario nella città di Béziers.
Il mio incontro con Jean- Michel Audiquet fu dovuto a un imprevisto e
piuttosto improbabile colpo di fortuna. Ma, nella corsa sulle montagne russe
che è stata la mia vita, a ogni colpo fortunato del genere di solito faceva
seguito qualcosa di piuttosto brutto. Quell'anno non avrebbe fatto eccezione.
Prima la parte buona. Londra non aveva funzionato del tutto,
principalmente a causa della mia natura pigra e antisociale. Tenevo le mie
lezioni, ma questo era tutto. Non avevo fatto alcuno sforzo per cercare di
conoscere i nuovi colleghi, e neppure per mostrare la mia faccia in giro per
l'università, tanto che ero stato rapidamente ribattezzato «il fantasma». Però
non avevo sprecato del tutto il mio tempo. Durante il periodo londinese,
avevo diviso la mia attività di scrittore in due parti. Cominciavo verso le
sette di sera e, per le prime quattro o cinque ore, scrivevo di filosofia seria.
Con «seria», naturalmente, intendo una filosofia altamente tecnica che con
ogni probabilità viene letta solo da poche centinaia di persone: nel mondo
accademico, se arrivi a qualche migliaio di lettori, sei una superstar. Erano
il genere di lavori che venivano pubblicati su riviste professionali di
filosofia o su libri di case editrici universitarie, come quelle di Oxford,
Cambridge e del Mit. Ma nella seconda metà della serata, dopo mezzanotte,
quando Jack o Jim o Paddy cominciavano a farsi sentire sul serio, scrivevo
cose completamente diverse. Il risultato fu The Philosopher at the End of
the Universe, un'introduzione alla filosofia attraverso i film di fantascienza
di grande successo. Chi di voi l'ha letto non avrà difficoltà a credere che sia
stato scritto in vari stadi di ebbrezza. Comunque, con sorpresa di tutti - e
soprattutto dell'editore - il libro vendette benissimo. Anzi, cominciò ad
arrivarmi parecchio denaro dalla vendita dei diritti all'estero ancora prima
che il libro venisse pubblicato. E così, non molto tempo dopo la conclusione
del mio incarico a Londra, mi ritrovai inaspettatamente a sedere sopra un
mucchio di soldi; non un mucchio enorme, ma sufficiente per mantenermi
per un bel po’ di tempo. Non avendo idea di cosa farne, ma non potendone
più della pioggia incessante - piovve ogni singolo giorno che trascorsi in
Irlanda, lo giuro -, affittai una casa nel Sud della Francia e pensai di fare un
tentativo come scrittore a tempo pieno. Fu così che ci trasferimmo tutti e
quattro in una casetta nel cuore della Linguadoca.
La casa si trovava ai margini di un piccolo paese confinante con la
meravigliosa riserva naturale costituita dal delta del fiume Orb. Della
riserva faceva parte anche una laguna di acqua salata: la maire, come la
chiamano da quelle parti, un termine occitano sinonimo dell'inglese mire,
«acquitrino». E la zona brulicava di tori neri, pony bianchi e fenicotteri
rosa, tutti tipici della regione. Ogni mattina attraversavamo la riserva,
raggiungevamo la spiaggia e andavamo a nuotare. Pensavo che Brenin e le
«ragazze» avrebbero apprezzato lo stile di vita francese, e non mi sbagliavo.
Ma, circa un mese dopo il nostro trasferimento, Brenin si ammalò. Avevo
già notato una generale letargia che, ripensandoci, era cominciata ancor
prima che lasciassimo Londra. All'inizio attribuii la cosa al fatto che stava
invecchiando. Ma quando cominciò a rifiutare il pasto della sera, al punto
che dovevo convincerlo a sforzarsi di mangiare, lo portai subito dal
veterinario, l'unico veterinario e una delle poche persone che conoscevo in
Francia: Jean- Michel Audiquet. Non ero particolarmente ansioso di andare
a quella visita. Jean- Michel non parlava una parola di inglese e a
quell'epoca il mio francese scolastico non era certo all'altezza di un consulto
medico, sia pure di medicina veterinaria. Ma non avrei mai immaginato che
ci fosse qualche problema davvero grave. Credevo che Jean- Michel mi
avrebbe detto che Brenin era semplicemente vecchio, che faceva molto
caldo e che quindi era naturale che mangiasse meno di prima.
Per fortuna Jean- Michel prendeva il suo lavoro molto seriamente. Brenin
e io arrivammo alle undici di un mercoledì mattina e alle undici e un quarto
erano già stati fatti gli esami del sangue. Alle undici e mezzo Brenin era
sotto i ferri. Durante la visita Jean- Michel aveva sentito un nodulo nell'area
addominale. Il nodulo risultò essere un tumore alla milza, un tumore, mi
disse il veterinario, che era stato sul punto di rompersi. Asportò la milza di
Brenin - a quanto pare, si può vivere benissimo anche senza - e io tornai a
casa in stato di shock. Ma incredibilmente la sera stessa Brenin era di nuovo
in piedi, anche se un po’ traballante, così potei andarlo a prendere per
riportarlo a casa. Jean- Michel mi disse che non aveva notato metastasi e,
con un po’ di fortuna, sarebbe risultato che si era trattato di un tumore
primario e non secondario. I risultati degli esami del sangue sarebbero
arrivati entro una settimana e allora avremmo potuto saperne di più. Avrei
dovuto portare Brenin a casa, tenerlo a riposo e riportarlo da lui due giorni
dopo.
Con Jean- Michel si riusciva sempre a capire quando la cura stava
andando bene, o perlomeno quando sembrava che stesse andando bene,
perché in quel caso lui si lasciava andare a un altro dei suoi passatempi
preferiti: la presa in giro. Non essendo il francese il mio forte, la maggior
parte delle cose che mi diceva andava completamente persa, per cui le sue
battute ai miei danni non potevano mai essere troppo sottili o intelligenti.
Mi guardava fisso con l'aria seria e mi diceva solennemente: «Ce n'est pas
bon». Non va bene. E scuoteva la testa. Ma poi mi guardava di nuovo,
scoppiava in una risata ed esclamava: «C'est trés bon!». Va benissimo! E
naturalmente, dato che il mio francese era pessimo e io ero così concentrato
nel cercare di elaborare quello che mi diceva, ci cascavo ogni volta.
Fu proprio al rientro, due giorni dopo l'intervento, che iniziarono le
complicazioni. Avevo guidato verso casa sentendomi un po’ più felice di
quanto fossi stato negli ultimi giorni. Jean- Michel era stato molto positivo e
io cominciavo a sperare che tutto potesse risolversi per il meglio. Ormai
Brenin aveva dieci anni e io sapevo che non sarebbe rimasto con noi ancora
per molto, ma non ero ancora pronto a perderlo. Come se avessi mai potuto
essere pronto. Ma cominciavo a sperare che forse sarebbe riuscito a schivare
quella pallottola.
Arrivati a casa, lo feci scendere dalla jeep e mi accorsi che aveva il
posteriore insanguinato. Mi precipitai di nuovo dal veterinario. Una delle
ghiandole anali di Brenin si era infettata, una circostanza della quale né
Jean- Michel né io ci eravamo accorti finché il sangue non aveva
cominciato a fuoriuscire. Così Brenin dovette subire l'ulteriore umiliazione
della rasatura del sedere. Dopodiché Jean- Michel incise la ghiandola in
modo da drenare l'infezione. Con la prescrizione di un cocktail di
antibiotici, mi riportai a casa Brenin. Fu allora che cominciò il vero orrore.
Era di vitale importanza, mi aveva informato Jean- Michel, che la zona
venisse tenuta pulita. Ciò significava che ogni due ore dovevo lavare il
sedere di Brenin con acqua calda e qualcosa che, secondo la mia traduzione,
Jean- Michel aveva chiamato «sapone intimo femminile». A quanto pare, è
una cosa francese, ma lo potete trovare in qualsiasi farmacia. Ecco dunque
un'altra voce del mio elenco di cose che non vedevo l'ora di fare:
presentarmi nella farmacia del paese e chiedere all'attraente signora dietro il
banco, magari aiutandomi con la mimica nel caso in cui il mio vocabolario
o la mia grammatica non fossero stati all'altezza, se aveva del sapone intimo
femminile. Dopo avere scrupolosamente lavato il didietro del povero
Brenin, dovevo siringare la ghiandola anale. Vale a dire che dovevo
prendere una siringa, riempirla con una soluzione antibatterica, infilare l'ago
nella ghiandola, adesso aperta e in suppurazione, e iniettare il liquido. E
dovevo farlo ogni due ore, giorno e notte. La chiave per la guarigione, mi
era stato detto, era assicurarsi che l'infezione non si estendesse e
raggiungesse la ferita chirurgica.
Jean- Michel mi aveva detto di riportargli Brenin il giorno successivo,
cosa che feci dopo una notte in bianco. Quando arrivai all'ambulatorio,
anche l'altra ghiandola anale di Brenin si era infettata e c'era sangue
dappertutto. «Mon Dieu» commentò Jean- Michel, che ripeté la procedura
del giorno prima: rasò il resto del sedere di Brenin e incise la seconda
ghiandola. Tornai a casa per un lungo weekend di doppi lavaggi e doppie
iniezioni: ogni due ore, giorno e notte. E non è che dormissi molto tra
un'iniezione e l'altra. A Brenin era stato imposto un ingombrante collare di
plastica per impedirgli di leccarsi le ferite. Inutile dire che lui lo detestava e
il suo sistema preferito per manifestare l'irritazione era sbattere il collare
contro pareti, tavoli, televisore e qualsiasi altra cosa gli capitasse a tiro.
Brenin non era affatto contento del trattamento che stava ricevendo. Dal
suo punto di vista, era andato dal veterinario il mercoledì, avvertendo
appena un leggero malessere, e adesso si trovava torturato da un'atrocità
dopo l'altra, ogni due ore. E, anche se non era forte come al solito, era
ancora abbastanza forte e non aveva la minima intenzione di permettermi di
interferire con il suo didietro, se poteva evitarlo. Così dovevo avvicinarmi a
lui, spingerlo in un angolo e poi trascinarlo per il collare verso il posto dove
avevo preparato la ciotola con l'acqua saponata, la spugna e la siringa.
Quindi dovevo immobilizzarlo a terra, distendermi su di lui che continuava
a dimenarsi e infine, quando diventava troppo debole per opporsi,
cominciare la pulizia e le iniezioni. Durante queste ultime operazioni,
Brenin si limitava a stare disteso e a lamentarsi. Ascoltare quei lamenti è
stata una delle cose più difficili che abbia mai dovuto fare.
Quando riportai Brenin dal veterinario in quello che poi chiamai il Lunedì
Nero - che seguiva il Venerdì Nero, quando si era infettata la prima
ghiandola, e il Sabato Nero, quando si era infettata anche la seconda - la
ferita chirurgica si era infettata a propria volta. A quel punto Brenin era un
lupo molto, molto malato. Il cocktail di antibiotici prescritto dal veterinario
non stava funzionando. Il venerdì Jean- Michel aveva fatto un tampone a
Brenin e l'aveva mandato a un laboratorio di analisi per scoprire di quale
tipo di infezione batterica si trattasse e, cosa più importante, a quali
antibiotici fosse sensibile. I risultati però non erano ancora arrivati. Nel
frattempo provammo un altro antibiotico, che in passato si era dimostrato
efficace contro ceppi molto resistenti. Jean- Michel dovette anche riaprire la
ferita chirurgica per eliminare l'infezione. La pulizia e le iniezioni nel sedere
di Brenin continuarono senza sosta, ogni due ore, per i due giorni
successivi. Ma adesso dovevo seguire la stessa procedura anche nello
stomaco, naturalmente con un'altra siringa.
Quando il mercoledì tornai dal veterinario, le notizie erano cattive, ma
non del tutto inaspettate. Brenin aveva contratto una forma antibioticoresistente di Escherichia coli, molto simile all'Mrsa, lo stafilococco aureo
resistente alla meticillina. Con ogni probabilità, il batterio era già presente
nell'intestino prima dell'intervento chirurgico e il sistema immunitario
indebolito gli aveva permesso di diffondersi senza ostacoli. La conclusione
fu che quasi sicuramente Brenin sarebbe morto.
Volendo tentare il tutto per tutto, Jean- Michel decise di provare con un
sistema della vecchia scuola, qualcosa che ormai nell'era degli antibiotici
non si faceva più. Avrete sentito parlare di persone a cui sono stati
ricostruiti un ginocchio o una spalla. Bè, al povero Brenin in pratica venne
ricostruito il sedere. Avendo constatato che il posteriore del mio lupo, pur
essendo pulitissimo, era infestato da batteri e avendo notato il rigonfiamento
nella zona sottostante le ghiandole anali, Jean- Michel decise che il
problema di Brenin consisteva nel fatto che l'evoluzione non era stata
efficientissima nei confronti delle suddette ghiandole, le quali potevano
essere molto valide per immagazzinare l'odore utile a marcare il territorio,
ma erano assai poco efficaci nell'eliminare indesiderate infezioni batteriche.
Così Jean- Michel operò di nuovo Brenin e, se le mie capacità di traduttore
non mi tradirono, spostò le ghiandole anali di due o tre centimetri più in
basso (potete immaginare la quantità di mimica, da entrambe le parti, e la
montagna di disegni, da parte del veterinario, per farmi capire quel
concetto!). I dettagli e la dinamica dell'operazione non mi erano molto
chiari, ma l'idea, mi spiegò Jean- Michel, era che adesso l'infezione poteva
defluire naturalmente, invece di restare imbottigliata dentro. Ma né lui né io
nutrivamo molte speranze.
Quella sera andai riprendere Brenin e lo portai a casa a morire. È difficile
trasmettere il senso di isolamento, di solitudine e di disperazione di quei
giorni. Il vero orrore non consisteva nella consapevolezza che stavo per
perdere Brenin. Tutte le vite giungono al termine e, a parte i sei mesi di
quarantena, ero felice dell'esistenza che il mio lupo aveva vissuto. Credo
che lo fosse anche lui. L'orrore della situazione consisteva nel fare quello
che dovevo fare per cercare di tenerlo in vita. Naturalmente le sue ferite
erano disgustose: puzzavano di decomposizione e il tanfo permeava tutta la
casa. Ma l'orrore non aveva niente a che fare neppure con questo. L'orrore
consisteva nella sofferenza che ero costretto a imporre a Brenin, una
sofferenza che dovevo infliggergli ogni due ore e che quasi certamente
sarebbe stata inutile. Al fondo di quella sofferenza, credo, c'era una sorta di
solitudine. Non la mia solitudine, che era irrilevante, ma quella del mio
lupo.
Brenin era terrorizzato e tutti i miei tentativi per confortarlo non potevano
modificare la situazione. È anche probabile che provasse molto dolore,
anche se non ne ero certo. Sono sicuro, invece, che la pulizia delle ferite,
che continuavo a fare ogni due ore, giorno e notte, gli faceva molto male. I
miei sforzi per pulirlo e curarlo erano inevitabilmente accompagnati da una
gamma di versi che andava dal debole gemito all'urlo fortissimo. Stavo
perdendo l'amore di Brenin: era questo che credevo. Era un pensiero
orribile, ma non ci portava al cuore dell'attuale situazione. Se solo Brenin
fosse migliorato, avrei accettato con gioia che mi odiasse per il resto della
sua vita. Questo è uno dei molti patti che, nella mia psicosi da mancanza di
sonno, strinsi con Dio. La merda aveva davvero colpito il ventilatore, ma il
mio cucciolo di lupo adesso era vecchio e stava morendo davanti ai miei
occhi. Il vero orrore era nell'idea che Brenin credesse di avere perso il mio
affetto. Continuavo a pensare che avrebbe ricordato i suoi ultimi giorni
come quelli in cui era stato torturato dall'uomo che si supponeva dovesse
amarlo. L'avevo tradito, abbandonato. E non ero il solo. Nina e Tess erano
spaventate dal suo grande collare di plastica: ogni volta che Brenin si
avvicinava, le «ragazze» si alzavano e si spostavano dall'altra parte della
stanza. Era una scena che mi spezzava il cuore, e credo che una piccola
parte rimarrà spezzata per sempre. La gente dice spesso - di solito quando
vuole essere melodrammatica - che tutti noi moriamo soli. Non so se sia
vero. Ma, mentre è facile antropomorfizzare questo tipo di situazioni, è
difficile evitare la conclusione che Brenin dev'essersi sentito completamente
solo, tradito, abbandonato e addirittura brutalizzato dal branco che era stato
la sua vita.
Io sono un consequenzialista riguardo alle questioni morali. Credo cioè
che un'azione possa essere giudicata giusta o sbagliata esclusivamente in
base alle conseguenze che determina. Sono una di quelle persone convinte
che la strada che porta all'inferno sia lastricata di buone intenzioni. Ho
sempre avuto una profonda sfiducia nelle intenzioni che, a mio parere, sono
spesso maschere, e maschere dentro altre maschere: simulazioni di cui ci
serviamo per travestire la sgradevole verità delle nostre motivazioni
autentiche. Mi dissi che avrei fatto a Brenin ciò che avrei voluto che
qualcuno facesse a me nelle stesse circostanze. Non l'avrei tenuto in vita a
ogni costo, perché io non avrei mai voluto essere tenuto in vita a ogni costo.
Se, però, ci fosse stata la speranza che io potessi riprendermi e tornare a
condurre una vita piena e appagante, allora avrei voluto che qualcuno
lottasse per me, anche se non avessi capito che cosa stava facendo. Perciò,
mi dissi, dovevo lottare per Brenin, anche se non lui capiva quello che stavo
facendo, anche se non voleva che lo facessi. È questo che continuavo a
ripetermi. Ma forse, in realtà, semplicemente non ero ancora pronto, non ero
ancora abbastanza forte, per immaginare una vita senza Brenin. Forse il mio
principio all'apparenza così nobile - fà a Brenin ciò che vorresti che gli altri
facessero a te - era solo una maschera per nascondere la mia indisponibilità.
Chi può sapere qual era la mia vera motivazione? Chi può sapere se esiste
qualcosa come una vera motivazione? E, francamente, a chi importa?
Costringendo Brenin a soffrire in quel modo, e con ogni probabilità a
morire in quel modo, stavo facendo una scommessa con la mia anima
consequenzialista. Stavo costringendo la figura più importante e fedele degli
ultimi dieci anni della mia vita a una morte piena di dolore e paura, una
morte in cui si sentiva abbandonato da coloro che amava. Se Brenin fosse
morto, le mie azioni sarebbero state imperdonabili. Non ci sarebbe stato
perdono per quello che avevo fatto, né avrebbe dovuto esserci. D'altra parte,
che cosa sarebbe successo, se avessi semplicemente rinunciato? Se avessi
rinunciato quando Brenin avrebbe potuto riprendersi? Ci aggrappiamo con
tanta forza alle nostre intenzioni perché le conseguenze sono implacabili. Le
conseguenze ci dannano se agiamo e spesso ci dannano se non agiamo.
Spesso è solo la fortuna, la fortuna cieca, che può salvare noi
consequenzialisti.
Brenin migliorò: incredibile, ma vero. Dopo circa un mese - non ho mai
avuto le idee molto chiare sull'esatta sequenza degli eventi - mi svegliai
dopo pochi minuti di sonno rubato e mi accorsi che in Brenin c'era qualcosa
di diverso. Non riuscivo a capire di che cosa si trattasse esattamente, ma
qualcosa era cambiato. Adesso lo so: Brenin mi stava guardando. Adesso mi
rendo conto che durante l'ultimo mese non mi aveva mai guardato, forse
perché pensava che, se avesse incontrato il mio sguardo, io mi sarei
ricordato che dovevo ricominciare a fargli male. Ma questo all'epoca non lo
sapevo. Il mio primo pensiero fu che era arrivata la fine. Avevo già visto
morire sia persone sia cani e sapevo che spesso le ore immediatamente
precedenti la morte sono caratterizzate da un apparente miglioramento: per
poche ore i malati sembrano riacquistare le forze, ma è solo il segnale che
stanno per andarsene. Brenin però non se ne andò. Il miglioramento
continuò anche nei giorni seguenti, diffondendosi in tutto il corpo come una
voce sussurrata tra la folla, una voce che lentamente, ma con sicurezza, si
trasformò davanti ai miei occhi in una promessa. Il suo appetito migliorò e a
poco a poco gli tornarono le forze. Nel giro di una settimana eravamo pronti
per la nostra prima uscita dopo più di un mese, una tranquilla passeggiata
nella riserva per andare a vedere i fenicotteri. I lavaggi e le iniezioni delle
ferite naturalmente continuarono, e sarebbero continuati per diverse
settimane. Ma l'infezione era debellata. E Brenin non si opponeva più alle
mie cure: se ne stava pazientemente disteso e aspettava che finissi di fare
quello che dovevo fare.
Quando ripenso a quei giorni, lo faccio sempre con una spiccata
sensazione di irrealtà. Per oltre un mese le esigenze delle terapie di Brenin
non mi avevano quasi permesso di dormire. Lo sfinimento a volte mi faceva
appisolare, ma credo che fosse sempre per pochi minuti soltanto. A volte,
quando mi svegliavo, non ricordavo che Brenin era malato. Ma poi sentivo
nelle narici il fetore della decomposizione e la situazione, nel suo orrore
senza speranza, si imponeva di nuovo alla mia consapevolezza. Dopo
qualche giorno di una simile routine cominciano le allucinazioni da
mancanza di sonno. Ce ne furono parecchie, ma la più frequente era quella
in cui ero morto e all'inferno, e così sarebbe stato per l'eternità.
Tertulliano, il più feroce e depravato dei primi cristiani - e questo dice
qualcosa - aveva una sua visione preferita dell'inferno: un luogo in cui tutti
coloro che non si erano salvati venivano torturati da demoni che infilavano
forconi arroventati nel posteriore e cose del genere. I salvati se ne stavano a
guardare lo spettacolo dai loro palchi in paradiso, ridendo allegramente dei
tormenti inflitti ai dannati. È difficile provare qualcosa di diverso dal
disprezzo per Tertulliano e per la profondità del risentimento che doveva
avere dentro di sé per potere pensare al paradiso e all'inferno in questi
termini. Per lui il paradiso era un luogo vendicativo e ciò era solo un
riflesso della sua anima vendicativa. Ma, per quanto riguarda l'inferno di per
sé, io credo che la visione di Tertulliano sia molto blanda.
L'inferno sarebbe molto peggiore se, invece di essere un posto dove si
viene torturati e brutalizzati, fosse un posto dove sei costretto a torturare e
brutalizzare quelli che ami di più. Sei costretto a farlo anche se lo trovi
rivoltante e il disgusto ti penetra dentro, fin nel profondo dell'anima. Sei
costretto a farlo anche se ciò ti costerà la cosa per te più preziosa del
mondo: il loro amore. Ma lo fai comunque, perché - ed è qui che troviamo il
genio dell'inferno -è per il loro bene. L'inferno ti dà la scelta e tu lo fai
comunque perché l'alternativa è peggiore. Questo è un inferno di gran lunga
peggiore di quello di Tertulliano. Se mi trovassi in un inferno del genere,
scambierei il posto con i dannati di Tertulliano in un batter d'occhio. In quei
giorni, quando Brenin stava morendo, pensavo che l'inferno fosse essere
costretto a torturare un lupo che amavo perché era per il suo bene. Ma
sarebbe stato un inferno strano, così come era strano il paradiso di
Tertulliano, popolato di gente che odia. Il mio inferno sarebbe stato
popolato di persone che amano. Mi piacerebbe pensare che chi odia non
possa andare in paradiso e chi ama non possa andare all'inferno. Ma il
consequenzialista che c'è in me non mi permette di crederlo.
La gente dice sempre di amare il proprio cane. E sono sicuro che ne è
convinta. Ma, credetemi, finché non avrete pulito il sedere malato,
puzzolente e in suppurazione del vostro cane ogni due ore per ben più di un
mese, non potete saperlo. Di solito pensiamo all'amore come a un
sentimento caldo e avvolgente. Ma l'amore ha molte facce e quella era solo
una.
Nel periodo in cui Brenin era così malato, ero soggetto a una mescolanza
instabile di sentimenti, emozioni e desideri, nessuno dei quali abbastanza
costante o prevalente da potere essere definito un sentimento d'amore. Per
gran parte del tempo mi sentivo come se fossi stato colpito in piena faccia:
senza fiato, scosso, stordito, nauseato. Per gran parte del tempo era come se
stessi camminando nelle sabbie mobili, o piuttosto attraverso le sabbie
mobili; era come se l'aria si fosse in parte coagulata intorno a me in una
densa, viscosa ansia caotica che rendeva impossibile qualsiasi azione
spontanea, e addirittura il pensiero. Perlopiù mi sentivo ottenebrato. A un
certo punto, quando fui certo che Brenin stesse per morire - e non mi piace
ammetterlo, ma è vero - mi sentii quasi sollevato e pensai che, se quando la
prossima volta fossi andato da lui per lavarlo e siringarlo non si fosse
svegliato, forse sarebbe stato meglio.
Sensazioni, sensazioni, sensazioni: tutte molto forti, alcune quasi
travolgenti. Ma nessuna che potesse essere plausibilmente identificata con
l'amore che provavo per Brenin. L'amore in questione è ciò che Aristotele
avrebbe definito philia: l'amore per la famiglia, l'amore per il branco. Si
distingue dall'eros - il desiderio ardente dell'amore erotico - e dall'agape,
l'amore impersonale verso Dio e l'umanità nel loro insieme. Il mio
attaccamento a Brenin non era, ve lo assicuro, in alcun modo erotico. E non
lo amavo neppure nel modo in cui la Bibbia sostiene che dovrei amare il
mio vicino o il mio Dio. Io amavo Brenin come un fratello. E questo amore
- questa philia - non è una sensazione di nessun tipo.
Le sensazioni possono essere manifestazioni di philia e possono
accompagnarla, ma non sono philia. Perché mi sentivo intontito e nauseato?
Come potevo sentirmi sollevato dalla prospettiva dell'imminente morte di
Brenin? Perché lo amavo e farlo soffrire in quel modo era quasi - ma, grazie
a Dio, non completamente - insopportabile. Queste sensazioni, per quanto
diverse, disparate e disunite possano essere, sono tutte manifestazioni di
quell'amore. Ma l'amore non è nessuna di quelle sensazioni. Ci sono così
tante sensazioni che, in contesti diversi, possono accompagnarlo che la
philia non può essere identificata con nessuna di loro. E può esistere senza
nessuna di loro.
L'amore ha molte facce. E, se ami, devi essere abbastanza forte da saperle
considerare tutte. Io credo che l'essenza della philia sia molto più dura,
molto più crudele di quanto ci piaccia ammettere. C'è una cosa senza la
quale la philia non può esistere e non è questione di sensazioni, ma di
volontà. Philia - l'amore adeguato al tuo branco - è la volontà di fare
qualcosa per coloro che fanno parte del branco, anche se non vuoi farlo,
anche se ti fa orrore e ti disgusta e anche se, alla fine, potresti dover pagare
un prezzo molto alto, forse più alto di quanto tu possa sopportare. Lo fai
perché è ciò che è meglio per il branco. Lo fai perché devi. Può darsi che tu
non sia mai costretto a farlo, ma devi essere sempre pronto a farlo. L'amore
a volte è disgustoso. L'amore può dannarti per l'eternità. L'amore può
portarti all'inferno. Ma se sei fortunato, se sei molto fortunato, ti riporterà
indietro.
Otto. La freccia del tempo
Ci incontreremo di nuovo nei sogni: è l'ultima cosa che dissi a Brenin. La
dissi mentre il veterinario gli conficcava l'ago ipodermico in una vena della
zampa anteriore destra - ricordo la zampa, ricordo la vena - e gli iniettava
una dose letale di anestetico. Quando terminai la frase, Brenin se n'era già
andato. Mi piace pensare che comunque non fosse lì. Mi piace pensare che
fosse in Alabama, intento a strofinare il naso nella pelliccia di sua madre.
Mi piace pensare che fosse a Knockduff con Nina e Tess, felice di saltare
con loro nel mare d'orzo mentre il diffidente sole irlandese si alzava su uno
scenario di nebbioso splendore dorato. Mi piace pensare che fosse nel
Wimbledon Common, a scorrazzare tra i boschi con le «ragazze»
all'inseguimento di scoiattoli e di quei furbacchioni dei conigli. E mi piace
pensare che fosse di nuovo con loro, a sguazzare nelle onde calde del
Mediterraneo.
Il tumore che si era annunciato l'anno prima era tornato, questa volta
metastatizzato e irrimediabilmente maligno. Si trattava di un linfosarcoma,
che è curabile negli uomini, ma che, essendo le vicende della scienza
veterinaria quelle che sono, per i cani significa quasi sempre la morte.
Questa volta decisi di non tentare alcun intervento invasivo per salvare
Brenin, perché non credevo assolutamente che sarebbe sopravvissuto
all'operazione, per non parlare delle complicazioni postoperatorie. Rimasi
sconvolto quando venni a sapere che, durante l'anno trascorso da che Brenin
si era ammalato, Jean- Michel, il veterinario la cui competenza da vecchia
scuola aveva salvato il mio lupo la prima volta, se n'era andato, anche lui
vittima di un tumore. E forse, quando il collega che era subentrato
nell'ambulatorio me lo disse, intuii che era finito anche il tempo di Brenin.
Cercai di rendergli la vita più comoda e confortevole possibile e, per la
prima volta nella sua esistenza, lo lasciai dormire sul letto insieme a me,
con immensa mortificazione di Nina e Tess, che non riuscivano a credere
che le escludessi da quella meravigliosa ed eccezionale concessione.
Quando gli antidolorifici smisero di funzionare e il dolore diventò
insopportabile - in base al mio giudizio sincero e tormentato, ma
profondamente fallibile -, portai Brenin a Béziers perché venisse soppresso.
E a Béziers lui morì, sul retro di una jeep molto simile a quella su cui
avevamo scorrazzato in lungo e in largo nel Sudest degli Stati Uniti tanti
anni prima, in cerca di rugby e feste e donne e birra.
Non avrei potuto seppellirlo in giardino perché i proprietari della casa si
sarebbero sicuramente opposti. Così lo seppellii in un posto dove ci
fermavamo sempre durante le nostre passeggiate quotidiane: una piccola
radura circondata da faggi e querce nane. Il terreno era sabbioso e non ci
misi molto a scavare una fossa abbastanza grande. Dopo avere sepolto
Brenin, innalzai sopra la tomba un tumulo con i sassi prelevati dalla diga
che impediva ai marosi delle tempeste invernali di allagare il paese. Fu
un'operazione lunga e faticosa, perché la diga distava circa duecento metri
e, quando terminai, era già sera inoltrata. Accesi un falò con alcuni pezzi di
legno trasportati dalla corrente e decisi di passare il resto della nottata con
mio fratello.
Questa è la parte della storia che sono più riluttante a raccontare, dato che,
ancora una volta, ne esco come il totale psicotico che senza dubbio ero. A
tenermi compagnia c'erano Nina e Tess e i due litri di Jack Daniel's che
avevo messo da parte sapendo che quella particolare notte sarebbe arrivata
presto. Nelle ultime settimane non avevo bevuto per niente, dato che
dovevo avere la mente lucida per prendere le decisioni migliori possibili per
Brenin. Non potevo permettere che una malinconia alcolica mi spingesse a
addormentarlo un solo momento prima della sua ora. E non potevo
permettere neppure che un'euforia alcolica lo costringesse a restare
aggrappato a una vita che non era più degna di essere vissuta. Era la prima
volta da anni che rimanevo a secco per più di un giorno o due e quella notte
avevo in programma di interrompere decisamente la siccità. E così, dopo
che Brenin era stato sepolto, Nina e Tess si distesero tranquille accanto al
fuoco e ascoltarono infuriare la mia rabbia da bourbon sullo sfondo della
luce morente. Una volta attaccato il secondo litro, quella che era cominciata
come una silenziosa riflessione sulla possibilità di una vita dopo la morte si
trasformò in un furioso torrente di invettive contro Dio. Frasi più o meno
del tipo: Andiamo, str...! Fammi vedere! Fammi vedere se continuiamo a
vivere anche dopo, brutto figlio di p...!
Quanto accadde subito dopo suona orrendamente inverosimile, ma giuro
su Dio che è vero. Nel momento stesso in cui dicevo quelle frasi, guardai al
di là del falò e lo vidi: il fantasma di pietra di Brenin.
Voglio sottolineare quanto questo sia inspiegabile. Per creare il tumulo,
ero andato avanti e indietro dalla diga: raccoglievo le pietre staccate o
sparse che trovavo, le trasportavo fino alla radura e le lasciavo
semplicemente cadere sopra la tomba di Brenin. Avevo ripetuto l'operazione
molte, molte volte e il lavoro aveva richiesto in tutto circa cinque ore. La
caduta delle pietre sulla fossa era stato un processo del tutto casuale. Ne
sono ancora convinto. Non avevo sistemato le pietre: le avevo
semplicemente lasciate cadere. Non ero stato guidato da una visione globale
del tumulo. Anzi, volevo solo finirlo e ubriacarmi all'inverosimile.
Ma adesso a fissarmi attraverso le fiamme c'era il fantasma di pietra di
Brenin. Davanti c'era la testa, una lastra di roccia a forma di diamante: il
muso appiattito a terra, com'era sua abitudine, e una macchia di muschio
sulla punta che sembrava a tutti gli effetti il naso. Il resto del tumulo era un
lupo raggomitolato come se fosse stato nella neve: un'abitudine che Brenin
aveva ereditato dai suoi antenati artici e che gli era stato impossibile
abbandonare, perfino nel caldo soffocante dell'Alabama o nell'estate della
Linguadoca. Allo zenit della mia rabbia e della mia miseria, Brenin mi stava
guardando a propria volta.
Psicologi del profondo - freudiani, junghiani e simili -potranno forse
sostenere che inconsciamente avevo creato l'immagine di un Brenin
addormentato: l'atto del lasciare cadere le pietre sulla tomba era stato
guidato dal desiderio inconscio di realizzare un monumento a sua
immagine. Forse hanno ragione, ma questa spiegazione non mi sembra per
niente plausibile. Non spiega il notevole ruolo giocato dal caso nella
costruzione del tumulo. Quando portavo una pietra alla tomba, non la
posavo: la lasciavo cadere sulle altre e poi mi voltavo immediatamente per
andare a cercare la successiva. Alcune pietre si fermavano dove erano
cadute, ma la maggior parte no: rotolava in basso. Se le pietre rotolavano, e
dove rotolavano, era determinato dal caso. Ed è per questo che la storia
degli psicologi del profondo non convince. Che il mio inconscio controlli le
mie azioni è una cosa, ma che controlli il caso è tutt'altra cosa.
Sarebbe facile spiegare il fantasma di pietra di Brenin come
un'allucinazione o una confabulazione provocata dall'alcol. Sarebbe ancora
più facile spiegarlo come un sogno. Già, ci incontreremo di nuovo nei
sogni. Ma il fantasma di pietra di Brenin non se ne andò. Mi addormentai
per terra accanto al falò e, quando il fuoco si spense, forse sarei morto di
freddo, se non fosse stato per un fortuito attacco di vomito che mi costrinse
a svegliarmi. Ma quando mi svegliai il fantasma di pietra di Brenin era
ancora lì. È lì a tutt'oggi.
L'ultimo anno di Brenin fu un regalo per tutti e due. Ricordo quel periodo
come un'estate senza fine. Non sono mai stato ossessionato dal tempo. Ho
perso il mio ultimo orologio a una partita di poker a Charleston, nella
Carolina del Sud, nel 1992 e non mi sono ancora deciso a sostituirlo.
Naturalmente non possedere un orologio non ti libera dalle costrizioni del
tempo: ho la sensazione di passare metà della vita a chiedere l'ora alla gente.
Ma l'aspetto migliore del vivere in Francia era che si trattava di quanto di
più simile a un'esistenza senza tempo avessi mai sperimentato o
immaginato. In Francia vivevamo non secondo l'orologio, ma secondo il
sole. Ma chi sto prendendo in giro? Noi vivevamo in base a un orologio, ma
era quello di Nina, non il mio.
Mi alzavo sempre al sorgere del sole, il che in estate significava verso le
sei del mattino. Sapevo che era l'alba perché per Nina era il segnale della
sveglia e il momento in cui cominciare a leccarmi la mano o il piede che
sbucava dalle coperte. E se non c'erano mani o piedi in esposizione, lei
spostava le lenzuola con il naso finché non trovava qualcosa. A quel punto
scendevo cautamente la ripida scala di pino - la lenta prudenza mattutina era
dovuta a un ginocchio rotto ai tempi del rugby -, portandomi dietro il mio
laptop. Mi sedevo in terrazza, sul davanti della casa, e scrivevo nella
frescura caliginosa e piena di zanzare del primo mattino. Brenin si
sistemava nel suo angolo preferito del giardino, raggomitolato come se
fosse stato nella neve, con il muso allungato sul terreno. Nina, la guardiana
del tempo del branco, si distendeva accanto al cancello, con gli occhi lucenti
sempre fissi su di me in attesa della solita passeggiata, alla quale mancava
ancora qualche ora. Tess, la principessa del branco, aspettava che mi
immergessi nel lavoro e poi scivolava silenziosa in casa per vedere se
riusciva a intrufolarsi nel mio letto senza che me ne accorgessi. Di solito ci
riusciva.
Poi verso le dieci, prima che facesse troppo caldo, Nina si alzava, veniva
da me e mi posava la testa in grembo. Se questo non provocava la reazione
desiderata - cioè che smettessi di scrivere - cominciava a darmi con il muso
dei colpetti decisi e ripetuti sulle braccia, impedendomi di continuare a
digitare sulla tastiera. Il messaggio era inequivocabile: è ora di andare in
spiaggia. Non era tanto una passeggiata quanto un'operazione militare. Per
prima cosa, c'era la preliminare raccolta degli ombrelloni e di altra
attrezzatura, come palle e/ o frisbee. Questa attività informava gli altri
membri del branco dell'imminente marcia e il risultato era un coro di ululati,
guaiti e latrati che segnalava a chiunque nel villaggio che noi stavamo per
muoverci. Il frisbee era per Nina, nuotatrice esperta ed entusiasta. Gli
ombrelloni erano per Brenin e Tess, che si limitavano a sguazzare nell'acqua
bassa e a volte, nei giorni senza vento e se il mare era calmo, potevano
essere persuasi a nuotare sul serio. Ma a loro non piaceva affatto: nuotavano
verso di me, con la tensione ai limiti del panico chiaramente visibile sui
musi, ma, non appena mi raggiungevano, si voltavano subito e tornavano
verso la spiaggia, che era il posto dove preferivano passare la maggior parte
del tempo. Quando mi stancavo di vederli ansimare sotto il sole sempre più
caldo, aprivo gli ombrelloni - uno a testa - che avevo comprato per loro.
Ripensandoci adesso, mi rendo conto che ormai dovevo essere diventato
piuttosto «stravagante», un po’ come quelle vecchie signore con tanti gatti.
L'aspetto positivo era che i numerosi ladri che popolavano le spiagge della
Francia meridionale nei mesi estivi giravano sempre alla larga dal nostro
accampamento. E lo stesso facevano gli altri cani.
Durante la passeggiata per raggiungere la spiaggia c'erano certe cose che
dovevano essere fatte in un certo ordine e in un certo modo. I cani del
vicinato andavano salutati e, dove necessario, intimiditi nel modo più
opportuno: prima c'era Vanille, la femmina di setter inglese, che doveva
essere intimidita da Nina, con Tess come assistente, ma al tempo stesso
salutata da Brenin in modo amichevole, seppure distaccato; poi era la volta
di Rouge, il grosso maschio di ridgeback, che veniva offeso dall'urina di
Brenin sul recinto del suo giardino, ma al tempo stesso salutato sia da Nina
sia da Tess con un entusiasmo che sconfinava nella smanceria; e finalmente
c'era la femmina di Dogo argentino di cui ho già parlato, ma della quale non
ho mai saputo il nome, che una volta commise l'errore di attaccare Tess.
Certo, Tess l'aveva scelta per un trattamento speciale: tratteneva il primo
transito intestinale del mattino finché non arrivavamo davanti alla casa della
dogo e poi depositava il prodotto quanto più umanamente - anzi,
caninamente - possibile vicino alla recinzione del giardino. Riflettendoci
adesso, forse era per questo che la dogo cercava sempre di mordermi.
Tess, in genere, era una maestra nella deposizione tattica delle feci.
Abitavamo ancora a Wimbledon e una volta, mentre stavamo attraversando
il campo da golf che fa parte del parco, con una dimostrazione di
straordinaria precisione riuscì a fare la cacca esattamente sopra una pallina
da golf atterrata lì vicino. Il mio consiglio - «Se fossi in lei, dropperei» servì ben poco a placare il furioso, ma soprattutto incredulo, socio del
London Scottish Golf Club.
Superata l'ultima casa, entravamo nei vigneti, o meglio nei vigneti
dimenticati, abbandonati da tempo al terreno salmastro e alle frequenti
tempeste, e poi proseguivamo fino alla maire, che andava dalla diga
all'estremità settentrionale della spiaggia. Nella stagione giusta dell'anno, la
zona diventava un tappeto di fenicotteri rosa: i flamants roses, come
vengono chiamati nell'assai più bella lingua francese. Se capitava che un
fenicottero si aggirasse solitario sulla spiaggia, Nina e Tess non mancavano
mai di lanciarsi al suo inseguimento finché non si alzava in volo per
tornarsene nel suo legittimo territorio. Per fortuna nessuna delle due arrivò
mai neppure remotamente vicina a catturarne uno. Mentre le «ragazze» si
davano invano alla caccia, Brenin mi guardava come per dire: «I giovani
d'oggi... Se solo avessi qualche anno di meno...».
Una volta arrivati in spiaggia, Nina si precipitava dritta in acqua e
cominciava a saltare e abbaiare, chiedendo a gran voce il suo frisbee.
Durante l'estate sulla spiaggia era in vigore una severa politica di divieto di
accesso ai cani (i lupi, in realtà, non erano esplicitamente citati). Ma i
francesi sono noti per considerare le leggi del loro paese come un elenco di
suggerimenti, piuttosto che come rigide disposizioni; raramente il divieto
veniva rispettato e di solito la spiaggia era affollata di cani. Ogni tanto
arrivavano i gendarmes e multavano la gente facendo una gran scena, ma
noi, appena li vedevamo, ci spostavamo di qualche centinaio di metri, sicuri
che non avrebbero camminato fino a noi. Qualche volta però ci beccarono,
una seccatura dovuta non tanto all'ammontare della multa, quanto alla
lunghezza della paternale che ci toccava ascoltare prima di essere multati.
Grazie a una combinazione di fortuna, capacità di nasconderci e finta
ingenuità, riuscimmo a superare l'estate totalizzando non più di cento euro
di multe.
Dopo la spiaggia e poco prima che tutto chiudesse per l'ora di pranzo - era
sempre Nina che ci diceva quando era il momento di muoverci - andavamo
alla boulangerie del villaggio e io poi dividevo un paio di pains au chocolat
fra i tre. Questa suddivisione avveniva secondo un rituale ben definito.
Uscivamo dalla boulangerie e andavamo alla panchina di pietra distante
pochi metri, di fronte al negozio. Io mi sedevo, aprivo il sacchetto di carta,
staccavo pezzetti di pain e li distribuivo a turno a ciascuno dei tre, cercando
di evitare la notevole quantità di saliva che veniva sbavata nella mia
direzione. Nuotare mette appetito. Dopo passavamo al bar di Yvette, dove
mi concedevo un numero sconsiderato di bicchieri di rosé - il drink diurno
preferito in Lin-guadoca -, mentre Yvette la cinofila serviva ai tre una
ciotola d'acqua e faceva un sacco di coccole a Brenin. A quel punto
tornavamo a casa, passando dietro il paese e attraversando il bosco che
confinava con la casa.
Una volta arrivati, ognuno di noi si trovava un posto all'ombra dove
passare il resto della giornata. Io riprendevo a scrivere. A quell'ora dentro
casa faceva troppo caldo per i gusti di Tess, che pertanto aveva preso
l'abitudine di starsene sdraiata ai miei piedi sotto il tavolo in terrazza. Nina
preferiva la parete opposta della terrazza, ombreggiata dal tetto per buona
parte della giornata. Dato che il suo angolo preferito di giardino nel
pomeriggio era al sole, Brenin saliva sulla terrazza scoperta e si sistemava
nell'angolo all'ombra. Da quella posizione aveva un'ottima visuale della
campagna circostante e, cosa ancora più importante, la possibilità di
avvistare subito qualsiasi cosa interessante si stesse avvicinando.
Riprendevamo a muoverci quando le ombre si allungavano, verso le sette
della sera. Per prima cosa preparavo la cena per i quadrupedi, seguita da
alcuni aperitivi per il bipede. Poi andavamo a fare una passeggiata, che di
solito culminava alla Réunion, il nostro ristorante preferito.
Dico il «nostro» e non il «mio» ristorante preferito a ragion veduta. Io ci
andavo per la cena, Brenin e le «ragazze» per la seconda cena. Lionel e
Martine, i proprietari, ci riservavano sempre uno dei grandi tavoli rotondi
nell'angolo, dove c'era spazio in abbondanza perché i cani potessero
sdraiarsi e stirarsi. Mentre io procedevo con calma nel mio pasto di quattro
portate, gli animali esigevano una tassa non insignificante su ogni piatto.
Come chiunque abbia vissuto in Francia sa bene, è impossibile essere
vegetariano in quel paese, meno che mai in campagna. La prima volta in cui
avevo spiegato a Lionel le restrizioni della mia dieta, lui mi aveva guardato
senza capire e mi aveva proposto il pollo. Perciò avevo dovuto seguire
l'esempio di Brenin e delle «ragazze» e passare al pesce. Di solito la cena
cominciava con un'insalata di mare assolutamente sontuosa, che contava
fino a un massimo di dieci capesante. Tre delle quali andavano al
contingente canino, seguite da tre fette di salmone affumicato prelevate
dalla seconda portata. La maggior parte della pelle, della coda e della testa
della sogliola alla mugnaia, che costituiva la terza portata, finiva nello
stesso modo. E quando arrivavo al dessert, mi veniva offerta gratuitamente
una terza crèpe, da dividere fra i miei tre compagni: era il gentile contributo
di Lionel alla tassa canina della sera. Naturalmente tenevo per me il vino e
il mare de muscat, un tipo di brandy ottenuto da uva moscata. Dopo cena
tornavamo tranquillamente a casa, seguendo il bordo della diga, io
piacevolmente sbronzo e i miei amici canini piacevolmente sazi.
Dormivamo sempre molto bene.
Fu così ogni giorno dell'estate nell'ultimo anno di vita di Brenin. E quella
della Linguadoca è un'estate lunga e splendida. L'inverno ci costrinse a certi
aggiustamenti. Tragicamente, La Réunion restava chiuso da metà novembre
a metà marzo: in quei mesi Lionel e Martine lavoravano nelle località
sciistiche. L'attività natatoria veniva molto ridotta, sicuramente da parte
mia, se non di Nina, la quale adesso mi permetteva di dormire fin verso le
otto. E la mattina il mio lavoro di scrittore si svolgeva prevalentemente
dentro casa. A mezzogiorno la permanenza da Yvette tendeva a protrarsi un
po’ più a lungo, dato che non avevo un posto dove andare la sera. Ma lo
schema di base della giornata, la sua essenza, rimaneva immutato.
In tutto quel periodo, estate e inverno, fu Nina la nostra guardiana del
tempo. Era stata spinta ad assumere quel ruolo da qualcosa che era successo
quasi all'inizio del nostro soggiorno in Francia, un evento così cupo e
tragico che temo la perseguiti ancora oggi, ad anni di distanza. Fu colpa mia
e me ne assumo l'intera responsabilità. Forse quel giorno avevo passato
troppo tempo al computer, o forse avevo indugiato un po’ troppo nelle
piacevoli, fresche acque del Mediterraneo. Quale che fosse la ragione,
quando quel giorno eravamo arrivati in paese... la boulangerie era chiusa per
la pausa pranzo. E il pranzo in Linguadoca è qualcosa di piacevole e lungo.
Certo, obiettivamente parlando - e per me è facile essere oggettivo -, non
era poi un grosso problema. Avrei solo dovuto passare circa un'ora più del
solito da Yvette, cosa che avevo fatto con piacere, e alle quattro del
pomeriggio la boulangerie avrebbe riaperto. Ma considerare obiettivamente
problemi legati al cibo non è mai stato il forte di Nina. Né lo è mai stato
accettare ritardi nelle gratificazioni. Le ore che Nina aveva trascorso da
Yvette, quel giorno, erano state ore di confusione tormentata, di angoscia
esistenziale del tipo più debilitante (non occorre dire che il bar di Yvette
non vendeva cibo). Nina aveva passeggiato avanti e indietro per tutto il
tempo, con un lampo di follia negli occhi. Non era come doveva essere.
Quella era stata la lunga, buia ora di pranzo della sua anima.
Naturalmente le quattro del pomeriggio erano arrivate, il mondo aveva
avuto di nuovo un senso e la giornata aveva potuto riprendere il suo corso
normale. Ma a partire da quel giorno Nina fu motivata da due paure
gemelle: la paura di arrivare e trovare la boulangerie chiusa e la paura di
non andare alla Réunion. Dio non volesse che la sera prendessi una strada
diversa dal solito per andare al ristorante! E non appena arrivavamo a
qualche centinaio di metri dal locale, Nina entrava comunque, che il resto di
noi la seguisse o meno.
Fu solo in seguito - dopo che Brenin era morto e ce n'eravamo andati
dalla Francia - che mi resi conto di quanto fosse stato intensamente
uniforme quell'anno della mia vita. Ma immagino che fosse stato solo un
prolungamento del tipo di esistenza che ci eravamo goduti in Irlanda e a
Londra. Quasi tutti quelli che conosco definirebbero una vita del genere,
con la sua regolarità e ripetitività, monotona, perfino estremamente noiosa.
Ma io credo di avere imparato da quei giorni forse più che da qualsiasi
persona o cosa. La chiave di quello che ho imparato è in una domanda
ingannevolmente semplice: che cosa perse Brenin, quando morì?
È chiaro che io - un pazzo che ululava alla luna e si infuriava con Dio persi molto quando Brenin morì. E c'è chi vi dirà, come disse a me, che
questo dipendeva dalla vita triste e solitaria che avevo condotto in quegli
anni. Forse è vero. Ma non mi interessa ciò che persi io: mi interessa ciò che
perse Brenin.
In che senso la morte è un male? Non per gli altri, ma per l'individuo che
muore? In che senso la tua morte è un male per te? La morte - qualunque
altra cosa possa essere - non è qualcosa che accade nella vita. Wittgenstein
disse che la sua vita era illimitata così come era illimitato il suo campo
visivo. Ovviamente non intendeva dire che viviamo per sempre: nel 1951 lo
stesso Wittgenstein morì (anche lui di tumore). Ciò che voleva sottolineare
è che la morte è il limite di una vita, e il limite di una vita non può
manifestarsi in quella vita più di quanto il limite di un campo visivo si
manifesti in quel campo. Il limite di un campo visivo non è qualcosa che
vedi: ne sei consapevole proprio a causa di ciò che non vedi. È così che
funziona con i limiti: un limite di qualcosa non è parte di quella cosa; se lo
fosse, allora non sarebbe il suo limite.
Se accettiamo tutto questo, ci troviamo però a dover subito affrontare un
problema: sembrerebbe, infatti, che la morte non possa nuocere
all'individuo che muore. La versione classica del problema fu enunciata,
duemila anni prima di Wittgenstein, dal filosofo greco Epicuro. La morte,
sosteneva Epicuro, non può nuocerci. Quando siamo vivi, la morte non è
ancora arrivata e quindi non può averci nuociuto. E quando moriamo - dato
che la morte è il limite della nostra vita e non un evento della vita - non può
nuocerci perché non ci siamo più. Perciò la morte non può essere un male,
almeno non per la persona che muore.
Che cosa c'è di sbagliato nell'argomentazione di Epicuro? O meglio, c'è
qualcosa di sbagliato? Perlomeno tra gli esseri umani, c'è un consenso quasi
universale sul fatto che c'è qualcosa di sbagliato. E sembra esserci un
sostanziale consenso anche sul perché l'argomentazione è sbagliata: la
morte ci nuoce a causa di ciò che ci porta via. La morte è ciò che i filosofi
definiscono «un danno da privazione». Questa, tuttavia, è la parte facile. La
parte difficile sta nel capire che cosa ci porti via la morte e come possa
portarci via una qualsiasi cosa, quando non siamo più qui per farcela portare
via.
Non andremmo molto lontano, se rispondessimo a queste domande
dicendo che la morte ci nuoce perché ci porta via la vita. Perché, se
Wittgenstein ha ragione e la morte è il limite della nostra vita e quindi non
accade nella nostra vita, allora la vita è esattamente ciò che non abbiamo più
quando moriamo. Ma è possibile sottrarci solo qualcosa che possediamo
effettivamente. Perciò come può la morte portarci via qualcosa che non
abbiamo più?
Una risposta più promettente, penso, è quella delle possibilità: la morte ci
nuoce perché si porta via tutte le nostre possibilità. Ma, alla fine, credo che
neppure questa idea possa funzionare. Parte del problema consiste nel fatto
che le possibilità sono troppo promiscue: ci sono fin troppe possibilità e
quindi non c'è nulla in una possibilità che la renda intrinsecamente mia o
vostra. Tra le possibilità che ho ce ne sono molte per le quali non nutro il
minimo interesse. È possibile che io diventi un pensatore, un sarto, un
soldato o un marinaio; è possibile che diventi un mendicante o un ladro. Ma
non mi interessa affatto dare seguito, o cercare di realizzare, nessuna di
queste possibilità. È possibile che io muoia domani, o tra cinquant'anni. Ma
mi interessa molto di più cercare di realizzare la seconda possibilità,
piuttosto che la prima. Le possibilità sono semplicemente troppo a buon
mercato. Ognuno di noi ne ha a disposizione un numero infinito, o almeno
enorme e indefinito. E ci interessa realizzarne solo una frazione minuscola.
In realtà non siamo neppure consapevoli della maggior parte delle nostre
possibilità.
Per di più, speriamo tutti ardentemente che molte non si realizzino mai.
La maggior parte di noi, con ogni probabilità, non è particolarmente ansiosa
di cercare di concretizzare le possibilità mendicante/ ladro. È possibile che
chiunque di noi diventi un assassino, un torturatore, un pedofilo o un pazzo.
Una cosa è possibile se non c'è contraddizione implicita nel supporre che
accada: è questa la definizione di possibilità. Perciò, per quanto riteniate
improbabile che si realizzi una qualsiasi di queste possibilità, sono
comunque possibilità. Ci sono possibilità che speriamo si concretizzino, ma
ce ne sono altre che preghiamo che non si realizzino mai. Tra le nostre
possibilità ci sono quelle che vorremmo cogliere e altre che vorremmo
rifiutare nel modo più categorico. Dubito che la morte possa nuocerci
privandoci di possibilità che non ci interessano. E sono sicuro che non può
nuocerci privandoci di quelle che respingeremmo con ogni fibra del nostro
essere. Nel caso di determinate possibilità, preferiremmo morire piuttosto
che vederle realizzate. La morte non può nuocerci privandocene.
Tuttavia il concetto di possibilità ci indirizza verso una spiegazione più
promettente. Solo alcune delle nostre possibilità sono rilevanti dal punto di
vista del danno creato dalla morte: sono quelle che speriamo si realizzino. A
ciascuna di queste possibilità corrisponde un desiderio: il desiderio che la
possibilità si realizzi. Se si tratta di un desiderio intenso, che però non
possiamo soddisfare subito, potremmo ritrovarci a darci come obiettivo la
realizzazione di tale desiderio. E se l'obiettivo è difficile da raggiungere,
potremmo ritrovarci a investire molta della nostra energia e molto del nostro
tempo in un progetto mirante al raggiungimento dell'obiettivo. Credo che
sia nei termini dei concetti di desiderio, obiettivo e progetto che noi uomini
cerchiamo inevitabilmente di capire perché la morte è un male per chi
muore.
Apparentemente non abbiamo fatto progressi nella soluzione del
problema di Epicuro. Se la morte è il limite di una vita, e non qualcosa che
accade in una vita, nel momento in cui la morte avviene noi non ci siamo
più e quindi non possiamo essere privati di niente, desideri, obiettivi e
progetti compresi. Tuttavia i desideri, gli obiettivi e i progetti hanno tutti
qualcosa in comune, qualcosa di cruciale in relazione al problema di
Epicuro. Sono tutti orientati verso il futuro: per loro stessa natura, ci
proiettano oltre il presente e verso il futuro. È perché abbiamo desideri,
obiettivi e progetti che abbiamo un futuro: un futuro è qualcosa che ognuno
di noi ha adesso, nel tempo presente. La morte ci fa del male perché ci priva
di un futuro.
Se ci si pensa, l'idea di perdere un futuro è molto strana. E la sua
stranezza deriva dalla stranezza dell'idea stessa di futuro. Il futuro non esiste
ancora. Quindi come puoi perderlo? Puoi perdere un futuro solo se adesso
in un certo senso ne hai uno. Ma come puoi avere qualcosa che non esiste
ancora? Il che dimostra, come minimo, che in questo contesto l'idea di avere
e l'idea di perdere hanno significati molto diversi che in altri, più abituali
contesti. È forse possibile avere un futuro, ma non nello stesso senso in cui
potreste avere le spalle larghe o un orologio Rolex. E se un assassino vi
privasse del vostro futuro, il senso di privazione conseguente sarebbe molto
diverso da quello determinato dall'età che vi priva delle vostre spalle ampie
o da un rapinatore che vi priva dell'orologio.
Se per ognuno di noi la morte è un male perché ci priva di un futuro,
allora il futuro deve essere qualcosa che abbiamo adesso, in questo
momento. Abbiamo un futuro perché ci troviamo - ora ed effettivamente in situazioni che ci indirizzano verso un futuro o ci legano a un futuro. Tali
situazioni sono i desideri, gli obiettivi e i progetti. Ognuno di noi è, per
usare la definizione di Martin Heidegger, un essere- per- il- futuro. Ognuno
di noi è, nella sua natura essenziale, rivolto a un futuro che non esiste
ancora. E, almeno in questo senso, si può dire che abbiamo un futuro.
Cominciamo con i desideri. La caratteristica fondamentale dei desideri è
che possono essere soddisfatti o frustrati. Il desiderio di Brenin di bere verrà
soddisfatto se Brenin attraverserà la stanza per arrivare alla sua ciotola e
berrà. Il desiderio sarà frustrato se Brenin arriverà fino alla ciotola e la
troverà vuota. In ogni caso ci vuole tempo perché un desiderio venga
soddisfatto e, tipicamente, ci vuole tempo anche perché venga frustrato. Ci
vuole tempo perché Brenin attraversi la stanza e arrivi alla ciotola e quindi
ci vorrà tempo prima che il suo desiderio venga soddisfatto o frustrato.
Questo è uno dei sensi, il più basilare, in cui i desideri sono orientati verso il
futuro: soddisfarli richiede tempo. Lo stesso vale, in modo ancora più
palese, per gli obiettivi e i progetti, entrambi essenzialmente desideri a
lungo termine. I desideri possono essere soddisfatti o frustrati, e gli obiettivi
e i progetti possono essere realizzati oppure no. E soddisfare e realizzare
richiede tempo.
C'è però un senso più complicato in cui possiamo avere un futuro. Un
desiderio, un obiettivo o un progetto possono essere orientati verso il futuro
in due modi molto diversi. Come il desiderio di Brenin di bere, il desiderio
può orientarci verso un futuro nel senso che la sua soddisfazione richiede
tempo. Se Brenin vuole soddisfare il suo desiderio, deve persistere al di là
dell'attimo presente: deve sopravvivere almeno il tempo necessario per
attraversare la stanza e arrivare alla ciotola. Per alcuni desideri, tuttavia, il
legame con il futuro è più forte e più profondo di quello dell'esempio.
Alcuni desideri comportano un concetto esplicito del futuro. Attraversare la
stanza per bere è una cosa. Pianificare la vita intorno alla visione di come si
vorrebbe il proprio futuro è tutt'altra cosa.
In confronto ad altri animali, noi uomini passiamo una quantità
sproporzionata di tempo facendo cose che, almeno a un certo livello, in
realtà preferiremmo non fare. Ci comportiamo così a causa della visione di
come ci piacerebbe che fosse la nostra vita futura. È questa la ragione della
lenta marcia attraverso la nostra lunga istruzione scolastica e le successive
carriere. Tutti noi sappiamo quanto queste ultime possano essere ingrate e
nemmeno io, un insegnante di professione, posso fingere che la prima sia
uno spasso ininterrotto. Ma facciamo comunque queste cose perché
abbiamo desideri di un certo tipo. Sono desideri che non possono essere
soddisfatti né adesso, né in un immediato futuro, ma che forse potranno, se
abbiamo abbastanza talento, abbastanza fortuna e se ci impegniamo a
sufficienza, essere soddisfatti in un futuro imprecisato. Le nostre attività del
momento - educative, professionali e spesso ricreative - sono studiate,
eseguite e orientate in funzione della visione del futuro che forse potranno
assicurarci. Per avere questi tipi di desideri, devi avere un concetto del
futuro: devi essere in grado di pensare al futuro come al futuro.
A quanto pare, dunque, possiamo avere un futuro in due sensi diversi. C'è
un senso implicito: io ho dei desideri la cui soddisfazione richiede tempo. E
c'è un senso esplicito: sto orientando o organizzando la mia vita intorno alla
visione del futuro che vorrei. Tuttavia, quando la scimmia che c'è in noi
vede una distinzione, vede anche un potenziale vantaggio. Innanzitutto la
scimmia identifica quale degli elementi distinguibili le conviene di più, o è
naturalmente più adatto a lei. Poi dichiara che tale elemento è superiore
all'altro. Credetemi, lo so: quella scimmia sono io.
È il secondo senso dell'avere un futuro che sembra essere caratteristico
degli uomini. Non è chiaro se gli altri animali dedichino molto tempo semmai ne dedicano - a modellare il proprio comportamento in base alla
concezione di quello che vorrebbero che fosse il loro futuro. La
gratificazione ritardata sembra essere un tratto distintivo che, pur non
essendo unicamente umano, è di certo più pronunciato nell'uomo che in
qualsiasi altro animale. E allora la scimmia dentro di noi scivola con
naturalezza da questa asserzione fattuale a una valutazione morale basata su
di essa. Il secondo senso dell'avere un futuro, pensiamo inevitabilmente, è
superiore al primo. E dato che siamo animali intelligenti, siamo in grado di
sostenere e argomentare questa valutazione morale. Nel secondo senso quello in cui organizzo me stesso e la mia vita intorno alla visione del futuro
che vorrei - io sono legato più strettamente al futuro. Possiedo il mio futuro
in un senso più forte, più intenso e più importante di qualsiasi altro animale
non umano. Immaginiamo due atleti: uno è scrupoloso e lavora sodo, l'altro
è un fannullone di talento. Entrambi perdono l'occasione della gloria
olimpica, finendo, supponiamo, appena fuori dalla zona medaglie. Il primo
atleta, la cui vita è stata foggiata da una disciplina ferrea e un'assiduità
impeccabile, sembra perdere più del secondo, il quale non si è mai
impegnato veramente. La perdita del primo atleta è maggiore perché il suo
investimento - il tempo, l'impegno, l'energia e l'emozione che ha messo in
quello che faceva - è stato superiore. Ciò che perdi quando muori è un
elemento dipendente dall'investimento che hai fatto nella vita. E gli uomini,
poiché hanno un concetto del futuro e quindi possono disciplinare,
organizzare e orientare il loro comportamento in base alla concezione del
futuro che vorrebbero, investono nella loro vita molto più degli altri
animali. La morte è peggio per un uomo che per qualsiasi altro animale. La
vita di un uomo, invece, è più importante di quella di qualsiasi altro
animale. È solo un ulteriore aspetto della superiorità umana: noi perdiamo
di più quando moriamo.
Una volta credevo anch'io a questa storia. Anzi, gli ultimi due paragrafi
sono stati sviluppati dal sottoscritto - da scimmia quale sono - in Animals
Like Us e anche, un po’ più disinvoltamente, in The Philosopher at the End
of the Universe. Oggi mi vergogno della mia mancanza di profondità di
giudizio e dei miei abietti pregiudizi scimmieschi. Investimento: quanto
scimmia si può essere? La pecca fatale, adesso me ne rendo conto, non è nel
racconto in sé. Credo che noi uomini siamo costretti a pensare alla morte
come a un danno da privazione: siamo costretti a pensare che la morte sia
un male perché ci porta via qualcosa. Non credo che abbiamo
necessariamente ragione a pensarla così, ma non credo che siamo in grado
di pensare in modo diverso. Naturalmente alcuni di noi sono convinti che la
morte non sia la fine, ma sia solo una transizione verso una nuova forma di
esistenza, una vita nell'aldilà. Chissà? Magari hanno ragione. Ma non è
questo che mi interessa. Ciò che mi interessa è capire se la fine della nostra
vita sia un male, se sia un male per la persona della cui fine stiamo
parlando. E non importa come o quando quella fine avrà luogo. Se credete
in una vita nell'aldilà, probabilmente credete nell'anima e in Dio. E Dio,
essendo onnipotente, potrebbe distruggere anche le anime. Se Dio vi facesse
una cosa del genere, quella sarebbe, presumibilmente, la vostra fine. In quel
caso, sarebbe un male? Un male per voi? È questa la domanda che mi
interessa. È il rapporto tra noi e la nostra fine il punto cruciale, qualunque
forma assuma quella fine.
Supponiamo che la storia che ho raccontato sia vera: gli uomini quando
muoiono - o quando incontrano la loro fine, quale che sia - perdono più
degli altri animali. La morte di un uomo è una tragedia più grande della
morte di un lupo. L'errore è pensare che da questo consegua che le vite
umane sono superiori. Il fatto che morendo noi perdiamo di più non è
un'indicazione della nostra superiorità: al contrario, è un indizio della nostra
dannazione. La ragione è che, incorporata in questa visione della morte, c'è
una certa concezione del tempo. E, incorporata in questa concezione del
tempo, c'è una visione del significato della vita.
La concezione del tempo alla base della visione della morte che ho
esposto è un'immagine familiare: la freccia del tempo. Il futuro è qualcosa
che noi abbiamo adesso, nel tempo presente (qualunque cosa questo
significhi) e lo abbiamo effettivamente, non come mera possibilità. E
abbiamo un futuro perché abbiamo effettivamente - adesso - situazioni che
ci orientano verso quel futuro: desideri, obiettivi, progetti. Immaginatele
come frecce dirette nel futuro. Alcune ci guidano verso il futuro solo
implicitamente: hanno bisogno di tempo per raggiungere il bersaglio. Per
soddisfare un desiderio, devi sopravvivere abbastanza a lungo perché la
freccia di quel particolare desiderio arrivi al bersaglio. I desideri dei lupi e
dei cani sono così. Alcune frecce, però, sono diverse. Alcune sono frecce
incendiarie che volano nella notte buia del futuro e illuminano quel futuro
per noi. A queste frecce corrispondono i desideri, gli obiettivi e i progetti
umani che ci guidano esplicitamente verso il futuro tramite una chiara
concezione di come quel futuro dovrà essere. La morte nuoce a qualsiasi
creatura interrompendo il volo della sua freccia dei desideri. Ma la morte
nuoce in misura maggiore alle creature le cui frecce sono incendiarie.
È con questo tipo di metafore che noi uomini cerchiamo di capire il
tempo. Pensiamo al tempo come a una freccia in volo che, dal passato,
attraversa il presente e si dirige verso il futuro. In alternativa, pensiamo al
tempo come a un fiume che scorre dal passato in direzione del futuro.
Oppure come a una nave che salpa nel passato, attraversa il presente e punta
verso un futuro lontano e sconosciuto. Noi uomini siamo presi in questo
flusso del tempo perché siamo esseri temporali. Come per altri animali, le
frecce dei desideri ci trascinano nel flusso temporale e ci consentono di
rimanervi agganciati. E, a differenza di altri animali, le nostre frecce
possono, in qualche misura, illuminare quel flusso, facendolo diventare
qualcosa che può essere visto, capito e forse plasmato.
Naturalmente queste sono tutte metafore. Solo metafore. E, per di più,
sono tutte metafore spaziali. Come osservò Kant - tra molti altri -, ogni
volta che cerchiamo di capire il tempo, torniamo sempre a un'analogia con
lo spazio. Inoltre, queste metafore comportano tutte una certa concezione di
ciò che è importante nella vita, una certa concezione del significato della
vita.
Le metafore suggeriscono una visione del significato della vita come
qualcosa verso cui dobbiamo puntare, o come una direzione nella quale
dobbiamo muoverci. Il presente scivola sempre via: nel suo volo la freccia
del tempo non fa che passare attraverso una tappa del suo percorso e
puntare alla successiva. Perciò, se il significato della vita è legato a
momenti, anch'esso non fa che scivolare continuamente via. Noi pensiamo
che il significato della vita debba essere legato ai nostri desideri, obiettivi e
progetti, dei quali deve essere un elemento dipendente. Il significato della
vita è qualcosa verso cui possiamo progredire, qualcosa da realizzare. E,
come tutte le realizzazioni importanti, non è qualcosa che può accadere
adesso, ma solo in seguito, più avanti.
Tuttavia noi sappiamo anche che più avanti lungo la linea si troverà non il
significato, ma la sua assenza. Se proseguiamo abbastanza, troviamo non il
significato, ma la morte e la decomposizione. Arriviamo al punto in cui il
volo di tutte le nostre frecce si interrompe. Troviamo la fine del significato.
Noi - tutti noi - siamo esseri- per- il- futuro, ed è in ciò che va trovata la
possibilità che la nostra vita abbia un significato. Ma siamo anche esseriperla- morte. La freccia del tempo è la nostra salvezza e, al tempo stesso, la
nostra dannazione e di conseguenza ci sentiamo attratti e, al tempo stesso,
respinti dalla sua traiettoria. Siamo creature che danno significato: la nostra
vita ha un significato che, crediamo, la vita degli altri animali non può
avere. Siamo esseri legati alla morte, esseri che seguono le tracce della
morte come nessun altro animale può fare. Sia il significato sia la fine della
nostra vita si trovano da qualche parte, più avanti lungo la linea. E quella
linea, perciò, ci affascina e, al tempo stesso, ci fa inorridire. Questa,
fondamentalmente, è la condizione esistenziale degli esseri umani.
Disse il corvo di Edgar Allan Poe: mai più. Forse «mai più» è un concetto
che i corvi padroneggiano. Ho il sospetto che i cani, invece, non lo
padroneggino. Nina amava Brenin. Era cresciuta con lui fin da quando era
cucciola. E voleva passare con lui ogni istante in cui era sveglia. Certo,
quando arrivammo in Francia, forse perfino già a Londra, Brenin ormai le
interessava molto meno di Tess. L'interesse di Nina nei confronti degli altri
cani, o lupi, era in funzione del tempo che erano disposti a dedicare alla
lotta con lei. E in Francia, ormai, Brenin non apprezzava più molto le zuffe.
In ogni caso Nina gli rimase sempre molto affezionata e lo salutava con una
grande leccata sul naso ogni volta che non lo vedeva da più di un'ora.
Fu per questo che rimasi sorpreso quando, dopo essere stato dal
veterinario, riportai a casa il corpo di Brenin. Nina gli diede un'annusata
sbrigativa e poi rivolse l'attenzione all'impegno, a quanto pareva di gran
lunga più interessante, di giocare con Tess. Brenin non c'era più: sono
sicuro che Nina l'aveva capito. Così come sono sicuro che non poteva capire
che Brenin non ci sarebbe stato mai più.
Noi uomini tendiamo a pensare che un episodio del genere dimostri la
fondamentale inferiorità dell'intelligenza degli animali. Gli animali non
possono capire la morte: solo gli uomini possono farlo. Quindi noi siamo
migliori di loro. Un tempo ci credevo anch'io. Adesso ho il sospetto che si
debba dedurre il contrario.
Supponete che per un anno vi porti ogni giorno sulla stessa spiaggia,
seguendo sempre lo stesso percorso e facendo sempre le stesse cose. Dopo
la spiaggia, vi porto ogni giorno alla stessa boulangerie, dove vi compro un
pain au chocolat: non un beignet framboise né un croissant, ma un pain au
chocolat. Ben presto, ne sono certo, mi direste: «Che cosa? Un altro pain au
chocolat! Non potevi comprarmi qualcos'altro? Almeno per una volta? Non
ne posso più dei maledetti pains au chocolat».
È così che funziona con noi uomini. Pensiamo al tempo della nostra vita
come a una linea, nei confronti della quale abbiamo un atteggiamento molto
ambivalente. Le frecce dei nostri desideri, obiettivi e progetti ci legano a
quella linea, nella quale troviamo la possibilità che la vita abbia un
significato. Ma la linea punta anche verso la morte, che si porterà via quel
significato. E quindi la linea ci attrae e contemporaneamente ci disgusta, ci
attira e ci terrorizza. È la nostra paura della linea che ci fa desiderare sempre
ciò che è diverso. Quando addentiamo il pain au chocolat, non possiamo
fare a meno di vedere tutti gli altri pains au chocolat disseminati lungo la
linea, prima e dopo. Non riusciamo mai a goderci il momento per quello che
è di per sé perché per noi il momento non è mai quello che è di per sé. Il
momento è continuamente «spostato», sia in avanti sia all'indietro. Quello
che per noi è l'adesso è costituito dai nostri ricordi di ciò che è avvenuto
prima e dalle nostre aspettative di ciò che verrà. E questo equivale a dire
che per noi non c'è un adesso. Il momento del presente è spostato,
distribuito nel tempo: il momento è irreale. Il momento ci sfugge sempre. E
quindi per noi il significato della vita non può mai essere nel momento.
Naturalmente noi - alcuni di noi - amiamo la nostra routine e i nostri
rituali. Ma bramiamo anche ciò che è diverso. Avreste dovuto vedere
l'espressione dei miei tre cani quando, ogni giorno, cominciavo a dividere i
pains au chocolat. L'attesa fremente, i fiumi di saliva, la concentrazione così
intensa da essere quasi dolorosa. Per quanto li riguardava, avrebbe potuto
essere pain au chocolat da qui all'eternità. Per loro, il momento in cui le
mascelle si chiudevano sul pain au chocolat era completo in se stesso, non
contaminato da qualsiasi altro momento disseminato nel tempo. Non poteva
essere né accresciuto, né sminuito da ciò che era successo prima e da ciò
che doveva ancora succedere. Per noi, invece, nessun momento è completo
in se stesso. Ogni momento è adulterato, inquinato da ciò che ricordiamo e
da ciò che ci aspettiamo. In ogni momento della nostra vita la freccia del
tempo ci mantiene «verdi e morenti». È questa la ragione per cui crediamo
di essere superiori a tutti gli altri animali.
Nietzsche parlò di eterno ritorno, o eterno ritorno dell'uguale. Ci sono due
modi diversi, ma reciprocamente compatibili, di interpretare Nietzsche.
Come minimo, Nietzsche flirtò con uno di questi modi e abbracciò con
convinzione l'altro. Potremmo definire il primo come l'interpretazione
metafisica dell'eterno ritorno. In questo contesto, il termine «metafisico»
indica una descrizione di come le cose sono realmente. Quindi vedere
l'eterno ritorno come una dottrina metafisica significa pensare che descriva
qualcosa che sta effettivamente per accadere - o, se è per questo, che è già
accaduta - un infinito numero di volte. Se pensate che l'universo sia
costituito da un numero finito di particelle - atomi o particelle subatomiche , allora queste particelle entreranno solo in un numero finito di
combinazioni. Nietzsche di fatto riteneva l'universo composto da un numero
finito di quanti d'energia, ma, dato che questi erano capaci di combinazioni
e ricombinazioni, il punto essenziale rimane lo stesso. Se pensate anche che
il tempo sia infinito, ne consegue che le medesime combinazioni di
particelle o di quanti d'energia devono ripetersi. Anzi, devono ripetersi in
continuazione. Ma voi, e il mondo intorno a voi, e gli eventi che hanno
costituito la vostra vita sono solo, in definitiva, combinazioni di particelle.
Così, a quanto pare, voi, il vostro mondo e la vostra vita dovrete ripetervi in
continuazione. Se il tempo è infinito, allora dovete ripetervi in eterno.
Questo modo di pensare l'eterno ritorno è discutibile, in quanto si basa sui
presupposti che l'universo sia finito e che il tempo sia infinito. Se rifiutate
questi presupposti - se ritenete, per esempio, che il tempo sia stato creato
con l'universo e muoia con esso - allora la tesi non regge. Nietzsche flirtò
con questa interpretazione dell'eterno ritorno, ma non la avallò mai
esplicitamente nei suoi lavori pubblicati.
Ciò che invece avallò fu quella che potremmo definire l'interpretazione
esistenziale dell'eterno ritorno. Su questa interpretazione, l'idea dell'eterno
ritorno ci fornisce una sorta di test esistenziale. Nella Gaia scienza
Nietzsche lo descrive così:
Il peso più grande. Che accadrebbe se, un giorno o una notte, un demone
strisciasse furtivo nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse: «Questa
vita, come tu ora la vivi e l'hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e
ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma
ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e ogni cosa
indicibilmente piccola e grande della tua vita dovrà fare ritorno a te, e tutte
nella stessa sequenza e successione - e così pure questo ragno e questo lume
di luna tra gli alberi e così pure questo attimo e io stesso. L'eterna clessidra
dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta - e tu con essa, granello di
polvere!». - Non ti rovesceresti a terra, digrignando i denti e maledicendo il
demone che così ha parlato? Oppure hai forse vissuto una volta un attimo
immane, in cui questa sarebbe stata la tua risposta: «Tu sei un dio, e mai
intesi cosa più divina!»? Se quel pensiero ti prendesse in suo potere, a te,
quale sei ora, farebbe subire una metamorfosi, e forse ti stritolerebbe ...
Qui l'eterno ritorno è presentato non come una descrizione del mondo, ma
come qualcosa che devi chiedere a te stesso, se vuoi capire come sta
andando la tua vita e che tipo di persona sei. Innanzitutto, per dirla con
Nietzsche, ogni gioia vuole eternità. Se la tua vita sta andando bene, sarai
molto più incline ad abbracciare l'idea che si ripeta in continuazione. Per
contro, se la vita non ti sta andando bene, probabilmente considererai tale
idea con orrore. È una constatazione più ovvia che profonda. Ciò che è
meno ovvio, forse, è il modo in cui reagisci all'informazione rivelata dal
demone.
Supponiamo che qualcuno ti chieda: «Con chi vuoi trascorrere
l'eternità?». Tra parentesi, avrebbe potuto essere questa la domanda sulle
labbra dei testimoni di Geova che, molti anni fa, commisero l'errore di
bussare alla nostra porta di casa a Knockduff. Brenin e Nina erano con me
nel giardino sul retro e partirono alla carica verso la porta davanti per
vedere chi c'era. Quando arrivai anch'io, trovai uno dei testimoni in lacrime,
con la faccia rivolta verso il muro, mentre Brenin e Nina lo annusavano con
espressione preoccupata. Non scoprii mai che cosa avessero avuto
intenzione di chiedermi i testimoni di Geova quel giorno: si congedarono
molto in fretta. Ma noi naturalmente diamo una connotazione religiosa alla
domanda: «Con chi vuoi trascorrere l'eternità?». L'eternità è la vita
nell'aldilà, la quale non è che la continuazione della linea della nostra vita
dopo il decesso del corpo fisico. Ciò che a volte tralasciamo in questo
quadro è l'unica persona che in quell'eternità non potrai evitare: te stesso.
Perciò la domanda che la religione ci rivolge è: «Sei sicuro di essere una
persona con cui vorresti passare l'eternità?». E questa è una bella domanda.
Nietzsche, comunque, la rende molto più pressante. Se l'eternità è una
continuazione della linea della nostra vita, allora qualunque progresso
esistenziale noi facciamo in questa vita potremo continuare a farlo nella
prossima. Se la vita è un viaggio di formazione dell'anima - una teodicea di
formazione dell'anima - allora il viaggio può continuare anche dopo la
morte del corpo. Ma supponiamo che ci sia solo questa vita. Supponiamo
che la vita non sia una linea. Supponiamo che il tempo sia un cerchio e che
la vita si ripeta in continuazione, ritornando eternamente come descritto dal
demone di Nietzsche. Tu sei sempre la persona con cui dovrai trascorrere
l'eternità, ma ora l'eternità è un cerchio, non una linea, e quindi non hai
ulteriori possibilità di migliorare o perfezionare te stesso. Qualunque cosa tu
faccia, devi farla adesso.
Se sei forte, pensava Nietzsche, farai adesso ciò che senti di dover fare.
Se, come diceva lui, la tua vita e il tuo spirito sono in ascesa, allora adesso
vorrai fare di te stesso il tipo di persona con cui vorresti trascorrere
l'eternità. Ma se sei debole, se il tuo spirito è in declino - se sei stanco -, ti
rifugerai nella dilazione, nell'idea che potrai sempre fare ciò che devi fare
più tardi, nella vita che deve ancora venire.
L'eterno ritorno, quindi, è un modo per valutare se sei uno spirito in
ascesa o in declino. È questo che intendevo dire affermando che si tratta di
un test esistenziale.
Tuttavia l'idea dell'eterno ritorno fa un'altra cosa, e io credo che sia la più
importante: mina la concezione del significato della vita che la concezione
del tempo come linea implica. Se pensiamo al tempo come a una linea,
pensiamo naturalmente al significato della vita come a qualcosa verso cui
dobbiamo tendere, qualcosa da conseguire più avanti lungo quella linea.
Ogni momento scivola via, per cui non è possibile trovare il significato
della vita nel momento. Inoltre il significato di ogni singolo momento
deriva dalla sua posizione sulla linea: il suo significato consiste nel modo in
cui si rapporta a quanto è successo prima, che esiste ancora sotto forma di
ricordo, e a quanto deve ancora venire, che esiste sotto forma di aspettativa.
Ogni momento è sempre contaminato dai fantasmi del passato e del futuro.
Di conseguenza nessun momento è completo in se stesso: il contenuto e il
significato di ogni momento è differito e distribuito lungo la linea della
freccia del tempo.
Ma se il tempo è un cerchio e non una linea, se la nostra vita è destinata a
ripetersi in continuazione, allora il significato della vita non può consistere
in una progressione verso un punto decisivo lungo quella linea. Non c'è un
punto del genere perché non c'è una linea del genere. I momenti non
scivolano via: al contrario, si ripresentano in continuazione, senza fine. Il
significato di ogni momento non deriva dalla sua collocazione su una linea,
da come si rapporta con ciò che viene prima e con ciò che viene dopo lungo
quella linea. Non è contaminato da fantasmi passati e futuri. Ogni momento
è ciò che è: ogni momento è completo e intero di per sé.
Ora il significato della vita è completamente diverso. Invece di trovarsi in
questo o quel punto decisivo della linea, o in un tratto decisivo della linea, il
significato della vita si trova nei momenti: certo, non in tutti i momenti, ma
solo in alcuni. Il significato della vita di un individuo può essere
disseminato lungo tutta quella vita, come i chicchi di orzo sparsi nei campi
di Knockduff al tempo del raccolto. Il significato della vita può essere
trovato nei suoi momenti più alti, ognuno dei quali è completo in se stesso e
non ne richiede altri per avere un significato o una giustificazione.
Una cosa che ho imparato dall'ultimo anno di vita di Brenin è che i lupi, e
anche i cani, superano il test esistenziale di Nietzsche in un modo che
raramente riesce agli uomini. Un essere umano avrebbe detto: «Non la
solita, vecchia passeggiata anche oggi! Non possiamo andare da qualche
altra parte, tanto per cambiare? Sono arcistufo della spiaggia. E non darmi
un altro pain au chocolat: ormai sono diventato un pain au chocolat
anch'io!». E così via. Di volta in volta affascinati e disgustati dalla freccia
del tempo, il nostro disgusto ci spinge a cercare la felicità in ciò che è nuovo
e diverso, in qualsiasi deviazione dalla freccia del tempo. Ma la nostra
passione per la freccia significa che qualsiasi deviazione dalla sua linea
semplicemente crea una nuova linea, e la nostra felicità adesso pretende che
anche noi deviamo da quella linea. La ricerca umana della felicità è di
conseguenza regressiva e vana. E alla fine di ogni traiettoria c'è solo il mai
più. Mai più la sensazione del sole sul viso. Mai più la visione del sorriso
sulle labbra della persona che si ama, o dello scintillio nei suoi occhi. La
nostra concezione della vita e del suo significato è organizzata intorno a una
visione di perdita. Nessuna meraviglia che la freccia del tempo ci faccia
orrore e, al tempo stesso, ci affascini. Nessuna meraviglia che cerchiamo di
trovare la felicità nel nuovo e nell'insolito, in qualsiasi deviazione, per
quanto piccola, dalla linea della freccia. Forse la nostra ribellione è solo un
inutile spasmo, ma è certamente comprensibile. La nostra comprensione del
tempo è la nostra dannazione. Wittgenstein aveva torto, in modo sottile ma
decisivo. La morte non è il limite della mia vita. Ho sempre portato la mia
morte con me.
Il tempo dei lupi, suppongo, è un cerchio, non una linea. Ogni momento
della loro vita è completo in se stesso.
E la felicità, per loro, si trova sempre nell'eterno ritorno dell'uguale. Se il
tempo è un cerchio, non esiste il mai più. E, di conseguenza, l'esistenza di
ogni individuo non è organizzata intorno alla visione della vita come un
processo di perdita. Durante l'ultimo anno di Brenin, la regolarità e la
ripetizione nelle nostre vite mi consentirono di intravedere, in modo fugace
e indistinto, l'eterno ritorno dell'uguale. Dove non c'è un senso del mai più,
non c'è alcun senso di perdita. Per un lupo o per un cane la morte è
veramente il limite di una vita. E per questa ragione «la morte non avrà
dominio» su di loro. Questo, mi piace pensare, è ciò che è essere un lupo o
un cane.
Adesso capisco perché Nina si limitò a dare solo un'annusata superficiale
a Brenin, anche se l'aveva amato forse più di qualsiasi altra cosa al mondo.
Di tutti noi Nina era quella che comprendeva meglio il tempo. Era la
custode del tempo, la zelante guardiana dell'eterno ritorno dell'uguale. Ogni
giorno sapeva esattamente quando erano le sei del mattino e quando dovevo
trascinarmi fuori dal letto e cominciare a lavorare. Ogni giorno sapeva al
secondo quando erano le dieci del mattino e mi posava la testa in grembo
per dirmi che era ora di smettere di scrivere e di andare in spiaggia. Sapeva
quando era ora di andarcene dalla spiaggia per arrivare alla boulangerie
prima che chiudesse per pranzo. Ogni giorno, che fosse in vigore l'ora solare
o quella legale, Nina sapeva esattamente quando erano le sette di sera e
doveva essere servita la cena e poi quando era ora di andare alla Réunion
per il dessert. Preservare e garantire l'eterno ritorno dell'uguale era la sua
missione della vita. Per Nina niente poteva cambiare, niente poteva essere
diverso. Capiva che l'autentica felicità si trova solo in ciò che è uguale, in
ciò che non cambia, in ciò che è eterno e immutabile. Nina capiva che è la
struttura a essere reale, non le contingenze. Capiva che ogni gioia vuole
eternità, che se hai detto sì a un momento, hai detto sì a tutti i momenti. La
sua vita era una dimostrazione dell'irrilevanza del mai più.
Nove. La religione del lupo
Noi vediamo attraverso i momenti ed è per questa ragione che il momento
ci sfugge. Un lupo vede il momento, ma non può vederci attraverso. La
freccia del tempo gli sfugge. È questa la differenza tra gli uomini e i lupi.
Noi ci rapportiamo al tempo in maniera diversa. Siamo creature temporali in
un modo in cui né i lupi né i cani lo sono. Anzi, secondo Heidegger, la
temporalità, come la chiamava, è l'essenza degli esseri umani. Non mi
interessa la domanda di che cosa sia realmente il tempo. Se è per questo,
non interessava neppure a Heidegger. Nonostante le dichiarazioni di alcuni
scienziati, nessuno sa che cosa sia realmente il tempo e sospetto che
nessuno lo saprà mai. È l'esperienza del tempo che è cruciale per noi.
In realtà questo non è del tutto esatto. È la mia formazione filosofica che
mi spinge a cercare distinzioni nette dove non ce ne sono. La filosofia è un
atto di potere - qualcuno direbbe di arroganza - con cui tentiamo di imporre
distinzioni e divisioni a un mondo che in realtà non le accetta e non è adatto
ad accettarle. Il mondo è troppo scivoloso. Ho il sospetto che, invece delle
differenze che vorremmo trovare, ci siano meramente diversi gradi di
somiglianza e di differenza. Il lupo è una creatura tanto del tempo quanto
del momento. Il punto è che noi siamo più creature del tempo, e meno del
momento, di quanto sia il lupo. Siamo migliori di lui nel guardare attraverso
i momenti. E il lupo è migliore di noi nel guardare i momenti. Il lupo è
abbastanza vicino a noi perché noi capiamo sia cosa guadagniamo sia cosa
perdiamo per questo. Se un lupo potesse parlare, io credo che potremmo
capirlo.
La scimmia che è in noi è rapida nel trasformare qualsiasi differenza a
proprio vantaggio: qualsiasi differenza descrittiva viene subito trasformata
in valutativa. La scimmia ci dice che siamo migliori del lupo perché siamo
più abili nel guardare attraverso il momento, dimenticando opportunamente
che il lupo è migliore di noi nel guardare il momento. Se vivere con Brenin
mi ha insegnato una cosa, è che la superiorità è tale sempre e solo in un
determinato ambito. Inoltre, quella particolare superiorità probabilmente
risulterà essere una deficienza altrove.
La temporalità - vivere il tempo come una linea che dal passato punta al
futuro - comporta certi vantaggi, ma anche certi svantaggi. Ci sono molte
scimmie pronte a esaltare i vantaggi della temporalità. Scopo di questa
particolare scimmia è richiamare l'attenzione sullo svantaggio: non
riusciamo a comprendere il significato della nostra vita e, proprio per questa
ragione, troviamo così difficile essere felici.
Durante le ultime settimane di vita di Brenin, lui e io facemmo qualcosa
insieme che mi fece capire che cosa significa essere una creatura del
momento piuttosto che una creatura del tempo, una creatura, cioè, più adatta
a guardare i momenti piuttosto che attraverso i momenti. Ormai sapevo che
Brenin stava per morire, o almeno lo sapevo a livello intellettuale, dato che
rifiutavo decisamente di affrontare l'idea sul piano emotivo. Decisi che
Brenin aveva bisogno di qualche giorno di pausa da Nina e Tess. Quelle due
lo infastidivano in continuazione, anche quando cercava di dormire, cosa
che, negli ultimi tempi, faceva per gran parte della giornata. Non era colpa
delle «ragazze». Non potevo portarle a fare una passeggiata, perché avrei
dovuto lasciare Brenin da solo. E proprio non me la sentivo. Me lo
immaginavo tentare di alzarsi in piedi, faticosamente ma con
determinazione, sollecitato dall'eccitazione rumorosa di Nina e Tess, e poi
restare disperatamente deluso quando gli avessi detto che non poteva venire
con noi. E non avevo intenzione di fargli trascorrere i suoi ultimi giorni in
quel modo. Perciò nelle ultime settimane Nina e Tess erano state confinate
in giardino e in casa e, comprensibilmente, erano sempre più irrequiete.
Pensai che a Brenin avrebbe fatto bene una pausa e così portai Nina e Tess
alla pensione per cani di Issanka, un paese a circa un'ora d'auto in direzione
Montpellier. Le avrei lasciate là per qualche giorno, in modo che il mio lupo
potesse godersi un po’ di buon riposo.
Quando Brenin e io tornammo a casa - naturalmente lui aveva insistito
per venire con noi a Issanka - si verificò una strana, graduale
trasformazione. Il buon riposo sembrava essere l'ultima cosa che aveva in
mente. Cominciò a seguirmi in giro per casa, saltellando e uggiolando,
contento ed eccitato. E quando mi preparai un piatto di spaghetti, volle la
sua parte: una cosa che non faceva da molto, molto tempo. Così gli chiesi:
«Vuoi andare a fare una passeggiata?». La sua reazione non fu esattamente
quella del Buffalo Boy dei vecchi tempi, ma fu comunque sorprendente:
saltò sul divano e cominciò a ululare, confermando che, sì, voleva fare una
passeggiata. Pensavo di fare due passi tranquilli fino alla diga, dove
avremmo passeggiato per poche centinaia di metri. Ma quando arrivai al
cancello, Brenin stava saltando e correndo avanti e indietro lungo il fossato
che ci separava dalla riserva naturale. A quel punto feci una cosa a cui
ancora oggi stento a credere.
Non correvo da subito dopo che ci eravamo trasferiti in Francia, più di un
anno prima. Ci avevo provato appena arrivati, ma avevo constatato che,
dopo i primi due o tre chilometri, Brenin cominciava a restare molto
indietro rispetto a noi e la cosa non lo rendeva per niente felice. Era
diventato vecchio senza che me ne accorgessi. Così le corse erano diventate
passeggiate, punteggiate dalle nuotate e dalle spedizioni alla boulangerie e
alla Réunion. E non avevo neppure praticato altre forme di esercizio fisico.
All'arrivo in Francia avevo comprato una serie di pesi e una panca, ma solo
raramente ero riuscito a convincermi a utilizzare quegli attrezzi che per la
maggior parte del tempo se ne stavano abbandonati in terrazza ad
arrugginire lentamente e a ricordarmi quanto mi ero lasciato andare.
Se Brenin era diventato più vecchio e più debole, ero diventato più
vecchio e più debole anch'io. Succede spesso quando vivi con dei cani.
Avevo trascorso la maggior parte del mio anno francese in una sorta di
prematuro pensionamento, scrivendo un po', ma soprattutto passando una
notevole quantità di tempo con i piedi a mollo nel vino giovane. Nina e
Tess, naturalmente, erano ancora in grado di fare lunghe corse, ma Brenin
no e di conseguenza si passeggiava solamente. E quindi, a causa del modo
bizzarro in cui la composizione delle nostre vite si era intrecciata, il declino
fisico di Brenin si rispecchiava nel mio. Adesso, in piedi davanti a casa,
guardai il mio lupo correre avanti e indietro lungo il fossato e gli dissi:
«Forza, proviamoci, figliolo. Un ultimo urrà per i ragazzi Rowlands. Che
cosa ne dici?». Ripescai i miei calzoncini e andammo a correre. Tenevo
attentamente d'occhio Brenin, convinto che si sarebbe stancato molto presto.
In quel caso l'avrei riportato subito a casa. Ma non si stancò. Dovevamo
essere proprio un bel quadretto, noi due: un lupo morente e un uomo ormai
prossimo ai quarant'anni e irreparabilmente fuori forma. Corremmo
attraverso il bosco fino al Canal du Midi, dove continuammo a correre
all'ombra dei faggi giganti che fiancheggiano le sponde del canale. Brenin
era accanto a me e teneva agevolmente il mio ritmo. Poi tagliammo
attraverso la riserva naturale, seguendo i campi popolati dai tori neri e dai
pony bianchi delle fattorie fino alla diga. Brenin non era ancora stanco.
Sembrava quello di un tempo e, come un fantasma, scivolava senza sforzo
sul terreno, quasi fluttuando a quattro o cinque centimetri da terra, mentre
accanto a lui arrancavo io, la sua scimmia pesante, sbuffante e sgraziata.
Chissà? Forse aveva semplicemente voglia di restare da solo con me per po'.
Forse voleva dirmi addio e non poteva farlo nel modo dovuto, con Nina e
Tess tra i piedi. Qualunque fosse la ragione, quel giorno vide un netto
miglioramento di Brenin, in termini sia di energia sia di comportamento. E
la situazione non cambiò più sostanzialmente: neppure il ritorno a casa di
Nina e Tess, qualche giorno dopo, la modificò. Non andammo più a correre
insieme - Brenin non raggiunse più i livelli d'energia di quella mattina -, ma
facevamo una passeggiata quasi tutti i giorni. Lui stava bene. E si sentì bene
quasi fino al giorno in cui morì.
Non posso fare a meno di paragonare Brenin a me, se fossi stato io ad
avere un cancro. Per lui il cancro era un'afflizione del momento. In un certo
momento si sentiva bene. In un altro momento, un'ora dopo, stava male. Ma
ogni momento era completo in se stesso e non aveva alcuna relazione con
nessun altro momento. Per me il cancro sarebbe un'afflizione del tempo,
non del momento. L'orrore del cancro - l'orrore di qualsiasi grave malattia
umana - sta nel fatto che la malattia si spande nel tempo. L'orrore consiste
nel fatto che interromperà le frecce dei nostri desideri, obiettivi e progetti. E
noi lo sappiamo. Io sarei rimasto a casa a riposare. Sarei rimasto a casa a
riposare anche se, in quel momento, mi fossi sentito benissimo. È questo
che fai, quando hai il cancro. Dato che siamo creature temporali, le malattie
gravi sono disgrazie temporali. Il loro orrore risiede in ciò che fanno nel
tempo, non in ciò che fanno in un determinato momento. Ed è per questo
che su di noi hanno un dominio che non possono avere su una creatura del
momento.
Il lupo prende ogni momento per quello che è. Ed è questo che noi
scimmie troviamo così difficile da fare. Per noi ogni momento è
indefinitamente differito. Ogni momento ha un significato che dipende dalla
sua relazione con altri momenti e un contenuto che è irrimediabilmente
contaminato da tali momenti. Noi siamo creature del tempo, i lupi sono
creature del momento. I momenti, per noi, sono trasparenti. Ci passiamo
attraverso con la mano quando cerchiamo di impossessarci di qualcosa.
Sono diafani. Non sono mai del tutto reali. Non ci sono. I momenti sono i
fantasmi del passato e del futuro, gli echi e le anticipazioni di quello che è
stato e di quello che potrà essere.
Nella sua classica analisi della percezione del tempo, Edmund Husserl
sostenne che il presente, ciò che definiamo «ora», può essere scomposto in
tre diverse componenti derivanti dall'esperienza. C'è, in parte, l'esperienza
di ciò che definiva l"«ora originario». Ma nella nostra normale
consapevolezza del tempo tale esperienza è inevitabilmente modellata sia
dalle anticipazioni del probabile corso futuro dell'esperienza, che Husserl
chiamava «protensioni», sia dai ricordi del recente passato, che chiamava
«ritenzioni». Per capire che cosa intendesse Husserl, prendete qualcosa a
portata di mano. Supponiamo che prendiate un bicchiere di vino.
Presumibilmente lo percepite come un bicchiere. Tuttavia le vostre dita non
toccano tutto il bicchiere, ma solo una sua parte. Anche così, avete
comunque la sensazione di avere un intero bicchiere in mano, e non parti di
un bicchiere. L'esperienza del bicchiere in mano non è condizionata dai
limiti della mano che vi permette di vivere quell'esperienza. Perché?
Secondo Husserl, è perché l'esperienza di reggere il bicchiere un'esperienza di qualcosa che state facendo «ora» - è costituita da
anticipazioni di come l'esperienza cambierà in determinate circostanze e da
ricordi di come è cambiata nel recente passato. Per esempio, prevedete che,
facendo scivolare le dita verso il basso, avvertirete un restringimento del
vostro campo d'azione tattile, dovuto al fatto che state reggendo il bicchiere
dallo stelo e non dalla coppa. Parimenti, potreste ricordare che quando,
alcuni istanti prima, avete fatto scorrere le dita verso il basso, la vostra
esperienza si è modificata in quello stesso modo. Perfino un'esperienza
dell"«ora», sosteneva Husserl, è inestricabilmente legata a esperienze del
passato e del futuro.
Tutto questo, ne sono sicuro, vale per i lupi come per gli uomini. Non
viviamo mai l"«ora» come tale: l"«ora originario» è un'astrazione e non
corrisponde a nulla che si possa mai incontrare nell'esperienza. Quello che
definiamo «ora» è in parte passato e in parte futuro. Ma le differenze di
grado possono essere importanti quanto le differenze di genere. Noi uomini
abbiamo portato ciò a un livello completamente nuovo. Gran parte della
nostra vita trascorre vivendo nel passato o nel futuro. Forse, se ci proviamo
con sufficiente convinzione, riusciamo a vivere l"«ora» in modo abbastanza
simile a quello di un lupo, cioè come qualcosa sovrascritto solo in minima
misura dalle ritenzioni del passato e dalle protensioni del futuro. Ma non è
questo il nostro modo abituale di affrontare il mondo. In noi, e nella nostra
normale esperienza del mondo, l"«ora» è stato cancellato e si è
accartocciato nel nulla.
Ci sono molti svantaggi nell'essere una creatura temporale, alcuni
evidenti, altri meno. Uno svantaggio evidente è che trascorriamo una
grande, forse sproporzionata quantità di tempo fissandoci su un passato che
non c'è più e su un futuro che deve ancora venire. Il passato che ricordiamo
e il futuro che desideriamo plasmano in modo decisivo ciò a cui noi
assurdamente ci riferiamo come al qui e ora. Le creature temporali possono
essere nevrotiche in un modo in cui le creature del momento non saranno
mai.
La temporalità, però, presenta anche altri svantaggi, più sottili e più
importanti. C'è una sorta di rovina temporale a cui sono soggetti solo gli
uomini, perché solo gli uomini vivono abbastanza nel passato e nel futuro
da consentire il manifestarsi di tale afflizione. Poiché siamo più bravi a
guardare attraverso i momenti piuttosto che a guardare i momenti stessi poiché siamo animali temporali -, vogliamo che la nostra vita abbia un
significato e, al tempo stesso, non riusciamo a capire come possa averlo. Il
dono della temporalità per noi è il desiderio di ciò che non possiamo capire.
Sisifo era un mortale che aveva offeso gli dèi. In che modo esattamente
non si sa e le versioni divergono. Forse la più popolare è quella secondo la
quale Sisifo, dopo la morte, convinse Ade a permettergli di tornare
temporaneamente sulla terra per una certa missione urgente, promettendo di
fare ritorno non appena portato a termine il suo compito. Ma dopo avere
visto di nuovo la luce del giorno e sentito sul viso il calore del sole, Sisifo
non se la sentì più di tornare nell'oscurità degli inferi. E infatti non ci tornò.
Ignorando i numerosi avvertimenti e incurante degli ordini espliciti, riuscì a
vivere molti altri anni nella luce. Ma alla fine, in seguito a un decreto degli
dèi, venne ricondotto a forza nell'Ade, dove era già pronto il suo masso.
La punizione di Sisifo consisteva infatti nello spingere un enorme masso
fino alla sommità di un'altura. Completata l'operazione, dopo molti giorni,
settimane o addirittura mesi di estenuante lavoro, il masso rotolava giù, fino
alla base dell'altura, e Sisifo doveva ricominciare da capo la sua fatica. E
questo per l'eternità. Si tratta di una punizione davvero orribile,
caratterizzata da una crudeltà di cui forse solo gli dèi possono essere capaci.
Ma in cosa consiste esattamente l'orrore?
Il modo in cui di solito il mito viene raccontato enfatizza la difficoltà
della fatica di Sisifo. Il masso è tipicamente descritto come pesantissimo, di
dimensioni tali da poter essere a malapena spostato. Così ogni passo in
salita sulla collina mette a durissima prova il cuore, i nervi e i muscoli di
Sisifo, portandoli al limite. Ma, come ha osservato Richard Taylor, è dubbio
che il vero orrore della punizione sia nella difficoltà del compito.
Supponiamo che, invece di un grosso masso, gli dèi avessero dato a Sisifo
un sassolino, così piccolo da poter essere messo in tasca. In quel caso Sisifo
avrebbe potuto salire fino alla vetta con una comoda passeggiata. Avrebbe
guardato il sassolino rotolare giù e avrebbe ricominciato il suo lavoro.
Nonostante la natura molto meno ardua del compito, penso che l'orrore della
punizione sarebbe risultato ben poco mitigato.
Noi siamo gli animali che pensano che nella vita la cosa più importante
sia la felicità. Perciò siamo fortemente tentati di immaginare che l'orrore
della punizione di Sisifo consista nel fatto che lui la odia: la punizione lo
rende molto infelice. Ma io credo che neppure questa ipotesi sia corretta.
Possiamo solo presumere che Sisifo maledica il suo destino. Tuttavia
supponiamo che gli dèi fossero meno vendicativi di come vengono
rappresentati nel mito. Anzi, supponiamo che avessero preso provvedimenti
per mitigare l'infelicità della loro vittima, provvedimenti miranti a
riconciliare Sisifo con il suo destino. E che l'avessero fatto instillando in
Sisifo un'irrazionale, ma comunque intensa compulsione a spingere massi
fino in cima alle alture. Non preoccupiamoci più di tanto del modo in cui
l'hanno fatto: è il risultato che è importante. E il risultato è che Sisifo adesso
è felice solo quando spinge massi verso la cima delle alture. Se non gli
consentono di spingere massi, si sente decisamente frustrato, addirittura
depresso. E così la pietà degli dèi si concretizza nel costringere Sisifo a
desiderare, anzi a bramare con tutto il cuore, proprio la punizione che gli
stessi dèi gli hanno inflitto. L'unico, autentico desiderio di Sisifo è spingere
massi e la soddisfazione di quel desiderio gli viene garantita per l'eternità.
La pietà degli dèi è indubbiamente perversa, ma è comunque pietà.
Anzi, è una pietà così totale che forse non ha più senso considerare la
fatica di Sisifo come una punizione. Semmai, sembra più un premio che un
castigo. Se felicità significa sentirsi bene, avere la sensazione che la vita e
tutto quanto c'è nella vita sia meraviglioso, la nuova situazione esistenziale
di Sisifo sembra ottimale. Nessuno potrebbe essere più felice di lui, al quale
è garantita l'eterna realizzazione del suo desiderio più profondo. Se ciò che
nella vita ha maggiore importanza è la felicità, allora dovrebbe essere
impossibile immaginare una vita migliore di quella di Sisifo.
A me pare però che l'orrore della punizione non venga minimamente
attenuato dalla pietà degli dèi. A volte i premi degli dèi possono essere
peggiori dei castighi. Secondo me, dovremmo sentirci dispiaciuti per Sisifo
addirittura più di prima. Prima della «pietà» degli dèi, Sisifo possedeva
almeno una sorta di dignità. Esseri potenti ma crudeli gli hanno imposto il
suo destino. Sisifo si rende conto dell'inutilità della sua fatica. La compie
perché costretto. Non può fare niente altro, neppure morire. Ma riconosce
l'inutilità del suo compito e disprezza gli dèi che gliel'hanno imposto.
Questa dignità viene perduta nel momento in cui gli dèi si mostrano pietosi.
Ora il nostro disprezzo - forse venato di compassione, ma comunque
disprezzo - deve indirizzarsi tanto a Sisifo quanto agli dèi che lo hanno
trasformato in quel modo: Sisifo lo scemo, Sisifo l'illuso, Sisifo lo stupido.
Forse durante i lunghi, faticosi andirivieni dall'altura, Sisifo a volte ricorda
vagamente i tempi precedenti la pietà degli dèi. Forse si sente chiamare da
una qualche piccola, silenziosa voce dalle acque stagnanti della sua anima.
E forse allora, per un attimo, capisce, grazie a echi e sussurri, che cosa gli è
successo. E si rende conto di essere sminuito. Capisce di avere perso
qualcosa d'importante, di più importante dell'attuale felicità. La pietà degli
dèi l'ha privato della possibilità che la sua vita - o piuttosto la sua vita
ultraterrena - sia qualcosa di più di uno scherzo perverso. Proprio questa
possibilità è più importante della sua felicità.
Dubito che noi uomini siamo il tipo di animale che può essere felice,
almeno non nel modo in cui pensiamo alla felicità. Il calcolo - i nostri
complotti e inganni scimmieschi - ci è penetrato troppo in profondità
nell'anima per permetterci di essere felici. Inseguiamo le sensazioni che
accompagnano il successo delle nostre macchinazioni e menzogne e
rifuggiamo da quelle che ne accompagnano il fallimento. Non facciamo in
tempo a centrare un bersaglio che siamo già alla ricerca del successivo.
Siamo sempre alla ricerca di qualcosa di più e di meglio e la felicità, di
conseguenza, ci scivola continuamente di mano. La sensazione - è questo
che riteniamo essere la felicità - è una creatura del momento. Ma per noi il
momento non c'è, ogni momento è costantemente differito. Quindi non può
esserci felicità per noi.
Ma se non altro adesso possiamo comprendere la nostra ossessione per le
sensazioni: è il sintomo di qualcosa di molto più profondo. Il pensiero
assillante di doversi sentire in un certo modo - l'idea ampiamente diffusa
che sia questo ciò che nella vita è più importante - è un tentativo di
reclamare qualcosa che il nostro vivere nel passato e nel futuro ci ha
sottratto: il momento. Questo, per noi, non è più una possibilità reale. Ma
anche se potessimo essere felici, anche se fossimo quel tipo di creatura per
cui la felicità è una possibilità reale, non sarebbe questo il punto.
Il vero orrore della punizione di Sisifo non sta ovviamente né nella sua
difficoltà, né nel fatto che rende Sisifo così disperatamente infelice. L'orrore
consiste tutto nell'assoluta inutilità della punizione. Non si tratta
semplicemente del fatto che la fatica di Sisifo non produce alcun risultato.
Può capitarvi di dovere svolgere un compito significativo e di non riuscire a
portarlo a termine con successo. I vostri sforzi non hanno portato a nulla e
questo può essere motivo di tristezza e rimpianto. Ma non c'è orrore.
L'orrore della fatica di Sisifo - che sia facile o difficile, che a Sisifo piaccia
o che la detesti - non è nel fallimento dell'impresa, ma nel fatto che non c'è
niente che possa essere considerato come successo. Che Sisifo riesca a
portare il masso in cima all'altura o meno, il masso rotolerà comunque di
sotto e il lavoro dovrà ricominciare da capo. La fatica di Sisifo è inutile.
Non mira a nulla. Il suo compito è sterile quanto il masso.
Questa osservazione potrebbe indurci a pensare che, se solo potessimo
trovare uno scopo alla fatica di Sisifo, il problema sarebbe risolto. Sarebbe
lo scopo, piuttosto che la felicità, la cosa più importante da trovare nella
vita, che sia la vita di Sisifo o di chiunque altro. Ma, ancora una volta, non
credo che questa visione sia corretta. Per capire perché, supponiamo che ci
fosse un senso nella fatica di Sisifo. Supponiamo che ci fosse un obiettivo
verso il quale erano indirizzati i suoi sforzi. Il masso, invece di rotolare giù
dall'altura, restava al suo posto sulla vetta. E le discese di Sisifo non
avevano più lo scopo di recuperare lo stesso masso, ma di raccoglierne ogni
volta uno diverso. L'ordine degli dèi, adesso, è costruire un tempio bello e
imponente, un tributo adeguato, per come la vedono gli dèi, al loro potere e
alla loro magnificenza. Supponiamo anche che, essendo pietosi, gli dèi
abbiano inculcato in Sisifo il desiderio intenso di fare esattamente quello.
Dopo anni e anni di atroce e spaventosa fatica, immaginiamo che sia
riuscito a portare a termine il suo compito. Il tempio è finito. Sisifo può
finalmente riposarsi e guardare soddisfatto il frutto del suo lavoro. Resta
solo una domanda: e adesso?
È qui il problema. Se pensate che ciò che importa di più nella vita sia un
obiettivo o uno scopo, allora non appena quello scopo è stato raggiunto la
vostra vita non ha più significato. Così come nella versione originale del
mito l'esistenza di Sisifo non ha significato perché non ha scopo, così, nella
nostra rivisitazione, l'esistenza di Sisifo perde qualsiasi significato abbia
avuto non appena lo scopo viene raggiunto. La sua vita in cima a quella
montagna, con lo sguardo fisso per sempre su un obiettivo che non può
cambiare o modificare, è priva di significato quanto lo era quella passata a
spingere un masso enorme solo per vederlo rotolare giù non appena
raggiunta la vetta.
Noi pensiamo al tempo come a una linea che dal passato si protende verso
il futuro, con le vite di ognuno di noi disposte come segmenti sovrapposti di
quella stessa linea. Forse è per questo che per noi è così naturale pensare a
ciò che importa nella vita come a un obiettivo verso il quale puntare,
qualcosa verso cui stiamo progredendo. La cosa più importante nella vita è
qualcosa per cui dobbiamo lavorare. È una funzione degli obiettivi e dei
progetti della nostra vita. E se ci impegniamo abbastanza, se abbiamo
abbastanza talento e, forse, se siamo abbastanza fortunati, è qualcosa che
possiamo conseguire. Naturalmente non è del tutto chiaro quando ciò possa
accadere. C'è chi pensa che quello che è più importante nella vita possa
essere ottenuto in questa vita. Molti invece credono che possa essere
conseguito solo nella prossima e che questa vita sia importante soltanto
perché ci consente di prepararci all'altra. Ma perfino una riflessione casuale
sul caso di Sisifo dovrebbe convincerci che il significato della vita non può
essere di questo tipo. Qualunque altra cosa sia il significato della vita, non
può consistere in una progressione verso un obiettivo o punto finale, sia
esso in questa vita o nella prossima.
Ovviamente il mito di Sisifo è un'allegoria della vita umana (e infatti fu
usato come tale dal filosofo esistenzialista francese Albert Camus).
L'allegoria non è sottile. La vita di ognuno di noi è come uno dei viaggi di
Sisifo verso la vetta e ogni giorno della nostra vita è come uno dei passi di
Sisifo in quel viaggio. C'è un'unica differenza: chi spinge ogni volta di
nuovo il masso su per l'altura è Sisifo stesso, mentre noi lasciamo questo
compito ai nostri figli.
Mentre oggi andate al lavoro, a scuola o dovunque dobbiate andare,
osservate la folla affaccendata. Che cosa sta facendo tutta quella gente?
Dove sta andando? Focalizzate l'attenzione su un individuo a caso. Forse sta
andando in ufficio, dove oggi farà le stesse cose che ha fatto ieri e dove
domani farà le stesse cose che ha fatto oggi. Il rapporto deve essere sulla
scrivania della signora X entro le tre del pomeriggio - questo è cruciale - e il
nostro individuo non deve dimenticare l'appuntamento delle quattro e
mezzo con il signor Y; se l'incontro non dovesse andare bene, le
conseguenze per la sua azienda nel mercato nordamericano saranno molto
gravi. Si rende conto che sono tutte questioni molto importanti. Forse
questo genere di cose gli piace, forse no. Le fa comunque, perché ha una
casa e una famiglia e deve crescere i suoi figli. Perché? Perché tra qualche
anno i suoi figli possano fare più o meno le stesse cose che fa lui, più o
meno per le stesse ragioni, e procreare figli i quali, a loro volta, faranno più
o meno le stesse cose, più o meno per le stesse ragioni. A quel punto
saranno loro a preoccuparsi dei rapporti, delle riunioni e dei risultati nel
mercato nordamericano.
È questo il dilemma esistenziale che ci rivela Sisifo. Come l'uomo che
deve incontrare la signora X e il signor Y e preoccuparsi del mercato
nordamericano, noi possiamo riempirci la vita con piccoli obiettivi, con
minuscoli scopi, i quali però non possono dare significato alla vita, dato che
tendono solo alla propria ripetizione, eseguita da noi o dai nostri figli. Ma se
dovessimo trovare uno scopo che fosse abbastanza ambizioso da dare
significato alla nostra vita - e non sono sicuro di sapere quale potrebbe
essere -, allora dovremmo, a ogni costo, fare in modo di non raggiungerlo
mai. Se lo raggiungessimo, la nostra vita perderebbe di nuovo significato.
Certo, sarebbe simpatico se potessimo far coincidere il raggiungimento
dell'ambizioso scopo che dà significato alla vita con il nostro ultimo respiro.
Ma che tipo di scopo può essere raggiunto nel momento della nostra
massima debolezza? E se possiamo raggiungerlo nel momento della
massima debolezza, perché non ci siamo riusciti prima? Dobbiamo pensare
al significato della vita come a un pesce che abbiamo tenuto agganciato
all'amo per un certo tempo e che tiriamo fuori dall'acqua solo prima di
morire? Che razza di significato è? E che razza di pesce può mai essere, se
riusciamo a portarlo a riva proprio quando le forze ci vengono a mancare?
Se presumiamo che il significato della vita consista in uno scopo,
dobbiamo sperare di non raggiungerlo mai. Se il significato della vita
consiste in uno scopo, allora condizione necessaria perché la vita continui
ad avere significato è il mancato raggiungimento di quello scopo. Per quello
che posso giudicare, ciò vuol dire trasformare il significato della vita in una
speranza che non può realizzarsi. Ma che senso ha una speranza che non
può realizzarsi? Una speranza del genere non può dare significato alla vita.
Sicuramente Sisifo nutriva la vana speranza che il suo masso restasse, per la
primissima volta, fermo in cima all'altura, là dove l'aveva messo. Ma questa
speranza non dava significato alla sua vita. Il significato della vita, credo
che dovremmo concludere, non può essere trovato in una progressione
verso un punto finale o un obiettivo. Non c'è significato nella fine.
Se il significato della vita non è la felicità e non è lo scopo, che cos'è?
Anzi, che tipo di cosa potrebbe essere? In relazione ai problemi filosofici,
Wittgenstein era solito parlare di mossa decisiva nel gioco di prestigio. A
suo avviso, un problema filosofico apparentemente insolubile risulterà
sempre basato su un qualche presupposto che abbiamo inconsciamente, e in
ultima analisi illecitamente, introdotto nel dibattito. Tale presupposto ci
indirizza in modo decisivo verso un certo modo di riflettere sul problema. E
l'impasse cui prima o poi inevitabilmente arriviamo è un'espressione non del
problema in se stesso, ma del presupposto che ci ha spinto a riflettere sul
problema in quel modo.
Per quanto riguarda il significato della vita, ecco il mio suggerimento per
la mossa decisiva nel gioco di prestigio. Abbiamo supposto che ciò che
importa di più nella vita è avere qualcosa. Se la nostra vita è una linea
costituita dalle frecce in volo dei nostri desideri, allora possiamo possedere
qualunque cosa quelle frecce comprendano nella loro traiettoria. Nel West
americano del XIX secolo, a volte ai coloni veniva promesso tanto terreno
quanto potevano coprirne cavalcando per un giorno: era il land grab,
l'accaparramento della terra. Noi pensiamo, in linea di principio, di poter
possedere tutto ciò che le frecce dei nostri desideri, obiettivi e progetti
possono coprire. Ciò che più importa nella vita - il significato della nostra
vita - può essere afferrato grazie al talento, all'operosità e forse alla fortuna.
Questo potrebbe essere la felicità, o potrebbe essere uno scopo. Si possono
avere entrambi. Ma Brenin mi ha insegnato che non è così che vanno le
cose con il significato della vita. La cosa più importante della vita - il
significato della vita, se è in questi termini che volete pensare - si trova
esattamente in ciò che non possiamo avere.
L'idea che il significato della vita sia qualcosa che può essere posseduto è,
ritengo, un retaggio della nostra avida anima scimmiesca. Per una scimmia,
avere è molto importante. Una scimmia valuta se stessa in base a ciò che ha.
Ma per un lupo è cruciale essere, non avere. Per un lupo ciò che più importa
nella vita non è possedere una data cosa o una quantità di cose, ma è essere
un certo tipo di lupo. Tuttavia, anche se ammettiamo questo, la nostra anima
scimmiesca cercherà subito di ribadire il primato del possesso. Essere un
certo tipo di scimmia è qualcosa che possiamo sforzarci di ottenere. Essere
un certo tipo di scimmia è solo uno dei tanti scopi che possiamo avere. La
scimmia che vogliamo essere è un obiettivo verso il quale possiamo
progredire. È qualcosa che possiamo realizzare, se siamo abbastanza in
gamba, abbastanza operosi e abbastanza fortunati.
La lezione più importante e difficile da imparare nella vita è che le cose
non stanno così. La cosa più importante nella vita è qualcosa che non si
potrà mai possedere. Il significato della vita si trova proprio in ciò che le
creature temporali non possono possedere: i momenti. È questa la ragione
per cui per noi è così difficile individuare un significato plausibile della
vita. I momenti sono l'unica cosa che noi scimmie non possiamo possedere.
Il nostro possesso delle cose si basa sulla cancellazione del momento:
attraversiamo i momenti al fine di possedere gli oggetti dei nostri desideri.
Vogliamo possedere le cose cui diamo valore e che reclamiamo; la nostra
vita è un unico, grande land grab. Ed è per questo che siamo creature del
tempo e non del momento, di quel momento che sfugge sempre dalle nostre
dita pronte ad afferrare e dai pollici opponibili.
Affermando che il significato della vita si trova nei momenti non sto
riprendendo quelle superficiali prediche che ci esortano a «vivere nel
momento». Non raccomanderei mai di cercare di fare qualcosa
d'impossibile. Piuttosto, l'idea è che ci siano alcuni momenti. Non tutti,
certo, ma ci sono alcuni momenti. E nell'ombra di quei momenti scopriremo
ciò che più importa nella vita. Questi sono i nostri momenti più alti.
Senza dubbio l'espressione «momenti più alti» può indurci in errore,
orientandoci di nuovo in direzione di quella visione del significato della vita
che dovremmo respingere. Probabilmente pensiamo ai nostri momenti più
alti in uno dei tre modi seguenti, tutti sbagliati. Il primo modo è pensare ai
nostri momenti più alti come a quelli verso i quali la nostra vita può
progredire, momenti in vista dei quali le nostre vite stanno lavorando,
momenti che possiamo raggiungere, se siamo abbastanza in gamba e
operosi. Ma i momenti più alti non sono il culmine della nostra vita, non
sono la meta della nostra esistenza. I momenti più alti sono disseminati
lungo la vita. Sono momenti sparsi nel tempo: le piccole onde create da un
lupo che sguazza nelle calde acque estive del Mediterraneo.
Siamo tanto condizionati a pensare che ciò che importa nella vita è la
felicità - da noi intesa come sensazione di benessere - che ogni discorso sui
momenti più alti porta inevitabilmente alla mente uno stato di piacere
intenso simile al nirvana. È il secondo modo di fraintendere ciò che voglio
dire con «momenti più alti». In realtà i nostri momenti più alti sono
raramente piacevoli. A volte sono i momenti più spiacevoli che si possano
immaginare, i più bui della vita. I momenti più alti sono quelli in cui siamo
al nostro meglio. E spesso ci vuole qualcosa di veramente orribile per farci
essere al nostro meglio.
C'è un altro modo, più sottile e insidioso, ma altrettanto sbagliato, di
pensare ai momenti più alti, e cioè ritenere che ci rivelino ciò che siamo
davvero. Sono i momenti, crediamo, che ci definiscono. Nel pensiero
occidentale c'è una persistente tendenza a immaginare il sé o la persona
come il genere di cosa che può essere definito. Riecheggiando Shakespeare,
declamiamo solennemente frasi come «Questo su tutto: fedeltà a te stesso».
Il che implica l'esistenza di un vero te stesso, nei confronti del quale puoi
essere o meno fedele. Dubito seriamente che le cose stiano così. Dubito
seriamente che ci sia un vero te stesso o, se è per questo, un vero me stesso:
un sé, una persona che persiste immutabile e trascende tutti i diversi modi in
cui potremmo esserle infedeli. Anzi, dubito addirittura che fosse questa la
visione di Shakespeare, visto che la mette in bocca a un palese stupido come
Polonio (e grazie a Colin McGinn per avermi convinto di questo).
Perciò dubito che esista un vero io in contrapposizione a un falso io. Ci
sono solo io. Anzi, non sono neppure più sicuro che perfino quell'io esista.
Forse ciò che definisco «io» non è altro che una successione di persone
diverse, tutte collegate psicologicamente ed emotivamente e tutte unite
dall'illusione di essere me. Chi lo sa? Non ha davvero importanza. Il punto
cruciale è che ognuno dei miei momenti più alti è completo in se stesso e
non richiede giustificazione nel ruolo che si suppone giochi nel definire chi
e che cosa sono io. Sono i momenti che importano, non la persona che si
suppone (erroneamente) essi rivelino. È questa la lezione difficile.
Io sono un filosofo di professione e, di conseguenza, un'ostinata forma di
pessimismo è, o dovrebbe essere, uno dei miei ferri del mestiere. Povero,
vecchio Dio: dopo tutto il disturbo che si è preso per me - l'intervento
assurdamente improbabile sotto forma del fantasma di pietra di Brenin - non
riesco ancora a convincermi a credere in Lui. Ma se potessi credere, allora
spererei nel Dio della preghiera di Eli Jenkins in Sotto il bosco di latte: il
Dio che cerca sempre il nostro lato migliore, non il peggiore. I nostri
momenti più alti rivelano il nostro lato migliore, non il peggiore. L'io al mio
peggio è reale quanto l'io al mio meglio. Ma ciò che mi rende degno - se lo
sono - è l'io al mio meglio.
Sono stato al mio meglio, ne sono convinto, quando dicevo di no alla
morte di Brenin durante quei primi giorni in Francia. Ero un pazzo privato
del sonno. Pensavo di essere morto e all'inferno. La mia visione di ciò che
stava succedendo nella mia vita faceva sembrare Tertulliano assolutamente
ragionevole. Ero a pezzi. Ma, malgrado tutto, quelli sono stati tra i momenti
più alti della mia vita. È questo che Sisifo alla fine ha capito. Siamo al
nostro meglio quando non ha più senso andare avanti, quando non c'è più
alcuna speranza che ci spinga ad andare avanti. Ma la speranza è una forma
di desiderio, che è ciò che fa di noi creature temporali: le frecce della
speranza tracciano la loro traiettoria nella terra inesplorata del nostro futuro.
E a volte è necessario mettere la speranza al suo posto, riporla dentro la sua
piccola, squallida scatola. E andiamo avanti comunque e, nel farlo, creiamo
un senso (anche se, naturalmente, non è per questo che lo facciamo:
qualsiasi ragione minerebbe quel senso). In quei momenti gridiamo
«Vaffanculo!» agli dèi dell'Olimpo, agli dèi di questo mondo o dell'altro e ai
loro piani per costringerci a spingere per l'eternità massi su per le alture o a
imporre la stessa fatica ai nostri figli. Per essere al nostro meglio dobbiamo
essere costretti in un angolo, dove non c'è speranza e niente da guadagnare
andando avanti. E noi andiamo avanti comunque.
Siamo al nostro meglio quando la morte si sta chinando sopra la nostra
spalla e non c'è più nulla che possiamo fare perché il nostro tempo è quasi
finito. Ma gridiamo «Vaffanculo!» alla linea della nostra vita e
abbracciamo, invece, il momento. Sto per morire, ma in questo momento mi
sento bene e mi sento forte. E farò quello che voglio. Questo momento è
completo in se stesso e non ha bisogno di trovare giustificazioni in altri
momenti, passati o futuri.
Siamo al nostro meglio quando il pit bull della vita ci afferra per la gola e
ci immobilizza a terra. E noi siamo solo cuccioli di tre mesi che possono
essere facilmente sbranati. C'è dolore in arrivo, lo sappiamo, e non c'è
speranza. Ma non gridiamo e non piagnucoliamo. Non lottiamo neppure.
Ma dalle profondità del nostro essere sale un ringhio, un ringhio calmo e
sonoro, che contrasta con la nostra tenera età e fragilità esistenziale. È un
ringhio che dice: «Vaffanculo!».
Perché sono qui? Dopo quattro miliardi di anni di sviluppo cieco e
irrazionale, l'universo ha prodotto me. Ne valeva la pena? Ne dubito
seriamente. Ma comunque sono qui per gridare «Vaffanculo!» quando gli
dèi non mi hanno lasciato speranza, quando Cerbero, il cane dell'inferno, mi
ha inchiodato a terra tenendomi per il collo. Non sono i miei momenti felici:
adesso so che sono però i miei momenti più alti, perché sono i più
importanti. E sono importanti per ciò che sono in se stessi, non per un
qualche ruolo che si presume abbiano nel definire chi sono. Se io valgo
qualcosa, in qualsiasi forma e aspetto, se valeva la pena che l'universo mi
producesse, allora sono questi momenti che mi rendono tale.
E così, suppongo, è stato un lupo che mi ha rivelato tutto questo: lui era la
luce e io ho potuto vedere me stesso nell'ombra che proiettava. Ciò che ho
imparato, in effetti, è stata l'antitesi della religione. La religione vende
sempre speranza. Se sei cristiano o musulmano, è la speranza di essere
degno del paradiso. Se sei buddhista, è la speranza di ottenere la liberazione
dalla grande ruota della vita e della morte e raggiungere il nirvana. Nelle
religioni giudaico- cristiane la speranza è addirittura elevata al rango di
virtù primaria e ribattezzata fede.
La speranza è il venditore di auto usate dell'esistenza umana: così
amichevole, così plausibile. Ma non puoi contare su di lui. Ciò che più
importa nella vita è il te stesso che resta quando la speranza è svanita. Il
tempo alla fine ci porterà via tutto. Tutto quello che abbiamo acquisito con
il talento, l'operosità e la fortuna ci verrà sottratto. Il tempo ci porta via la
forza, i desideri, gli obiettivi, i progetti, il futuro, la felicità e perfino la
speranza. Qualunque cosa possiamo avere, qualunque cosa possediamo, il
tempo ce la porterà via. Ma ciò che il tempo non potrà mai portarci via è chi
siamo stati nei nostri momenti migliori.
C'è un quadro di Alfred von Kowalski intitolato Lupo solitario.
Rappresenta un lupo che, di notte, dalla sommità di una collinetta innevata
fissa una capanna di tronchi di legno, più in basso. Dal camino della
capanna si alza il fumo e la finestra è illuminata da una luce calda. La
capanna mi ha sempre ricordato Knockduff, quando in inverno rientravo da
una delle nostre passeggiate serali con Brenin e le «ragazze» che mi
trottavano davanti e, lasciandomi il buio del bosco alle spalle, mi dirigevo
verso la luce accogliente che avevo lasciato accesa in casa. Naturalmente il
quadro di Kowalski è allegorico: una rappresentazione dell'estraneo che
osserva da fuori il caldo e intimo comfort della vita di qualcun altro. Ma
forse la capanna mi ricordava Knockduff solo perché il lupo mi ricordava
me stesso e la vita che avevo vissuto.
In un modo o nell'altro, quella vita è giunta al termine, o perlomeno ha
cominciato ad avviarsi verso la conclusione, in quella notte buia di gennaio
in Linguadoca quando seppellii Brenin, inveii contro Dio e mi ubriacai
quasi a morte. A volte mi chiedo se quella notte io non sia morto davvero.
Cartesio, durante la sua lunga, buia notte dell'anima, trovò rifugio in un Dio
che non lo avrebbe mai ingannato. Cartesio poteva dubitare praticamente di
tutto: del fatto che ci fosse un mondo fisico intorno a lui e che lui stesso
avesse un corpo fisico. Da matematico e logico di talento quale era, poteva
mettere in dubbio le verità della matematica e della logica. Ma non poteva
dubitare dell'esistenza di un Dio buono e gentile. Quel Dio non avrebbe mai
permesso che lui venisse ingannato, purché lui fosse stato sufficientemente
attento nel valutare le proprie convinzioni.
Probabilmente Cartesio si sbagliava. C'è una differenza tra un Dio buono
e un Dio gentile. Un Dio buono forse non permetterebbe che noi venissimo
ingannati. Ma un Dio gentile quasi certamente sì. I momenti più alti della
vita sono assai duri e opprimenti. C'è una ragione per cui il valore della
nostra vita può esserci rivelato solo in determinati momenti. Non siamo
abbastanza forti perché ci venga rivelato in qualsiasi altro modo. Anche se
non sono religioso in nessun senso convenzionale del termine, a volte,
quando ripenso alla notte della morte di Brenin, all'attimo in cui guardai
attraverso le fiamme della sua pira funebre e vidi il suo fantasma di pietra
restituirmi lo sguardo, penso che Dio mi stesse dicendo: «Va tutto bene,
Mark, sul serio. Non dev'essere sempre così dura. Sei al sicuro». Questa
sensazione, ritengo, è l'essenza della religione degli uomini.
Perciò a volte mi chiedo se questo non sia il sogno incredibilmente bello
di un morto, un sogno regalatogli da un Dio gentile, e non dal Dio buono di
Cartesio. Questo è un Dio che permette che io venga ingannato, proprio
perché è quello che un Dio gentile fa. Lo stesso Dio che quella notte
maledissi con il mio respiro morente.
Me lo chiedo perché se quella notte Dio mi fosse apparso, mi avesse dato
carta e penna e mi avesse chiesto di scrivere come avrei voluto che fosse la
mia vita da quel momento in poi, non avrei potuto descriverla meglio. Oggi
sono sposato con Emma, che non è solo la donna più bella che abbia mai
visto, ma è anche la persona più gentile che abbia mai conosciuto, una
persona che è indiscutibilmente, palesemente, irrimediabilmente e
categoricamente superiore a me.
La spirale della mia carriera ha continuato a salire: dopo essere stato un
modesto assistente in un'ancor più modesta università, ignorato da tutti,
adesso mi vedo offrire stipendi inverosimilmente esagerati dalle migliori
università degli Stati Uniti. I miei libri sono diventati best seller, o almeno
ciò che passa per best seller nella rarefatta atmosfera dell'editoria
accademica. E non sono più il tipo di persona che è capace, o che
prenderebbe mai in considerazione l'idea, di bersi due litri di Jack in una
volta sola, qualunque fossero le circostanze o le motivazioni. Come dovete
avere capito, non si arriva a diventare il tipo d'uomo in grado di bere in quel
modo senza molti, molti anni di costante e scrupoloso allenamento.
Non sto raccontando tutto questo per gloriarmi o perché sia
particolarmente compiaciuto di me stesso. È vero anzi il contrario: sono
sinceramente sconcertato. Lo dico perché so che niente di tutto questo, alla
fine, è ciò che fa di me una persona degna. Mentirei se dicessi che non ne
sono orgoglioso, ma, al tempo stesso, diffido di questo orgoglio. È
l'orgoglio della scimmia, della mia cupa, furtiva anima scimmiesca, quella
convinta che la cosa più importante nella vita è riuscire ad arrivare in cima
mediante ragioni strumentali e tutto ciò che ne consegue. Ma quando
ricordo Brenin, ricordo anche che la cosa più importante è il te stesso che
resta quando i tuoi calcoli falliscono, quando i complotti che hai ordito
finiscono e le bugie che hai raccontato ti si bloccano in gola. In ultima
analisi è tutta - ma proprio tutta - fortuna e gli dèi possono portartela via con
la stessa rapidità con cui te l'hanno concessa. La cosa più importante è la
persona che sei quando la fortuna finisce.
Nella notte in cui ho sepolto Brenin, nel calore rosato della sua pira
funebre e nel pungente freddo notturno della Linguadoca, troviamo la
condizione umana fondamentale. Una vita vissuta nel calore rosato e nella
dolcezza della speranza è quella che ciascuno di noi sceglierebbe, se
potesse. Saremmo pazzi, se non lo facessimo. Ma la cosa più importante
quando arriva il momento - e il momento arriva sempre - è vivere la vita
con la freddezza di un lupo. Una vita del genere è troppo dura, troppo rigida
e noi potremmo solo avvizzire. Ma arrivano momenti in cui siamo in grado
di viverla. Sono questi momenti che ci rendono degni perché, in
conclusione, è solo la nostra sfida che ci redime. Se i lupi avessero una
religione - se esistesse una religione del lupo -, questo è ciò che ci direbbe.
Non potevo lasciare le ossa di Brenin a riposare tutte sole nel Sud della
Francia. Così acquistai una casa nello stesso paese. Nelle nostre passeggiate
quotidiane passavamo sempre a salutare il suo fantasma di pietra. Ma è da
Miami che sto scrivendo queste ultime frasi. Alla fine ho ceduto a uno di
quegli stipendi inverosimilmente esagerati di cui parlavo. Emma e io siamo
arrivati qui pochi mesi fa. Nina e Tess ci sono ancora e non occorre dire che
sono venute con noi. Nina continua a svegliarmi ogni mattina alle sei e, se
non ho mani o piedi esposti, si dà da fare con le lenzuola fino a scoprirmi.
Leccata, leccata: non sai che ci sono persone che dobbiamo vedere e posti in
cui dobbiamo andare? Ma sia Nina sia Tess cominciano a mostrare i segni
dell'età. Passano quasi tutto il giorno dormendo, accanto alla piscina, in
giardino o sul divano. Non posso più andare a correre con loro. Avevo
ripreso a correre dopo la morte di Brenin, con loro grande gioia. Ma adesso
dopo un paio di chilometri restano troppo indietro e quindi la cosa non ha
più senso. Forse per un po’ diventerò grasso e lento insieme alle mie due
«ragazze», esattamente come mi successe con Brenin. Comunque, quelle
due apprezzano molto le nostre tranquille passeggiate lungo Old Cutler
Road, dove trovano ancora l'energia per intimidire tutti i cani americani che
incontrano, di gran lunga troppo entusiasti ed eccitabili, troppo giovani, per
i loro gusti. Sono sicuro che sono molto felici di riuscire ancora a
terrorizzare tutti i cani locali. Cani e relativi padroni attraversano la strada
per evitarci. Ma è okay. Se conosco bene Nina e Tess, sono certo che
vogliono uscire di scena da cani di prim'ordine. Ma si stanno spegnendo,
tutte e due. Il caldo è davvero un bene per l'artrite di Nina: credetemi, so
come si sente.
A volte ho una sensazione, una sensazione stranissima. Quella di essere
stato un lupo e di essere adesso solo uno stupido labrador. Brenin è arrivato
a rappresentare una parte della mia vita che non c'è più. È una sensazione
dolceamara. Sono triste perché non sono più il lupo che ero. E sono felice
perché non sono più il lupo che ero. Ma, soprattutto, un tempo sono stato un
lupo. Io sono una creatura del tempo, ma ricordo ancora che ciò che conta
sono i momenti più alti - momenti sparsi lungo la vita come chicchi d'orzo
all'epoca del raccolto - non dove cominci e non dove finirai. Forse non si
può restare lupo per tutta la vita. Ma non è mai stato questo il punto. Un
giorno gli dèi decideranno di nuovo di non darmi speranza. Forse succederà
presto. Spero di no, ma so che succederà. Quando accadrà, farò del mio
meglio per ricordare il cucciolo di lupo afferrato per il collo e inchiodato a
terra.
Ma qui c'è la verità del branco: i nostri momenti non sono mai nostri. A
volte i miei ricordi di Brenin si colorano di un bizzarro senso di stupore. È
come se i ricordi fossero composti da due immagini parzialmente
sovrapposte: intuisci che le immagini sono collegate in un modo importante,
ma sono troppo confuse per distinguerle bene. E poi, all'improvviso, le
immagini convergono, di colpo a fuoco come quelle di un vecchio
caleidoscopio. Ricordo Brenin accanto a me, lungo le linee di touche del
campo da rugby a Tuscaloosa. Lo ricordo seduto vicino a me alle feste del
dopopartita, quando le belle ragazze dell'Alabama si avvicinavano e mi
dicevano: «Adoro il tuo cane». Lo ricordo correre con me nelle strade di
Tuscaloosa e, quando tali strade si trasformano nei sentieri della campagna
irlandese, ricordo il branco che mi correva accanto, adeguando il passo al
mio. Ricordo tutti e tre saltare come salmoni nei mari d'orzo. Ricordo
Brenin che muore tra le mie braccia sul retro della jeep quando il veterinario
gli conficca l'ago nella vena della zampa anteriore destra. E quando avviene
la convergenza delle immagini, mi domando: quello ero proprio io? Sono
stato proprio io a fare quelle cose? Quella è davvero la mia vita?
Questa percezione a volte mi colpisce come una scoperta vagamente
surreale. Non è me che ricordo lungo la linea di touche a Tuscaloosa: è il
lupo che mi camminava accanto. Non è me che ricordo alle feste: è il lupo
che mi sedeva vicino e le belle ragazze mi rivolgevano la parola grazie a lui.
Non è me che ricordo correre lungo le strade di Tuscaloosa o i sentieri di
campagna di Kinsale: sono i lupi che adeguavano il loro passo al mio. Il
ricordo di me stesso è sempre rimosso. Che addirittura io sia in quei ricordi
non è scontato: a volte è un bonus fortuito che dev'essere scoperto.
Non ricordo mai me stesso. Ricordo me stesso solo attraverso i miei
ricordi di altri. E qui ci troviamo a confrontarci in modo decisivo con la
fallacia dell'egoismo, l'errore fondamentale della scimmia. Quello che
importa non è ciò che abbiamo, ma chi siamo stati quando eravamo al
nostro meglio. E chi eravamo quando eravamo al nostro meglio ci è rivelato
solo in certi momenti, i nostri momenti più alti. Ma i nostri momenti non
sono mai del tutto nostri. Anche quando siamo davvero soli, quando il pit
bull ci tiene bloccati a terra e noi siamo solo cuccioli facili da fare a pezzi, è
il cane che ricordiamo, non noi stessi. I nostri momenti - quelli più
meravigliosi e quelli più terrificanti - diventano nostri solo attraverso i
nostri ricordi di altri, che questi altri siano buoni o cattivi. I nostri momenti
appartengono al branco ed è attraverso il branco che ricordiamo noi stessi.
Se io fossi stato un lupo invece di una scimmia, di me si sarebbe detto che
ero un solitario. A volte un lupo lascia il proprio branco e si allontana nei
boschi per non tornare mai più. Ha iniziato un viaggio e non farà più
ritorno. Nessuno sa perché alcuni lupi si comportano così. C'è chi ipotizza
un desiderio genetico di riproduzione, unito all'indisponibilità di aspettare il
proprio turno per risalire la gerarchia del branco. Alcuni sostengono che i
lupi solitari siano esemplari particolarmente asociali che, a differenza dei
lupi normali, non gradiscono la compagnia dei loro simili. Io posso
identificarmi, a modo mio, in entrambi i soggetti ipotizzati. Ma chi lo sa?
Forse certi lupi pensano semplicemente che là fuori c'è un grande, vecchio
mondo e che sarebbe un peccato non vederne la maggior parte possibile. In
realtà non ha importanza. Alcuni lupi solitari muoiono soli. Alcuni, quelli
fortunati, incontrano altri come loro e formano nuovi branchi.
E così, per una strana svolta del destino, la mia vita adesso è la migliore
che abbia mai avuto, almeno a giudicare da quanto sono felice. Mentre
scrivo queste parole, Emma è ormai pronta a entrare in travaglio. Bè, in
realtà lo è già da qualche giorno. Ci sono parecchi, chiari segnali uterini, ma
niente di abbastanza organizzato o regolare da risultare decisivo. In ogni
caso vivo nella speranza. Mi aspetto che da un momento all'altro mia
moglie mi chiami per dirmi di prendere la valigia e accompagnarla al South
Miami Hospital. Perciò devo essere breve. Dopo quarant'anni da solitario
irrequieto e senza radici, finalmente ho trovato un branco umano. Il mio
primo bambino, mio figlio, nascerà da un giorno all'altro e ho la sensazione,
un sospetto insinuante che non riesco a scrollarmi di dosso, che succederà
proprio oggi. E spero che questo non lo costringa a vivere all'altezza di
aspettative troppo alte, ma penso davvero che potrei chiamarlo Brenin.
Brenin, mi preoccupano le tue ossa, che riposano a cinquemila chilometri
di distanza in Francia. Spero che tu non ti senta troppo solo. Mi manchi e mi
manca vedere ogni mattina il tuo fantasma di pietra. Ma, se gli dèi vorranno,
presto il nostro branco sarà di nuovo lì, per l'estate senza fine della
Linguadoca. Fino ad allora dormi bene, fratello lupo. Ci incontreremo di
nuovo nei sogni.
Ringraziamenti
George Miller è stato il primo a commissionare questo libro per conto
della Granta. È stato quasi certamente un atto di grande fiducia da parte sua,
dato che, per unanime consenso, nessuno aveva la minima idea di cosa
stesse succedendo nelle prime stesure del testo. Quando George se n'è
andato, il processo editoriale è passato a Sara Holloway, che è un editor da
sogno. Le sue domande acute, intelligenti e, soprattutto, pazienti, unite alla
determinazione nell'assicurarsi che non perdessi di vista le cose davvero
importanti, hanno reso questo libro molto migliore di quanto sarebbe stato
altrimenti. Lesley Levene si è occupata della revisione del testo. Mai, nella
mia lunga esperienza, il processo di revisione è stato così indolore,
addirittura vagamente piacevole, e mai da questo lavoro ho imparato tanto
sull'arte di scrivere. I miei più sinceri ringraziamenti a tutti e tre. Grazie
anche a Vicki Harris per l'eccellente correzione di bozze. E grazie, non
occorre dirlo, alla mia agente, Liz Puttick, per avere fatto decollare un altro
dei miei folli progetti.
Questo libro non esisterebbe senza il suo soggetto e protagonista. Perciò,
grazie, Brenin, mio fratello lupo, per avere condiviso la tua vita con me. E,
naturalmente, grazie anche alle tue fedeli compagne, Nina e Tess.
Infine, a Brenin: mio figlio, non mio fratello. Non posso dire che questo
libro sia stato scritto per te perché l'ho cominciato prima ancora che tu fossi
uno scintillio nell'occhio del tuo genitore. Ma l'ho finito perché volevo che
capissi il tuo nome. E anche perché avevo già speso tutto l'anticipo. Ricorda
- e rabbrividisco al pensiero di quante volte rimpiangerò di averlo detto che è solo la nostra sfida che ci redime.
Scarica