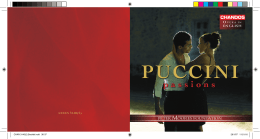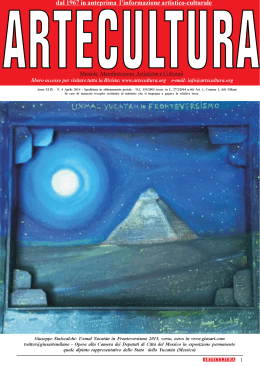38 - Trieste Artecultura - febbraio/marzo 2014 “Madama Butterfly” in scena al Teatro Verdi L’AMORE INFRANTO di Pierpaolo Zurlo Ci sono opere senza tempo, opere che paiono non invecchiare mai: Madama Butterfly, andata in scena al Teatro Lirico “G. Verdi” è sicuramente una di queste. Sarà per la scrittura (apparentemente) evanescente ma penetrante, che pare incisa con una grafia morbida su un telo di lino, priva di rughe, priva di tempo, priva di orpelli; sarà per la sapiente costruzione a tasselli, a brevi motivi che ricorrono con una precisione meticolosa a sottolineare emozioni, pensieri, timori, ardori, paure; sarà perché, senza nemmeno apprezzare coscientemente questi particolari infiniti, il piacere dell’afflato melodico trascina senza requie da un momento scenico ad un altro, da un’emozione a quella successiva. Poco conta, in fin dei conti: il teatro stracolmo (ma solitamente tutti i teatri che programmano quest’opera si ritrovano stracolmi) ha tributato un successo straripante allo spettacolo, premiando l’intero cast e in particolare la protagonista per l’intensità della sua interpretazione. E pensare che quest’opera alla sua “prima” (a Milano, a La Scala, il 17 febbraio 1904) era caduta rovinosamente. Poi, attraverso varie “versioni” (consistenti in tagli più o meno estesi e in piccole ma significative alterazioni del libretto che sempre più hanno focalizzato l’attenzione sulla figura della protagonista), da Brescia (28 maggio 1904) a Londra (10 luglio 1905) per terminare a Parigi (l’ultima, quella che s’ascolta oggi nei teatri di tutto il mondo, andata in scena all’Opéra Comique il 28 dicembre 1906, frutto della collaborazione del compositore e del sovrintendente del teatro, e regista, Robert Carré), ha saputo imporsi nei gusti del pubblico e della critica. Più lenta la seconda a comprendere la grandezza dell’arte pucciniana, se si pensa ai molti libelli denigratori stampati nel corso dei decenni (alcuni col compositore ancora in vita) che via via hanno ceduto però il passo ad una valutazione diametralmente opposta (a volte purtroppo altrettanto superficiale ed entusiasticamente acritica) o ad alcune recensioni che hanno raggiunto vertici di totale – e simpatica, dopo tutto – incomprensibilità. Come testimonia la caustica uscita di John Bingham Morton che s’era profuso, nella sua rubrica “Beachcomber” (nel Daily Express, anno 1924), nell’enigmatica battuta «Wagner is the Puccini of music»… Da tali “sentenze” ci si può render conto di quanta strada la musica del lucchese abbia dovuto percorrere per diventare oggetto di studio serio e profondo. Studio serio e profondo che pare essere alla base della resa musicale della pregevole edizione della “tragedia giapponese in due atti” presentata a Trieste: Donato Renzetti ha concertato con impeto – che nulla però ha concesso a quello svenevole sdilinquirsi melodico che spesso s’associa a Puccini – la colorita partitura. Serrata, precisa nel ritmo, incalzante nel racconto, lontana da quel sentimentalismo di maniera che spesso sciupa la trasparente bellezza delle linee melodiche, la lettura del direttore ha saputo esaltare l’aspetto drammatico e timbrico di quest’opera. A partire dalla disposizione dell’orchestra, coi contrabbassi a sinistra, i legni in fondo, gli ottoni concentrati a destra, tutti a sostenere, a irrobustire, a “speziare” la scrittura brillantissima di Puccini. Fin dalle prime misure, quell’enigmatica fuga che sembra alludere al frenetico mobilitarsi di tutta la casa per l’imminente matrimonio e che allude invece, più sinistramente, citandone la forma e la disposizione delle voci orchestrali, al preludio dell’opera di Bedrich Smetana Prodaná nevesta (che noi conosciamo come La sposa venduta, per l’appunto) e che dà da subito la piena caratterizzazione di un’intelligenza creativa che cita con sensibile e raffinato acume un altro lavoro per il teatro musicale, che nel titolo contiene però già tutto il dramma che seguirà a queste prime note. La continuità timbrica e il fitto irretirsi dei motivi originali giapponesi congiunti alle sezioni di stampo più marcatamente “occidentale” hanno trovato in Renzetti un sapiente equilibrio. Come sapiente, e intelligente, è stata la scelta di restituire l’opera così come l’aveva concepita Puccini, in due atti, con al centro del secondo tempo la meravigliosa sospensione del “coro a bocca chiusa” seguìto, senza soluzione di continuità, dal piccolo “poema sinfonico” che narra i pensieri, le emozioni 38 - Trieste Artecultura - febbraio/marzo 2014 39 - Trieste Artecultura - febbraio/marzo 2014 della protagonista nella lunga veglia che la accompagna fino alle prime luci del giorno che la vedrà morire. Anche di queste pagine Renzetti ha messo in risalto la pregnanza strumentale, la forza espressiva che le pervade, con una meticolosa attenzione ai tanti dettagli timbrici, ai contrasti dei vari materiali musicali che Puccini utilizza ed allo stile d’assieme che alterna con disinvoltura il passo leggero a quello più drammatico. In questo cammino all’interno dell’opera ha trovato una fida alleata nell’intensa Cio-Cio-San di Amarilli Nizza che s’è imposta con una lettura intensa, tutta giocata sulla parola e sulla “definizione” dello spazio scenico ideato dal regista, Giulio Ciabatti. Gesti credibili (incluso il suicidio finale che non è, come spesso si crede, un hara-kiri – riservato agli uomini – ma un ton-to, il taglio della gola, gesto tipicamente destinato alle donne) e coerenti, la cui efficacia s’è misurata nella gestione accorta dei vari passaggi dai toni di conversazione a quelli più intensamente drammatici. È bello, timbricamente bello è risultato alla fine il contrasto fra la sua voce, più chiara e più vibrante, e quella più pastosa, scura della Suzuki di Chiara Chialli, che nel duetto cosiddetto “dei fiori” (“Scuoti quella fronda”), sospinto da un ondeggiare sicuro che non cercava il liberty di superficie, ha ben stilizzato l’insieme, facendo piovere letteralmente le voci, così come gradualmente piovevano in scena i fiori, a creare un tappeto arabescato di raffinatissimo colore vocale. Luciano Ganci, un Pinkerton sicuro, dal bel timbro chiaro e disinvolto, ha incalzato la protagonista fino al raggiungimento dello scopo che s’era prefissato, per poi – come da libretto – scomparire, lasciando l’amaro in scena e nel ricordo del pubblico. Pur confinato, localmente, al solo primo tempo dell’opera (cui poi Puccini avrebbe cercato di rimediare col successivo inserimento del breve “Addio fiorito asil” del secondo tempo), per valutarlo è stato ben più che sufficiente il duetto che ha intessuto con CioCio-San alla fine del primo atto: il luogo convenzionale nel quale si dovrebbe realizzare musicalmente il mutuo scambio amoroso (e che è invece, in Madama Butterfly, il momento in cui la ricerca superficiale dell’appagamento sensuale si scontra con l’autentico lirismo femminile), gli è giustamente valso il riconoscimento da parte del pubblico. Ben diverso il ruolo di Shar- pless, che di sé permea tutto il corso degli accadimenti e che ha trovato nel timbro vocale pieno e umano di Filippo Polinelli un qualificato interprete, morbidamente lirico nelle sezioni più umanamente partecipate e incisivo, scenicamente, in quelle più discorsive (l’alternanza fra le due è la vera cifra stilistica di quest’opera). Completavano il cast, in ruoli quantitativamente piccoli ma per nulla superflui, il Goro di Gianluca Sorrentino e il principe Yamadori di Makoto Kuraishi che hanno entrambi ben delineato le due figure che si situano allo snodo, all’incontro delle due civiltà, quella orientale e quella occidentale, facendolo in punta di piedi, con discrezione, senza per questo diminuire la fatale portata di quella contaminazione culturale che è il tema principale di Madama Butterfly e che spesso Puccini non lesina di velare d’un tono vagamente caricaturale. La regia di Giulio Ciabatti ha posto l’evolversi degli avvenimenti in una “casa a soffietto” d’un Oriente fiabesco, per nulla degradato – ancora – dal liberismo economico occidentale, ma già segnato da quel che poi il “secolo breve” avrebbe accentuato: turismo sessuale, prevaricazione, sfruttamento. Il “minimale” impianto scenografico permette di accentrare l’attenzione sui protagonisti ma soprattutto sulla protagonista dandole quel rilievo che Puccini stesso, attraverso le quattro diverse versioni, ha inteso darle. La totale assenza di scrupoli di un Pinkerton, isolato dal contesto orientale (ma tenuto a distanza anche dall’atteggiamento deplorante di Sharpless), ha enfatizzato, in questa lettura scenica, quel valore – tipicamente giapponese – del “gruppo”, del “nucleo sociale” (opposto all’individualità egoista e avventurosamente sfrenata che Pinkerton simbolicamente rappresenta). Ed è così che ha ancor di più accentuato, col venir meno del consenso sociale (rappresentato dal coro femminile che la abbandona a metà del primo atto), il senso profondo di totale solitudine che gradatamente avvolge l’eroina: attraverso quei passaggi fondamentali che sono le sue arie, ha disegnato l’incauto sporgersi di questa delicata farfalla dal sogno d’amore mai realmente corrisposto (il duetto del primo atto) alla vertigine della delusione (“Un bel dì vedremo”), alla desolazione dell’isolamento (“Che tua madre dovrà prenderti in braccio” ) sino all’abisso del sacrificio finale che strappa le sue fragili ali non più utili, ormai, ad alcun volo. 39 - Trieste Artecultura - febbraio/marzo 2014
Scaricare