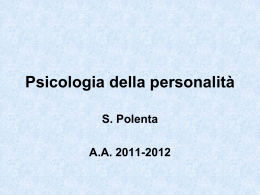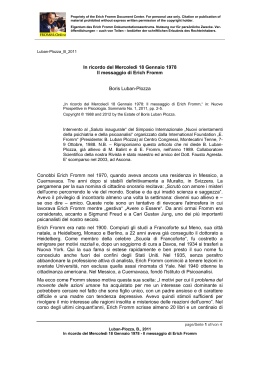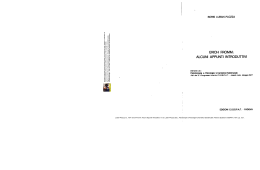Intenzionalità • Una delle caratteristiche più evidenti delle persone è che sono attive e manifestano un comportamento «intenzionale». • Il concetto di intenzionalità è più semplice da riconoscere che non da descrivere. – Il biologo S. Kauffman dice: quando chiamo il mio cane, mi guarda. È un comportamento intenzionale. • Per W. Freeman (neuroscienziato) l’intenzionalità e il produrre azioni dirette verso uno scopo è una caratteristica di base del nostro cervello. …la diade deterministica natura-cultura… non riesce a tenere conto della capacità degli esseri umani di costruire e perseguire i propri obiettivi personali nell’ambito del contesto sociale (Freeman, 1999, Come pensa il cervello, tr. it. 2000). • Gli individui sono «centri attivi» di interessi e motivazioni, che percepiscono le esperienze come «proprie»: …alla base del nostro senso di essere un centro indipendente di iniziativa e di percezione, integrato, con le nostre ambizioni e i nostri ideali più centrali, con la nostra esperienza che la mente e il corpo formano un’unità nello spazio e un continuo nel tempo. Questa configurazione psichica coesiva e permanente forma il settore centrale della personalità (Kohut, 1977). La concezione del neonato come groviglio di impulsi e bisogni meramente fisici, come tabula rasa governata solo da impulsi, non tiene presente che… …la caratteristica più notevole dei bambini di ogni età è tuttavia la loro capacità di generare intenzioni o stati motivazionali coerenti: non sono in balia degli stimoli, né in costante conflitto di impulsi. (Trevarthen*, 1980, tr. it 1998, p. 34) * C. Trevarthen è neuroscienziato e psicologo dello sviluppo. Sin dall’origine, l’essere umano può essere immaginato come un centro attivo dotato di intenzionalità, con caratteristiche proprie (anche se solo potenziali), impegnato a evolvere e a conoscere se stesso e il mondo che lo circonda. Donald Winnicott ha utilizzato il termine di “vero Sé” per alludere alla spontaneità originaria del soggetto. Un individuo è «sano» quando riesce a percepire di «star vivendo la propria vita» Per Piero Bertolini e Marco Dallari l’intenzionalità, sulla scorta della tradizione fenomenologica (depurata però da ogni idealismo), è incontro fra persone reali, soggetti a pieno titolo, soggetti attivi in relazione Per Colwin Trevarthen (1997) è possibile parlare in modo sensato di “intenzionalità” nei neonati. A suo parere i neonati hanno un’innata capacità di autoriferimento. John Dewey pone al centro della sua pedagogia l’ «esperienza» intesa come interazione fra l’io (self) e l’ambiente. Tale interazione è resa significativa dal fatto che l’azione compiuta dal self è intenzionale (purposeful) e intelligente I ricercatori dell’Infant Research parlano di dello sviluppo del Sé non solo quale esito di regolazioni intersoggettive ma anche di “autoregolazioni”, cioè di avere una propria «logica» interna di funzionamento, di essere «autonomo» e non solo «eteronomo». In Carl Rogers alla base dello sviluppo della personalità vi è il concetto di organismo inteso come un tuttounico, irriducibile alla semplice somma delle parti, una «persona» e dotato di una «tendenza attualizzante» Heinz Kohut parla di un Sé nucleare. Una delle difficoltà del lavorare con i neonati è che possiedono menti proprie. Talvolta, quando non fanno determinate cose, è perché non vogliono farle, mentre quando vogliono fare qualcosa, ce la mettono davvero tutta. Trevarthen (1997, p. 149). • Il neonato viene alla luce con un sé giocoso, espressivo e portato alla sperimentazione, pronto ad esplorare ed ad usare oggetti e a comunicare con le altre persone su come usarli Un bimbo di due mesi è una personalità complessa, capace di distinguere le persone da altri oggetti “fisici”, trattandole come una categoria di importanza primaria per il proprio sviluppo. Trevarthen (1974, tr. it. 1998, p. 43) • Un bambino ha una sua “voce” che non ha niente a che vedere con l’esigenza di essere nutrito, rimanere al sicuro e protetto: le protoconversazioni hanno inizio quando il bambino non si accontenta di rimanere al sicuro e si cimenta in “conversazioni” con i fratelli, i genitori, altri bambini della sua età. Questo comportamento rappresenta uno scambio reciproco. (Trevarthen 1997, p. 147) Natura o cultura? Sulla scorta di tali considerazioni, Trevarthen è convinto che una visione più chiara di come il cervello umano si sviluppa possa fornire un contributo alle teorie dello sviluppo e ai connessi metodi educativi (1980, tr. it 1998, pp. 1-2). Ma… … sottolinea che man mano che le nostre conoscenze sul cervello aumentano, non diminuisce la distanza fra la logica materialistica della biologia e la consapevolezza che abbiamo come esseri umani di essere dotati di sentimenti complessi e una vita consapevole. Tutto ciò appare alquanto frustrante per lo scienziato moderno, che probabilmente si risolverà ad accogliere una prospettiva di tipo dualistico e a cercare spiegazioni diverse per gli eventi fisiologici da una parte e per quelli mentali o spirituali dall’altra. A chi non è un biologo, o non è impegnato a semplificare il comportamento umano, la natura biologica ereditata dall’uomo appare irrilevante, uno strumento subordinato alla mente, o una fonte di impulsi fastidiosi per la vita personale del “Sé”. Io penso invece che, se vogliamo comprendere il neonato in quanto essere umano, sia necessario affrontare il paradosso che sorge fra mente e materia biologica, da che un bambino piccolo è una giovane mente immersa in materia biologica. Ma ammetto che è facile cadere in una spiegazione molto rozza della mente in termini di pezzettini di strutture cerebrali. Condivido le preoccupazioni di chi si chiede se sarà mai possibile conoscere abbastanza sui pallidi labirinti del cervello da poter indicare il loro esatto contributo alla vita mentale e al comportamento. In particolare, mi sembra lecito domandare che cosa abbiano a che fare i discorsi che facciamo sul cervello con lo sviluppo della coscienza, delle intenzioni e delle relazioni personali nel bambino (Trevarthen). • Gli psicologi sembrano spesso credere che le caratteristiche umane sia determinate alla nascita geneticamente e che in seguito vengano modificate dalle influenze ambientali. Ma è davvero così? (Trevarthen, 1997, tr. it. 1998, p. 3) Se osserviamo lo sviluppo di un essere umano, notiamo che esso inizia sotto la forma di una cellula entro la quale sono combinati i cromosomi di un uomo e quelli di uno spermatozoo. Attraverso migliaia di cicli di divisione cellulare, le molecole dei geni costruiscono immagini di se stesse e le distribuiscono in maniera uguale a ciascuna cellula. Questa chimica eccezionale spiega come i cromosomi riescano a trasmettere informazioni in maniera indistruttibile per formare sempre la stessa specie di organismo (Crick 1962). Alcuni prodotti delle molecole dei geni agiscono “all’indietro”, in modo da esercitare un controllo sul destino dei geni stessi cosicché, poco tempo dopo l’inizio della trascrizione del codice genetico, i processi significativi dello sviluppo non interessano più solamente il livello molecolare, ma quello sovraordinato in cui avviene un’interazione fra membrane e fibre cellulari ripiegate o fra raggruppamenti e strati di cellule, che agiscono come complemento dei geni. Non vi è dubbio, cioè, che il codice genetico agisca come la matrice che può generare infinite copie identiche di giornali, cosicché la trasmissione delle funzioni viventi viene assicurata in maniera assai affidabile attraverso le molteplici replicazioni cellulari. Tuttavia questo non spiega interamente la formazione dei complessi organismi pluricellulari. Il fatto è che i geni, seppure essenziali, non possiedono, in se stessi, alcuna funzione vivente; il loro “codice” deve essere interpretato all’interno della chimica cellulare, della fisiologia e delle abitudini di vita all’interno dell’intero organismo (Srb, Owen, Edgar 1965; Waddington 1966). I geni possiedono significati diversi in diverse forme di vita. Sono come animali domestici in una fattoria di strutture cellulari e, man mano che l’evoluzione procede, essi certamente mutano, adattandoli alle modalità di “allevamento” intracellulare (Grant 1977). Si è ipotizzato che l’evoluzione degli animali sociali operi attraverso geni per l’ “egoismo” o per l’ “altruismo” (Dawkins 1976); ma questi sono concetti che si applicano alla personalità umana, e qualsivoglia egoismo o altruismo il gene possa avere gli viene attributo dalla persona nella quale si trova. Da questo punto di vista è la persona a causare il tratto ereditario o genetico (Trevarthen, 1997, tr. it. 1998, p. 4). • Anche Gabbard (2000, tr. it 2002) evidenzia “che vi sono nella vita periodi definiti durante i quali l’espressione di un gene è dipendente da un certo tipo di influenza ambientale”. – L’impatto dei fattori ambientali spiega le differenze fenotipiche e la discordanza di molte malattie tra gemelli monozigoti. Egli cita alcuni esprimenti: – È stato osservato che in una colonia di scimmie il 20% che manifestava una vulnerabilità genetica alla separazione dalla madre (rilevata in base alle reazioni depressive sviluppate in seguito a brevi separazione e al conseguente aumento del cortisolo e di ACTH). Se queste scimmie venivano affidate a madri particolarmente accuditive riuscivano a integrarsi perfettamente nel gruppo tanto da raggiungere i vertici della gerarchia sociale. – Rosenblum e Andrews (1994) assegnarono piccoli di scimmia casualmente a madri normali e madri rese ansiose da un programma di alimentazione imprevedibile. Le scimmie che erano state accudite da madri ansiose mostravano una diminuita capacità di interazione gruppale ed erano socialmente subordinati, che tuttavia si manifestava quando stavano diventando adulte, confermando l’ipotesi psicoanalitica che disturbi della prima fase dello sviluppo si manifestano in periodi evolutivi successivi. – In Finlandia alcuni ricercatori hanno dimostrato che la terapia psicoanalitica può avere un impatto significativo sul metabolismo della serotonina. Un paziente di 25 depresso e affetto da un disturbo borderline di personalità dopo un anno di psicoterapia presentava, pur senza aver assunto farmaci, una captazione della serotonina normale. Quindi, l’esperienza mentale può influenzare la biologica e viceversa. Se ne deduce che ogni tipo di intervento (educativo, psicologico, psichiatrico, medico) va considerato come “biopsicosociale”. - Ad esempio, i farmaci usati nella psichiatria hanno anche un effetto “psicologico” e gli interventi “psicoterapeutici” influenzano il cervello al di là del loro impatto psicologico. ripensare il rapporto natura-cultura – Il rapporto mente-cervello non è una questione di aut-aut, ma di et-et. – Gabbard parla di una “deplorevole tendenza verso la dicotomizzazione” in cui da un lato si mettono i disturbi di stampo psicologico e dall’altro quelli di origine biologica (da curare farmacologicamente). Questa suddivisione in un approccio biologico e uno psicologico non risponde più alle conoscenze che si stanno acquisendo nell’ambito delle neuroscienze, alla plasticità del cervello, al fatto che i modelli mendeliani dell’ereditarietà non si applicano alle malattie mentali. Pur dovendo preesistere un sostrato genetico che predispone all’insorgenza di una certa malattia mentale, gli studi sulla plasticità cerebrale mostrano che le modalità di sviluppo cellulare non sia regolato solo dai geni, ma ci sia una forte dipendenza da segnali ambientali (Hyman 1999). - Nell’ambito della medicina si assiste a una grande rivalutazione degli aspetti educativo-sociali (arte-terapia, sorrisoterapia, pet-terapia, musico-terapia ecc.), perché si è visto che sono in grado di migliorare assai il benessere del paziente, non solo sul versante “psicologico”, ma anche nella sua capacità di reagire “fisicamente” alla malattia. Centralità dell’emotività • Trevarthen sostiene anche che le emozioni sono regolatrici delle attività psicologiche, non i loro prodotti: «sono cause, non effetti, della percezione e dell'azione». Anche Greenspan e Brazelton, nel loro testo del 2000 (tr. it. 2001) I bisogni irrinunciabili dei bambini, affermano qualcosa di simile a proposito delle emozioni e del Sé: Greenspan: «L’organizzazione delle emozioni si sviluppa prima del controllo motorio. A ogni stadio della crescita cognitiva corrisponde uno stadio precedente nella sfera affettiva che anticipa le interazioni col mondo fisico. Questa organizzazione delle emozioni rappresenta la prima modalità che il bambino ha di acquisire una conoscenza del mondo, e dà avvio alla costruzione del pensiero. Allo stesso modo, è da qui che comincia a delinearsi il senso di Sé, che necessita della consapevolezza di un confine tra le proprie emozioni e quelle che provengono dall’esterno. Anche questa consapevolezza ha le sue radici necessariamente nelle relazioni interpersonali. Non si può fare un esame di realtà senza il senso di sé. Tutto questo comincia nel primo anno, ma poi il bambino lo esplicita, simbolicamente, nel secondo e nel terzo anno, utilizzando parole che hanno un significato affettivo: ‘dammelo’ e ‘no, non puoi averlo’. Ogni interscambio del genere ha un ‘io’ e un ‘tu’ e crea un confine simbolico». Brazelton: «Credo che anche l’intenzionalità cominci nell’utero. I neonati hanno un’intenzionalità» (p. 11) L’uomo come essere biologicamente incompleto L’uomo può essere definito come il primate che emerse in quella determinata fase dell’evoluzione in cui la determinazione istintiva scese al minimo e lo sviluppo del cervello raggiunse il massimo. Fromm (1973) • Ha pertanto bisogno di stabilire dei nuovi legami affettivi con i suoi compagni, senza i quali soffrirebbe di un forte isolamento e smarrimento. Ha bisogno di rimettere radici (Fromm 1973). L’uomo – di qualsiasi età e civiltà – è messo di fronte alla soluzione di un eterno problema: il problema di come superare la solitudine e raggiungere l’unione (Fromm 1956). • Un’intera tradizione di pensiero (che parte da J. G. Herder e giunge fino a Geertz), sostiene che l’uomo è un essere biologicamente incompleto. – Per riferirsi a questa caratteristica dell’uomo, oggi si usa anche il termine neotenia, mutuandolo dalla biologia, per riferirsi alla minor specializzazione dell’uomo rispetto ad altri animali e alla conseguente maggior adattabilità ambientale. • L’azione quasi-meccanica dell’istinto animale nell’uomo si allenta: l’istintualità umana non è autosufficiente, tanto che il piccolo dell’uomo ha bisogno di molte più cure e per molto più tempo di tutti gli altri animali. – La psicoanalisi di Freud è basata sulla differenza fra la «pulsione» e l’ «istinto». Quest’ultimo allude a qualcosa di interamente predeterminato; la pulsione, pur avendo un sostrato biologico, è più indeterminata, più plasmabile, sublimabile ha bisogno di «oggetti» da «investire» (→ investimento oggettuale). Freud la chiama «libido»: la libido evolve e si struttura lungo il percorso di vita. Freud riconobbe l’esistenza di tappe particolarmente importanti lungo tale percorso, tappe che appartengono ai primi anni di vita (fase orale/anale/genitale) – Erich Fromm distingue le «pulsioni» dalle «passioni»: infatti, a suo parere, anche gli animali hanno «pulsioni» (fame, protezione, sessualità, attaccamento); le «passioni» sono invece tipicamente umane perché rappresentano le risposte al dilemma fondamentale della vita umana: Le passioni fondamentali dell’uomo non sono radicate nei suoi bisogni istintivi, ma nelle specifiche condizioni dell’esistenza umana, nel bisogno di trovare, dopo la perdita della correlazione dello stadio preumano, una nuova correlazione tra l’uomo e la natura (Fromm, 1955) • La differenza risiede nel fatto che l’animale vive le pulsioni come qualcosa che sono tutt’uno con il suo appartenere all’ordine naturale. • Invece l’uomo si «stacca» dalla natura: è, sì, ancora parte della natura, ma anche separato: non angelo, non animale. • Tale mancanza di autosufficienza del funzionamento istintuale umano richiede che l’uomo trovi all’esterno – nei rapporti sociali, nella cultura (intesa in senso lato) – una dimensione dove poter trovare dei criteri per risanare la rottura dell’impulso, per sapere come agire e chi è. – La cultura è la seconda natura dell’uomo. (Remotti 2000). – La cultura è necessaria, secondo tale concezione, perché l’uomo non è dotato di un corredo istintuale che, al pari di quello degli animali, possa indirizzarlo e guidarlo: egli ha bisogno della cultura per sapere cosa deve fare. Se non riuscisse a mettersi in rapporto con un sistema capace di dare senso alla sua esistenza sarebbe un essere paralizzato (E. Fromm 1941). – Il patrimonio culturale acquisisce uno status oggettivo, costituisce un corpus di valori e conoscenze che dialoga con i meccanismi mentali degli esseri umani, strutturandoli. Ogni volta che un elemento culturale si è prodotto entra a far parte della «cultura»: non viene perso, ma capitalizzato: la cultura arricchisce le possibilità di scelta dell’uomo fornendogli un patrimonio non solo di strumenti mentali e tecnologici, ma anche di significati e di visioni del mondo, che costituiscono una «esternalizzazione” dei loro processi mentali, una ricchezza oggettivamente presente a cui le menti degli individui possono attingere (Wilson- Keil, 1999). L’interiorizzazione delle attività radicate socialmente e sviluppate storicamente è l’aspetto caratteristico della psicologia umana, il fondamento del salto qualitativo dalla psicologia animale a quella umana. […] I processi psicologici, così come avvengono negli animali, di fatto cessano di esistere; essi sono incorporati in questo sistema di comportamento e sono ricostruiti culturalmente e sviluppati fino a formare una nuova entità psicologica. Vygotskij (1930-1935, p. 88) • l’uomo, quindi, «emerge» dall’indifferenziazione con la natura, diventa individuo, cosciente di sé, e solo: egli vive «in prima persona», non più come parte di un qualcosa, della Natura: egli è «individuato» e non può, neanche da ubriaco, cedere la propria individualità. Questa lo perseguita, come un dono, ma anche come un maleficio e una tortura. • L’uomo è costretto a diventare un «traditore» (Jung) in quanto deve tradire i rapporti di appartenenza; e, come i traditori, si guarda sempre alle spalle… Albero della Conoscenza del Bene e del Male Lucas Cranach detto il Vecchio (1472 –1553) Fromm interpreta la cacciata dal Paradiso terrestre come l’esito di un essere diventato consapevole di sé dell’uomo: egli ha mangiato dall’Albero della conoscenza e da quel momento diventa cosciente di sé, si vergogna della propria nudità e non può più restare nella beata, ma incosciente, appartenenza con tutte cose che si respira nel Paradiso terrestre. • L’uomo diventa inquieto perché, da un lato, non può abbandonarsi e appartenere totalmente, perché ciò gli farebbe perdere il suo essere individuo; dall’altro la sua separatezza gli crea disagio, senso di isolamento, paura. • Ecco perché per Fromm la libertà è dono ambiguo che occorre accettare con coraggio: dà all’uomo autonomia, ma gli toglie sicurezza. – Fuga dalla libertà (1941) è costruito attorno all’idea che gli uomini, inconsciamente, rinuncino alla libertà e si leghino a feticci o ideologie. → l’ambiguità dell’essere umano è che egli cerca contemporaneamente autonomia e appartenenza • L’uomo inizia a provare nostalgia per la Natura da cui proviene e la percepisce come una Grande Madre avvolgente. • Se, come evidenzia Fromm, non vuole «impazzire» per la sensazione di separatezza deve ristabilire dei legami, delle appartenenze. • Ma l’appartenenza va ottenuta senza rinunciare all’individualità e alla separatezza; se appartenesse «troppo», cederebbe nuovamente la sua identità, si rifonderebbe nel tutto, come avviene nelle appartenenze tribali, fusionali, nell’adorazione di un’ideologia ecc. • Questo essere dentro e fuori dalla natura genera quella sensazione di innaturalezza del comportamento umano. Se amassi i paradossi, potrei affermare che è naturale per l’uomo comportarsi in maniera innaturale. Róheim (1950, p. 498) Dewey, nel suo Arte come esperienza (cap. 1), afferma che l’arte ambisce a ritornare all’istintività animale, all’essere un tutt’uno con l’esperienza che si va compiendo. Per afferrare le fonti dell’esperienza estetica è perciò necessario ricorrere alla vita animale al di sotto della scala umana. Gli atti della volpe, del cane e del tordo possono valere almeno a ricordare e simboleggiare quella unità dell’esperienza che noi frazioniamo tanto, quando il lavoro diventa fatica, e il pensiero ci astrae dal mondo. L’animale vivo è pienamente presente, tutto là, in ognuna delle sue azioni: nelle sue occhiate caute, nel suo annusare accorto, nel suo drizzare gli orecchi improvvisamente. Tutti i suoi sensi indistintamente stanno sul chi vive. Se state attenti, vedete il movimento confondersi con la sensazione e la sensazione con il movimento, determinando quella grazia animale con la quale all’uomo riesce così difficile gareggiare. • Pirandello affermava che l’uomo è come se avesse la “febbre” Sì, perché un cane, poniamo, quando gli sia passata la prima febbre della vita, che fa? mangia e dorme: vive come può vivere, come deve vivere; chiude gli occhi, paziente, e lascia che il tempo passi, freddo se freddo, caldo se caldo; e se gli danno un calcio se lo prende, perché è segno che gli tocca anche questo. Ma l’uomo? Anche da vecchio, sempre con la febbre; delira e non se n’avvede; non può fare a meno d’atteggiarsi, anche davanti a sé stesso, in qualche modo, e si figura tante cose che ha bisogno di creder vere e di prendere sul serio (Pirandello, L’umorismo, 1908). L’uomo si annoia e l’animale no O greggia mia che posi […] Quanta invidia ti porto! Non sol perché d'affanno Quasi libera vai; Ch'ogni stento, ogni danno, Ogni estremo timor subito scordi; Ma più perché giammai tedio non provi. Quando tu siedi all'ombra, sovra l'erbe, Tu se' queta e contenta; E gran parte dell'anno Senza noia consumi in quello stato. Ed io pur seggo sovra l'erbe, all'ombra, E un fastidio m'ingombra La mente, ed uno spron quasi mi punge Sì che, sedendo, più che mai son lunge Da trovar pace o loco. E pur nulla non bramo, E non ho fino a qui cagion di pianto. Quel che tu goda o quanto, Non so già dir; ma fortunata sei. Ed io godo ancor poco, O greggia mia, né di ciò sol mi lagno. Se tu parlar sapessi, io chiederei: Dimmi: perché giacendo A bell'agio, ozioso, S'appaga ogni animale; Me, s'io giaccio in riposo, il tedio assale? (Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia) • Per G. Róheim, il complesso di Edipo non è un evento innato della psiche, ma un inevitabile processo umano che trova la sua ragion d’essere nel prolungamento della condizione infantile di dipendenza dalla madre. Infatti, il complesso edipico nasce dal conflitto tra la naturale tendenza a crescere ed il desiderio di restare, simbolicamente, nell’utero materno. • È nostalgia per un’appartenenza totale. – Di tale idee sono anche E. Fromm e C. G. Jung • La “simbiosi”, il “narcisismo primario”, la “fase autistica” del neonato su cui hanno insistito molti psicoanalisti oggi sono concetti non più sostenibili dalla moderna scienza psicologicoevolutiva. • Ha tuttavia senso parlare di momenti “simbiotici” di fusione fantasticata tra rappresentazioni di sé e rappresentazioni dell’oggetto in situazioni d’intensa attivazione affettiva (Kernberg 2005, pp. 90-91). → la ricerca dell’ «oggetto totalmente soddisfacente» Spiega G. Róheim: • L’essere umano vuole crescere ma, contemporaneamente, non tollera “la separazione, sempre prematura, dalla madre” (1950, p 491). • La cultura, freudianamente, è per Róheim un tentativo di attingere in maniera sublimata al soddisfacimento pulsionale; ma a tale dimensione se ne aggiunge un’altra, quella che richiama l’uomo al ricordo dei beati momenti dell’onnipotenza infantile e, inevitabilmente, ai connessi sentimenti di solitudine e di perdita: “il grande pericolo contro cui il genere umano ha sviluppato la cultura è la perdita oggettuale, l’essere lasciato solo al buio” (1943, p. 91). • In tale visione concettuale, la natura umana si trova in “una situazione conflittuale fra due tendenze, regressione e maturazione” (p. 511); ciò costituisce l’aspetto “tragico” dell’uomo. • Cedere alla regressione significherebbe rinunciare all’identità, al compito di umanizzazione che ognuno porta con sé; significherebbe ridiventare l’uomo tribale, l’uomo fuso con la Natura, rinunciare alla libertà. → Per Fromm l’alternativa è: produttività o fuga dalla libertà? Accettare la sfida a cui l’essere umano si trova di fronte per progredire verso la costruzione di una dimensione propriamente umana, basata sulla solidarietà e sulla produttività a tutti i livelli (emotivo, cognitivo, artistico ecc.) oppure legarsi a dei feticci, regredire verso forme simbiotiche di appartenenza? • L’uomo deve ‘inventare’ la sua umanità, deve escogitarla e crearla dal nulla; nascendo si assume l’onere di ‘diventare’ umano. Scrive Francesco Remotti. Diventare umani è un compito a cui gli esseri umani non possono sottrarsi: l’umanità non è data e garantita biologicamente: esige invece di essere costruita culturalmente. Essa non è un presupposto, se non in minima parte: è invece un telos, una meta, un qualcosa che va cercato (e non è detto che venga raggiunto): più radicalmente un qualcosa che va inventato (Remotti 2000).
Scaricare