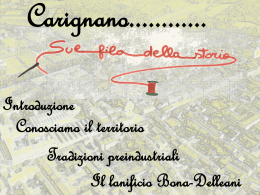Luisa Cigagna TRAME DI VITA E LAVORO: LE OPERAIE DEL LANIFICIO PAOLETTI DI FOLLINA (1795-1982) Laurea Vecchio Ordinamento Trame di vita e lavoro: le operaie del Lanificio Paoletti di Follina (1795-1982) 253 INDICE DELLA TESI IL PERCHÉ E IL COME DI UNA RICERCA CENNI STORICI • La lavorazione della lana nel Trevigiano • Uno sguardo comparativo: gli altri poli lanieri della Regione Veneto LO SVILUPPO INDUSTRIALE • Attività proto-industriali e industriali a Follina • Permanenze e trasformazioni nel XIX secolo • La società di Mutuo Soccorso • Il Vittoriese nel XIX secolo IL LANIFICIO PAOLETTI • La nascita del Lanificio e le vicende Ottocentesche • L’azienda e le sue dimensioni nella prima metà Novecento • Dal paternalismo alla sindacalizzazione • La colonia marina di Jesolo GLI ANNI DELLA MEMORIA: DAL 1945 AL 1982 • Dalle macerie della guerra alla ricostruzione • Il ruolo e l’importanza del Settore Laniero per la ripresa economica del Paese • Le condizioni di vita della popolazione • Il Secondo Dopoguerra a Follina • L’azienda dal Secondo Dopoguerra agli anni Sessanta • Andamento generale del Settore Laniero (1951-1971) • L’evoluzione del Tessile/Abbigliamento • Luci e ombre del “miracolo economico” in Provincia di Treviso • Il lanificio Paoletti negli anni del “boom” • Trasformazioni economiche, sociali e culturali • Dal 1965 alla crisi petrolifera • Turbolenze e innovazioni degli anni Settanta • Il crepuscolo degli anni Ottanta 254 L. CIGAGNA LA REALTÀ FEMMINILE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Vite di donne tra fabbrica e famiglia La dimensione “etica” del lavoro e il laburismo veneto Il lavoro delle donne: tra protezione ed eguaglianza Il valore del lavoro Strategie sociali e familiari fuori e dentro la fabbrica Lavorare in fabbrica? Una fortuna! Lavorare vuol dire “uscire di casa” La fabbrica: una rete di relazioni Come si impara il lavoro Reparti, turni di lavoro, salari Il cottimo Padroni, capi, disciplina Presenza femminile: percentuali e ruoli Condizioni di lavoro e rischi d’infortunio Nubilato, matrimonio, famiglia Gravidanza e maternità Un doppio lavoro: in casa e in fabbrica La gestione del denaro Orgoglio e soddisfazione del proprio lavoro Conclusioni LE TESTIMONIANZE – Le interviste alle operaie Bibliografia Pagine web consultate Ringraziamenti Trame di vita e lavoro: le operaie del Lanificio Paoletti di Follina (1795-1982) 255 Sintesi della tesi La storia di Follina come polo industriale attivo fin dal XII secolo, dalla fine dell’800 si è caratterizzata per una considerevole presenza di lavoro femminile nei lanifici. Un’esperienza rilevante non soltanto per il contributo economico dato alle famiglie, ma per il valore simbolico che il lavoro femminile ha rappresentato in questa comunità di lunga tradizione industriale. Una particolarità, considerando il contesto geografico di un territorio pedemontano caratterizzato prevalentemente da un’economia di tipo agricolo. Uno degli obiettivi della ricerca è stato quello di verificare se l’attività di lavoro continuativa di queste donne abbia prodotto qualche segnale di emancipazione precoce per le operaie stesse e quali siano stati i cambiamenti e le trasformazioni che questo lavoro femminile ha prodotto a livello familiare e nella struttura sociale del paese. L’esperienza continuativa di lavoro in fabbrica di queste donne, il valore economico del loro stipendio, hanno rappresentato una risorsa che non è stata mai studiata e valorizzata, pur essendo la componente e la consistenza di lavoro femminile all’interno della fabbrica maggioritaria rispetto a quella maschile. Una pratica che si è conclusa con il passaggio a nuove forme di produzione e di organizzazione del lavoro avvenute negli anni Sessanta del ‘900. La ricerca ha intrecciato archivi orali e cartacei, in questo modo è stato possibile ricostruire non soltanto le vicende di lavoro delle operaie, ma anche l’andamento dell’azienda e del settore laniero italiano nell’arco di tempo considerato. Dalla ricerca è emersa in tutta la sua evidenza la centralità per le famiglie del contributo economico dato dal lavoro femminile, in una stagione della nostra storia difficile come quella ricostruzione post-bellica e precedente all’avvio del boom economico. Tuttavia il lavoro femminile ha continuato a rappresentare, anche successivamente, la possibilità di una maggior scolarizzazione per i figli e di una mobilità sociale precoce rispetto ad altri paesi e a situazioni familiari del paese. Un contributo allo sviluppo economico e sociale di Follina di cui fino ad oggi non si era dato conto ma che rientra a tutti gli effetti nella storia di questa comunità. ANNO ACCADEMICO: 2006-2007 RELATORE: Prof.ssa Nadia Maria Filippini CORRELATORI: Prof.ssa Bruna Bianchi, Prof. Danilo Gasparini 256 L. CIGAGNA INTRODUZIONE Follina è un piccolo comune della provincia di Treviso a ridosso delle Prealpi Bellunesi e a metà strada tra Vittorio Veneto e Valdobbiadene. Nel passato è stato rinomato centro per la produzione di panni lana e sede di un’antica e importante Abbazia cistercense. Ancor oggi il paesaggio e il contesto urbano trasmettono i segni inequivocabili di una vocazione produttiva evidenziata anche nel toponimo che deriva dal “fullone”, la gualchiera ad acqua utilizzata per dare consistenza e morbidezza ai tessuti di lana. Sono state le particolari condizioni ambientali, economiche e istituzionali a legare indissolubilmente il destino di questo luogo alla produzione di panni lana, grazie alla presenza di risorse energetiche quali acqua, abbondanza di materia prima anche se di scarsa qualità, all’ampia disponibilità di manodopera conseguente alla marginalità dell’agricoltura pedemontana, a cui si aggiungeva anche il favore di particolari condizioni politico-istituzionali. – essendo Follina sottoposta al feudo dei Conti Brandolini di Cison di Valmarino. Pare che la lavorazione dei panni lana – follatura e tessitura – siano state introdotte dai monaci cistercensi intorno al XII secolo, insieme ad altre attività artigianali legate alla presenza dei corsi d’acqua. Ma è a partire dal ‘500 che la sinergia tra imprenditori privati e feudatari della zona, crea le condizioni favorevoli per il decollo dell’attività su scala protoindustriale. Nel corso del ‘600 l’arrivo di maestranze straniere e l’applicazione d’innovazioni tecnologiche d’avanguardia, rendono il distretto Follinese uno dei più dinamici e attivi della Serenissima e tale si manterrà fino agli inizi dell’800, quando l’attività tessile risulterà essere la prima fonte di reddito per il paese e la terza – dopo viticoltura e allevamento – per l’intera Vallata. Con il passaggio al Regno Lombardo-Veneto il trend di crescita dei lanifici follinesi continua e nel 1818 sono segnalati nel territorio comunale ben 13 fabbricanti di panni lana anche se “non tutti della medesima rilevanza”, tra i lanifici di piccole dimensioni troviamo anche quello di Gaspare Paoletti, fondato nel 1795. A metà dell’800 il 77% della popolazione era ancora impiegato nell’attività dei lanifici e anche nei paesi vicini la filatura e la tessitura a domicilio erano un’importante fonte di reddito i famiglie locali. Dopo la difficile congiuntura economica della metà del secolo, dovuta ai moti del 1848, ci fu una ripresa, ma non vennero più raggiunti Trame di vita e lavoro: le operaie del Lanificio Paoletti di Follina (1795-1982) 257 i livelli di produzione e impiego di manodopera del precedente periodo. Il distretto follinese cominciò inesorabilmente a declinare e alla fine dell’800 dei tredici lanifici follinesi ne sopravviverà soltanto uno: il Lanificio Paoletti che impiegava circa un centinaio di operai, mentre le altre ditte che ripresero a lavorare, poterono farlo soltanto in maniera artigianale e con dimensioni assai ridotte. I lanifici follinesi, dalle loro origini medioevali fino all’età contemporanea, sono stati oggetto di studi e pubblicazioni che ne hanno indagato la storia e la valenza economica e produttiva, ma fino ad oggi non è stata analizzata – se non parzialmente – la componente umana che nei lanifici ha lavorato: operai e soprattutto operaie, che dalla fine dell’800, con la meccanizzazione dei telai, hanno iniziato a rappresentare la manodopera più numerosa degli stabilimenti . Questa relazione sintetizza parte della ricerca che ha avuto per oggetto la storia contemporanea del lanificio e delle operaie che in esso hanno lavorato a partire dagli anni Quaranta del Novecento fino alla chiusura dello stabilimento avvenuta nel 1982. Le loro vicende di lavoro, le loro storie personali si intrecciano con le trasformazioni che hanno completamente ridisegnato e mutato il destino e la vocazione – non soltanto di Follina – ma anche della nostra Regione. La loro storia, per quanto marginale possa essere stata quella dei lanifici follinesi in un contesto economico e geografico più ampio, ha una sua originalità e una sua specificità territoriale: Follina era infatti l’unico paese della vallata ad avere una industria e una tradizione operaia, in un contesto essenzialmente agricolo. La ricchezza dell’Archivio di fabbrica (Archivio Storico Paoletti) e la disponibilità dei titolari, in primis del Commendator Paolo Paoletti, la memoria delle operaie intervistate, mi hanno permesso di ricostruire con sufficiente ricchezza di dati, le vicende del Lanificio Paoletti e soprattutto di mettere in luce la singolare vicenda delle lavoratrici la cui attività di lavoro in fabbrica costituisce una sorta di eccezione rispetto alle esperienze di lavoro delle altre donne di questo territorio. Dall’intreccio di archivi orali e cartacei (Archivio Storico Paoletti, Archivio Comunale di Follina, Archivio Storico della Camera di Commercio di Treviso, Archivi Contemporanei di Storia Politica di Cà Tron- Fondazione Cassamarca, Archivio Associazione dell’Industria Laniera Italiana di Biella) è scaturito il disegno di questa ricerca storica, che ho chiamato “trame di vita” per l’evidente similitudine tra le traiettorie esistenziali e lavorative di queste donne e la tecnica della tessitura. Partendo da un “ordito” comune a quasi tutte le intervistate (condizione sociale, età, scolarizzazione, situazione familiare, doppia presenza al lavoro e in famiglia), ciascuna di loro, attraverso il proprio percorso di vita e di lavoro, ha spostato sui fili dell’ordito la propria “navetta”, costruendo appunto “trame” diverse. La ricchezza del loro vissuto, il valore della loro fatica per il benessere di tante famiglie mi hanno fatto sentire quasi il “dovere” di documentare la loro esperienza di vita, perché come scrive Nuala O’ Faolain: “Lo facevo un po’ per me stessa (...) e un po’ per offrire una sorta di risarcimento alle mi- 258 L. CIGAGNA gliaia di sconosciute che riempiono i cimiteri e potrebbero benissimo non essere mai nate per quanto gli altri sanno di loro. Muoiono ignorati anche migliaia di uomini, ma per lo meno da vivi hanno avuto un pubblico di ascoltatori in una taverna o sulla piazza di un mercato. Quello che sono stati ha significato qualcosa per il resto del mondo” 1 . 1 O’Faolain N., La Storia di Chicago May, Parma, Guanda 2007, p. 8 Trame di vita e lavoro: le operaie del Lanificio Paoletti di Follina (1795-1982) 259 I PAOLETTI: UNA FAMIGLIA E UN’IMPRESA NELLA STORIA DI FOLLINA Il legame indissolubile di Follina con la lavorazione della lana si riflette nelle vicende e nella storia della famiglia Paoletti che la tradizione vuole giunta a Follina ancora nel XII secolo, a seguito dei monaci, proprio per contribuire all’avvio della lavorazione dei pannilana. Dei “Pauletto” tessitori residenti a Miane si trovano a partire dalla metà del XVII secolo, la famiglia si sposterà però da Miane a Follina soltanto alla fine del ‘700 per avviare , ad opera di Giacomo Paoletti, la piccola attività manifatturiera, mentre sarà il figlio Gaspare a costruire la prima vera “fabbrica” nel 1833, un edificio che si sviluppava su tre piani che – nonostante gli ampliamenti, le modifiche e le distruzioni avvenute a causa delle due guerre mondiali – è tuttora visibile nel cuore del complesso industriale. Nel corso dell’800 il lanificio Paoletti incrementa le proprie potenzialità produttive e – grazie a una moderna cultura industriale e alla solidità finanziaria della famiglia – riesce a uscire indenne dalle turbolenze economiche di fine secolo per rimanere poi l’unica vera industriale di Follina, capace di dare lavoro ad oltre un centinaio di operai. L’utilizzo della forza motrice a vapore ed elettrica avvierà il processo di meccanizzazione della filatura e della tessitura che, sommato alle differenze salariali tra uomini e donne, produrrà il progressivo e massiccio ingresso in fabbrica di manodopera femminile, come è stato confermato dalle interviste al Commendator Paolo Paoletti e dai racconti delle operaie. Con Alessandro Rossi, nel 1877, Gaspare Paoletti sarà uno dei soci fondatori – insieme a industriali del calibro dei vicentini Marzotto e Cassola e dei follinesi Colles e Andretta che avevano stabilimenti di dimensioni considerevoli e davano lavoro a centinaia di operai – dell’Associazione Laniera Italiana, nata per “patrocinare e promuovere” gli interessi dell’industria laniera italiana e per diffondere tra i soci una moderna cultura industriale e imprenditoriale. Il dato è interessante perché spiega lo “stile imprenditoriale” di una famiglia che si sempre contraddistinta nel territorio per senso di responsabilità sociale e per spirito d’innovazione. Una famiglia che ebbe fin dalle vicende risorgimentali della metà dell’800 un ruolo nelle vicende politiche italiane, sotto il LombardoVeneto per le simpatie risorgimentali e poi nel neonato Regno d’Italia, tanto che il primo sindaco “italiano” di Miane, nel 1866, fu proprio un Paolo Paoletti. L’interesse per la vita politica farà ricoprire a Gaspare Paoletti il ruolo di consigliere comunale negli anni precedenti la Grande Guerra, negli anni ’30 Giovanni Paoletti sarà il Podestà di Follina, mentre il Commendator Paolo Paoletti rimarrà in carica come sindaco di Follina dal 4 giugno 1957 al 2 dicembre 1966. Si può facilmente comprendere che in un paese di poco più di tremila abitanti il ruolo e il peso di questa famiglia andasse oltre quello imprenditoriale e avesse una valenza molto più ampia, anche in relazione alla selezione del personale e ai rapporti all’interno della fabbrica. Particolare attenzione meritano poi le numerose iniziative “benefiche” e filantropiche a favore dei propri dipendenti che i Paoletti attuarono fin dall’inizio della loro attività imprenditoriale: dalla co- 260 L. CIGAGNA struzione del piccolo villaggio operaio in via Cartera, allo spaccio aziendale, dalla costituzione della “banda” aziendale, al finanziamento del locale “dopolavoro”, alla “colonia marina” di Jesolo per i figli degli operai, alle “liberalità” messe in atto in occasione di matrimoni o di particolari situazioni di difficoltà. Una forma “paternalismo” illuminato, che deriva da una concezione positiva di questo termine, e che si fonda sulla consapevolezza dei limiti del potere imprenditoriale ma anche sulla coscienza di “dovere” ai propri dipendenti qualcosa di “più” del solo salario, anche in contesti di massima debolezza contrattuale da parte dei lavoratori. 2 Paternalismo che – secondo le più recenti acquisizioni storiografiche – si configura come una “relazione di scambio”, una “forma di contrattazione” tra datore di lavoro e lavoratore utile alla formazione del consenso aziendale ma fondata anche su un reciproco vantaggio economico. 3 Una strategia di gestione dei rapporti umani all’interno dell’azienda, svincolata dal riconoscimento di organizzazioni o rappresentanze sindacali, anzi fortemente antagonista ad esse; frutto di una visione “arcaica” della gestione della manodopera ma capace di resistere e sopravvivere fino alla metà del ‘900 e di riemergere con particolare vigore soprattutto in concomitanza a fasi di ristrutturazione produttiva e di razionalizzazione aziendale. Dopo centoottantasette anni di attività ininterrotta (considerando che anche durante la Grande Guerra il Lanificio per continuare la produzione si era trasferito nel biellese e che durante la Seconda Guerra Mondiale aveva comunque continuato l’attività grazie al lavoro femminile) e dopo aver saputo rinnovarsi e resistere alle cicliche crisi del settore, il lanificio Paoletti cesserà la sua produzione nel dicembre del 1982. Per il paese fu un duro colpo, quasi uno choc, nonostante si fossero sviluppate nel frattempo molte attività artigianali e di piccola industria, perché veniva a mancare un’attività produttiva secolare, radicata nel vissuto e nell’immaginario dei follinesi come una presenza privilegiata e rassicurante. Per volontà dei figli di Paolo Paoletti, Andrea e Giovanni, l’attività riprese alla fine del 1983 e continua tutt’ora, nonostante le turbolenze economiche e le pesanti incognite che incombono sul settore tessile a causa della globalizzazione. VITE DI DONNE TRA LAVORO E FAMIGLIA Non è stato facile dipanare la matassa dell’esperienza di vita delle intervistate per rintracciare in maniera autonoma il senso di ciò che la vicenda lavorativa ha rappresentato e costituito per loro. Il rapporto che le donne hanno stabilito con il loro lavoro è complesso, ambiguo e spesso contraddittorio. Cristina Borderìas definisce questa ambiguità come “difficoltà di rispondere e a identificarsi Bertucelli L., Il paternalismo industriale: una discussione storiografica, in merlino.unimo. it/web_dep/materiali_discussione/0257.pdf, pp. 5-9 3 Bairati P. Sul filo di lana. Cinque generazioni d’imprenditori. I Marzotto, Bologna, Il Mulino, 1986 2 Trame di vita e lavoro: le operaie del Lanificio Paoletti di Follina (1795-1982) 261 con logiche contraddittorie ed esercizi di valori radicalmente contrapposti come sono quelli del mondo della produzione e riproduzione. ” Ma anche come necessità a mantenere con la propria vita un carattere di “relazione globale sia a livello di pratiche materiali che di rappresentazioni identitarie ” 4 La sensazione che avvertivo nettamente negli incontri era quella di un rifiuto non espresso ma chiaramente percepibile di “pensarsi unicamente in una posizione familiare o unicamente in una posizione professionale (...) in obbedienza al desiderio di parlare della loro famiglia senza mettere da parte il lavoro e parlare dell’esperienza lavorativa senza separarla dal contesto familiare”. 5 Durante gli incontri, superata la prima fase nella quale spiegavo il motivo del mio studio, il risvolto soggettivo della loro esperienza di lavoro veniva messo in secondo piano, sorpassato per importanza dalle vicende familiari, delle quali venivano fatte descrizioni ampie ed emotivamente coinvolgenti. La ridefinizione della loro identità attraverso il lavoro procedeva quindi per vie tortuose, oppure avveniva a sorpresa in affermazioni che emergevano da contesti apparentemente neutrali o lontani dal discorso principale. Soltanto verso la fine del colloquio o nell’incontro successivo si poteva scendere al di sotto del livello di guardia e magari sentirsi raccontare qualche episodio che andava ad intaccare le affermazioni “politicamente corrette” espresse in precedenza, in quel caso però la richiesta era sempre quella di spegnere il registratore, perché quanto si andava a dire non venisse documentato ufficialmente e perché queste donne hanno piena consapevolezza del loro ruolo sociale ed era palese la loro volontà di mantenersi fedeli ad un’immagine e ad una parte vissuta e interpretata lungo tutta la loro esistenza e soprattutto di non mettere in discussione i ruoli e la società e nella quale sono vissute. Tuttavia, nello spazio relazionale che si era instaurato, la “confidenza” consentiva disvelamenti di sé a volte sconcertanti; ecco allora che uscivano dai cassetti della memoria spezzoni di pellicola pieni di una carica emotiva ancora vivissima e dirompente, letture del passato a volte crude e disincantate, ma sempre lucidissime e vere. Il racconto trasmetteva allora il costo umano e personale delle operazioni di neutralizzazione dei conflitti, la consapevolezza di aver subito e accettato qualche ingiustizia, per la reale impossibilità di agire diversamente in un contesto sociale e familiare nel quale la subalternità femminile era un dato di fatto indiscutibile; subordinazione ad autorità e gerarchie alla quale non erano estranei neppure i loro compagni uomini, condizionati al pari delle donne dalla struttura sociale ed economica. Le interviste sottolineano la complessità delle traiettorie femminili, complessità che è sempre frutto di continue contrattazioni dei propri progetti personali con quelli del resto dei membri della famiglia e della famiglia stessa come nucleo. Riuscire a capire questa complessità permette di leggere le scelte effettuate in 4 Borderìas C. Strategie della libertà. Storie e teorie del lavoro femminile, Roma, Manifestolibri 2000, pp. 74-86 5 Ibidem, pp. 205-206 262 L. CIGAGNA una chiave temporale più ampia di quella del momento storico nel quale sono avvenute: una pratica, un comportamento che al momento può sembrare frutto di un atteggiamento conservatore, alla lunga invece può rivelarsi una strategia più adeguata di autonomia per sé o per la propria discendenza, una sorta d’investimento a lungo termine. 6 Il lavoro dunque ancora come elemento a doppia valenza: come etica di vita, ma anche come strumento di realizzazione di strategie lunghe di mobilità sociale, capace di assumere altri significati rispetto a quello di partenza di “destino ineluttabile”. La famiglia è il perno dell’esistenza di queste donne: una famiglia onnipresente, centro dei discorsi e delle decisioni, luogo delle memorie e delle sofferenze, ambito nel quale si perpetuano ruoli e valori e si concordano strategie economiche e sociali.. Sono tanti tipi di famiglia incontrati: possono essere “famiglie patriarcali,” rette con pugno di ferro e scarsa equità da suocere che avevano una mentalità “del Settecento”; “famiglie estese”, dove zii celibi e zie nubili sono figure estremamente positive e sostitutive in tutto e per tutto dei genitori; “famiglie nucleari”, dove marito e moglie riproducono ancora il ruolo di subordinazione della donna nonostante la valenza del suo contributo economico. La famiglia e le reti di vicinato svolgono nella vita di queste donne un ruolo essenziale, supplendo alla carenza di servizi e di sostegni assistenziali pubblici, sostenendo le donne nei momenti di difficoltà, consentendo loro di andare al lavoro con serenità. La famiglia recupera ed eroga forze e risorse, ma è anche un vortice di impegni e di doveri per la legge del contraccambio, dal momento che il ruolo di assistenza e di cura è appannaggio tutto femminile. Ecco che allora, quando il parente anziano si ammala, è la donna che rinuncia al lavoro e che torna fra le pareti domestiche a svolgere il suo dovere primario. Dal fitto scambio di relazioni, famiglia e comunità escono rafforzate e continuamente rinnovate. La famiglia diventa un punto di appoggio essenziale nel caso della ricerca o della perdita dell’impiego e permette di immettersi nel mercato di lavoro con maggior oculatezza e in tempi anche lunghi, poiché la somma dei redditi di più persone e a volte anche di più attività in settori diversi (anche se precarie) consente di mantenere livelli di vita accettabili. La famiglia è quindi entità economica che produce consumo e risparmio e che permette di indirizzare le risorse collettive verso obiettivi comuni (costruirsi la casa propria, mandare i figli a scuola), anche se in molti casi l’ultima parola spetta agli uomini. Il modello femminile tradizionale non viene mai messo in discussione dalle donne intervistate, l’accettazione dei modelli di vita provenienti dalla famiglia e dalla società – consapevole o inconsapevole – è piena e totale, anzi, sono quasi orgogliose di avervi aderito (senza nascondere magari amare disillusioni), convinte di aver fatto la cosa giusta. Non esistevano alternative possibili, non erano contemplate: l’obbedienza, la sottomissione, la dedizione, sono aspetti della personalità coltivati, a volte anche a dispetto di umiliazioni e di grandi soffe6 Borderìas C., op. cit. p. 172 Trame di vita e lavoro: le operaie del Lanificio Paoletti di Follina (1795-1982) 263 renze. Nelle interviste, l’incombenza dei lavori domestici e il dovere di cura dei propri cari come appannaggio esclusivamente femminile – anche se la donna lavora fuori casa – non viene mai assolutamente messo in discussione: è un dato di fatto, un dovere “naturale” insito nel loro essere nate donne. Un’operaia dice quasi con rabbia di non sopportare le donne di oggi, perché “non sono capaci di adattarsi a fare sacrifici”. Per queste donne l’essenza della femminilità è quella tradizionale e riflette i ruoli e l’immagine muliebre della generazione che le ha precedute; la madre, le zie sono l’esempio, il modello a cui ispirarsi, anche se si riconosce che tra una generazione e l’altra ci sono stati considerevoli cambiamenti, dei veri e propri “salti” in avanti. Solo qualcuna ammette che “non era fatta per stare a casa” o ha tentato operazioni di rinnovamento che hanno provocato severe condanne al di fuori del proprio ambiente familiare. A questo proposito un’operaia racconta che quando è andata a conoscere la famiglia del marito che era di origine contadina, li ha scandalizzati e ha scatenato le invidie delle cognate perché “fumava, era magra e vestita bene, con una gonna plissettata e la camicetta di sangallo tutta trasparente, abbastanza scollata e senza maniche”. Questo suo modo di essere ne decreta l’ostracismo e la severa condanna morale della famiglia del fidanzato, che farà di tutto per posticipare all’infinito il loro matrimonio perché lei “era la signora da Follina: capricciosa, viziata, “tanto ciapa e tanto magna”. Ancora una volta la diffidenza e l’ostilità fra mondo contadino e mondo operaio emerge con forza, anche se l’esiguità dell’esperienza follinese non sarà in grado di fornire alle operaie e agli operai né la coscienza né la forza di una lotta di classe, capace di tradursi in cambiamenti sociali radicalmente diversi da quelli della campagna veneta. Nei racconti di queste donne ci sono tante storie diverse, tanti quanti sono i tipi di famiglia incontrati, storie differenti anche per il tipo di rapporto familiare vissuto sereno o di forte conflitto sia con i parenti che con il marito. Ci sono anche storie d’amore che fanno tornare in mente i fotoromanzi degli anni Quaranta per il linguaggio figurato con il quale vengono raccontate, vicende contrastate ma a lieto fine. In generale l’affettività coniugale è celata, o non compare affatto, i sentimenti che si possono esprimere sono quelli verso i figli, o i genitori quando gravi malattie o lutti fanno cadere la cortina di omertà sui sentimenti tipica della cultura di quelle generazioni. Attraverso le microstorie delle operaie intervistate, si ripercorrono tutte le trasformazioni della nostra società e gli effetti che esse hanno avuto sui singoli individui. Troviamo la disgregazione delle famiglie patriarcali, la persistenza di famiglie estese tradizionali nelle quali i fratelli e le sorelle non sposati rimangono a vivere in casa facendosi carico dell’educazione dei nipoti quasi più dei genitori biologici; la diffusione delle famiglie nucleari con residenza propria, nelle quali si comincia a parlare di controllo delle nascite, di adesione a nuovi modelli e stili di vita, dove l’investimento sulla scolarizzazione dei figli è un’evidente strategia di mobilità sociale ascendente, della quale si dà conto elencando le fortune e il benessere raggiunto dai figli e dai nipoti. Una trama complessa di 264 L. CIGAGNA vecchio e di nuovo, come sempre accade nelle fasi di cambiamento della società e della storia. L’ETICA LABURISTA La prima forte impressione che si ricava dalle interviste à l’interiorizzazione dell’etica “laburista”, la centralità della dimensione del lavoro (anche di quello familiare) come valore personale e collettivo trasmesso in famiglia fin dalla più tenera età. Qui si trova la conferma del pieno successo dell’operazione di “pedagogia sociale” avviata all’indomani dell’unificazione dello Stato Italiano – ma ampiamente praticata anche nel resto dell’Europa – per arginare i guasti dell’industrializzazione e le derive delle masse operaie, facili prede dell’ ideologia socialista. Lo sviluppo industriale infatti, rompendo gli antichi legami di protezione tra proprietari e dipendenti, aveva lasciato i proletari in balia della crudezza delle leggi di mercato. La fragilità dei ceti meno abbienti poteva diventare pericolosa per l’ordine e la pace sociale, erano quindi necessarie riforme di tipo economico, giuridico e sociale per debellare l’ignoranza e la superstizione e instillare nelle masse l’amore per il lavoro e la rassegnazione e per renderle consapevoli dei nuovi doveri di cittadinanza. I poveri erano per loro natura “oziosi e imprevidenti” per il fascino del benessere mai pienamente raggiunto e “viziosi” perché incapaci di darsi una direzione etica di vita. La miseria non era soltanto una conseguenza della loro condizione sociale inferiore ma era frutto di una “mentalità difettosa” che veniva colpita e segnata dalla giustizia e dall’ordine provvidenziale. Ecco allora che il lavoro diventa “un principio di socializzazione” capace di assorbire la povertà e di organizzare l’ordine sociale. Il lavoro diventa per laici, cattolici e socialisti il “fluido antropologico” che plasma e rinnova l’uomo in profondità e lo rende adatto alla produzione, è la merce di scambio tra l’operaio e l’industriale, è l’elemento di stabilità sociale che permette l’accettazione delle inevitabili disuguaglianze sociali. L’etica del lavoro per fare presa però prevede anche dure sanzioni per chi non vi si conforma: la miseria viene colpevolizzata, se l’indigente non diventa produttivo e indipendente nella sua capacità di consumo (e quindi non contribuisce al successo dell’etica del lavoro) va abbandonato a se stesso. I poveri vanno distinti tra “poveri buoni” – degni di aiuto e sostegno – e “poveri cattivi” che vanno abbandonati al loro destino di reietti. Il lavoro diventa in questo modo principio morale e valore sociale. L’ideologia del lavoro trova il suo pieno compimento agli albori del ’900, quando l’attività lavorativa “continua e retribuita” è il titolo unico ed esclusivo di partecipazione alla vita sociale. È il lavoro a conferire il pieno diritto di cittadinanza e il suo valore è riconosciuto trasversalmente al di là delle differenze ideologiche e di classe. Il lavoro come norma di comportamento completamente condivisa e assimilata ormai funziona da sé, senza passare attraverso un esame critico, come un vero e proprio sistema di pensiero. Possiamo Trame di vita e lavoro: le operaie del Lanificio Paoletti di Follina (1795-1982) 265 senz’altro affermare la centralità della dimensione culturale e simbolica del lavoro nella nostra Regione è stata traghettata con successo oltre ogni più rosea previsione, diventando struttura portante della società veneta a partire dalla famiglia. Una famiglia (senza distinzioni tra mondo contadino e operaio) che trasmette il lavoro come valore personale e collettivo e che è depositaria di saperi diffusi (l’arte di ingegnarsi e saper fare un po’ di tutto) e che insegna i valori dell’impegno e della parsimonia, della moderazione e della solidarietà sociale. Fin da piccoli, infatti, maschi e femmine venivano spinti ad aiutare gli adulti, a dimostrare di saper fare bene il compito affidato loro, e al termine della scuola elementare era naturale cercare un’occupazione che permettesse di imparare un mestiere che (giunti ai 13/14 anni) avviasse a qualche tipo di attività retribuita. Un “familismo” virtuoso di impronta ancora fortemente contadina, nonostante la presenza di piccole o grandi attività industriali con concentrazioni di masse operaie che però non riescono ad elaborare un’identità corporativa distinta e autonoma rispetto al nucleo sociale dominante. Per tutte le donne intervistate dimostrare di “saper fare bene il proprio dovere” per guadagnarsi onestamente la mercede, avere spirito di adattamento per “rendere” il giusto al padrone, erano requisiti importanti anche come qualità matrimoniali, perché quando una donna entrava in famiglia, entrava anche in qualità di forza lavoro. In questo senso la disponibilità infinita al lavoro, è retaggio comune, sia per le donne di provenienza contadina che per le donne di origine operaia. Perché, anche nella formazione al lavoro delle donne è evidente il riflesso di uno sviluppo parziale e regolato da leggi diverse rispetto a quello degli uomini e che ne enfatizza la dipendenza, la disponibilità illimitata per la famiglia e la vocazione al matrimonio. L’interiorizzazione del lavoro come valore assoluto ed espressione del proprio essere moralmente corretti e responsabili si percepisce nettamente, in tutti i racconti delle operaie intervistate, molte dicono con enfasi “io ho sempre fatto il mio dovere” e quando si chiede loro che tipo di controllo ci fosse in fabbrica, molte delle intervistate hanno risposto che non erano necessari controlli perché “ a quell’epoca bastava dire che un lavoro doveva essere fatto per la sera e il lavoro era fatto”, oppure “dentro quel portone andavamo tutti per lavorare e quindi sapevamo di non dover far altro” e anche quando negli anni ’70 sono stati introdotti controlli per migliorare la produzione un’operaia dice “ quando hanno cominciato a fare i controlli c’era sempre quello che ti controllava, ma oramai noi più che lavorare non facevamo”. Un’altra racconta “a volte dicevo alle mie colleghe di firmarmi loro il cartellino perché avevo scrupolo di non aver reso al lavoro. Stavo là ore in più, tanto che il portinaio mi accompagnava lui alla porta perché io avevo scrupolo. Quando sono stata a casa però il padrone mi ha ringraziato per il lavoro che avevo fatto”. Il lavoro è inteso non soltanto come capacità professionale (sopratutto per gli operai) ma anche come strumento essenziale per l’inserimento nella realtà pro- 266 L. CIGAGNA duttiva, come perno dell’identità individuale e collettiva e come dovere sociale e morale. Il valore del lavoro si presenta anche come “tratto culturale comune” fra datore di lavoro e lavoratore, tra componente operaia e industriale; un valore e un linguaggio condivisi dunque, sui quali si fonda la costruzione del consenso dell’ “ideologia produttivistica” all’interno della fabbrica e di uno spazio utile all’elaborazione di strategie collaborative all’interno dell’azienda. Per l’operaio e l’operaia il lavoro è però anche fiducia nelle proprie capacità professionali, capacità di controllo delle proprie mansioni, orgoglio di essere soggetti determinanti all’interno di un percorso produttivo e lo si ricava chiaramente dalle interviste. Per queste donne il lavoro è anche realizzazione personale, momento di accrescimento che dà consapevolezza del proprio valore. Quando si chiede loro se sono state contente di aver lavorato in fabbrica, la maggior parte risponde di sì, che il lavoro – il loro specifico lavoro di tessitura, orditura o altro – piaceva, dava soddisfazione. Per le tessitrici “era soddisfazione veder uscire la stoffa dal telaio, anche se c’era la preoccupazione di guardare una machina e il lavoro da mandare avanti, ma quando il lavoro era complicato era una soddisfazione farlo”. Una di loro racconta: “A me il lavoro piaceva, dava soddisfazione arrangiarsi, vedere quello che veniva fuori dal telaio. Ci voleva tanta pazienza e precisione, ma a me piaceva. Il lavoro della tessitrice è tanto impegnativo perché bisogna stare attente a non mettere i fili in modo sbagliato. Si guadagnava anche più degli altri, perché era impegnativo, a volte la mia busta paga era più pesante di quella del marito. Delle volte mi sogno ancora del mio lavoro e se oggi mi dessero un telaio saprei ancora manovrarlo”. Un’altra dice che la sua aspirazione era diventare tessitrice: “Anche quando facevo la cuoca nella pausa di mezzogiorno io andavo al telaio perché mi piaceva e una volta il capo mi ha detto: “ti piace più dei tuoi figli eh? Lo credo bene! A poco a poco ho imparato a lavorare perché era soddisfazione veder crescere la stoffa sotto ai propri occhi. Ero orgogliosa di lavorare in tessitura perché chi faceva altri lavori una volta veniva considerato dai vecchi operai un poco stupido, ma non da noi. Per fortuna adesso sono tutti un po’ più svegli di una volta. “Essere tessitrice era motivo d’orgoglio, racconta Francesca Meneghin – la prima sindacalista donna dei tessili in Provincia di Treviso (tessitrice lei stessa): “Le tessitrici erano molto rispettate e invidiate e tra loro c’era molta competizione, anche a parità di “titolo” (la grossezza del filato) cercavano di essere una più brava dell’altra e se si voleva offendere qualcuna le si dava della “filandera”. Perché il lavoro della filanda era più sporco e malsano”. Un’operaia che ha dovuto licenziarsi per motivi di salute dice: “Se avessi potuto avrei voluto restare a lavorare ancora”. Un’altra racconta: “Io sono contenta di essere andata in “corina” e il mio lavoro mi piaceva tanto anche se era dura star dentro tante ore anche se poi con il tempo mi è pesato meno. Adesso mi sembra impossibile aver passato la dentro 35 anni”. Alcune invece non hanno rimpianti: “Io non rimpiango la fabbrica proprio per niente, perché ultimamente era- Trame di vita e lavoro: le operaie del Lanificio Paoletti di Follina (1795-1982) 267 vamo proprio sballottati” E un’altra: “Quando mi sono licenziata non ho neanche provato dispiacere perché avevo già 37 anni di lavoro e quindi potevo andare in pensione e non ho neanche provato dispiacere a stare a casa, perché sono andata in agosto, quando si stava in ferie. Non ho neanche portato via il grembiule e la roba per non dire non torno più, ma non sono più tornata”. LAVORARE IN FABBRICA? UNA FORTUNA! Il lavoro, per chi non appartiene alle classi agiate, è ineluttabile condizione esistenziale, e per chi, a causa di qualche rovescio delle fortune familiari, ha dovuto cambiare radicalmente stile di vita diventa fatica necessaria alla sopravvivenza. A Follina il lavoro di fabbrica aveva una lunga tradizione sia per gli uomini che per le donne e, oltre che alle valenze suddette, poteva rappresentare la continuità di una tradizione familiare, oppure la fonte di riscatto sociale per gli abitanti delle frazioni limitrofe. Per le donne nubili rappresentava indubbiamente un valore aggiunto in vista del matrimonio (anche in assenza del requisito della “bellezza”, canone estetico stigmatizzato ma che per le ragazze da marito, consentiva qualche diritto di scelta in più), dal momento che “la busta” poteva assicurare un quantitativo di denaro liquido quanto mai prezioso in un economia povera, dove per gli scambi e gli acquisti si usava ancora il baratto di generi in natura (uova, ecc). Racconta un’operaia, “per tirare avanti si andava a servizio o in filanda, però noi bramavamo di entrare in fabbrica perché era vicino, era un posto sicuro e più retribuito di altri, in paese lavorare dai Paoletti era considerata una fortuna”. E un'altra dice “ quelli che andavano a servizio stavano peggio di me, avevano il vitto e l’alloggio gratis, ma non dormivano a casa loro, erano sempre sotto padrone, mentre io finito il lavoro dormivo a casa mia e potevo guardare mia figlia. E ancora: “Quelli degli altri paesi dicevano quasi con invidia: eh, voialtri vé la canora! (n.d.a la ciminiera) Perché da loro non ce n’erano tanti che lavoravano in fabbrica, erano più contadini ma viaggiavano il mondo, stavano via sette, otto mesi e tornavano a casa d’inverno. Gli operai avevano la busta paga e anche se dovevano comprarsi tutto, mentre i contadini avevano sempre qualcosa da mangiare, gli operai stavano meglio dei contadini”. E poi: “Se a Follina non ci fossero stati i Paoletti avrebbero dovuto emigrare come nell’800 quando hanno chiuso tante fabbriche e la gente è dovuta andar via”. Per molte operaie era il bisogno, la necessità a rendere accettabile e privilegiata la loro condizione, anche se in alcuni momenti significava sottoporsi a fatiche e, riguardo ai figli, a rinunce laceranti: “Mi toccava lavorare lo stesso, anche se avevo la figlia gravemente ammalata!Ma pur di avere i soldi per curarla sarei andata anche a battere”. Un’altra precisa: “Avere il mio stipendio è stata una fortuna grande, perché lui ne ha combinata qualcuna e mi è toccato andare a chiedere i soldi in prestito ai Paoletti. Le mie colleghe mi dicevano – “vieni a pren- 268 L. CIGAGNA derti la tredicesima” e io rispondevo che non potevo e che avevo premura per non dire che dovevo lasciarli giù per pagare il debito”. Qualcuna dice che dopo la nascita dei figli avrebbe voluto smettere di lavorare per dedicarsi alla famiglia, ma di non esserselo potuto permettere perché: “mio marito era in proprio e non aveva una paga sicura, era uno che lavorava eccome! Ma la sua paga era diversa dalla mia”. Un’altra: “Ho continuato a lavorare dopo il matrimonio e i figli perché mio marito faceva l’artigiano (il sarto) e l’ho aiutato tanto a “pontar” , poi quando sono uscite le confezioni lui ha dovuto smettere e andare anche lui a lavorare in fabbrica. ” Per molte delle operaie intervistate essere entrate in fabbrica giovanissime ha significato rinunciare ad altre aspirazioni e forse ad un destino diverso: un’operaia confessa che le sarebbe piaciuto continuare ad andare a scuola, anche perché riusciva bene e “la maestra diceva sempre a mia mamma di farmi continuare, ma non si poteva e per me questo è stato un “gropet” un dispiacere”. Un’altra dice: “A me non è piaciuto lavorare in fabbrica, ma non sono neanche tipo da stare a casa. Mi sarebbe piaciuto ricamare, avevo il ricamo nel sangue, ma con quello non si vive”. A Follina era presente solo la scuola elementare; per frequentare le medie bisognava andare al Collegio Balbi Valier di Pieve di Soligo, ma per coprire i dieci chilometri di distanza che separano i due paesi non esistevano collegamenti con mezzi di trasporto pubblico, quindi bisognava entrare in convitto e la maggior parte delle famiglie non era in grado di sostenere il costo della retta, e allora, come dice un’operaia, non “c’era altra fortuna che trovare un lavoro qui”. Ma sulle mancate possibilità di scolarizzazione incideva indubbiamente anche il fatto di essere donne, come racconta un’operaia “a mio papà sarebbe piaciuto che io andassi a scuola, ma a mio fratello non aveva voglia di studiare e mia mamma diceva che brutto fare differenze. Allora sono andata a lavorare in fabbrica come rammendatrice”. In famiglia il principio di equità tra fratelli per le donne funziona sempre al ribasso. Certamente era una fortuna essere chiamati in fabbrica, ma aggiunge un’altra “a quattordici anni mi sembrava di essere “finita dentro” ma neanche a parlarne però perché si aveva proprio bisogno e chi non poteva lavorar qua andava all’estero”. LAVORARE VUOL DIRE “USCIRE DI CASA” È interessante osservare in ogni modo che anche per queste donne “il lavoro” è il lavoro retribuito, quello che si fa fuori dalle mura domestiche – in fabbrica – quello che si fa in casa invece non è lavoro, e soprattutto non è lavoro qualificante. Quando ho chiesto ad una di loro che cosa facesse prima di essere assunta al Lanificio Paoletti mi ha risposto che era a casa e non faceva niente, mentre in realtà doveva occuparsi della madre cardiopatica e inferma, come racconta: “Ho potuto andare a lavorare in fabbrica perché mio fratello si è sposato ed è Trame di vita e lavoro: le operaie del Lanificio Paoletti di Follina (1795-1982) 269 entrata in famiglia mia cognata, e dopo faceva tutto lei”. Un’altra invece ricorda di aver iniziato a lavorare presso Paoletti come domestica poi, siccome avevano acquistato dei nuovi macchinari, ha sentito dire che cercavano personale, “allora sono corsa giù, ma cercavano dodici ragazze e se ne sono presentate ventiquattro, il padrone, però non voleva far torto a nessuna e ha fatto “cavare le bruschette” (scegliere le pagliuzze da un mazzo) e lei è stata tra i fortunati ad essere assunta, “quando ho preso quella giusta mi è venuto male dalla gioia che potevo andare a lavorare”. (anche qui fare la domestica non è lavorare!). Lavorare in fabbrica significava abbandonare il ruolo tradizionalmente attribuito alle donne sposate, continuare o smettere di lavorare non era quindi una scelta autonoma delle donne, ma entrava a far parte di quelle decisioni che spettavano al marito, o ai genitori nel caso delle donne nubili. Una di loro rammenta: “Ho cominciato a lavorare presto, a 15 anni. Ho continuato a lavorare in fabbrica anche dopo che mi sono sposata perché lui faceva il calzolaio, dopo quando il lavoro era poco ha trovato posto come bidello e quando è entrato di ruolo mi ha tenuto a casa perché diceva che aveva piacere di trovare pronta una minestra calda. A quegli anni là si andava a cucire poi mi hanno chiamato in fabbrica. Delle volte mi sogno ancora del mio lavoro e se oggi mi dessero un telaio saprei ancora manovrarlo. Era soddisfazione fare il mio mestiere, veramente mi piaceva, ma naturalmente mio marito ha deciso così”. Per un’altra: “Lavorare era importante per tirarsi fuori dalla famiglia patriarcale”. LA FABBRICA: UNA RETE DI RELAZIONI Per queste donne la fabbrica ha rappresentato anche la scoperta e la costruzione di importanti reti relazionali e di spazi di socializzazione che in altri contesti non si sarebbero potuti realizzare. Amicizia e complicità dentro e fuori lo stabilimento si sono rivelate indispensabili per superare i momenti di difficoltà e conflittualità e per rendere anche accettabile la segregazione che il lavoro di fabbrica rappresentava soprattutto per le giovani. Così racconta una rammendatrice: “Ero contenta di andare in fabbrica perché lì avevo le amiche e si faceva presto a star bene con loro”. Una tessitrice ricorda che “con le colleghe andavo anche troppo d’accordo, si passava insieme la festa e si andava di qua e di là, prendevamo il treno a andavamo a Venezia. Le più matte eravamo noi, eravamo in cinque o sei. Invece negli ultimi anni non era più così, non si andava più d’accordo perché una ti guardava, l’altra non ti guardava..”. Un’altra dice: “ogni tanto facevamo le nostre cenette al ristorante e quando sono andata in pensione le ho invitate tutte qua, quelle sposate anche con i figli, e abbiamo fatto un evviva in cortile. Quel giorno in reparto mi hanno regalato tanti di quei fiori che sembrava un giardino e quanti bigliettini!” Un’altra ancora dice: “A me il lavoro piaceva e andavo volentieri perché in fabbrica mi ero fatta delle amiche e al lavoro stavo bene”. Un’operaia che ha dovuto licenziarsi per accudire la famiglia 270 L. CIGAGNA racconta: “Ci si aiutava, non posso dire che bene di quelle vicine perché si cercava di aiutarsi. Dopo che sono stata a casa ogni volta che le incontravo mi dicevano “ci manchi, ci manchi” io non ho baruffato con nessuno. Penso alla fabbrica e alle mie colleghe con nostalgia”. Nell’ambiente di lavoro le donne hanno portato con sé la loro tradizionale capacità di mettersi in relazione con le persone, di percepire i bisogni altrui, l’adattabilità senza che da questo però derivasse una valorizzazione della presenza femminile nella sua specificità (se non a posteriori) Elemento molto presente in tessitura era la solidarietà tra colleghe che si realizzava in aiuto concreto e assistenza durante le ore di lavoro, un’operaia racconta : “Io avevo due colleghe, una dietro e una davanti che se c’era un filo rotto si accorgeva e mi dava una botta sulla spalla con la mano e allora io fermavo subito il telaio, perché se non ci si accorgeva subito del filo che si rompeva poi se ne rompevano dieci. Ci si aiutava così”. Un’altra racconta che, anche se lei era nubile e non aveva figli, volentieri si prestava a pulire il telaio alle colleghe in gravidanza, perché per loro era impossibile e rischioso entrare nei telai. Per alcune di loro l’abitudine a frequentarsi è rimasta anche dopo il pensionamento e sottolineano l’importanza di questi rapporti di amicizia consolidati nell’arco di tanti anni di lavoro in comune. Qualcun’altra invece ha una visione meno positiva dell’ambiente di lavoro e dice che in fabbrica c’era di tutto“c’erano quelle che ti prendevano in giro e ti guardavano per quello che facevi”. C’era chi chiacchierava sempre degli altri”. Coltivare i rapporti umani anche all’esterno della fabbrica è stato – ed è – uno dei tratti distintivi dello stile imprenditoriale della famiglia Paletti. Ancor oggi, i titolari in occasione delle feste natalizie vanno a trovare gli operai più anziani a casa e lo stesso accade quando gli stessi vengono ricoverati in ospedale. Un costume molto apprezzato ma che fa risaltare immediatamente come la dimensione dei rapporti umani sia ancora quella del piccolo paese. COME SI IMPARA IL LAVORO Il Commendator Paoletti ricorda che le donne “erano sensibili ad apprendere, ed erano molto precise” 7 . Come si usava nella tradizione, il lavoro prima di tutto si “rubava con gli occhi”, osservando attentamente i movimenti e i passaggi che le colleghe esperte svolgevano e conquistandosi passo passo, la gratificazione dell’assegnazione di qualche compito più complicato. Non tutte le colleghe erano disponibili a insegnare più dello stretto indispensabile: da “corine” s’imparava al principio a curare le stoffe che venivano dal telaio togliendo loro le impurità e i nodi con una pinzetta, poi a poco si imparava il rammendo vero e proprio. Le stoffe venivano stese su appositi banchi e poi si passavano con la punta delle dita per sentire i nodi, si faceva pratica pian piano ogni gruppo ave7 Intervista al Commendator Paolo Paoletti del 12 gennaio 2006 Trame di vita e lavoro: le operaie del Lanificio Paoletti di Follina (1795-1982) 271 va un certo numero di pezze da sistemare e la più anziana insegnava come fare, ma si imparava anche guardando e bisognava aver buoni occhi. Un’operaia racconta: “Quando sono entrata io, a 14 anni noi eravamo chiamate le “tosete” e prima ci insegnavano a togliere i nodi e poi a rammendare. Quando si entrava in una squadra si facevano i primi tre mesi di “garzonado”, io sono entrata a settembre e la prima paga l’ho avuta a Natale e mi penso sempre che mi hanno dato cinque lire e mi pareva di aver portato a casa un tesoro”. Una tessitrice racconta: “Prima si iniziava a fare le spole e poi si andava ad “incorsar” a mettere dentro i licci per preparare la tessitura. Era difficile preparare il telaio, bisognava stare attenti a tutti i passaggi che c’erano, ai colori e al tessuto se era dritto, se c’era una spinatura o un disegno. Quella che era dentro il telaio doveva stare attenta a trovare i licci giusti per la passatura e quella che dava fuori i fili doveva stare attenta ai colori e darglieli giusti. Ci davano uno schema, era il perito che lo preparava e quando si cominciava il lavoro si doveva fare un pezzetto e lo si portava alle pinzine e ce n’era una addetta apposta che controllava se su questo pezzo di stoffa c’era qualche fallo o se era giusto. Un’altra racconta che: “Mi hanno assunto che non avevo neanche tredici anni, a quei tempi non si era ancora messi nel libretto, ma c’era necessità di lavorare. Man mano che si cresceva si veniva passati di reparto, spolatura, torcitura e poi tessitura”. Poi bisognava anche aggiornarsi: “All’inizio (anni 40) si lavorava solo con un telaio, poi due e infine quattro. Di solito si facevano 40 metri di stoffa (era la misura della pezza) ma dipendeva dalla grossezza del filato. Poi , intorno agli anni settanta ci hanno messo a lavorare con il cronometro e lì siamo stati messi a cottimo, prima invece il lavoro era a giornata”. Un’altra conferma che: “Intorno agli anni ’70 è cambiato tutto, anche il lavoro, hanno lasciato a casa tanta gente. Prima eravamo in due alle macchine poi invece una soltanto allora bisognava stare più attenti a come si faceva”. Quando non c’era lavoro, le operaie più giovani venivano adibite anche ad attività fuori dalla fabbrica, un operaia racconta che “quando non c’era lavoro ci mandavano a cavar erba e una volta ci hanno anche mandato a fare la marmellata. Mentre sbucciavamo la frutta ci dicevano anche di mangiare qualcosa e noi lo facevamo perché avevamo davvero fame!” REPARTI, TURNI, SALARIO E COTTIMO Il Lanificio Paoletti, svolgeva il ciclo completo della produzione: in fabbrica entrava la lana succida e ne usciva il tessuto finito. I reparti dell’azienda erano: carderia, filatura, ritorcitura orditura, tessitura, cernitura, pinzine, tintura, finissaggio, assistenza meccanica e falegnameria. Erano reparti completamente maschili la carderia, la tintura, la follatura, la lavatura delle lane, mentre ritorcitura, orditura, cernitura e pinzine erano esclusivamente femminili. Una scarsissima presenza di uomini si riscontra in tessitura ( e di solito si tratta di capi- 272 L. CIGAGNA reparto) e in filatura, mentre misto era il reparto di finissaggio; le officine meccaniche e la falegnameria erano esclusivamente maschili. Un’operaia racconta che però “in tempo di guerra si facevano tutti i lavori, anche quelli degli uomini, dopo la fine della guerra invece, si tornò ai vecchi compiti” Si partiva dalla lana succida (appena tosata) che veniva scelta dalle cernitrici – che erano soltanto donne ed erano le più pagate – le quali dividevano i vari tipi di lana (quella proveniente dalla schiena, dalla pancia) che poi veniva lavata, cardata e pettinata per passare alla filatura. Dalla filatura andava in tintoria oppure passava direttamente alla ritorcitura. Bisognava caricare le spole di filato che la macchina avrebbe ritorto e avvolto in rocche. Un operaia racconta : “C’erano macchine grandi e si mettevano su le spole e la macchina ritorceva due, tre, quattro cavi. Il filo poteva essere liscio o con i riccetti allora era più difficile, se il filo si rompeva bisognava aggiustarlo e quando le spole erano piene bisognava scaricarle. Bisognava correre, perché le macchine erano lunghe e quando il filo si attorcigliava bisognava essere svelte perché si doveva romperlo e riannodarlo sulla spola giusta. Era un lavoro di attenzione”. Le rocche passavano poi in orditura dove il filato veniva caricato negli orditoi e avvolto nei subbi (pesanti fino a sessanta chili), i cilindri di metallo sul quale si avvolgevano i fili dell’ordito e che dovevano essere esattamente calcolati e misurati in base alla lunghezza della pezza che si doveva tessere. Era un lavoro che richiedeva una certa predisposizione matematica e tutti i calcoli si “facevano a mente”. I subbi (in dialetto “suboli”) venivano portati in tessitura e caricati sul telaio per l’incorsatura, ovvero per far passare i fili dell’ordito dentro le maglie (gli anellini) dei licci. Racconta una tessitrice: “Una volta ci toccava “incorsare” per preparare il lavoro e bisognava essere in due: l’incorsatrice e l’attaccafilo, dopo invece è venuto quello che ci preparava tutto e noi bastava che lavorassimo”. “Incorsare” era un lavoro complicato e di attenzione perché bisognava passare i fili negli anelli giusti, rispettando lo schema del disegno preparato dal perito tessile; bastava sbagliare un filo perché il disegno uscisse difettoso. Racconta un’operaia: “A me il telaio piaceva tanto, quando mi avevano dato la carta e l’avevo letta tre volte io l’avevo capita, anche se era difficile io non lavoravo con la carta in mano”. La tessitura era “la fase centrale, il cuore del processo produttivo . L’ordito veniva attraversato a fili alterni dal filo della trama che veniva trasportato dalla navetta (una specie di barchetta appuntita alle estremità che conteneva la spola con il filo della trama) e l’insieme dei due tipi di filato, battuti da un pettine per rendere la trama fitta, costituiva il tessuto vero e proprio. “Erano a navetta i telai Saurer rimasti in uso fino negli anni Settanta. Ma nel Secondo Dopoguerra la tessitura ebbe consistenti progressi tecnologici grazie al brevetto nel 1954 del telaio Sulzer detto “a proiettile”. Una macchina assolutamente innovativa, dove la navetta veniva sostituita da un corpo di metallo con una pinza – trascinata da dei nastri in fibra sintetica – che pizzicava la trama e la trascinava sopra il tessuto senza sfregarlo, assicurando quindi oltre ad una doppia velocità di passaggio della trama una migliore qualità del tessuto finito. Grazie a questa innovazione Trame di vita e lavoro: le operaie del Lanificio Paoletti di Follina (1795-1982) 273 si aumentò il numero di telai assegnati ad ogni operaio perché il numero di rotture dei filati veniva ridotto drasticamente. La qualità di acciaio del proiettile inoltre garantiva una resistenza maggiore al macchinario che poteva essere utilizzato senza rotture per molti anni rese i telai Sulzer assolutamente competitivi fino alla metà degli anni Ottanta” 8 . Tuttavia alla Paoletti i telai iniziali furono sempre e soltanto i telai Saurer. La memoria di un’operaia ripercorre tutte le trasformazioni avvenute nella tessitura: “Per tanti anni abbiamo lavorato con i telai meccanici con una navetta. All’inizio si lavorava con un telaio soltanto, poi con due e con i telai nuovi (quelli Saurer) siamo arrivati a otto telai ciascuno. Si poteva guardare tanti telai perché la macchina si fermava da sola quando c’era qualche problema”. La differenza tra i telai vecchi e quelli “nuovi” è sottolineata da tutte le tessitrici: “I telai di una volta erano organizzati diversamente, all’inizio una persona era più che sufficiente, una volta quando il filo finiva, se la navetta passava senza trovare il filo la forchetta si spezzava. La bravura era quella di correre e di aver l’occhio per fermare la macchina in tempo quando finiva il filo della spola per non fare i disastri. Ma a volte erano i ragazzi che preparavano il telaio ad appendere le lame storte e può immaginare che disastri, tutti i licci si spezzavano e non solo andava a farsi benedire il cottimo ma c’erano anche dispiaceri e le multe. Adesso le macchine nuove sono meglio e i telai vecchi li tengono per le coperte o le stuoie”. E ancora: “Nei telai vecchi bisognava stare attenti quando finiva il filo con i nuovi invece si lavorava meglio. Quando finiva la pezza c’era il disegnatore che controllava la pezza e se c’erano difetti metteva un biglietto e la mandava in “curina” per il rammendo. A volte la spola si fermava in mezzo e rompeva tutto, allora bisognava fermare il telaio e allora si perdeva tempo perché si era a contratto. Era segnato quanti metri si faceva e si veniva pagati anche in base alla quantità. Il metraggio dipendeva dal tipo di stoffa, più grossa o più fina, se la stoffa era grossa il filo finiva prima e bisognava cambiare più spesso le spole, se invece era fina, durava di più”. A seconda del tipo di tessuto il rammendo poteva essere più o meno complicato e impegnativo. Si seguivano la trama e l’ordito del tessuto e a seconda del disegno il numero di fili da prendere o lasciare poteva essere lo stesso o cambiare. Era un lavoro di grande pazienza e precisione. “All’inizio pensavo – racconta una “curina” – non imparerò mai...invece è semplice. C’erano poi delle stoffe che noi dicevamo “arabe” perché avevano tanti cambi di fili e bisognava studiare per aggiustarle. Al rammendo si lavorava in squadre, si era cinque per ogni squadra. Per imparare si guardava, c’era una tavola e si era messe vicino alla più vecchia. Si passava la stoffa e si trovavano gli errori e poi con l’ago si metteva dentro il filo della smagliatura”. Olivieri N., Il lanificio Tiberghien fra storia e memoria, Verona, Cierre edizioni, 2007, pp. 197-199 8 274 L. CIGAGNA Una “curina” spiega che: “La stoffa si rammenda una prima volta quando è ancora in olio perché la lana viene ingrassata per passare nelle macchine. Ci cambiavamo prima di andare a casa per non sapere da olio. Dopo veniva lavata e follata e diventava bella ma se tornava dal lavaggio con impurità andavano tolte con la “cureta”, una specie di pinzetta, se invece restavano piccoli nodi c’era un tavolo inclinato chiamato il tribunale e su quello si passava tutta la stoffa con la mano per sentire dove si trovavano le annodature che si tagliavano con le forbici. Quando era finita si ripassava per controllare se andava bene. Dopo c’è chi le fa il pelo, la garzatura”.Il tessuto doveva essere rivisto perché uscisse dalla fabbrica perfetto. Per ridurre i costi di produzione e per non ampliare il reparto di rammendo, dal 1970 al 1982, il Lanificio Paoletti diede il lavoro ad una serie di “riparatrici” a domicilio. Si tratta di 36 donne la maggior parte delle quali ha esperienza di lavoro nei lanifici vicentini (Lanerossi, Sartori di Schio, Lanificio Veronese Tiberghien, Maglificio Palladio). Le donne, regolarmente registrate e retribuite, lavorano a volte per un mese intero, a volte soltanto per 15 giorni o per una settimana soltanto, probabilmente in relazione ai picchi di lavoro della fabbrica. Alcune di loro lavorano sei giorni alla settimana per otto/nove ore, altre per orari più ridotti. In lanificio, a seconda del reparto di assegnazione si lavorava a turno o a giornata, comunque l’orario era di otto ore lavorative al giorno. Chi lavorava a turno faceva quindici giorni il mattino e quindici il pomeriggio; il mattino iniziava alle quattro e terminava alle dodici, il pomeriggio iniziava a mezzogiorno e terminava alle ventidue. Poi pian piano il mattino si è iniziato alle quattro e poi alle cinque, fino ad arrivare alle sei di mattina, spostando ovviamente la fine del turno e l’inizio di quello successivo. Chi invece lavorava a giornata entrava in fabbrica alle otto e finiva alle dodici e rientrava all’una per finire alle cinque o sei del pomeriggio. Ogni turno aveva diritto a mezz’ora di pausa per la colazione il mattino e la sera per la cena. La settimana lavorativa era di sei giorni su sette e un terzo e più della giornata di queste donne trascorreva in fabbrica; a seconda dei periodi e dei reparti e delle stagioni l’orario poteva ridursi o ampliarsi dalle sei alle dieci e anche dodici ore al giorno, soprattutto nei periodi di grandi commesse. Due volte all’anno, nei periodi di campionatura si lavorava anche la domenica mattina, che veniva recuperata come giorno di riposo il sabato successivo. Alle donne era vietato fare il turno di notte, quando è stata introdotta la lavorazione a ciclo continuo – verso la fine degli anni ’60 – e per garantire il funzionamento dei macchinari, sono stati assunti gli uomini. Da quel momento il numero delle donne comincia a diminuire così come variano le loro mansioni, diventando meno specializzate e più generiche. Negli anni ’40 si iniziava alle quattro di mattina, e si finiva a mezzogiorno. Per chi abitava fuori paese fare il turno del mattino significava alzarsi e partire poco dopo le tre di notte – estate e inverno – per essere in fabbrica in orario. Una di loro racconta: “ si era anche poco vestite, io avevo uno scialletto e gli zoccoli. D’inverno quando pioveva o nevicava si arrivava tutte bagnate e allora si mette- Trame di vita e lavoro: le operaie del Lanificio Paoletti di Follina (1795-1982) 275 vano i vestiti sulle caldaie e si aspettava un poco per tornare a metterli addosso, perché non avevamo roba per cambiarci e in quegli anni nei reparti non c’era neanche il riscaldamento”. Un’altra racconta: “io prima di sposarmi abitavo in quella righetta di case attaccate alla fabbrica in via Cartera, ma, così giovani come eravamo, era fatica alzarsi così presto!” E un’altra aggiunge: “Della fabbrica ricordo gli anni più belli della giovinezza, però se dico che non mi è costata fatica direi una bugia. Era faticoso per gli orari, per le persone da stare insieme...mamma mia!”. Un’operaia di Valmareno dice:“ i primi tempi andavo a lavorare a piedi e poi in bicicletta, mi alzavo prima delle quattro, vento o pioggia, estate o inverno era la bicicletta che sapeva la strada: io non la vedevo, mi sembrava di essere la “Cavallina Storna” di Pascoli!” Sono molte le donne che “fanno straordinario”, e lavorano oltre le 48 ore settimanali, da lunedì a sabato e – durante i periodi di campionatura – alcune lavoravano anche mezza giornata della domenica. Ogni turno aveva diritto a mezz’ora di pausa per la colazione il mattino e per la cena la sera. Chi abitava a Follina riusciva ad andare a casa a mangiare, gli altri si portavano qualcosa da casa, da scaldare in cucina. Nel dopoguerra fu realizzata la mensa, ma il vitto variava dal minestrone di verdure alla minestra di fagioli. Per chi non aveva aiuto in casa, la mezz’ora di pausa consisteva nell’occuparsi dei figli, mettersi un pezzo di pane in tasca e tornare a lavorare, mangiando in piedi mentre si lavorava. Per queste donne “era più il trambusto che altro e poi si trascuravano anche loro, ma intanto correvano a casa a vedere i figli. Io avevo la fortuna di trovare pronto e dopo guardavo anche i bambini ma facevo anche un sonnellino seduta sulla sedia perché avevo tanto sonno e i miei figli non sono stati di quelli che dormivano tutta la notte”. E un’operaia nubile racconta: “ Non tornerei più a lavorare per la libertà, perché non mi tocca più correre anche se avevo la fortuna di avere mio papà e mia mamma che mi preparavano tutto, ma quando sono stata a casa ho detto basta perché in fondo il lavoro era sempre quello “stoffe, stoffe da cominciare e da finire” sempre quello”.. Una di loro afferma: “Direi una bugia se dicessi che lavorare non mi è costato fatica, però ero giovane quando sono entrata in fabbrica e lì ho passato gli anni più belli della mia giovinezza. Quando ho ricevuto la lettera di licenziamento è stata dura perché quando tu sai di avercela messa tutta.... siamo stati messi in cassa integrazione e poi sono stata una delle prime ad essere richiamata quando hanno riaperto la fabbrica, sono rimasta fino a quando ho raggiunto i contributi che mi servivano per la pensione”. Tra i vari reparti c’erano differenze salariali. Secondo quando ricorda il Commendator Paoletti, le più pagate erano le “cernitrici” 9 e i dati sono desumibili anche dai libri paga. Per le operaie però le differenze tra un reparto e l’altro sono state fonte di malcontento. Una sindacalista ricorda: “I contratti di lavoro avevano importi diversi a seconda della categoria e l’altra per esempio le ordi9 Intervista al Commendator Paolo Paoletti del 29 luglio 2007 276 L. CIGAGNA trici prendevano qualcosa in più delle tessitrici e anche le rammendatrici; onestamente non sembrava giusto, ma erano i contratti che non corrispondevano del tutto alla realtà del lavoro, alle effettive responsabilità. C’era differenza di stipendio anche tra uomini e donne e allora abbiamo fatto la lotta con i sindacati perché facevamo lo stesso lavoro con lo stesso orario. Stessi doveri sì, ma anche stessi diritti. Abbiamo fatto anche qualche sciopero”. Era il cottimo a stabile i tempi del lavoro, perché più si lavorava più si guadagnava. Ecco allora che l’operaia era costretta ad essere veloce e precisa, per non fermare la macchina e quindi interrompere il contatore che segnava le battute del telaio o la quantità di lana filata. Come già detto in precedenza, la paga era quindicinale: in tessitura le pezze venivano numerate, si contavano i colpi battuti per catena, e ogni mille battute scattava il cottimo. Per calcolare lo stipendio a cottimo venivano segnati i colpi pagati anticipatamente e quelli da pagare (effettuati), la differenza – moltiplicata per le tariffe stabilite – dava l’importo dello stipendio. Per ogni anno e reparto (ma non tutte le lavorazioni erano a cottimo) erano previsti registri del cottimo; fra quelli reperiti si trovano quelli del reparto tessitura: per ogni operaia sono state minuziosamente segnate le quantità di lana utilizzata, i colpi battuti, gli anticipi liquidati. Più metri si facevano più soldi si prendevano, c’era un contagiri sul telaio: “Bisognava lavorare perché ci mettevano a contratto, allora se lavoravi si guadagnava, si facevano “tanti di mille” si diceva, ogni mille battute ci davano un tot e allora se facevi abbastanza di “mille” si faceva una giornata discreta, ma se il lavoro andava male perché magari il filo si rompeva o anche il telaio non andava perché c’era anche quello da dire e allora bisognava chiamare il tecnico e quello non veniva perché magari era occupato o aveva i suoi pallini e allora bisognava aspettare e il tempo passava e quelle erano le arrabbiature che si prendevano. E poi si era a turno perché magari invece la nostra compagna andava bene e poi arrivavo io e si rompevano i fili e allora bisognava andare sotto ad aggiustarli”. Un’altra tessitrice racconta: “ Nei primi anni di applicazione era un modo per avere una paga migliore, oltre la paga minima e questo per le famiglie era importante perché in quegli anni gli uomini erano quasi tutti disoccupati”. In tessitura bisognava avere un’attenzione costante, non “perdere neanche una trama” e se il filato terminava bisognava stare attente a fermare il telaio per non dover disfare una parte del tessuto; la qualità della tessitura e la sua minor o maggiore difficoltà dipendeva anche dalle caratteristiche del filato: più il titolo (lo spessore) del filato era basso, migliore era il lavoro, più il titolo era grosso maggiore era l’impegno per la tessitrice. Una di loro racconta:“Era un’umiliazione quando si sbagliava perché mettevano un biglietto con il tuo nome ma non era colpa nostra perché tante volte dipendeva da chi regolava la macchina e siccome si era a cottimo era un disastro se non venivano subito ad aggiustarla e lì si andava a simpatia. Si perdevano bei soldi perché pagavano a giornata. Se io passavo il cottimo era segno che ero una che lavorava bene”. Trame di vita e lavoro: le operaie del Lanificio Paoletti di Follina (1795-1982) 277 Si lavorava a cottimo anche nel rammendo: “e i soldi venivano assegnati per squadre, messi dentro delle buste. Erano le più anziane che facevano le parti poi, ma non erano giuste, perché noi più piccole non prendevamo quei soldi mentre si era in tutte che si controllavano le stoffe. Fino a quando non si passava rammendatrice non si prendevano quei soldi e non era giusto”. PRESENZA FEMMINILE. PERCENTUALE E RUOLI Scorrendo i vecchi “libri Matricola” che iniziano il 25 maggio 1919 e che – riportano i dati di paternità, provenienza geografica, precedenti esperienze di lavoro ed eventuale grado d’invalidità, sono riuscita a registrare – in un settantennio – il passaggio nel lanificio di 367 donne. Non è però stato possibile ricostruire la sequenza dettagliata – anno per anno – della percentuale femminile presente in fabbrica, dato che i libri paga quindicinali sono presenti in maniera saltuaria. Si osserva però che la percentuale di presenza femminile oscilla da un minimo del 37% del 1980 ad un massimo del 68% nel 1941. L’inversione di tendenza tra la tradizionale predominanza femminile si ha a partire dal biennio 1968/69, quando nei reparti vengono introdotti i nuovi telai e i nuovi sistemi di controllo della produzione e soprattutto quando vengono avviati i turni notturni, ai quali vengono adibiti esclusivamente uomini. In quegli anni scompare anche la tradizionale divisione dei reparti e il personale viene accorpato in tre grandi categorie: impiegati, intermedi e operai. Se tra gli impiegati c’è una minima percentuale di donne, fra gli intermedi si trovano solo uomini. Anche nei dati generali dei lanifici della Provincia si osserva che la maggioranza delle donne è inquadrata come operaia e le posizioni gerarchiche superiori sono ricoperte quasi esclusivamente da uomini. CONDIZIONI DI LAVORO E RISCHI D’INFORTUNIO La sicurezza negli ambienti di lavoro era stata normata con una serie di provvedimenti legislativi a partire dal 1898 che culminarono nel 1933 con la creazione di un apposito ente: l’INAIL. Dai registri degli infortuni reperiti nell’archivio aziendale e integrati con le denunce d’infortunio reperite nell’archivio comunale, emerge che i pericolo di incidenti era alto in tutti i reparti meccanizzati come filatura, torcitura, tessitura e spolatura. Negli altri reparti c’era il rischio di cadute, di strappi muscolari dovuti all’eccessivo peso trasportato oppure all’utilizzo di sostanze chimiche o alle alte temperature. Le lavoratrici più esposte erano le tessitrici che potevano essere colpite al volto o alla testa dalle navette che uscivano dalla custodia ad alta velocità, travolgendo anche le protezioni. Ci si poteva ferire anche pulendo il telaio, dal momento che bisognava letteralmente entrarci dentro dalla parte su- 278 L. CIGAGNA periore, rischiando quindi di precipitare sugli ingranaggi. Ma anche in altri reparti potevano accadere incidenti di una certa gravità, come quello accaduto ad un’operaia alla quale le cinghie di un macchinario hanno strappato il cuoio capelluto. Per le tessitrici c’era anche il problema del caldo e del rumore. I titolari fornivano le lavoratrici di apposite cuffie ma a detta delle operaie “non è che risolvessero il problema”. Molte di loro hanno subito perdita d’udito o hanno sofferto di emicrania per molti anni proprio a causa del rumore dei telai. Durante l’estate il soffitto di eternit dei reparti peggiorava la situazione e il lavoro diventava più faticoso. In altri reparti si era continuamente a contatto con la polvere o con le sostanze usate per migliorare il passaggio del filato negli ingranaggi dei macchinari per la filatura e la tessitura. UN DOPPIO LAVORO: IN FABBRICA E IN FAMIGLIA Tutte le intervistate sottolineano che gli anni di lavoro sono stati anni di fatica fisica, non soltanto per il lavoro in fabbrica ma anche per il lavoro di cura dei propri familiari e per la gestione dei lavori domestici – che senza l’ausilio degli elettrodomestici – sembrava non avere mai fine, soprattutto per quelle che non potevano contare su una famiglia estesa o allargata. Per queste donne il tempo libero non esisteva e non c’è confine tra lavoro di fabbrica e lavoro in casa. Proprio il lavora in fabbrica però, permette ad alcune di loro di comperare – per prime in paese ! – la lavatrice e di “socializzarla” con le vicine per il bucato pesante. Sono tutte donne cresciute nella necessità di “produrre” all’interno della famiglia beni di autoconsumo (vestiario, verdura, pane…) ecco allora che, la sera o la domenica, si dedicano al cucito o alla coltivazione dell’orto, proprio perché considerato una fonte di risparmio e di minor dipendenza economica dall’esterno. La sobrietà e la parsimonia sono tratti caratteristici di tutte le intervistate, memoria di un epoca nella quale “sprecare” era impensabile. Per chi aveva la fortuna di avere qualche suocera o zia in casa il peso dei lavori domestici era minore, come l’ansia per la custodia dei figli, ma nei momenti in cui queste persone anziane si ammalavano, tutto l’onere dell’assistenza ricadeva sulle donne. Alcune delle operaie si sono trovate davanti alla scelta obbligata di smettere di lavorare in fabbrica per assistere gli anziani, a prezzo poi di pagarsi i contributi volontari per il raggiungimento della pensione. Chi non poteva licenziarsi doveva farsi carico di una maggiore fatica e spesso questo ha significato sottrarre ai figli quel poco di tempo che erano riuscite a ritagliare dalle loro giornate di lavoro infinito. Trame di vita e lavoro: le operaie del Lanificio Paoletti di Follina (1795-1982) 279 CONCLUSIONI Uno degli obiettivi della ricerca era quello di verificare se l’attività di lavoro continuativa di queste donne avesse prodotto qualche segnale di emanazione precoce per le operaie stesse e avesse avuto effetti anche nel tessuto sociale follinese, con tutti i limiti di un campione di donne abbastanza modesto e una arco di tempo abbastanza ridotto. Dai risultati è evidente che in questo territorio decentrato della Provincia di Treviso, nel corso del ‘900 il lavoro in fabbrica, nei lanifici o nelle filande, non ha rappresentato lo strumento per l’acquisizione di una coscienza di classe o di una militanza sindacale o politica. Forse anche a causa dell’esaurirsi della presenza di un proletariato industriale diffuso a seguito della chiusura dei grandi lanifici Colles e Andreetta . L’ultima vampata di rivolta operaia si ebbe negli anni ’20, quando durante uno sciopero generale, i manifestanti provenienti da Vittorio Veneto e dalla Vallata, occuparono il Municipio. A Follina, i ruoli, la struttura sociale e familiare vengono mantenuti in vita, pur con le trasformazioni e gli adeguamenti avvenuti a partire dagli anni Sessanta a seguito della scomparsa della civiltà contadina. Le donne intervistate non hanno utilizzato la loro indipendenza economica come uno strumento di emancipazione sociale, ma l’hanno fatta confluire – come nella migliore tradizione delle famiglie contadine – nel cumulo del reddito familiare, a riprova che il possesso di risorse economiche non costituisce di per sé elemento di maggior autonomia personale rispetto alla propria famiglia o all’interno di un matrimonio. La “mistica della femminilità” di queste donne non è diversa nei valori, nelle sottomissioni e subordinazioni, nella rassegnazione e sublimazione dei desideri rispetto a quelle che “non hanno mai lavorato”. Solo qualcuna di loro approfitta dello spazio che il lavoro concede per forme di socializzazione estranee alla famiglia, mai trasgressive però e sempre declinate al femminile. Nel lavoro queste donne hanno trovato una loro forma di realizzazione professionale e umana, si sono sentite “utili” alla loro famiglia e sono orgogliose di quello che hanno imparato e saputo fare, anche se magari in gioventù avrebbero avuto aspirazioni diverse. Sono donne serene e forti, a volte ironiche e feroci nelle loro rabbie ancora non sopite. Sono donne che hanno il senso della fragilità delle strategie di cambiamento individuale e hanno costruito la loro vita attorno a nuclei forti e antichi, adattandosi ad un presente più limitato delle loro aspettative e hanno consegnato alle generazioni successive la possibilità di cambiamenti e rotture che avrebbero potuto mettere in pericolo il recente benessere acquisito. Tuttavia, queste donne sono state “soggetti di cambiamento sociale” e nel loro ambito familiare sono riuscite a produrre traiettorie sociali diverse per i loro discendenti e le generazioni successive. Raccogliere i loro racconti si è rivelato, oltre che un’esperienza umana coinvolgente ed emozionante, anche un modo per ricostruire la storia di una comunità e di un’azienda da un punto di vista 280 L. CIGAGNA forse inconsueto, ma tutt’altro che minore. Le loro storie ci rivelano che il passato, se studiato con categorie non neutre, rivela aspetti economici e sociali non ancora del tutto studiati e documentati. Conoscere attraverso il loro racconto la complessità delle relazioni e dei ruoli che hanno vissuto dentro e fuori le mura del lanificio, ci permette di cogliere gli aspetti più duri e crudi di un passato che non è – come vorrebbero i nostalgici – sempre idilliaco e bonario. Un passato che non ha tenuto conto che a Follina le donne – più degli uomini – hanno rappresentato per molti anni il fulcro dell’economia familiare basata proprio sulle loro risorse come fonte principale di reddito. Per guadagnarsi la “busta” queste operaie hanno trascorso fra le pareti della fabbrica la loro giovinezza e maturità; continuando a lavorare si sono sposate e hanno fatto i figli e li hanno cresciuti. I loro ricordi sono legati indissolubilmente al lanificio, ai reparti, ai colleghi e alla famiglia Paoletti. Dentro la fabbrica hanno imparato a superare i momenti difficili con pazienza e tenacia, acquistando dal loro lavoro l’orgoglio e la dignità di un ruolo, coltivando e costruendo giorno per giorno la speranza del loro riscatto, perché le donne sanno che “va considerato realizzato non solo ciò che si iscrive nella propria traiettoria, ma anche ciò che si può trasmettere alle generazioni future”. 10 10 Borderias C. , op. cit. p. 98
Scaricare