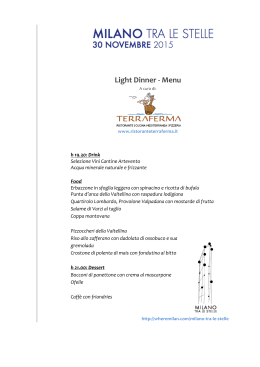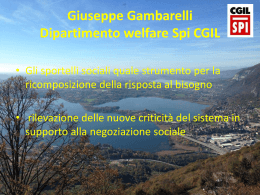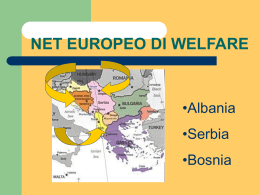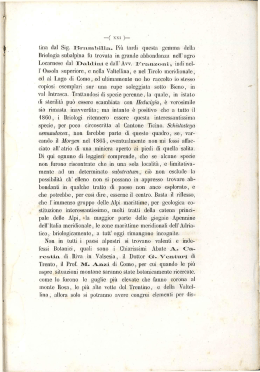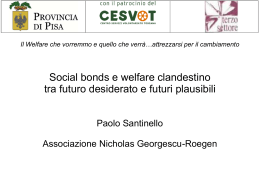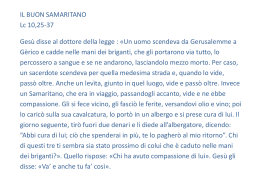Diocesi di Como Scuola di formazione socio‐politica Secondo anno 2010‐2011 18 febbraio 2011 ‐ Morbegno Economia civile e nuova cultura del lavoro Prof. Aldo Bonomi sociologo Danilo Ronconi Benvenuti anche questa sera all’ultimo incontro del secondo anno della nostra Scuola sociale. Un grazie particolare al prof. Bonomi, che ha riservato una serata per noi. Il primo anno della nostra Scuola è stato imperniato sui principi della Dottrina sociale della Chiesa, per arrivare quest’anno ad approfondimenti su tematiche specifiche: la democrazia e i suoi fondamenti, la bioetica e la politica, e, da ultimo, il modulo sull’economia civile che ci è stato introdotto dal prof. Zamagni e si è quindi focalizzato su impresa e famiglia; questa sera toccheremo la tematica del lavoro, tema che è un ambito fondamentale della vita adulta, come ci ha ricordato nell’ultimo incontro il prof. Prandini. Ci siamo proposti quindi di affrontare questo tema tenendo presenti alcune considerazioni: il fatto che il lavoro manca, in questo momento di crisi che colpisce alcune famiglie, e soprattutto il mondo giovanile; un lavoro che è molto cambiato e che continua a cambiare (ricordiamo i referendum all’interno della Fiat) con un sempre maggior ricorso al lavoro flessibile che diventa però spesso precariato; un lavoro che richiede sempre maggior assorbimento da parte delle persone, dal punto di vista emotivo e dell’invasione della sfera privata. Abbiamo chiesto quindi al prof. Bonomi di aiutarci ad entrare in queste problematiche, a capire quali sono i cambiamenti in atto, e se questi sono compatibili con una visione sociale e civile dell’economia. Il professore è nostro convalligiano, e mi piace sottolineare la sua attenzione particolare e disinteressata al nostro territorio, come ad esempio la ricerca svolta in collaborazione con la Caritas sul tema del suicidio. Prof. Bonomi Se posso fare una battuta, l’interesse al territorio è come quelli che tornano dall’esilio. E detto questo posso iniziare la mia relazione! Mi sono segnato 6 o 7 punti, due di carattere teorico, un po’ di racconto e interpretazione e alla fine un po’ di conclusione. Il primo punto è un invito ad essere un po’ ‘schizofrenici’ nell’uso degli attrezzi per interpretare la realtà, e quindi, anche quando si parla di lavoro o di lavori, a mio parere bisogna tener conto che tutti quanti noi siamo figli di una cultura del ‘900, e che molto spesso applichiamo questa cultura leggendo quello che 1 avviene nel nuovo secolo; spesso quindi non capiamo i grandi cambiamenti in atto. Dico subito che tutti quanti noi, quando pensiamo al lavoro, all’organizzazione sociale, all’economia, abbiamo in mente un paradigma molto semplice che ci scatta nella testa per interpretare i fenomeni: da una parte abbiamo la polarità del capitale, che significa l’impresa (quelli che pagano i salari, che fanno lavorare gli altri ma che producono crescita e redistribuzione); dall’altra parte il lavoro e in mezzo c’è lo stato che con il suo welfare o il suo sistema delle garanzie ridistribuisce risorse, diritti e quindi per noi è automatico, quando pensiamo al lavoro, pensare immediatamente al welfare (la sanità, le pensioni…). Anche l’organizzazione sociale a cui facciamo riferimento è segnata da questo paradigma, nel senso che le forze sociali sono quelle che da una parte rappresentano il lavoro, dall’altra l’impresa; e la politica è, o era, quella forma che ‘ha occupato’ lo stato, nel senso nobile del termine, attraverso elezioni democratiche, oppure anche in forma rivoluzionaria, come ha fatto il comunismo, occupando il Palazzo d’Inverno nel nome degli interessi dei lavoratori; la Dottrina sociale della Chiesa invece, è un rapporto con la dimensione statuale che deve ovviamente occuparsi e ridistribuire risorse per gli ultimi, e gli ultimi sono il mondo del lavoro ecc.. Questo paradigma tendenzialmente è stato valido in quella che noi chiamiamo l’età dell’oro, o il secolo breve, cioè dopo la Seconda guerra mondiale per tutto il ‘900. Una prima annotazione, un po’ cinica: chi ha una certa età si ricorderà che il meccanismo attraverso il quale si ridistribuivano le risorse era fondamentalmente la legge finanziaria; c’era cioè ogni anno un atto pubblico dello stato che, a seconda degli ‘indirizzi politici’ era in favore della dimensione del lavoro e accompagnava l’impresa. Facendo un esempio locale, lo stato, attraverso la mediazione nobile di Vanoni, ha portato qui in Valtellina la Nuova Pignone, un pezzo di Eni, che era lo stato che si occupava dell’impresa, e attraverso l’impresa ha prodotto lavoro. E se si pensa cosa è oggi la Nuovo Pignone, si capisce immediatamente che c’è un salto di paradigma. E’ ancora valido questo paradigma? Oggi, a prescindere da qualsiasi forza politica vinca le elezioni, chiunque vince e democraticamente sta dentro il meccanismo della statualità, deve fare un meccanismo tale per cui non distribuisce risorse ma tagli. La finanziaria di Tremonti (ma sarebbe stato lo stesso se ci fosse stato Padoa Schioppa) o di Visco sono finanziarie in cui lo stato dice che non ha più nulla da ridistribuire, né per il lavoro né per l’impresa, ma deve ‘razionalizzare’ e cambiare il welfare. Questo è il paradigma del ‘900. Perché vi dico questo con molta freddezza? Perché se continuiamo a ragionare con questo paradigma pensiamo che la dimensione del lavoro che va tutelata e la dimensione dell’impresa è quella a cui siamo stati abituati per tutto il ‘900. Il salto logico che si deve fare, nella sua drammaticità, è che, accanto al paradigma capitale‐lavoro e stato nel mezzo, riconosce un nuovo paradigma di flussi che impattano nei luoghi, li cambiano dal punto di vista dei lavori, dal punto di vista antropologico e culturale, e in mezzo la dimensione del territorio. Quando dico ‘flussi’ intendo alcune cose. Ad esempio la finanza è un flusso: chi avrebbe detto che il fallimento della Lehman Brothers, la grande banca americana fallita all’inizio della crisi, avrebbe avuto delle ripercussioni in Valtellina? Sappiamo tutti che tendenzialmente metà della popolazione valtellinese è ‘bancocentrica’, nel senso che ha un po’ di azioni o del Credito Valtellinese o della Popolare di Sondrio. Ovviamente tutti hanno ricevuto la lettera o di Melazzini o di De Censi in cui si diceva che le azioni da 100 sono passate a valere 30. Questo flusso finanziario è quindi arrivato qui, causando la restrizione sui mutui per l’acquisto delle case e sul credito alle imprese. Ecco che la finanza è un flusso che impatta nei luoghi e li cambia. Proprio perché la finanza è un flusso vi dovete aspettare che prima o poi anche le vostre due banche facciano la fine di tutte le altre banche del territorio, che cioè vengano acquisite da qualcuno ancora più grande. E’ un destino inevitabile che questo succeda, perché in tutti i territori del sistema‐paese c’è un processo di grande aggregazione per stare dentro la competizione. Vedete come i meccanismi finanziari producono un meccanismo di questo genere che non è qualcosa che non riguarda la Valtellina, perché sapete benissimo che la seconda impresa occupazionale della Valle, in termini di numeri, dopo la pubblica amministrazione sono le due banche. Le transnazionali sono un flusso, e significa che le imprese, dentro la globalizzazione, non sono più radicate sul territorio, ma vi sono solo ancorate, e si sollevano in base alle opportunità localizzative. Un esempio: quando la Nuovo Pignone è stata acquisita da un’impresa svedese c’è stato il problema di tenerla qui, con tutto quello che questo significa. L’esempio più semplice è però la Fiat: stiamo ragionando ancora come se il conflitto che c’è stato a Torino e a Pomigliano sia un conflitto dentro una logica capitale‐lavoro e stato in 2 mezzo. Invece la Fiat di Marchionne non è più quella di Romiti, che era una fabbrica fordista nella one‐ company‐town Torino. La Fiat di Marchionne è in primo luogo un flusso finanziario (poi c’è dietro un progetto industriale) che dice che ha 3 miliardi da investire, e li può quindi investire in Serbia, in Canada, o a Torino o a Pomigliano, quindi si negozia. Non si tratta più quindi dell’impresa a cui eravamo abituati. Le transnazionali sono un flusso e quindi le imprese atterrano sui territori in base alle convenienze localizzative, per costo del lavoro, opportunità, vincoli ecologici, e cultura imprenditoriale locale. Le Internet companies sono un flusso: SKY è un flusso, Murdoch è un flusso. E’ un sistema di comunicazione globale. E ovviamente il cambiamento antropologico dei flussi che arrivano nei luoghi è molto semplice: molti di voi tornando a casa troveranno i figli che chattano su Facebook, e sono dentro questo flusso, anche se voi chiederete loro di smettere e passare ai libri. Le Internet companies sono un flusso che entra nei territori, muta e cambia le forme della cultura locale. Ultimo esempio: le migrazioni sono un flusso, perché arrivano nei luoghi e li costringono a confrontarsi con modelli culturali, religiosi, sessuali, antropologici diversi: è l’incontro (o lo scontro) di civiltà. Una delle tematiche che attraversa questa valle è quella di chiedersi se un persona è dei nostri o no. I flussi di migrazione sono stati anche flussi di migrazione interna: anche quando arrivano i meridionali il ragionamento era lo stesso. Ora però si tratta di migrazioni globali che impattano nei luoghi e li cambiano. Se questo è il salto di paradigma, noi non possiamo più pensare alle forme del lavoro in primo luogo al singolare, perché (e questo è il secondo punto di riflessione teorica), se ragioniamo sul lavoro, dal fine secolo ad oggi è avvenuto un grande cambiamento epocale che si spiega con un concetto filosofico: l’attualità dell’inattualità. Cioè stanno riapparendo tutte le forme dei lavori storicamente dati che noi credevamo di aver superato. Questo è il punto vero su cui bisogna ragionare. Noi pensavamo di esser arrivati ad un punto tale in cui c’era il lavoro a vita, normato, salariato, garantito; il welfare garantito, dalla culla alla tomba, i servizi sociale e la pensione; ovviamente pensavamo che le imprese erano territorializzate e localizzate molto spesso vicino a casa. Oggi invece ad esempio il lavoro vicino a casa non lo troviamo più. Cosa è cambiato? Quello che nella modernità sta avvenendo è che in primo luogo riappare la schiavitù. Usando un termine meno forte: riappaiono i lavori servili. Prendiamo un caso estremo: se si va in Albania, si prende una ragazzina e la si mette sulla strada a prostituirsi, quello è schiavismo; ragioniamo invece nella normalità, in cui l’aumento dei lavori servili significa ad esempio che sempre più, chi può permetterselo, ha la badante. E’ una forma di welfare differito di cui c’è aumento anche nella tradizionalissima Valtellina; c’è tutta una serie di lavori che, se si è bianco, ‘studiato’ ed europeo non si fa. C’è una divisione etnica del lavoro, quindi (contraddizione estrema del nostro paese) il tasso di disoccupazione giovanile e non solo nel Mezzogiorno è altissimo, ma quando c’è da fare la raccolta dei pomodori a Pachino, o far funzionare la flotta peschereccia a Mazara del Vallo ci si deve affidare ai tunisini. Così anche per tutto un ciclo che riguarda ad esempio le ferriere. Anche nella tranquilla Valtellina i mungitori e chi si occupa delle vacche sono Indiani o Sikh. Quindi sappiamo che, a seconda del tipo di lavoro che c’è, c’è un mercato etnico dentro i flussi della globalizzazione. Si deve ragionare su questa contraddizione, sul fatto cioè che ci sia un tasso di disoccupazione altissimo giovanile (29%, 2 milioni di giovani che ormai non cercano più né lavoro, né studiano, e ormai sono in un ‘limbo’) e nello stesso tempo il click day (negli ultimi 15 giorni si clikkava un sito del Ministero e in base a questo si chiamava la forza lavoro) è durato 3 minuti, nei quali è andata via tutta la forza lavoro disponibile, le offerte che c’erano sul mercato dell’immigrazione. Quindi c’è un aumento dei lavori servili che però non ci riguardano, perché, ovviamente, se avete una figlia disoccupata non la mandate a fare la badante, né mandate un figlio a raccogliere i pomodori. Ieri ero in televisione a discutere di lavoro e si è presentata una donna italiana che fa la badante e che si lamentava del fatto di essere stata un po’ ‘allontanata’ dalla famiglia perché quello della badante sembra un lavoro poco dignitoso, da stranieri. Seconda attualità dell’inattualità: ritorna la ‘servitù della gleba’, cioè di coloro che stavano sul terreno del feudatario ed erano sua proprietà, quelle che Gogol’, raccontando la Russia zarista, chiama le ‘anime morte’. Chi sono i moderni servi della gleba? Sono i subfornitori, cioè fondamentalmente gli artigiani, le piccole imprese, che lavorano in commessa che viene loro data da una grande impresa. Se andate nel ricco Nord est ed entrate in alcuni capannoni, ed intervistate il proprietario, gli chiederete come prima cosa di chi 3 è il capannone. Vi risponderà che l’ha avuto in leasing da Benetton, poi vi dirà che così è anche per i macchinari, e poi per la materia prima; Benetton gli indica anche i modelli e i colori, e lui lavora, porta le merci da Benetton che lo paga un anno dopo. Vi dirà che è lui il padrone, e quando cercherete di fargli capire che non è il padrone, ma un proletaroide, si offenderà moltissimo, perché è convinto di essere invece lui il padrone della piccola impresa. Un ciclo di subfornitura ci sta pure qui in Valtellina, e se andate nella pedemontana lombarda trovate il proliferare di questo fenomeno. La servitù della gleba è quindi sancita dalla subfornitura, tant’è che abbiamo dovuto fare una legge, peraltro non rispettata, in cui si dice che si paga il lavoro di subfornitura a 60 giorni. Terza attualità dell’inattualità: riappaiono in maniera molto forti quelle che nel Medioevo erano le gilde, o corporazioni di mestiere, che riguardano soprattutto coloro che hanno nel proprio sapere e nelle proprie competenze, continuamente aggiornate, il mezzo di produzione, l’intelligenza, il know how: è la famosa terziarizzazione, quella per cui c’è una proliferazione di nuove professioni, legate all’informatica, alla pubblicità, alla comunicazione, al marketing. Pensate che le forme nuove di lavori che vorrebbero essere riconosciute, e che avevamo censito ai tempi del C.N.E.L. con De Rita, sono almeno 350. Siamo abituati agli ordini professionali di quelle che nel ‘900 erano le cosiddette professioni liberali: gli avvocati, i notai, gli ingegneri… Oggi c’è un proliferare delle nuove professioni, che nella maggior parte dei casi si coniugano all’inglese perché vengono dai meccanismi della nuova economia, e quindi c’è grande voglia di nuove corporazioni di mestiere, di mettersi insieme, di essere riconosciuti, legittimati: sono le famose partite I.V.A. Ultimo dato: c’è il lavoro normato, salariato che si spacca in due tronconi, uno è quello a tempo determinato (o addirittura in affitto) e l’altro quello a vita. Quando si pensa al lavoro di solito si pensa solo a quest’ultimo, secondo la logica del ‘900: si entra in un posto di lavoro, si ha la garanzia e si acquisisce professionalità, si fa carriera, si arriva alla pensione e si esce. Nulla di tutto questo, e se vi paiono fantasie sociologiche vi leggerò i dati dell’I.S.T.A.T.: in Italia il mercato del lavoro si divide in 4 grandi segmenti: un bacino di lavoro individuale con autonomia direttiva (5.400.000 tra dirigenti, consulenti, quelli che ‘ce l’hanno fatta’); poi il lavoro sempre individuale, ma con situazione di dipendenza (chi lavora individualmente mediato da una cooperativa o strutture simili: 970.000 persone); quindi una situazione di lavoro individuale che riguarda 6.500.000 persone con in più il lavoro dipendente atipico e a termine (2.500.000 persone) e il lavoro dipendente classico (15 milioni di persone). Come vedete il lavoro dipendente classico si sta restringendo e stanno aumentando tutte le nuove forme dei lavori. Questo è il vero, grande cambiamento epocale che sta avvenendo e che ha delle implicazioni incredibili dal punto di vista antropologico e culturale. Un esempio che mi riguarda personalmente è che io, che ormai ho 60 anni, sono riuscito a far capire a mia mamma che lavoro faccio solo da una decina di anni, perché lei, che giustamente era contenta di avermi fatto studiare, si chiedeva come mai io fossi ‘dottore’, perché per lei il dottore è solo quello che si occupa della salute ; mi diceva ancora che non aveva capito che lavoro facessi, ma che capiva che lavoravo con le parole, cosa assolutamente insignificante, ovviamente. Ma la cosa più grave era che lei, credendo di farmi un complimento, dopo che ero andato alcune volte in televisione, mi ha detto: “Forse ho capito che lavoro fai: sei un po’ come Sgarbi, però va bene”. Perché chi ha in mente la forma del lavoro del ‘900 non capisce: ho cercato di farle capire che faccio il sociologo e mi occupo delle ‘malattie’ della società, ma per lei le malattie sono quelle che riguardano il corpo umano. Vedete che cambiamenti epocali ci sono stati. A fianco di questo schema che vi ho presentato del che cosa è il lavoro oggi in Italia, sempre ragionando in termini di mentalità del ‘900, ci si deve chiedere che cosa è il capitale. Il lavoro si trova in un capitalismo che è strutturato in questo modo: il capitalismo italiano è fatto da 10 grandi gruppi, che non sono più quelli a cui eravamo abituati nel ‘900 (la Falk ad esempio non c’è più; nel T5 e T3 di Sesto S. Giovanni, che erano i grandi forni della Falk, cresceranno gli alberi, come mi spiegava Renzo Piano, perché ovviamente c’è un progetto di ristrutturazione edilizia di quel territorio; l’Alfa Romeo non c’è più) e che rimandano tutti al capitalismo delle reti, non più a quello manifatturiero. Ci sono due banche, Banca Intesa San Paolo e Unicredito, che insieme fanno 400.000 dipendenti (ovviamente non solo in Italia ma in tutto il mondo), poi abbiamo l’Enel (e ne sapete direttamente qualcosa, perché un po’ ne avete qua, anche se ce ne sarà sempre meno, dato che l’Enel sta dismettendo le centrali, con tutto quello che ciò significa), l’E.N.I., un po’ 4 di Pirelli e un po’ di Fiat (completamente cambiata, perché non è più quella di Romiti), un po’ di Finmeccanica, e quelli che gestiscono le autostrade. Poi ci sono 6.000 medie imprese globalizzate (l’ex Nuova Pignone è una di queste) e 6 milioni di capitalisti molecolari, cioè artigiani, piccoli imprenditori, commercianti ecc. Questa è la parte del capitale. Quindi questa è la situazione. Se questi sono i grandi cambiamenti, partirei da un esempio molto interessante. Sabato scorsa ero a Milano alla Fondazione Cariplo con il Cardinale di Barcellona e il Card. Tettamanzi di Milano a presentare i risultati del Fondo famiglia‐lavoro della diocesi di Milano a cui le A.C.L.I. hanno contribuito insieme alla Caritas. La diocesi di Milano riguarda il cuore del capitalismo produttivo italiano, con Milano, parte di Varese, Monza, Lecco, parte di Como, Melegnano. E’ la parte più produttiva del sistema‐paese. Il Cardinale di Milano ha istituito un Fondo di 11 milioni di euro per sostenere le famiglie e i lavoratori in difficoltà dentro la crisi, quelli che non erano protetti dal meccanismo del ‘900. Perché se in tempo di crisi sei un lavoratore normato, salariato a vita, tendenzialmente hai la cassa integrazione che ti protegge. E’ molto interessante andare a vedere chi ha chiesto aiuto al Fondo: il 56% dei richiedenti sono migranti, non quelli clandestini, ma quelli che fanno i lavori che noi non facciamo più e che sono in regola, e che sono in parte i primi che hanno pagato il prezzo della crisi; come inciso vi dirò che ho sentito in molte parrocchie il ragionamento del chiedersi se queste persone sono dei nostri o no, e mi sono molto preoccupato, perché se nei centri di Ascolto Caritas ci si comincia a porre questo problema significa che non ce n’è più per nessuno: non mi meraviglio se sento questi discorsi in una sede della Lega, ma se lo sento in una parrocchia mi preoccupo perché significa che comincia a venir meno un meccanismo di solidarietà estremamente importante. L’altra polarità che mi ha colpito è che un 12% (che però secondo me va raddoppiato) era fatto da quei famosi ceti medi (impiegati, insegnanti…) che hanno superato la vergogna della miseria; dico che il numero va raddoppiato perché quando li abbiamo intervistati ci hanno detto che mai avrebbero pensato di dover chiedere aiuto per comprare i libri dei figli o pagare la rata della macchina. Si tratta quindi di una crisi dei ceti medi che erano garantiti dentro queste forme dei lavori. L’altro dato su cui vi farei riflettere è che il 53% delle famiglie che hanno chiesto aiuto erano ‘regolari’(marito, moglie, uno o due figli), l’altro restante, cioè più del 40%, era fatto da monogenitori donne (12%) con figli, monogenitori maschi e poi un mix. Il che significa che l’altro tassello del welfare è un soggetto che non è più in grado di ‘tenere assieme’ tutto quanto. Quindi dentro questa transizione abbiamo una modernizzazione accelerata che viene avanti e che ha cambiato le forme del produrre, le forme dei lavori e che nello stesso tempo mette in crisi la forma del welfare e la famiglia come tassello di ridistribuzione della solidarietà tra simili (di sangue) con tutto ciò che questo significa. Cosa si può fare allora? In primo luogo si deve prendere atto che la modernità ha questa faccia, senza avere nostalgia: non serve pensare che si possa tornare al passato (lavoro a vita, sindacato che tutela, welfare, imprese territorializzate) perché non è possibile. Questo è il punto: i grandi cambiamenti sono questi. Può sembrare un ragionamento strano, perché c’è sempre qualcuno che obietta come possa essere possibile che, nel massimo della modernità, ci sia una situazione di questo genere. E’ molto semplice: siamo passati da una società con mezzi scarsi e fini certi ad una società con mezzi iperabbondanti e fini totalmente incerti. La prima cosa che dobbiamo quindi fronteggiare è fondamentalmente il senso di incertezza rispetto al futuro e la paura del cambiamento, perché prima (anni ’50‐’60) i mezzi erano scarsi (il benessere è stato costruito attraverso una logica di grandi sacrifici) ma i fini erano certi (avere la casa di proprietà, mandare i figli a scuola e farli studiare, poi, da ultimo, si sapeva come si nasceva e si sapeva come si moriva). Siamo passati ad una società con mezzi iperabbondanti, in cui la tecnica permette di andare virtualmente da Morbegno a New York e ritorno in chat, oppure prendere un volo low cost: il problema è che il tutto avviene nella totale incertezza dei fini. Quindi come prima cosa, se ragionassi sull’impegno sociale politico dei cattolici, è che bisogna lavorare sull’apocalisse culturale: Ernesto De Martino, un grande antropologo, diceva una cosa molto semplice, cioè che l’apocalisse culturale ci prende ogni volta che non ci riconosciamo più in ciò che ci era abituale, cioè nelle nostre abitudini (e sto parlando degli ultimi 20 anni di questo paese). C’è stata una tale accelerazione del cambiamento che bisogna parlare ai soggetti sociali in termini ‘maieutici’, educarli a prendere atto dei 5 grandi mutamenti della realtà che ci sono stati. Bisogna lavorare su due polarità: l’infelicità senza desideri e l’infelicità desiderante. L’infelicità senza desideri prende gli anziani, che dicono che tutto è cambiato, che non capiscono più nulla, che non sanno più come muoversi, che non si riconoscono più nei grandi cambiamenti (della tecnica, della cultura, della sessualità, dei valori, delle forme di convivenza, degli usi e dei costumi); l’infelicità desiderante, che è quella che prende soprattutto i giovani, è quella per cui questa società mostra tutto come se fosse a disposizione; i giovani hanno una cultura dei desideri dentro la quale tutto è disponibile (in Internet trovi tutto); si può cioè fare tutto, ma il problema è che, appena si cerca di prendere qualcosa (il lavoro, una casa) non si trova nulla e questo produce una rabbia sorda. Ecco perché bisogna lavorare sull’apocalisse culturale, educare al cambiamento, all’ipermodernità che viene avanti: educare, informare, spiegare i grandi cambiamenti. Questo è secondo me il primo compito. Secondo compito: questi cambiamenti, che partono dal lavoro e dall’economia ma poi riguardano tutta la società, producono tre grandi comportamenti collettivi. Primo comportamento, che mi preoccupa molto, è che, siccome aumentano incertezza e paura, aumenta anche il fatto che il soggetto si sente solo. Non c’è più la comunità di riferimento di un tempo, la famiglia è in difficoltà, i paesi sono ‘spaesati’ (chiudono negozi e bar, vengono avanti ipermercati e discoteche), vengono meno le figure di riferimento della comunità originaria: nel ‘900 c’era capitale, lavoro e stato, ma nella comunità c’erano 5 persone di riferimento (il parroco, il farmacista e il medico condotto, il maresciallo dei carabinieri, il direttore della banca e aggiungiamo la maestra) che hanno perso questo ruolo. La maestra non conta più, anzi di solito è una precaria, il direttore della banca lo cambiano in continuazione, il parroco fa quello che può (come dice il card. Martini, il parroco sta dentro il cattolicesimo di minoranza), figuriamoci il maresciallo dei carabinieri. Non c’è più quel mondo del ‘libretto della spesa’, che era il codice della fiducia. All’Iperal oggi non ci si va se non si ha il Bancomat o la carta di credito. Nella dissolvenza della comunità c’è però una grande voglia di comunità, perché l’essere umano, anche se siamo nella fase della secolarizzazione e dell’individualismo compiuto, è fatto per stare in comunione, per stare con l’altro. Ci sono però tre comportamenti collettivi in cui questa voglia di comunità precipita: la voglia di comunità rancorosa (come dice il dizionario, rancorosa è una persona che ritiene che non gli è stato riconosciuto un merito o che ha subito un torto, e penso che un poco tutti noi un po’ rancorosi lo siamo); c’è una forma di rancore territoriale (non c’è più la comunità, quindi ‘chiudiamoci’ nella nostra comunità, con la nostalgia di come eravamo, e non è un fatto che accade solo in Valtellina; pensate che a Opera, dove c’è una grande comunità Rom, la comunità si è raccolta intorno a loro, ma non con scopi pacifici, né a livello di Consiglio pastorale, né di sindacato: la comunità si è rinserrata contro lo straniero); c’è una forma di rancore nei giovani che sono disoccupati (circa il 29%): noi siamo, come sistema‐paese, a metà tra Germania e Tunisia, non solo geograficamente, ma anche dal punto di vista della composizione tecnico‐produttiva, perché siamo un capitalismo molecolare diffuso e non il grande capitalismo renano con grande impresa, grande sindacato e grande banca, e dovremo scegliere qual è l’uscita dalla crisi; ma la disoccupazione giovanile in Germania è ad una tasso fisiologico ed assorbibile del 10%, da noi è al 29%, in Algeria è al 45%, in Tunisia al 30% da dieci anni e quelli che stanno facendo la rivolta oggi lì, e giustamente, sono i giovani che hanno studiato). Terzo tipo di rancore sono i famosi capitalisti molecolari, quei 6 milioni di imprenditori, artigiani e piccoli imprenditori che non ce la fanno più, quelli che una volta erano la piccola borghesia; il dato eclatante della crisi è che non abbiamo avuto fenomeni come 20 anni fa alla Fiat di Torino, quando i cassaintegrati si impiccavano perché perdevano lavoro ed identità (sto parlando dei tempi di Romiti, dei primi grandi licenziamenti di massa), ma nella crisi attuale molti artigiani e commercianti del Nord est quando sono falliti si sono tolti la vita. E’ un bacino di rancore che va svuotato, perché la gente è incattivita, e questa cattiveria si nota anche nelle forme di convivenza. Tutti sono arrabbiatissimi, tesi e nervosi. A fianco di questo grumo rancoroso, per fortuna, ci siete voi, che magari alla mattina siete rancorosi ma alla sera siete in parrocchia. Voi siete una cosa molto importante, quella che io chiamo la ‘comunità di cura’: io credo che per fare quello che voi state facendo stasera ci voglia minimamente uno spirito che ci spinge a stare insieme agli altri, a curare noi stessi e a pensare ad un minimo di cose cristianamente compatibili. La comunità di cura è fatta dal meglio delle professioni del ‘900, del welfare: ad esempio gli insegnanti, che sono un pezzo fondamentale di questa comunità di cura, che io difendo perché quella funzione di educare e produrre inclusione è fondamentale, 6 tant’è vero che sono stati loro a dire al ministro Gelmini che era meglio fare le classi miste che separate; poi penso a medici, infermieri e psichiatri, tutti coloro che fanno una professione di cura e di inclusione sono un pezzo di welfare che dobbiamo mantenere. Dobbiamo concentrare le poche risorse in alcune funzioni pubbliche, che abbiano una grande capacità di inclusione ed educazione. C’è poi a fianco, l’impresa sociale, il volontariato, l’associazionismo, quello di cui vi ha parlato Zamagni. Le A.C.L.I. sono un pezzo di questa comunità di cura, e io dico che anche il sindacato lo è. Per fortuna c’è una comunità di cura che ‘tiene’, per cui, nonostante questa modernità selvaggia che viene avanti, in questo paese non abbiamo ancora buttato i vecchietti per la strada e non abbiamo ancora gasato gli handicappati. Dobbiamo ‘tenere’ su alcune cose, anche se la famiglia non ce la fa più, perché è diventata il luogo della guerra civile e molecolare, un luogo di conflitto tra generazioni, e ci sono dei dati che lo dicono: ogni 3 giorni viene ammazzata una donna entro le crisi della forma di convivenza e dei rapporti affettivi, quindi significa che c’è qualcosa che non va. Da quando eravamo una società agro‐silvo‐pastorale c’è stato un aumento della violenza dentro i rapporti interpersonali, il che significa che c’è bisogno di cura. Seconda indicazione: oltre a svuotare il bacino del rancore dovete alimentare la comunità di cura, perché questa non è più naturalmente data, ma è un artificio, va costruita artificialmente. Ma non basta, perché se pensate che il problema si risolva mandando per il mondo quelli che appartengono alla comunità di cura contrapponendoli a quelli che sono nella comunità del rancore, vi illudete, perché in questo paese vince il rancore; la cultura egemone è quella del rancore, non della cura. Allora bisogna ragionare su un terzo punto: la comunità operosa, cioè i soggetti dell’economia. Bisogna ricominciare a costruire un rapporto tra la dimensione economica dell’impresa (che deve essere responsabile, territorializzata, tener presente i problemi ecc. ‐ e ne avete microesempi anche qui in valle) e la dimensione della cura che produce coesione sociale; bisogna costruire una dottrina sociale in cui l’impresa deve essere certamente orientata al profitto, ma responsabile; pensate che al Forum di Davos sulla globalizzazione quelli che hanno tenuto la lezione sul come se ne esce sono stati gli Indiani, con una tesi ben precisa: abbiamo un paese di affamati, ma cominciamo ad entrare nei modelli di sviluppo, quindi ci serve una crescita includente, mentre sino ad ora si è ragionato in termini di esclusione. Una crescita inclusiva si può avere solo mettendo insieme la comunità operosa con la cultura della comunità di cura, e che tutte e due insieme prendano per mano i rancorosi impauriti ed incerti, dicendo loro: “Non abbiate paura, forse anche questa volta l’umanità ce la farà”. Risposte ad alcuni interventi Ha parlato, riferendosi ai giovani, di voglia di comunità, di rancorosità e anche di apocalisse culturale e di educazione. Questa educazione al cambiamento è più rivolta ai giovani o agli anziani? Mi sembra anche che si stia investendo molto poco sui giovani. Ho scritto recentemente che quello che mi preoccupa è che siamo una società che sta smarrendo la propria ombra: una società che non si occupa di chi viene dietro è una società morta. Quando guardo ai giovani mi viene da dire che io alla loro età volevo cambiamento, ho fatto la rivoluzione, ho fatto di tutto, sono andato via di casa, ma mi trattengo dal fare predicozzi, primo perché so che non posso dare esempi, poi perché sono molto convinto che siamo davanti ad una generazione ‘senza libro’. Per la prima volta nella nostra storia viene avanti un soggetto giovanile che, per fortuna o per disgrazia, non ha il libro come punto di riferimento. Ognuno di noi l’ha avuto, quale che esso fosse, e quando dico ‘libro’ intendo un’ideologia, un’appartenenza, con tutto ciò che significa. Dentro il libro ci stanno i valori e la Weltanschauung, cioè la concezione del mondo. Il libro dei giovani oggi è giustamente la Rete, e stanno imparando una grammatica e un linguaggio, con molta difficoltà, perché quando si ha il libro un po’ di certezze ci sono, ma se ci si deve costruire questa grammatica giorno per giorno si fa fatica. Probabilmente poi ci insegneranno questa grammatica e questo linguaggio, quindi bisogna essere ottimisti da questo punto di vista. Seconda cosa: hanno avuto la disgrazia di appartenere ad una società gerontocratica, in cui nessuno va mai in pensione, soprattutto nei ruoli di potere, a incominciare dai professori universitari per finire ai politici. Io credo che una funzione di queste cose sia ‘senatoriale’, cioè di coloro che quando iniziano un percorso di maturità, hanno il compito di aprire la strada a quelli che vengono dopo; ma qui di strada non ce n’è, soprattutto 7 perché siamo tutti abbarbicati a difendere le corporazioni del ‘900. Terzo punto, e questo è il vero problema: con loro bisognerebbe ricominciare a sviluppare un meccanismo di autorevolezza; la famiglia che abbiamo distrutto nel ’68 non ha più autorevolezza, che significa avere la forza di sviluppare il conflitto con quello che viene dopo di te, perché se questo non ha il rapporto conflittuale e crede che tutto sia facile non riuscirà mai ad emanciparsi e a crescere. Ci sono tesi psichiatriche e psicanalitiche che dicono che ovviamente il desiderio senza limiti, senza il concetto di limite, è un desiderio che ti perde. Quindi o i limiti li trovi nel quotidiano, o sono quelli del non trovar più lavoro, ecc. e di fronte ad essi si è talmente impotenti e deboli che ci sono 2 milioni di giovani che non cercano più lavoro e neppure studiano. E due milioni significa che questo è diventato un problema sociale molto alto, per le famiglie e per i giovani. Su questo punto nodale la società italiana, se non vuol fare la fine della Tunisia, dovrà interrogarsi, perché prima o poi quel bacino che cresce inevitabilmente chiederà spazio. Di fronte a questa crisi, alla disoccupazione giovanile, le A.C.L.I. si sono interrogate due anni fa e il Presidente nazionale ha preparato un documento sullo Statuto dei Lavori che è fallito ancor quasi prima di nascere perché si inquadrava ancora nel vecchio paradigma. Ma al di là di tutto il problema resta, e non si intravvedono soluzioni. I giovani senza lavoro non hanno futuro. Il cap. 2 della Caritas in Veritate al n. 25 parla chiarissimo delle crisi psicologiche delle famiglie. La diagnosi che abbiamo sentito è stata bellissima, ma quali soluzioni ci sono? Credo che l’umanità, o meglio le società, hanno sempre vissuto drammatici periodi di transizione come questo; il passaggio di secolo non è stato solo un fatto temporale. Bisogna essere però ottimisti perché se noi guardiamo quello che riappare, guardiamo ad un déjà vu, cioè a come abbiamo reagito un tempo rispetto a questo. Vi faccio due esempi: pensate al passaggio dalla società agricola a quella industriale. Anche quello sembrava l’apocalisse, perché si era abituati a lavorare con il sorgere e il tramontare del sole, e ad un certo punto l’umanità ha dovuto abituarsi a lavorare al suono delle sirene, al lavoro notturno; l’industrializzazione ha significato questo: esodo dalla campagna dentro le fabbriche con grande cambiamento delle forme del lavoro. Secondo: eravamo abituati al prosumerismo (anglicismo che riunisce il ruolo di produttore e consumatore) di ciò che ci lasciava il padrone, cioè si produceva, il padrone lasciava nella mezzadria un po’ di cose e così si consumava quello che si lavorava. Nel passaggio alla società industriale abbiamo dovuto pensare che la merce si pagava. Terzo: quello che contava era la storia orale, non si sapeva leggere o scrivere; quando si va in fabbrica bisogna perlomeno, per capire il comando, imparare a leggere o scrivere. Quarto: non esisteva molto il denaro, c’era molto di più il baratto. Entrando invece nella società salariata ci si deve muovere con il denaro. Sembrava davvero l’apocalisse, e i contadini, quelli del “Quarto stato” di Pellizza da Volpedo, fecero rivoluzione a Milano, stroncati da Bava Beccaris. Capito questo, cominciarono ad organizzarsi, non nel sindacato, ma nelle Leghe, nelle Mutue (perché in campagna non c’era più la badante o la balia); non sapevano leggere e scrivere, non sapevano l’uso del denaro e quindi inventarono le Casse Rurali, le Banche di Credito cooperativo, le Casse di Risparmio, e anche, ovviamente, le Cooperative di consumo. Oggi siamo nella stessa situazione, solo che quello che lasciamo è quello che abbiamo conquistato nel passaggio dall’agricoltura all’industria. Ora dal lavoro dobbiamo passare ai lavori e quindi, tendenzialmente, era giusta la proposta dello Statuto dei Lavori, ma con l’errore di pensare che lo stato doveva metterci i soldi. Bisogna invece partire dal basso, auto organizzarsi, costruire le mutue ecc. Già lo si fa: dirigo un istituto di ricerca in cui lavorano 40 persone. Siamo tutti lavoratori autonomi, il cosiddetto terziario avanzato, e tutti quanti noi non abbiamo pensione, quindi siamo andati da un’assicurazione tutti insieme per ‘spuntare’ una pensione assicurativa. E’ importante quindi l’auto organizzazione dei soggetti per il lavoro, per la conoscenza (perché oggi non basta saper leggere e scrivere ma bisogna chattare e navigare) e bisogna aver fiducia che dentro il cambiamento il soggetto umano trova la forza di organizzarsi per affrontare la modernità che viene avanti. E ci saranno periodi in cui si è già capito come si esce dalla crisi (ad esempio attraverso la green economy, sempre più con problematiche ambientali) anche se con grandi turbolenze, perché finora la crescita è stata non inclusiva ma selettiva ed escludente. Il problema è che queste cose si cambiano prendendo parola ed agendo. Da registrazione – non corretta dal relatore 8
Scarica