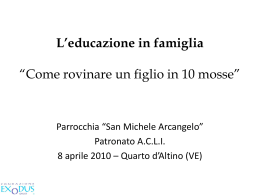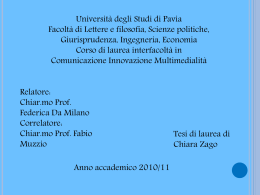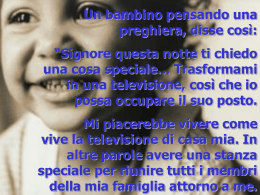Anno 1 Numero 38 - 10.11.2008 A che serve la televisione Editoriale di Gian Maria Tosatti In un libro estremamente acuto, Lo sguardo e l’evento, Marco Dinoi, ricorda rapidamente il Don Chisciotte incompiuto di Orson Welles. Un breve lavoro in cui il cavaliere di Cervantes, seduto in una platea cinematografica, si lancia contro lo schermo fino a squarciarlo, tra lo stupore di un pubblico, lucidamente consapevole della differenza di piani fra immagine e realtà. Quest’opera di Welles è un paradosso che, come sempre, nasconde una verità a sua volta paradossale. Guardando il film, o forse alla fine del film, infatti, ci si chiede chi effettivamente sia dalla parte giusta, il pubblico, nel suo distacco sterile, o il cavaliere dalla complessa Weltanschauung. Tale paradosso cinematografico diventa ancora più calzante se portato nel presente e adattato al rapporto che intercorre fra spettatore (o, più correttamente, spettatori) e televisione. In una linea di continuità che parte dal concetto heiddegeriano di “immagine del mondo” e arriva alla constatazione di Barthes secondo cui gli uomini «vivono conformemente ad un immaginario generalizzato», Dinoi ci aiuta a capire come «la finestra sul mondo tenda a diventare il mondo». Ciò in virtù del fatto che lo spettatore contemporaneo crea naturalmente, come Don Chisciotte, un piano esperienziale misto fra ciò che è reale e ciò che è rappresentato dall’immagine. Cosa che si dimostra giusta e fondata se si tiene conto che, di fatto, la televisione è lo strumento percettivo più evoluto che l’uomo abbia sviluppato da quando la sua identità ha iniziato a sviluppare un piano metamorfico che rendesse le macchine una estensione di sé. Assunta dunque a sesto senso la scatola delle visioni, con i suoi modelli culturali e la sua informazione sul presente-futuro, assume una essenza trascendente, vagamente oracolare, simile alla palla di vetro delle fattucchiere medievali, qualcosa entro cui è contenuta l’anima del mondo e il romanzo delle Parche. Eppure, in un epoca di ateismo temperato, risulta assai difficile poter assegnare consapevolmente alla televisione quel ruolo di specchio magico che, di fatto, poi s’innesca per magnetismo ogni qual volta l’elettricità statica dello schermo trattiene come una forza di gravità il flusso dei pensieri e di suggestioni di chi gli sta di fronte. Così, a ben pensarci, l’onniscente finestra, come nel Mago di Oz, appare nella sua cruda limitatezza, ma ancor più nella sua perversione di amplificatore non dei nostri sensi, quanto dei disegni di qualche architetto, o meglio, di una squadra di architetti, ordinati in fila indiana lungo la linea di un palinsesto. La percezione umana passa dunque per uno strumento maneggevole e maneggiato, la cui pretesa obiettività va esattamente contro la stessa costituzione dell’identità del mezzo che, non essendo veramente magico, prevede che dall’altra parte della bocca della verità vi sia un operatore con la tagliola il cui obiettivo è far emergere una determinata e, gioco forza, limitata versione della realtà. Non è questo necessariamente un male. Che lo sia, o che invece sia il suo opposto dipende da quale funzione viene con chiarezza attribuita allo strumento e alle sue meccaniche. Se è innegabile un legame fra la televisione e il teatro (che è stato appunto la televisione per 25 secoli), nella prospettiva appena proposta esso diventa quasi una linea guida, una istruzione per l’uso. E riferendosi al teatro, ed alla sua funzione, Bertolt Brecht, ebbe a dire nel 1955 (ossia quando la televisione non era ancora un mezzo di comunicazione della massa) che «il mondo d’oggi può essere descritto agli uomini d’oggi solo a patto che lo si descriva come un mondo che può essere cambiato». In questo senso, attualizzando, si potrà affermare che, per lo spettatore contemporaneo, funambolo come il Don Chisciotte di Welles sul filo teso fra platea e schermo sfondato dall’immagine, la televisione serva a misurare la distanza fra il ruolo tragico dell’essere umano (delineantesi attraverso i contenuti: fiction, film, sceneggiati, sit-com, ecc.) e i confini della realtà che lo contengono (descritti dall’informazione dei telegiornali o delle trasmissioni di approfondimento). Tale scenario sviluppa una prospettiva dialettica di rapporto fra l’ambizione umana e una lettura in chiave tragico-greca dell’assunto di Charles Wright-Mills (contemporaneo a quello brechtiano) secondo cui l’uomo contemporaneo è trasceso nella possibilità di incidere sull’evoluzione (politica) del mondo, fin nei suoi microcontesti. Ed appunto nella differente accezione che queste due visioni danno al concetto di “destino” che si consuma la sintesi della questione. La televisione può essere lo strumento in grado di collocare l’uomo nella realtà permettendogli di eleggere un destino che la sua ambizione dovrà battere. Da questa ipotesi nascerebbe una Tele-destino, effettiva “rifondazione” della tragedia classica (che avrebbe come precursore il progetto di un teatro “effettivamente” televisivo che ha portato per tre anni la Societas Raffaello Sanzio a creare agoni nelle città simbolo di tutta Europa). Una necessità ontologica del mezzo che coincide con una necessità storica della società. Tele-destino sarebbe una televisione fatta da architetti e drammaturghi, in cui i la catarticità dei “contenuti” e l’oggettività dell’informazione sarebbero paradigmi imprescindibili. (Tutto l’opposto di Tele-sogni, il terribile incubo concepito anni fa da Maurizio Costanzo di televisione fatta dalla gente, priva di contenuti e priva di destino, sabbia mobile dell’intelletto e colonna portante della stagnazione sociale, che dalle nostre finestre aperte sul mondo entra quotidianamente nelle nostre vite). Come in televisione L’incidente della realtà di Attilio Scarpellini In La fille qui cachait ses yeux, l’ultimo romanzo dello scrittore Jean Roux, un uomo e una donna viaggiano insieme sull’autostrada che da Parigi va ad Avignone. Mentre stanno parlando un rallentamento improvviso li porta nel cuore di un incidente sulla corsia di sorpasso. “Albert dovette forzare la mano sul volante, mentre la scena dell’incidente emergeva da lontano come una nube che nel cielo forma una figura inaspettata, e forzare se stesso per non pensare che la vera destinazione di quel viaggio, il loro primo viaggio insieme, non fosse bruscamente arrivata e ora, mentre le scorrevano accanto nel traffico canalizzato dai poliziotti, a quella strana andatura lenta e crescente, simile al ritmo di una triste sinfonia, stavano entrando in un altro tempo, nel loro limbo: con la coda dell’occhio aveva intravisto l’automobile rovesciata sul ciglio della strada, forse una Peugeot 305, e l’ambulanza che avanzava quasi senza peso nella direzione opposta di marcia; proprio sulla striscia della mezzeria un uomo era disteso a terra, la testa appoggiata su una giacca ripiegata, un altro gli stava sopra, chino sul suo corpo, come se lo volesse ricoprire o raccogliere dalla bocca le sue ultime parole, le porte dell’ambulanza si erano aperte e, con angelica indolenza, gli uomini con il giubbotto rosso spingevano la barella sulla strada. Albert si rese conto che la mano di Esther si era staccata dalla sua e che adesso aveva paura di alzare gli occhi su di lei per guardarla.” Più tardi, mentre i due sono seduti al tavolo di un ristorante assieme ad altri amici, Esther racconta la sua versione dell’incidente, omettendo completamente il dettaglio dell’uomo sdraiato a terra: il traffico rallenta, le ambulanze arrivano suonando dall’altra parte della strada, e all’improvviso “tutto è stato come in televisione, persino la patina delle immagini era cambiata: era diventata più vaga e nello stesso tempo più fatale.” Roux annota l’euforia con cui la ragazza, una body artista che si esercita “a far sparire il proprio corpo”, descrive la scena agli amici: “avvolgendo ogni parola nell’emozione briosa, innocente di un evento dove non è avvenuto niente, a parte l’evento dell’evento che con il suo ritmo da film rallenta ed elettrizza le nostre vite. Per Esther la realtà aveva prodotto l’ennesima sceneggiatura. Nascosto dietro un sorriso rarefatto, Albert la guardava obliquamente, indeciso se amare perdutamente quell’innocenza che senza dubbio lo avrebbe dannato per tutta la vita o scagliarsi contro di lei con una di quelle prediche moralistiche che erano la sua specialità” Dopo aver lasciato Esther, Albert lavorerà da una parte alla ricostruzione della storia dell’uomo rimasto vittima dell’incidente, dall’altra a quella del passato della ragazza, scoprendo che nel momento in cui suo padre è morto in un ospedale della provincia francese lei era impegnata in un provino per la televisione franco-tedesca Arté. La fille qui cachait ses yeux, romanzo incompiuto (e fallimentare secondo il suo stesso autore che lo aveva destinato al macero), continuerà a girare a vuoto sul tema dell’elusione della morte o meglio dello scarto temporale tra la puntualità del suo evento e l’impossibilità di guardarlo in faccia, di entrare “con gli occhi aperti”, come dice Esther “nello spazio in cui un altro venendo meno al mio sguardo lo azzera, costringendomi a non essere più o a esistere solo dopo di lui”. Un'altra scena di incidente occupa completamente la videoinstallazione dell’artista olandese Aernut Mik presentata al Museion di Bolzano nel corso dell’esposizione inaugurale Sguardo periferico e corpo collettivo. Per la precisione, l’immagine di Refraction (2004) straborda dalla sua cornice – “rompere la struttura” è una delle caratteristiche del lavoro finzionale di Mik – producendo un continuum televisivo senza interruzioni, un lungo piano sequenza che dà l’impressione di articolarsi interamente attorno all’evento: il pullman rovesciato nel mezzo della strada, una lunga coda di automobili bloccate, i pompieri e i poliziotti che prestano i primi soccorsi, i superstiti seduti sul ciglio con le coperte sulle spalle. Poi, il campo visivo che si apre in grandangolare fino ad abbracciare l’intero orizzonte, la squallida pianura ungherese, i dirupi fangosi e un gregge di pecore che attraversa la scena con l’anarchica incuranza che ha la natura sui teatri delle catastrofi umane. Dapprima è la stessa ipertrofia del disastro a produrre un sentimento di alienazione, molto simile a quello che trasuda dai reiterati incidenti delle corriere turche raccontate nella Nuova vita, uno dei più lunari romanzi di Orhan Pamuk. Ma ci vuole qualche minuto perché questo moto perpetuo di uomini e di animali, dopo aver stonato lo spettatore, cominci a insospettirlo e dalla distrattività dell’immagine televisiva emerga l’assurdità del dettaglio che rivela la messa in scena e la sua finalità: il pompiere che si cala da un oblò nell’abitacolo del pullmann entra in un ambiente completamente vuoto, gli uomini e le donne che stazionano sul ciglio della strada vengono assistiti ma non sono feriti, le barelle delle ambulanze non trasportano alcun corpo e sulla strada ci sono tutte le tracce di un incidente catastrofico tranne quelle che segnalano la sua tragedia umana – non c’è sangue, né corpi straziati recuperati dalle lamiere. Insomma, niente accaduto e niente accade. Aernut Mik ha messo in scena la forma televisiva dell’evento senza l’evento o se si preferisce il montaggio di una realtà che, per l’appunto, è ormai la mera rifrazione della sua apparenza mediatica. La percezione televisiva che nel romanzo di Roux si sovrappone alla realtà dell’evento per svuotarlo del suo contenuto reale – la morte – nella scena di Refraction dà luogo al suo contrario: l’elemento perturbante non è il cadavere, ma la sua assenza e il totale appiattimento di un’immagine priva di punti di riferimento, anche rimossi, al di fuori di se stessa. Nella sequenza tendenzialmente infinita, e vistosamente indefinita, In un senso, questo trompe l’oeil celebra la fine di quella dualità tra l’immagine e il segno che Baudrillard considerava ancora l’estrema risorsa della rappresentazione prima dell’avvento di una “realtà integrale” dove la rappresentazione non avrebbe rappresentato più nulla: né romanzo né tragedia, né epos né commedia, solo il vacuo ondeggiare dello sguardo in un paesaggio dove niente può essere al di là dell’immagine e persino le macerie della vita sono soltanto simulate. La realtà non è più neanche un incidente. Finzione? In treatment: la psicanalisi come strumento per portare il “dramma” sullo schermo di Mariano Aprea Poche volte, o forse mai, si è avuto modo di vedere in televisione un’opera di finzione di così alto profilo: In treatment, trasmessa per la prima volta dal noto network statunitense HBO il 28 gennaio 2008, è passata dai cinque episodi "sperimentali" a una programmazione di ben 45 puntate. Remake della popolare serie TV israeliana "Be Tipul", firmata dal filmmaker Hagai Levi, è prodotta negli Usa da Mark Wahlberg e sceneggiata e diretta da Rodrigo Garcia. Il successo ottenuto da questa serie televisiva travalica i parametri abituali con cui l’intrattenimento misura le proprie riuscite. Non si tratta soltanto di una buona realizzazione, di un opera di gusto, piuttosto che adatta alle famiglie o ai singles; non riguarda un livello di gradimento popolare piuttosto che di un elite intellettuale, ma evidenzia la rara capacità, tipica delle opere teatrali meglio riuscite, di coniugare le vicende umane, anche basse, le necessità, i desideri, i dolori, le mancanze, le ire e le improvvise dolcezze con le regole della messa in scena e della drammaturgia imbrigliate nel mezzo rappresentativamente più ambiguo e sfuggente a nostra disposizione che è la televisione. La qualità principale di quest’opera, che rappresenta cinque diverse sedute psicanalitiche una per ogni giorno della settimana della durata di trenta minuti, la più generale se si vuole, è quella di aver piegato il mezzo televisivo e la sua agghiacciante retorica, all’arte e alla disciplina teatrale dell’interpretazione e della drammaturgia. Senza nessun timore e con grande padronanza dei mezzi espressivi, gli autori e gli interpreti hanno dilatato tutti i tempi dell’immagine e del montaggio lasciando, prima di ogni altra cosa, spazio alla parola. La parola parlata in queste cinque sedute psicanalitiche non è una parola alta, non necessariamente, anzi spesso è cruda e brutale, ma non è mai arbitraria, affiora sempre come il risultato di una scandaglio interiore, concreto e sovente doloroso che la consegna allo spettatore piena della sua dignità, avvolta nell’eleganza di un’ esistenza consapevolmente irrevocabile. La drammaturgia è pertanto una scrittura per la scena e della scena che si avvale di una conoscenza teorica dei processi psicanalitici, mediando probabilmente tra una impostazione “Kleiniana” e una comportamentalista e passando di quando in quando attraverso i modelli interpretativi della lacaniana Ecole Freudienne. Consapevolezza, questa, degli sceneggiatori che permette loro con grande naturalezza di usare un linguaggio diretto e non intellettualistico, quotidiano ma non necessariamente casuale, che conferisce una grande forza e spontaneità al dialogo tra i personaggi mantenendo desta l’attenzione della spettatore in una sorta di ricerca della verità nascosta, del tesoro occultato nel tempo perduto del passato che il presente ci rivela nella lacerazione emotiva dei personaggi e a tratti ci offusca come se qualunque scoperta mettesse in gioco il paesaggio di un’esistenza effimera ma dalla quale con sovrumana difficoltà riusciamo a staccarci. Proprio questa continua altalena della contraddittorietà, decisamente affine alla natura umana, tiene sospeso il fiato di una rappresentazione che di per sé appare ferma, statica priva apparentemente di colpi di scena. Ma questa è la sua ricchezza: messi all’interno di un setting psicanalitico frontale, il terapeuta ed il paziente trascorrono trenta minuti di girato in cui lievi spostamenti di macchina, primi e primissimi piani costituiscono l’elemento saliente del movimento dell’immagine, ma al contempo le forme sono così dettagliate, i volti così fortemente impressi sulla pellicola che sembrano vivere al di fuori dello schermo con una vivacità quasi imbarazzante. E così veniamo a scoprire il ruolo che gli attori svolgono in questa opera inconsueta: Gabriel Byrne, Paul Weston, Melissa George, Laura, Blair Underwood, Alex, Mia Wasikowska, Sophie, Embeth Davidtz. Amy, Josh Charles, Jake, Dianne Wiest, Gina sono tutti di una bravura non comune, la tecnica immedesimativa che usano li mette nella condizione di comunicare in modo chiaro, definito, non ambiguo le emozioni, a volte forti e feroci, dei personaggi; da fermi, seduti come sono, riescono ad imprimere ai propri volti e ai propri gesti una dinamica di coerente intensità con il testo drammaturgico. Una prova attoriale interamente dovuta all’ elaborazione attenta delle premesse che costituiscono il vissuto dei personaggi e allo sviluppo delle motivazioni che li animano: non un solo pensiero che non sia elaborato, nessun interprete che non aderisca al personaggio e alla sua evoluzione, non si permettono gli attori di trovare punti di fuga, di poggiarsi su espedienti funzionali e di servizio, al contrario mettono interamente in gioco il proprio bagaglio tecnico per permettere a quella specifica condizione umana di apparire nella sua dignità nuda. Ecco, il lavoro dell’attore dovrebbe nutrire sempre questo grande rispetto per l’umano e per la sua difficile condizione come appare in questi entractes. Il lavoro dell’attore è questa descensio ad inferos che fa rivivere le anime di coloro che un tempo erano uomini e ne fa testimonianza con tutta la paura, con tutto il coraggio. Una particolare riflessione va rivolta alle interpretazioni di Gabriel Byrne e Dianne Wiest, rispettivamente l’analista e l’analista dell’analista. Il primo adotta una tecnica che in buona parte, come accade agli altri interpreti, si avvale del Metodo ma che non rifiuta l’esperienza critica del personaggio – l’analista è pur sempre un investigatore - che fa sì che l’attore sembri prendere le distanze da quanto gli avviene pur mantenendo il vivido contatto con la realtà degli avvenimenti; la seconda segue la medesima strada, ma pur mantenendo una prospettiva critica, riempie gli intervalli tra immedesimazione e estraniazione di una componente emozionale, squisitamente attorica, in cui sembra che nell’intercapedine dei due momenti si situi lo stupore e la commozione dell’attore nel suo rendersi partecipe e spettatore della vita del personaggio. Non a caso le è stato conferito il Grammy Awards quale migliore attrice non protagonista… Infine, un senso. La psicanalisi di In treatment si mostra come dialogo drammatico. Nel rapporto tra terapeuta e paziente si consuma un dramma, quello di due esseri umani che osservano le proprie maschere fronteggiarsi. La messa in scena sembra proprio suggerire questo: a specchio il terapeuta ed il paziente reali producono, nello svolgersi del transfert e del controtransfert, gli attori delle proprie passioni. Lo psicanalista non può fare di più che allestire questo singolare spettacolo e permettere al paziente di poterlo osservare al fine di riconoscervi la propria storia e coglierne il rimedio per il proprio dolore, ma proprio per questo il terapeuta non può, per quanto voglia, entrare nella vita reale dell’altro e deve inesorabilmente, finito lo spettacolo, lasciarlo al suo destino, a un momento non rappresentabile della sua esistenza, al cortocircuito tra esperienza reale e desiderio, in quel preciso momento anche il terapeuta rientra nella sua realtà e un senso di insopprimibile inadeguatezza gli si stringe al cuore rendendo morbida la mente al sonno. Telemomò Una conversazione con Andrea Cosentino di Graziano Graziani In una lunga chiacchierata con Andrea Cosentino, uno dei nomi più rappresentativi della scena indipendente romana e nazionale, abbiamo ricostruito il percorso di spettacoli e di pensiero che hanno portato questo artista a confrontarsi con il linguaggio della televisione e a dare vita a un progetto “fuori formato” come Telemomò. A partire da Angelica fino al progetto di una finta festa popolare ripresa da una finta Tv locale ne La festa del Pararacchio (ma con solide radici nei lavori precedenti), il teatro di Andrea Cosentino costituisce una delle ricerche più feconde sui temi della finzione, del rapporto con il teatro e di quello con la realtà, che non è più un oggetto “puro”, ma è, in tutto e per tutto, frutto di una costruzione precedente, di un racconto di un montaggio. In Angelica hai sperimentato per la prima volta l’idea di un montaggio/smontaggio del linguaggio televisivo. Spettacolo che viene cronologicamente dopo L’Asino albino, ma che nasce dagli stessi materiali di lavoro, tanto è vero che li definisci un “dittico”. Ci racconti la genesi di questo lavoro? Molto semplicemente all’inizio pensavo che sarebbero stati un unico spettacolo. Il fatto è che non mi piace lavorare su un solo spunto quando progetto qualcosa, ne metto sempre insieme almeno due. Per me è quasi una scelta di metodo, che ricorda un po’ quella frase di Lautréamont adottata dai surrealisti dell’incontro casuale di una macchina da cucire e di un ombrello su un tavolo operatorio, anche se a me non interessa sprofondare nell’inconscio quanto zigzagare nella complessità. Ma insomma, all’inizio pensavo di lavorare unendo lo spunto della gita all’Asinara con quello di una scena di morte recitata a ripetizione da un’attrice di fiction all’interno di un’abitazione popolare romana. Poi è accaduto che ciascuno di questi due temi mi si è a sua volta ampliato tanto da doverlo sviluppare in maniera autonoma. Tuttavia mi piace pensarli come un dittico, come qualcosa che va visto in modo unitario, uno di seguito all’altro. Un tema che sembra unirli è quello della morte, però affrontato in modo diverso. Io dichiaro che L’Asino albino è uno spettacolo sul tempo che passa, Angelica è un lavoro sulla morte. Evidentemente c’è una connessione. Poi forse il primo è uno spettacolo più caldo, più emozionale, mentre il secondo è più complesso – ma questa è un’osservazione che mi viene fatta da chi li vede, più che essere una mia sensazione. Ambedue hanno al centro dello spettacolo la morte nella sua irrappresentabilità. Una morte vera, quella dell’asino albino, nel primo; una morte finta, quella di Angelica, nel secondo. Ne L’Asino albino la morte è annunciata fin dall’inizio, anche se poi la faccio vedere – o meglio, intravedere, perché sono in controluce – solo alla fine. E in questo finale continuamente annunciato e rimandato, che apre e chiude il cerchio, si riversano i mille rivoli di cui è composto lo spettacolo. In Angelica, invece, c’è un’attrice e i suoi tentativi di raggiungere una rappresentazione convincente della morte. In un certo senso, è come se Angelica cominciasse dove finisce L’Asino albino. Allo stesso tempo però i due spettacoli hanno una costruzione simile: sono la messa in scena ripetuta di un finale. Ma è qualcosa di cui mi sono reso conto davvero solamente a posteriori. Prendiamoli uno per uno. L’Asino albino parla anche della storia di un ex brigatista, detenuto nel carcere dell’Asinara. Sì, ma non con l’ottica del narratore civile, che va a caccia delle storie nascoste o dimenticate ma di palese rilevanza sociale, come potrebbe essere il caso del terrorismo degli anni Settanta. Io piuttosto rivendico la casualità che c’è dietro lo spunto per i miei spettacoli: in questo caso io che sono andato da turista in un posto come l’isola dell’Asinara, con il risultato di confrontarmi con le rovine di una storia che non conoscevo se non sommariamente e imbattermi in un asinello morto stecchito sotto un cespuglio, a cercare un ultimo impossibile riparo da un sole feroce. La storia dell’ex brigatista Ramataz è il racconto di un passato letteralmente “chiuso” che si contrappone al presente inarticolato dei turisti balneari. Ma è una contrapposizione strutturale e non di valori. Quanto più nella vita col passare degli anni mi accorgo di diventare sempre più moralista, tanto più sulla scena mi infastidisce chi pretende di fare la morale. Con la carrellata di turisti, che sono personaggi-macchietta senza una profondità, non intendo prendere in giro “la massa” più di quanto invece non prenda in giro me stesso. Molti dei loro tic sono i miei: vedi il romano che fuma in continuazione. È una riduzione teatral-macchiettistica, quella dei miei personaggi, che vuole essere il doppio di una deriva sociale e culturale che io osservo attorno a me, ma dalla quale non pretendo affatto di tirarmi fuori. Questa cosa in Angelica la tematizzo tirando in ballo Pasolini. In quel caso parlo esplicitamente di una mutazione antropologica della quale io faccio pienamente parte. Ed è qui che, nel tuo percorso, incontri il montaggio, cioè il linguaggio audiovisivo, e quello della tv nello specifico. In Angelica la riflessione sul montaggio è parte strutturale dello spettacolo. E il discorso sulla morte ha a che vedere con la finzione, una morte recitata che diventa tanto più grottesca quanto più viene ripetuta per ottenere un risultato “credibile”. E alla fine l’incapacità-impossibilità di farsi – e dunque ricreare – una rappresentazione soggettiva della morte da parte dell’attrice si risolve con la necessità da parte del regista di spezzare il corpo stesso di Angelica in dettagli, per risolvere la questione, appunto, con il montaggio. Il montaggio come arma a doppio taglio: strumento linguistico che ci offre il racconto di un tutto dove non ci sono che parti. In questo caso io gioco a portare alle estreme conseguenze, fino a rovesciarlo, un ragionamento che Pasolini fa in un piccolo saggio dove si discetta di Cinema e Morte. Lui parla della morte come momento di verità, possibilità estrema di rappresentazione del vivente. Io parlo dell’irrappresentabilità della morte nella nostra società, di un vero e proprio rimosso collettivo, e dunque in qualche modo di un’attuale impossibilità di verità. Pasolini parlava anche del cinema come linguaggio della realtà – era una posizione molto criticata a volte anche con sufficienza dai semiologi dell’epoca – ma Pasolini aveva in mente il cinema neorealista o il grande cinema d’autore a lui contemporaneo. Se ancora trenta anni fa poteva essere plausibile affermare che la realtà ha trovato il suo mezzo di espressione nel linguaggio cinematografico, oggi è evidente che la televisione si è sovrapposta alla realtà modellandola attraverso la miseria del suo linguaggio standardizzato. Quello che faccio in Angelica è sposare la tesi di Pasolini, spostandola però sul linguaggio povero della fiction televisiva. E lo faccio per tentare di parlare di quella mutazione antropologica che Pasolini preconizzava negli anni Settanta, ma che ora è compiuta e ci riguarda tutti. È talmente compiuta che non ne siamo neanche più davvero coscienti, al punto che continuiamo a dibattere come se nulla fosse accaduto di memoria e presente, tradizione e modernità, come se fossimo ancora dentro un solco di continuità con il nostro passato, le nostre radici e quant’altro. Tornando alla televisione – a quella che è poi diventata Telemomò – quello che tento di fare è di smontare il montaggio, per evidenziare comicamente le ferite che infligge sul corpo della realtà per organizzarla. Pur di organizzarla. Io uso bambole di plastica, parrucche, giocattoli e pezzi di corpo che faccio sporgere attraverso lo schermo bucato di un vecchio televisore. Eppure funziona. Il linguaggio crea la realtà, indipendentemente dalla sua consistenza, ecco. Quello che mi diverte è smontare il giocattolo, ma senza smettere di farlo funzionare. Questo è molto importante: devi appassionarti a un racconto e contemporaneamente non poter fare a meno di vederne i meccanismi in funzione e accorgerti che i protagonisti, nei quali pure non smetti di identificarti, sono pezzi di plastica. Al contempo il montaggio televisivo viene disarticolato e dilatato comicamente dai tempi morti, ma vivi, nei quali raccolgo e ripongo bambole o indosso parrucche tra una inquadratura e la successiva. È una di quelle operazioni che puoi fare solo in scena. E non perché il teatro possieda di per sé un linguaggio migliore o più sofisticato della televisione o del cinema, ma proprio per la sua resistenza a farsi compiutamente linguaggio, a esaurirsi in comunicazione. In teatro per lo meno si è vivi, appunto. Comunque vivi. Eppure il tuo lavoro compie una rottura anche con linguaggio teatrale, che passa per il tuo mondo di stare in scena, di non recitare. Non è tanto un non recitare, anzi talvolta recito manifestamente e grottescamente. Piuttosto rifiuto la recitazione come pretesa di restituzione di una verità del personaggio, come “calco innocente” della realtà. Nei miei spettacoli distorco voci e faccio macchiette o al contrario parlo e spiego. In effetti faccio le due cose allo stesso tempo, sono la marionetta e il marionettista, e queste due funzioni sono sempre dichiarate e giocate a vista, addirittura si infilano nella struttura drammaturgica degli spettacoli. Perché anche nel “non recitare” c’è un rischio. Prendi la narrazione teatrale, a cui spesso il mio lavoro viene accostato. A un certo punto la gente andava ad ascoltare i narratori perché sembravano più veri di quanto potesse esserlo un “mattatore” in scena. Ma a mio avviso anche lì si nasconde una mistificazione. Se non altro perché non sei al livello di chi ti ascolta, il quale non ha neanche il permesso di replicare. Simuli una familiarità che non concedi. La mia soluzione, che è quasi una disciplina che mi sforzo di seguire, consiste nel non fingere di non fingere. Questa è anche la “verità” del mio lavoro. Sembra un paradosso vuoto, ma se ci pensi è la cosa più onesta che si possa fare da un palco. O meglio, è la prescrizione di ciò che non si deve fare. Nel tuo caso è stato utilizzato anche il termine anti-narrazione. Quanto conta nel tuo lavoro questo “mettere in piazza” i meccanismi, questo stare e non stare nell’oggetto del racconto? Non posso chiamarmi completamente fuori dal fenomeno della narrazione, perché io in qualche modo racconto. Solo che invece di raccontare storie a sfondo sociale, io racconto spettacoli. Non avendo storie da raccontare, e non essendo in grado di rapportarmi con la Storia con la maiuscola, faccio spettacoli in cui racconto spettacoli. In questo paradosso risiede la problematicità del mio lavoro, e anche, credo, il suo carattere specifico. Ultimamente mi diverte dire che faccio dell’avanspettacolo. Semanticamente, l’avanspettacolo è qualcosa che viene prima dello spettacolo. Anche i miei lavori sono qualcosa che viene prima degli spettacoli veri e propri, che come forma spettacolo compiuta non vedranno mai la luce. Hanno piuttosto a che vedere con la progettazione e allo stesso tempo il dissezionamento di quegli stessi spettacoli ipotetici. Questo per me è un modo per occuparmi – e rendere in qualche misura partecipe chi mi guarda – del processo di produzione delle storie e delle rappresentazioni, e credo che in questo momento storico ciò sia abbastanza sensato. Un buon esempio del mio rapporto ambivalente con la narrazione è la maschera della vecchietta, che appare in Angelica e in molti altri miei spettacoli. La vecchietta, col suo pseudo-dialetto, è l’alter ego che mi permette di raccontare storie, di innescare il racconto delle vicende vere e proprie. Ma allo stesso tempo mi permette di ricollegarmi – demistificandola – a un’idea di autenticità precedente alla mutazione antropologica di cui parlava Pasolini. A un’autenticità che io devo considerare irrimediabilmente perduta. L’archetipo per la mia generazione credo sia stata la pubblicità del Mulino Bianco: nonostante la loro patinata risibilità, non potevi impedirti di provare qualcosa di simile alla nostalgia guardando quelle pubblicità. Ma la realtà dei fatti è che io non ho mai vissuto in un mondo rurale, e se penso alla mia infanzia rispetto a oggi posso forse ricordarmi di un po’ più di verde attorno a casa, ma nulla di più. Allora mi rendo conto che la nostalgia verso il mondo rurale, nella forma in cui la vivo, è già una rappresentazione di rappresentazioni. Il Mulino Bianco costruiva un’arcadia rurale del tutto diversa dalla dura realtà della vita contadina. Capirlo è rendersi conto che la fotografia di una fotografia potrà anche essere uguale all’originale, ma tra il fotografo e il soggetto fotografato è andata perduta qualunque vicinanza. In questo senso io e il mio lavoro apparteniamo al post-moderno (qualunque cosa voglia dire ora questo termine già invecchiato). Forse addirittura il mio rapporto con la contemporaneità è più simile a quello che ha la scena sperimentale dagli anni Novanta in poi, quella dei post-moderni o post-organici, piuttosto che alla sensibilità dei narratori. Tuttavia – come ha sottolineato Attilio Scarpellini – i miei strumenti sono altri, non sono contigui alla contemporaneità di cui voglio parlare, ma appartengono alla sfera teatrale: neanche al suo linguaggio, ma proprio al suo artigianato. L’avanspettacolo ti ha portato allo spettacolo successivo, Antò le Momò. Anche qui c’è una morte, un racconto di uno spettacolo, un dissezionamento. Ce ne parli? Antò è tornare alla libertà dei miei inizi – quando lavoravo molto sull’improvvisazione e sul frammento – con la maturità di un percorso da drammaturgo. In realtà Antò le momò nasce come una sorta di “best of” in evoluzione, non uno spettacolo compiuto come dicevo, ma un contenitore aperto, poco più che un titolo – che è poi il titolo di un mio lavoro di parecchi anni fa – cui ho aggiunto un sottotitolo che vuol essere una dichiarazione di intenti: avanspettacolo della crudeltà. Cioè il tentativo di unire la leggerezza della vecchia tradizione comica dell’avanspettacolo con la profondità metafisica e per nulla auto-indulgente delle visioni artaudiane. Ma anche avanspettacolo in un senso ulteriore a quello di cui sopra, quasi un libretto di istruzioni per l’uso della società dello spettacolo. È un lavoro col quale conto di girare a lungo, calibrandolo ogni volta a seconda dei contesti e dell’ispirazione, e che magari tra tre anni sarà completamente diverso da quel che è adesso, e che già adesso contiene pezzi nuovi e pezzi vecchi, addirittura precedenti al dittico. Uno fra tutti: la telenovela raccontata dalla solita vecchietta utilizzando le barbie come si trattasse di guarattelle napoletane, che è poi l’antenato di Telemomò. Antò le Momò viene dopo il dittico, anche come ideazione. Come si relaziona agli altri due spettacoli? In «Antò» cerco di concentrarmi sulla forza del singolo materiale, mi sforzo di pensarlo per numeri, come fosse del vero avanspettacolo. Il corpo dello spettacolo è fatto di attrazioni, per dirla alla Mejerhold, cioè pezzi efficaci e autosufficienti, contornate di improvvisazioni e digressioni che mi consentono di porgere il numero e adattarlo a quel pubblico e a quella situazione specifica. Anche se poi non resisto mai del tutto alla tentazione di unire i numeri in volute più ampie, di riunificarli in possibilità di senso, ma questa è una cosa che faccio riannodando a volo d’angelo materiali dispersi in finali tronchi e suggestivi. Ecco, se l’Asino albino e Angelica erano la messa in scena ripetuta di un finale, direi che adesso mi diverto a moltiplicare finali. Come mi piace dire scherzosamente, mi considero il più grande autore di finali vivente, credo che un giorno farò uno spettacolo solo di finali. E d’altra parte se i miei spettacoli iniziano con un “comunque”, è perché vengono a loro volta dopo un finale, dopo Beckett se vuoi, dopo che tutto è stato già detto e la catastrofe si è compiuta. Il mio “comunque” è l’espressione più autenticamente popolare che conosca, quella che serve per andare avanti pur nel fallimento. Ci parli del “pantheon” di personaggi che popolano i tuoi spettacoli? Per essere un pantheon, è decisamente decaduto. Con loro ho un rapporto da mestierante, nel senso che quando mi servono li utilizzo. Sono la mia tavolozza dei colori, qualunque nuovo soggetto io voglia dipingere parto dai personaggi che ho, e solo in casi estremi me ne procuro di nuovi. Ci sono dei tipi fissi che ritornano, mi sto costruendo la mia personale Commedia dell’Arte, la mia compagnia girovaga incorporata. Ma anche il mio circo viaggiante, perché non sono solo i personaggi a ritornare, ma anche giochi e situazioni, una tra tutte Telemomò. È una cosa che faccio sempre più coscientemente e programmaticamente. Mi aiuta a rendere manifeste, a me stesso e ai miei spettatori più fedeli, l’evoluzione del mio lavoro. Evidenziare non solo la struttura di ogni singolo spettacolo, ma proprio i materiali e le linee di sviluppo su cui vado costruendo il mio piccolo artigianale universo creativo. Ogni personaggio-macchietta rappresenta un mattone prezioso per me, che per qualche verso mi rappresenta e al quale faccio fatica a rinunciare. Il fumatore passa dall’Asino albino ad Angelica senza rimaneggiamenti. Il meticoloso che nell’«Asino albino» fa cruciverba e fotografa la spiaggia, finisce in Antò le momò a fare il viterbese irascibile capitato per caso nel teatro, e che finirà per innamorarsi di una barbie. L’opinionista dell’Asino albino è slittato nel Pulcinella di Antò le momò, nel quale c’è chi ha visto un omaggio a Troisi, cosa che ovviamente non mi dispiace affatto, ma la cui genesi è tutt’altra: risale a un mio spettacolo di più di dieci anni fa, «La tartaruga in bicicletta in discesa va veloce», nel quale raccontavo del mio servizio civile con gli utenti di un servizio psichiatrico. Il calco originale è un malato di mente di origine napoletana, Agostino, che parlava stentatamente per modi di dire, attraverso un collage senza capo né coda di parole e argomentazioni orecchiate e mal digerite. Della vecchietta ho già detto: lei è la mia narratrice, il mio modo per parlare dei cortocircuiti tra la contemporaneità e le sue scorie, i detriti di quello che scompare. Il modello originale era un’anziana signora da me conosciuta che scendeva in piazza in un paese abruzzese per chiacchierare con le sue comari, ma anziché spettegolare della gente del paese, raccontava quello che era successo il giorno prima nella soap che seguiva ormai da anni. La vecchietta dice di qualcosa che si è rotto nella cultura popolare, e non ho resistito a infilarla anche in Antò le momò e poi nella Festa del Paparacchio, a maneggiare maldestramente surreali macchine agricole, disquisire di tradizioni inventate di sana pianta o cucinare improbabili ricette tipiche. Fare di me un teatro ambulante è anche un modo per emanciparmi dai teatri come luoghi fisici e istituzioni usurate. Pensare per progetti piuttosto che per spettacoli. La Festa del Paparacchio, ad esempio, è un progetto di animazione teatrale travestito da finta festa tradizionale, la cui vocazione è di essere inscenato in paesi o quartieri periferici, e comunque in luoghi dimenticati dal circuito teatrale. Ed è anche un format che mi consente di collaborare con altri gruppi o singoli artisti. Ma anche Antò le momò è tutt’altro che un lavoro chiuso, e quest’anno lo riproporrò a frammenti – vecchi e nuovi – in una situazione letteralmente avanspettacolare, ovvero nel foyer del Teatro Palladium a Roma, in apertura degli spettacoli teatrali della stagione. Tutto quello che faccio ultimamente risponde a un bisogno che sento sempre più forte, quello di inventare contesti nuovi per i miei progetti. Fuggire dai teatri per incontrare il pubblico altrove, o perlomeno con altre ritualità. Tracciare reti e percorsi inediti. C’è qualcos’altro che abbia senso? In Antò le Momò c’è la marionetta di Artaud, come in Angelica quella di Giovanni Paolo II. Anche nella Festa del Paparacchio compaiono le marionette di Walt Disney e Cristoforo Colombo. Che rapporti con queste marionette? Le marionette dell’Asino albino erano i personaggi? A differenza di quelli, però, raffigurano personaggi conosciuti. Perché? La marionetta, che io equiparo alla maschera, per me è la verità del teatro, il suo livello più profondo e magico. La maschera, lo notava Barthes, ha qualcosa a che vedere con la morte, Barthes parlava delle maschere mortuarie, che da un altro punto di vista sono il negativo della maschera teatrale. Quelle devono immortalare una figura, questa deve rendere viva un’icona. Il fatto che siano Artaud e il papa Giovanni Paolo II è in parte casuale, ma sicuramente rafforza l’effetto di morto che rivive, specialmente per il secondo, la cui morte mediatizzata è stata una delle immagini più intense e memorabili degli ultimi anni. Ed è per questo che compare in Angelica, uscendo da una carrozzina per neonati in apertura di spettacolo e andando a morire nel finale dentro lo schermo di una televisione. Per quanto riguarda Artaud, volevo farne il protagonista del mio avanspettacolo della crudeltà appunto, così come mi divertiva immensamente l’idea di manovrare-prestare metà del mio corpo alla maschera di Artaud, diventarne in senso stretto il doppio, il Dio meschino che gli ruba i gesti e le parole nell’atto stesso di compierli e pronunziarle. Tutto questo ha anche indubbiamente un suo lato iconoclasta, ma – mi auguro – non un’iconoclastia compiaciuta o denigratoria. Personalmente trovo piuttosto fastidiosa l’iconoclastia gratuita, il più delle volte per l’artista è una scorciatoia per far di se stesso un’icona. Tanto per capirci, la storia del rock è tutta un’iconografia iconoclasta, e anche tanto teatro sperimentale-giovanile tenta da decenni strade simili, senza davvero arrivare all’obiettivo data la marginalità del mezzo. Io al teatro chiedo qualcosa di più serio, di più articolato. È piuttosto la tecnica della maschera teatrale ad essere intrinsecamente iconoclasta, la vita di una maschera in scena è direttamente proporzionale alla sua capacità di deviare dalla sua fissità materiale, di essere un’icona mutante e metamorfica – un’immagine in grado di assorbire attivamente le espressioni del vivente. In effetti questa possibilità, ancora prima che una tecnica del gioco in maschera o della manipolazione della marionetta, si decide nel momento della sua costruzione. Non è possibile spiegarlo a parole, ma gran parte del lavoro teatrale, e sottolineo teatrale, che ho fatto sui volti di legno di Artaud e del Papa è consistito nell’attenzione paziente e nel trasporto che ho avuto nello scolpirli e studiarne le possibilità espressive man mano che gli intagliavo spigoli con le sgorbie e sfaccettavo superfici con raspini e carta vetrata. Cos’è Tele Momò? E che futuro avrà? Telemomò compare per la prima volta in Angelica, ma è a sua volta lo sviluppo delle barbie usate come guarattelle per raccontare telenovelas a cui accennavo prima. Rispetto a quel lavoro si è aggiunta la cornice vuota della tv e si disarticola più compiutamente il linguaggio televisivo, con il suo bagaglio di campi e controcampi, primi piani espressivi, dettagli significativi e via dicendo. Si mima – è la formula più sintetica che uso per spiegarlo – la povertà del linguaggio televisivo mediante la povertà dei miei mezzi scenici. La mia ambizione è pian piano di inglobare nella mia cornice bucata tutti i tipi di format televisivi possibili. Ma stando ben attento a non imitare programmi specifici e men che meno personaggi televisivi. La tentazione c’è sempre data la facilità dell’operazione, ma mi sforzo di mantenere la mia critica a un livello più radicale, centrata sui linguaggi e i format. Vorrei, per assurdo, che dopo aver visto Telemomò non fosse più possibile assistere a un programma televisivo senza vederne la struttura in filigrana e riderne. Ma vorrei anche, e ho già iniziato a sperimentare questa possibilità, utilizzare la cornice di Telemomò per esprimermi seriamente; vedere cosa si può effettivamente esprimere da quel buco di quaranta centimetri quadrati. Dichiarare francamente a me stesso e al mondo che non esiste un altrove migliore dal quale ripartire. Grotowski e Brook negli anni Sessanta sono partiti svuotando lo spazio, io riparto da una cornice bucata. Nel tragitto si è persa una dimensione. Comunque. Telemomò è un meccanismo complesso dentro un’idea semplice, di quelle che a posteriori ti chiedi come non averci pensato prima, o come mai nessuno ci abbia pensato prima di te. Io l’ho inventata dopo aver fatto materialmente televisione, e forse non è un caso. In televisione portavo proprio la mia Beautiful sgangherata fatta con le barbie, però l’idea di base – la mia vecchietta che raccontava, ovvero il cortocircuito tra cultura orale e rappresentazione postmoderna– è stata cambiata e semplificata, e alla fine non ero affatto soddisfatto del risultato. Era diventato un onesto prodotto di cabaret televisivo, del tutto omogeneo al mezzo che lo conteneva. Forse per questo, per reazione a un mezzo che era stato in grado di neutralizzare il mio teatro, mi è venuto in mente a mia volta di inserire nel mio teatro la cornice, di farmela da me la mia televisione. E forse, per altro verso, non è neanche un caso che Telemomò nasca in questi anni, nei quali il tubo catodico inizia a perdere decisamente colpi a scapito della rete. I tempi devono essere maturi, come diceva Marx la storia si ripete una prima volta come tragedia la seconda come farsa. Io vorrei fare di Telemomò la seconda volta della televisione. Con Telemomò voglio fare ancora molta strada, sempre per quell’idea di lavorare per filoni più che spettacoli. Con Telemomò, ad esempio, apro e chiudo la «Festa del Pataracchio»: per un evento di piazza niente di più giusto dal mio punto di vista che partire dalla condivisione, per quanto parodizzata, di un linguaggio come quello televisivo. Se la televisione ha fatto l’Italia di oggi, da lì bisognerà pur passare per disfarla. Sto cercando anche di farne una web-tv trasversale. Credo che abbia le carte in regola: l’unica televisione che contiene il proprio contenitore, ma anche l’unico mass media che tracima dalla propria cornice. Vorrei invadere come un virus il web di pillole di Telemomò, fino a creare una installazione on-line, una specie di monumento funebre carnevalesco alla televisione generalista. Che sta morendo. Vergin di servo encomio mi applico al codardo oltraggio. La “scena” televisiva Una conversazione con Enrico Ghezzi di Mariateresa Surianello Se uno scarto c’è stato, nella televisione italiana del servizio pubblico, è facile da individuare. Se si è creata una zona di resistenza alla deriva televisiva dell’ultimo ventennio, e forse ormai di più, uno degli artefici è certo Enrico Ghezzi. Icona delle notti di Rai Tre con Fuori orario, Ghezzi ha i tratti dell’anti-divo, nella sua veste, non proprio ordinaria, di lavoratore infaticabile e gentile. Divoratore e dispensatore di immagini in sequenze debordiane, inventore di quel formato riproducibile quotidianamente, Blob, e utile a elaborare e rilanciare frammenti recuperati dalla stessa tv, come dal suo pattume, e/o preziosi inediti ripresi nei luoghi più reconditi ma sensibili del pianeta, fino a produrre una “sintesi oggettiva” della giornata, vera striscia di informazione, spesso più utile di tutte le edizioni dei tg, con Enrico Ghezzi abbiamo provato a parlare del grande assente in televisione, il teatro. Nelle scarse occasioni in cui il teatro compare in televisione (con poche eccezionalità), si percepisce una sorta di sottomissione dei linguaggi della scena a quelli della televisione. E’ così? Il teatro è stato definitivamente inglobato nel visivo televisivo? No, se fosse stato inglobato ci sarebbe un lavoro maggiore. Trovo che purtroppo, semplicemente, non c’è né da una parte, né dall’altra una diramazione del teatro nella televisione. Non credo minimamente nella traduzione da un linguaggio a un altro, né da una scena all’altra perché quella televisiva è comunque una scena – e ancora meno credo nella pubblicità, nella televisione come cinghia di trasmissione. O meglio, so bene che è così, la televisione fa al novanta per cento pubblicità in quello che trasmette, dai talk show... qualunque cosa passi in realtà pubblicizza qualcos’altro. Il video più che la televisione è importante e affascinante, anche come mezzo di registrazione e di conservazione di tracce di eventi teatrali, grandi e piccoli, del resto, di qualunque cosa. Come il video e la televisione avrebbero potuto essere e non sono stati - ormai colpevolmente per almeno cinquant’anni in tutto l’Occidente, ma anche di più - una sorta di archivio permanente. Non necessariamente sarebbero dovuti andare in onda, ma di cose di ogni genere, anche semplicemente, sistematicamente registrare le voci degli anziani, non solo gli eminenti in ogni campo. Anche semplicemente registrare. E in questo, anche il teatro, non meno e non più, avrebbe avuto il suo senso. Recentemente, si è iniziato a registrare il teatro, a documentarlo. Sì, però, quando si parla di teatro in televisione, cioè di spettacoli registrati, spesso ben registrati o a volte ben registrati, a volte registrati dagli stessi registi che hanno fatto la cosa in teatro, a volte da altri, alcuni anche più bravi, più intelligenti, più televisivi. Alla fine mi sembra che sia una sorta di piccolo passo dovuto, di piccolo tributo. Perché nel caso della televisione in Italia, della Rai, delle emittenze pubbliche, rientra nelle piccole eccezione. Come nelle finanziarie, ci sono dei budget e poi c’è un piccolo budget su Rai Due per il teatro e un altro per la musica, la notte, da un’altra parte. Ma in effetti essendo tutti degli spazi residuali sono quasi razzistici, anche quando hanno un senso – lo ribadisco - come certificato di esistenza e in qualche modo di pubblicità. Allora è evidente che una cosa di teatro potrebbe essere per esempio un canale intero, adesso che si parla di digitale, di canali a pagamento. Non è una soluzione, io non credo che sia un problema il teatro in tv. Nulla è un problema. Semplicemente bisogna un po’ inventare le cose. Anche lì se c’è un canale intero e si limita a utilizzare vecchio repertorio e nuovo repertorio di documentazione di spettacoli e sicuramente interessante per un pubblico settoriale, può servire a imparare delle cose del teatro passato e di quello contemporaneo. Quello che secondo me manca e manca da sempre, anche se un tempo con il monopolio più ferreo Rai potevano esserci occasioni importanti, basta pensare agli esordi di Ronconi, legate comunque a personalità particolari, che comunque avrebbero fatto cose inventive. Io credo che la televisione per il modo che è, per la forma che è sia stata pochissimo, ahimè, usata non tanto – ripeto - come diramazione e transizione, ma come ulteriore set teatrale. Come il telefono. Se pensiamo una cosa che a noi ci venire in mente uno spettacolo è il telefono. E, invece, noi lo vediamo, in radio o in televisione, il telefono è il vero cambiamento di scala, è una zona di teatro quotidiano, una soap quotidiana. E’ un genere televisivo, teatrale e quasi cinematografico che sta lì, radiofonico, che sta lì, che ha altri fini, ma che ognuno di noi sa benissimo essere anche parte principale del teatro quotidiano della nostra vita. E’ poco lavorato sia dal teatro, sia dalla televisione, molto meno di quello che potrebbe. Il teatro lo trovo un problema davvero residuale, esperiale. Quindi bisogna semplicemente da una parte avere un sano sindacalismo e riformismo, un tentativo timido di ottenere risorse e poi farne un uso ottimale. Però è difensivo, è solo per esistere in mezzo a tante altre cose, dalla musica sinfonica..., parlando di televisione generalista. Lo stesso nelle televisioni via cavo avere i vari scaffali. La vera invenzione teatrale sarebbe pensare teatro, non necessariamente con testi nuovi, non vanno inventati i testi, ma pensare a messe in scene televisive, che si confrontino con la forma, col volto televisivo, con la possibilità di interattività o di connessione che è quella televisiva, anche a partire dai vecchi testi. La ripresa pari pari di uno spettacolo sublime, vale solo per uno spettacolo sublime, di Ronconi, di un Cecchi straodinario o anche uno Straub che fa il teatro a Buti, lo riprendi anche frontalmente, anzi meglio frontalmente che non la scansione banalissima della regia televisiva e hai una cosa lontanissima dal teatro, è lo spettro del teatro. Che poi, senza essere pensato, è quello che avviene normalmente. Altra cosa è stato il teatro in televisione di Eduardo, che erano proprio regie televisive e che molto hanno contribuito alla grande fortuna di quel teatro. Lì la maggiore attrazione era lui, e comunque era imperniato. Se invece pensiamo a Ronconi, al suo spettacolo più straordinario, in qualche modo smaccatamente televisivo, perché la non visibilità integrale del suo Orlando Furioso era proprio dovuta alla pluralità di set in uno stesso set. Il dover scegliere, fu uno spettacolo che non si sarebbe mai visto intero. In qualche modo anticipava, o meglio usava – perché c’erano già in vari Paesi - la pluralità di canali. Utilizzava questo parallelismo no-stop delle scene televisive non è un caso che quando ha fatto – pur essendo in periodo di monopolio, quindi teoricamente sarebbe stato pensabile – quando ha fatto l’Orlando Furioso per la televisione ha fatto un film magnifico, sontuoso, uno scacco. Tanto lo spettacolo era innovativo, quanto il film era un film sull’impossibilità di osare una cosa tale in televisione che pure era il set più adatto per fare questo. Probabilmente era troppo facile farlo in televisione e troppo difficile perché mai la Rai avrebbe concesso tre reti, anche solo per due ore. Era politicamente difficile, ma tecnicamente, teatralmente, poeticamente troppo facile, perché è già così la televisione, devi comunque scegliere in un parallelismo che non è mai preordinato. Po t e v a a v v e n i r e c o n G l i u l t i m i g i o r n i dell’umanità, io lo proposi all’epoca di fare una cosa su due-tre reti a notte fonda, quando comunque non avrebbe dato fastidio a nessuno. Però non si fece. Qual è stato il motivo di questa assenza quasi totale del teatro dalla televisione, anche per quanto riguarda la comunicazione (prima parlavi di pubblicità) spicciola di quanto accade nei teatri sparsi sul territorio? Noi a Rai Tre con Guglielmi ce lo eravamo posto e onestamente non ci interessava per niente la cosiddetta traduzione dei linguaggi, portare in televisione la musica colta..., tutte le cose che ci piacciono, allora perché non i quadri. Allora, salvo schegge, cose fulminee, provocatoriamente insufficienti, inadatte, che forse avrebbero potuto e dovuto far sentire proprio l’insoddisfazione di questo, l’altra possibilità era ed è quella che alcune personalità teatrali o alcune situazioni teatrali, sicure di perdere la fragranza del teatro in televisione la perderesti comunque, puoi avere la fragranza di un elemento del teatro... Secondo me Pippo Delbono, nonostante le sue belle musiche le sue situazioni magiche è molto più televisivo che teatrale. Non ha nessun bisogno della scena teatrale. Dovrebbe inventare televisione molto più che un film, che finirà per fare. E’ questa la cosa che puoi fare, puoi dare per un giorno la regia del telegiornale a un grande regista teatrale italiano. Uno che fa teatro oggi, vedendo la televisione asfittica e ormai priva di qualunque intenzionalità editoriale che ha tutta la televisione, non solo quella italiana, in qualche modo la televisione mondiale. Non ci sono eccezioni, le eccezioni sono singoli programmi e quindi non fanno parte di accenzioni editoriali. Rispetto a questo, situazioni di teatro, personalità di teatro, idee teatrali, non trasposte in televisione, ma che aggrediscano la televisione – si permetta questo - che tanto tutto sopporta fin troppo bene. Ogni tanto ci sono dei programmi che tu guardi esattamente come guarderesti il teatro, nel senso che ti perdi sui dettagli, su una sorta di cifra nella tela che si tesse nel pomeriggio, nella serata. In realtà segui il teatro. Tutti i talk show hanno un senso teatrale, perché per il resto sono orribile televisione, crudelissimo gioco a eliminazione, dove si vede che poi uno comincia a contare il tempo che gli rimane per intervenire. E’ osceno da ogni punto di vista, di cosiddetto contenuto, di messaggio da veicolare. L’unico elemento interessante è una sorta di set teatrale, una sorta di teatrino-teatrone. La televisione è eminentemente teatrale, è molto più vicina al teatro che al cinema. La televisione è già una sintesi di teatro e cinema. Quindi se voi non lo avete fatto il teatro, il motivo è stato la mancanza di risorse? Se vuoi dire noi di Rai Tre, abbiamo deciso semplicemente di non aderire alle richieste più o meno pressanti... Poi nei programmi andavano ospiti... l’esempio straordinario di teatro in televisione è Carmelo Bene, una personalità unica, eccezionale a dire poco. Ha fatto televisione che non era ripresa dei suoi spettacoli. Ha fatto altre cose, compresi gli Amleti – uno al cinema, diverse volte a teatro e due volte almeno in televisione. E poi ha fatto le sue apparizioni televisive che erano straordinario teatro sia che parlasse di calcio da Biscardi, sia le due serate da Costanzo. Quello era un momento di straordinario teatro, non direi di particolare televisione. Qualcosa che sbaragliava quasi la televisione. Cosa rappresenta l’esposizione del proprio corpo dentro la cornice televisiva? E’ una cosa molto diversa dal cinema. E’ sempre divismo, microdivismo diffuso, ma è molto vicina alla prossimità teatrale, quella dei mezzibusti, delle persone correntemente in televisione. Questa sorta di doppia vita. E’ molto vicina alla conoscenza, al cameratismo, addirittura, alla complicità che c’è tra pubblico e teatranti, il teatro si regge abbastanza su questo. Raramente sulla folgorazione dell’estraneo e dello ieraticamente lontano... Grotowski o straordinarie distanze, ma per il resto si regge su questo. Io lo trovo molto vicino alla televisione il teatro. E’ proprio il rituale del teatro. Mentre il cinema è inevitabilmente architettonico, è una sorta di passaggio continuo tra l’architettura da una parte e la pittura, se vuoi, dall’altra. Invece, il teatro è molto più vicino alla televisione. Il teatro che rimane è costretto molto più del cinema, delle mostre, dei concerti, delle altre arti a difendersi, a essere altra cosa. Dovrebbe essere infinitamente altra cosa per questo dovrebbe temere la televisione, perché la televisione è eminentemente teatrale. La televisione è la scena teatrale dell’ultimo secolo. Nelle tue apparizioni sfalsi i piani di esposizione – dal fuori sinc al flusso gestuale – e procedi per accumulo. Crei proprio una performance che va a scardinare la semplicità del linguaggio telev isivo, quello a cui siamo abituati, naturalmente. Perché invece di lavorare in sottrazione, tenti di alimentare e di trasmettere la tua complessità? E’ una sottrazione anche questa, perché è una cosa talmente semplice, talmente minimale, talmente banale e riconoscibile a suo modo... Lì non è un problema di teatro, è proprio di sottrazione rispetto, non al banale televisivo, ma alla comunicazione in quanto immediatezza fasulla, facile che dovrebbe essere o misterica e anche critica rispetto alla propria mistericità immediata enigmatica, oppure non può che essere critica rispetto all’ideologia della diretta, all’ideologia dell’immediatezza. Al fatto che anche le persone più intelligenti e geniali quando vanno in televisione, improvvisamente, si dimettono da ogni soggettività e imparano a parlare. E infatti poi torneranno quelli che saranno selezionati per la loro capacità di parlare e di dire in un minuto quello che potrebbero dire meglio in tre minuti. Slogan, anche belli, intelligenti, però chiaramente sono continui tradimenti, continue traduzioni, ma a quale fine? Al fine di ritornare, di ripetere la presenza. E’ terrificante sacrificare alla comunicazione... la televisione non ha bisogno del nostro obolo, della nostra aggiunta, del nostro granellino... L’eventuale successo che possono avere avuto alcune mie idee o programmi sono molto felice di usarlo poi in senso opposto, come un intralcio, come anche un fastidio. Ho incontrato in treno un teatrante che mi ha fermato e mi ha detto: “Io apprezzo molto la sua danza”. Mi ha divertito, mi ha sconcertato. Comunque, la televisione credo sia un luogo straordinario per verificare la tensione tra essere e non essere e tra essere e riessere. Che sarà prima o poi questo Amleto che devo fare. nessuno della comunicazione televisiva nell’epoca in cui il mezzo fa veramente una cosa sola col messaggio. Siamo molte oltre, e in Italia più che altrove, le annotazioni tutto sommato blande di Marshall McLuhan sulla telegenica cravatta che avrebbe determinato la vittoria di Kennedy su Nixon in un celebre dibattito televisivo anni sessanta: non c’è un politico che non abbia appreso, oltre alla propria lingua, il controllo del proprio corpo in uno specchio diverso dello schermo e che non si eserciti in quella abbreviata retorica da imbonitori che ha rimpiazzato la vecchia oratoria (tribunizia e avvocatesca) dei notabili di un tempo, guardandosi e riguardandosi dentro un video come un atleta che deve migliorare la sua performance. Tribuna politica Come cambia il dibattito politico quando diventa mediatico di Attilio Scarpellini «Le tribune politiche televisive dell’immediato dopoguerra – scrive Colin Crouch in un libro sintomaticamente intitolato Postdemocrazia – sembrano comiche se viste oggi; ma lo sono perché quelle persone parlano il linguaggio normale delle conversazioni serie con i vezzi e le stranezze che abbiamo tutti» I dibattiti televisivi di oggi possono essere comici per altre ragioni, soprattutto perché nessuno riesce più a misurare la distanza tra la parodia della satira (televisiva) e i suoi obiettivi reali, tra l’originale e l’imitazione: la Cortellesi su Raitre vale la Santanché a Matrix (e la Santanché ringrazia), il ministro Gasparri è l’alter ego del “suo” Neri Marcoré, tanto che qualcuno comincia a sentirsi in dovere di sottotitolare le sue dichiarazioni – come quella su Obama e Al Qaeda – specificando che non si tratta di satira, mentre Silvio Berlusconi, giunto al culmine di quel destino di icona pop che il suo principale consigliere gli aveva preconizzato qualche anno fa, può essere imitato soltanto da se stesso. Tutti costoro ed altri ancora non sono, come è ormai drammaticamente evidente, delle persone nel senso che il politologo inglese intende – abitate dalla discreta anomalia sempre uguale e sempre diversa che tutti condividiamo – né tanto meno dei personaggi pubblici, nel senso in cui ne sono esistiti fino alla Prima Repubblica, sono dei personaggi tout court, nel senso di Mickey Mouse: compresi in un tratto, ristretti in un’icona, sovra determinati da un linguaggio che, fatta eccezione per qualche idioletto, non è il loro, come non è il nostro, ma quello di tutti e di Lo specchio dei politici novecenteschi era la folla, misura ondivaga di una seduzione che aveva ancora qualcosa di animale e che comunque imponeva un confronto tra corpi, tra voci, tra nervi, il calore di quella prossimità così ben evocato nel Tempo del disprezzo di Andrè Malraux, quando nella solitudine del carcere, e in un’anticipazione mentale della simultaneità televisiva, Krassner rievoca i volti di tutti i compagni, illuminati dal basso come nei quadri di Latour, che lo hanno ascoltato nell’ultima riunione. La radio dei regimi totalitari, o delle democrazie di massa, era ancora un medium “caldo” che nella voce si portava appresso un pezzo di irriducibile corporeità e che puntava tutto sul potere di concentrazione di una parola esclusiva ed invasiva: teatro di appelli e di mobilitazioni a cui da fuori rispondeva la parola critica, articolata, della stampa scritta. I politici di una volta – avidi e spietati quanto quelli odierni – nascevano dalla polvere della strada e ne portavano i segni addosso anche al potere (era la loro garanzia, l’amuleto di un successo la cui ultima istanza era comunque il territorio). I telepolitici di oggi vivono immersi in un Reality che li costringe a snervanti sessioni di bellezza o di simpatia, di seduzione o di aggressività sotto la lampada solare del consenso mediatico, l’unico parametro ammesso di un potere che, persa ogni sovranità simbolica, è sempre più simile a un indice di gradimento: la stessa autoreferenzialità di cui li si accusa così spesso non è che il riflesso dell’autoreferenzialità mediatica in cui sono impaniati. Finora non si era mai visto un ministro scapolo costretto a megafonare il proprio fidanzamento sui giornali e sulle tv, cercando di insinuare la propria love-story nelle graduatorie del gossip estivo come una qualunque velina con un qualunque calciatore. Ma lo sfondamento della quarta parete del privato è il sale di ogni stimmungdemokratie che si rispetti: la vita pubblica, gran mito della grecità che la considerava l’unica degna di essere vissuta, è solo l’amplificazione di un teatro di finzioni private chiamate a soddisfare il bisogno di equivalenza, se non di uguaglianza, dello spettatore di massa, richiedendo anche ai rappresentanti del popolo il carisma dei tronisti. Così il telepolitico diviene quanto di più simile alla fenomenologia di Mike Bongiorno a suo tempo delineata da Umberto Eco: arrogante e mediocre, moderatamente volgare, una specie di media universale del sentire comune in ogni materia. Poiché gli italiani cantano, egli canterà e anzi scriverà canzoni. Dal momento che il calcio è lo sport nazionale, ne sarà un cultore appassionato, anzi il proprietario di una squadra. Gli italiani vedono molta televisione, lui ne possiederà tre. Gli italiani amano ostentare i soldi e le donne, lui possiede i primi e millanta le seconde. E via dicendo, dalla cucina all’arte, non c’è un terreno in cui i gesti e le parole di Silvio Berlusconi non siano una gigantografia del sentimento nazionale medio come esso si è edificato in cinquanta anni di ipertrofia televisiva. Gli italiani ad esempio sono simpaticamente razzisti, oltre che terribilmente invidiosi e allora giù irresistibili battute sul messia abbronzato della Casa Bianca…Per qualcuno si tratta di una gaffe imperdonabile? Come direbbe Eco, è la lezione di Mike Bongiorno. Il controllo esterno della propria immagine diviene essenziale: non è un caso che, a questo proposito, nessun leader sia riuscito a toccare il livello di padronanza scientifica della propria proiezione mediatica del padrone di televisioni per antonomasia, Silvio Berlusconi, l’uomo che al massimo dell’arbitrio unisce il massimo della reificazione di se stesso. L’unico leader occidentale che, come Bin Laden, preferisca comunicare inviando cassette precofenzionate alle televisioni pubbliche è notoriamente un accurato ed esigentissimo gestore delle proprie apparizioni catodiche la differenza settimanale di cultura on-line su www.differenza.org direttore responsabile Gian Maria Tosatti in redazione Graziano Graziani, Attilio Scarpellini, Mariateresa Surianello. La rivista è finanziata nell'ambito del progetto Scenari Indipendenti, promosso dalla Provincia di Roma in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio.
Scarica