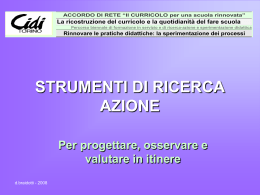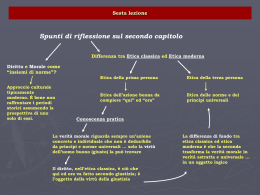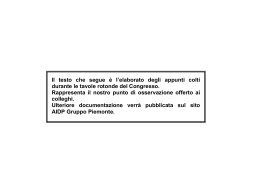12 Culture martedì 15 | luglio 2008 | Interni Culture Esteri martedì 15 | luglio 2008 | Un nuovo libro della filosofa, “Trasposizioni”, mette l’accento sulla necessità di costruire un’etica sostenibile del presente, un modo per sfuggire, da una parte, all’accettazione del nuovo a tutti i costi, dall’altra al rimpianto del passato. Un discorso giusto ma che rinuncia alla prospettiva più importante: trasformare l’esistente. Una politica riformista che non convince e che rischia di non cogliere il problema oggi più scottante: come rilanciare i movimenti di controcondotta Anna Simone Quando in Italia uscì Madri, mostri e macchine di Rosi Braidotti - grazie ad Annamaria Crispino e alla manifestolibri che lo ha da poco ripubblicato in una nuova edizione ampliata - parte del femminismo italiano, soprattutto di ultima generazione, tirò un sospiro di sollievo: finalmente l’esperienza femminile del poter mettere al mondo un essere vivente perdeva tutta quell’aurea mistica, etica e morale che aveva inchiodato il corpo femminile alla sua funzione riproduttiva, all’interno di un sistema normativo e prescrittivo, per secoli e secoli. La maternità intesa come “destino” diventava qualcos’altro. Senza mai uscire dalla tradizione europea degli studi sulla differenza sessuale, Rosi Braidotti ci consentiva di pensare la maternità come una tra le esperienze possibili del corpo femminile e non come “l’esperienza” con la e maiuscola, ma soprattutto ci consentiva di risignificare quella dimensione romantica e melensa della maternità che ci era stata cucita addosso prevalentemente dagli uomini. Un saggio dell’urbanista Carlo Cellamare Roma, Rione Monti Elogio della lentezza Enzo Scandurra Braidotti, ma che cos’è il femminismo se si dimentica la libertà? Un nodo, un grimaldello attraverso cui è stato possibile pensare il proprio corpo come un “freak”, una felice mostruosità, un’eccedenza abnorme in grado di sovvertire la norma, molto più simile ad un immaginario gotico che ad un immaginario legato alla tradizione del dolce stil novo. Un libro di rottura, insomma, seppure sempre pensato e prodotto all’interno della tradizione di studi del pensiero europeo della differenza sessuale. Da allora Rosi Braidotti ha prodotto altri testi, quasi sempre “troppo” ambiziosi, sino a quest’ultimo appena edito da Luca Sossella - sempre a cura di Anna Maria Crispino - dal titolo Trasposizioni. Sull’etica nomade (pp. 343, euro 18). Zigzagando tra innumerevoli autori e autrici Braidotti tenta la difficilissima impresa di accorpare in un solo volume molti dei temi che attanagliano il dibattito politico, filosofico, sociologico e antropologico con- temporaneo - dalla globalizzazione alla “natura umana”, dall’etica alla morale, dalla genetica al postumanesimo, dal razzismo al tempo, dalla memoria all’immaginazione a volte riuscendoci, a volte perdendosi tra i mille rivoli aperti dal suo metodo “rizomatico” ovviamente mutuato da Gilles Deleuze e da Felix Guattari dei famosi Mille piani. La cartografia del presente che ci consegna Braidotti in questo ambizioso lavoro, pur aprendo continuamente varchi, soglie critiche, pieghe, pur attraversando il pensiero positivo e vitalista sempre di matrice deleuziana tanto quanto le soglie del pensiero negativo resta sempre, però, come imbrigliata all’interno di una prospettiva riformista. La sua tesi è chiara fin dalle prime pagine: viviamo in un mondo in cui il post ’89 ha segnato la fine delle ideologie classiche (marxismo, comunismo, socialismo e femminismo) e l’inizio di un’epoca di passioni tristi, di “apatia morale” legate all’individualizzazione dei desideri e delle aspettative che, però, devono condurci verso la messa a punto di nuove pratiche di resistenza. Per fare questo, però - suggerisce Braidotti - dobbiamo altresì evitare di cadere nelle trappole del pensiero dualistico e dicotomico del presente che ci vuole o a favore del nuovo (lei si riferisce prevalentemente alle bio-tecnologie) o a favore della nostalgia di “ciò che è stato”. Al contrario bisognerebbe pensare, dal suo punto di vista, «un’etica della sostenibilità» che non ci faccia uscire dal presente provando, invece, a risignificarlo attraverso modalità e pratiche politiche duttili, flessibili, nomadiche. E fin qui ci si potrebbe stare se, pe- rò, l’etica della sostenibilità non fosse sempre e solo un esercizio per attivare una critica al mondo “così com’è” senza mai stravolgerlo fino in fondo. Braidotti ha senz’altro ragione quando cerca, con i suoi mezzi e i suoi strumenti filosoficopolitici, di spostare tutto sull’etica provando a risignificarla e tirandosi fuori dalle letture reazionarie tanto di moda perché, effettivamente, oggi la politica sembra essere diventata solo etica e morale. Ma non si pone fino in fondo una domanda che invece è la grande domanda del presente: lavorare per un’etica della sostenibilità in tutti i campi del sapere e quindi anche delle pratiche è la stessa cosa che tentare nuovi tagli e rotture in grado di riportarci all’interno di un ethos della libertà come paventato già da Foucault alcuni decenni fa? Oggi come oggi non viene prima il bisogno di libertà, la decostruzione dei saperi-poteri e poi, eventualmente, anche la costruzione di un’etica della sostenibilità? Tra i mille rivoli claustrofobici di una politica sempre più prossima ad attivare i più beceri meccanismi di controllo e securitari, l’urgenza prioritaria di un pensiero femminista non dovrebbe essere quella di rivendicare libertà prima ancora che sostenibilità? Le pagine che Braidotti dedica a Impero di Toni Negri e Michael Hardt sono assai intense e significative. Lei dice che per quanto sia stata efficace la fotografia del presente globalizzato messa a punto dai due autori non è stata altresì in grado di produrre cambiamento alcuno affidando il tutto alla “moltitudine” che, in quanto forza rivoluzionaria, avrebbe dovuto sovvertire l’esistente. Una forza che, secon- 2 13 do Braidotti, sembra essere più una metafisica disincarnata della rivoluzione che non un principio di realtà. Una critica condivisibile se guardiamo al presente dei movimenti nati a Genova, ma anche un bisogno di “prendere le distanze” che porta Braidotti a sposare fino in fondo le tesi del riformismo di matrice social-democratica senza interrogarsi molto, invece, su chi e come oggi può incarnare il demone del cambiamento che non necessariamente può prodursi solo provando a risignificare il presente a partire dalla differenza di sesso e colore. Si trasforma, infatti, solo ciò che già c’è. Ma siamo certe che rendere sostenibile ciò che già c’è possa in futuro produrre qualcosa di buono? No ne abbiamo la certezza e infatti pur considerando questo testo importante e significativo è importante sottolineare co- me non basti esercitarsi, nel produrre dissensi nomadici e rizomatici, nei confronti di un presente altrettanto nomadico e rizomatico. In poche parole se il mondo ci chiede di essere flessibili non basta imparare a diventare flessibili, a frammentare l’unitarietà della soggettività per cavalcare le mille onde del presente provando anche, talvolta, a resistere attraverso l’esercizio del pensiero critico. Occorre fare molto di più, probabilmente perché la posta in gioco è più alta: come fare per evitare che le nostre soggettività siano sempre assoggettate ad un potere, ad una norma, ad una condotta? Per esempio potremmo imparare dai movimenti dei migranti, delle femministe, dei trans, dei gay, delle lesbiche, dei subalterni etc. Un esercizio che Butler e Spivak provano a fare in quest’ultimo libretto di imminente uscita in Italia da Filema, Chi canta lo Stato-Nazione?, riferimento esplicito ad una pratica di lotta messa a punto dal movimento dei migranti negli Stati Uniti. Loro cantano nelle manifestazioni l’inno statunitense per sovvertirne il senso, per sovvertire quell’idea secondo cui si appartiene ad uno Stato Nazione solo in virtù del vincolo di sangue e non per il solo fatto di essere lì in quel momento. Ma loro cantano anche per dirci che la possibilità del “diritto ad avere diritti” conta più di tante parole, di tanti libri, di tanti pensieri perché chiama in causa la loro esperienza reale, il loro bisogno di libertà che non è poi tanto diverso dal nostro. Insomma: più lotte, più libertà, più conflitto e meno sostenibilità. O meglio: prima le lotte e la libertà e poi, se proprio vogliamo riconfigurare il presente, più sostenibilità. Fare società, fare città, ricostruire il legame sociale, opporsi alla deriva di questo capitalismo virulento e disumano che ci condanna tutti all’isolamento idiota e al consumismo eterodiretto dai mass-media: questo dovrebbe essere il compito principale di una sinistra che abbandona il paradigma della crescita verso quello della frugalità e della convivenza. Il libro di Carlo Cellamare, Fare città. Pratiche urbane e storie di luoghi, (elèuthera, 2008, pp.183, euro 15,00) è un libro che ad una prima lettura appare innocuo e forse quasi sottotono: non si lascia andare a facili catastrofismi, non indugia alla rassegnazione, ci parla, al contrario, della vita quotidiana di individui in carne ed ossa, con le loro pene, le loro passioni, il loro abbandono al chiacchiericcio e perfino alla pigrizia. Sono gli abitanti del Rione Monti a Roma; non una comunità di persone che condividono ma un universo di differenze che vanno dal “vecchio monticiano” alla star del cinema, dal giornalista all’impegnato a sinistra, dal vecchio artigiano ai piccoli caffè letterari sparsi un po’ ovunque. Ma ecco che ad una lettura meno distratta i “vizi”, meglio sarebbe chiamarle virtù, di questi abitanti locali si rivelano sovversivi: lentezza vs velocità, kairos vs tempus, il piacere di essere insieme, la generosità della vita in comune, il godimento del tempo, contro le parole d’ordine di questa contemporaneità: competizione, crescita, consumo. Cellamare, nella descrizione di questi comportamenti, si rifà ad una tradizione illustre: De Certeau (L’invenzione del quotidiano), Simmel (La metropoli e la vita dello spirito, Socievolezza, Saggio sull’intimità). Tradizione illustre quanto ignorata e mascherata dalle grandi narrazioni sociologiche che hanno riscosso un ben più ampio successo. Da una parte, dunque, ci sono le vite vere, i luoghi, la costruzione del senso dello stare insieme, dall’altra la governance fatta di regole, norme, prescrizioni, sfratti, dispositivi tecnici, professionisti della trasformazione fisica, amministratori, faccendieri, eletti. A poco a poco, leggendo il libro, si svela quella drammatica frattura tra le pratiche di vita quotidiane e la loro rappresentanza politica, la vita del “palazzo” chiuso su se stesso. Quella scollatura che Marramao definisce come rottura tra dimensione materiale e dimensione simbolica, tra rappresentanza e rappresentazione o, per dirla con le parole dell’autore, che è urbanista, tra la città di pietra e la città vissuta. Tra queste due dimensioni è stato scavato un abisso non più governabile: è il terreno sul quale cresce quel disagio che è stato chiamato antipolitica. La destra può permettersi di rifiutare la complessità del contemporaneo perché fa appello alla “pancia”, la sinistra no e allora le spetta, in primis, il compito di ricucire vita materiale e sua rappresentazione simbolica, ovvero, per citare Dominijanni «ritrovare il nesso perduto fra obiettivi e soggettività, fini ed esperienza, progetto e narrazione». Il maggior pregio di questo libro dalla lettura facile, ma non banalizzante, è proprio quello di aver riportato la politica dentro le vicende umane, di aver posto l’accento sulla gestione della res publica sfidando la rappresentanza sul terreno del suo fallimento e mirando alla ricostruzione del potere dei cittadini espropriato dal buonismo veltroniano, dalla governance. Il fallimento dell’esperienza del centro sociale Angelo Mai - occupato da un gruppo di senza casa il 17 novembre 2004, trasformato in teatro e osteria, sgomberato il 4 ottobre 2006 e trasferito presso l’ex bocciofila di via delle Terme di Caracalla - è ancora ferita aperta. Cellamare ce lo racconta con la solita pacatezza di linguaggio ma anche senza fare sconti a nessuno. Fallimento della politica delle pratiche e dell’autogoverno che non è riuscita a produrre un progetto di senso capace di diventare patrimonio collettivo del Rione Monti e fallimento ancora più grave della rappresentanza, delle istituzioni incapaci di gestire il conflitto. Forse, senza una sponda, la società civile, da sola, regredisce sui propri particulari. E i cosiddetti movimenti? Quelli che hanno attraversato e usato quell’esperienza di occupazione? Essi hanno mostrato tutta la loro fragilità e non-innocenza. La loro vittoria di Pirro si è risolta nella gestione di frammenti, di nicchie dentro le quali continuare a difendere le loro marmoree microidentità. Così, sonnacchioso e pacioso, come l’immagine di Aldo Fabrizi, noto romano, il Rione Monti ha assistito alla parabola discendente di una delle esperienze di autogoverno più significative messa in atto dai cittadini: quella della Rete Monti che a differenza di altre esperienze, aveva coltivato la presunzione di coinvolgere l’intera società civile del Rione. Per entrare in Monti, ci dice Cellamare nella premessa, si deve scendere; forse è anche questa una metafora politica. Resta l’appello a fare città: un appello da raccogliere se si vuole risalire la china della disfatta.
Scaricare