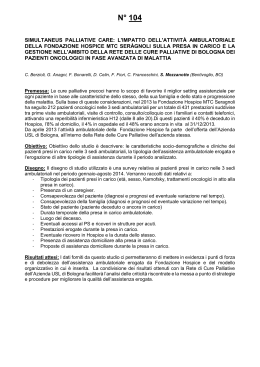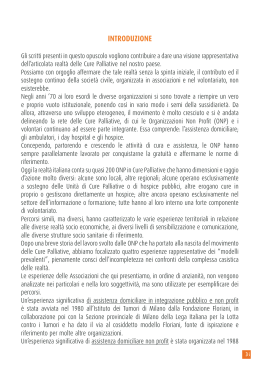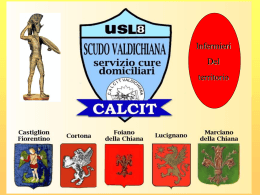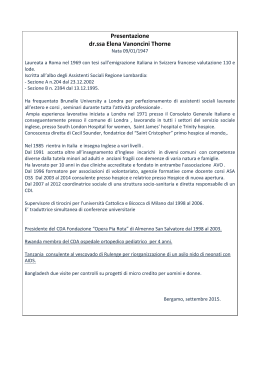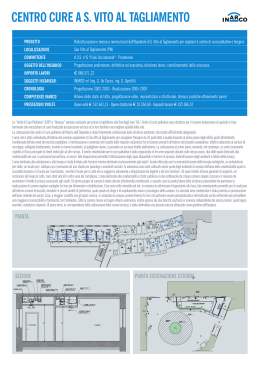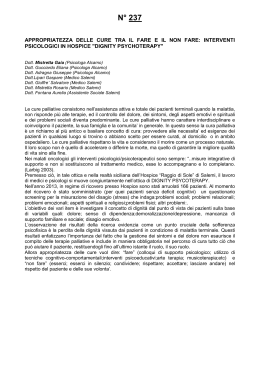Supplemento n. 2 al n. 24 di Verso Sera, notiziario quadrimestrale dellAssociazione Cure Palliative di Bergamo In copertina San Martino dà il suo mantello al bisognoso. Trento Longaretti Vicinia di San Martino - Bergamo 1 2 Quale sguardo si posa su di me? Testimonianze dallhospice di Borgo Palazzo dellAzienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo 3 4 Dedicato a Kika, amatissima presidente dellAssociazione Cure Palliative Bergamo 5 6 Indice pag. 9 Gli Autori 11 Premessa 13 Introduzione. Lincontro tra due libertà Gianbattista Cossolini e Maria Stella Moro 15 Una rete di cure palliative Arnaldo Minetti 19 Laura Marilena Papini e Alessandra Fadini 23 Luci e ombre di un diario di bordo. Considerazioni e riflessioni di un gruppo di studenti universitari Giovanna, Francesca, Silvia, Maria Francesca, Mariastella, Marco 27 Vivi Vilma Ruggeri 29 Sguardi emozionanti Elisa Capoferri 33 Un cammino di ricerca tra emozione e razionalità Aurora Minetti 37 Il frastuono del silenzio: metafora di un ascolto interiore Maria Francesca Pasinelli 43 Percorsi condivisi Giovanna, Franca, Cinzia, Gabriella 47 Insieme in silenzio Chiara Soloni 7 pag. 8 49 Drammatizzazione, testi tratti da Il libro dellhospice Associazione Teatro dOccasione di Bergamo 57 Sobrietà Ivo Lizzola 63 Formazione, medicina e terminalità Giacomo Delvecchio e Luisella Barberis 69 Che cosè che supera la sofferenza e il dolore? Ivana Fadini 79 Vorrei raccontarvi una storia Maria Stella Moro 85 Incrociamo gli sguardi Albino Fascendini 91 Ricerca di un senso al vivere e al morire Daniela Plebani 95 Appendice 120 Glossario 121 Bibliografia 125 Nota Gli Autori Associazione Teatro dOccasione Bergamo. Barberis, Luisella U.S.C. Formazione e Aggiornamento. Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti, Bergamo Capoferri, Elisa Psicologa presso lhospice di Borgo Palazzo, Bergamo Cossolini, Gianbattista Direttore U.S.C. Cure Palliative e hospice di Borgo Palazzo, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo Delvecchio, Giacomo U.S.C. Formazione e Aggiornamento. Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti, Bergamo Fadini, Alessandra Infermiera Professionale presso lhospice di Borgo Palazzo, Bergamo Fadini, Ivana Corso di Laurea in Scienze dellEducazione, Università di Bergamo Fascendini, Albino Medico, bioetico Gabriella Gruppo auto mutuo aiuto Bergamo 9 Giovanna, Franca, Cinzia. Volontarie A.C.P., Bergamo Giovanna, Francesca, Silvia, Maria, Francesca, Mariastella, Marco. Studenti, Corso di Laurea in Scienze dellEducazione, Università di Bergamo e Corso di Laurea Infermieristica, Università Bicocca, Milano Lizzola, Ivo Cattedra di Pedagogia sociale, facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Bergamo Minetti, Arnaldo Presidente Associazione Cure Palliative ONLUS, Bergamo Minetti, Aurora Dottoranda di ricerca in Scienze della Comunicazione, Università della Svizzera italiana, Lugano Moro, Maria Stella Scienze dellEducazione, Università di Bergamo Papini, Marilena Infermiera Professionale presso lhospice di Borgo Palazzo, Bergamo Pasinelli, Maria Francesca Scienze dellEducazione, Università di Bergamo Plebani, Daniela Scienze dellEducazione, Università di Bergamo Ruggeri, Vilma Infermiera Professionale presso lhospice di Borgo Palazzo, Bergamo Soloni, Chiara Medico presso lhospice di Borgo Palazzo, Bergamo 10 Premessa Questo volume contiene soprattutto i materiali del Convegno Quale sguardo si posa su di me? Testimonianze dallhospice di Borgo Palazzo, organizzato l11 novembre 2005 dallAssociazione Cure Palliative ONLUS di Bergamo, in occasione della VI Giornata Nazionale contro la sofferenza inutile della persona inguaribile, promossa dalla Federazione Cure Palliative. In quella sede abbiamo scelto di non proporre lusuale informazione e comunicazione sulla realtà dellhospice e del movimento delle cure palliative, con qualche rischio di autoreferenzialità: abbiamo deciso di dare voce prevalentemente ad altri sguardi e punti di vista, soprattutto da parte di chi ha attraversato i nostri spazi per tirocinii, dottorati di ricerca, master... coniugando queste voci con quelle degli operatori dellhospice e dei volontari. Abbiamo anche consegnato il libro dellhospice a un gruppo di artisti, perché ne elaborasse una drammatizzazione, e anche questo sguardo (che è diventato azione) è presente in queste pagine. Abbiamo, infine, ritenuto opportuno aggiungere una Appendice con materiali tratti dal nostro notiziario Verso Sera, per permettere al lettore di farsi unidea del contesto in cui collocare questa nostra proposta editoriale. Il ricordo di Kika, a cui il libro è dedicato, è seguito dallesplicitazione di come intendiamo il ruolo del volontariato e il futuro del welfare; il nostro percorso e le nostre proposte sono evidenziate nel Modello Bergamo, accompagnato da brevi cenni sulla Centrale Operativa e dallappello per rafforzare la rete di cure palliative. Il testo di un volantino di divulgazione e alcune fotografie dellhospice e di vita vissuta completano queste pagine. Consegnandovi questo volume, vi auguriamo buona lettura e v i rimandiamo per altri approfondimenti al sito www.associazionecurepalliative.it e alla collezione passata, presente e futura di Verso Sera. Il libro dellhospice è collocato su un leggio nella luminose veranda: sulle sue pagine i degenti, i parenti, il personale, i volontari, i visitatori possono scrivere pensieri, emozioni, riflessioni e tutto ciò che desiderano. 11 12 Introduzione Incontro tra due libertà Gianbattista Cossolini, Maria Stella Moro Nellepoca dellinformation technology si sa di che cosa muoiono le persone, mentre non si ha, spesso, unidea esatta di come si muore: è importante quindi fare emergere lo specifico dialogo, che si sviluppa nellhospice attraverso lintrecciarsi di destini, fatto di gesti, di silenzi e di ascolti più che di parole. Questa la trama del Convegno Quale sguardo di posa su di me?, trama che si snoda in una collana di ricostruzioni esperienziali, di ricerca e di emozioni raccontata da operatori e da Altri: malati, familiari, amici e Altre culture nellincrocio delle loro prospettive, dei loro sguardi (H. Arendt). Dialogo che si tesse partendo dai singoli vissuti, storie, esperienze di vita che si confondono, si sovrappongono per dare origine a sensi, significati condivisi. Nuovi sensi e significati che permettano a tutti e tre i soggetti coinvolti (pazienti, famigliari, operatori sanitari) di fare fronte al mistero che più spaventa luomo: il suo limite estremo, la morte, nei confronti del quale egli deve trovare una misura, una vicinanza-distanza corretta, accettabile. Creare una sorta di viaggio comune, attraverso un progetto terapeutico e assistenziale adeguato e coordinato, in cui si cerca di farsi carico del malato nella sua interezza e complessità. Progetto che non può prescindere dalla prospettiva del paziente (dove questa può essere colta), dalla valutazione soggettiva della vita e della sua qualità e dalle aspettative, emozioni della famiglia, degli amici e di chiunque operi accanto al malato. Prendersi cura di una persona implica anche prendersi cura del contesto in cui vive, del suo mondo, è dare enpowerment a tutti i soggetti che vivono accanto a lui per dare enpowerment a lui stesso. Significa essere consapevoli che il proprio progetto è strettamente intrecciato con la storia, cioè si comprende in che forma gli obiettivi individuati in sede di progettazione sono stati raggiunti solo a posteriori, solo dopo un intreccio di eventi, imprevisti, persone, solo dopo una storia che ha visto protagonisti il paziente, la sua famiglia. Gli uomini, non luomo, abitano la terra, nellincrocio delle loro prospettive, dei loro sguardi (H. Arendt, 1964). Léquipe oltre che sistema, parte di un sistema più ampio rappresentato dallhospice in quanto organizzazione, è quindi, come pluralità delle relazioni fra i soggetti che la costituiscono, nodo in un campo relazionale 13 allinterno del quale ciascuna parte prende forma in relazione continua con le altre parti, in modo tale che la forma delle parti inflette al suo interno lintero sistema delle relazioni che lhanno resa ciò che è (T. Ingold, 2001). Le aperture a confronti, ad attesi imprevisti, ad Altre culture di primo acchito possono lasciare spiazzati, ma rappresentano risorsa e possibilità per il proprio progetto. Lasciarsi sorprendere dallAltro impedisce di cristallizzarsi sui risultati già raggiunti, consolidati e di acquisire consapevolezza che luomo agisce per pre-giudizi e, quindi, fare in modo che essi non si trasformino in pregiudizi ideologici e omologanti. Solo vivendo dentro le relazioni, immersi in esse e contemporaneamente vedendosi fuori si acquisisce un sguardo attento e realistico, che permette una visione complessa della realtà per trovare nel qui e nellora i punti di forza dellaltrove e del dopo. Incrocio di sguardi. Sguardo sul presente che espone sul futuro. Sguardo che impedisce che la propria volontà diventi esercizio di forza nella convinzione di sapere qual è il bene dellaltro, riducendolo allimmagine che si ha di lui, privandolo di voce, di volto, di nome. Sguardo quindi che deve permettere di co-costruire relazioni asimmetriche che siano esempi di buona gestione del potere nella differenza e nella pluralità dei pareri diversi perché la verità è essenzialmente relazionale, [ ] solo lesperienza del tu ci apre non solo verso quella dellego ma anche verso quella delloggetto, del mondo esterno (R. Panikkar, 2003). Sguardo che deve permettere un reciproca narrazione, lincontro tra due libertà. Narrazione che diventa lunico linguaggio che rende possibile comprendere lagire umano. Narrare è vivere, è vivere con significato dando cioè senso allesperienza, è vivere da uomini. Permettere quindi a chi ci sta di fronte di narrarsi significa riconoscerlo come uomo nellincontro reciproco tra due libertà. Luomo è molto più di uno spettatore o di costruttore del mondo. Innanzi tutto è un attore [che compie atto], fondamentalmente un autore, che si fa [crea se stesso] attraverso la sua capacità non esaurita dal suo facere ma che include anche il suo agere. La sua attività non è semplicemente poiesis, ma soprattutto prassi prassi è quella attività umana che modifica e modella non solamente lesistenza esteriore delluomo, ma anche la dimensione inte riore della sua vita (R. Panikkar, 2003). 14 La Rete di Cure Palliative Arnaldo Minetti Come presidente dellAssociazione Cure Palliative di Bergamo ritengo doveroso ringraziare tutti coloro che portano il loro contributo a questo Convegno, arricchendo ulteriormente le nostre prospettive attraverso letture e punti di vista non usuali. Il movimento delle cure palliative e il movimento hospice traggono anche da ciò la loro linfa vitale, accrescendo costantemente la capacità di porsi in modo diverso nei confronti del malato, della famiglia, della persona in generale e stimolando tutti gli operatori sanitari e gli utenti a un approccio ricco, completo, a tutto campo: teniamo molto a valorizzare questo nostro ruolo di rinnovamento culturale e degli atteggiamenti professionali e di relazione. Mi spetta anche di ribadire ancora una volta che lhospice non può essere una cattedrale nel deserto, ma una delle opzioni possibili nella continuità del percorso terapeutico; non può essere lunico luogo dove assistere il malato in fase avanzata, ma va garantita la possibilità di restare a domicilio con una assistenza sia medica sia infermieristica qualificata. Per consentire ciò è importante che si costruisca un collegamento sinergico e costante (rete di cure palliative) fra tutte le strutture sanitarie e le singole unità operative che si occupano di tutte le malattie inguaribili, in rete con il territorio e con lassistenza domiciliare. Su questa completezza di rete, cè ancora tanta strada da fare: noi come associazione faremo la nostra parte, serve però un ampio sostegno da parte dellopinione pubblica sensibile a queste tematiche. Ma qui, in questo contesto, permettetemi due parole sul piano personale, come marito innamoratissimo di Kika e compagno del suo viaggio nella terminalità, conclusosi nel suo hospice il 14 luglio. Non ripeto gli apprezzamenti già noti sulla struttura e sulla grande disponibilità, umanità e professionalità del personale, ma evidenzio solo un paio di aspetti. Il primo è una ulteriore accentuazione della necessità di rete: dopo aver strenuamente combattuto con terapie attive contro tre tumori, Kika è giunta alla diagnosi di terminalità e a una prognosi di alcuni mesi a marzo 2005. Per il suo ruolo e la sua storia e per le nostre conoscenze, ha inevitabilmente usufruito di tutte le più alte professionalità e del massimo di attenzione, ma i nessi e i percorsi di relazione fra diverse figure specialistiche, fra diverse unità operative mostrano di essere ancora abbastanza empirici e volontaristici e la 15 presa in cura con vera continuità denuncia approssimazioni migliorabili e superabili: ciò non vuole essere una critica, perché non smetterò mai di ringraziare coloro che lhanno amorevolmente seguita, ma uno stimolo a un salto culturale, organizzativo, metodologico. Né come cittadini, né come operatori sanitari, né come volontari dobbiamo dare per scontato che la situazione richieda tempi molto lunghi per cambiare: solo se non ci rassegniamo di fronte a queste problematiche e se sapremo valorizzare le nostre motivazioni profonde e il grande sostegno dei malati, dei parenti e dellopinione pubblica, potremo fare molto di più e meglio, senza paura di volare, senza perdere la spinta propulsiva che ci ha permesso di fare iniziative esemplari. Il pionierismo che ci ha animato nel combattere il tabù della morte e del morire, nel costruire i primi embrioni di domiciliarità, nel sognare e realizzare lhospice resta oggi fondante anche per la realizzazione della rete di cure palliative, lo sviluppo e miglioramento dellassistenza domiciliare, anche attraverso sperimentazioni come la Centrale Operativa Cure Palliative e Domiciliarità, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, delle équipe di cura e assistenza, delle realtà di volontariato. Il secondo punto di riflessione personale che desidero condividere torna sullo specifico della struttura di degenza e riguarda uno degli aspetti forti e pesanti degli ultimi giorni di vita: langoscia da impotenza in attesa della morte imminente, una sofferenza totale che, a volte, è assai più devastante del dolore fisico. È laspetto più caratterizzante della degenza in hospice, dove una recente indagine sui bisogni principali dei pazienti conferma che, subito dopo il controllo dei sintomi, il bisogno prevalente è la necessità di occupare la mente nel lungo percorso di attesa. Ogni secondo è pieno come anni di una persona sana, ogni sguardo porta con sé una vita intera e non solo. Prendersi cura di questa sofferenza vuol dire tante cose: combattere il dolore, trovare le giuste risposte ad ogni sintomo, garantire continuità al presidio medico moltiplicando contestualmente lintervento infermieristico, presidiare il supporto psicologico e il conforto spirituale, coniugare lascolto, la compagnia, la diversione e la distrazione, il rilassamento, la presenza partecipante di familiari e amici e tutto ciò che riempie di senso - contenuti - atti ciò che definiamo la miglior qualità di vita possibile fino alla fine. Sono cosciente che alcuni operatori sanitari, pur condividendo questi obiettivi delle cure palliative e dellhospice, mantengono il dubbio che ciò possa limitare le risorse destinate alla fase acuta, alla ricerca o ad altri aspetti: pensano quasi che sia un lusso delle società occidentali ampliare e articolare cura e assistenza alla fase terminale, al fine vita. Più volte abbiamo lottato per ribaltare lapproccio al tema della sostenibilità: 16 le risorse non sono sicuramente sufficienti per tutto, ma lo devono essere per le vere priorità e su di esse e sui livelli essenziali di assistenza le risorse devono comunque essere trovate, a scapito di obiettivi secondari, di sprechi e inefficienze, di privilegi corporativi e di rendite. È una questione di civiltà e sicuramente anche sullattenzione alla qualità di vita in fase terminale si misura la civiltà di un Paese e la qualità del suo sistema sanitario. Solo per le malattie inguaribili stiamo parlando di quasi trecentomila persone ogni anno in Italia. Trecentomila famiglie travolte da un tornado, di cui è doveroso farsi carico. Migliaia e migliaia di faticosi percorsi, ognuno irripetibile e unico. Vorrei passare ad un esempio per essere più concreto e per cercare di capirci meglio: vorrei ricordare in particolare il sorriso sereno di Kika nel momento del massaggio rilassante con sottofondo musicale, una percezione personale di ciò che può essere la qualità di vita. Kika riconquistava così la possibilità di prendere fiato e anche di distrarsi, per recuperare energie residue verso sé e verso gli altri: lhospice è anche questo e lo sono le cure palliative nel loro percorso di continuo arricchimento e attenzione ad aspetti come questi e, proprio per questo, non dobbiamo abbassare la guardia e appiattire la ricchezza del nostro esserci. Su ciò può ancora crescere di molto la nostra presa di coscienza e capacità di presa in carico; possono crescere tutti gli operatori sanitari e i volontari, può crescere la integrazione fra operatori e volontari al servizio del malato e dei parenti, perché questo può aiutare a non burocratizzarsi e a non perdere il senso di ciò che facciamo. Tutto ciò può crescere nel nostro hospice, sicuramente, e nellattività complessiva dellUnità di Cure Palliative, ma si dovrà irradiare inevitabilmente sul territorio attraverso la Centrale Operativa e lAssistenza Domiciliare Integrata e dovrà coinvolgere tutte le strutture e tutto il personale che hanno rapporto con linguaribilità: se così non fosse, se non ci impegnassimo duramente su questo fronte, avremmo solo realizzato alcune strutture della cosiddetta buona morte e non certo la rete organica delle cure palliative. Proprio la realizzazione della rete di cure palliative e laffermazione di una cultura conseguente costituiscono la nostra missione. Quello che a Bergamo abbiamo chiamato Progetto Hospice è tutto questo: non abbiamo la presunzione di aver creato il modello del miglior hospice in assoluto e della sua integrazione in rete, ma siamo convinti di aver creato le premesse per lavorare insieme, per dare la massima estensione possibile alla potenzialità che deriva dalle nostre forze concrete, dal particolare connubio fra personale sanitario e volontari, dalleccellente rapporto con la popolazione e con i media, dal nostro percorso storico specifico. Sicuramente abbiamo limiti e carenze, ma desideriamo colmarli e superarli. 17 Stiamo cercando di costruire nuovi percorsi senza risparmiarci e chiediamo a tutti coloro che interagiscono con noi di darci altri stimoli e sostegni per andare ancora più avanti. Grazie per laiuto che ci avete dato, che ci state dando e che ci darete. 18 Laura Marilena Papini, Alessandra Fadini Con questo racconto vogliamo narrare la complessità delle emozioni vissute da noi, operatori dellhospice di Borgo Palazzo, in un percorso di cinque anni trascorso nellincontro di molte persone: magari arrabbiate poi rasserenate, depresse poi rassegnate, impaurite poi coraggiose, angosciate che, con sguardi interrogativi e indagatori, cercano di comunicare una grande necessità di aiuto. Questi sguardi noi abbiamo cercato di intercettare e accogliere con dolcezza e delicatezza e non reprimere, anche perché spesso ci hanno aiutato a dissolvere le nostre paure o sofferenze. Questi sguardi ci hanno insegnato a riflettere sulla morte e sul senso del limite e del confine in cui viviamo, aiutandoci a guardare diversamente i continui cambiamenti che caratterizzano le nostre vite: ecco che allora davanti a noi si schiude una nuova prospettiva dove la sofferenza e la solitudine non costituiscono più lunico orizzonte. Volgendoci indietro abbiamo fissato nella memoria tanti sguardi, ma quello di Laura ci comunica tenerezza e dignità. Cosè il ricordo? È conoscenza personale, è testimonianza, ma anche formazione. Il ricordo di Laura, di un padre, di una madre, di un figlio o di un amico, di un percorso di cura? Sappiamo che, quando il ricordo arriva, uno dei protagonisti della storia ha già speso il suo tempo, mentre laltro spesso sente che è stato comunque un tempo troppo breve. A volte, il ricordo inizia prima della morte, il paziente o uno della sua famiglia parla della loro storia, di come hanno costruito il loro rapporto, dei sogni realizzati e quelli ancora incompiuti. E mentre fanno conoscenza con il loro ricordo il tempo li incalza, li costringe a ridimensionare gli spazi, i tempi e i gesti. In quel tempo ristretto tutti i sentimenti vengono a galla e come dice F. Toscani (malato terminale, 1997): Morire non è mai un problema privato del morente. Lintera famiglia è proiettata in una crisi profonda nella quale si sovrappongono i ricordi, buoni o cattivi della vita passata, i bisogni del presente, le incertezze e le angosce per il futuro. Questa condizione non cessa con la vita del malato, ma si protrae a volte per 19 mesi, a volte per anni, oppure a volte per sempre in quel complesso di sofferenza conosciuto come cordoglio. Si comprende comè importante che il paziente e la sua famiglia diventino soggetti di cura e attenzioni. Prendersi cura di tutti, anche della famiglia significa riconoscere dignità alla persona e a chi gli sta accanto. Significa ascoltare i loro bisogni, le loro paure, costruire un progetto su di loro con unéquipe multidisciplinare che si confronta quotidianamente e settimanalmente con la verifica del progetto. Unéquipe che si modifica, si organizza, si pone degli obiettivi programmati e progettati con e per la famiglia e il paziente. Condividere qualche cosa, sentire che qualcuno si sta prendendo cura di te e ti ascolta, è non sentirsi solo. Il caso è la storia di una giovane donna che da subito ha condiviso con noi questo progetto, lei ci ha guidato e suggerito il percorso dei suoi ultimi giorni. Laura era un insegnante di 38 anni, sposata con un bambino di tre anni e orfana di padre. Arrivò in hospice il 20 febbraio conoscendo esattamente le finalità della nostra struttura e delle Cure Palliative. Allingresso la paziente era stanca, astenica e molto sofferente, ma si presentava come una persona gentile, cordiale e luminosa nonostante il fisico e il viso mostrassero tutta la sofferenza e la crudeltà della malattia. La situazione ci apparve subito complessa e critica sia per la sintomatologia sia per come lei parlava apertamente della sua morte. Iniziò a raccontarci la sua storia, la storia della sua malattia e della morte imminente. Léquipe rimase molto sorpresa, incredula e commossa, infatti era la prima volta che una persona parlava della propria morte così apertamente e con tanta forza. Da subito, nonostante il nostro imbarazzo e la nostra commozione, il dialogo fu sempre molto leale. Non le fu mai negata la realtà clinica in rapida evoluzione, ma Laura già sapeva. Sapeva che non avrebbe avuto molto tempo e quel tempo lo voleva spendere bene. La sua prima richiesta fu: Vorrei passare gli ultimi giorni della mia vita senza dolore e vomito così da poter aiutare mio marito a preparare mio figlio alla mia morte. Laura era molto preoccupata per il figlio e per il marito, il suo progetto finale era aiutare loro ad accettare la sua morte. Léquipe si propose da un lato di eliminare la sintomatologia che la disturbava e annientava togliendole la possibilità di coltivare i suoi affetti e dallaltro si offrì a supporto per essere daiuto a lei e al marito con il bambino. Nei giorni seguenti il dolore e il vomito furono controllati e Laura poté ricevere la visita della sua famiglia e di numerosi amici comunicando e relazionando con loro. 20 Una sorella di Laura non la lasciava mai sola. Il loro rapporto era profondo e si era intensificato e rafforzato con la malattia, anche la personalità di Laura era forte, capace di coinvolgere, comunicare emozioni, rabbia, dolore e affetto con discrezione, in modo sottile, in punta di piedi lasciando però un segno. Come diceva lei: Era entrata nel cuore della gente. Tra noi e lei si creò un rapporto intenso, profondo, amava la nostra presenza, le nostre cure erano ben accette, gradiva essere aiutata nellespletamento delligiene, discutere le terapie, parlare di suo figlio, dei suoi progetti e del suo lavoro di insegnante ormai lontano. Ci chiedeva il perché della nostra scelta professionale, conosceva i nostri nomi e parte della nostra vita. Ci ascoltavamo e raccontavamo. Noi rispettavamo i suoi tempi, i suoi desideri e le sue volontà. Quando piangeva non facevamo domande dirette, lasciavamo che la sua paura, la sua disperazione, la sua rabbia e impotenza (in parte anche nostra), si manifestassero. Ci parlava con delicatezza della sua fede, pura e autentica che però un giorno durante un incontro con la psicologa non le impedì di arrabbiarsi molto con Dio e di farle dire: Mi hai fatto sposare, avere un figlio, perché? Perché se devo morire così presto e lasciare tutto ciò? Perché? Perché? La rabbia era tanta, come chiedere ad una madre di lasciare tutto ciò? Come chiedere a lei così vera, tanto vera da entrare nel cuore di tutti , di arrendersi? Come e perché? Tra la psicologa e Laura quel giorno ci fu un lungo silenzio, le parole non servivano, la rabbia era giusta e le risposte non cerano. Quel silenzio fu interminabile e fu il segno terrificante di un vuoto: lei chiedeva e voleva delle risposte da Dio amato cercato e voluto. Ora anche Lui taceva, non aveva risposte. La psicologa usciva spesso provata da questi incontri, ma per entrambe fu una esperienza intensa e daiuto reciproco. Grazie a questi colloqui Laura poté incontrare il marito e il figlio con più serenità. Un giorno, il 25 febbraio, fu per Laura molto importante. La mattina iniziò con un pianto liberatorio e poi si rasserenò. La sorella, sempre presente, ci riferì: sta affrontando la morte con dignità e serenità. Nel pomeriggio ricevette la visita del marito e del figlio; lincontro fu sereno e prima di tornare a casa il bimbo disse alla mamma: È stato molto bello incontrarti. Dopo questa giornata seguì una notte di verbalizzazioni molto profonde con lelaborazione del lutto e la serenità per il futuro del figlio, trasmessa dalla sicurezza del marito. 21 Léquipe rimase ad ascoltare e lei stessa disse: Se torno a casa è perché sto bene e non perché devo soffrire e far soffrire. Ci chiedeva solo questo, passare gli ultimi giorni senza dolore, né vomito per stare con la sua famiglia, i suoi amici e il suo bambino. Tutto ciò fu possibile, ma presto il male tornò a farsi sentire e a minare fortemente il fisico e la sua resistenza, fu necessario adeguare la terapia con alte dosi di antidolorifici. Sempre più spesso faceva fatica a parlare e a comunicare, ma la sua forza interiore non le impediva di affrontare quei giorni e di condividerli con noi. Durante uno degli ultimi dialoghi con la psicologa, accadde un episodio significativo: ricevette una telefonata da casa che le comunicava che il bambino aveva la febbre e non sarebbe venuto a trovarla; lei stava per dire come curarlo ma si interruppe, guardò la dottoressa che rimase in silenzio. Laura in quel momento capì che in futuro non sarebbe più stata lei ad occuparsi del figlio e quindi, come in una staffetta, cedette il testimone al marito e lo fece con grande dolore ma con dignità. Il colloquio non proseguì. Laura volle rimanere da sola, il suo progetto di lasciare il figlio al marito stava riuscendo e lei non era più in questo progetto. La forza di Laura ci sorprendeva ogni volta. Uno degli ultimi giorni ci chiese un crocefisso, non uno qualsiasi ma uno colorato. Tutti: parenti, amici, e anche noi ci prodigammo per trovarlo, finché unamica lo acquistò. Quando si entrava nella camera lei aveva spesso lo sguardo rivolto a quel crocefisso che era così pieno di colori da illuminare tutto lambiente. Forse stava dialogando con Dio, sicuramente aveva accettato la sua morte. Laura ci lasciò una mattina del 4 marzo, esattamente due mesi dopo la diagnosi. Per le ultime ore fu necessario concordare con lei una sedazione continua perché i sintomi non erano più controllabili e lei accettò. Stare accanto a Laura nella fase finale della sua vita è stata unesperienza che ha sfidato le nostre certezze più radicate e ci ha portato a riconsiderare la relazione che abbiamo con la nostra morte. È stato un viaggio fatto di continue scoperte che ha richiesto coraggio e flessibilità, capacità di affrontare il rischio e la sofferenza. Stando accanto a lei abbiamo curato noi stessi. Prendersi cura degli altri crea sempre un beneficio reciproco che conferisce senso dintimità, di condivisione, di autenticità al nostro operare. Per questo non cè più differenza tra chi riceve e chi dà, ma esiste una interconnessione capace di superare i muri divisori dove tanto spesso cerchiamo invano riparo. 22 Luci e ombre di un diario di bordo Considerazioni e riflessioni di un gruppo di studenti universitari Giovanna, Francesca, Silvia, Maria Francesca, Mariastella, Marco Considerando solo la nostra vita, il nostro mondo ritagliato nellimmensità delluniverso totale, vediamo, e più ancora sentiamo, che ha bisogno di rinnovarsi, che è proprio della vita risorgere (M. Zambrano). Laccoglienza è il punto di partenza di un percorso, di un viaggio comune in cui si riconoscerà la presenza dei vari fattori caratterizzanti il quadro clinico dellammalato nei suoi aspetti organici, psichici, socio-culturali e spirituali ma, soprattutto, centrato sulla relazione (sugli attesi imprevisti), sullautodeterminazione dellammalato. Linizio di questo viaggio è la costruzione di un rapporto di fiducia reciproca partendo dalla non disconferma della storia clinica antecedente dellammalato - anche se magari in contrasto con le proprie conoscenze teoriche e competenze professionali - come, per esempio, assunzione di determinati farmaci o abitudini consolidate. È un momento in cui tutto diviene relativo e finalizzato alla costruzione della relazione, con lintento di far rimanere lammalato attore - protagonista, responsabile della sua salute. Allinterno dellhospice vi sono degli aspetti privilegiati nella relazione: rispetto ad altri contesti sanitari, qui si cerca di vivere il tempo nella preziosità dellistante pur essendo in una condizione di finalità di tempo. Un tempo non solo più strutturato e ragionato, ma anche diversamente impiegato, che sa attendere per accogliere e sostenere discontinuità, novità, eccezioni, ombre, incertezze, non risposte. Si cerca di oltrepassare il senso di efficientismo programmato spesso tipico di altri luoghi. Tutto questo necessita di momenti riflessivi in cui il tempo si riposi, dove siano presenti confronti, condivisioni, anche contrasti allinterno delléquipe, pur nel rispetto dei ruoli e delle competenze. Ciò permette di ottenere una sufficiente tutela al forte senso di responsabilità che si viene a creare, unitamente ad una libera emersione ed espressione della propria emotività. Gli operatori non si muovono su un sentiero personale e collettivo già tracciato, ma su un percorso da farsi, che si crea in itinere, affidati e affidabili gli uni agli atri. Importante sembra essere non solo la biografia dellammalato, ma anche quella di ciascun operatore che per la volontà propria è in questo luogo e non per situazione circostanziale di vita: forse, è grazie alle proprie storie e alla scelta effettuata che si riconosce la preziosità del tempo e la ricchezza del lavoro di gruppo. 23 Tutto questo sembra creare nellhospice unatmosfera nuova che lo fa sembrare luogo diverso, quasi sentito come casa da tutti, proprio attraverso una proposta per gli operatori di destrutturare un loro ruolo predefinito. La finalità dellhospice sembra proprio emergere da dove invece la medicina mostra i suoi limiti e la sua impotenza; dove cè apparente insuccesso terapeutico e sentimento di perdita si cura e ci si prende cura nellincontro tra professionalità e umanità. Si vorrebbe che i nostri gesti fossero perfetti: con i propri figli, con chi amiamo, con i morenti. Ma nellhospice, in questo luogo-casa scopriamo che le azioni, le parole damore sono i gesti quotidiani attraverso cui intessiamo le nostre relazioni e incontriamo il volto dellaltro. Il luogo esalta la significatività delle nostre azioni, delle nostre parole. Attraverso i propri gesti, il personale dellhospice entra in storie significative già esistenti, in racconti già narrati, creando relazioni nuove. Gesti che, cercando di non diventare esercizio, espressione di forza che sveli il mistero del volto dellaltro, tracceranno un solco, creeranno storia, vale a dire qualcosa che dura per sempre. Quindi, di fronte a ogni congedo, a ogni morte, ogni infermiere, medico, volontario è lì, come se fosse la prima volta. È lì a farne esperienza di nuovo perché ogni morte, ogni persona è unica, irripetibile, come uniche e irripetibili sono le lacrime di chi resta. Questo fa sì che nessuno si possa definire esperto di fronte ad essa. Ogni volta è un inizio che porta a decostruirsi e ricostruirsi, a confrontarsi con la propria zona dombra, con i propri limiti, le proprie paure, ad intrecciare in un nuovo ricamo i fili del proprio passato e prepararsi al futuro. Questa inesperienza, impreparazione che sembrerebbe un limite, in realtà è una ricchezza, unopportunità che impedisce listituzionalizzazione dellhospice, dei gesti di cura, mantenendo vivo il concetto dunicità di ciascuna persona. Lotta contro unistituzionalizzazione, quindi, che passa attraverso la constatazione giornaliera che il dolore, la malattia, la morte sono solo dellammalato, sono solo suoi, sono dentro di lui più dogni altra cosa. È il malato, è il suo corpo che sta vivendo la morte. È il suo corpo (sua possibilità di relazione e di conoscenza) che si sta disgregando, che sta lasciando lentamente scivolare fuori la vita, che sta diventando estraneo perché muore mentre si vorrebbe vivere. La consapevolezza di ciò porta ad uno sguardo attento, rispettoso da parte delléquipe a cogliere i bisogni del malato e della sua famiglia, a prestare attenzione al racconto unico narrato. Ascolto, attenzione, rispetto e pudore sono gli imperativi che la malattia e la morte impongono e che spezzano, o forse solo accompagnano, la solitudine che si sposa con queste ultime. Lotta contro listituzionalizzazione e ascolto rispettoso diventano la consegna, leredità dogni paziente per léquipe, insieme con la propria traccia, volto e nome. Eredità damore che può essere colta nelle frasi, nei pensieri che, come pe24 gni, segni, testamenti, presenze delle assenze sono lasciati dai familiari sulle pagine bianche di un libro. Segni, parole germogliate, tracciate e consegnate come risposta al dono che si sente di aver ricevuto, ma che in realtà si è cocostruito attraverso il coraggio di affidarsi in questa storia senza tempo, senza futuro, a chi allinizio ci è estraneo. Per alcune persone questo luogo rappresenta la possibilità di rinascere, di dis-nascere, risignificando, ridisegnando il mondo. Talvolta si presenta una nuova lettura, un nuovo punto di visto rispetto alla propria storia, è un rescatar, come ci insegna Maria Zambrano, tornare a prendere: si capisce che non sono gli eventi che hanno costituito questa storia, ma il nostro modo di assumerli e di attribuire loro senso e questo può cambiare; può permettere una consegna, segni di una buona semina, uneredità in un gioco di parole e gesti dei quali non sai che cosa ne verrà fatto, ma gioco basato su alcune regole: gratitudine, manifestazione e il darsi di dignità. Ogni volta è un nuovo inizio perché morire diventa la metafora del pensare, dellagire, del vivere: tutto questo può avvenire, ma per limiti. Bisogna ripartire ogni volta da qui, da uno stare in presenza. È di nuovo un dirsi il patto fra donne e uomini. È riesistere. È un rimotivarsi a scegliere la vita nonostante, o grazie, lo specchiarsi nella vulnerabilità, nel limite, nella finitezza. Pensieri nei giorni a venire Malgrado ci siano dei tentativi di risposta, ci sembra importante che alcune domande rimangano sospese sul futuro. Ci siamo riconosciuti in questa cultura che pone poca attenzione alla sofferenza, al limite, alla precarietà, alla morte cercando di estrometterli e di nasconderli dietro falsi miti quali leterna giovinezza, il benessere. Gadamer afferma: Occorre ritrovare il senso del dolore e della sofferenza nelleducazione di oggi. Manca la resistenza. Riconosciamo limportanza del fatto che vengano avviati processi culturali i quali riconoscano la morte come parte del processo della vita, evento naturale, meta finale della vita umana; è davvero importante preservare uno spazio alla dimensione simbolica dellesperienza umana della malattia, ma ci chiediamo: può un nuovo modello, un nuovo concetto di morte sviluppare nellindividuo il coraggio di affrontarla proteggendolo da superstizioni ma soprattutto da paura e disperazione? In fondo, anche queste ultime non fanno parte della dignità di uomo? Abbiamo colto quanto sia importante la creazione di una relazione empatica, intesa come lentrare in risonanza, la non negazione di uno spazio per la comunicazione e lelaborazione della dimensione simbolica, ma come si può trovare il modo per essere strumento, azione non agente per laltro che gli permetta di vivere il suo dolore? È il suo dolore e nessuno glielo può togliere e forse è anche giusto non toglierglielo. Ci chiediamo quale potrebbe essere il ruolo di un educatore e se potrebbe 25 esserci un ruolo allinterno di questo luogo: potrebbe essere quello di fornire un punto di vista esterno critico, che permetta la non anestetizzazione, listituzionalizzazione? Come tenere sotto controllo il potere inevitabilmente presente? Anche Maria Zambrano si chiede: Ma può esistere il sapere separato dellamore e dal potere? Un educatore potrebbe provare a portare avanti unetica della malattia? Crediamo sia importante sottolineare come lhospice non dovrà mai essere tenuto fuori dal tessuto sociale perché significherebbe sminuire la dimensione umana. Come provarci? Come far conoscere questa realtà? Cosa perderebbe la società se non si fermasse attorno a queste storie? Infine, ci fermiamo perché ci accorgiamo di quanto sia grande il mistero della morte e proviamo a rispettarlo, non andando oltre, non cercando di svelarlo, ma contemplandolo attraverso limmagine del Seminatore di Van Gogh che, secondo don Roberto Pennati, racconta la vita: Chi ha provato a seminare con le mani sa quanta potenza, energia e speranza cè in questo gesto silenzioso. Questuomo è un propiziatore di vita, ma anche un seppellitore. Se il chicco di grano non muore [ ] questuomo affida alla vita attraverso la morte, alcuni semi, ma quanti rischi, quante fatiche, dovranno superare per diventare piantina, stelo, spiga, farina, cibo e, infine, ancora vita. Questuomo è così curvo e così scuro perché sente addosso la grave responsabilità di questo gesto e ne è quasi schiacciato. La pianta stessa che incrocia è simbolo della vita oltre che segno della fatica del creato. Anche la creazione soffre le doglie del parto [ ]. Una pianta piegata dal vento, un tronco scuro, contorto, pochi fiori che danno gioia, alcuni rami tagliati o potati come braccia monche, alcuni getti nuovi in avida ricerca di foglie e frutti nuovi. E poi il sole, un grande sole: cè bisogno di un grande sole per sollevare e rendere accettabili il peso e le contraddizioni della vita. 26 Vivi Vilma Ruggeri Il tempo scorre veloce, certe emozioni non si cancellano e basta un niente per farle rivivere. Ricordo Vivi lucidamente e mentre scrivo brividi salgono lungo il mio corpo. Non è facile esprimere emozioni sulla carta, difficile è condividerle, faticoso trasmetterle ad altri, come se questi altri volessero rubare qualcosa di mio; con la paura che nelle parole non ci sia il rispetto o la giusta considerazione per le sensazioni provate. Oggi il sole, ormai senza calore, entra dalla mia finestra; osservo le ultime foglie cadere dagli alberi, sento qualche piccolo passerotto cinguettare e il mio pensiero vola lontano, vola da Vivi. Durante una riunione déquipe i medici comunicano che cè un problema. Cè necessità di discuterlo e condividerlo tutti insieme. Cè Vivi. In un vicino ospedale cè una piccola bimba di pochi mesi con unaspettativa di vita minima, dimissibile, senza la possibilità di tornare a domicilio. Sono un po sconvolta, spaventata. Una bimba allhospice? Dubbi, domande, timori. Perché una bimba allhospice? Ma la riunione prosegue e si sottolineano diverse problematiche Non ha famiglia, o per meglio dire, la famiglia non può essere presente. Non si sa esattamente quanto potrà vivere, le statistiche per il tipo di patologia non sono favorevoli. Dal punto di vista della coscienza il quadro clinico è incerto, non capisce, non piange, forse ha dolore. Nonostante le perplessità del caso non si può non decidere, ed ecco che Vivi arriva allhospice. È più bella del previsto. Labbiamo sistemata nella camera più vicina a noi infermiere predisponendo lettino, carrozzina, fasciatoio e tutto quanto poteva rendere la sua permanenza più gradevole possibile. La sua famiglia viene a visitarla una volta la settimana, la sua mamma è triste ma, per motivi personali, è alloscuro della patologia della figlia, solo il padre sa. Così, con laiuto e il supporto delle volontarie, abbiamo iniziato a prenderci cura della piccola. Ci sono state difficoltà tecniche, dovute probabilmente alla poca esperienza nellaccudire i bimbi, superate anche dal supporto di un pediatra che confermava le scelte terapeutiche. Ma i nostri, i miei dubbi vanno al di là della tecnica, del saper fare; le mie domande spaziano e le risposte sono incerte. Quanto capisce? Ha dolore? 27 Riesce ad esprimere il suo dolore? Cosa posso fare per aiutarla? Sto facendo tutto ciò che è possibile per rendere la sua vita qualitativamente migliore? Che cosè meglio per lei? Nel frattempo Vivi sta con noi. Vivi nella sua carrozzina con quel sondino che spesso si toglie e bisogna riposizionare Vivi tra le nostre braccia la notte quando non dorme Vivi sedata ad ogni minimo dubbio di dolore Vivi che ti guarda con due occhi angelici,un po strabici Vivi con i suoi versetti simili ad un pianto Vivi che a volte abbozza (forse è solo un illusione) un sorriso Vivi con gli altri pazienti adulti che chiedono di lei Vivi con i suoi fratellini e con suo papà Vivi con la sua mamma affranta dal dolore Vivi riempita di regali da tutti Vivi con le volontarie che la coccolano tutto il giorno Vivi nella quotidianità giorno dopo giorno. Come previsto, lentamente, le sue condizioni iniziano a peggiorare, pian piano, non è più possibile alimentarla, il respiro è sempre più irregolare, dorme spesso; al minimo accenno di dolore vero o presunto che sia vengono somministrati antidolorifici. E alla fine di una lunga notte in cui Daniela e io eravamo di turno, Vivi fra le nostre braccia nellimpercettibile silenzio di un respiro se nè andata. Le lacrime mie e di Daniela solcano i nostri visi. È FINITA. Vivi ci ha lasciato. Vivi non soffre più. Vivi non vive più. Labbiamo vestita di rosso con la tutina che le aveva regalato una nostra collega, la Gibi. Abbiamo telefonato ai genitori. Loro non sanno, ma ci hanno fatto un bellissimo regalo: siamo state vicino alla nostra bimba in modo speciale. Il sole se nè andato non illumina più la mia stanza, le foglie cadute sono a terra inermi, quello che vedo sembra rispecchiare il mio stato danimo, quante riflessioni passano nella mia mente, la morte di un bimbo, inconcepibile, ingiusta; limpotenza delluomo, del medico, dellinfermiere; il dolore di una mamma. La speranza di aver contribuito, seppur in minima parte, ad alleviare la sua sofferenza, ad averle donato amore, a essere comunque lì, anche solo ad aspettare è il raggio di sole che scalda il mio cuore e mi permette di lavorare come infermiera allhospice, nonostante i dubbi, le difficoltà, le incomprensioni e le domande a cui non esiste risposta. 28 Sguardi emozionanti Elisa Capoferri Salgo le scale, sto per entrare, è il mio primo giorno di lavoro in hospice, mi guardo intorno, sono emozionata, di quellemozione che è insieme spavento e curiosità, tipica per me di quando inizio un nuova avventura. Saluto la nostra caposala, le infermiere e il personale che quella mattina è di turno e mi avvio verso quel luogo, quella piccola stanzetta, che nei giorni precedenti, quando accompagnata da una collega ho visitato lhospice, mi è stata indicata e che ora riconosco, come lo spazio dove sistemare le mie cose. Mentre percorro il corridoio noto una signora, guarda fuori della finestra verso il giardino; è vestita, indossa una gonna e una camicetta bianca con dei fiorellini e un golfino sulle spalle. Non indossa dunque né un pigiama, né una vestaglia, ma già al primo sguardo mi accorgo che non ha laria di essere una volontaria e tanto meno una parente. Si volta verso di me, ci guardiamo per un breve istante, sorrido, la signora ricambia il mio sorriso, insieme diciamo buongiorno; lo stesso giorno, nella tarda mattinata, la incontrerò per un primo colloquio. La signora Carla rappresenta ancora dentro di me il migliore augurio di benvenuto in hospice che potessi sperare: il suo sguardo e il suo sorriso mi hanno accolta e mi hanno fatto pienamente intuire il significato del mio essere lì. Non ho ancora detto che io per professione, o meglio, di mestiere faccio lo psicologo, uso la parola mestiere perché la preferisco, rimanda ad un sapere che non è solo quello dei libri, ma che si costruisce giorno dopo giorno anche sulla base dellesperienza. In questo anno e mezzo di lavoro in hospice mi sono sentita talvolta un po come un artigiano che per fronteggiare le difficoltà del suo lavoro è costretto a sporcarsi le mani, a lasciare le certezze per ingegnarsi e improvvisare nel tentare di trovare soluzioni nuove di fronte a richieste sempre diverse e mutevoli. Lespressione sporcarsi le mani non ha chiaramente una valenza negativa o dispregiativa, anzi trovo che sia un buon modo per esprimere, da un lato, linevitabilità del coinvolgimento emotivo che nasce dallessere persone, anche se operatori sanitari, che incontrano altre persone che soffrono; dallaltro, lo sforzo incessante di cercare nuovi strumenti di lavoro o di riconoscere come centrali quegli strumenti che in altri contesti sono certamente noti ma forse più marginali. Mi riferisco in particolare alla necessità di comunicare spesso con i nostri malati anche senza parole. 29 Storicamente la parola è stata considerata da noi psicologi come il principale strumento di cura, oggi è noto che la cura psicologica non è fatta solo di parole e che la comunicazione passa anche attraverso il linguaggio del corpo. Ciò si fa ancor più evidente in alcuni contesti e situazioni, ad esempio, quando siamo immersi nellangoscia del dolore e questo lacera la nostra interiorità, oscura i nostri orizzonti. In tal senso quando siamo nel dolore il linguaggio delle parole si dirada e poi si spegne [ ] è il linguaggio del corpo - al di là di ogni nostra intenzione - a gridare in silenzio per farsi intendere e se è possibile per farsi aiutare (E. Borgna, 1999). Recentemente in hospice ho incontrato una paziente gravemente malata, di una malattia che la costringeva a rimanere isolata; con lei ho potuto per un po condividere, in alcuni colloqui, quanto le succedeva. In seguito, con laggravarsi delle sue condizioni fisiche, ma ancor più per il precipitare daccadimenti che hanno colpito i suoi familiari, la signora ha potuto dirmi io non ho più parole per esprimere il dolore che provo; da quel momento, in accordo con la signora, la mia vicinanza si è potuta esprimere solo attraverso una presenza silenziosa e discreta, segnata dalla fatica a reggere il suo sguardo così carico e denso di sofferenza. Ho scelto il titolo di questo convegno sguardi emozionanti pensando alle persone che ho incontrato e incontro quotidianamente in hospice: malati, familiari, amici dei malati, operatori sanitari, volontari. Quando penso a tutte queste persone ritrovo innanzitutto molti sguardi e in questi sguardi molte emozioni. Lincontro e la conoscenza dellaltro avviene prima ancora che dalle sue parole dai suoi sguardi e dai suoi gesti. È attraverso gli sguardi che illuminano o oscurano un volto che possiamo cogliere e riconoscere laltro nella sua vulnerabilità, nelle sue lacerazioni, nelle sue attese e nelle sue speranze. Pensiamo allesperienza originaria dello sguardo tra una madre e il suo bambino, sguardo attraverso cui la madre riconosce e accoglie i bisogni del suo piccolo e lui può rispecchiarsi, riconoscersi e trovare i suoi confini. Rivedo lo sguardo interrogativo di chi, consapevole di quanto gli sta accadendo, chiede con forza di sapere come sarà il momento del trapasso e di essere rassicurato che non sarà solo; quello duro di chi è arrabbiato e non può accettare quanto accade; quello spaventato e angosciato di chi vive la perdita di sé e non trova speranza. Poi, lo sguardo disperato di chi è troppo giovane per lasciare la vita e non riesce a salutare le persone che ama; quello rassegnato e più sereno di chi ha potuto dare un senso al suo dolore; lo sguardo straziante di una madre che sta perdendo un figlio o di un figlio che sta perdendo un genitore; quello di un fratello o di un amico che non capisce 30 perché sta succedendo tutto questo; e, ancora, lo sguardo dolce di chi vuole proteggere i suoi cari dalla sofferenza, le lacrime trattenute a fatica e gli sforzi per non far capire allaltro. E poi, rivedo i nostri sguardi: quello talvolta sfinito di un medico o quello timoroso di un infermiere che, dopo aver incontrato un paziente, si chiede se ha fatto o detto bene, se avrebbe dovuto fare diversamente; quello commosso del volontario; penso anche al mio sguardo, che posso solo immaginare o incontrare nel rimando degli sguardi altrui come quando, dopo un colloquio molto faticoso e coinvolgente, qualcuno legge nei miei occhi lemozione e mi chiede Penso a questi sguardi come ad un ponte fra mondo interiore e mondo esteriore, tra il sé e laltro, tra noi e loro; lo sguardo appartiene alla nostra interiorità, guardiamo laltro, il mondo sempre da un luogo interno, silenzioso, nei volti si adombrano i linguaggi dellanima, si sigillano inquietudini, lacerazioni, domande, nello sguardo si esprime lattesa di qualcosa o qualcuno che sta per arrivare o accadere, si esprime lattesa di essere guardati, considerati, accolti, nei volti e negli sguardi risuona quanto accade fuori o nel proprio corpo. Ascoltare e decifrare questi sguardi e questi volti è insieme facile e difficile: facile perché, ribadisco, lo sguardo fa parte di un linguaggio primario, ci si può intendere con uno sguardo; difficile perché le espressioni e le allusioni di questi sguardi rievocano in noi le stesse emozioni, inquietudini, angosce che chiedono di essere accolte, sopportate, tollerate ed è nel nostro sguardo, come in un gioco di specchi, che laltro legge le risposte o le mancate risposte alle sue attese. Perciò è negli sguardi degli altri che leggiamo le tracce dei nostri sguardi e gli altri a loro volta leggono nei nostri sguardi le tracce dei loro sguardi I nostri sguardi ci immergono in una cascata di relazioni con il mondo delle persone e delle cose: dalle quali rinascono stimolazioni senza fine in una circolarità tematica che ci unisce gli uni agli altri (E. Borgna, 1999). Infine, nel ripercorrere questo tempo in hospice, non posso non pensare allaccompagnamento nellesperienza radicale della perdita. Mi riferisco alla fatica dei famigliari, degli amici, o alla nostra fatica ad accettare che lo sguardo ad un certo punto non ci sia più, quando gli occhi si chiudono perché sono stanchi di vedere o perché non possono riaprirsi più. È il dolore disperato o sommesso che spesso si traduce verbalmente nellespressione non potrò più vederlo o vederla, che è al contempo il dolore di non essere più visti, da quello sguardo che, guardandoci, ci vedeva e riconosceva. Vorrei chiudere ritornando allo sguardo della signora Carla che sorridendomi 31 mi accoglieva. Un accoglimento che ha permesso di tollerare i miei timori, le mie titubanze, i tremori. Il suo sguardo non cè più, come molti altri, ma si è tramutato in una traccia che posso ripercorrere per fare altri passi, altri pezzi di strada con chi incontrerò. 32 Un cammino di ricerca tra emozione e razionalità Aurora Minetti Spesso mi hanno chiesto le motivazioni che mi hanno spinta ad impegnarmi per un periodo così lungo, tre anni, in un reparto ospedaliero che accoglie malati terminali in fase avanzata e altrettanto spesso ho avuto difficoltà a dare una risposta chiara. Dopo circa sei mesi di mia ricerca in hospice ho iniziato a comprendere meglio cosa mi spinse ad indagare un terreno così apparentemente lontano da questa fase della mia vita, con i miei trentatre anni, un matrimonio e la nascita delle mie due bambine. La risposta, nonostante possa apparire paradossale, risiede anche nella mia vita presente e nella coscienza e insieme paura, dellinevitabilità della fine. Sin da quando ero bimba, di fronte ad una situazione di morte, la prima reazione di chi mi stava vicino (con levidente intento di proteggermi) era allontanarmi da essa sia fisicamente che emotivamente; ciò comportava il ritrovarmi, senza capirne il motivo, in un luogo diverso e a parlare di qualcosa daltro. Parlare di morte rappresenta senza dubbio una cosa non facile, sia per la sua profondità, ma anche per la pluralità dei punti di vista che si possono adottare (una ricerca storica, antropologica, sociologica, psicologica, ecc..). Di conseguenza sono cresciuta, come molti, con la rimozione-paura di morire; la morte rappresentava un fenomeno altro del quale era meglio non approfondirne il senso. Utilizzando le parole di Epicuro: Quando siamo noi non cè la morte; quando cè la morte, non siamo più noi. Nulla dunque essa è per i vivi e per i morti, perché in quelli non cè, e questi non ci sono più. Conseguita la laurea in Sociologia e iniziato un percorso presso lUniversità degli Studi di Bergamo, nel maggio 2005 ho intrapreso un Dottorato di ricerca in Scienze della Comunicazione presso lUniversità della Svizzera italiana di Lugano. Inizialmente il focus della ricerca di dottorato era centrato sullanalisi da condurre sui pazienti, prevalentemente oncologici, giunti in hospice in fase terminale; lobiettivo era lo studio delle loro narrazioni per poi giungere, in una seconda fase, ad una comprensione e successiva rielaborazione dei loro bisogni. Tali risultati avrebbero potuto diventare uno strumento di lavoro principal- 33 mente per gli operatori, che lavorano in hospice, per i parenti dei malati in fase ultima e per tutte quelle persone che, attraverso il volontariato, ricoprono diversi ruoli allinterno di questa struttura. La metodologia di ricerca da applicare allo studio era di tipo qualitativo, ritenuta la più appropriata poiché volta a mettere in risalto i diversi aspetti ed eventi della vita dellhospice e ad analizzare forme come la sua cultura organizzativa, i suoi valori e le dinamiche di costruzione di procedure istituzionalizzate. In questo modo si è tracciato un approccio di tipo etnografico, basato inizialmente sullosservazione passiva del contesto hospice, per poi passare a unosservazione partecipante nel momento in cui avrei iniziato ad instaurare relazioni sia con gli operatori che con i pazienti e i loro parenti. Lintervista narrativa al malato sarebbe stato uno strumento successivo. Tutto iniziò il giorno in cui mi presentai per la prima volta in hospice e iniziai a raccogliere informazioni e a trascriverle su un diario di cui desidero riportarne il mio primo giorno. 14 maggio 2005, ore 9.30 Oggi mi sono inoltrata in hospice. La giornata era soleggiata e accompagnata da una piacevole temperatura primaverile. Parcheggiata la macchina nel piazzale adiacente il padiglione 14, ho iniziato ad incamminarmi lungo il viale centrale. Mi ero recata in questo luogo altre volte, vicino cè anche lA.S.L. e ricordo linaugurazione dellhospice. Noto molti alberi secolari che fanno da cornice a una infinità di cartelloni segnaletici: consultorio familiare, infettivi, camera mortuaria e così via. Il contrasto è evidente. Mentre mi incammino cerco di fare ordine tra i miei pensieri e mi domando chi incontrerò per primo, cosa gli dirò, ma soprattutto come mi presenterò, con quale ruolo. Per fortuna, superato il portellone dentrata principale trovo il dottor Cossolini, il primario, il quale mi indica dove andare. Limpatto è forte: un lungo corridoio luminoso è lunica strada da percorrere e io vado. Sulla mia sinistra ci sono sei camere, sono tutte occupate, lo capisco perché le porte sono o socchiuse o aperte e noto delle persone. Sulla mia destra ci sono delle grandi vetrate che danno verso il giardino che circonda lhospice. La cosa che mi stupisce maggiormente però è il silenzio e la quasi totale assenza di via-vai di dottori o infermieri. Finalmente trovo la sala riunioni e lì aspetto. Dopo qualche minuto mi raggiunge il primario e la nostra prima chiacchierata prende velocemente il via: la prima questione che egli mi pone è lufficializzazione del mio ruolo tra gli operatori allinterno del reparto e mi comunica la data della prossima riunione déquipe, giorno in cui mi presenterò. Dopo sei mesi di ricerca vissuta in hospice ho deciso, insieme con léquipe che segue il mio progetto di dottorato, di modificare il focus e le modalità 34 dindagine. Iniziare un progetto di ricerca in una determinata maniera non significa che tale iter sia quello più giusto e, soprattutto, che sia il più adatto a cogliere i significati ricercati. Giorno dopo giorno, seguendo il primo approccio, sentivo sempre più la necessità di ascoltare anche altre persone coinvolte in questo momento della malattia: il tempo che avevo a disposizione per stare con i malati spesso era molto breve (a causa della loro condizione fisica) e riuscire ad instaurare un rapporto dempatia, tale da rendere le nostre conversazioni finalizzate allo scopo della ricerca, risultava difficilissimo e comunque non sufficiente per arrivare ad una comprensione profonda del bisogno espresso in quella particolare fase della vita. A questo proposito desidero chiarire cosa intendo per bisogni, quelle esigenze, cioè, non solo fisiche, ma anche psicologiche, che i malati esprimono (più o meno in maniera esplicita) quando si avvicinano alla fine della vita. Quando si parla di bisogni, dipendentemente dal contesto, questi assumono accezioni positive o negative, basti pensare al bisogno del neonato ( che in questo caso ci rimanda a sensazioni affettive, amorevoli e naturali) e al bisogno del morente ( che invece viene identificato come un qualche cosa di innaturale e da nascondere). In questo senso, parlare di bisogni diventa doppiamente significativo, per lutilizzo che se ne farà dopo averli ricercati, ma anche per il significato che gli si vuole attribuire, ovvero non negativo come il senso comune ci suggerisce, bensì semplicemente naturale. Ritornando alle problematiche descritte precedentemente, ciò di cui avevo bisogno era di maggior materiale empirico, su cui poi sviluppare delle riflessioni, e che racchiudesse più prospettive. A questo proposito ho trovato grande conforto negli studi sociolinguistici della performance narrativa, che sottolineano il carattere essenzialmente temporale della narrazione, il suo sviluppo e la sua risoluzione mediante le interazioni tra diversi personaggi, che non fossero solo i malati, bensì, come nel mio caso, anche gli operatori e i parenti dei malati. Laddove molti autori della tradizione empirista avevano considerato la malattia come parte della natura, estranea alla cultura, gli studiosi interpretativi hanno posto al centro del loro interesse analitico la relazione tra cultura e malattia. La narrazione, in questo senso, non è solo ciò che viene rappresentato in una storia completa, bensì anche la storia fatta propria dal pubblico (i medici, gli infermieri, i caregivers, i volontari, ecc.), il quale riceve il messaggio ricomponendolo. Ogni discorso, cioè, è pragmaticamente situato nelle relazioni sociali e tutte le asserzioni sullesperienza della malattia sono situate in pratiche linguistiche che fanno parte della narrazione della vita e della sofferenza. La malattia è così il frutto di un modello esplicativo, non unentità, e ogni evento di malattia chiama in causa molteplici contesti e interpretazioni. 35 Così, lobiettivo della nostra ricerca è rimasto losservazione dei bisogni, ma attraverso lanalisi del modello teorico (che nel nostro caso nasce dalla filosofia delle cure palliative) e della ricostruzione e realizzazione dei suoi modelli operativi, il tutto finalizzato a proporre nuove linee guida per lo sviluppo delle competenze professionali degli operatori sanitari impegnati in contesti di medicina palliativa. Parlare di iter standardizzati può certamente provocare perplessità o addirittura disapprovazione da parte di molti, ma ritengo che attraverso lapplicazione di procedure condivise e generalizzabili si possa approdare successivamente a percorsi ad personam, percorsi che mirano al raggiungimento di unelevata qualità di vita inseriti comunque in un contesto ospedaliero, così diverso da quello domiciliare. Ecco quanto mi propongo di fare, consapevole del fatto che in itinere posso trovarmi nuovamente di fronte a cambiamenti anche radicali, ma ritengo che tutto questo sia parte di un percorso di ricerca non fine a se stesso. 36 Il frastuono del silenzio: metafora di un ascolto interiore Maria Francesca Pasinelli Il silenzio ha ancora in sé una virtualità comunicativa e una dimensione di senso? Cosa si nasconde in un silenzio, in uno sguardo che sostituisce la parola e si fa indicibile: si pietrifica in una condizione di silenzio? Cosa si anima, cosa vive, nella persona che ho dinnanzi a me, sana o malata, triste o (almeno apparentemente) gaia, disperata o felice? Non riesco ad avvicinarmi agli altri, ad unaltra persona, se non conosco (se non cerco di conoscere) leffimera, ostinata, realtà del silenzio (E. Borgna, 1999). Nellimmaginario comune, il silenzio rappresenta un fenomeno umano che può assumere differenti significati: esso è percepito in modo negativo quando è intollerabile nel caso in cui rimanda al vuoto dellesistenza, al fatto che può nascondere sofferenza, oppure se rinvia allangoscia di non sapere comunicare agli altri e con gli altri. Talvolta ricorda lattesa impaziente di un incontro grazie alla quale spezzare il gelo della nostra solitudine. È percepito in modo buono, invece, quando diventa necessità di isolarsi dalle chiacchiere quotidiane, quando è auto-riflessione, conoscenza, raccoglimento, altrimenti un mezzo per recuperare la calma e la comprensione per ciò che si sta vivendo. Per altri, psicologi e psichiatri in particolare, il silenzio è soprattutto una chiusura al mondo, la negazione dellincontro interpersonale, un sintomo depressivo, un tempo vuoto. Il titolo di questo mio racconto autobiografico, Il frastuono del silenzio, vuole racchiudere lidea che esso contenga anche elementi creativi, che non sia affatto muto e inesplorabile, privo di suoni e immagini. Mi sono persuasa, al contrario, che racchiuda relazione, discorso, memoria e desiderio se lo si lascia espandere e vivere dentro di noi. Ma da dove deriva questa mia convinzione? Certo, non proviene da letture approfondite di filosofi ma da un discorso più debole e modesto. Da una storia di vita più semplice. In altre parole, è stato generato da una triste esperienza che ha segnato in modo profondo la mia vita, quella di mio padre e dei miei familiari. A mio padre Giovanni, allora cinquantottenne, era stata diagnosticata una malattia inguaribile e degenerativa chiamata Morbo di Alzheimer. È una forma di demenza che a mano a mano ti allontana dal mondo e dalla tua stessa identità. Per chi di voi non conoscesse gli effetti di questa patologia mi basta ricordare che è un precoce e progressivo declino delle capacità cognitive; non come avviene, però, nellinvecchiamento naturale, ma piuttosto, come precoce e rapido decadimen37 to totale delle funzioni corticali superiori. In pratica sono colpite la memoria, la capacità di risolvere i problemi quotidiani, la destrezza motoria. Vengono meno il controllo delle reazioni emotive e la capacità di servirsi del linguaggio per esprimersi e comunicare. Tutto questo comporta una lenta e irreversibile modificazione della personalità e del comportamento. Lammalato non è più in grado di rivestire quei ruoli che prima gli erano propri. Per me, per noi, è stata unesperienza penosa guardare accadere tutto questo. Ho desiderato sfuggire al dolore per quel morire evocato ogni giorno: mio padre stava perdendo tutto il suo mondo e noi perdevamo lui. Noi, come affetti, eravamo divenuti unidea perduta nella sua memoria. Sempre più spesso ho sentito il bisogno di isolarmi da tutto. Volevo nascondermi anche da me stessa. Volevo tacere per non aprire nuove ferite. Così, ricercavo tutte quelle situazioni di solitudine che mi alleviassero la tensione emotiva. Mi allontanavo sperando di trovare il senso di ciò che si stava muovendo dentro di me. Il silenzio si era trasformato in un rifugio in cui rintracciare una percezione più chiara di me come figlia, come madre, come compagna, come sorella. Era diventato un meccanismo di difesa per soccorrere la mia interiorità, confusa dalla cascata di emozioni che mi stavano turbando il cuore e la mente. Il silenzio continuava a scavare nella mia memoria e spine dolorose avevano preso ad affiorare. Con il passare del tempo, però, il rimpianto e il rimorso avevano iniziato a lasciare spazio ad orizzonti nuovi dentro di me, come se i conflitti si fossero ridotti e il cuore avesse riordinato i suoi battiti. È stato là, in quegli angoli di me stessa, che ho iniziato a comprendere quanto il silenzio sia fonte di segni e di indicazioni, quanto sia luogo di trasformazioni e di creatività. Le mie voci interiori avevano iniziato a dialogare e ad esprimere una melodia vivace. Tutto questo anche quando la mia mente mi pareva distante dal mondo. È stato un piacere profondo accorgermi che non ero stata mai sola e che nella natura di certi silenzi abitavano volti e sguardi provenienti dal passato, fatte di una sostanza calda che me le rendevano indispensabili. Altre volte esse mi giungevano sotto forma di fragorosi ricordi, di tracce che continuavano a vivere nella memoria. Parevano giungere da lontananze abissali, un po annacquati dal trascorrere del tempo, ma così luminosi e confortanti per me. Dentro il silenzio, le voci sembravano disperdersi, però, non so in quale modo, esse mi attendevano in un luogo in cui la paura di essere abbandonati non cera. Intanto la malattia di mio padre stava avanzando nel suo processo di annientamento. I primi disturbi comportamentali li abbiamo registrati con assoluta impotenza. La sua disattenzione era fraintesa per disinteresse, mentre la dimenticanza di nomi e di oggetti per un affaticamento psicofisico. Lo spazio che ci circondava per noi restava familiare, ma per lui era divenuto estraneo e minaccioso. Il suo linguaggio si era impoverito ed era diventato faticoso interagire con lui. Anche i suoi gesti avevano perduto in precisione e 38 in finalità. Le chiavi di casa, per esempio, erano divenute degli oggetti misteriosi e inutili perché per mio padre avevano perduto il loro scopo. Il deterioramento causato dalla malattia si era aggravato fino alla comparsa di una sindrome, detta agnosia. Un fenomeno mortifero perché esso si era manifestato con lincapacità di riconoscere i propri cari, con limpossibilità di riconoscere anche le parti del proprio corpo. Il mio dolore si appoggiò ad altro dolore. La morte strappava via brandelli di vita, di identità, di speranza. Fare i conti con la sua perdita è stata una sofferenza. Smettere di attendermi reciprocità è stato altrettanto amaro. Trasformarmi da figlia in madre nei suoi riguardi è stato prima innaturale e insolito. Poi è stato inevitabile e necessario. Questo è stato un altro passaggio di cambiamento importante, infatti quando le parti vecchie di me hanno accettato di morire, quando le mie attese si sono rimpicciolite, ho compreso che potevo provare a relazionarmi con lui in modo diverso. Tentare di ascoltare in modo nuovo i suoi farfugliamenti, di leggere i movimenti espressivi delle sue mani, di cogliere quale sguardo era ancora vivo nei suoi occhi e cosa comunicasse. Mi sono addestrata a decifrare emozioni di cui prima avevo paura, a fare esperienza di nuovi gesti e di sguardi nuovi con i quali avvicinarmi in modo migliore al suo bisogno. Più di ieri, oggi mi è difficile non avvertire quanto mormorio faccia il silenzio dentro di me. Ma nel silenzio si possono ascoltare voci segrete, voci che giungono da un altrove misterioso, voci dellanima che nascono dalla più profonda intimità e che portano con sé nel nostro mondo, significati e risonanze talora indecifrabili che lermeneutica ci aiuta a decifrare (E. Borgna, 1999). In questo modo, durante la malattia di mio padre, il silenzio non mi è più parso privo di significati, ma è divenuto un elemento prezioso che ha segnato in me un profondo cambiamento, non solo perché ha ripulito la memoria dalla pesantezza, ma perché mi ha anche consentito di rielaborare quegli aspetti lasciati nellombra e mi ha permesso di narrare la nostra storia con gli occhi addolciti dal ricordo. Quanto vissuto personalmente, quanto conquistato con fatica nel corso degli anni, quanto elaborato durante la malattia di mio padre, vale a dire la trasformazione del silenzio da sofferenza e distacco dal mondo ad occasione di rinascita e sviluppo, ha ottenuto unulteriore conferma durante lesperienza vissuta allhospice. Lanno scorso, in occasione del corso universitario di Pedagogia Sociale del prof. Lizzola ho scelto di partecipare, insieme con altre compagne di corso, ad un seminario organizzato presso la struttura dellhospice. Il motivo di quella mia scelta presumo avesse in sé più ragioni: alcune della mente altre del cuore. Forse andavo semplicemente alla ricerca di un 39 confronto con la morte e con il morire degli altri. E mi domandavo quanto tempo occorresse per elaborare il lutto di una perdita e quanto coraggio per accettare il nostro destino umano. Mi tornano alla mente i pensieri illuminanti di Gadamer a proposito delle malattie gravi: Oggi, le malattie terminali e croniche rivestono sempre più un ruolo di primo piano nellinteresse medico perché non si è in grado di eliminarle. In realtà il più cronico, fra tutti i malanni, è la via verso la morte. Imparare ad accettare questa nostra lontana destinazione rappresenta il massimo compito delluomo (H. G. Gadamer, 1994). Così, durante quellesperienza allhospice, mentre attendevo che il tempo, le circostanze e gli incontri mi aiutassero a comprendere la vita, ho ritrovato alcuni aspetti che mi hanno rimandato alla natura di certi silenzi, di certe attitudini e di certe elaborazioni che ho vissuto durante la malattia di mio padre. Pure in quel luogo il silenzio era sorprendentemente carico di segni e di significati nuovi. Oltre a ciò il personale era impegnato a percepire il paziente non come un caso clinico al quale somministrare semplicemente dei farmaci per lenire la sua sofferenza, al quale fornire unassistenza congelata nelle procedure rassicuranti, bensì era vissuto come una persona cara a cui prestare il giusto ascolto, la giusta sensibilità umana. In questa casa istituzionale ritrovavo una partecipazione e un affetto che sembravano intrecciare storie di vita in cui la morte dellaltro diventava anche la propria morte (quella degli operatori, dei volontari, dei parenti ) proprio perché il paziente non era sentito come una persona estranea di passaggio nella propria attività di cura, ma era vissuta come un possibile fratello o una probabile sorella. Gli operatori non erano impegnati a guardare solamente con gli occhi della ragione tecnica, ma anche con occhi del cuore per accogliere nel silenzio i bisogni del malato che chiede di essere soprattutto accolto e compreso. Allhospice, attraversando i corridoi del reparto, raccolta nel pudore che il luogo mi suscitava, ho sperimentato frastuoni teneri di voci affettuose degli operatori e dei parenti rotolare nellaria delle stanze, per poi guizzare fuori a contaminare laria di slanci di umanità e di dedizione. Ho percepito una moltitudine di suoni sgorgare da quelle mani e da quegli sguardi: frastuoni amorevoli di premure e di ascolto, di sensibilità e di condivisione per colmare quello spazio abitato dalla tribolazione e dal dolore. In quel frammento di tempo trascorso allhospice, per cercare una risposta alle mie domande, ho udito un frastuono tale dumanità che per analogia mi ha ricordato una delle tante corsie dospedale in cui i bimbi appena nati gorgheggiano pianti e strillano gioia. Dopo tutto anche dove si muore il rumore dellaffaccendarsi della vita non cessa mai di esprimere il suo mistero. Mi sto convincendo sempre più del fatto che nelle azioni di cura le parole 40 sono talvolta inutili perché dicono troppo o troppo poco. Contano di più i gesti e gli sguardi. Conta di più la leggerezza del cuore e lincontro con lumanità. Principalmente là, nei luoghi in cui la vita si affaccia e negli altri in cui la vita si congeda. Forse penserete che le mie considerazioni non sia altro che labbandono ad un esercizio immaginativo, ma mi piace credere che se daremo ascolto a chi ha bisogno di una mano amica, come ci suggeriscono le parole di una splendida poesia, ci sarà possibile udire il frastuono delle loro esistenze e della loro unicità. Il mondo ha un volto darsura Per chi si ferma a morire: imploriamo rugiada: anche la gloria ha un arido sapore. Le bandiere tormentano un morente, ma un piccolo ventaglio, se mano amica lagiti rinfresca come pioggia. Chio sia al tuo fianco, quando la tua sete verrà, per recarti la tessala rugiada e i balsami iblei. (E. Dickinson, 1995) 41 42 Percorsi condivisi Giovanna, Franca, Cinzia, Gabriella Nella nostra società spesso succede che, chi perde una persona cara, può contare unicamente su risorse e capacità psicologiche personali: il lutto è vissuto in effetti come un fatto privato, un problema individuale. Al contrario in passato, i riti e le forme del lutto avevano la funzione di permettere e facilitare lespressione del dolore soggettivo attraverso un sostegno psicosociale. Oggi viene a mancare lappoggio della comunità, delle istituzioni e si ha quindi una maggior difficoltà nel superamento del lutto. Gli operatori e i volontari allinterno di unéquipe di cure palliative, prendendosi cura non solo del malato, ma anche di tutta la sua famiglia, si fanno carico di sostenere i familiari nellaffrontare la perdita del proprio caro attraverso la possibilità di condividere i sentimenti e creare una relazione di sostegno, uno spazio di ascolto e di espressione che li accompagnerà anche in seguito nella fase del lutto. Il sostegno al lutto è quindi parte della continuità di cura, per cui laiuto fornito alla famiglia durante il periodo di malattia terminale non sarà soltanto di beneficio nellavvicinarsi dellevento finale, ma avrà anche un significato nel lungo periodo. La presenza di volontari nella fase immediatamente successiva al decesso può essere di grande aiuto ai familiari anche solo nelle attività più semplici, come far fronte ai problemi pratici o attraverso quel sostegno empatico che permette loro di esprimere lo stato danimo del momento, sia esso tristezza, dolore, rabbia o pianto. In hospice accade spesso che tra volontari e parenti si instauri una relazione empatica tale da consentire un accompagnamento che continua anche dopo il periodo del lutto attraverso relazioni di tipo amicale o semplici contatti telefonici. Da queste singole e spontanee esperienze è nata lidea di costituire un gruppo in grado di fornire sostegno ai familiari, basandosi sullesperienza dellauto mutuo aiuto. Ma perché un gruppo per elaborare la perdita? In primo luogo perché il gruppo ha un forte potenziale terapeutico che consente di rompere la solitudine, con cui si vive in genere lesperienza del lutto, e di recuperare una ritualità di condivisione. Lobiettivo è quindi quello di ridurre il vissuto di solitudine e di isolamento sociale attraverso la condivisione con compagni di viaggio con cui poter 43 imparare a riconoscere e a tollerare il dolore della perdita, mediante la creazione di uno spazio di ascolto attivo, paritario e quindi di sostegno reciproco. Laiuto che si dà e che si riceve permette di far emergere il bisogno umano di comunicare, di manifestare il proprio pesante carico emotivo interiore, che spesso non si può esprimere allesterno perché familiari e amici non lo tollerano troppo a lungo. Il gruppo raccoglie esperienze di vita di ogni partecipante, perciò la relazione di aiuto non è unilaterale ma reciproca ed è basata sul confronto e il sostegno fra persone che stanno vivendo, od hanno vissuto, realtà simili. Il gruppo è aperto: può accogliere in ogni momento nuovi partecipanti, i quali possono trovarsi in fasi differenti del processo di elaborazione. Ogni persona può esprimere liberamente le proprie emozioni, le proprie sensazioni sicura di essere accolta, ascoltata con attenzione e rispetto e, più di tutto, in assenza di giudizio. Parlare del proprio dolore con chi ci può comprendere, perché sta vivendo lo stesso problema, aiuta ad imparare a convivere con la sofferenza e a ritrovare un nuovo equilibrio. La presenza dei volontari, necessaria in fase di attivazione del gruppo, continua poi quale elemento garante, partecipe, mai giudicante e come riferimento della memoria e dell esperienza di crescita del gruppo. Con il tempo la partecipazione al gruppo fa nascere amicizie, vere relazioni daiuto, e, facendo tesoro delle esperienze comuni, si è portati ad affrontare nuovi percorsi per essere daiuto ad altri, con sofferenze più recenti e acute, non per dimenticare, ma riuscendo a trasformare il dolore in una risorsa utile per sé e per gli altri. Riportiamo la testimonianza diretta di uno dei due gruppi di auto mutuo aiuto, costituitosi a Bergamo circa un anno fa, per lelaborazione e il superamento del lutto: Siamo in nove (casualmente solo donne), qualche volta sette o otto se ne manca qualcuna, intorno a una tavola rettangolare, ma sarebbe meglio chiamarla tavola rotonda perchè qui nessuno presiede, nessuno interpreta, nessuno insegna: siamo tutte eguali e diverse con il carico della nostra esperienza personale. Intanto ci guardiamo, dopo esserci salutate vociando affettuosamente, e di nuovo incontriamo le nostre immagini a distanza di una settimana dallultima riunione. Ognuna custodisce un lutto proprio o lesperienza del dolore altrui al quale si è avvicinata per condividerlo. Infatti, tre del nostro gruppo, Cinzia Franca e Giovanna, sono volontarie dellAssociazione Cure Palliative, e il loro compito implica anche lassistenza e il supporto ai parenti degli ammalati in fase terminale e dopo il decesso. Hanno contribuito allavvio del gruppo e frequentano i nostri incontri per meglio comprendere le dinamiche psicologiche del lutto e del suo superamento. Inoltre cè Miriam, assistente sociale, una giovane, silenziosa presenza che fa gli onori di casa, poichè siamo ospiti nella 44 sala riunioni dellAssociazione Paolo Belli. Questo manipolo di donne che ha scelto dincontrarsi una volta la settimana, costituisce uno dei due Gruppi A.M.A. in Bergamo per lelaborazione del lutto, vale a dire un gruppo di auto- mutuo-aiuto nato per spontanea aggregazione al termine di due serate di convegno durante le quali avevamo appreso che cosa sono i gruppi e le loro diversificazioni, i loro scopi e la loro caratteristica di base: essere un incontro libero, informale, paritario, fra persone che desiderano parlare dei loro problemi o ascoltare le esperienze di altri. Non ci sono psicologi fra noi; non ci sono neanche esperti che interpretano le situazioni e le reazioni a modo loro: siamo libere di parlare, ascoltare o essere semplicemente presenti. Questa parità, questa libertà di parola a poco a poco aiuta anche quelle fra noi che hanno difficoltà ad aprirsi, a intervenire, a dire la loro storia e il loro magone, genera una corrente di simpatia che non è invasiva ma si percepisce e genera una comunicazione spontanea e amichevole. Il nostro gruppo è dedicato non solo alla elaborazione e superamento del lutto, ma anche della perdita in senso più ampio, sia essa di familiari che di amici, di un amore, di un lavoro, di qualcosa che ha rappresentato molto nella vita. Sono infinite le perdite che si possono totalizzare nellesistenza di ognuno. Talora sono perdite antiche e misconosciute, come quelle che ci hanno colpito nellinfanzia o nelladolescenza, talora abbiamo sofferto per sensi di colpa, tradimenti da parte di chi godeva della nostra fiducia. Sono momenti che hanno segnato più o meno profondamente la nostra anima e dei quali non cè né tempo né costume di parlare. Ma resta tuttavia il bisogno, un bisogno profondo spesso ignorato nei rapporti con familiari e amici. E qui noi parliamo. Rivisitiamo la nostra vita. A ruota libera, in italiano o in dialetto, riandando a episodi dapprima vicini e penosi, poi, quasi superando momentaneamente il dolore, ci raccontiamo a vicenda, camminiamo su e giù nella nostra vita ricordando episodi dimenticati, anche buffi, mostriamo delle fotografie, esterniamo la nostra fede o i nostri dubbi, con una libertà che, forse, non abbiamo conosciuto prima. Perché di questo si parla: si parla della vita. Possono sembrare chiacchiere di donne, che qualche volta sono un po garrule, ma tutte avevamo gli occhi lucidi quando Marinella con la sua parlata bergamasca ci diceva come in poco più di un mese avesse perduto marito e figlio: ol me scet, singhiozzava il mio ragazzo. Oppure mentre Carla, uscendo da un silenzio di anni, riandava pacatamente alla perdita del figlio, dolore che non aveva potuto nemmeno condividere col marito. Oppure ancora, quando Antonella e Marcella rievocavano le ultime ore vissute con i loro uomini, luna con la serenità della fede, laltra con lo smarrimento umano di un dolore recente e palpabile. Chiacchiere inutili, fine a se stesse? Qualcuno può anche porsi queste domande, ma noi no. Da che ci incontriamo abbiamo visto risultati promettenti: alcune di noi, che allinizio si limitavano a ascoltare, non tengono più il dolore murato nel loro intimo, ma parlano, si raccontano, sono più sciolte e quasi rifiorite nel vestire, nella cura di se stesse. Piccole cose, ma segni della vita che riprende. E, quando usciamo dalle nostre riunioni, siamo più serene, più leggere. Sembriamo un gruppo di ragazze che camminano più spedite e a voce alta si danno appuntamento per fare una passeggiata o bere un caffè insieme. Ci telefonia- 45 mo, dice una. Ci sentiamo, risponde laltra. E questo è un modo di dirci che possiamo chiamarci durante la settimana, sentire una voce amica. Sappiamo bene che ci sono lutti, perdite incolmabili come un pozzo profondo; ma giorno per giorno, quasi goccia a goccia, lacqua della vita riaffiora. 46 Insieme in silenzio Chiara Soloni Vado in un posto lontano Dove non può venire Nessuno di voi. Marco, 8 anni (M. Jankovic, 2004) Una vacanza inattesa, in un periodo diverso dallusuale: ottobre, con tuo marito e tuo figlio che cresce a vista docchio. In questo momento così strano, la partenza, ricevo un messaggio sul telefono: Da questa mattina Laura correrà nei giardini del Paradiso. Mi crolla un masso addosso. Silenzio. Riemerge la professione che amo.Sei sempre medico, mi dico, anche in vacanza. Laura è una bambina di non ancora tre anni, non ha mai potuto imparare a correre, da più di un anno lotta contro una malattia inguaribile, mamma e papà lottano con lei. I genitori, giovani e belli, hanno fatto la coraggiosa scelta di riportare Laura a casa: hanno rivoluzionato appartamento, ritmi quotidiani e lavorativi per vivere la loro vita familiare. Sette intensi mesi sono trascorsi fino a quando, e non vorresti mai succedesse, Laura senza disturbare nessuno è passata dal sonno al sonno perenne. Mamma e papà hanno trovato Laura che dormiva. La morte fa star male tutti, non si è mai pronti, quando poi riguarda un bambino è ancora più triste, annientante. Come medico mi arrabbio: bisogna combattere; come medico neo palliatore mi dico: curare si può e si deve; come mamma ci sto male e penso al nostro bambino. Quando unisco tutte queste cose mi dico: impara e ascolta questi bambini che lottano per la vita, impara da questi genitori così coraggiosi che soffrendo supportano e incoraggiano questa loro piccola vita che li sta abbandonando. Cosa dirà un bambino che si ammala? Cosa penserà della vita quando avrà dolore? Cosa penserà dellUomo quando gli metterà addosso delle macchine che lo aiutano a vivere ma che gli danno anche fastidio? Cosa penserà un bimbo malato quando non avrà le forze per ridere, giocare, colorare, correre? Come staranno mamma e papà quando vedono la loro creatura così? Cosa augurare loro? Solo la silenziosa presenza può essere preziosa. 47 Io non voglio morire Ma ho paura di vivere. Edoardo, 7 anni (M. Jankovic, 2004) Claudia è una piccola bimba che è arrivata con una bella vestina bianca di pizzo Sangallo, confezionata da una nonna, proprio per loccasione del trasferimento dal reparto al nostro hospice. Claudia è una florida bimba di due anni appena compiuti, resterà con noi meno di due mesi. Ha una mamma sorridente, ha promesso alla sua bimba di sorridere sempre e di cercare di essere serena. La fatica di cercare di essere serena con Claudia è immensa, la mamma è forte e molto grande nei confronti della malattia di Claudia ma anche di tutte le altre vicissitudini correlate. La mamma di Claudia nonostante tutto riesce ad essere sorridente. Ci si sente veramente impotenti di fronte a qualsiasi sofferenza soprattutto di fronte a chi non può dirti ciò che sente. Di fronte a tutto ciò non resta che condividere la sofferenza interiore. Sollevare dai sintomi apparenti i bambini e far sentire loro lamore, il calore della nostra presenza. Amore e calore per i piccoli e presenza per mamma e papà che non devono sentirsi soli nellaffrontare questo travaglio della morte. Presenza fatta di silenzi, di discorsi chiari e concisi, di verità dette fuori dai denti, di impegno medico-sanitario a ridurre i sintomi del bambino, presenza anche di condivisione della fatica quotidiana e della sofferenza che è anche dei sanitari. Non ci si può abituare alla sofferenza in generale e tanto meno a quella di un bambino, come fare per aiutarlo? Lascolto deve essere alla base della nostra terapia: ascolto del bambino e della famiglia, ascolto non solo delle parole ma di tutto ciò con cui noi comunichiamo: corpo, volto, occhi, mani, disegni, carezze, scatti dira, silenzi, musiche, pianti. Ascoltare in silenzioso rispetto tutto ciò che i bambini ci dicono. 48 DRAMMATIZZAZIONE Testi tratti da Il libro dellhospice Associazione Teatro dOccasione di Bergamo Attori: Ferruccio Giuliani, Paola Guidotti, Sara Medini, Renata Pozzi Diego Rovetta, Giovanni Soldani Alle percussioni: Oliviero Cossali Alle tastiere: Oscar Cossali Regia: Piero Marcellini 49 La terra è intrisa di pianto. Sono le lacrime nostre. La rugiada della terra. Per me invece tutte le stagioni Stillano lamara pece dei pioppi Troppo colpiti dalla bufera. A me il sole rovina le mani Il viso, produce altra sete, mi fa dentro il deserto. Il melograno è già fiorito: Il mattino riprende carne Nelle dolci fragole. Il sole è vino per la lucertola, ubriaca se ne sta tutto il giorno sulla pietra sola paura la presenza delluomo Sono un stelo arso Un albero bruciato In mezzo a una brughiera: almeno sul ramo più scarno una cicala cantasse! (David Maria Turoldo) Sara Cara Kika, sono grata al Signore per averti conosciuto: con il tuo impegno tenace hai realizzato un grande sogno: lhospice, struttura pubblica che rende più civile e serena la morte di pazienti afflitti da molte sofferenze, ma soprattutto hai rappresentato per i volontari un punto fermo e un esempio di coerenza, anche quando la tua malattia progrediva. Per questo non mi lamenterò di averti perso: ringrazierò di averti avuta. Perché il perdere è una vicenda contingente, ma lavere è assoluto. Adesso credo che tu sia in un posto tranquillo; ma sono certa che continuerai a vivere dentro il cuore di chi ti ha voluto bene. Erika. Giovanni Si dice che alla fine della vita bisognerebbe scrivere un libro. Per raccontare la tua (sacrifici, sofferenze, tribolazioni, fatiche) ce ne vorrebbero almeno due. Davide Renata Carissima Kika. Senza di te, la mia presidente, io mi sento smarrita e orfana: non ho più il mio punto di riferimento, che eri tu, Kika. 50 Ho un rammarico: quello di non averti potuto abbracciare per lultima volta. Però tu lo sai: nella camera ardente ho potuto rivederti per poco, il tempo utile per darti un bacione sulle tue guanciotte. Riposa in pace, piccola, lassù nei Campi Elisi! Arrivederci. Giulia Paola Cara Kika, troppo presto ci hai lasciato; ma il tuo esempio rimarrà in noi. Spero che tu da lassù continuerai a illuminare le nostre menti e i nostri cuori per proseguire il cammino che tu con tanto amore ci hai insegnato. Da unamica, che sperava proprio che tu ce la facessi a sconfiggere quel brutto male, un grande abbraccio. Marta Sara Kika, hai affrontato la tua malattia con un coraggio e uno spirito davvero ammirevoli. Lamore, la tenacia, la grande realizzazione dellhospice e quanto hai fatto per la tua e nostra associazione resteranno per sempre nei nostri cuori. Grazie. Patrizia Renata Con te, nocchiero di questa barca, viaggiavamo sereni. Ora, da dove ci proteggi, illumina la rotta da te intrapresa per farci continuare il tuo e il nostro viaggio in mari tranquilli. Silvia. Amaro poeta, sul tuo stelo riarso si è posato un fiore, sul ramo scarnificato dalla sofferenza si è posata una cicala a cantare lestate. Paola e Sara Il est arrivé ce moment où les anges vont venir te chercher. Tu les as tant priés durant toutes les années de ta vie. Ils tenméneront, et maintenant avec eux tu pourras briller dans le ciel, pour léternitè. Una nouvelle étoile va naitre dans linfini ciel: grace à leur venu, ce sera toi qui me regardera au travers des nuages! È arrivato il momento in cui gli angeli vengano a cercarti. Tu li hai tanto pregati per tutti gli anni delle tua vita: essi ti accompagneranno, e ora con loro tu potrai brillare nel cielo per leternità. Una nuova stella sta nascendo nel cielo infinito: grazie alla loro venuta sarai tu che mi proteggerai attraverso le nuvole! Claire 51 Per nuotare ci si spoglia; per aspirare alla verità bisogna sbarazzarsi degli abiti in un senso assai più intimo: ci si deve spogliare di un abito molto più interiore, fatto di pensieri, di idee, di egoismo e di cose simili, prima di poterci dire svestiti abbastanza. (S. Kierkegaard) Ferruccio - Chi scrive questa lettera è la mamma di Giorgio. Renata Ve lo presento: Giorgio ha 33 anni. È un angelo. Ringrazio Dio di avermelo dato. Il percorso della sua vita è stato molto tortuoso: Dio gli ha dato prove molto pesanti da affrontare. La cosa più bella è che il mio angelo le ha sempre affrontate con serenità, pur tra molte sofferenze. È meraviglioso: sapete perché? Nonostante lui fosse al corrente della sua malattia, aveva pure la forza di sostenere i suoi genitori. Si trovava in questa clinica (io avevo un rifiuto per questa struttura, ma mi sbagliavo). Ora devo ringraziare tutte le persone che ci lavorano e che hanno aiutato a passare sullaltra sponda con dignità il mio Giorgio. Oggi 13 gennaio 2005 termino questa lettera con un nodo alla gola e il cuore a pezzi: il mio adorato Giorgio è giunto sullaltra sponda. La mamma Francesca. Diego Oggi il mio babbo ha avuto la brillante idea di lasciarci se nè andato allEden, lui lha meritato. Sono fortunato ad avere un papà come lui. Simone Giovanni Ciao, Mamma! Ti stai spegnendo lentamente e io ti sto accanto. Con me sei stata una madre perfetta, ma mi stai salutando troppo presto: molte cose avevo ancora da dirti e da fare insieme a te. Sei sempre stata una donna forte, anche per tutte le sofferenze che hai patito: mai un lamento, sempre un sorriso sul tuo viso dolce; soprattutto eri sempre pronta a fare sorridere gli altri. Ora guarderò il cielo, e vedrò una nuova stella brillare: quella stella sarai tu, la mia mamma! Viviana Sara Ciao, nonno Angelo. In questo momento di grande dolore per la nostra famiglia, le emozioni parlano più delle parole. È difficile accettare certe cose che qualcuno definisce normale processo fisiologico dellesistenza umana. Eh, sì: è proprio difficile; soprattutto se queste cose arrivano allimprovviso e troppo presto. 52 Forse, però non esiste un troppo presto o un troppo tardi: forse esiste solo il fatto che Dio ha bisogno di una persona forte e di carattere accanto a sé per affiancarlo nelle sue decisioni, e credo che quella persona sia tu. Ci hai dimostrato, in questo periodo, cosa vuol dire vivere la vita, avere il coraggio di affrontare gli spazi bui che questa ci riserva. Il coraggio può assumere varie forme, ma il coraggio più nobile è quello di saper affrontare il dolore, di vivere ogni istante con grande tenacia e carattere, sempre a testa alta. È proprio questo coraggio che mi hai insegnato, e spero di saperlo avere anchio. Ma sono certa che il ricordo della persona che sei stato e che sarai sempre per me e per tutta la famiglia, prevarrà sulle paure e sui dubbi che la vita ci pone davanti. Ti mando, nonno, i più bei fiori del mondo. Ornella Diego Ricordo di aver letto che i fiori sono fragili e muoiono in un soffio quasi come i giorni in una vita, ma se ne hai cura dai tu un senso alla loro breve vita. Salutaci la mamma e continua a divertirti con noi. Con tutto lamore. Anna, Serena, Paolo Giovanni Ciao, mamma. Nel giorno del tuo compleanno ti sei addormentata, per affrontare un lungo viaggio verso un mondo diverso da quello terreno, dove potrai di nuovo essere vicino a tuo marito. In questi giorni di sofferenza ti ricorderò per la tua continua voglia di voler andare. Andare dove? Solo tu lo sapevi: probabilmente volevi ribellarti a ciò che ti costringeva a restare in un luogo dove tu non accettavi di stare. Piero Bisogna dir sempre ciò che si vede. Soprattutto bisogna sempre, e qui è difficile, vedere ciò che si vede. (C. Péguy) Paola Due mani ti accarezzavano e il tuo viso piano, piano da sofferente diventava disteso e sereno. Hai sofferto il male in silenzio, e ora non soffri più. Ti voglio bene, mamma. Anna Paola Non è stata la tua una morte dolcissima, perché non può essere in alcun senso dolce morire a 44 anni. Ma te ne sei andata con dignità e rispetto, lasciandoci nel cuore un po della tua forza. Daniela 53 Leternità non è una specie di aggiunta futura alla vita, di prolungamento della nostra esistenza allinfinito; essa si trova già nellintimo delluomo, frutto del suo agire spirituale. (K. Rahner) Sara Ciao, Matilde. Questo non è un addio, ma certamente un arrivederci. Hai tanto sofferto e Dio ti ricompenserà. Da lassù prega per tutti i tuoi cari che hanno molto sofferto per la tua lunga e dolorosa malattia. Incontrerai coloro che ti hanno preceduto e sarai tanto felice. Sarai avvolta dalla luce e consolata tra le braccia del Padre di tutti noi che non abbandona i suoi figli. Antonietta Renata Caro Enrico, sono le tre del mattino, e tu stai finalmente riposando sereno. È bello essere qui con te e Sara, ancora come quando eravamo bambine. Spero che la tua sofferenza non duri a lungo. Sono sicura che mamma e papà, che tanto ti hanno amato, ma poco goduto, ti prenderanno con loro dove avrai per sempre pace e serenità. Un forte abbraccio. Laura Sara Un pensiero che non posso più tenere dentro per un amico. Povera è questa vita terrena se non la riempi con i sorrisi, anche se ci è stato concesso poco tempo. Grazie per tutti quelli che mi hai regalato sfumati nel tempo, prima con tutti i muscoli del viso poi con la bocca, con gli occhi, con la tua mano stanca che stringe la mia. Sto pregando con tutto il cuore, anche se è difficile quando sanguina così forte, ma continuerò, continuerò a farlo. Se il tuo destino è di non risvegliarti più, non ti preoccupare: non finirà qui: ci sarà sempre un sorriso per te. Ti porterò con me nei miei pensieri e nei miei sogni, ti parlerò con la voce del cuore, sicura che tu mi ascolterai quando ti dirò: ti voglio bene. Annarita Diego Lunico dono che posso farti in questo momento di intensa sofferenza sono i miei pensieri, i nostri pensieri damore e di gratitudine. A te che con il tuo sacrificio e la tua dolcezza hai cambiato per sempre le nostre vite; a te che sei riuscita ad aprirci gli occhi e il cuore; a te che, senza saperlo, ci hai salvato dallindifferenza e dallegoismo. A te piccolissimo angelo doniamo i nostri pensieri più sinceri e puri perché il tuo ricordo ci accompagni per sempre e il tuo esempio ci aiuti ad affrontare con coraggio ogni 54 giorno. Nel tuo esempio vivremo e sperimenteremo la gratitudine verso lesistenza che spesso ruba le cose più preziose, ma altrettanto spesso ci dona incommensurabili gioie. Sono gli ultimi momenti in cui possiamo vederti e sentirti e proprio ora, proprio, adesso che ancora ti sentiamo vicina, lasciamo traccia del tuo amore per te su queste pagine perché rimangano a testimonianza di quello che hai rappresentato per noi. Con infinito amore. Giulio Ho visto il corpo di una madre morta piangendo: sul suo volto le lacrime avevamo scavato due lunghi solchi. Quei solchi mi hanno condotto alla soglie dellestate, in attesa che una cicala prendesse a cantare. Ho visto il corpo di un bambino simile a quello di un angelo al quale fosse stato permesso di morire: sembrava attendere di essere chiamato. Quel corpo di angelo mi sembrò per un attimo la farfalla pronta a prendere il volo nel cielo dellestate. Paola Ricordo, Maria, una favola. Un angioletto volava basso, sempre più in basso. Sfiorò la terra, si ruppe le ali e per lui non ci fu più domani. Gesù, che da lassù vide ogni cosa, fece preparare in cielo una culla nuova, dove langioletto potesse dormire vicino a Lui, felice e benedetto. Una nonna che ti pensa in paradiso. Sara Ora il pensiero torna a te, zio Luigi. Non riesco a comprendere nemmeno ciò che sta accadendo. Da quel giorno tutto è cambiato: ieri eri felice e sorridevi, mentre fumavi riscaldato dal sole dellestate. Oggi sei qui in un letto da dove la malattia ti porta via lentamente. Non riesco nemmeno a credere che per te ora non cè più nulla da fare: ieri mi aiutavi nei compiti, al fresco dellombra estiva; oggi, al freddo dellinverno, tu sei lì. Oggi mi rendo conto che sono stata fortunata a conoscerti. Matilde Paola Ciao, nonna. Oggi che te ne sei andata, so che mi volevi tanto bene. Mi mancherai tanto. 55 Ricordo quando mi facevi ridere con le tue battute scherzose, quando mi insegnavi a ballare. Nonna, ti ho sempre voluto bene come i tuoi figli. Nonna, tu eri come la mamma per me. Ti voglio tanto, tanto bene. Patrizia Diego Cara vita, dopo trentatré anni di gioie soddisfazioni e liete sorprese, ieri, per la prima volta mi hai tolto qualcosa di veramente importante: mio padre. È vero: tra me e lui cè sempre stato un rapporto freddo e distaccato, ma sempre pieno di rispetto reciproco. Ora già mi manca, così come mi mancheranno le tante occasioni avute e mai colte per incontrarci. Sapevo che sarebbe arrivato questo momento e me ne assumo la responsabilità che mi spetta. Però voglio dirti vita che, nonostante tutto, ogni giorno che passa tu sei sempre più bella da godere in ogni secondo che trascorre E auguro a tutti coloro che leggeranno questa pagina di saper accettare sempre con un sorriso tutto ciò che tu vita riservi nella buona e nella cattiva sorte. Carlo Uomo: il tempo era sempre infinito prima che tu venissi al mondo e sarà infinito quando tu lavrai lasciato. Che cosa è tra due infiniti la tua vita? Un punto. Renata Nella notte delle stelle cadenti, il nostro sguardo non è rivolto al cielo, ma sul tuo viso luminoso; la luce che ne emana scende direttamente in fondo al mio cuore, mi fa dimenticare tutte le sofferenze e le amarezze che ci circondano. È strano: quando ti guardo non riesco a essere triste; è talmente tanta lenergia che trasmetti, che cancella tutti i miei tristi pensieri. Lunica cosa che mi viene spontanea è quella di sorriderti e di accarezzarti dolcemente il viso. È strano che un piccolo esserino come te sia riuscito a smuovere tanto amore intorno a sé. Vai stellina vai lontano e con la tua luce veglia su di noi. Alice Tutto quello che ho veduto minsegna a confidare nel creatore per tutto quello che ho veduto. 56 Sobrietà Ivo Lizzola Lincontro è sempre una ferita e lo ricorda uno psichiatra umanista come Eugenio Borgna: riprendendo lezioni profonde e delicate di filosofe come Simone Weil e Maria Zambrano. Perché ogni incontro è rischio e realtà di separazione e distanza, è parziale incomprensione. Specie quando le condizioni tra noi sono radicalmente diverse, e lasimmetria è marcata. Sempre è così nella relazione di cura, quando il corpo malato un poco ti rinchiude ed isola mentre ti riconsegna in mani daltri. Mani che applicano terapie, intervengono, operano. Su un corpo daltri, con un sapere esperto, tecnico. Necessariamente distante. E, insieme, mani che toccano e riconoscono, che si scusano, ascoltano, restano sospese chiedendo permesso. Approssimandosi allaltro nel suo momento, nel suo spazio. È importante arrivare in ritardo, un poco dopo: per poter ascoltare, rispondere, non invadere. Con un troppo di iniziativa, di buone intenzioni, di desiderio di alleviare o consolare, spesso non si riconosce, non si rispetta, si ferisce. Un poco lasciando spazio, e tempo, in sola prossimità, leggera e attenta, lincontro con chi è malato, o muore, può mantenere la promessa sentita nascendo: non sarai lasciato solo, abbandonato. Né preso. Non ha senso, davanti o accanto al morire, reagire facendo. Quasi dovessimo nasconderci quello strano senso di colpa che sottilmente resta dentro: per essere i salvati, i sopravvissuti; per non riuscire a salvare. Il nostro agire è costretto a uscire dalla ricerca di una razionalità e di una efficacia emancipativa; e deve lasciare la presa: non può provare la disponibilità dellaltro (come quando lavoriamo o educhiamo, o operiamo su di lui). Il nostro agire è solo presenza, testimonianza, nel varco dellesistenza, in un movimento non costitutivo (come quando applichiamo terapie) ma riconoscente, recettivo. Sobrio. In questa sobrietà si può riguadagnare il senso del limite e lattenzione allambivalenza delle nostre presenze e dei nostri gesti, alle nostre ombre e al mistero. Compimento e in compiutezza di noi e dellincontro tra noi: promessa, annuncio, sola bellezza e solo dono, sulla-venire. Come laurora: lo scricchiolio della luce, di padre David Maria Turoldo nelle poesie ultime, del suo finire. Lessere dellaltro appare quando trova nel nostro sguardo quella luce aurorale che consente il suo disvelarsi, perché lo sguardo, attento, si curva sul suo apparire (M. Zambrano, 2000). La sobrietà fa toccare, così, qualità pro57 prie di quella che la Weil chiama «azione non agente»: quellazione che non pretende di fare o di portare il Bene, ritenendo di possederlo o realizzarlo, quellazione fosse anche uno sguardo che non tende a un fine ma si vive sospesa e in ascolto della realtà nella sua datità offerente (S. Weil, 1985). La sobrietà, modo di vivere lobbligazione è, allora, lasciarsi interrogare e chiamare in responsabilità. È una forma controcorrente di cogliere le opportunità: perché il perdere non è visto nel lasciare, il perdere è visto nel prendere. Farsi poveri di conoscenza, di presa sul mondo e sullaltro (anche se giustificata per il suo bene) fa stare nellessenziale, aperti allaltro, in estrema vulnerabilità. Come in esilio, perché appaia limmensità, esposti al racconto dellaltro basta qualche scintilla di vulnerabilità per stare in presenza, e nella cura (M. Zambrano), come sanno bene molti operatori sociali e della sanità. Voler essere pienamente, senza vuoti, nelle cose e presso altri è invece cedere alla tentazione dellesistenza, così bene messa in luce da Zambrano. Vale la pena cercare un pensare capace di sentire, non depurato dalle emozioni; senza arrendere la scienza al sentimento assegna valore epistemico a quel pensare che si nutre [anche] del sentire; perché solo quando si nutre di sentimenti la ragione è capace di stare alla ricerca della verità (L. Mortari). E la decisione è capace dessere rispettosa del vissuto altrui riconoscendo un altro a cui è consentita una resistenza etica, una trascendenza. In un tempo in cui donne e uomini sono frequentemente chiamati a fronteggiare situazioni nuove e incerte, a volte drammatiche, altre volte (o per altri) stimolanti la creatività, in una tensione forte e in una continua decisione, acquisire la sobrietà di mente e di cuore pare quasi impossibile. Come appare quasi impossibile lasciar maturare profondamente in sé il senso di obbligazione per altri. Eppure, superando una considerazione di superficie, si può cogliere come questo tempo non richiami solo più azione e intensità, più reazione o duttilità, o adattamento: conduce molti a cercare un impegno in coscienza, ad affinare capacità desperienza, a sentire godimento della bellezza e della bontà. Conduce, anche, a un sapere del (nel) soffrire, ad accettare di entrare nel messaggio, nel senso di situazioni di prova e di dolore come pure di vicinanza e di affidamento (E. Fizzotti, 2004; V.E. Frankl, 2001). Ci vuole sobrietà per saper trattare con laltro, e con il mistero del morire e del nascere. Dice Maria Zambrano che ci vuole un sapere dei sentimenti, che è andato via via immiserendosi. [...] La liberazione è allora nella pietà, la matrice originaria della vita del sentire [...] Ma la pietà non è filantropia, né compassione. La filosofa spagnola che così a lungo vive lesilio, lo sradicamento, suggerisce che la pietà è qualcosa di più: è ciò che ci consente di comunicare [...] Pietà 58 è saper trattare con il diverso, con quello che è radicalmente altro da noi (M. Zambrano, 1997). Ci vuole un sapere segnato da sobrietà, che non riduce la realtà e ogni altro a moto chiarificatore della ragione e della coscienza individuale. È accettazione che laltro, che altro sia, che sorga. Fuori da un gioco di rispecchiamenti e di conferme, con il cuore trasparente, cuore che si lascia attraversare dalla luce, che vive nella luce. Quel cuore che è proprio di quella classe di amanti che non aspirano alla liberazione e alla pace definitiva cui appartiene, secondo Maria Zambrano, santAgostino. Un cuore trasparente, un sapere che sente, ospita la pietà, il sentimento delleterogeneità dellessere, della qualità dellessere [...] aspirazione a trovare i tratti e il modo di intendersi con ognuna di queste molteplici maniere della realtà [...]. Pietà è saper trattare con il mistero. Per questo il suo linguaggio e i suoi modi ripugnano così fortemente luomo moderno, che freneticamente si è buttato a trattare solo con ciò che è chiaro e distinto (M. Zambrano, 1997). La sobrietà che conduce alla pietà, al «saper trattare con il mistero», accetta lombra, lambivalenza dellindistinto. Guarda nel buio rinunciando alla violenta lama chiarificatrice del giudizio una volta per tutte. Lesperienza del mondo e dellaltro è risposta allapparire e al risplendere della luce, come lo possono essere lo sguardo e il pensiero. Nel guardare ogni volta si risponde, e si accetta di esporsi: è come vedere per la prima volta non un già visto, un già conosciuto e posseduto, ma il continuo emergere dellaltro e del mondo, come non era ancora apparso (S. Petosino, 2004). In questo la sobrietà si rivela atto di responsabilità, e lontanissima dalla passività. Uno sguardo sobrio del cuore e della mente lascia essere ciò che è, senza cadere nellindifferenza. Uno sguardo sobrio nei gesti e nei pensieri è riserbo, salvaguardia, riguardo, preoccupazione e cura, rispetto e ascolto rinnovato, ancora riproposto. È un lasciare che non è un perdere, né un abbandonare, con gesti che non reagiscono, con pensieri che non riflettono ma rispondono, e vanno attendendo. Attenzione e attesa sincontrano in questo sguardo, in questa capacità delle donne e degli uomini di cogliere accogliendo, in questo diventare guardare del vedere (S. Petosino, 2004). Quando donne e uomini sono capaci di questo e non tanto per un moto di intenzionalità, di volontà, ma per una sorta di recettività e sospensione, quasi per una sorta di grazia fanno esperienza di ciò che è proprio e di ciò che non è proprio. Un rimando allimmemorabile, allorigine, di cui non riusciamo ad avere un sapere chiaro. Una comune filialità. Come se il tempo saprisse: vicino allestrema vulnerabilità, come al morire, o nel riverbero dellamore e ai fremiti del nascere, si è sorpresi, affidati. È anche sempre (un poco, o con forza) un dramma. Prova dunicità, e di solitudine, dabbandono e daffidamento. 59 La malattia è una delle tante esperienze di sofferenza delle donne e degli uomini ma, a differenza e più di altre, diventa simbolo e figura del soffrire. Forse perché la malattia, come esperienza umana, chiede sempre di tenere insieme la spiegazione di qualcosa con la comprensione di qualcuno, la ricerca di senso e lo sviluppo di un sapere. Ombra di un corpo che è, in origine, fragile e meraviglioso dono, luogo di cure, di gesti, di sussurri destinati. Da sempre i modi di vivere la malattia, e di curarla e sostenerla, svelano i paesaggi interiori profondi degli uomini e delle donne; e li costruiscono, li ospitano. Questo è lo spazio dellalleanza, della prossimità, dellamicizia: contro la radicale estraneità reciproca delle coscienze. Movimento instauratore di senso, tra persone mortali, il cui tempo sapre a altre dimensioni, di evento. Quando la parola prova a rappresentare la realtà, quando il gesto si fa tecnica risolutiva, quando le relazioni si iscrivono nello scambio funzionale e nel contratto, allora le coscienze si accostano in estraneità reciproca. È faticosa, la malattia, sempre angosciante, estranea. Abitato nel corpo dallestraneo, dal nulla. Da qualcosa che ha a che fare col mistero della vita. Resta lo scarto. È corrosiva la malattia, riduce gli spazi (del lavoro, dei consumi, degli affetti) e ridisegna libertà e responsabilità. Ad esempio ponendo in questione la fiducia in te stesso, e ponendo il problema del fidarti di altri, dellaffidarti. La sensazione di vivere una sempre incerta salute, o la convivenza per anni con cronicità di cui si è consapevoli dal momento della diagnosi, non solo aumentano il peso psicologico dellesperienza della malattia e della cura, ma conferiscono ad essa un rilievo più incisivo sulla vita di ognuno: chiamando in gioco dimensioni simboliche che agiscono nella mente, nellimmaginario, nei sentimenti, nelle paure. Le donne e gli uomini scoprono dessere una grande questione. E lo scoprono anche quanti accompagnano i pazienti o assistono i malati. Questione aperta, e non solo di fronte alla cronicità o alla terminalità, che chiede in qualche modo di provvedere anche alla speranza, alla significazione, alla ri-elaborazione di spazi di libertà e di volontà possibili. La malattia propone un compito alla libertà, apre a una rinnovata disposizione di sé. Nella condizione dolente, che si lega quasi sempre alla malattia, come annota Lévinas, cè questo rovesciamento dellattività del soggetto in passività [ ] nel pianto e nel singhiozzo [ ] là dove non cè più nulla tra noi ed essa, la suprema responsabilità di questa assunzione estrema si rovescia in suprema irresponsabilità, in infanzia (E. Lévinas, 1987). Lesperienza intera della sofferenza non può essere scomposta e guarita. Si è notato che la considerazione della malattia come evenienza soprattutto sanitaria è moderna, legata allaffermarsi della pratica medica. Ma prima e oltre che evenienza sanitaria, per il suo intimo legame con la sofferenza e con la rappresentazione della mortalità, è consistente figura simbolica, nel senso che presenta la 60 condizione umana nei suoi aspetti complessi e radicali. Ci ricorda che il corpo è luogo della coscienza, prima che suo oggetto. Ma qui e da qui può nascere anche una radicale significazione conoscitiva della sofferenza: urtando contro il dolore fisico e il malheur come la mosca contro il vetro, il pensiero non si sviluppa in discorso, ma non può evitare il vetro (S. Weil, 1982). Resistere al male apre a complesse strategie, a diversi percorsi dentro di sé e dentro la storia tra le donne e gli uomini. Il pensiero non spiega, non risolve, non accetta consolazioni: assume una realtà. Scuote una esistenza quotidiana, una trama biografica e di relazioni intime e sociali: facendone emergere strutture, significati, aree non indagate o rifuggite dalla riflessione; parti di sé silenziose o sommerse. Affinando sentire e attendere. Paul Ricoeur annota come la souffrance ci riporti sul bordo. Dove lesperienza del nulla si tende con quella della nostalgia del grembo (P. Ricoeur, 1993). Dove il corpo, forse, sente lorigine, senza riparo. In piena e non mediata angoscia e fede. Souffrance è più che dolore, è partecipazione alla finitezza, apre alla comprensione della nostra vulnerabilità. Salvare questa finitezza è serbarla, custodirla con gesti di cura: custodia che è una forma della riconoscenza, un ringraziamento in cui si tendono e ri-dicono le sorgenti dei legami tra generi e generazioni. Tenerezza infinita di corpi mortali. La relazione con laltro corpo, nella malattia e nella cura, come nellamore, nella paternità-maternità, nella filialità, ha la primordialità, loriginarietà, lassenza di modello dei vissuti pre-filosofici. Epifania: laltro mi visita e mi parla dalla sua esteriorità in una forma che è, insieme, spoglia e carica di significato, fragile e resistente. La fragilità fisica coincide con la resistenza etica. Resistenza non di una forza, ma di una fragilità, resistenza di quel che non ha resistenza, che apre la dimensione stessa dellinfinito, dellassolutamente Altro come suggerisce sempre Lévinas. Abbandono e comunione. Striscia esile e incerta: il tempo va dissolvendosi (in quante patologie!), diviene niente. Il corpo è luogo di evento e di comunciaizone, rompe il tempo. Questo rinvia oggi la malattia e il corpo malato a uno spazio sociale definito in termini di integrazione o non integrazione, di dipendenza o di indipendenza trascinando con sé le famiglie e le prossimità in queste marginalizzazioni e dipendenze (M. Mannoni, 1995). Non si accettano volentieri presso i reparti di lungo degenza i troppo malati, i troppo poveri, i troppo handicappati, i troppo vecchi. Ci sono le decadenze scomode. La separazione tra sociale e sanitario, tra familiare e sanitario, le restrizioni di spesa (programmate in Europa dal 92 in poi) riguardano particolarmente queste persone. Si pensano nuovi spazi, e si richiama con forza in gioco la famiglia e la dedizione volontaria assistenziale. È uno scivolamento silenzioso dal diritto alla assistenza benevola. 61 Negli spazi di parola e di compagnia, aperti dallanimo fragile e sofferente sono lamorosa coltivazione del respiro di una convivenza, del suo risignificarsi, del suo confermare fedeltà e cura. Stanchezze, logoramenti liminali, energie fluttuanti: in questo nuovo senso la convivenza tra donne e uomini (più che su accumulo di patrimoni, di risorse e di saperi) si rinnova su matrimoni, su abbracci di generi, di generazioni e di differenze col senso della vulnerabilità e della possibilità. Malati donatori, allora, come i bambini? Sì, se coinvolti nella danza e nel ritmo della relazione e del pieno rispetto che disegna il circuito dare-ricevere. Ciò è possibile, già si racconta. 62 Formazione, medicina e terminalità Giacomo Delvecchio e Luisella Barberis È fin troppo facile parlare di crisi della medicina, istituto che promette sempre di più e da cui si pretende ancora di più. Purtroppo vi sono per la medicina un limite che non può superare e una promessa che non può mantenere: sanare il tempo del dolore e il tempo della fine e della terminalità. Lincontro con questi temi è ineludibile per tutti ed è di fronte a questi momenti che la medicina mostra tutto il suo limite. Ricercando le cause che hanno portato a questa condizione, molti hanno prescritto terapie per la cura della medicina malata: vi è chi propone di accentuare la prospettiva tecnologica e allopposto vi è chi propone di recuperare quel surplus di umanità che la tecnologia avrebbe inaridito e come se la cura della persona fosse un epifenomeno su cui la biologia non ha niente da dire (H. Atlan, 1995). Pensiamo che queste soluzioni da sole siano insufficienti perché in realtà al primo posto vi è una crisi di fondo riguardante addirittura lontologia medica (I. Cavicchi, 2004). Per questo si è convinti che difficilmente tale crisi possa essere risolta in modo volontaristico dallesterno della medicina con strumenti organizzativi e sociali, che implicano costose e sofferte trasformazioni. Queste sono vanificante se non si accompagnano ad un ripensamento profondo dello scopo e del senso dellagire medico. È possibile invece pensare che la soluzione, o un tentativo di soluzione, possa provenire dallinterno della professione. In questo caso è pensabile allora che siano i professionisti a dover riformulare non tanto i contenuti quanto i fondamenti della loro arte. Nel fare questo non si deve tanto smuovere uno sforzo retorico o moralistico quanto piuttosto andrebbe ripensata una certa modalità di intendere la competenza professionale, costituendo la piena realizzazione di questa il plusvalore etico da offrire al malato-cliente. In altre parole il primo requisito, che è molto di più che deontologico perché non si dà pratica medica senza una prospettiva morale, per un buon medico non è tanto quello di essere buono, quanto piuttosto quello di essere bravo. Costruire e mantenere una tale competenza professionale, cosa che è sempre difficile da realizzare, richiede un particolare approccio educativo, specie quando ci si confronta con la terminalità e il dolore. Ecco allora che la formazione del medico e di ogni altro professionista sanitario diventa cruciale. Per preparare allincontro con la sofferenza e la terminalità bisogna fornire e 63 saper fornire un sapere diverso a coloro che vogliono-devono saper essere medici in modo diverso. Di fronte a questo compito la pedagogia medica usuale va anchessa ripensata. Da un assunto bisogna partire: vi sono cose che la medicina e la scienza non possono sapere. Si possono indagare ma non comprendere. Così è per la morte. Per formare bravi operatori sanitari, specie quelli che del morire si devono occupare, bisogna anche in medicina ripensare la morte adottando uno sguardo antropologico che non sia disgiunto però, per non essere strabico, da una conoscenza della storia della medicina. Ci ricorda il Semmelweis di Céline, prima di diventare uno scrittore a sua volta un medico che parla di un medico, che nel passato della classicità mai si sarebbe mischiata la morte con la vita, limpurità del cadavere col vivente (G. Ceronetti, 1979): la morte era un evento sacrale e violare lintegrità del soma nella morte corporale era un tabù che anche i medici rispettavano. Non vi era però per i medici alcuna necessità epistemologica di violare questo interdetto. Solo con la nascita della medicina moderna e il venir meno del vitalismo la morte e lo studio della morte sono diventati i capisaldi per la conoscenza della vita: secondo un programma grandioso da cui ancor oggi la nostra scienza dipende, la vita è diventata infatti tutto quello che si oppone alla morte (X. Bichat, 1805). A seguire, nei testi di medicina però la morte stessa, pur centrale per la comprensione del vivente, è stata anestetizzata nel suo valore metafisico per trasformarla in valore biologico con termini altri e asettici, quali necrosi, necrobiosi, apoptosi (U. Dianzani, 2000). Il mistero della morte però, come del resto il mistero della vita, permane. Accanto alla morte scientifica, alla morte spiegata e ricca di parole, vi è il mistero della morte umana, la morte inspiegata perché incomprensibile, priva di parole per dire il silenzio. Ecco, la parola esatta da usare è mistero. Il mistero si scontra con le necessità della scienza. La morte ha oggettivato diversamente anche il corpo che da salma è diventato un cadavere perdendo la sua umanità e guadagnando la sua biologia. Se il corpo del morto non è più sacro ma è strumento per la medicina, con facilità e analogia si può pensare che anche il corpo del vivo sia strumento per la medicina, naturalmente per una medicina che in corpore viri si occupa paternalisticamente di fini buoni. In realtà di fronte al mistero non cè scienza che tenga. Non ci sono azioni sanitarie risolutive (ma risolutive di cosa? E per cosa, se non per tacitare lansia entro un fare inoperoso?) da insegnare e da mettere in campo al letto del morente da parte di nessuno. Cè solo il rispetto, che non può essere insegnato perché appartiene ad un intuito morale innato in tutti. Il rispetto da parte degli operatori va però declinato con rispetto: nessuno sa infatti se il senso del 64 mistero è uguale in tutti o è diverso per ognuno degli astanti, siano essi il malato terminale, i famigliari, gli operatori sanitari. Dopo questo vi è un altro problema per la pedagogia medica che non può essere né sottaciuto né banalizzato. Per i professionisti, che sono uomini e donne uniti tra loro e ai loro malati in una comune umanità, il tempo del mistero della morte non è solo quello del farsi o del compimento. Non vi è solo il durante la morte, ma vi è anche il dopo la morte. È questo un tempo dilatato per tutte le morti cui i professionisti hanno presenziato e prestato quellassistenza rispettosa e operosa di cui si diceva. Ma tutto questo tempo di tutte queste morti sommato insieme diventa un cumulo gigantesco e insopportabile. Forse è per questo che ogni sanitario si ricorda bene il primo decesso di malato incontrato allinizio della carriera professionale ma perde poi la memoria specifica di tutti o dei molti tra quelli che si sono succeduti nel prosieguo degli anni. È questo un banale meccanismo difensivo, una sorta di immunità emotiva, che sembra cinismo a chi di medicina non sa nulla ma che anche i sociologi ben sperimentano quando hanno la ventura di cimentarsi in prima persona con la vita e con la morte nel lavoro di corsia (M. Marzano, 2004). Da parte di molti in medicina si insegna, o si pretende di insegnare, lempatia, come viatico allincontro con laltro. Certo, sfruttando lintelligenza emotiva leducazione allempatia funziona per sentire dentro di sé le pene dellaltro e per decidere meglio con lui dove andare e cosa fare. Educare allempatia pone un problema al formatore che ha di fronte il personale che andrà a lavorare nei luoghi della cronicità morbosa che sfocia nella terminalità. È un problema di salubrità mentale, ossia come guidare i professionisti eccessivamente sollecitati da un punto di vista emotivo ad un giusto equilibrio tra unidentificazione continua con gli altri morenti e un distacco anaffettivo da questa condizione. La concentrazione delle forze per un equilibrio delicato tra abnegazione e rifiuto, tra oblazione e fuga, tra ansia e disincanto non è tanto e solo un problema psicologico quanto, nella sua radice, pedagogico. Qui davvero la pedagogia medica deve essere vera pedagogia individuale e sociale, anzi prima sociale e poi individuale ribaltandone la sequenza consolidata. La pedagogia sociale è unarte difficile da praticare perché si fa con tutti coloro che lavorano presi insieme e con lorganizzazione e listituzione. Coloro che lavorano in un luogo di terminalità, come può essere un hospice ma non solo un hospice, costituiscono unéquipe che deve essere costruita prima, mantenuta e salvaguardata poi. Ciò richiede intenzioni, attenzioni e prudenza educative. Lintervento del formatore qui è massimamente delicato perché quello che ne va di mezzo è lidentità del professionista e dellintero collettivo di lavoro con tutte le possibili immaginabili ripercussioni future. Il formatore impegnato a questo livello deve avere una chiara direzione e 65 deve essere consapevole di agire tra due forche caudine: da una parte sa che il suo errore avrà pesanti conseguenze in termini di insuccesso sui fronti dei professionisti e dei malati ma dallaltra parte sa che il suo intervento modificherà irreversibilmente il futuro professionale dei professionisti che, una volta tolti dai reparti di degenza ordinaria, non saranno più eleggibili per ritornarvi, perché la loro disposizione professionale sarà cambiata completamente e incompatibilmente con questi. Di fronte ai futuri operatori dellhospice il compito non facile del formatore ha un duplice obiettivo: prima deve decostruire, poi costruire. Lavorare a contatto con la terminalità richiede un modo nuovo di lavorare in sanità, non per funzioni ma per processi. Per arrivare a questo bisogna prima decostruire. Per decostruire si deve eliminare nel personale limmagine usuale del lavoro della corsia in cui funzioni e gerarchie sono mansionaristicamente chiare e definite. Di fronte alla terminalità e al processo del morire la linea gerarchica e le funzioni prestabilite non sono sempre un impiccio ma sono il più delle volte un freno perché sono una salvaguardia di fronte alla paura e allansia delle decisione che coglie ogni vivente qui giunto. Per costruire salvaguardando il professionista dallansia della decisione bisogna che il singolo sia fin dallinizio partecipe del gruppo. Il gruppo non è solo il contenitore del burn out perché luogo deputato a sciogliere le tensioni individuali nella catarsi collettiva; il gruppo è invece lo strumento collaborativo in cui si condividono le scelte e soprattutto le ragioni delle scelte rimotivando continuamente la professione. La formazione è quindi il momento essenziale e la sua programmazione non deve essere lasciata né al caso né allo spontaneismo né allimprovvisazione ma deve essere, come un intervento chirurgico, precisa e pianificata fin dallinizio nei modi e nei tempi. Con questi presupposti pedagogici e con questi obiettivi la formazione daula tradizionale non ha senso alcuno e diventa obbligatoriamente qualcosa daltro: diventa un grande laboratorio- azione in cui tutti gli operatori insieme di fronte ai temi della sofferenza e della terminalità si confrontano e costruiscono una comune aderenza ad ununica immagine professionale. Lobiettivo finale per il formatore è quello di insegnare ad avere non più gerarchie, non più mansioni, non più compiti prestabiliti ma apprendere la condivisione responsabile di scelte, di decisioni, di percorsi per arrivare a costruire e a mantenere nel tempo comuni modalità di sentire e di agire. La pedagogia individuale richiede invece unaltra riflessione che si accompagna però e si affianca nei tempi alla formazione collettiva e che nel collettivo alla fine va anchessa riportata e condivisa in modo che possa diventare parte del patrimonio di tutti. Si parlava di morte come mistero che richiede rispetto nel suo farsi e nel suo permanere quando il dopo è arrivato. Nel silenzio del dopo cè una memoria 66 che in qualche modo, o chiaro od oscuro non importa, rimane nel medico e in ogni altro operatore. Ora, se è vero che come dice Ricoeur il medico è il sopravvissuto di tutti i suoi moribondi (2000) un senso questa memoria lo deve pur avere. E quale altro senso può avere questa esperienza per un medico e per un operatore sanitario se non quello, con le parole di Jasper, prima vero medico e poi vero filosofo, di far sì che si possa diventare diversi da come di solito sono gli uomini (K. Jasper, 1991)? Così si costruisce quel luogo, quello indicato da Gadamer, della più segreta esperienza di vita (H-G. Gadamer, 1994) da cui per ogni medico scaturisce la cura. Ma per maturare diversamente se stessi nel luogo da cui scaturisce la cura, la memoria della finitudine deve essere meditazione per sé e testimonianza per altri. E quale altro compimento si può dare diverso da questo allinsegnamento di quei clinici convinti, ancora e sempre più oggi, che la migliore opportunità per un uomo è di diventare un medico (1998)? 67 68 Che cosè che supera la sofferenza e il dolore? Ivana Fadini Cosa è che supera la sofferenza e il dolore? È lamore, sono i sorrisi, il capire con gli occhi , senza nemmeno dire una parola. È la gioia di poter dare e trasmettere ai nostri cari tutto lamore di cui hanno bisogno. Qui cè gente che sa trasformare attimi di sconforto in forza per poter proseguire il nostro cammino di luce... Testimonianza da Il libro dellhospice Ci sono in ognuno di noi gomitoli di timori reali e giustificati, ma anche aggrovigliate matasse di paure irrazionali, o inspiegabili, fantasmi ostinati dei nostri ricordi e delle nostra infanzia, o paure ancestrali, che si sono radicate in noi nella notte dei tempi e ci sono pervenute attraverso linconscio collettivo, forse attraverso il corredo cromosomico, come tante altre caratteristiche della nostra specie. Difatti la specie umana, oltre al sorriso e alla posizione eretta, è la sola specie animale che abbia paura anche in prospettiva, non solo di fronte a un pericolo reale o immediato, come tutti gli altri animali. Così, cè chi teme il fuoco, chi lacqua, chi il buio o il dolore in generale; chi la caduta della luna, chi più banalmente, i viaggi in aereo. Chi ha paura, purtroppo realisticamente, di svegliarsi una mattina in pieno day-after da catastrofe nucleare (per cause belliche o nucleari); chi teme la povertà, chi il dolore perché lo considera senza via di scampo, chi la folla, chi la morte, chi gli spazi aperti. Prima della mia esperienza in hospice anche io ero tra quelli che avevano paura del dolore perché credevo non avesse via duscita. Ma mi stavo sbagliando, e mi sono posta e ho posto una domanda: Che cosè il dolore? Ho trovato molte risposte nelle varie esperienze. Il dolore è un filo di gomitolo che pian piano si srotola e lentamente si lega stretto alle nostre dita, ascoltando in silenzio le nostre sofferenze. Il dolore è un pianto dirotto che si asciuga col pianto di una nostra amica imprigionandosi in un fazzoletto bagnato stretto forte nella mano. Infine, il dolore è prendersi per mano, chiudere gli occhi respirando lentamente per poi risvegliarsi in un sorriso pieno di speranza. Durante unintervista ad Antonio Tabucchi gli fu chiesto che cosa gli comunicava il dolore altrui: ...Credo che in tutti susciti compassione, compassio 69 significa soffrire con. È una forma di partecipazione. E alla domanda se il suo dolore laiutava a comunicare o al contrario, frenava, interrompeva, recideva qualcosa rispose: Credo che sia un nostro diritto comunicare il nostro dolore alle persone che ci amano. Così come è un dovere ascoltare il dolore che esse eventualmente vogliono comunicare. Il dolore spezza i discorsi, si impone alle consuetudini, quando anche gli affetti di chi è vicino vengono messi alla prova; la trama delle parole che cercano di avvicinare, consolare, si rompe davanti allo stupore per il di più della presenza di un corpo che è diventato inquietante, diverso da come ci conosciamo. Leducatore rapportandosi con il dolore deve relazionarsi cioè incontrare il dolore degli altri, la malattia che distrugge il dolore degli altri, la malattia che distrugge il loro corpo, la loro morte in cui inevitabilmente ci si specchia. Questa identificazione, la possibilità pur remota di essere vulnerabile, spinge luomo a rifuggire la vicinanza con chi soffre. Come reagisce chi non può separarsi dal proprio corpo malato? Con sgomento, rifiuto, rabbia, disperazione. La malattia è con speranza associata allidea di guarigione, in un epoca nella quale la medicina ha escogitato scampo da mali incurabili. Ma ci sono malattie contro cui la medicina ha ingaggiato da anni una durissima guerra, non ancora vinta. Chi riceve la condanna a morte da un medico, deve rielaborare la propria vita, i progetti che vanno distrutti e deve difendersi. Nel viaggio verso la fine i compagni sono molto spesso il dolore, i ricordi, la vita passata, perché il tratto in cui si aspetta la morte sembra essere già non più vita. Un moribondo viene visto come un essere già morto. Non ha voce in capitolo per quanto riguarda le cure, a volte non è pienamente consapevole delle sue reali condizioni, ma, se sa, è difficile comunicare con lui e la sua condizione è quasi imbarazzante. La morte del malato terminale offre lopportunità di pensare la vita e affrontare anche lesperienza che sembra non abbia niente a che fare con la vita ed è invece il suo naturale epilogo. Allora quale sguardo si posa su di me? È lo sguardo della speranza. Non si può vivere senza speranza. In un certo senso, la speranza è tanto più forte quanto più grande è la minaccia alla propria vita e progettualità. A ogni ostacolo va rapportato il relativo rimedio. Per risolvere un problema della scienza è sufficiente la ragione, per compiere una scelta eticamente impegnativa si deve far ricorso alla volontà, per affrontare il dolore cronico è inevitabile il sostegno della speranza. Padre J. Kaller scriveva a proposito della speranza: È la speranza che fa accendere una candela nelloscurità invece di imprecare contro le tenebre. E deve essere così, infatti la speranza non è fatta di certezze, ma di attese e mistero. È un fidarsi e affidarsi a qualcuno più che a qualcosa. La speranza 70 non si improvvisa, si costruisce. Si cresce nella speranza per poterla offrire a chi prova dolore. È evidente che è faticoso stare a contatto con persone che soffrono, dove il dolore è un dolore totale. Il dolore del corpo provoca una sofferenza emotiva, e il dolore emotivo intenso diventa anche sofferenza fisica. Dalla mia esperienza ho appreso che a volte stando vicino a persone che soffrono si corre il rischio di sentirsi contaminati dalla loro sofferenza e si sperimenta il proprio essere umani con paure, angosce e limiti. Bisogna uscire dalla propria casa andare verso la casa dellaltro, di chi soffre mettendosi a disposizione, donando un semplice sguardoche ha un effetto più efficace di mille parole, regalando un sorriso. Bisogna mettersi nella condizione di chi ascolta, tendere una mano, così si riuscirà almeno in parte a sanare un cuore ferito, solo, sconsolato. Tecniche non invasive per curare il dolore Partendo dal punto di vista di un educatore mi sembra importante elencare alcune tecniche non invasive per il sollievo del dolore. Per il controllo del dolore, in generale si distinguono due categorie: tecniche farmacologiche e non farmacologiche. Dei due gruppi, il metodo più diffuso e utilizzato è certamente il primo, mediante la somministrazione di analgesici. La distinzione in queste due categorie riduce però ad un approccio troppo stretto la relazione che intercorre tra farmaco e dolore. Appare quindi più corretto e completo, definire le tecniche non farmacologiche come tecniche non invasive per il sollievo del dolore. Sicuramente tali metodiche meriterebbero uno spazio, nellassistenza, ben maggiore di quel che ricoprono attualmente. In questo ambito infatti, leducatore avrebbe la possibilità, collaborando a stretto contatto con linfermiere, di applicare interventi specifici ed efficaci. Questo certamente non significa che la terapia farmacologica non debba essere utilizzata, bensì che lintegrazione di queste due tecniche può portare sia ad una riduzione dei farmaci analgesici somministrati per il controllo del dolore che ad unassistenza più completa ed efficace, soprattutto dal punto di vista relazionale. Di seguito è presentata una breve dissertazione su alcune principali tecniche non invasive attuate in hospice per il sollievo dal dolore, rappresentate da distrazione, rilassamento, musicoterapia per occupare la mente nel lungo percorso di attesa. Distrazione La tecnica della distrazione consiste nel concentrare deliberatamente la propria attenzione su stimoli diversi dalla sensazione dolorosa. La capacità di distrarsi dal dolore non significa che questo non esiste o che è minimo: anche le persone con dolore grave possono scegliere di farsi aiutare da esso. La 71 distrazione può essere insegnata ai bambini (i genitori vanno avvertiti di non confondere questa tecnica, che il bambino sceglie di adottare, con il distrarlo a sorpresa prima di eventi dolorosi: questa non fa che produrre sentimenti di sfiducia e paura nei bambini). In generale, la distrazione non può essere attuata per periodi molto lunghi. Quando essa ha termine, è possibile che la persona provi un maggior senso di dolore e affaticamento. Alcuni esempi di distrazione sono rappresentati da: distrazione visiva, che consiste nel contare oggetti (fiori sulla carta da parati, macchie sul muro, animali in un quadro, lo sbattere le palpebre di qualcuno, ecc.) o descrivere oggetti; distrazione uditiva (canzoni, registrazioni, ecc.); distrazione tattile cinestetica (tenere, accarezzare, dondolare, respirare aritmicamente) e immagine guidata. Limmagine guidata consiste nellutilizzare la propria immaginazione, in modo significativo e specifico, per raggiungere il rilassamento e il controllo. La persona si concentra sullimmagine e vede se stessa coinvolta nella scena. Per eseguire questa tecnica è necessario parlare con la persona di unimmagine che ha trovato piacevole e rilassante (es. stare distesa su una spiaggia, sentire unonda di acqua fresca, galleggiare su una zattera, guardare il tramonto,ecc.); scegliere la scena che coinvolga almeno due sensi; far entrare mentalmente la persona nella scena; fare in modo che vi si immedesimi lentamente (chiedendo: Come le appare?, Quali rumori, odori, sensazioni o gusti prova?); mettere in atto la tecnica dellimmagine guidata e terminare la tecnica contando fino a tre e dicendo sono rilassato (se non viene stabilita un conclusione precisa la persona si può appisolare e dormire, cosa che non corrisponde allo scopo della tecnica). Ci sono poi tecniche di respirazione particolari: respiro lento e ritmico, che si realizza dicendo alla persona di inspirare in modo lento e profondo attraverso il naso e di espirare attraverso la bocca (se possibile provare a rallentare la frequenza a nove atti respiratori al minuto) e insegnare ad eseguire respiri extra se necessario. Respirazione secondo il battito cardiaco: fare un respiro lento e profondo, contare le pulsazioni sentendo il polso radiale, inspirare contando due battiti ed espirare contando i successivi tre battiti. Respirazione hewho: fare un respiro lento e profondo, inspirare dicendo iih, espirare dicendo huu; la frequenza può essere aumentata (non oltre i 40 atti al minuto) se il dolore aumenta. Rilassamento Unaltra tecnica utile nel controllo del dolore è rappresentata dal rilassamento, il quale porta ad uno stato di sollievo dalla tensione muscolare che la persona raggiunge con la pratica volontaria di tecniche prestabilite. Nel linguaggio comune rilassarsi significa distendersi con un buon libro, guardare un film comico o tenere una piacevole discussione con gli amici. In 72 realtà non è sufficiente volersi rilassare per esserlo, per giungere a quello stato globale di distensione muscolare, di relax fisico e mentale detto stato di rilassamento. Gli stati di rilassamento terapeutico si ottengono con lapprendimento attivo e regolare di un metodi di rilassamento. Gli effetti terapeutici del rilassamento riducono lansia, danno alla persona un certo controllo del dolore, diminuiscono la tensione della muscolatura scheletrica e distraggono dal dolore. Le principali tecniche di rilassamento sono biofeedback, yoga, meditazione, esercizi di rilassamento progressivo, il rilassamento progressivo di Jocobson, il training autogeno di Schultz. Il Biofeedback è una tecnica per ottenere il controllo volontario delle attività dellorganismo (muscolari o termiche) che sono abitualmente riflesse o automatiche. Con laiuto di un apparecchio per biofeedback, in genere elettromiografico, il paziente constata la sua contrazione muscolare attraverso la visualizzazione luminosa o sonora, e applicando le tecniche di rilassamento(controllo respiratorio, rilasciamento muscolare) apprezza il grado di rilasciamento prodotto. In seguito si può arrivare ad ottenere gli stessi effetti raggiunti in tali sedute anche nella vita quotidiana. Una tecnica utilizzabile in hospice è rappresentata dal rilassamento progressivo, che consiste in un esercizio, da insegnare o da affidare allautoapprendimento, che implica la comprensione di un modo sistematico di contrarre e rilasciare i gruppi muscolari, iniziando dal viso e arrivando fino ai piedi. Lo si può abbinare ad esercizi di respirazione, che fanno concentrare lattenzione su processi interni allorganismo. Richiede di solito 15-30 minuti e può essere accompagnato da istruzioni registrate che dirigono la persona indicando la sequenza dei muscoli da rilasciare. Il rilassamento progressivo di Jacobson utilizza il contrasto tra stato di contrazione e di rilassamento di un muscolo: contratto un muscolo, il paziente riconosce il suo stato di tensione, apprezza tutte le sensazioni che accompagnano questa contrazione volontaria, quindi rilascia il muscolo e apprezza le sensazioni che derivano dal rilassamento cercando, nel contempo, di ottenere un sempre maggior rilassamento. Nel rilassamento autogeno di Schultz il soggetto si impegna a raggiungere il rilassamento, ripetendo mentalmente una formula che lo aiuta a raggiungere la concentrazione necessaria come ad esempio, sono calmo, ...profondamente calmo, ...perfettamente calmo. Per meglio assimilare la tecnica è indispensabile apprendere i sei esercizi di base che compongono questo metodo e che permettono di ottenere il controllo respiratorio, muscolare, cardiaco, vascolare, vascolare addominale (plesso solare), vascolare encefalico (fronte). 73 Musicoterapia È una tecnica medica che utilizza la musica come strumento di cura e di mantenimento del benessere, e rientra nella più ampia categoria della suonoterapia, in cui i suoni sono utilizzati per migliorare le condizioni fisiche e mentali delle persone. La musicoterapica ha cominciato ad affermarsi negli Stati Uniti al termine della Seconda Guerra mondiale, quando fu utilizzata come pratica di cura complementare nei veterani di guerra. Alla fine degli anni Quaranta fu istituito il primo diploma in musicoterapia e nel 1950 venne fondata la prima associazione di musicoterapeuti, la National Association of Music Therapy. Attualmente lassociazione statunitense di riferimento per questa disciplina è lAmerican Music Association, nata nel 1998. Esistono diversi orientamenti di musicoterapica, ognuno con una propria struttura teorica di riferimento, una tecnica di riferimento, una tecnica e un metodo. Sono numerosi gli studi che dimostrano i benefici ottenibili a livello fisico e psicologico dalla musicoterapia, che trova applicazione sia nei soggetti sani, per rilassarsi, ridurre lo stress, migliorare lumore e accompagnare lattività fisica, sia in chi soffre di patologie acute o croniche, come i deficit fisici, emotivi, sociali o cognitivi. In generale, la musica influisce sul battito cardiaco, la pressione sanguinea, la respirazione, il livello di alcuni ormoni, in particolare quelli dello stress e le endorfine. È importante che la musica sia scelta da un terapeuta adeguatamente preparato, in grado di rispondere alle necessità specifiche dei singoli pazienti. Uno studio delluniversità di Tokio, infatti, attesta che esiste una precisa differenza di azione della musica classica, rispetto a quella rock su alcune funzioni fisiologiche e sul battito cardiaco, in particolare. La prima deprime lattività del sistema nervoso simpatico e induce una diminuzione della frequenza del battito cardiaco, mentre la seconda lo innalza, generando un senso di disagio, come il rumore. La musica, è intuitivo, influisce anche sullo stato danimo. Le caratteristiche ritmiche possono indurre calma o eccitamento e favorire lespressione non verbale delle emozioni. È dimostrato che la musica trova la sua applicazione in varie branche della medicina a cominciare dalla riabilitazione, sia in caso di danni cerebrali sia nella fase di recupero dopo interventi chirurgici e traumi. Per esempio, uno studio condotto presso il dipartimento di Medicina e Cura di Linkoping, in Svezia, ha rilevato che le pazienti isterectomizzate che sono state sottoposte a musicoterapia di gruppo hanno riferito una maggiore efficacia dellanalgesia e hanno ripreso in pieno le loro normali attività più rapidamente rispetto alle donne che non avevano tale trattamento. La musica viene utilizzata con pazienti terminali anche presso lhospice di Bergamo. 74 Uno studio condotto presso lhospice of Palm Beach county in Florida, che prevedeva il ricorso a sessioni di musica attiva e passiva, ha dimostrato che esse hanno favorito linterazione tra il malato e i famigliari, hanno costituito il contesto per una riflessione spirituale interiore e la verbalizzazione delle ansie e delle paure. Le sessioni di musicoterapia sono state efficaci, inoltre, per il controllo del dolore e per favorire il benessere fisico e il rilassamento, probabilmente grazie al superiore rilascio di endorfine indotto dallattività musicale. Altrove la musica è stata anche utilizzata nelle sale parto. Le madri che ne hanno beneficato hanno richiesto una somministrazione ridotta di farmaci antidolorifici durante il travaglio, perché la musica ha indotto la visualizzazione di immagini positive, il rilassamento, favorendo altresì la dilatazione della cervice e il posizionamento corretto del bambino. La Pet Therapy Questa terapia nasce nel 1953 in America, ad opera dello psichiatra Boris Levinson. Mentre lavorava con un bambino autistico, si rese conto che il suo cane gli offriva la possibilità di proiettare le proprie sensazioni interiori, costituiva unoccasione di scambio affettivo, di gioco e rendeva più piacevole le sedute. Nel 1961 coniò il termine Pet Therapy, oggi sostituito in italiano, più propriamente, da Terapie Assistite dallAnimale (TAA). Lespressione Pet Therapy, infatti, viene utilizzata per indicare i programmi di addestramento del comportamento animale. La Terapia Assistita dallAnimale (TAA) è un intervento che ha obiettivi specifici predefiniti, in cui un animale, che risponde a determinati requisiti, è parte integrante del trattamento. La TAA è diretta da un professionista con esperienza specifica nel campo, nellambito dellesercizio della propria professione. Ad essa si affiancano le Attività Assistite dallAnimale (AAA), interventi di tipo educativo, ricreativo e/o terapeutico, che hanno lobiettivo di migliorare la qualità della vita. Gli interventi di AAA possono essere erogati in ambienti di vario tipo, da professionisti opportunamente formati, para-professionisti e/ o volontari, con animali che rispondono a determinati requisiti. La TAA e la AAA sono utilizzate da noi in hospice. Meccanismi dazione Le TAA sono finalizzate ad un miglioramento delle condizioni fisiche, sociali ed emotive delle persone a cui sono dirette. Non si propongono come metodo unico, infallibile, né in sostituzione ad altre forme di terapia, bensì in affiancamento ad esse. La prescrizione, la progettazione e lattuazione di un simile intervento richiede la presenza di una équipe multidisciplinare, a seconda del paziente e della patologia da trattare. 75 I meccanismi dazione fondamentali di questo tipo di intervento sono: il rapporto uomo-animale, affettivo ed emozionale, in grado di arrecare non solo benefici emotivi e psicologici, ma anche fisici, quali labbassamento della pressione sanguigna, il rallentamento del battito cardiaco; la comunicazione uomo-animale, che si basa su una forma di linguaggio molto semplice, cadenzata, con ripetizioni frequenti, tono crescente e interrogativo, che produce un effetto rassicurante, sia in chi parla, sia in chi ascolta; il tatto: il contatto corporeo, il piacere tattile permettono la formazione di un confine psicologico, della propria identità, del proprio Sé e della propria esistenza; lelemento ludico, cioè il gioco e il divertimento, che portano benefici psicosomatici. Le persone, tramite esso, possono liberare le loro energie e ricavare sensazioni di benessere e di calma; lattaccamento: il legame che si viene a creare tra uomo e animale può, almeno in parte, compensare la mancanza eventuale di quello interumano, e, comunque, favorire lo sviluppo di legami di attaccamento basati sulla fiducia, che potranno, in seguito, essere anche trasferiti ad altri individui; lempatia: la capacità di identificarsi con lanimale, nel tempo, viene trasferita anche alle relazioni con gli altri esseri umani; lantropomorfismo: lattribuzione di alcune caratteristiche umane allanimale, può rappresentare un valido meccanismo per superare un eventuale egocentrismo e focalizzare attenzione sul mondo esterno; il senso di comunione con la natura. La Terapia Artistica Comprende la terapia del colore e si rivolge al corpo umano nella sua dimensione fisiologica e patologica, esercitando tecniche diverse per conoscere lespressione artistica a valutandone gli effetti sulla persona. Servendosi dei colori per dipingere senza scopi precisi, la persona assistita ha la possibilità di far scorrere la propria fantasia; il risultato dellaiuto che la terapia artistica può concedere sarà diverso a seconda dei materiali, delle tecniche e degli strumenti impiegati. Il colore suscita sensazioni nellessere umano: il giallo porta luce, il verde equilibrio, il rosso e larancio suscitano entusiasmo, il blu dà quiete. Luso terapeutico del colore sfrutta queste capacità per cercare di armonizzare la sfera psichica e nel tempo anche quella fisica del soggetto. Questo genere di attività, proprio perchè privo di schemi, è accessibile anche per coloro che sostengono di non avere uno spiccato senso artistico, ogni persona può esprimere stati danimo ed emozioni: infatti in ogni attività, non è importante il risultato finale, quanto il processo e lesperienza creativa, 76 mantenendosi in una condizione di ascolto dei sensi. Per un intervento di questo tipo, è necessario preparare il personale, le persone assistite e lambiente. Si può partire da una frase, un oggetto, una poesia, un racconto e trarre spunto da qui per proporre un tema da dipingere. La persona assistita, potrà anche scegliere il colore che più si addice toccando un oggetto di quella tinta e analizzando le sensazioni che trasmette. Se necessario, loperatore dovrà fornire indicazione concernenti la creazione di nuovi colori. Potrebbe poi essere interessante per lassistito analizzare con loperatore il proprio dipinto, descriverne il significato e le sensazioni che questo gli trasmette. Non è necessario che il disegno abbia una precisa forma: potrebbe anche limitarsi ad una sovrapposizione di colori, significante per lautore. Larte terapia non usa gli elementi artistici a fini diagnostici o psicologici: lindividuo impara ad osservare, ascoltare, muoversi, sentire e pensare in modo più cosciente. 77 78 Vorrei raccontare una storia Mariastella Moro Vorrei raccontare una storia, la storia di un bambino selvaggio che venne ritrovato nei boschi vicino a Parigi alla fine del 1700. Numerosi furono i medici e gli studiosi che si interessarono a questo bambino veramente strano. Un bambino che dopo molti mesi non aveva ancora altro nome che il sauvage. Fra i vari medici che si fecero portare il sauvage per esprimere il loro giudizio sulla possibilità di una sua educabilità il più autorevole fu Pinel, lo psichiatra che passò alla storia come colui che tolse le catene ai pazzi. Pinel concluse il suo rapporto con un giudizio implacabile: il sauvage non è educabile. Nella diagnosi psichiatrica di Pinel una semplice similitudine diviene unidentità: il sauvage presenta un insieme di segni che si possono ritrovare anche nei bambini diagnosticati idioti; il bambino assomiglia a loro: quindi è un idiota! Una diagnosi che racchiude il bambino allinterno di un ritratto generale, di una categoria standard: quello dellidiozia, negando di fatto la sua specificità, unicità come individuo. Nello stesso anno il sauvage incontra un altro giovane medico idealista: Itard. Incontro decisivo per lidentità di entrambi perché Itard, più tardi, darà un nome al sauvage: Victor. Gli conferirà un inizio di identità civile e sociale e Victor , a sua volta, permetterà a Itard la realizzazione di un inedito progetto pedagogico che lo toglierà dal ruolo di oggetto di curiosità scientifica per fargli assumere il ruolo di soggetto del suo destino. Itard nonostante la stima intellettuale che aveva di Pinel non poté accettare il suo inappellabile verdetto espresso su Victor e propose la seguente spiegazione: i segni che Victor presentava erano più gli effetti di un isolamento prolungato che uno stato di imbecillità congenità, in quanto luomo non progredisce da solo. Elaborò, quindi, un percorso riabilitativo-educativo che rispettasse il più possibile lindividualità, la storia così particolare di Victor. Un percorso nel quale Victor non era oggetto di un intervento pensato dallesperto e da lui imposto, ma soggetto-interlocutore, dotato di propri desideri, emozioni, ritmi, abitudini, e quindi con il potere di determinare e controllare il proprio processo riabilitativo attraverso una continua interazione con lesperto allinterno di una relazione di reciprocità (A. Canevaro, J. Gaudreau, 2002). Itard attuò inconsapevolmente un cambiamento di paradigma perché recuperò lidentità, la soggettività al di là delle classificazioni. far emergere il nome significa, infatti, andare al di là delle apparenze, dei ritratti comuni allinterno dei quali si costringono gli individui con le classificazioni, per riconoscerli nella loro unicità irripetibile. Chiamare una persona per nome da 79 parte del medico o dellinfermiera significa dirgli: la scienza dice che tu hai , ma tu sei; vuol dire avere un chi oltre a un che cosa, avere una persona reale con la sua particolare esperienza della malattia determinata da un fitto intreccio di elementi fisiologici, soggettivi e culturali. Cè in ogni essere umano qualcosa di sacro. Ma non è la persona. Neppure la persona umana. È lui proprio qui nella sua singolarità, semplicemente (S. Weil, 1983). Pinel e Itard possono rappresentare due momenti complementari nella relazione medico-paziente in quanto la diagnosi è la descrizione generale, comprensione oggettiva, del problema ed è fondamentale per riuscire ad inquadrarlo, ma essa richiede di essere completata e approfondita da una descrizione della specificità del soggetto fatta in prima persona attraverso la narrazione per permettere la comunicazione, per far emergere i bisogni individuali di cura del paziente. Ciò richiede al medico di uscire dal mondo delluniverso unico della diagnosi che pone al centro il problema che deve essere inquadrato, compreso da chi detiene il sapere razionale, per aprirsi alla differenza degli universi multipli, così come sono definiti da Tobia Nathàn in Medici e Stregoni, che mettono laccento sulla comunicazione. Essi propongono di uscire dal linguaggio tecnico che delinea lo stesso ritratto dei differenti malati sulla base delle categorie diagnostiche standard e costruire con il paziente un linguaggio diverso che permetta di interagire con lui, di far emergere il suo ritratto unico e irripetibile da quello generale della diagnosi, evitando così che le classificazioni e le tipologie da strumenti di comprensione diventino mezzi di deformazione e coercizione. Si può così passare dallincomunicabilità tra il linguaggio medico e quello quotidiano, allincontro tra espressioni e mondi diversi. Incontro che permette di interpretare il messaggio della malattia sia attraverso il linguaggio del corpo che le parole del paziente. Ci sono realtà che posso conoscere soltanto non restando presso di me, solo rompendo la continuità dellesperienza cognitiva nella quale sono presente a me stesso. [ ] Questa continuità dellesperienza cognitiva mi fa cercare spiegazioni, ragioni, mi fa verificare cause trovare misure, mi fa riconoscere laltro a partire dalle mie reazioni, come simile a me, o radicalmente diverso nel confronto con me. Interrompendo questa continuità ci sarà spazio per porsi accanto al vivere unico e irripetibile di un altro. [ ] Perché se il dolore e lansia, o il pudore e la gioia, o la malinconia sono ben note anche a me come stato danimo, quando sono il dolore e lansia suoi, quando la gioia e pudore traspaiono dai suoi gesti, o la malinconia dalla sua espressione, allora entro nellignoto, nellirripetibile e unico modo in cui gli stati danimo si vivono in ognuno. Il gesto, lespressione, il corpo dellaltro sono qui ma la totalità cui rinviano è invisibile e irraggiungibile, celata mentre si espone ( I. Lizzola, 2002). 80 Porre al centro la comunicazione permette di superare la cesura fra mente e corpo che la biomedicina ha sancito trasformando il corpo in una macchina composta da più parti aggregate, in un organismo. questo corpo-organismo che deve essere indagato, osservato, per cogliere i segni che consentano di individuare la patologia che può essere sconfitta attraverso la terapia. prospettiva, questa della biomedicina, che viene messa in discussione dal dolore cronico nel suo essere totale. Il dolore, percepito sia come contrazione delluniverso nella presenza immediata del corpo o viceversa come una dilatazione dellorganismo che giunge a saturare ogni possibile spazio, finisce col dissolvere il sé insieme al corpo. E nel far ciò dimostra come il corpo stesso non sia riducibile a un oggetto, a una qualche entità fisica o a un semplice stato fisiologico. Il corpo non è il sostrato della soggettività ma il suo fondamento, e ciò spiega perché la classica distinzione della cultura occidentale tra organismo fisico e vita della mente sia contrassegnata da implicite contraddizioni (F. Dovigo, 2004). Il corpo movendosi nella realtà è il tramite e linterprete attraverso cui conosciamo il mondo, con cui la mente si incarna nel mondo. Mente, corpo e mondo sono elementi interdipendenti dellunico processo di conoscenza della realtà. Quindi il tentativo di separare il dolore fisico dallesperienza soggettiva si rivela un compito impossibile, in quanto il dolore è la sua descrizione da parte del paziente. Ciò apre una nuova prospettiva fondata non più sulla vista , ma sullascolto: dove la storia di un caso si approfondisce fino a diventare una vera storia, un racconto, aprendo allesperienza che il malato e la sua famiglia fanno della malattia, trasformandoli da spettatori di unavventura che li vede coinvolti in prima persona , ma rispetto alla quale hanno pochissime possibilità dintervento, in protagonisti direttamente coinvolti nel processo di costruzione della propria salute (F. Dovigo, 2004). In questo modo le parole con cui il paziente cerca dentro di sé e con gli altri una spiegazione alla malattia lasciano una traccia nelle cartelle cliniche dove trovano solitamente posto solo storie narrate da altri, cioè dagli operatori. Una comunicazione sanitaria che si va delineando come forma di narrazione collettiva a cui i diversi protagonisti (medici, pazienti, infermieri, terapisti, volontari, famigliari) contribuiscono seppur con pesi differenti. Un racconto comune che, attraverso una negoziazione continua fra prospettive differenti e potenzialmente conflittuali, permette una continua lettura e interpretazione del decorso della malattia in modo da costruire un senso condiviso che aiuti sia i sanitari che i pazienti a confrontarsi con lincertezza che questa esperienza inevitabilmente comporta. Un racconto collettivo dove il medico si congeda dalla volontà e la sostitu81 isce con lattenzione, con un ascolto vero che passa attraverso lattivazione di tutte le proprie sensibilità, un mettersi in gioco, perché il dialogo si avvale sia del linguaggio esplicito che implicito. Ascolto a-centrato o sguardo profondo che porta il corpo a vedere oltre il corpo per ri-conoscere chi gli sta di fronte in modo da accogliere la sua storia, la sua originalità. Un ascolto che origina unazione che si pone in circolarità con losservazione e la riflessione per permettere alloperatore di ri-orientare lazione in caso di necessità, rimanendo costantemente aperto ai rimandi offerti dal paziente per evitare di calpestarlo con le proprie certezze, in quanto la propria descrizione-interpretazione deriva da un punto di vista particolare che non può essere né esaustivo né definitivo. Una circolarità che permette di problematizzare lazione, di non ricercare conferme ma nuove possibilità, di evidenziare le varie rappresentazioni e i punti di vista che guidano i propri gesti (osservare losservazione). Si va delineando così un diverso concetto di aiuto. Infatti nella prospettiva basata sulla osservazione vi è la netta distinzione tra salute e malattia, tra chi cura e chi è curato. Essa tratteggia una rappresentazione passiva del paziente, in quanto il bisogno è sinonimo di mancanza (non ha , non sa) e di dipendenza, e attiva azioni esterne di assistenza e compensazione unidirezionali: (A cura B). Essa origina due distinti percorsi che potremmo definire di delega: quello paternalistico (so io qual è il suo bene o dottore faccia lei) e, più recentemente, quello contrattualistico dove lautonomia del malato-cliente si gioca sulla scelta del medico-specialista presente sul mercato. Mentre nel racconto collettivo il paziente viene visto con risorse, capacità che gli permettono di far fronte ai propri bisogni e desideri, come naturalmente predisposto allattività, a fare da filtro verso le azioni esterne. Laccento si sposta dal controllo (dal punto di vista dellambiente esterno) al problema dellorganizzazione interna dei sistemi (dal punto di vista della loro autonomia), da un idea di sistema determinato dagli input ambientali a un idea di sistema autonomo che grazie alla chiusura organizzativa definisce il dominio delle perturbazioni ambientali pertinenti (M. Ceruti, 1989). Lazione di cura, in questa prospettiva, non si svolge in una direzione unica (medico-paziente, medico- famiglia, ecc. e viceversa), ma in una pluralità di direzioni in quanto il paziente e il medico sono immersi in una complessa rete di interazioni. Un azione che si tesse, in maniera continua e flessibile, attraverso uno scambio continuo di informazioni, significati e gesti fra coloro che vi partecipano(si istaura una circolarità tra A e B). Sappiamo che anche chi cura entra, inevitabilmente, nel rapporto di cura, entra cioè in quel circolo ermeneutica in cui, come afferma Dilthey, lo spiega82 re (Erklären) che è proprio delle scienze esatte lascia il posto al comprendere (Verstehen), a quellatteggiamento di conoscenza in cui lesperienza vissuta non è una variabile di disturbo, ma ha dignità e valore di cittadinanza (F. Dovigo, 2004). Quindi la relazione si va delineando come luogo di incontro e di scambio fra gli attori coinvolti. Ma la condivisione e lo scambio implicano reciprocità, assunzione reciproca della responsabilità di costruire il percorso di cura, un farsi compagni di viaggio seppur con zaini differenti. Ciò porta, da una parte, a vedere nellaltro un interlocutore a cui rispondere tutelandosi dagli eccessi dellazione (oggettivazione della persona, invadenza, manipolazione), mentre dallaltra il paziente può di nuovo prendersi cura di sé, esprimere responsabilità e creatività, vedersi curato e curante, potersi di nuovo narrare e interpretare. Posso vedermi curato e curante, agente e paziente, in una rete di comunicazioni ed elaborazioni, di decisioni e di affidamenti che mi coinvolgono con quanti mi sono prossimi (I. Lizzola, 2002). Si può così notare nelle organizzazioni sanitarie le tracce di una graduale trasformazione che coinvolge gli atteggiamenti, le pratiche, i linguaggi degli operatori. Si fanno largo nuove metafore di concepire ed esprimere lidea stessa di cura centrate sulle dimensioni di attenzione, costruzione della salute. Un invito a pensare la cura non come curare o prendersi cura dove non ci si cura tanto degli altri, ma delle cose da procurare a loro (si mette al centro le prestazioni e non il paziente), ma come aver cura che offre agli altri la possibilità di potersi prendere cura di sé. Forma di cura possibile solo se colui che cura è disposto a mettersi in gioco, a condividere lo spaesamento di chi è curato attraverso un incontro privilegiato come quello di Itard e Victor nonostante le sue imperfezioni, le sue crisi. Un incontro e condivisione che, come abbiamo detto precedentemente, deve essere segnato da gesti che riacquistino il loro significato etico parlando di vicinanza, di attenzione per permettere allaltro di sentirsi a casa, di sentirsi rispettato. Ciò diventa primario soprattutto quando, per necessità, nelle organizzazioni sanitarie ci si trova ad invadere il corpo- luogo dintimità dellaltro annullando il confine fra lIo e il Tu (nelle visite, nelligiene personale di pazienti non autosufficienti, durante i vari esami, ecc.) e questo può causare un rigetto nellaltro. Per tale motivo, il contatto fisico richiede abilità relazionali, di entrare in punta di piedi instaurando un dialogo, cercando di spiegare ciò che si sta facendo, non agendo in maniera meccanica per preservare la dignità della persona. 83 Vorrei concludere questi pensieri, che nascono dalla mia esperienza diretta allinterno dellhospice attraverso il tirocinio unita alla mia storia personale di educatrice e studente, con una citazione: in un certo senso stiamo imparando un intero nuovo mondo. In parte è soltanto imparare dei nomi, ma imparare dei nomi è approfondire il significato linguistico o semantico di qualcosa, perché imparare nuovi nomi sulle cose vuol dire imparare anche qualcosa sul loro conto. Se conosci i nomi di ogni albero guardi gli alberi in modo diverso. Altrimenti sono solo alberi. Se invece cominci ad imparare i nomi di ciascuno allora diventano qualcosa di diverso (F. Dovigo, 2004). A questa, vorrei aggiungere che servizi di cura che pongono al centro le persone e non le prestazioni devono scendere nei particolari, oltre le etichette fuorvianti se vogliono incontrare lumanità faccia a faccia, perché gli uomini come gli alberi si nutrono di differenze. 84 Incrociamo gli sguardi Albino Fascendini In ospedale vedo molti morti Li accogliamo in condizioni gravissime, privi di conoscenza, in stato di coma profondo: con prontezza e competenza diamo inizio a indagini, assistenza e cura. Di questi morti, non incrociamo mai lo sguardo. Non so dire quale sguardo si posa su di me? Incrociamo lo sguardo di padri e di madri, di figli, parenti e amici. Vi leggiamo sorpresa, incredulità, rabbia, angoscia. Impariamo a capire e informare con parole scarne; ad accompagnare in silenzio senza improvvisare risposte non vere. Di queste esperienze ricordo la premurosa attenzione e limpegno senza riserva di tante persone pronte a farsi carico di assistenza e cura per corpi devastati, sapendo di curare senza poter guarire. Perché è presto evidente che stiamo prendendoci cura di un corpo, di una macchina indispensabile per riattivare vite umane, per rimettere in moto emozioni, pensieri, relazioni. Tutti abbiamo bisogno di relazioni. Di più ne hanno bisogno, subito, i sopravvissuti, che hanno conosciuto, toccato e amato quei corpi. Così lincredulità, lo stupore, lo smarrimento ci travolge. Sfiorati dalla morte da vivi, attraversano i confini della vita e, per interminabili istanti, restano come sospesi in una nebbia dargento, che somiglia al caos gelido, immenso, senza una speranza o un rottame a cui aggrapparsi senza un solo segnale della terra per orientare la disperazione. Lincertezza è più ostile della morte (E. Dickinson, 1995). I morti non hanno occhi, né sguardo. Così su di noi si posa lo sguardo dei sopravvissuti, che dobbiamo aiutare a ritrovarsi e riconoscersi, per approdare ad un dolore sereno, capaci di farsi carico della pena e accettare limpotenza ad alleviarla. Ecco: non i morti, ma i morenti e i sopravvissuti sfiorati dalla morte ci guardano e possono incrociare il nostro sguardo. Non possiamo evitare questo estremo incontro. Dobbiamo catturare lultimo sguardo dei morenti e aprire il nostro, come finestra nelle nostre case, per vedere e capire e dare risposte adeguate a chi muore e sopportare, nella luce, lattesa quotidiana del nostro morire. Jacopo è un bambino di cinque anni. Tenuto per mano dalla nonna passeggia su un marciapiede, in città, vicino allospedale. Una vettura sbanda lo travol85 ge e lo trascina sullasfalto per alcuni metri. La nonna quasi non si accorge. I soccorsi del 118 sono rapidissimi. Viene portato in ospedale. È in coma profondo. Il respiro è insufficiente. Il polso è bradicardico, ritmico, valido. Le pupille sono isocoriche, midriatiche, scarsamente reagenti alla luce. Il piccolo traumatizzato viene intubato e mantenuto in ventilazione meccanica assistita. Il quadro clinico peggiora rapidamente: fibrillazione ventricolare e midriasi rigida. Le manovre rianimatorie sono inefficaci. Il tracciato elettroencefalografico è piatto. Dopo circa unora dal ricovero nessun parente è stato rintracciato. Concordiamo tra noi di mantenere il piccolo malato in ventilazione meccanica in attesa dei genitori. Quando arriva la madre riferisco i fatti, illustro le condizioni cliniche del bambino allingresso, il rapido gravissimo peggioramento, lirreversibilità in atto. La madre spalanca gli occhi, mi guarda, atteggia il volto ad un sorriso immobile, incomprensibile, stupito. Poi esplode: Dottore, lei sta scherzando, vero? No, signora. Risposta povera, impotente, colpevole. Ho visto poche persone morire in ospedale Non ho mai visto nessuno morire nellangoscia, nella disperazione, con dolori incoercibili. Ho visto uscire di scena in pochi istanti. Ho raccolto domande senza avere il tempo di dare risposte e di essere utile. Andrea è un uomo dallapparente età di cinquanta anni, robusto. Viene condotto in Pronto Soccorso dopo un incidente non ben precisato. È sveglio, orientato, pallido, sofferente. Respira con qualche difficoltà. Il polso è frequente, ritmico, apprezzabile. Sdraiato sulla barella, Andrea indossa scarpe e abiti da lavoro. Tiene le sue mani premute sul petto. Prima che possa controllare la pressione, raccogliere qualche informazione e visitarlo, Andrea mi guarda con occhi spalancati e mi dice: Dottore, sto morendo?! Andrea chiede e afferma, sa già la risposta, vuole solo conferma. Ho appena fatto in tempo ad appoggiare la mia mano sotto le sue mani e avverto il disastro. È evidentissimo uno sfondamento toracico. Sto formulando una risposta, un commento alle parole di Andrea e lo vedo impallidire ulteriormente, non sento più il polso. Andrea continua a guardarmi, le sue pupille sono midriatiche. Distolgo il mio sguardo, ruoto il capo di lato e rispondo: Lo so, Andrea!. Rispondo solo a me stesso. Andrea è morto: trauma toracico, rottura dei grossi vasi, tamponamento cardiaco. La risposta pronta e chiara non è utile a nessuno. Io sono solo con la mia impotenza. Insieme con altri, ho accompagnato molti malati terminali, nei loro ultimi giorni Raccogliamo desideri bisogni domande. Concordiamo informazioni da dare. Predisponiamo cure adeguandole ai sintomi e ai desideri dei malati. Siamo 86 vicini ai sopravvissuti. Certamente commettiamo errori. Non sempre otteniamo soddisfazione per tutti. Non ho mai visto nessuno morire nellangoscia e nella disperazione. Parlo per me, beninteso. Forse siamo particolarmente attenti e premurosi, disponibili e professionalmente preparati. Quanto ho osservato prova che è possibile, talvolta, costruire percorsi umani anche per situazioni di dolore e sofferenza estremi. È possibile se, soprattutto quando le parole vengono dette con fatica e parsimonia, prestiamo molta attenzione al volto, agli sguardi, ad occhi che guardano ascoltano e dicono. Gli occhi del malato che sta morendo, gli occhi dei familiari, degli amici e i nostri occhi. Allora il volto ci appare come quel luogo unico in cui si trasgredisce incessantemente la distinzione tra materia e spirito, tra anima e corpo, tra forma e contenuto. Il volto è lespressione di una identità umana allincrocio tra il visibile e linvisibile (B. Chenu, 1996). Il volto, ci dice Levinas, è lidentità stessa dellessere. Il volto parla, si espone; esso è molto di più di una Gestalt che latto della percezione rende unitaria. Esso è la manifestazione più totale dellessenza della nostra umanità. Con il suo chiedere e dare parola, con il suo guardare e farsi guardare, il volto conferma che luomo è quellessere che trae senso dal confronto con laltro, che la sua sussistenza dipende dalla relazione, che lessenza stessa dellumanità è il suo essere in relazione. Il volto è dunque lesperienza dellaltro che dalla sua estraneità mi chiama alla partecipazione, chiede che lalterità sia insieme riconosciuta e oltrepassata attraverso la comunicazione dello sguardo e della voce (A. Carotenuto, 1997). Ecco: volto, occhi, sguardo sono tappe e strumenti essenziali per stare insieme e comunicare volontà desideri emozioni. Tanto più essenziali quanto più il corpo si fa avaro di gesti e di parole. Nel percorso di accompagnamento abbiamo cercato sempre di adeguare le nostre risposte alle domande del malato, che possono cambiare radicalmente, in relazione al mutare delle sue condizioni fisiche e psicologiche. Antonia è una giovane donna coniugata e innamorata di suo marito e della vita. Ha un bambino di pochi anni. È amica mia. Un giorno si presenta in studio preoccupatissima. Lascolto raccontare i suoi disturbi. Sospetto un tumore mammario. Le indagini strumentali confermano il sospetto. Comincia il percorso terapeutico: intervento chirurgico, chemioterapia, controlli ripetuti. Antonia è forte. Vuole essere informata di tutto: terapie, risultati, evoluzioni possibili, prognosi. Non è curiosità: esercita il suo diritto di gestire il proprio male. È, apparentemente, molto serena, cosciente della serietà della malattia. La vedo sconvolta quando intensi dolori diffusi spingono i medici curanti a modificare le terapie. Ricorrono alla morfina e non ne parlano con lei. I 87 dolori si attenuano. Diffuse metastasi ossee ed epatiche vengono documentate. Le informazioni non arrivano. Antonia affronta i medici a viso aperto e ribadisce la sua volontà di essere informata sempre e di tutto quanto la riguarda. Quando la rivedo, Antonia si sfoga con me. Critica apertamente il comportamento dei colleghi e mi vuole garante del rispetto delle sue volontà. Glielo prometto. Antonia mi guarda intensamente e dice sarò una delle prime malate ospiti da te. Ricordati la promessa. Avevamo da poche settimane inaugurato un hospice presso un ospedale cittadino. Il quadro clinico evolve in netto peggioramento. Antonia viene ricoverata in hospice. La sintomatologia è ben controllata. Antonia è di nuovo serena. Adesso puoi fare quello che ritieni giusto. Non è necessario che mi dica tutto. Mi fido di te. Sono quasi pronta. E due giorni dopo: Scusami, ci ho ripensato. Non darmi troppa morfina. Sto bene, mi toglie il dolore, mi aiuta ad essere serena nellattesa, ma . Ma , Antonia? Temo di rilassarmi troppo, in questa attesa. Temo di essere meno vigile. Temo di dire cose che non vorrei. Tu sai quante amiche e amici mi sono cari. Tu sai quante cose mi hanno confidato. Non vorrei . Sublime delicatezza! Generosa attenzione ai diritti degli altri. Non è sempre così. Non per colpa. Talvolta siamo sopraffatti dalla complessità dei problemi e non riusciamo a misurarne peso, priorità, urgenza. Non riusciamo a capire. Prendiamo in considerazione solo il nostro punto di vista. Non vediamo lo sguardo che si posa su di noi. Non incrociamo gli sguardi. Anche parenti e malati possono rimuovere problemi, sottovalutare bisogni e pretendere risposte per sé soli. Così, tutti quanti dimentichiamo gli altri, lasciamo cadere uno sguardo, perdiamo loccasione e la possibilità di incontrarci, in un lungo istante rivelatore, prima che la relazione umana abbia fine. Il signor B.L. di 73 anni è accolto in hospice per una cachessia da neoplasia polmonare con diffuse metastasi. È in fase terminale. Più volte ha detto di voler dormire, perché molto stanco. Alcuni giorni prima di morire parla a lungo con il medico: potrebbe avere paura, potrebbe essere angosciato, non vuole vedersi morire. Il medico gli prospetta le possibilità di ricorrere alla sedazione terminale. Il malato accetta la proposta e si rasserena. Vedono entrambi chiaramente levoluzione della malattia: terminalità prossima. Alla esplicita richiesta il medico propone una soluzione idonea. Ma né il medico, né il malato, né altri valutano lopportunità di informare i famigliari sulla irreversibilità del quadro clinico, sui timori e i desideri del malato, sulla proposta del medico. La situazione precipita. Léquipe curante decide di iniziare la sedazione terminale. I famigliari si oppongono. Non è ancora giunto il momento! dicono. Sei ore dopo si dà inizio alla sedazione terminale. 88 Sarebbe stato preferibile una maggior attenzione di tutti agli sguardi degli altri, per concordare soluzioni accettate da tutti, che tenendo come priorità lautonomia del malato, mantenessero viva, il più a lungo possibile, una relazione tollerabile, profonda, umana. Mi chiedo che cosa ho imparato da queste esperienze. Che cosa conservo da tante emozioni, che hanno occupato alcuni dei miei giorni. Che cosa ho letto nello sguardo che si è posato su di me. Quali risposte hanno letto gli altri nel mio sguardo. Non ho certo imparato a morire. Neppure ho abbandonato linconscia convinzione di essere immortale. Quando mi sono lasciato catturare dallo sguardo, che si posava su di me e mi suggeriva: lasciatemi andare, lasciatemi morire. Non vi limitate a trattare i miei sintomi con le vostre sofisticate novità, ma aiutatemi a trovare la mia strada! Allora ho imparato il potere dellimpotenza. Diceva Cicely Saunders, in una testimonianza resa a David Clark, in una intervista televisiva: Io penso che il potere dellessere impotenti sia qualcosa che si impara quando si è con le persone che muoiono e che sono fondamentalmente indifese[ ], il potere dellimpotenza è qualcosa che si può coltivare senza fine, in modo da passare dalla comprensione clinica a quella filosofica e teologica e lì non cè fine alla scoperta (C. Saunders). Sono sempre più convinto della mia finitudine reale e comincio ad accettarla in una prospettiva quotidiana. Un mio carissimo amico e collega aggredito in giovane età da un cancro al colon, mi diceva quando il male ti morde la carne, desideri aspettative sogni perdono senso e interesse. Cambia la prospettiva. Tutto diventa quotidiano, istantaneo banale vuoto. Ha senso anche lattesa. E cominci a prepararti, ogni giorno. Morire sì, non essere aggrediti dalla morte. Morire persuasi che un siffatto viaggio sia il migliore. Al pensier della morte repentina il sangue mi si gela. Morte non mi ghermire, ma da lontano annunciati e da amica mi prendi come lestrema delle mie abitudini. (V. Cardarelli, 1989) 89 Ho conosciuto Olga in una residenza sanitaria per anziani, luogo squallido e affollato. Olga è una signora esile, minuta; veste inappuntabile sempre, linda, decorosa; gioca a carte; lavora alluncinetto; parla pochissimo; sta bene; è serena. Unico limite la sua profonda sordità, ben compensata dallattenzione vivace e silenziosa alle parole degli altri, ai rumori delle cose. Olga ha 102 anni. Negli ultimi mesi, quando la vado a trovare, spesso la sorprendo a letto, vigile, immobile, in silenzio. Mi saluta con un sorriso. Le chiedo: Come va Olga? La risposta immediata chiara concisa non lascia dubbi: Aspetto!. Non sono pronto ad una risposta tanto sicura, piena di senso, realistica, quotidiana. Ancora non ho imparato a portare con leggerezza il peso dei giorni. Non ho risposte verbali. Atteggio il volto e gli occhi a sorpresa stupore incredulità. Olga legge nel mio sguardo la retorica, un povero tentativo di consolare e ferma subito le mie parole fuori luogo, inutili,false, dannose. Scusi dottore lei ha qualcosa di meglio da suggerirmi ? Olga ha raggiunto la salute globale, ha attinto la saggezza. Io no. Non ho risposte alla sua domanda e cambio discorso, parlo daltro. I suoi parenti la vengono ancora a trovare? Olga pronta insiste: Certamente, anche se meno spesso, soprattutto mia figlia: ha i suoi acciacchi, poverina! La figlia ha 80 anni. Rivivo le intense emozioni provate incrociando lo sguardo di uomini e donne che vedo morire. Non dire niente. Non hai risposte da dare al mio sguardo che si annebbia. Non hai spiegazioni per la morte. Accettala, è un momento della vita. La morte, anche se vasta, è soltanto la morte e non può crescere. La morte è una e viene solo una volta, e solo inchioda gli occhi. (E. Dickinson, 1995) Ad Olga ho dato risposte banali, parole vuote, senza senso, parlando daltro, volgendo lo sguardo altrove. Ma ho raccolto il messaggio. Che cosè morire, se non stare nudi nel vento e disciogliersi nel sole? E che cosè emettere lestremo respiro se non liberarlo dal suo incessante fluire, così che possa risorgere e spaziare alla ricerca di Dio? Solo se berrete al fiume del silenzio, potrete davvero cantare. E quando avrete raggiunto la vetta del monte, allora incomincerete a salire. E quando la terra esigerà il vostro corpo, allora danzerete realmente. (K. Gibran, 1992) 90 Ricerca di un senso al vivere e al morire Daniela Plebani Puoi indicarmi qualcuno che dia giusto valore al suo tempo ed alla giornata e che si renda conto come egli muoia giorno per giorno? Luomo forte e saggio non deve fuggire dalla vita ma uscirne. Il nostro errore sta nel pensare che la morte venga dopo, mentre essa come ci ha preceduto così ci seguirà. Il saggio non è mai scacciato dalla vita (Seneca) Romano Guardini scrive che il venire al mondo è la nostra fortuna e la nostra zavorra. Questo perché è nel momento in cui nasciamo che la morte entra in noi, quando la vita ha il sopravvento, che paradosso!: da quel giorno non vi è più modo di evitarla, siamo diventati tutti più vulnerabili. Morte. La sola parola evoca paura e rifiuto, per luomo essa rappresenta buio , mistero e angoscia, la rifiuta per istinto; tra la vita e la morte la scelta è sempre a favore della prima. Ma perché tanto timore? Forse perché essa ci preclude anche lignoto, linconoscibile; certo è che tutti siamo angosciati dinnanzi al mistero, ad un dopo inimmaginabile. A cosa ci condurrà la morte?, Quale il suo senso più profondo?. Luomo è sempre stato assillato da questi interrogativi: dallinquietudine del primitivo, alla riflessione filosofica, sino alla storia delle religioni, a dimostrazione del carattere immutabile e permanente della stessa. Essa è una costante, indefinibile, non esperibile e inimmaginabile. È dunque auspicabile non pensarla? Non cercare di intuirne il senso? Spinoza sosteneva questo ritenendo insano e quasi perverso considerare la morte un problema degno di attenzione e che luomo libero a nessuna cosa pensa meno che alla morte; e la sua esperienza è una meditazione non della morte ma della vita. Contrariamente, Jankèlèvitch (allievo di Bergson) riteneva che il modo migliore per interrogare il senso della vita fosse quello di riflettere sulla morte. Egli vedeva in essa un mistero insondabile che ci rende consapevoli della nostra invalicabile finitudine; che nega la vita ma che al contempo la rende possibile conferendole un senso. 91 In accordo con Jankèlèvitch, ritengo non sia possibile pensare alla vita senza, al contempo, riflettere sulla morte: le due sono inestricabilmente unite e il senso delluna non può che generare quello dellaltra. Perché nascere, vivere e morire? Cosa lega i tre eventi? Forse leterno fluttuare di quel soffio vitale che tutto crea, modifica e distrugge ma che incessantemente continua, senza mai posa. Forse aveva ragione Eraclito quando affermava che il principio e la fine sono la stessa cosa. In effetti la vita di ogni individuo ha inizio senza che la volontà dello stesso abbia avuto modo di esplicarsi, così come accade nella morte. Succede e basta! Vita e morte sono i due grandi eventi nei quali è la volontà di altri o altro a farla da padrone. Nasciamo abbandonando lignoto per ritornarci in morte: mistero prima e mistero poi. La non-esistenza è la dimensione dalla quale e nella quale siamo stati e saremo. Inizio e fine sembrano essere proprio la stessa cosa. Non afferriamo che ne era di noi, prima che fossimo. Non ci è possibile immaginare che dietro di noi sta un momento nel quale confiniamo con il nulla. Ma è così. È un mistero, il fatto che ad un certo punto abbiamo cominciato ad essere; come questi uomini: proprio noi. Lì ricevemmo in noi la nostra stessa esistenza; possibilità e limiti. E ciò che lì venne alla luce, incominciò a destarsi e a crearsi (R. Guardini, 1987). E, più di chiunque altro, è il malato terminale che è animato dal desiderio di andare in fondo a se stesso, di accostarsi il più possibile alla verità più profonda, di tentar di carpire il segreto che unisce vita e morte, gioia e dolore. Spetta dunque a tutti quanti ruotano attorno ad esso, il compito di aiutarlo in un compito tanto difficile quanto intimo, affinché si possano dare risposte al suo animo tormentato per trovare finalmente un poco di pace. Luomo, di fronte allimminenza della propria morte, ha bisogno di una vicinanza umana che lo aiuti ad aprirsi a ciò che lo trascende, al mistero della propria esistenza. Questo atteggiamento è detto accompagnamento spirituale in quanto fa riferimento ad una dimensione dellessere umano (noetica,) in cui si è affrancati dalle emozioni, dalle pulsioni e dalle emozioni. Laccompagnamento spirituale è un atteggiamento che si radica nel convincimento di un èthos comune, quello dellunica appartenenza alla razza umana (L. Pinkus, 2003). Questa competenza presuppone ladesione a due valori: - la convinzione della singolarità e quindi del valore di ogni persona umana, della sua interiorità e delle sue risorse, al di là delle possibili divergenze di tipo filosofico, religioso o ideologico; - la riflessione che la nostra crescita avviene in una cultura che esige il sostegno delle cosiddette reti di appartenenza. Prendere coscienza di ciò porta allesigenza di vivere la solidarietà con gli altri. Non a caso è nelle unità di cure palliative che si attribuisce grande importan92 za alla qualità della presenza e della compagnia: cosa, in effetti, si può umanamente offrire se non la profondità della nostra presenza e la finezza della nostra attenzione?. Non vuole cedere e abbandonare il campo, semplicemente perché, pur assediato da nemici imprevisti, si sente ancora vivo e circondato da solidi apprezzamenti, come pure dagli ancor più validi baluardi degli affetti di persone incontestabilmente cordiali (P. Roveda, 2003). Aiutare dunque il morente ad accostarsi al mistero, a conferire un senso agli ultimi giorni di vita come completamento allintera esistenza, un senso che gli permetta di aprire la propria porta sullignoto verso il quale si sta dirigendo. Questo significa anche permettergli di mostrare più volti, di avere diverse possibilità dessere pur mantenendo la fedeltà a se stessi; sì perché cambiare non significa tradire il nostro Io più profondo, il nostro Essere originario, ma avere la possibilità di essere altro da ciò che siamo hic et nunc. Chi più del malato terminale ha diritto ad esprimere tutti i possibili volti del proprio Io? Di mostrarsi angosciato e poi rasserenato, addolorato e poi rassegnato, terrorizzato e poi coraggioso, impotente e poi determinato? Tutto ciò significa realmente permettergli dessere pienamente se stesso. Credo sia molto difficile accettare questo nostro destino nel momento in cui esso si sarà definitivamente compiuto, difficile partire quando Qualcuno o Qualcosa lo ha deciso senza avere possibilità di riscatto. Un aiuto ci può essere offerto dalleducazione, da quel e-ducere in cui è necessario tirar fuori un significato, un senso possibile anche da ciò che di problematico e fortemente difficoltoso incontriamo nella vita. È importante credere che luomo è parte di ciò che porta in Sé: il Mistero (dal quale tutto è scaturito), che è parte di un essere-altro del quale siamo elementi fondamentali. Noi apparteniamo ad una Storia comune a tutti gli esseri viventi che ci porta a dimenticare la nostra personale, individuale, proprio per volgere lo sguardo ad Altro, ad un percorso che risulta essere infinito, eterno. Lindividuo è parte di tutto ciò anche se rappresenta una presenza fuggevole, un bagliore se visto nella totalità in cui giacciamo. Ma, nonostante la nostra permanenza sia un attimo nel tempo infinito, risulta necessaria, indispensabile allesplicarsi di una Storia importante e senza fine. Luomo porta dunque in sé una parte di eternità, quel qualcosa che continuerà sempre, anche dopo la morte del corpo. destra 93 94 Appendice Tutti i materiali sono tratti da Verso Sera, notiziario quadrimestrale dellAssociazione Cure Palliative di Bergamo; nn. 23, 21, 20, 24. 95 96 CIAO, KIKA, grande donna, grande presidente Maria Grazia Mamoli Minetti (Kika): 14 aprile 1947 14 luglio 2005 Giovedì 14 luglio 2005, alle 16,22, Kika è morta nel suo hospice. Da fine 2001 ha combattuto la sua personale battaglia contro tre successive manifestazioni tumorali e, con grande determinazione, ha affrontato tre interventi e le necessarie terapie di supporto, raggiungendo significativi traguardi di miglioramento e di qualità di vita. Nel marzo 2005 si è manifestato un ulteriore tumore, con ampie metastasi e diagnosi di inguaribilità: ma anche allora ha affrontato le terapie palliative, con forza e con concreti obiettivi di qualità di vita, fra cui il sogno di una ultima vacanza al mare. Un ulteriore aggravamento ha reso impossibile questo obiettivo e, dopo pochi giorni, cè stato il ricovero nellhospice di Borgo Palazzo. Anche attraverso questo percorso di malattia, Kika è stata per tutti noi un esempio di determinazione, di fiducia, di serenità, come lo è sempre stata prima, grazie alla sua naturale capacità di essere disponibile, aperta, semplice e profonda. I suoi occhi e il suo sorriso parlavano per lei e gettavano immediatamente un ponte di comunicazione e di empatia: per questo è stata una grande donna e una grande presidente e ha cementato il sentire di volontari, di sostenitori, di operatori sanitari, di malati e di parenti. Riassumiamo le tappe principali della sua esperienza nel volontariato bergamasco: alla fine degli anni Ottanta il Comune di Bergamo e la sezione locale della Lega per la lotta contro i tumori organizzano il primo corso di formazione per lassistenza domiciliare ai malati terminali. Kika si attiva con il primo gruppo di volontari, come coordinatrice, e partecipa alle prime esperienze di ADI con lallora Ussl. 97 Kika presiede uno dei numerosi corsi di formazione per volontari Kika firma il contratto di comodato duso del Padiglione Verga per creare lHospice Kika durante le iniziative di piazza di Trenta Ore per la vita nel 1998 Kika con le autorità allinaugurazione di Borgo Palazzo il 22 dicembre 2000 Kika riceve dallallora Sindaco di Bergamo lattestato di cittadina benemerita Kika a una cena con lequipe dellHospice 98 Kika durante la visita del Vescovo allHospice Kika allo stand dellAssociazione durante la Festa del Volontario. Kika a una cena in sostegno dellHospice Kika riceve una donazione dal Credito Bergamasco Kika al Gran Galà Bergamo al Donizetti, un appuntamento consolidato dellAssociazione Kika con un gruppo di volontari al Congresso nazionale della Società di Cure Palliative. 99 Nel 1989 viene costituita a Bergamo lAssociazione Cure Palliative: Kika è il riferimento costante dei volontari, sia nella concreta assistenza a domicilio che nei numerosi corsi di formazione. Dopo la presidenza Cossolini e Minetti, è eletta presidente e confermata nellincarico per tre mandati. Sono gli anni del sogno dellhospice e della sua concreta realizzazione, soprattutto dal 1997 al 2000, con centinaia di incontri, manifestazioni, spettacoli, cene, iniziative. Nel gennaio 2001 lhospice inizia la sua operatività con gestione degli Ospedali Riuniti e il resto è storia recente. Lhospice e il continuo miglioramento della qualità di cura e assistenza, lintegrazione dei volontari con léquipe e con un loro ruolo sempre più articolato e professionalizzato, la centrale operativa provinciale per gestire il coordinamento e la consulenza dellassistenza domiciliare su tutto il territorio, la campagna di sensibilizzazione sulla terapia del dolore e la diffusione delle cure palliative sono i progetti centrali su cui Kika ha lavorato e su cui lAssociazione Cure Palliative si impegna a continuare i suoi percorsi. Per il suo impegno nel mondo del volontariato, Kika ha ottenuto molti premi e benemerenze (Comune di Bergamo, Cavalieri dItalia, Rotary, Lions...), ma il riconoscimento più significativo è sempre venuto dalla stima e dallaffetto di tutti coloro che hanno potuto starle vicino. Ringraziamo le migliaia di persone che hanno voluto manifestare la loro partecipazione: le autorità politiche, amministrative, religiose e sanitarie, gli operatori socio-sanitari, i volontari, i rappresentanti degli enti e delle aziende sostenitrici, gli associati, i rappresentanti delle numerose associazioni locali, regionali e nazionali di volontariato, del mondo del lavoro, della comunità ecclesiale e della cooperazione sociale, i parenti dei malati assistiti, i cittadini di ogni ceto e cultura. Ringraziamo i media per lattenta e completa informazione. Ciao, Kika. 100 Sussidiarietà e sostenibilità Ci pare giusto e opportuno ribadire quali sono i fondamenti teorici della nostra concezione del ruolo di sussidiarietà del volontariato e, insieme, ribadire anche la nostra lettura della sostenibilità del welfare. Non a caso abbiamo voluto che lhospice fosse pubblico e, una volta realizzato, lo abbiamo donato agli Ospedali Riuniti perché lo gestissero e si creasse il primo vero esempio di struttura pubblica per malati terminali. Sussidiarietà Vale la pena di ricordare che la nostra concezione di sussidiarietà prevede il ruolo di stimolo al miglioramento qualitativo e alla capillarizzazione quantitativa del servizio pubblico, con eventuali interventi dintegrazione di fondi e di personale per accrescere la qualità e con eventuali periodi di supplenza quando si tratta di anticipare un incremento di servizio. Non concepiamo la sussidiarietà come sostituzione, come alternativa, come supplenza permanente, come tappa-buchi, come pezza sulle carenze, sulle manchevolezze, sui ritardi, sulle assenze del servizio pubblico, il quale deve assolutamente garantire stabilità, continuità, capillarità, equità, qualità al servizio, obiettivi non garantibili dal privato nonprofit e profit, perché potrebbero non esserne allaltezza in modo permanente o non averne le motivazioni economiche.. In particolare questi paletti sono fondamentali per tutte le associazioni di volontariato: le altre realtà del Terzo Settore e del nonprofit, fino alle organizzazioni della cooperazione sociale, possono, diversamente dal volontariato vero e proprio proporsi prioritariamente come gestori di segmenti del servizio, accreditandosi e acquisendo contratti - convenzioni - fondi e denaro dal servizio sanitario nazionale e regionale. Da quel momento stesso, essi cureranno la gestione e entreranno in dialettica con il volontariato in modo analogo alle strutture pubbliche, ricevendo stimoli, arricchimenti qualitativi e quantitativi, ma anche verifica e controllo affinché garantiscano allutente il miglior servizio possibile: anzi da queste organizzazioni nonprofit ci dovremmo aspettare il massimo di trasparenza, efficienza, efficacia. Non è mai accettabile che lorganizzazione nonprofit gestisca il servizio remunerando il personale sotto i minimi sindacali o con orari eccessivi, oppure accettando tariffe esigue che non permetterebbero la riproducibilità del servi101 zio stesso in altre realtà territoriali, cosa che può succedere, per esempio, se lorganizzazione nonprofit esercita la sua funzione in un determinato ambito (anche dando discreti risultati) ma solo perché utilizza un gran numero di operatori professionali pensionati o non pagati e ciò, ovviamente, non può garantire che un analogo livello di operatività possa essere erogato altrove. Anzi, crea lillusione o la falsa promessa che sia riproducibile una soluzione che invece non è tale. Analoghe considerazioni vanno fatte per situazioni allopposto e cioè (casi rari ma presenti !) dove il servizio reso dallorganizzazione nonprofit dovesse essere remunerato dalle istituzioni di riferimento in eccesso, creando così una situazione di spreco e di uso distorto di fondi pubblici, in ultima analisi carpiti impropriamente ad altri soggetti deboli e fragili. Ben diversamente devono operare, invece, le organizzazioni di volontariato vere e proprie, che esigono e devono esigere e controllare che il servizio pubblico garantisca sempre e comunque i requisiti minimi e da qui poi partono per stimolare incrementi in quantità e qualità, accettando anche, in questi casi, di farsene carico in prima persona per spostare più avanti i livelli da garantire allutenza, in una concezione di progressivo ripensamento della sostenibilità verso lalto e non verso i tagli e verso le riduzioni. Invitiamo tutti, qualunque sia il loro ruolo, a fare sempre chiarezza su questa concezione della sussidiarietà e sui necessari distinguo fra mondo del volontariato vero e proprio e generico nonprofit. Sostenibilità In anni di battaglie e di sensibilizzazione dellopinione pubblica e delle istituzioni, abbiamo conquistato che lassistenza e la cura dei malati terminali, in degenza e a domicilio, siano Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e quindi siano riconosciuti come diritti per tutti i cittadini, ovunque residenti nel nostro paese, e gratuiti. Parlare di sostenibilità, vuol dire partire da qui, comunque: pur assistendo con preoccupazione allo smantellamento progressivo dello stato sociale, con abbassamento dei servizi garantiti, e alla babele di differenze regionalistiche per una demagogica applicazione del federalismo, ribadiamo che questi sono LEA, non si toccano ed anzi va articolata e garantita la loro applicazione, pronti a ricorrere non solo a mobilitazioni politiche, ma anche ad azioni legali contro gli amministratori che non ne garantiscono lattuazione. Sui LEA è necessario essere concreti e determinati: una volta conquistatone il riconoscimento, la battaglia si sposta nellapplicazione e sulla capillarità. Non è nostra intenzione uscire dal seminato, ma ci tocca ribadire che la salute non è un business, ma un diritto equo e universale da garantire ai cittadini e su cui si misura il livello di civiltà di una società. Nella riforma del welfare, è legittimo porsi lobiettivo della sostenibilità, ma 102 declinandone le priorità: cura e assistenza ai malati terminali, così come alla cronicità e agli anziani, non possono venire dopo le grandi opere e i ponti di Messina e, comunque meritano di assorbire le enormi risorse finanziarie che invece sono idrovorate dagli sprechi, dagli accavallamenti di diverse istituzioni che si incartano sugli stessi problemi, dallonere insostenibile delleccesso di burocrazia e delleccesso di figure apicali e di costosissime consulenze. I diritti che sosteniamo sono sacrosanti, i fondi sono reperibili e i costi sostenibili, se si opera con il rispetto delle priorità. 103 Il modello Bergamo È giunto il momento per il movimento delle cure palliative (che vede la sinergia fra il mondo dei volontari e quello degli operatori sanitari) di fare un grande sforzo di confronto e di sintesi (pari a quello prodotto quando abbiamo elaborato i requisiti minimi) per definire quale è il modello di riferimento che vogliamo privilegiare e portare avanti in tutte le diverse realtà italiane, superando leccesso di differenziazioni che ha caratterizzato fino ad ora il complesso e articolato sviluppo delle cure palliative nelle diverse province. Ciò non vuol dire assolutamente appiattire la ricchezza dellesistente e burocratizzare, in tempi brevi, situazioni che sono per ora connotate in modo sì contraddittorio, ma anche ricco di spunti e sfaccettature. Vuol dire, però, fare il punto della situazione e prendere posizione sulle linee di sviluppo e sugli obiettivi che vogliamo raggiungere: non è accettabile, infatti, che alla caotica babele di differenze causate da un malinteso federalismo, si aggiungano altre grandi differenze dovute ai ritardi della nostra capacità di fare la sintesi del nostro movimento e di indicare scelte di sviluppo unitarie e condivise. Diamo il nostro contributo, sintetizzando in pochi punti essenziali le caratteristiche di ciò che abbiamo fatto e che potremmo definire il modello Bergamo. 104 1. Inizialmente a Bergamo un piccolo gruppo di medici anestesisti, occupandosi di terapia del dolore e cure palliative, fondò lAssociazione e allargò la comunicazione ad altri medici, infermieri, psicologi, nei diversi ospedali e sul territorio e coagulò il primo gruppo di volontari. Nacque allinterno di Anestesia II degli Ospedali Riuniti il Centro di terapia del dolore e cure palliative, con ambulatorio e consulenza verso gli altri reparti. Si ottenne la prima convenzione con lallora Ussl e con i primi casi di assistenza domiciliare. 2. LAssociazione Cure Palliative, attraverso numerosi corsi di formazione e moltissime iniziative pubbliche, articolò comunicazione, informazione, formazione, con notevole risalto sui media e sullopinione pubblica. Si moltiplicarono riunioni con medici attivi verso altre patologie e in altre aziende ospedaliere e sul territorio e con altre figure professionali. Venne data diffusione capillare al notiziario Verso Sera. Si diede successivamente e progressivamente stabilità e continuità ai rapporti con le istituzioni sanitarie (Asl e AO in primis), ai rapporti con lOrdine dei Medici e con lOsservatorio della Sanità Bergamasca, ai rapporti con altre associazioni (con adesione al Forum delle Associazioni di Volontariato Socio Sanitario Bergamasche), con altre componenti del Terzo Settore (mondo del lavoro, cooperazione sociale, comunità ecclesiale) e con le amministrazioni (Tavolo Politico Provinciale con Conferenza dei Sindaci, Provincia, Asl, sindacati, cooperative, Caritas, Forum). 3. Nel frattempo, attraverso una potente e articolata mobilitazione, venne lanciato il Progetto Hospice, con lo slogan Bergamo ha un cuore grande e con la raccolta di oltre 4 miliardi delle vecchie lire, per ristrutturare il padiglione Verga dellarea ex ONP, dato in comodato duso dallAsl. Lassociazione dichiarò subito di non voler assumere la gestione diretta dellhospice, ma di volerlo donare agli Ospedali Riuniti di Bergamo per realizzare il primo organico esempio di gestione pubblica, con creazione della UOCP e quattro livelli di servizio (degenza in hospice, day-hospital, ambulatori, consulenza sul territorio). 4. Da allora il modello Bergamo si articola attraverso uneccellente gestione pubblica della UOCP degli Ospedali Riuniti, grazie anche al supporto di alcuni contratti aggiuntivi finanziati dallAssociazione e grazie alla massiccia presenza di volontari soprattutto allinterno dellhospice. Evidenziamo leccellente conduzione dellhospice e labbinamento del day-hospital e degli ambulatori, attivi questi ultimi anche sul dolore benigno. È notevole lattività di formazione e comunicazione verso le diverse figure professionali e verso lopinione pubblica; lUOCP è determinante nella conduzione del Comitato Ospedale Senza Dolore degli Ospedali Riuniti e, presto, verso altre aziende e verso il territorio. Cè un ruolo diretto di supervisione dellADI in alcuni distretti, attraverso la presenza di due medici dellUOCP, e il futuro ruolo di consulenza e coordinamento attraverso la Centrale Operativa Provinciale, verso i medici palliativisti a gettone convenzionati con lAsl, verso gli Infermieri Senior Professional dellAsl e verso i pattanti accreditati per lADI di cure palliative, a seguito della esternalizzazione del servizio precedentemente gestito direttamente dalla équipe dellAsl stessa. È positivo il continuo coordino con laltro hospice ospedaliero attivo in provincia (quello del privato cattolico, Istituto Palazzolo, accreditato) e con quello residenziale (sempre del privato cattolico, a Gorlago). Si sta operando per una ampia apertura e accelerazione verso altre patologie, soprattutto neurologiche e cardiovascolari, pur permanendo una consistente prevalenza della terminalità oncologica. 105 5. 106 Non riteniamo per noi sostenibile una gestione diretta di tutta lassistenza domiciliare provinciale in ottica di ospedalizzazione domiciliare, data anche la conformazione del territorio con enclavi difficilmente raggiungibili, con conseguente spreco eccessivo di risorse e scarso utilizzo qualitativo e quantitativo delle stesse. Ribadiamo la priorità della gestione pubblica del servizio di cura e assistenza ai malati terminali e sottolineiamo il relativo LEA, con centralità della UOCP e dellhospice ospedaliero, con funzione dappoggio del day-hospital e degli ambulatori, con ruolo di coordino e consulenza sullintera rete sia nelle aziende ospedaliere sia nelle altre strutture di degenza e su tutto il territorio con lADI. La nostra sussidiarietà, come associazione di volontariato, consiste nello stimolo al miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio. Perché viene privilegiato il ricovero in hospice? Occorre risolvere i limiti della rete sanitaria e assistenziale: dimissioni protette, assistenza domiciliare, ruolo dei medici di medicina generale. Procediamo verso la Centrale Operativa Provinciale. Centinaia di malati hanno usufruito fino ad oggi del ricovero nelle 12 stanze dellhospice di Borgo Palazzo, realizzato dallAssociazione Cure Palliative e gestito dalla struttura pubblica degli Ospedali Riuniti: ne hanno apprezzato la grande professionalità, lalto livello di assistenza e comfort, lattenzione e umanità di tutto il personale e dei nostri volontari, la totale gratuità. Purtroppo, a volte soprattutto in alcuni periodi, le liste di attesa sono consistenti, e nei colloqui, che precedono leventuale ricovero, si apprende che è necessario aspettare o cercare una soluzione alternativa, in una situazione in cui il tempo per aspettare sicuramente non cè, lo stato danimo per cercare è minato dalla gravità della emergenza e le alternative sono quasi impossibili. Infatti anche laltro hospice ospedaliero esistente a Bergamo, quello dellIstituto Palazzolo (gestito dal privato cattolico accreditato e, come tale, anchesso gratuito), ha liste dattesa. A Gorlago ci sono alcuni letti in un hospice residenziale, cioè con caratteristiche socio - sanitarie e con minor presidio medico-infermieristico: anche questi letti non risolvono il problema delle liste dattesa, e comunque va chiarito che molti medici e molti parenti dei malati hanno già più volte espresso il loro disorientamento rispetto a questa categoria di hospice, prevista e realizzata nella Regione Lombardia, in base a una delibera che prevede due diversi livelli di accreditamento, quello ospedaliero e quello residenziale che diventa quasi di serie b. Non ci stancheremo mai di ripetere che cura e assistenza dei malati terminali fanno parte dei LEA (livelli essenziali di assistenza); devono prevedere la totale gratuità sia in degenza che a domicilio; devono essere finanziati con i fondi sanitari e richiedono una gestione sanitaria, con una supervisione specializzata dei palliativisti e dei terapisti del dolore: va da sé che cura e assistenza totale, come previsto nelle cure palliative, richiedono interventi a tutto campo (compresi gli aspetti sociali, psicologici, spirituali...), ma questa è una questione di completezza e non certo un pretesto per spostare il problema verso una gestione prevalentemente sociale, con abbassamento dei livelli di cura e assistenza. 107 Ma torniamo al dunque: ci sono in ogni caso liste dattesa, anche se ci troviamo nella provincia che ha il maggior tasso di copertura con i posti lettohospice presenti (la Regione prevede una unità operativa di cure palliative con hospice ogni 500.000 abitanti). I posti potrebbero essere quasi sufficienti, se funzionasse lintera rete di riferimento, ma il problema è proprio questo. 108 a. La degenza in hospice è una soluzione opportuna nel 20-25% dei casi: quando la complessità o articolazione dei sintomi richiede molteplici interventi medico - infermieristici non gestibili a casa; quando labitazione è inadatta e disagevole o non ci sono parenti e amici disponibili per lassistenza; quando le strutture di assistenza domiciliare non esistono o non sono in grado di coprire correttamente il sevizio ... La situazione è aggravata da alcune carenze della rete ospedaliera, così come è oggi: al di fuori dei reparti specialistici (in cui la degenza è possibile per i giorni strettamente necessari e con costi elevati per la comunità), non è stata creata una rete più leggera per post-acuzie, per riabilitazione, per lungodegenza, per sollievo. Nelliter estremamente complesso e variegato, che va dalla diagnosi di inguaribilità alla cura e assistenza per la miglior qualità di vita possibile fino alla fine, fra il reparto - ormai inadatto per le esigenze del malato terminale - e lhospice rischia di esserci il nulla, cosa che comporta talvolta una impropria permanenza del malato in ospedale, con interventi invasivi, inappropriati, inutili, e comporta talvolta laccelerazione dellopzione dellhospice, per evitare il vuoto terapeutico e assistenziale. Ma tutto ciò evidenzia che è il caso di riprendere in mano il problema con organicità, coinvolgendo tutte le professionalità impegnate, evitando approcci unilaterali e superficiali. b. La rete distrettuale dellADI (assistenza domiciliare integrata) dellAsl è in totale dismissione in applicazione delle direttive regionali e della scelta di spostare lassistenza su strutture prevalentemente private di pattanti (quasi sempre cooperative), che si fanno carico dellassistenza, spesso mescolando i livelli più bassi (che sanno gestire abbastanza bene) con i livelli più complessi (di cui spesso ignorano le implicazioni e complicazioni): il tutto è remunerato attraverso lAsl, con il voucher, tariffa onnicomprensiva a pacchetto che, nel caso dei malati terminali (a cui corrisponde la tariffa più alta), arriva regionalmente a 619 euro al mese, cifra assolutamente inadeguata a svolgere il carico di cura e assistenza, al di là delle considerazioni già fatte sulla necessità di una gestione sanitaria e specialistica. In questa situazione le cooperative riescono a coprire il servizio, in quantità e qualità, per i livelli più bassi dellassistenza domiciliare, ma resta sempre più sguarnito il livello dei pazienti critici e delle cure palliative; sono sempre meno i casi di malati inseriti nellADI - Cure Palliative; sono sempre di più i casi di malati e famiglie in crisi totale, perché privi di riferimento ed ecco perché aumentano enormemente le richieste di ricovero in hospice e crescono le liste di attesa, in assenza di quella alternativa dellADI, che dovrebbe essere lopzione prevalente da utilizzare. c. Nei colloqui pre-ricovero e nelle liste di attesa hanno diritto di priorità i casi più gravi e complessi (sia dal punto di vista medico che sociale). Essere allinterno di un programma ADI e quindi di una procedura avviata dal proprio medico di medicina generale e da lui seguita insieme alléquipe domiciliare, oppure provenire da un reparto ospedaliero attraverso una procedura di trasferimento da reparto a hospice o attraverso le cosiddette dimissioni protette o programmate sono premesse importanti nella valutazione delle liste di attesa. Ma qui nascono altri problemi. Il medico di medicina generale: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ha attivato la procedura ADI e la sta seguendo con léquipe domiciliare? sa che basta un fax o una telefonata per chiedere il colloquio in hospice? non ha attivato la procedura perché nella sua area lADI non funziona? in tal caso, come e per quanto egli è in grado di seguire il malato con il numero necessario di interventi, 7 giorni su 7, e con ladeguata conoscenza della terapia del dolore e delle cure palliative ? sa che può avere il supporto e la consulenza dellUnità di Cure Palliative in hospice? sa che uneventuale emergenza notturna o nel fine settimana coperta in modo generico dalla guardia medica (continuità assistenziale) porta nella maggioranza dei casi a interventi inopportuni e spesso a un errato ricorso al Pronto Soccorso? si sta attivando nella sua zona per associarsi ad altri colleghi (con recapito di riferimento, personale infermieristico, reperibilità 7 giorni x 24 ore) e diventare così costante ed elevato punto di riferimento per ogni esigenza dei malati? Il medico ospedaliero 1. accertata linguaribilità e valutata la prognosi, sa che è fondamentale o il raccordo con lhospice o la corretta e minuziosa procedura di dimis- 109 2. sioni protette per il ritorno al medico di medicina generale e lavvio dellADI? sa che il raffronto consulenziale con lUnità Operativa di Cure Palliative e con i terapisti del dolore è una opportunità sempre aperta, che può agevolare nel miglior modo liter del paziente in reparto e poi le sue dimissioni, senza accanimenti e senza abbandoni ? Sappiamo veramente tutti (e ne abbiamo tratto le conseguenze) che solo in ottica di rete, con tutte le necessarie interconnessioni, si può garantire ladeguato e doveroso livello di cura e assistenza al malato terminale? 110 d. Lopzione della degenza in hospice, gestita nellambito delle altre opzioni possibili dal reparto al sollievo al domicilio, riguarda tutte le patologie in fase terminale, anche se numericamente prevale quella oncologica. Lhospice non deve essere vissuto come lultima spiaggia, riservato quasi alla fase pre-agonica e anticamera della morte: è un drammatico equivoco che priva i malati della preziosa opportunità di usufruire di una struttura e di un modello di cura e assistenza veramente adeguato alla complessità di questo passaggio. Inoltre si fa carico contestualmente della famiglia, coinvolgendola come soggetto e oggetto della cura stessa: non a caso le camere singole dellhospice hanno il letto aggiunto per il parente e la struttura è aperta alle visite 24 ore per 365 giorni. Se fossero ben utilizzate strutture post acuzie, riabilitazione, lungodegenza, sollievo, oltre che lassistenza domiciliare integrata e la corretta gestione del percorso terapeutico da parte del medico curante, sicuramente le liste di attesa, nellhospice di Borgo Palazzo così come negli altri hospices, andrebbero diminuendo e si potrebbe operare ancor meglio con i malati ricoverati e con le loro famiglie, ottenendo un ulteriore ampliamento del periodo di degenza medio (oggi attestato sui 17-18 giorni, per il permanere di numerosi casi di ricovero più che tardivo, quasi pre-agonico) e una crescita percentuale di ricoveri di sollievo, con dimissioni successive, anche per esorcizzare la visione unilaterale (demotivante per i medici del territorio e dei reparti, per i parenti, per i malati) che indica lhospice come luogo ove si entra ma non si esce, tesi e visione estremistiche che privano le cure palliative dei loro contenuti essenziali, cioè prendersi cura in modo totale del malato, renderlo partecipe con il grado di consapevolezza che desidera senza chiudere mai alla speranza della miglior qualità di vita fino alla fine. e. Per anni abbiamo fatto assistenza domiciliare in sinergia con lAsl (allora Ussl) e con il Centro di terapia del dolore e cure palliative di Aneste- sia II degli OO. RR. Poi, grazie alla generosità dei bergamaschi, abbiamo creato lhospice di Borgo Palazzo e labbiamo passato per la gestione pubblica agli Ospedali Riuniti. Poi abbiamo garantito il potenziamento del personale medico - infermieristico con altri fondi e la massiccia presenza di volontari in hospice e day-hospital. Poi abbiamo dato allAsl la nostra disponibilità a creare e sostenere la Centrale Operativa di Cure Palliative e Domiciliarità, per garantire un numero verde e un riferimento unico di consulenza a livello provinciale. Cè molto da fare, anche a livello di formazione e informazione dei medici e del personale socio- sanitario in generale; cè ancora molto da fare a livello di comunicazione e sensibilizzazione dellopinione pubblica e affermazione del diritto al LEA per la terminalità; cè molto da fare per dare stabilità allalto livello dellhospice e alla sua capacità di risposta ai bisogni degli utenti; cè moltissimo da fare per lassistenza domiciliare capillare ed efficiente e il buon funzionamento di una rete ben coordinata e ben diretta. Diamo la nostra piena disponibilità e chiamiamo tutti al massimo di collaborazione. 111 Centrale operativa di cure palliative e domiciliarità Da quando, a marzo 2005, Asl, Ospedali Riuniti, Associazione Cure Palliative e Lega per la lotta contro i tumori hanno firmato il protocollo dintesa si è fatta molta strada: a. sono terminati i lavori murari e di arredo della sede, collocata proprio sotto lhospice, nello stesso Padiglione Verga e da settembre sono operativi, con le necessarie linee telefoniche; b. il coordinamento tecnico si è riunito più volte, ha analizzato i dati pregressi dellADI, ha steso lopuscolo operativo della centrale e le linee guida per lerogazione delle cure palliative domiciliari: sono stati creati tre Voucher Super per i Piani di Assistenza Individuali (PAI) del valore di 769, 879 e 1020 euro; c. sono stati riuniti i medici palliativisti a gettone, già operanti con precedenti contratti Asl; i medici di medicina generale; gli infermieri senior professional che coordinano i distretti; i pattanti, cioè le realtà accreditate per lassistenza domiciliare sul territorio provinciale; d. sono stati fatti due corsi di formazione di quattro incontri ciascuno (16 ore) con oltre 100 partecipanti, soprattutto infermieri professionali e operatori socio sanitari. Ora si entra nelloperatività vera e propria: nella prima fase il centralino e gli operatori della centrale sono contattabili, solo per i casi già arruolati in ADI, dai pattanti, dai medici di medicina generale, dalla guardia medica; successivamente anche gli utenti potranno rivolgersi alla centrale. Il numero telefonico è 035.385.394. Da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18 e sabato dalle 8 alle 12 risponde un operatore della centrale. Da lunedì a venerdì dalle 18 alle 8 e da sabato alle 12 fino a lunedì alle 8 risponde un operatore dellhospice di Borgo Palazzo. 112 Aiutateci a rafforzare la rete di cure palliative nella nostra provincia Nellultima riunione del direttivo, la nostra associazione ha approvato le priorità programmatiche e ha stanziato altri 300.000 Euro per migliorare e consolidare la cura e lassistenza ai malati in fase avanzata, sia in degenza che a domicilio. Al primo posto resta il potenziamento delléquipe medico-infermieristica dellUnità di Cure Palliative degli Ospedali Riuniti: con i fondi da noi versati sono garantiti fino al 2008 i contratti aggiuntivi presso lhospice di Borgo Palazzo per un medico palliativista, per una psicologa, per una ausiliaria e per alcune ore settimanali di altre figure di supporto (riflessologa, musicoterapista, fisioterapista). Anche sul piano qualitativo, lACP continua a finanziare molteplici iniziative di formazione, favorendo la partecipazione degli operatori sanitari a corsi, convegni, congressi e master. Centralità del malato, qualità di vita, qualità di cura e assistenza sono le nostre priorità assolute. Di grande rilevanza è lobiettivo di crescita dei nostri volontari per garantire una vera e propria integrazione con gli operatori sanitari: larticolazione delle iniziative di formazione permanente, con la supervisione della psicologa, si coniuga ormai con stimolanti gruppi di approfondimento e di dibattito (accoglienza, attività diversionali, auto-mutuo-aiuto) e con percorsi informativi formativi strutturati. Al di là di facili semplificazioni, il progetto di integrare organicamente i volontari nelléquipe (e nei progetti personalizzati di cura e assistenza) non è cosa da poco e passa attraverso una crescita teorica e pratica dei volontari, nel pieno rispetto delle reciproche competenze, ma in una visione sinergica, comune, condivisa. Oltre ai nostri molteplici momenti formativi e informativi interni, sosterremo la partecipazione di nostri volontari a corsi, convegni e congressi a livello nazionale. Cospicue risorse umane e finanziarie saranno rivolte alla Centrale Operativa Cure Palliative e Domiciliarità (nata dal Protocollo dIntesa fra Asl, Ospedali Riuniti, Associazione Cure Palliative e Lega contro i tumori), per coordinare lassistenza domiciliare integrata ai malati in fase avanzata dellintera provincia, garantendo la consulenza della Centrale e dellhospice 24 ore al giorno per 365 giorni allanno. Dopo che la Conferenza Stato-Regioni ha approvato gli standard quantitativi e qualitativi per le Cure Palliative (da raggiungere entro il 2008), diventa fon113 damentale creare e consolidare la rete di assistenza e cura, senza ritardi e senza troppo autocompiacersi dei risultati raggiunti fino ad ora. Mentre lUnità di Cure Palliative e lhospice articoleranno meglio il ruolo di coordinamento e consulenza verso il territorio (operando anche in alcuni distretti con propri medici palliativisti, che hanno concordato questi interventi a domicilio in aggiunta al loro ruolo prioritario in degenza, in day-hospital, in ambulatorio), lAsl, sempre attraverso la Centrale Operativa, sta completando larruolamento di medici palliativisti per le consulenze in tutti i distretti e si sta occupando di supervisionare il lavoro delle équipe accreditate per lADI (e i tre super vouchers) sul territorio e di promuovere momenti di approfondimento e di formazione del personale coinvolto. LAssociazione Cure Palliative, dopo aver sostenuto finanziariamente la partenza della Centrale, conferma la disponibilità per eventuali integrazioni dei fondi da destinare al ruolo dei medici palliativisti (che però, in proiezione, risultano già coperti dalle specifiche voci di spesa previste nel bilancio Asl): laspetto principale di cui si dovrà occupare, in accordo con gli altri soggetti firmatari del Protocollo, sarà quello della comunicazione e del coinvolgimento pieno e responsabile dei medici di medicina generale, nonchè dei reparti ospedalieri pubblici e privati che interagiscono con malattie inguaribili e delle altre strutture di degenza (lungodegenza, riabilitazione, RSD, RSA,...). Un aspetto molto significativo, correlato al punto precedente, è limpegno per la campagna Bergamo insieme contro il dolore, con partecipazione dellOrdine dei Medici, dellOrdine dei Farmacisti, del Tribunale dei diritti del malato, del Forum delle Associazioni di Volontariato Socio Sanitario Bergamasche, della Diocesi e della Conferenza dei Sindaci. Si tratta di estendere nelle altre aziende ospedaliere la interessante e concreta esperienza del Comitato Ospedale Senza Dolore (COSD) degli Ospedali Riuniti, che ha portato a organici percorsi formativi per oltre 800 operatori sanitari e ha già raggiunto lobiettivo in una decina di reparti dellOspedale di rilevare quotidianamente il dolore in cartella clinica per tutti i degenti. Ma la cosa deve estendersi anche alle altre strutture di ricovero e al territorio intero, con attivazione dei medici di medicina generale e con ampia sensibilizzazione della popolazione alle tematiche del dolore e della sofferenza. Non a caso anche lUniversità di Bergamo parteciperà al progetto attraverso alcune ricerche e focus groups con allargamento ad altre professionalità. Ciò significa che lAssociazione Cure Palliative, alla luce degli obiettivi programmatici sopra esplicitati, dedicherà il 2006 a un possente lavoro di comunicazione in primo luogo rafforzando contenuti e circolazione del notiziario Verso Sera, utilizzando anche numeri a 12-16-20 pagine e superando sempre le 6000 copie diffuse per ogni numero. Saranno prodotti materiali specifici di comunicazione mirata. Le numerose iniziative di comunicazione locale (incontri, conferenze, con114 vegni, interventi in sale consiliari, scuole, circoli, oratori, teatri...) saranno ulteriormente potenziate, mentre confermiamo le iniziative di alto profilo che oramai caratterizzano la nostra attività, come il Gran Galà Bergamo al Teatro Donizetti e lutilizzo mirato dei media (quotidiani, periodici, radio e TV). Abbiamo deciso di rilanciare momenti capillari di sensibilizzazione sui temi che ci hanno consentito, in questi 17 anni, di creare nella nostra provincia un retroterra culturale favorevole alle esperienze davanguardia dellhospice e della rete di cure palliative: terapia del dolore e lotta alla sofferenza inutile; qualità di cura e assistenza con attenzione agli aspetti fisici, psicologici, sociali, spirituali; degenza e domicilio in ununica rete coordinata al servizio dei bisogni del malato in fase avanzata e dei suoi parenti; qualità di vita fino alla fine. Ringraziamo gli operatori sanitari che hanno partecipato con disponibilità e convinzione a questi percorsi, che ora, però, si preparano ad un salto di qualità e quantità. Alcuni ritardi e sottovalutazioni (sia a livello di reparti ospedalieri che a livello di territorio) non sono più accettabili e gli obiettivi si spostano più avanti. Il progetto comune che sta alla base del Protocollo dIntesa della Centrale Operativa è un esempio di come ci si può muovere e i soggetti firmatari devono ora dimostrare nella quotidianità di essere in grado di far funzionare la rete o di elevare progressivamente il livello qualitativo e quantitativo di cura e assistenza. Non è più il caso di lamentarsi per il mancato funzionamento delle dimissioni protette dei reparti ospedalieri (con problemi per la continuità terapeutica); non è più il caso di lamentarsi per lo scarso utilizzo degli antidolorifici e degli oppiacei (con assurda persistenza del dolore); non è più il caso di lamentarsi per le scarse attivazioni dellassistenza domiciliare integrata da parte dei medici di medicina generale... Ora che la rete è in concreta costruzione, questi errori del passato non sono più ammissibili né giustificabili. Si tratta di informare e formare gli operatori sanitari perché operino in rete con la Centrale Operativa e con lhospice; si tratta di comunicare alla popolazione che questo servizio cè, è utilissimo, è gratuito, è un diritto garantito dai livelli essenziali di assistenza (LEA). Si tratta poi di individuare e correggere ritardi, omissioni, inefficienze. Ringraziamo i cittadini bergamaschi, gli enti, le aziende, i gruppi associativi che hanno dato costante appoggio e sostegno a questi percorsi e che ci hanno già dichiarato piena disponibilità per gli ulteriori sviluppi. Ai nostri oltre 700 iscritti e alle decine e decine di nostri volontari diciamo ancora una volta che contiamo su di loro per trasformare in realtà questi bei progetti, che sono sicuramente molto impegnativi e che comportano un ulteriore sforzo: ma ne vale la pena e, come sempre, non dobbiamo dimenticare che nella nostra multiforme attività di volontariato diamo molto, ma riceviamo ancor di più di quanto diamo, grazie a relazioni umane ricchissime e con la soddisfazione di affermare significativi livelli di civiltà. 115 ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE aderente a ONLUS Sede operativa: Bergamo, via Borgo Palazzo 130, tel. e fax 035/390687 Sede legale: Bergamo, via Betty Ambiveri 5, tel. e fax 035/321388 Sito internet: www.associazionecurepalliative.it E-mail: [email protected] * La lotta contro i tumori Migliaia di bergamaschi ogni anno si ammalano di tumore. Più della metà guarisce. Tremila di loro ogni anno muoiono di cancro. La lotta contro i tumori esige : 1) prevenzione, ricerca, formazione; 2) cura e percorsi terapeutici mirati per la guarigione; 3) cura e assistenza per la miglior qualità di vita, comunque; 4) assistenza domiciliare ogni qualvolta è possibile e utile; 5) hospice e assistenza totale al malato e alla famiglia. * Le altre malattie inguaribili Anche altre malattie croniche invalidanti (neurologiche, cardiologiche, infettive ...) non consentono la guarigione, ma necessitano di una articolata capacità di cura e assistenza. Questi malati e le loro famiglie ne hanno bisogno e ne hanno diritto. 116 * Dimissioni Protette Anche quando la guarigione non è possibile, il malato può e deve essere curato. Il reparto ospedaliero tradizionale non è più adatto e, attraverso le dimissioni protette, è importante allertare il medico di medicina generale, la famiglia, il territorio, per predisporre il successivo percorso terapeutico. I ricoveri impropri nei reparti, labbandono e laccanimento terapeutico non giovano al malato. * Assistenza Domiciliare Integrata Se il domicilio lo consente, se ci sono parenti presenti, se gli interventi medico infermieristici non sono troppi ... lassistenza a domicilio costituisce una soluzione preferibile per il malato, a patto che sia seguito da una equipe multidisciplinare (medico, infermiera, specialista palliativista; se necessario psicologo, assistente sociale, volontari). Deve essere attivata dal medico di medicina generale. * Terapia del Dolore E inaccettabile che non venga somministrata la corretta terapia del dolore, quando questo è controllabile nel 90 % dei casi. E anche possibile richiedere visite specialistiche utilizzando come riferimento gli ambulatori e gli specialisti di terapia del dolore (anche benigno) presso lHospice di via Borgo Palazzo: tel 035/390620, fax 035/ 390623. In questa area ci sono anche 4 letti di day - hospital per i malati che possono restare a domicilio ma necessitano di particolari procedure in degenza diurna. * Cure Palliative e Centrale Operativa Palliative deriva da pallium, il mantello dei Romani che proteggeva tutto: le cure palliative sono cure totali che si occupano di tutti gli aspetti della sofferenza, fisica, psicologica, spirituale, sociale. Al centro cè il malato e la sua qualità di vita. Anche i parenti vengono coinvolti nel percorso. Lequipe, con medico palliativista, infermiera professionale, psicologo ..., lavora con questi obiettivi e si avvale anche dellaiuto dei volontari, soprattutto per attività diversionali, compagnia, ascolto, accompagnamento. Lequipe garantisce la continuità del percorso terapeutico, fra i reparti, il territorio e lhospice, in sinergia con il ruolo del medico di medicina generale. LAssociazione Cure Palliative, la Lega per la Lotta contro i Tumori, gli Ospedali Riuniti e lASL hanno costruito insieme, a livello provinciale, la Centrale Operativa di Cure Palliative e Domiciliarità, per il coordinamento, la consulenza e la supervisione della Assistenza Domiciliare Integrata ai malati in fase avanzata. * Hospice Se lopzione del domicilio non è adatta, cè lHospice, una struttura di degenza a dimensione umana, mirata al massimo confort del malato. LHospice di via Borgo Palazzo 130 è stato realizzato dallAssociazione Cure Palliative, grazie alla generosità dei bergamaschi, ed è gestito dagli Ospedali Riuniti. E garantito dal servizio sanitario nazionale e gratuito. Ha 12 camere singole, tutte con letto aggiunto per un parente. Laccesso avviene direttamente dal reparto ospedaliero o attraverso la domanda inoltrata dal medico di medicina generale e successivo colloquio. I numeri dellarea di degenza sono: tel 035/390640, fax 035/390624. * Volontari Assistenza in Hospice, in day-hospital, a domicilio; comunicazione e informazione per sensibilizzare la popolazione; organizzazione di iniziative e raccolta fondi; formazione: ci sono tante cose da fare e abbiamo bisogno del vostro aiuto. Ciascuno di voi può aderire allAssociazione Cure Palliative e darci una mano oppure sostenerci. * I volontari si occupano di assistere gratuitamente in Hospice e a domicilio i malati in fase avanzata * I medici e gli infermieri si occupano di terapia del dolore e cure palliative * Gli associati lavorano per sensibilizzare la popolazione sui problemi della terminalità * Tutti insieme siamo impegnati a raccogliere i fondi e a sostenere lHospice 117 Una grigliata nel parco, una festa di laurea, un matrimonio, i giochi e i disegni dei nipotini, la visita del cagnolino, i regali di Natale... Anche questa è la vita vissuta nella quotidianità dellhospice. 118 119 Glossario ACP ADI AO ASL CO COSD CP DG DH DS FCP MMG ONLUS ONP OO RR PLS SICP UCP UOCP USC USCCP USSL TD 120 Associazione Cure Palliative Assistenza Domiciliare Integrata Azienda Ospedaliera Azienda Sanitaria Locale Centrale Operativa Comitato Ospedale Senza Dolore Cure Palliative Direttore Generale Day Hospital Direttore Sanitario Federazione Cure Palliative Medico di Medicina Generale Organizzazione Non Lucrativa dUtilità Sociale Organizzazione Non Profit Ospedali Riuniti Pediatra di Libera Scelta Società Italiana di Cure Palliative Unità di Cure Palliative Unità Operativa di Cure Palliative Unità Struttura Complessa Unità Struttura Complessa Cure Palliative Unità Socio-Sanitaria Locale Terapia del Dolore Bibliografia Introduzione Incontro tra due libertà. Arendt, H., Vita activa. La condizione umana, Bompiani, 1964. Ingold, T., Ecologia della cultura, Meltemi, 2001. Panikkar, R., La nuova innocenza, Servitium, 2003. Una rete di cure palliative Barbetta, G., Maggio, F., Non profit, Il Mulino, 2002. Zamagni, S., Non profit italiano al bivio, Egea, 2002. Marzano, M., Scene finali, Il Mulino, 2004. Gordon, D., Peruselli, C., Narrazione e fine della vita, Franco Angeli, 2001. SICP-FCP, Proposte di requisiti minimi tecnologici, strutturali e organizzativi, Ior, 2003. Amadori, D., De Conno, F., Libro italiano di cure palliative, Poietto, 2003. Marzi, A., Martini, A, Lhospice al servizio del malato oncologico grave e della sua famiglia, McGraw-Hill, 2004. Callahan, D., La medicina impossibile, Baldini & Castoldi, 2000. Sguardi emozionanti Borgna, E., Lattesa e la speranza, Feltrinelli, 1999. Un cammino di ricerca tra emozione e razionalità Mantovani, G., e Spagnolli, A., Metodi qualitativi in psicologia, Il Mulino, 2003. Cardano, M., Ricerca sociale, Libreria Stampatori Torino, 2004. Marzano, M., Scene finali, Il Mulino, 2004. Atkinson, R., Lintevista narrativa, Cortina, 2002. Ochs, E. e Capps, L., Costructing Panic, Harvard University Press, 2000. Gobo, G., Le risposte e il loro contesto, Franco Angeli, 2000. Mazzara, M., Metodi qualitativi in psicologia sociale, Carocci, 2002. Russo, M., Elementi di qualità nella ricerca sociale, Edizioni Goliardiche, Urbino 2000. Il frastuono del silenzio: metafora di un ascolto interiore Borgna, E., Noi siamo un colloquio, Feltrinelli, 1999. 121 Gadamer, H.G, Dove si nasconde la salute, Raffaello Cortina Editore, 1994. Dickinson, E., Tutte le poesie, Mondatori, 1995. Insieme in silenzio Jankovic, M., Ascoltare il bambino emato-oncologico per migliorarne la qualità di vita, in RiCP, vol. 6, n 2/2004. Sobrietà Zambrano, M., Dellaurora, Marietti, Genova 2000. Weil, S., Quaderni II, Adelphi, 1985. Mortari, L., Genere ed educazione, in G. Galeazzi (a cura), Ripensare la sofferenza, Città Aperta, 2004. Fizzotti, E., Soffrire con dignità, in G. Galeazzi (a cura), Ripensare la sofferenza, cit. Frankl, V.E., Homo patiens. Soffrire con dignità, Queriniana, 20012. Zambrano, M., Per una storia della pietà, in Aut Aut, 279, 1997. Petrosino, S., Piccola metafisica della luce, Jaca Book, 2004. Formazione, medicina e terminalità Atlan, H., Razionalità scientifica e razionalità del mito in Donghi P., Preta L., In principio era la cura, Laterza, 1995. Cavicchi, I., Ripensare la medicina, Bollati Boringhieri, 2004. Cernetti, G., Semmelweis, Céline, la morte in Céline L.F., Il dottor Semmelweis, Adelphi, 1979. Bichat, X., Recherches physiologiques sur la vie et la mort, Brosson Gabon, 1805. Dianzani, U., Istituzioni di patologia generale 3, Utet, 2000. Marzano, M., Scene finali. Il Mulino, 2004. Etica e vivere bene. Conversazione con P. Ricoeur in A.A..V.V., Il male, Cortina, 2000. Jasper, K., Der Artz im technischen Zeitalter (ed. it. Il medico nelletà della tecnica, Cortina, 1991). Gadamer, H-G., Uber die Verborgenheit der Gesundheit (ed. it. Dove si nasconde la salute, Cortina, 1994). The Editors, The Practice of Medicine in Harrisons Principle of Internal Medicine, McGraw-Hill, 1998. Cosa è che supera la sofferenza e il dolore? Carpenito, L.J., Diagnosi infermieristiche. Applicazione alla pratica clinica, C.E.A, 1998. Zavoli, S., Il dolore inutile. La pena in più del malato. Garzanti, 2002. La morte e il morire. Terapie, cure palliative e relazioni nelle fasi terminali 122 delle malattie cerebrali invalidanti, V Convegno regionale, Bergamo 24 Settembre 2005. La musicoterapia e la persona affetta da demenza, Corso di formazione, Lecco, 26 novembre 2005. Siti internet: www.evidencebasednursering.it/terapie.htm Vorrei raccontare una storia Canevaro, A., Gaudreau, J., Leducazione degli handicappati, Carocci, 2002. Dovigo, F., Abitare la salute, Franco Angeli, 2004. Lizzola, I., Aver cura della vita, Città Aperta, 2002. Meneghini, R., Lassistente educatore nella scuola, Tannini, 2001. Incrociamo gli sguardi Chenu, B., Tracce del volto. Dalla parola allo sguardo, Qiqajon, 1996. Carotenuto, A., Leclissi dello sguardo, Bompiani 1997. Dickinson, E., Tutte le poesie, Mondadori, 1995. Gibran, K., Il profeta, SE, 1992) Ricerca di un senso al vivere e al morire Guardini, R., Persona e libertà, La Scuola, 1987. Jankèlèvitch, V., Pensare la morte?, Cortina, 1995. Guardini, R., Persona e libertà, La Scuola, 1987. Pinkus, L.,Lintegrazione della dimensione personale e della dimensione professionale nellassistenza al malato terminale, in Bonetti, M., Rossi, M., Viafora, C. (a cura di), Silenzi e parole negli ultimi giorni di vita, Franco Angeli, 2003. Roveda, P., Verso un significato della sofferenza, in Pedagogia e Vita, n. 3, 2003. 123 Per la Federazione Cure Palliative visitate il sito: www.fedcp.org Per la Sociatà Italiana di Cure Palliative visitate il sito: www.socp.it Per lAssociazione Cure Palliative visitate il sito: www.associazionecurepalliative.it 124 NOTA Questo volume arriva gratuitamente a tutti gli associati e ai lettori stabili di Verso Sera (è un supplemento al n. 24). E una scelta di ampia circolazione e profonda comunicazione, che facciamo volentieri: ci pare corretto, però, chiedere a tutti coloro che lo ricevono di sostenere ulteriormente, attraverso una sottoscrizione, le nostre iniziative per lhospice, per la centrale operativa, per la qualità di cura e assistenza ai malati in fase avanzata, per la sensibilizzazione su terapia del dolore e cure palliative. BERGAMO HA UN GRANDE ACP - Associazione Cure Palliative ONLUS Per lassistenza domiciliare e per lHospice ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO Presso tutti gli sportelli bancari, potete fare versamenti su: C/C 18350 Credito Bergamasco ABI 03336 CAB 11102 CIN W C/C 14010 Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino ABI 05428 CAB 11108 CIN J Presso gli uffici postali: C/C postale 15826241 tutti intestati: Associazione Cure Palliative 125 Nella pagina accanto, la mappa e unimmagine dellhospice di Borgo palazzo. ACP - Associazione Cure Palliative - ONLUS Sede legale: Bergamo via Betty Ambiveri , 5 - telefono e fax 035/321388 Codice Fiscale: 95017580168 Sede operativa: 24125 Bergamo via Borgo Palazzo, 130 - telefono e fax 035/390687 VERSO SERA: Notiziario quadrimestrale dellAssociazione Cure Palliative di Bergamo Autorizzazione N. 31 del 25.07.1996 del Tribunale di Bergamo Tariffa Associazioni senza scopo di lucro: Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Filiale di Bergamo Direttore responsabile: Arnaldo Minetti Stampa: Artigrafiche Mariani e Monti, Ponteranica (BG) Supplemento n. 2 al n. 24 - febbraio - maggio 2006 126 aderente a 127 128 Finito di stampare nel mese di Marzo 2006 da Artigrafiche Mariani & Monti srl
Scarica