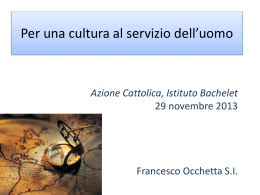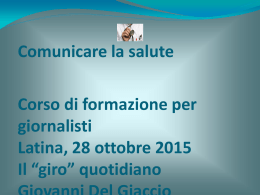Anno XXXIV n. 5 Maggio 2004 Ordine Direzione e redazione Via Appiani, 2 - 20121 Milano Telefono: 02 63 61 171 Telefax: 02 65 54 307 dei giornalisti della Lombardia http://www.odg.mi.it e-mail:[email protected] Spedizione in a.p. (45%) Comma 20 (lettera b) dell’art. 2 della legge n. 662/96 Filiale di Milano Associazione “Walter Tobagi” per la Formazione al Giornalismo Istituto “Carlo De Martino” per la Formazione al Giornalismo L’appuntamento è per eleggere i 9 consiglieri regionali e i 25 nazionali nonché i 3 revisori dei conti Giornalisti al voto il 23/24 e il 30/31 maggio Il Consiglio ha deciso di aprire soltanto il seggio di Milano. Ai giornalisti che abitano fuori provincia e che raggiungeranno Milano per votare verrà rimborsato il biglietto utilizzato sui mezzi pubblici Milano, 26 marzo 2004. Gli iscritti all’elenco professionisti e a quello pubblicisti dell’Albo di Milano saranno convocati in assemblea per l’elezione dei consiglieri regionali e di 25 consiglieri nazionali (14 professionisti e 11 pubblicisti) dell’Ordine. Le operazioni elettorali si svolgeranno, in seconda convocazione valida qualunque sia il numero degli intervenuti, il 23 e 24 maggio. Il ballottaggio, invece, si terrà il 30 e 31 maggio. Il Consiglio regionale è formato da sei professionisti e tre pubblicisti. Il Collegio dei revisori dei conti annovera due professionisti e un pubblicista. Si voterà, come negli anni passati, nella Sala Orlando dell’Unione del Commercio di Corso Venezia 49. Qui saranno collocate 30 cabine, capaci di smaltire 600 persone in un’ora. La sala di 600 mq è dotata di 600 poltrone. Le operazioni elettorali di prima convocazione (16 maggio) si svolgeranno nella sede dell’Ordine di via Appiani 2 anche se si sa in partenza che saranno da considerare nulle, in quanto è impossibile ipotizzare che votino il 50%+1 dei circa 17mila giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli elenchi dell’Albo. Non è ammesso il voto per corrispondenza o per delega. I professionisti votano soltanto per i professionisti e i pubblicisti soltanto per i pubblicisti. Il Consiglio, nella seduta del 23 febbraio, ha deciso di aprire soltanto il seggio di Milano: ai giornalisti che abitano fuori della provincia di Milano e che raggiungeranno Milano per votare, verrà rimborsato il biglietto utilizzato sui mezzi pubblici. Ed ecco il testo della lettera di convocazione dell’Assemblea elettorale: OGGETTO: elezione dei componenti del Consiglio regionale e del Collegio dei revisori dei conti dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia nonché di 25 consiglieri lombardi (14 professionisti e 11 pubblicisti) dell’Ordine nazionale dei Giornalisti. Avviso per posta (ex art. 3 DlgsLgt n. 382/1944 ed ex delibera 23 febbraio/22 marzo 2004 approvata con voto unanime dal Consiglio dell’OgL e ratificata all’unanimità dall’Assemblea degli iscritti all’Albo tenutasi il 25 marzo 2004 al Circolo della Stampa di Milano). In ottemperanza agli articoli 3, 4, 5, 6, 10 e 16 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 e agli articoli 5, 6, 7 e 16 del Regolamento (Dpr n. 115/1965) per l’esecuzione della legge stessa, gli iscritti all’elenco professionisti e a quello pubblicisti dell’Albo vengono convocati in assemblea per la elezione dei componenti del Consiglio regionale e di 25 consiglieri nazionali (14 professionisti e 11 pubblicisti). La prima convocazione dell’Assemblea degli iscritti è fissata per domenica 16 maggio 2004 (dalle 10 alle 18 con un unico seggio ubicato presso la sede dell’Ordine, via Appiani 2, Milano). Ti ricordo che, ai sensi dell’art. 4 (3° comma) della legge n. 69/1963, <l’assemblea è valida in prima convocazione, quando intervenga almeno la metà degli iscritti>. Le operazioni elettorali si svolgeranno poi in seconda convocazione valida qualunque sia il numero degli intervenuti (articolo 4, terzo comma, della legge professionale). In base agli articoli 9 (terzo comma) e 11 (terzo comma) del Regolamento, NE DI OR IER SS O ID ORDINE Le urne saranno aperte in Corso Venezia 49 L’ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE viene fissata a Milano in Corso Venezia 49 (presso la sala Orlando dell’Unione del Commercio Turismo e ServiziCts) in due giorni consecutivi per Ove non sia raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procederà, in un’assemblea successiva, a votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere. L’assemblea per la votazione di ballottaggio viene fissata a Milano in Corso Venezia 49 (presso la sala Orlando dell’Unione del Commercio) in due giorni consecutivi per DOMENICA 23 MAGGIO 2004 dalle ore 9,45 alle ore 13,15 e DOMENICA 30 MAGGIO 2004 dalle ore 9,45 alle 13,15 LUNEDI’ 24 MAGGIO 2004 dalle ore 9,30 alle ore 14 LUNEDI’ 31 MAGGIO 2004 dalle ore 9,30 alle 14 NON È AMMESSO IL VOTO PER CORRISPONDENZA O PER DELEGA Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. NORME Dovranno essere eletti: - per il Consiglio Regionale 6 professionisti 3 pubblicisti - per il Collegio dei Revisori dei conti 2 professionisti 1 pubblicista - per il Consiglio Nazionale 14 professionisti 11 pubblicisti Il voto si esprime mediante apposite schede da ritirarsi presso il seggio all’atto della votazione, recanti l’indicazione delle righe in bianco sulle quali l’elettore dovrà scrivere materialmente i nomi prescelti. I professionisti votano solo per i professionisti e i pubblicisti solo per i pubblicisti. TI IS Tutte le regole L NA R delle elezioni coordinate O GI I e spiegate con l’aiuto DE Sono eleggibili (e possono essere votati anche se non hanno espresso la volontà di candidarsi) tutti gli iscritti all’Albo, professionisti e pubblicisti, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione (articolo 3 della legge professionale) nel rispettivo elenco. I consiglieri uscenti sono rieleggibili. Sono elettori gli iscritti in regola con il pagamento delle quote annuali. Coloro che non sono in regola potranno provvedere al pagamento delle quote dovute presso il seggio elettorale dove verrà istituito apposito ufficio con l’incarico di riscuotere le quote e rilasciare un certificato attestante l’avvenuto pagamento. Solo la presentazione al seggio di questo certificato consente l’ammissione a votare (articolo 10, secondo comma, del Regolamento). prof. Francesco Abruzzo presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e dell’Assemblea degli iscritti SOMMARIO Mobbing della giurisprudenza Ricorso crescente dei giornalisti alla psicoterapia “vero e proprio campanello d’allarme” pag. 2 pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 5 6 7 8 12 16 18 22 24 http://www.odg.mi.it/reg_voto.htm E IN RD O “ DI ” ID LO B TA Notizie. Leggerle, scriverle per la maturità Inserto speciale all’interno di Paola Pastacaldi 5 BALLOTTAGGIO 2004 Free-lance Giornalismo e dintorni Proposta di legge “rivoluzionaria” Intervista al direttore di “Reset” Giancarlo Bosetti Negli Usa esplode lo scandalo del “copia e incolla” Tesi di laurea La “ Voce” di Indro Montanelli Giornalismo e giustizia Pm e giudici devono indagare sui loro collaboratori Professione Uffici stampa della PA e trattative Fnsi-Aran Memoria Gaetano Baldacci, l’uomo del Giorno La libreria di Tabloid Torna la “Storia di Milano” del Verri Le recensioni del mese 1 Convegno a Roma sul tema “Se il giornale dà il mal di capo”, organiz SALUTE, COSTITUZIONE, CODICE CIVILE E CODICE PENALE MOBBING Ricorso crescente dei giornalisti alla psicote Roma, 23 marzo 2004. Da novembre 2002, data della sua apertura, ad oggi, lo Sportello Mobbing della Stampa Romana, ha raccolto oltre cinquanta denunce, di cui oltre la metà ritenute ‘gravi’ dai medici e dai consulenti legali che le hanno esaminate. Una realtà che interessa testate grandi e piccole, tv e radio sia pubbliche che private, agenzie di stampa e che, probabilmente, è solo la punta dell’iceberg. Se ne è discusso oggi a Roma nel corso del convegno “Se il giornale dà il mal di capo”, organizzato dall’Associazione stampa romana e dall’Ucsi-Unione cattolica della stampa italiana, non solo per fare il punto sul lavoro svolto in poco più di un anno, ma anche e soprattutto per svelare quanto il mobbing sia di casa nelle redazioni, tanto da far pensare, come ha rilevato stamane il segretario di stampa romana, Silvia Garambois, che stia diventando “un insano strumento di governo delle redazioni”. Violenze psicologiche, dispetti, umiliazioni professionali, emarginazione che portano I preoccupanti dati della Casagit a stati d’ansia, stress psicofisico: il mobbing riesce attraverso una serie di meccanismi perversi a mettere in moto reazioni che portano l’organismo ad ammalarsi anche gravemente. I sintomi fisici più diffusi sono le eruzioni cutanee, l’abbassamento delle difese immunitarie (tosse, raffreddore, influenza, maggiore vulnerabilità alle malattie), ma anche disturbi tiroidei, cardiaci, problemi delle funzioni gastriche e digestivi. Nel giornalismo il mobbing sembra una specie di malattia congenita: a ogni cambio di direttore corrisponde la marginalizzazione di alcuni redattori e l’ascesa di altri. “La cosa più difficile per il mobbizzato è prendere coscienza del problema - è stato detto stamane - ma bisogna sapere che altri hanno vinto contro questo tipo di violenza. Non lasciarsi convincere di essere il malato o il colpevole della situazione, perché il vero malato è il mobber”. Che si tratti di un problema reale, sempre più sentito nelle redazioni è testimoniato anche dal ricorso crescente da parte dei giornalisti alla psicoterapia. Sono i dati Casagit a parlare e a rappresentare “un vero e proprio campanello d’allarme”, soprattutto se abbinati a quelli di malattie collegabili con lo stress. In Italia una legge per difendersi dal mobbing non esiste. Il più delle volte, i lavoratori che ne sono bersaglio tacciono, subiscono, o si licenziano. Ma la consapevolezza aumenta: lo dimostrano l’aumento delle strutture che sul territorio se ne occupano, Asl o Centri universitari, e l’attenzione che sindacati e categorie di lavoratori sempre più vi pongono. La Stampa romana ha elaborato un Protocollo per i Cdr che delinea i contorni del fenomeno, i metodi e i modi con cui può essere messo in atto e impegna editore, direttore e comitati di redazione a contrastarlo. Un documento che il Segretario della Fnsi, Paolo Serventi Longhi, giudica positivamente e pur mettendo in guardia contro “le eccessive declaratorie, perché le psicosomatizzazioni sono molte”, non esclude che nei prossimi mesi lo si possa inserire nella discussione per il rinnovo del contratto di lavoro dei giornalisti. (Asca) Lo Sportello di Roma finestra sulle violenze morali nelle redazioni intervento di Simonetta Ramogida* Farò un intervento “tecnico” perché spetta a me illustrare il “Protocollo” messo a punto per i Cdr e per la Commissione Contratto. Il testo è stato distribuito nella cartellina, quindi mi limiterò ad esporre gli aspetti principali. Prima, però, vorrei ricordare quello che abbiamo fatto in un anno e mezzo circa di Sportello Mobbing. Lo “Sportello” è nato a novembre 2002 e da allora sono arrivati alla nostra osservazione moltissimi casi di violenze morali nelle redazioni, molti di più di quanti noi stessi potevamo immaginare nel mettere a punto uno strumento in grado di monitorare il fenomeno. Naturalmente lo Sportello, fornisce l’assistenza ai giornalisti, assieme all’ufficio sindacale dell’Associazione Stampa Romana, e avvalendosi dei consulenti legali dell’Associazione. Per gli aspetti che riguardano la salute, invece, indirizziamo i colleghi presso le strutture pubbliche esistenti, dotate di un Centro Antimobbing, come la Asl RME di Viale Tor di Quinto, o il Day Hospital del Policlinico Umberto 1° per citarne solo alcuni. In questo periodo in cui abbiamo operato, sono giunti alla nostra osservazione 26 casi gravi di Mobbing, ma il fenomeno è molto più diffuso, e presente in tutte le realtà, nel senso che interessa i grandi quotidiani, come le radio, le Tv, sia pubblche che private, i grandi network, le agenzie di stampa, gli uffici stampa. È capitato che i Cdr ci chiedessero aiuto anche per le testate straniere che operano a Roma. Al sito www.stamparomana.it sono arrivate anche richieste di aiuto da parte di giornalisti che operano in altre città d’Italia e che sono iscritti ad altre Associazioni territoriali. Ma si sono accostati allo Sportello Mobbing, addirittura un cuoco di Firenze, una infermiera del Policlinico di Roma, un dipendente di una azienda elettrica di Rieti e tanti altri. Noi, abbiamo cercato di fornire le risposte a tutti, anche se lo Sportello Mobbing è nato per i giornalisti. La stesura del “Protocollo” per i Cdr è nata 2 prorio dalla constatazione diretta di quanto sia diffuso il problema. Allora, sulla falsariga di quanto avevano già fatto altre categorie professionali, abbiamo stilato un documento che in risalto che le risorse umane rappresentano il bene più importante e 1 mette significativo per l’azienda, e questo vale anche per le aziende editoriali che le molestie morali, le molestie sessuali, le prevaricazioni di vario 2 sottolinea genere incidono pesantemente sul lavoro, ma anche sulla salute dei giornalisti l’editore, il direttore, il cdr a contrastare nelle redazioni il fenomeno 3 impegna del mobbing che tali comportamenti vengono effettuati in maniera “strategica” per arre4 spiega care offesa alla dignità professionale del dipendente, a nuocere alla sua integrità psicofisica, a far degradare il clima lavorativo fino a determinare la sua espulsione, o la sua autoesclusione addirittura con le dimissioni. 5 dedica un paragrafo alle molestie sessuali: abbiamo osservato che a volte, il mobbing inizia con le molestie sessuali che è fatto divieto all’uso di ogni forma di discriminazione. Lo dice anche 6 afferma la Costituzione, noi elenchiamo i modi attraverso cui può avvenire la discriminazione spiega i disturbi che possono derivare dal Mobbing e in ultimo 7 infine la necessità all’interno dell’azienda della creazione di una Commis8 stabilisce sione composta da rappresentanti aziendali, e rappresentanti dei dipendenti. Tutto questo può anche essere un terreno di lavoro comune con i poligrafici. Infine il proble- ma del danno psicofisico. Su questo aspetto si sono cimentati grossi esperti di mobbing come Harald Ege, Renato Gilioli, e molti altri. I sintomi fisici più diffusi sono le eruzioni cutanee, l’abbassamento delle difese immunitarie (tosse, raffreddore, influenza, maggiore vulnerabilità alle malattie), disturbi tiroidei, disturbi cardiaci come la tachicardia, il senso di oppressione, l’ipertensione, i problemi delle funzioni gastriche e digestive: bulimia, gastrite, ulcera, i disturbi intestinali, i disturbi della sfera sessuale, i dolori osteoarticolari, l’astenia. I sintomi psichici più frequenti sono le manifestazioni psicosomatiche: perdita della concentrazione, di memoria, disturbi del sonno, cefalee, sudorazione, agitazione, irrequietezza, sindromi ansiose, depressione con fissazione del pensiero sul proprio problema, disturbi comportamentali che impediscono la partecipazione alla vita lavorativa, alterazioni della personalità fino al suicidio. Perché abbiamo titolato il nostro comunicato con UN CANNIBALE IN REDAZIONE ? Perché alla luce anche di quanto si è analizzato, il mobber con il suo comportamento è come se intaccasse gli organi vitali del mobbizzato. Garambois, nel suo intervento ha parlato di “comportamenti animaleschi” da parte del mobber, il Professor Piccione ha detto che il mobbing non è una malattia, ma una serie di sintomi. Di mobbing però ci si ammala. Quasi sempre. Con una sintomatologia diversa da persona a persona. Per il Devoto-Oli un “cannibale” è “chi si ciba di carne umana”, ovvero “un uomo crudele, feroce, disumano”. Poiché secondo gli studi più accreditati sul fenomeno del mobbing, il mobber è un “narciso frustrato”, si può immaginare che si nutra famelicamente della mente del mobbizzato (in preda ad attacchi di ansia, panico e depressione), del cuore del mobbizzato (che ha attacchi fino all’infarto. È di qualche tempo fa una sentenza che riconosce il danno biologico ad un soggetto che ha avuto un infarto a seguito delle molestie morali), dello stomaco del mobbizzato (gastriti, problemi dell’alimentazione), della tiroide del mobbizzato (problemi ormonali), e così di seguito. Infine, due parole sul mobbing come strumento in mano all’azienda per governare i processi di riorganizzazione del lavoro e le ristrutturazioni. Il metodo, ho letto da qualche parte ma mi sembra calzante, “è quello di tenere vivo il fuoco di una destabilizzazione permanente per distruggere valore anziché crearlo. Premiare nello stesso tempo tutti coloro che in buona misura più o meno consapevolmente aiutano questo disegno, invertendo così la tanto decantata meritocrazia che gli stessi vertici aziendali sono i primi ad umiliare. Infatti, che senso di fedeltà di appartenenza ad una azienda si può diffondere se l’incoraggiamento a portare a risultati si associa continuamente alle minacce e se le professionalità invece di venire valorizzate e incoraggiate secondo rigore ed equità vengono asservite ad un progetto di destabilizzazione? In questo modo si rafforza, invece, solo lo spirito di cordata”. * Simonetta Ramogida, nata a Roma, dopo la laurea conseguita all’Università la Sapienza di Roma in Scienze Politiche (indirizzo politico economico) con una tesi su “Il dualismo economico:problemi del mercato del lavoro”, consegue il Master in Giornalismo e Comunicazione di massa presso la Libera Università Luiss, mentre si occupa di ricerca economica alla Sapienza (professor Giovanni Caravale) su testi di Ricardo e Sraffa. Inizia la carriera giornalistica a Prima comunicazione dove per diversi anni si occupa di sindacato (vertenze editoriali) e comunicazione (marketing, pubblicità, uffici stampa e relazioni esterne), mentre collabora con l’Anica, di cui cura diverse campagne di comunicazione. Successivamente collabora con l’Agi (redazione economica), l’Ansa (redazione economica), il Messaggero (I nostri soldi, inserto economico sul risparmio) fino ad approdare all’Asca, dove da 15 anni si occupa prevalentemente di finanza (Bankitalia, Borsa, Risparmio, Consob, Banche). ORDINE 5 2004 zato il 23 marzo 2004 dall’Associazione stampa romana e dall’Ucsi Unione cattolica della stampa italiana IN REDAZIONE rapia “vero e proprio campanello d’allarme” Tribunale di Roma versus Rai: “Ha privato con volontà palese un giornalista delle mansioni” Circolare Inail spiega il mobbing strategico Anche nell’attività giornalistica il mobbing comincia ad essere riconosciuto e sanzionato in sede giudiziaria. Lo dimostra l’ordinanza recentemente emessa dalla IV Sezione - Lavoro del Tribunale di Roma in merito al ricorso presentato dal collega Rai Massimo Minisini, inquadrato nella Direzione Canali Innovativi e di Pubblica Utilità, retta da Riccardo Berti. La dott.ssa Tiziana Orrù ha riconosciuto “la gravità e la irreparabilità del danno dipendenti dalla denunciata situazione di mobbing conseguente alla privazione del diritto all’espletamento della prestazione lavorativa”. Emerge dalla documentazione – prosegue l’ordinanza - “la volontà palese di estromettere il ricorrente dalle funzioni esercitate senza attribuzione di incarichi equivalenti”. Si tratta di una vicenda che il magistrato giudica “evidentemente ricostruibile in termini di mobbing in quanto è il frutto di un processo di comportamenti materiali, non autonomamente sanzionabili in quanto formalmente legittimi, che assumono un significato peculiare in quanto tappe di una strategia prefigurata e volta alla totale privazione delle mansioni”. Una simile ordinanza indica che la legge fornisce ulteriori strumenti a tutela dei giornalisti e delle giornaliste contro i sempre più estesi processi di dequalificazione e marginalizzazione professionale in atto nelle redazioni. È un segnale che le aziende editoriali – ed in particolare il servizio pubblico – faranno bene a non trascurare. L’ Inail ha emanato la circolare n. 71 del 17 dicembre 2003, con la quale ha tracciato le modalità di trattazione delle pratiche riguardanti i “Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro. Rischio tutelato e diagnosi di malattia professionale”. Questa circolare, infatti, riporta un esaustivo ed articolato quadro di riferimento che consente, già da ora, di garantire omogeneità e correttezza nella trattazione delle pratiche. Quindi i disturbi psichici possono essere considerati di origine professionale solo se sono causati, o concausati in modo prevalente, da specifiche e particolari condizioni dell’attività e della organizzazione del lavoro. Si ritiene che tali condizioni ricorrano esclusivamente in presenza di situazioni di incongruenza delle scelte in ambito organizzativo, situazioni definibili con l’espressione “costrittività organizzativa”. Nel rischio tutelato può essere compreso anche il cosiddetto “mobbing strategico” specificamente ricollegabile a finalità lavorative. Si ribadisce tuttavia che le azioni finalizzate ad allontanare o emarginare il lavoratore rivestono rilevanza assicurativa solo se si concretizzano in una delle situazioni di “costrittività organizzativa” o in altre ad esse assimilabili. Fonte Università di Catanzaro Link http://www.unicz.it/lavoro/ Consulta: privilegiato il credito di un lavoratore mobbizzato in caso di fallimento dell’azienda Roma, 7 aprile 2004. Da oggi il giornalista demansionato o mobbizzato é più tutelato anche in caso di fallimento dell’azienda. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 113 (depositata ieri in cancelleria) dichiarando illegittima la norma (si tratta dell’articolo 2751 bis del codice civile) che non consentiva di inserire tra i crediti “privilegiati” le somme dovute al lavoratore subordinato per danni da demansionamento - mobbing compreso - subiti a causa dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro. I giudici della Consulta hanno così accolto un’eccezione sollevata dal tribunale di Ferrara, secondo cui era incostituzionale includere il credito del lavoratore tra quelli “chirografari” - cioé senza adeguate garanzie di recupero - anziché tra quelli “privilegiati”. Pierluigi Franz presidente Associazione stampa romana Silvia Garambois, segretario Associazione stampa romana Roberto Natale, segretario Usigrai l mal di redazione? Esiste. E negli ultimi anni la febbre del disagio, negli ambienti giornalistici, è sicuramente salita. La denuncia, per la prima volta in un quadro consapevole di dati e riferimenti, cinque anni fa, accendendo un piccolo spot d’attenzione su questo argomento proprio nell’occasione del venticinquennale della Casagit. E oggi, a trent’anni dalla nascita della Cassa, una data che ci fa riflettere per quanto profondamente coincide con il cambiamento di pelle della professione giornalistica, non possiamo che confermare almeno i sintomi della malattia. Mal di capo o mal di ufficio, il morbo come in tutte le epidemie si diffonde silenziosamente, spesso per contagio, e il vaccino ancora non è stato individuato. Per Casagit che ha comunque sotto gli occhi un osservatorio empirico ma indicativo dello stato di salute dei giornalisti il primo indicatore che conferma il fenomeno, neanche a dirlo, è l’aumento costante, negli ultimi anni, del ricorso alle psicoterapie. È un aumento generalizzato, su questo un chiarimento a priori va fatto, che riguarda in alcune fasce d’età purtroppo anche la parte più giovane anagraficamente degli assistiti, ma il nocciolo duro degli interventi “coperti” dal rimborso integrativo Casagit denuncia un male di vivere che tocca soprattutto chi vive, e non da ieri, la vita professionale in redazione. Il lavoro logora chi non ce l’ha, ma, soprattutto chi ce l’ha. E i segnali, che questo sia o no mobbing nel senso più correttamente declinabile del termine, confermano che il malessere esiste nella professione vissuta sul campo, perché la professione ha ormai un campo che ha sempre più ristretto la sua visuale diventando spesso un luogo virtuale. I “ Il potere ad un vigliacco Intervento di Michele Piccione della Clinica psichiatrica dell’Università di Roma-La Sapienza ORDINE 5 2004 Il lavoro (giornalistico) logora chi ce l’ha? intervento di Laura Delli Colli vicepresidente vicario Casagit La prova? I giornali vivono sempre più con la logica del lavoro “in ufficio” e non in un ambiente che, piuttosto, si è configurato negli anni come un luogo atipico, perfino negli orari. Internet e prima ancora la quantità dell’informazione e delle immagini disponibili, in entrata su quel server virtuale che è l’accesso quotidiano alle fonti, hanno modificato il nostro modo di lavorare: si esce meno dalla redazione e perfino il ruolo dell’inviato speciale, un tempo il massimo della libertà professionale, è diventato una declinazione d’onore della professione, spesso non coincidente con l’immagine di una ricerca sul campo da cronisti di razza che gli inviati di ieri avevano in sorte come un punto massimo di arrivo nella carriera da battitori liberi. Questo il quadro generale della professione. Quanto agli episodi, c’è ancora una forte resistenza nel denunciare, e anche molta impreparazione nel saper individuare come vero e proprio mobbing la vessazione strisciante che si propaga dal capo in giù all’interno di una redazione.Ormai già cinque anni fa avevamo aperto un fronte di dialogo con i colleghi, chiedendo, sia come Associazioni di Stampa che come Casagit di poter contare sulla trasparenza, almeno della casistica su cui poter costruire la prima analisi per quel famoso vaccino che non c’è. La voce più forte in un convegno promosso dalla nostra Cpo, la Commissione Pari Opportunità della Fnsi. Un convegno agguerrito al punto di dover rinunciare, per la tutela di alcune colleghe che avevano portato le loro testimonianze, a pubblicarne gli atti finali. Cosa è cambiato cinque anni dopo? E cosa legge Casagit nel quadro dei suoi dati quotidianamente ingoiati nella voragine degli archivi telematici? La radiografia quella di una realtà professionale diversa proprio sotto il profilo della salute. Lo stress ha raggiunto livelli di cronicità aggravate dal malessere redazionale. E nel malessere redazionale è difficile individuare la soglia tra una “normale” abitudine alle complicazioni di una convivenza da ufficio e gli episodi che la nuova consapevolezza della materia consente di individuare come vero e proprio mobbing. A noi comunque spetta soprattutto l’analisi degli effetti. E se siano o no da mobbing, possiamo confermare, come Casagit, che l titolo “Il potere ad un vigliacco” non deve ingannare in quanto questo intervento, tratto da un capitolo del volume monografico in corso di pubblicazione, non vuole avere valenza politica o sociologica ma esclusivamente clinica psicologica e psichiatrica. “Potere” deriva da potestas, cioè la facoltà di richiedere la gabella, e da possum – posso, il cui contrario è non possum – non posso. Ad esso è quindi riconosciuto un coefficiente di discrezionalità e soggettività che lo differenzia moltissimo dal “dovere” e lo espone all’abuso, cioè ab-usum. Su questo territorio si combatte la battaglia del Mobbing, inteso come violenza morale o psichica in occasione di lavoro che, come tale, non è una malattia ma un comportamento che può produrre sintomi. Come tale deve essere affrontato in modo assolutamente serio e congruo, tenendo ben presente che all’interno di esso cercano posto e collocazione una pletora di realtà umane, cliniche e professionali multiformi, diverse tra loro e per nulla compatibili, come: deliranti di persecuzione, frustrati, nullafacenti, nullavolenti, disamorati costituzionali, etc. La Comunità europea, sensibile alle attuali cosiddette patologie emergenti ed allarmata dal dilagare di questo fenomeno, considerato verosimilmente ragionevolmente fortemente sovrastimato, ha sollecitato i Paesi membri di occuparsene, legiferando in proposito. a Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano, su incarico del Ministro per la Funzione Pubblica, ha pertanto decretato l’istituzione di una Commissione pluridisciplinare, al fine di fornire la definizione del fenomeno, l’indicazione di modelli per la prevenzione e formulare una bozza, anche, di carattere I L l’aumento di certe patologie legate a un quadro fortemente potenziato di stress da lavoro è un fatto riscontrabile. Ci sono effetti squisitamente psicologici e la malattia in questo caso si esprime con il ricorso alle prestazioni specifiche. Ma ci sono anche, e in costante aumento, patologie apparentemente molto “normali” e generalmente diffuse che sono indubbiamente segnali di uno stress palese e di un malessere conclamato: al di là dei normali disturbi “da stress” il dismetabolismo o, nel quadro delle disfunzioni ormonali, l’aumento delle patologie tiroidee. Per non parlare del quadro di disturbi cardiologici sul quale Casagit sta indagando, anche statisticamente, nell’ultima fase del quadriennio dedicato alla prevenzione, un’iniziativa che si concluderà alla fine del prossimo anno, e che sta monitorando in tutt’Italia una fascia di popolazione giornalistica a rischio, per larga parte contrattualizzata. Quali disturbi? Ipertensione, danni cardiovascolari, infarto, ictus. Si tratta di patologie che hanno un costo individuale ma ormai anche professionale. Ma l’antidoto non è in una medicina che può somministrare il servizio sanitario né tantomeno l’integrazione, pur generosa, della Casagit. È probabilmente nella coscienza vigile di ciascuno di noi. Nell’attenzione a non fraintendere la normalità dello stress quotidiano, almeno nel lavoro, con quel morbo strisciante e contagioso che ha il nome di mobbing. Una persecuzione psicologica che a volte è vessatoria, dall’alto, a volte nasce dai colleghi ed è più “orizzontale”. Ma la somma, o l’alternativa, almeno negli effetti strategici di tipo emozionale o relazionale, non cambia, alla fine, il prodotto... normativo. La Commissione ha assolto il proprio compito dopo aver preso in considerazione la letteratura mondiale sull’argomento, i disegni ed i progetti di Legge giacenti alla Camera ed al Senato, e condiviso come presupposto ineludibile quello di considerare lavoratori sia il datore di lavoro che il prestatore d’opera, al fine di garantire entrambi da ingiuste accuse e da violenze vere. olto sinteticamente, tra i punti salienti, possono essere riconosciuti: la istituzione di Centri regionali di valutazione interconnessi tra loro e con una uniformità di criteri valutativi su scala nazionale; la necessità sul piano preventivo di rendere edotti i lavoratori sulle attività mobbizzanti (sia nel provocarle che nel riceverle), dichiarando M segue 3 SALUTE, COSTITUZIONE, CODICE CIVILE E CODICE PENALE Il potere ad un vigliacco segue da pagina 3 Duecento le pratiche Inail per “patologie da stress” Il mobbing dà i numeri. Sono 200 le pratiche aperte a tutt’oggi all’Inail per “patologie da stress correlate”, di cui solo 21 riconosciute come malattie professionali, generate da vessazioni in ambiente lavorativo. A diffondere tali dati è il presidente dell’Istituto italiano di medicina sociale, Pierantonio Ricci, annunciando in anteprima i contenuti di una relazione elaborata dall’ente. “Spesso – spiega Ricci – si tendono a far rientrare nel mobbing i fenomeni più disparati e questo perché manca una definizione universalmente accettata per questa patologia. Bisogna concentrare gli sforzi nella soluzione concreta dei problemi, piuttosto che strumentalizzare la popolarità di un fenomeno in preoccupante crescita per non condivisibili attacchi al mondo delle imprese”. (da Il Sole 24 Ore del 7 febbraio 2004) tempestivamente alle figure istituzionalmente all’uopo deputate il loro caso, al fine di comporre la vicenda per evitare il conflitto legale. Considerando che, l’interesse del mobbizzato è quello di far cessare l’attività e di non perdere il posto di lavoro, e quello del mobber di non agire come tale; con la consapevolezza di entrambi che il Mobbing vero rappresenta, oltre che una vergogna morale, anche e certamente una condotta svantaggiosa dal punto di vista professionale ed economico, e da non praticare. uesto emerge da uno studio preliminare che attualmente è in corso presso l’Università “La Sapienza” di Roma, circa il vissuto psicologico ed in parallelo delle due categorie, del mobber e del mobbizzato. E più precisamente: …sono riconosciuti tre momenti temporalmente non definiti in anticipo, e all’interno dei quali trova la sua gestazione questo fenomeno mostruoso. La dequalificazione consiste nell’abbassamento del livello La globale delle prestazioni del lavoratore con sottoutilizzazione delle capacità acquisite e impoverimento della professionalità. venga dal lavoratore denunziata la violazione dequalificazio- Allorquando dell’art. 2103 cod. civ., allegando di aver sofferto una dequalificazione professionale, il giudice deve stabilire se le mansioni ne consiste dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e l’ulteriore arricchimento della professionalità acquisita nella pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modinell’abbassa- fase fica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una dequalificazione professionamento le. Questa invece implica una sottrazione di mansioni tale – per la sua natura e portata, per la sua incidenza sui poteri del e sulla sua collocazione nell’ambito aziendale – da del livello delle lavoratore comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con sottoutilizzazione delle capacità dallo prestazioni stesso acquisite ed un conseguenziale impoverimento della sua professionalità (Cassazione Sezione Lavoro n. 5651 del Primo momento Secondo momento Terzo momento Conclusioni Il mobber costruisce una strategia identificando il soggetto, i tempi che fantastica brevi, ed i modi. Soddisfa così l’esigenza dell’espulsione dell’Altro in modo subdolo e mai esplicito. Non dà luogo ad alcun conflitto formale né ad alcuna possibilità di contestazione. Lo status psicologico è di quiete totale e di ampia soddisfazione, è totalmente assente qualsiasi sentimento di colpa. Lui sa l’Altro no. Il mobbizzato è sempre colto di sorpresa, ha bisogno di tempo per realizzare che quel qualcosa di negativo che gli sta accadendo sia veramente voluto, lo attribuisce al caso, al momento contingente, cerca e trova a tutti i costi riscontri analoghi nel passato ed anche in altri, aspetta e spera tutte le sere che il giorno successivo sia diverso e sorga con la fine dell’incubo. I livelli dell’ansia cominciano a salire, comincia a diventare più irascibile, tende a dormire meno, sicuramente male. È preoccupato,comincia a tornargli in mente quel qualcosa che lo disturba, si riduce la fantasia creativa e quella ludica, perde forza, non ha più la voglia per le cose che lo appassionavano in precedenza, tende ad essere remissivo ed accomodante, mai reattivo. Il mobber vive un’esperienza di trionfo, raccoglie la tempesta che il suo vento ha seminato. L’Altro è in difficoltà, l’unica cosa da fare è quella di non fare. Il mobbizzato a volte, non sempre, trova il coraggio e la possibilità di chiedere spiegazioni per paura di drammatizzare ancora di più la situazione. Procede con cautela e per cerchi concentrici. Inizialmente con la richiesta di conferma o smentita con i pari grado, successivamente con il “più amico” tra quelli con grado superiore, teme moltissimo il capo con cui fantastica fra sé e sé di parlare con discorsi preparati e predisposti, anche in collaborazione con la famiglia, con gli amici, se gli è accaduto di superare il grande disagio dovuto al pudore della “riservatezza della vergogna” scaturito dalla sua evidente debolezza, pochezza e fragilità. Comincia a star male sia a livello psichico che somatico, l’ansia è sempre più presente, la depressione del tono dell’umore comincia con il non essere più negabile, tanto quanto l’astenia, l’apatia, l’abulia. Non sono infrequenti tachicardia, ipertensione arteriosa, asma, oltre ai disturbi digestivi, quasi sempre denunziati. Aumenta la sospettosità anche nei confronti di altri e di altro, e per nulla in relazione con il mondo del lavoro. Quando il mobbizzato arriva al cospetto del mobber, costui quasi sempre gli dice quello che il mobbizzato spera con tutto sé stesso che gli venga detto, e cioè che non è vero niente. È il momento dell’identificazione con il persecutore, il mobbizzato più di Giuda, rinnega se stesso, si colpevolizza, loda il mobber trovandolo buono e comprensivo, è un modo disperato di cercare un po’ di pace. Il mobber sente di avere vinto, deve soltanto aspettare che il suo pesce fuori dall’acqua lavorativa smetta di respirare. Il mobbizzato è in caduta libera, è confuso, la realtà non solo è peggiorata ma ancor di più non coincide con i termini relazionali, perché è stato rassicurato, gli è stata spiegata la non sussistenza di alcuna attività persecutoria, di cui ha dato comunicazione a casa, agli eventuali amici, i quali tutti assieme pensano che stia veramente esagerando, che è completamente matto, e che non si capisce cos’altro vada cercando. In questa fase è veramente solo e totalmente incompreso, senza speranza si deprime, senza riferimenti si agita in ansia, senza consenso struttura idee persecutorie. Ma la tempesta non è ancora cessata, il timore per la perdita del lavoro è anche un bisogno e un desiderio, per di più è veramente malato e soffre psichicamente e fisicamente. La malattia, a ben vedere, rappresenta la giustificazione migliore, ultima, unica. Ribellarsi e reagire appare molto peggio che subire e rinunziare. A corredo e per concludere: in un altro lavoro abbiamo riportato delle valutazioni catamnestiche di 77 casi di mobbizzati che avevano concluso la loro vicenda in via extragiudiziale e di 7 Mobber da cui emergeva netto che l’unico momento di sofferenza per il mobber era in occasione della vicenda e del coinvolgimento legale. Questo è il vento e la tempesta del Mobber. Infatti, se il lavoratore sa cosa deve fare già nella prima fase non arriverà alla terza. Nella bozza di legge lo diciamo chiaramente e nella nostra esperienza lo abbiamo ampiamente verificato. È necessario capire e far capire che il Mobbing non è più una strategia vincente e che contro di esso il mondo del lavoro, e non solo del lavoro, deve sentire l’esigenza civile, il bisogno morale, la coerenza sociale di respingerlo, perché si può sopravvivere in povertà, non si può vivere senza dignità. Michele Piccione Q 20 marzo 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Filadoro). (da: www.legge-e-giustizia.it Da questi studi, seppure preliminari, si evincono in modo evidente i vissuti e soprattutto i modelli psicologici ed operativi delle due categorie. Bibliografia Mobbing: riflessioni sulla pelle…, Antonio Ascenzi e Gian Luigi Bergagio, G. Giappichelli Editore, Torino, 2002 Mobbing. Conoscerlo per vincerlo. Harald Ege, Franco Angeli Editore, Milano, 2001 Perché le Zebre non si ammalano di ulcera, R. Sapolsky, McGrawHill, 1999 Mobbing: la faccia impresentabile del mondo del lavoro, Alessandra Menelao, Mariella Della Porta e Giacomo Rindonone, Franco Angeli Editore, Milano, 2001 Mobbing: il marketing sociale come strumento per combatterlo, Antonio Ascenzi e Gian Luigi Bergagio, G. Giappichelli Editore, Torino, 2000 Molestie sessuali nei luoghi di lavoro: guida pratica di auto-aiuto per dirigenti, quadri e dipendenti, Massimo Santinello, Franco Angeli/Self Help, 1998 Mobbing: no grazie!, Birgit Rupprecht-Stroell, 2001, TEA Molestie morali: la violenza perversa nella famiglia e nel lavoro, Marie France Hirigoyen, Grandi Tascabili Einaudi, 2000 I numeri del Mobbing: la prima ricerca italiana, Harald Ege, Pitagora Editrice, Bologna, 1998 Cattivi capi, cattivi colleghi: come difendersi dal mobbing e dal nuovo “capitalismo selvaggio”, Alessandro e Renato Gilioli, Mondadori, 2000 Il benessere sul lavoro, ricerca Ispo, Sperling & Kupfer, 1998 Mobbing: conoscerlo, affrontarlo, prevenirlo, Carlo Lazzari, Edizioni Scientifiche Internazionali, 2001 Il Mobbing in Italia: terrorismo psicologico nei rapporti di lavoro, Nino Recupero e Sandra Carrettin, Edizioni Dedalo 2001 Mobbing: i costi umani dell’impresa, Paolo Saolini, Edizione lavoro, Roma, 2001 Mobbing, Davide Gallotti e Emanuela Cusmani, Editrice Ianua, Roma, 2001 Mobbing: vessazione sul luogo di lavoro, P.G. Monateri, M. Bona e U. Oliva, Giuffrè Editore, 2000 Stop Mobbing: resistere alla violenza psicologica sul luogo di lavoro, A. Casilli, Derive e Approdi/Map Roma, 2000 Il Mobbing in Italia: introduzione al Mobbing culturale, Harald Ege, Pitagora Editrice, Bologna, 1997 Vincere le ingiustizie nel lavoro, Carlo Lazzari, Pitagora Editrice, Bologna, 1997 Mobbing: che cos’è il terrorismo psicologico sul posto di lavoro, Harald Ege, Pitagora Editrice, Bologna, 1996 Stress e Mobbing, Harald Ege – Maurizio Pancioni, Pitagora Editrice, Bologna, 1999 4 ORDINE 5 2004 DA “QP/SENZA BAVAGLIO” «[email protected]» PROFESSIONE Freelance/Proposta di legge rivoluzionaria: difende l’etica e stabilisce anche un tariffario Milano, 8 aprile 2004. Dopo anni di incertezze, il 7 aprile 2004 segna un momento fondamentale. Per la storia del giornalismo e, soprattutto, dei giornalisti liberi professionisti italiani: il partito dei Comunisti Italiani ha infatti depositato la proposta di legge sulla tutela e sulle garanzie della categoria.Tutto nasce dalla ostinazione e dalla perseveranza di Simona Fossati (eletta il 6 aprile nella Commissione Contratto della Fnsi in rappresentanza dei freelance), Marilisa Verti e Luisa Espanet che, dopo aver analizzato il vuoto legislativo in materia e il pressapochismo che accompagna la situazione di migliaia di freelance italiani lasciati allo sbando più completo, hanno considerato che la soluzione avrebbe potuto arrivare proprio da una legge in materia. Si sono quindi incontrate con i dirigenti dei Comunisti Italiani, sensibili alle questioni lavorative e professionali, hanno discusso sui temi più scottanti della categoria, hanno evidenziato i gravi rischi per l’informazione che il panorama attuale comporta e hanno elaborato una proposta di legge simile a quella che in Francia esiste dal 1974, grazie a Cressard, giornalista eletto in Parlamento. Nella premessa alla Proposta di legge, presentata da Marco Rizzo, capogruppo del PdCI alla Camera, sono state recepite le loro osservazioni e le loro preoccupazioni. Invitiamo tutti i colleghi, freelance e contrattualizzati, a fare propri i contenuti di questo documento, a divulgarlo e a esercitare pressioni perché la proposta si trasformi in legge nel minor tempo possibile. L’invito è rivolto a tutti, poiché siamo convinti che solo una categoria forte, unita e rispettata possa diventare un argine contro vessazioni e malcostume che sono all’ordine del giorno e che la compattezza tra freelance e contrattualizzati possa produrre, come effetto, anche una maggior etica nell’editoria italiana. Ringraziamo le tre colleghe dell’esecutivo di Qp/Senza Bavaglio e i Comunisti Italiani per gli sforzi congiunti, e per questo passo in avanti verso la dignità di tutti i giornalisti e verso una informazione libera. Qp/Senza Bavaglio Ecco qui di seguito la premessa e il testo di legge Camera dei Deputati Gruppo misto - Comunisti Italiani Proposta di legge d’iniziativa del deputato Marco Rizzo presentata il 7 aprile 2004: “Norme per il riconoscimento della figura professionale dei freelance nell’ambito della categoria giornalistica” On. Colleghi, il tema della libertà di informazione è stato oggetto di lunghe ed ampie discussioni in Parlamento. Mi preme richiamare a tal proposito il messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Ciampi sulla questione del pluralismo e della libertà di informazione. In quel messaggio il Presidente evidenziava due campi su cui occorre intervenire per rendere efficaci i principi di garanzia del pluralismo nell’informazione: il primo riguarda il cosiddetto “esterno” l’altro è quello del pluralismo “interno”. Per pluralismo esterno si intende la necessità di avere una pluralità di soggetti che operano nel campo dell’informazione, questo non è il caso in oggetto della presente proposta di legge ma riguarda il conflitto di interessi e l’assetto del sistema dell’informazione. Il pluralismo “interno”, secondo la definizione data dal Capo dello Stato, è invece quella sfera di attività che attiene al lavoro redazionale, ossia alla qualità dell’informazione prodotta dalle testate giornalistiche e quindi alla qualità del lavoro svolto dalla categoria dei giornalisti. Secondo il Presidente della Repubblica è importante e necessario che, ai fini di garantire l’applicazione dei principi costituzionali di libertà di informazione e di rispetto del pluralismo, il prodotto informativo sia il più possibile equilibrato, rispettoso delle diverse opinioni e quanto più possibile aderente ai fatti in modo da inserirsi nell’alveo dei principi costituzionali. Per avvicinarsi a questi criteri occorre che gli operatori dell’informazione, la categoria dei giornalisti, siano messi in grado di operare nel rispetto delle norme costituzionali, delle vigenti leggi e dell’insieme delle regole deontologiche e professionali che stabiliscono le linee guida cui dovrebbero attenersi i giornalisti. È questa la materia che intendiamo affrontare con questa nostra proposta. Con la seguente proposta di legge si intende intervenire In particolare Su un settore della categoria giornalistica che, essendo fra quelli meno garantiti, rischia di trovarsi più facilmente oggetto delle pressioni delle proprietà editoriali. È ovvio che non stiamo parlando di mere relazioni industriali. Il tema dell’obiettività e del pluralismo dell’informazione riguarda l’assetto stesso di una moderna democrazia. Solo con una libera stampa e con la libertà degli stessi giornalisti possono trovare piena espressione e applicazione i principi di obiettività e pluralismo. Da qui nasce l’esigenza di proporre una normativa che innanzitutto, riconosca l’esistenza dei giornalisti liberi professionisti, detti freelance, una fascia della categoria giornalistica che tende a crescere sempre di più in base ad una combinazione di elementi determinati dai processi di frammentazione che investono tutti i settori del mercato del lavoro. I freelance aumentano sia per scelta individuale che per costrizione, quest’ultima dovuta al restringimento delle possibilità di accesso alla contrattualizzazione piena. Anche nel mondo giornalistico, così come nel resto del mercato del lavoro, si tende ormai ad utilizzare strumenti sempre più flessibili per regolamentare i rapporti di lavoro. A fronte di queste strozzature sono sempre di più coloro che, per libera scelta o per impossibilità ad ottenere un regolare contratto, decidono di svolgere la loro attività da freelance Siccome parliamo di operatori dell’informazione, ossia di produttori di una merce che attiene non solo al consumo individuale ma che tende a contribuire alla formazione della coscienza critica collettiva (la cosiddetta pubblica opinione) in politica così come in tutti gli altri settori della sfera umana, riteniamo sia doveroso delineare un quadro di riferimento che consenta alla categoria dei freelance di operare all’interno di un insieme di diritti consolidati in modo da mettere coloro che operano in questo ambito nella possibilità di preservare quanto più possibile la propria autonomia creativa ed essere allo stesso tempo in grado di rispettare i principi deontologici della categoria professionale a cui essi appartengono. La proposta di legge si sviluppa con due soli articoli. Il primo articolo definisce il quadro di riconoscimento dei giornalisti freelance individuandoli come un segmento particolare nell’ambito di coloro che esercitano la professione giornalistica. Ciò serve non a creare un sottogruppo, ma a meglio individuare i diritti e le competenze di coloro che, dall’interno della professione giornalistica, scelgono di svolgere la loro attività senza vincoli contrattuali. Al fine di evitare indebite sovrapposizioni con figure che esercitano altre attività, si stabilisce, nel secondo comma dell’art. 1, che l’esercizio della professione giornalistica è prevalente e determinante nell’attività del freelance. Il secondo articolo entra nello specifico dei diritti e dei doveri a carico dei freelance. Si stabilisce la necessità del riconoscimento della prestazione lavorativa a partire dalla formulazione dell’incarico e dalla specificazione del tipo di lavoro che il giornalista deve svolgere. Troppo spesso accade che il freelance svolga lavori che poi nonvengono pubblicati a causa di mutate scelte redazionali, il che comporta quasi sempre il mancato pagamento della prestazione svolta. Vi è poi il secondo comma che riguarda il riconoscimento dei diritti all’assistenza e alla previdenza previsti per l’intera categoria. Il giornalista freelance vive un’assimetria rispetto al suo datore di lavoro che lo distingue dagli altri liberi professionisti. Il mercato, infatti, è totalmente controllato dalla controparte, per cui il freelance si trova ad essere in una posizione debole rispetto alla sua committenza. Riteniamo che i diritti all’assistenza e alla previdenza siano diritti fondamentali per tutti i lavoratori e per tali motivi essi vadano riconosciuti anche ai freelance attraverso un meccanismo di voci aggiuntive che intervengono nella determinazione del compenso. Infine il terzo comma si sofferma sulla necessità che venga ufficializzato un tariffario della categoria dei freelance. Ovviamente la sua determinazione sta alla trattativa fra le parti sociali ma esso deve essere comunque agganciato al costo dei giornalisti contrattualizzati altrimenti si corre il rischio di incentivare, come già accade, un divario fra coloro che sono garantiti da regolare contratto e i freelance. Proposta di legge Art. 1 1. Nell’ambito dell’esercizio della professione giornalistica è riconosciuta la specificità dei giornalisti liberi professionisti, detti “freelance”, che operano nel rispetto dei principi costituzionali di libertà di espressione, di pluralismo e delle norme giuridiche e deontologiche previste per la professione giornalistica. 2. Ai fini del rispetto dei valori etici e professionali dei freelance e a tutela della libertà dell’informazione i giornalisti liberi professionisti esercitano continuativamente ed in piena autonomia l’attività giornalistica che costituisce la loro principale attività lavorativa. Art. 2 1. Ai giornalisti liberi professionisti è riconosciuto l’incarico di lavoro con la specifica della prestazione professionale richiesta, della durata dell’incarico, della tipologia (articolo, rubrica, dossier, reportage, o altro) del compenso pattuito anche in caso di non pubblicazione da parte del committente. 2. Ai giornalisti liberi professionisti è riconosciuto un trattamento economico che tenga conto del diritto all’assistenza e alla previdenza previsti per l’intera categoria dei giornalisti attraverso voci aggiuntive a carico degli editori nella determinazione del compenso. 3. Il tariffario minimo dovrà essere parametrato al costo per gli editori dei giornalisti assunti. La determinazione del compenso viene definito attraverso apposito tariffario dei compensi minimi concordato fra le parti sociali, sindacati di categoria, associazioni imprenditoriali e l’Ordine professionale. Ordine/Tabloid ORDINE - TABLOID periodico ufficiale del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia Mensile / Spedizione in a. p. (45%) Comma 20 (lettera B) art. 2 legge n. 662/96 - Filiale di Milano Anno XXXIV - Numero 5, maggio 2004 Direttore responsabile Condirettore FRANCO ABRUZZO BRUNO AMBROSI Direzione, redazione, amministrazione Via Appiani, 2 - 20121 Milano Tel. 02/ 63.61.171 - Telefax 02/ 65.54.307 Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia Franco Abruzzo presidente; Brunello Tanzi vicepresidente; Sergio D’Asnasch consigliere segretario; Davide Colombo consigliere tesoriere. ORDINE 5 2004 Consiglieri: Bruno Ambrosi, Letizia Gonzales, Liviana Nemes Fezzi, Cosma Damiano Nigro, Paola Pastacaldi Collegio dei revisori dei conti Alberto Comuzzi (presidente), Maurizio Michelini e Giacinto Sarubbi Direttore dell’OgL Elisabetta Graziani Segretaria di redazione Teresa Risé Stampa Stem Editoriale S.p.A. Via Brescia, 22 - 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) Registrazione n. 213 del 26 maggio 1970 presso il Tribunale di Milano. Testata iscritta al n. 6197 del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) Comunicazione e Pubblicità Comunicazioni giornalistiche Advercoop Via G.C.Venini, 46 - 20127 Milano Tel. 02/ 261.49.005 - Fax 02/ 289.34.08 La tiratura di questo numero è di 25.442 copie Chiuso in redazione il 19 aprile 2004 Realizzazione grafica: Grafica Torri Srl (coordinamento Franco Malaguti, Marco Micci) 5 “L’obiettività era una minaccia per i conservatori. Da destra e da sinistra è stata massacrata come una fanfaluca, una bugia. Questo ha avuto conseguenze molto negative. Ha compromesso un principio fondamentale per il lavoro giornalistico”. GIORNALISMO E DINTORNI “La pubblicità televisiva rischia di strangolare i giornali. Impedisce anche la sperimentazione di nuovi mezzi di informazione”. Giancarlo Bosetti: “L’obiettività valore assoluto della professione” di Paola Pastacaldi «L’obiettività? Una parola che aveva un significato speciale, particolare. Si chiamava obiettività, ma aveva allora un altro significato». Esordisce così Giancarlo Bosetti interrogato sul vecchio dibattito sull’obiettività che si fece a fine anni Settanta sull’Espresso con Umberto Eco, Piero Ottone e Mario Morcellini. Giancarlo Bosetti ha fondato nel ‘93, con una trentina di intellettuali, filosofi (tra i quali c’era anche Bobbio), sociologi ed economisti (tra i quali Michelangelo Bovero, Salvatore Veca) il mensile Reset, di cui è direttore. La rivista ha sviluppato con particolare attenzione i temi della stampa quotidiana in Italia, il rapporto con la televisione, sostenendo la discussione con interessanti pubblicazioni di autori di tutto il mondo sull’argomento, a partire dal noto saggio di Karl R. Popper, Cattiva maestra televisione (tra gli altri, Bobbio, Ad uso di amici e nemici, Anna Boschetti, La rivoluzione simbolica di Pierre). Bosetti, che si è laureato in filosofia con Emilio Agazzi e Mario Dal Prà, è stato caposervizio del settore politico, caporedattore centrale a Roma e vicedirettore dell’Unità, conosce dunque i meccanismi di funzionamento dei giornali. In questa intervista Giancarlo Bosetti ripercorre il periodo storico, contestualizzando il dibattito sull’obiettività all’interno di un clima politico refrattario alla sinistra, che poi mutò. «Era una formula, quella di essere obiettivi, dietro la quale si trincerava il conservatorismo asfissiante del giornalismo italiano. Prima del 1972 una parte del conservatorismo aveva escluso dal dibattito la sinistra, che non aveva diritto di cittadinanza, se ne parlava solo nei giornali indipendenti e solo quando c’era l’accordo di metterla in cattiva luce. Per esempio, si parlava del sindacato solo come un problema di ordine pubblico, non era come oggi che è normale parlarne. Eravamo ancora condizionati dalla guerra fredda, dal potere democristiano, dal conservatorismo sociale. Essere obiettivi voleva allora dire essere ubbidienti. L’obiettività così usata è stata screditata. Nel dibattito degli anni Settanta chi voleva rovesciare questa situazione non poteva farlo sotto l’insegna dell’obiettività, ma della opposizione, della controinformazione. Il conservatorismo allora era, ripeto, asfissiante. Titoli memorabili erano quelli sugli scioperi generali: tutti sulla viabilità, non c’era l’informazione. Il movi- mento sindacale figurava solo in occasione di incidenti di ordine pubblico. L’obiettività come concetto pragmatico era, dunque, indebolita da questo uso conservatore». Questo per spiegare come allora si finì per parlare di obiettività sull’Espresso in termini fortemente accesi e contrapposti. Umberto Eco che negava la possibilità di una obiettività del giornalismo, dicendo che era un mito. «Si affacciava una ideologia postmodernista di cui Umberto Eco era, allora più di oggi, tributario. Per le filosofie dei postmodernisti l’obiettività non esiste. Esiste solo una sua interpretazione. Era questo l’attacco postmodernista al concetto di verità assoluta. L’obiettività era una minaccia per i conservatori. Da destra e da sinistra è stata massacrata come una fanfaluca, una bugia. Questo ha avuto conseguenze molto negative. Ha compromesso un principio fondamentale per il lavoro giornalistico. Mentre è un valore che va messo al primo posto. Bisogna tendere alla ricostruzione di una verità obiettiva, Altri attacchi di artiglieria: i giornalisti con tessera. Ricordiamo Comprati e venduti di Giampaolo Pansa. Lo dico io che ero capocronista all’Unità a Milano e poi vicedirettore. Lavoravo in un giornale di partito. Ma la tessera nel portafoglio non l’avevano solo quelli di partito. Né la questione riguardava solo la Rai. Quel costume in Rai fu un precipitato catastrofico per la professione. Nel ‘7080 i direttori di giornali erano nominati dalle segreterie dei partiti. I giornali erano l’arena dove i partiti giocavano. Questa situazione ha frantumato l’obiettività». I giornalisti italiani sempre proni di fronte al potere politico. Come si dice e si scrive in ogni riflessione critica sulla stampa italiana. «È un fatto genetico di cui soffre l’Italia? No. L’asservimento alle cause politiche, agli interessi dell’economia dipende dalla debolezza dei giornali. Non fanno profitti, non prendono soldi. La causa ultima che comporta la dipendenza da altri poteri non professionali è questa. Tutte le proprietà, salvo poche Conversazione con il direttore del mensile Reset fondato nel ‘93 da una trentina di intellettuali, filosofi, sociologi ed economisti. perché è un valore assoluto in senso professionale». Le cause di questo crollo dove risiedono culturalmente? «Sono quattro a mio avviso. Primo, il versante sociale del conservatorismo. Secondo, il versante ideologico antiobiettività, cioé rovesciare la verità dei padroni. Il primo è cambiato quando al Corriere della Sera é arrivato Piero Ottone. Con il suo stile anglosassone e cosmopolita ha corretto la barra nella guida del principale quotidiano italiano e ha aperto le porte alla parte sociale esclusa. Ha fatto parlare dirigenti, sindacalisti e la base della sinistra. Ha introdotto una correzione verso il movimento sindacale, da cui poi la rottura con Indro Montanelli che era ed è un conservatore, anche se la percezione di lui negli ultimi anni era cambiata. La direzione di Ottone é stata una svolta. Non lo farà a nome dell’obiettività, perché la parola era compromessa. Nel suo Manuale del giornalista Alberto Papuzzi racconta bene la compromissione della parola in chiave sociale. Eco e gli altri ne assecondano, invece, la liquidazione con conseguenze negative. La svolta del ‘72 é questa. Ma l’obiettività subisce anche un’altra ferita. L’appartenenza politica dei giornalisti. eccezioni, come è il caso di Caracciolo che infatti nel 1976 darà corso ad un giornale nuovo. Ma anche Caracciolo e Scalfari avranno poi bisogno di una industria non editoriale. De Benedetti, appunto. Non è un caso. Il limite storico delle vendite inchiodato al 10 per cento della popolazione. Il dibattito inquinato sull’obiettività ha portato a questa debolezza strutturale. Possiamo accettare che l’obiettività venga trattata così oggi? No. Io come giornalista ho il dovere di essere obiettivo. Il giornalista dovrebbe perseguire la verità. Deve cercare con tutte le sue forze di sapere a Madrid quale è stato il numero dei morti». «Un ultimo fattore, il quarto, è che in Italia a metà degli anni Settanta si afferma l’homo videns ben contestualizzato da Sartori. Nell’ultimo quarto di secolo, dal ‘75, aumentano i canali ed esplode la televisione commerciale. In un Paese a basso indice di lettura questo produce una informazione basata solo su impressioni, emozioni. La nostra lettura dei fatti è più persuasiva che argomentativa, più legata alla magia della faccia che alla forza dell’argomento. La cavalcata della televisione negli anni Ottanta spazzola tutta la pubblicità che è quella che fa la diversità tra la forza dei nostri giornali e quella di altri Paesi. L’Italia a fine secolo batte un record mondiale, come pubblicità televisiva: più del 50 per cento. Siamo vicini al 56 del totale. Da dati della Fieg del 2002 risulta che la Gran Bretagna aveva il 30 per cento, gli Stati Uniti il 36, la Germania il 24, la Francia il 29». Ma in Italia c’è il problema della commistione pubblicità e infomazione. Il Cdr del Corriere denuncia una informazione di confine e chiede di avere più pagine di notizie, quando si fanno i numeri speciali dedicati a fiere e manifestazioni. «La mancanza di pubblicità è un’altra aggressione a danno dei giornali. Chi dice che c’è troppa pubblicità, dice una fesseria. Dietro c’è un Paese che si informa solo con la televisione. Questo produce una conseguenza grave sull’opinione pubblica nella capacità di valutare. La tv accorcia drammaticamente le argomentazioni. In tv si possono fare solo lanci di persuasione. La tv è tutta commerciale, la Rai è uguale. Fa un po’ più informazione ma alla fine non sposta i fattori. Dieci secondi di frase media per un argomento politico. In America si è calcolato che siano nove. Basta cronometrare. Anche se sono un politico molto bravo e riesco ad impostare un argomento molto razionale, posso fare solo una battuta verso un avversario, non un ragionamento. L’obiettività anche per via della tv va a farsi benedire. La politica non ha fatto niente per arginare. La pubblicità televisiva rischia di strangolare i giornali. Impedisce anche la sperimentazione di nuovi mezzi di informazione». Il Consiglio dell’Ordine della Lombardia ha quest’anno chiesto alla magistratura di indagare sulla commistione pubblicitàinformazione all’interno del Corriere della Sera, avendo valutato che ormai una buona parte dei giornalisti è sottoposta ad una tale pressione da parte del marketing da non essere più in grado di dire no, cioè di rispettare le regole fissate dal Codice della deontologia a proposito della pubblicità. Che deve essere palese, riconoscibile e ben distinta dall’informazione. La pubblicità è ormai ovunque, mascherata e occulta. Il lettore non la riconosce. In questa situazione i giornalisti da dove pescano le forze per rimettere in moto il meccanismo dell’obiettività, visto che in questi anni si sono allenati ad una scarsissima deontologia? «Rispettare le regole, la separazione. È chiaro che c’è un affanno, un inseguimento della pubblicità. Ma il male è la poca pubblicità». Rinasce L’Indipendente dopo sei anni con direttore Giordano Bruno Guerri Roma, 30 marzo 2004. “Analisi, commenti, niente articoli sterminati né foto di politici, prese di posizione molto nette, spesso a destra, qualche volta a sinistra, al centro quasi mai”: è l’identikit, nelle parole del direttore Giordano Bruno Guerri, del nuovo Indipendente, il quotidiano che torna dal primo aprile in edicola con l’ambizione di proporsi come “il Riformista di destra”. A quasi sei anni dalla sospensione delle pubblicazioni, L’Indipendente riparte da quattro pagine, “che diventeranno 6 o 8 da giugno, se tutto va bene, anche per dare un contribu- 6 to nel periodo elettorale”, spiega Guerri, che si definisce “euroscettico” e che avrà un atteggiamento “decisamente critico verso l’Unione Europea, ma senza estremismo”. Con “qualche stravaganza”, come l’assenza di steccati nelle pagine interne fra cultura, attualità, rubriche, il giornale punterà ad aiutare chiunque con intelligenza, umiltà, attenzione voglia comprendere l’Italia che sta cambiando e magari anche la destra a essere un po’ libertaria e libertina. Quella destra dove ci sono molte buone idee, tanta intelligenza e cultura, come talvolta capita anche a sinistra, ma non al centro, inteso come luogo della moderazione, del compromesso, del democristiano maneggione: credo che sia il peggio” dice Guerri - “della storia d’Italia e dell’Italia del momento. Contro il centro dirò la mia”. Come nella precedente esperienza ebbe la funzione di “sdoganare la Lega, arrivando a quota 300mila copie”, questa volta “se L’Indipendente riuscirà a creare una destra più moderata, più duttile e meno preoccupata di chi mangia i bambini, avrà svolto una bella funzione”. L’Indipendente, spiega an- cora il direttore, ha “un break-even di 3.200 copie” e “un bacino studiato di utenza di 50mila elettori, da ricercare fra l’elite di chi spende un euro in più per acquistare un secondo giornale”. Nessuna concorrenza, dice Guerri, per il Foglio di Giuliano Ferrara: “Siamo molto diversi, intanto per la lunghezza degli articoli. E poi il Foglio dà molto più spazio alla politica estera ed è molto autoreferenziale. Ferrara ha lanciato l’idea di questo tipo di quotidiani, ne fa uno egregiamente, nulla da togliergli. Se saremo un Riformista di destra? Questa definizione mi piace molto”. “Per un’intrapresa sociale, culturale, ideale bellissima, come è sempre la nascita di un nuovo giornale”, Guerri ha sospeso le sue attività di critico e scrittore. “La libertà si paga, ma in questi casi vale la pena perderla”. Con lo stesso marchio (riacquistato per 40mila euro), un progetto grafico “arioso”, firmato da Piergiorgio Maoloni e un azzurro tenue che vuole evocare “eleganza e leggerezza”, il giornale sarà in edicola sei volte alla settimana al prezzo di un euro. La domenica sarà dedicata a un appuntamento settimanale di informazione storica e storiografica, L’Indipendente della Storia (realizzato da Giorgio Dell’Arti), venduto in abbinamento facoltativo al prezzo di 1,50 euro (il 4 aprile sarà in omaggio). Sei i redattori, più un vicedirettore (Luciano Lanna) e tante firme annunciate: tra queste, Paolo Villaggio, Folco Quilici, Ida Magli, Roberto D’Agostino, Pierluigi Diaco, Sergio Luciano, Italo Cucci, Giuseppe Conte, Gennaro Malgieri, Antonio Pennacchik, Sergio Soave, Vittorio Sgarbi, Diego Gabutti,Alberto Mingardi, Claudio Risé, Alessandro Campi. Il nuovo quotidiano è edito dalla società a responsabilità limitata ORDINE 5 2004 International Herald Tribune del 23 marzo 2004 GIORNALISMO E DINTORNI Nella stampa Usa esplode lo scandalo “del copia e incolla” di Jacques Steinberg NewYork. Dallo scoppio dello scandalo di Jayson Blair del New York Times nella scorsa primavera, ci sono stati momenti in cui Romenesko, un compendio online degli sviluppi dei media di attualità, assomigliava a un bollettino di guerra. Nelle ultime due settimane, sul sito www.poynter.org sono stati pubblicati link ad articoli sulle punizioni o il licenziamento di giornalisti del Vancouver Sun nella Columbia Britannica (a proposito di un articolo su sesso e appuntamenti che rispecchiava fedelmente un testo pubblicato sul Times), dello Iowa State Daily (una rassegna cinematografica simile a quella pubblicata sullo Star Tribune di Minneapolis), del News Tribune di Tacoma, Washington (un giornalista che non è riuscito a verificare l’esistenza di cinque fonti citate in un articolo) e al Macon Telegraph della Georgia (per citazioni tratte dal San Diego Union Tribune senza menzionarne la fonte). Tutti questi casi hanno preceduto il servizio di USA Today di venerdì sull’indagine in corso su Jack Kelley, ex-inviato agli affari esteri. Un gruppo di giornalisti di USA Today ha “rinvenuto prove inconfutabili del fatto che Kelley ha inventato gran parte di almeno otto storie importanti” e “ha copiato di sana pianta più di venti citazioni o altro materiale da pubblicazioni concorrenti”. Almeno 10 giornali, dai più importanti come il Chicago Tribune ai più piccoli come il Sedalia Democrat del Missouri, hanno confermato casi di plagio o falsificazione da quando il Times ha riferito lo scorso maggio che Blair aveva inventato o copiato parti di almeno trenta articoli. È impossibile stabilire se questa epidemia di malefatte editoriali sia un segno di frenesia giornalistica in un mondo in cui i database sono a un solo click di mouse di distanza o se sia emersa semplicemente grazie a una più attenta sorveglianza. Stando alle indagini e alle interviste condotte dagli editori in tutta l’America, negli ultimi 10 mesi molti quotidiani hanno adottato metodi di salvaguardia dalla frode giornalistica. In risposta a una domanda contenuta nell’indagine svolta l’estate scorsa, più di 350 editori hanno dichiarato all’American Society of Newspaper Editors di avere intrapreso alcune “azioni specifiche” nei confronti dello staff o dei lettori “da quando lo scandalo di Jayson Blair del New York Times è diventato di dominio pubblico”. Il 51 per cento di loro hanno Edizioni de L’Indipendente, partecipata al 51% dalla Piccola Cooperativa Multimediale e al 49% da una cordata guidata da Italo Bocchino (parlamentare di An ed ex editore del Roma) che comprende lo stesso Guerri e, tra gli altri, Edoardo Montefusco (Rds), Lucio Garbo (Teleserenissima), Federica Lucisano (Iif), Gianni Biggio, (presidente degli industriali di Cagliari), Gianni Pilo, Gianluca Di Nardo, Vincenzo Auricchio, Antonio Pezzella, Matteo Cortese. L’investimento iniziale è di 3 milioni di euro. La pubblicità sarà raccolta dalla Manzoni Spa, La diffusione assicurata dalla Società Europea di Edizioni (Il Giornale). La stampa sarà effettuata a Roma, Napoli, Bergamo e Catania. (ANSA) ORDINE 5 2004 Jack Kelley è stato accusato di aver copiato di sana pianta “più di venti citazioni o altro materiale da pubblicazioni concorrenti”. affermato di essersi rivolti direttamente ai lettori, pubblicando articoli sulle politiche previste per questioni etiche o di raccolta di notizie; il 21 per cento hanno dichiarato che alcune di queste politiche erano nuove; il 7 per cento hanno affermato di avere inviato questionari ai lettori chiedendo un riscontro, e alcuni altri hanno scritto di avere iniziato a rivolgersi sistematicamente alle persone citate dal giornale per chiedere se pensavano di essere state trattate equamente. “Ho la sensazione che Jayson Blair abbia risvegliato l’attenzione di molti” ha affermato Vicki Gowler, direttrice del St. Paul Pioneer Press e presidente del comitato per l’etica e i valori dell’American Society of Newspaper Editors. Questa profusione di casi avviene in un momento in cui Internet rende relativamente Una nuova rivista: “Odissea” di Gian Luigi Falabrino In pochi numeri Odissea, la rivista culturale diretta da Angelo Gaccione, ha saputo raccogliere intorno a sé un bel numero di collaboratori, anche illustri, e soprattutto a porsi come una voce capace d’incidere nel dibattito culturale. So per esperienza diretta che non è facile per una testata di questo genere, per definizione di minoranza e senza risvolti commerciali, affermarsi e farsi sentire: e per questo la segnalo con dichiarata simpatia, tanto più che Gaccione ed i suoi collaboratori (fra i quali Maurizio Meschia direttore responsabile) non limitano la cultura al mero letteratismo ma pensano agli intellettuali come a persone inserite nel proprio tempo e che prendono posizione sui problemi dell’attualità politica. Così, già nel primo numero, la poetessa Donatella Bisutti pubblica un articolo molto acuto sulle soldatesse, e in particolare sul desiderio di molte ragazze di arruolarsi nelle forze armate. Molto acuto perché collega quel desiderio, da una parte, al bisogno di sicurezza dal “giovane branco dei maschi” facile per i giornalisti appropriarsi dell’opera di altri autori, e forse altrettanto facile per gli editori (o i colleghi o i concorrenti) identificare plagi e falsificazioni. È anche un momento in cui il pubblico ha una percezione alquanto negativa della credibilità dei giornalisti, anche se non visibilmente minore rispetto agli ultimi anni. (Da un’indagine condotta l’estate scorsa dal Pew Research Center for the People and the Press è emerso che il 56 per cento degli intervistati ritenevano che gli enti d’informazione “spesso riferiscono le notizie con scarsa precisione”, la stessa percentuale dell’anno precedente.) Memore dei gravi sotterfugi di Blair e seguendo l’esempio di altri 16 enti d’informazione che l’estate scorsa hanno firmato un documento analogo, il Times ha inasprito le norme per l’uso delle fonti anonime. e al bisogno di libertà, dall’altra al fatto che la cifra del femminile non è soltanto la vita, il partorire. Ai bisogni delle giovani il femminismo ha dato una risposta sbagliata, un errore che “costa caro prima di tutto alle donne” perché “incanala le energie del femminile in una direzione sbagliata”. E anche la guerra, l’uccisione di altri esseri umani è, per la Bisutti, una risposta sbagliata al lato oscuro del femminile, la Moira e Persefone: le donne dovrebbero combattere per il sacerdozio dell’Ombra, per il sentimento del Sacro, e non per l’atrocità del bagno di sangue. Altri temi politici sono affrontati nei numeri seguenti da Angelo Gaccione (la guerra in Iraq, piazza Fontana e nel n. 3 gli scioperi dei tranvieri a Milano), Giorgio Bonura e Uno di questi enti era il Washington Post. Leonard Downie Jr., direttore responsabile del quotidiano, ha scritto questo mese in un articolo che il Post aveva recentemente rivisto tutte le politiche di reporting, spiegando come, ad esempio, nonostante il velo dell’anonimato fosse talvolta l’unico modo per trasmettere informazioni importanti, il Post avrebbe cercato di spiegare ai lettori perché una data fonte non veniva citata. “Penso che il motivo principale per cui se ne sente parlare di più è che si viene più spesso smascherati” ha dichiarato Downie. “Eppure”, ha aggiunto, “alcuni giornalisti ed editori hanno ceduto alla tentazione di prendere decisioni negative in seguito alla “celebrazione del giornalismo”, in cui rientra la corsa al Premio Pulitzer, all’esposizione in televisione e a contratti editoriali molto remunerativi”. Teodoro de Donis. Ma è molto più ricca e variata, naturalmente, la parte letteraria. Forse salto qualche collaboratore illustre, ma bisogna citare almeno la rubrica fissa di Morando Morandini, gli articoli di Gina Lagorio, Ugo Ronfani, Fulvio Scaparro, Gilberto Finzi, Arturo Schwarz, le interviste sul teatro di Gianfranco Bosio e Laura Romani, la critica musicale di Sandro Boccardi. E poi ci sono i narratori e i poeti. Fra i primi, Ferruccio Parazzoli e Grazia Livi; fra i secondi, Roberto Sanesi con un poema su Pinelli, e traduzioni di Don Burness (Lina Angioletti), di poeti di Corfù (tradotti da Diomidis Vlachos e Gioia Roni Maestro), Khaled Najar e Ellen Hinsey (Donatella Bisutti). Insomma, una rivista da leggere e che fa discutere. I NOSTRI ERRORI Anche a Sassari c’è un master in giornalismo Nel numero di aprile di Tabloid abbiamo pubblicato l’elenco delle scuole e dei corsi di giornalismo, saltando il master di Sassari. Ce ne scusiamo con gli amici di Sassari e con i lettori: MASTER BIENNALE IN GIORNALISMO (promosso dall’Università degli studi di Sassari) Università di Sassari 07100 SASSARI Via dell’Università 11 tel. 079.239510 sito web www.uniss.it/reporters E-mail: [email protected] 7 www.corriere.it/severgnini del 23 marzo 2004 TESI DI LAUREA Estratto della tesi di laurea “La breve storia de la Voce di Montanelli” di Cristina Luini, relatrice professoressa Anna Lisa Carlotti, Università cattolica del Sacro Cuore La Voce Storia breve e ombra lunga di Indro Montanelli 1994 2004 Ciao Beppe e Italians tutti, ieri, 22 marzo, è caduto un anniversario che a me sta molto a cuore come credo a molti di noi. Il 22 marzo 1994, dieci anni fa, usciva nelle edicole il primo numero del quotidiano «La Voce» di Indro Montanelli. Quanti personalissimi ricordi mi legano a quel giorno e a quel primo numero. Ancora oggi quando mi capita di rileggerlo qualche volta, trafugandolo da uno scatolone di cartone dove giace insieme a tutte le altre copie acquistate che di quel giornale io ho sempre conservato, credo mi sento come possa sentirsi zio Paperone quando osserva orgoglioso il suo primo cent. I ricordi (anche di un’età più giovane dato che allora io avevo 20 anni) sono tutti dentro di me e rivivono in questi giorni: frequentavo il quinto anno di un istituto superiore e quella mattina persi parecchi autobus dato che il quotidiano - a mia sorpresa - non si trovava in diverse edicole. Non sapevo se esserne dispiaciuto o contento pensando al successo che quel primo giorno aveva già riscontrato. Ricordo quindi l’affannosa corsa da un’edicola all’altra della città; ricordo l’incontro casualissimo con una ragazza che capì subito che entrambi stavamo cercando la medesima cosa, e mi apostrofò dicendomi: «Ancora niente per la Voce?». Ricordo quel giorno a scuola quando durante l’intervallo i miei compagni mi chiesero il quotidiano in prestito per la consultazione (loro) della pagina dello sport. Ricordo un altro compagno di classe che, più sfortunato di me, non riuscendo a trovare il primo numero, mi propose l’acquisto del mio che naturalmente non cedetti a nessun prezzo. Ricordo il mio insegnante di diritto economia che riuscì, dopo esserselo da me fatto prestare Una breve storia figlia di un atto di co di Cristina Luini Nel decennale della sua nascita, approfondire la storia de la Voce significa ammettere che la fondazione del quotidiano è la conseguenza dell’atto di coraggio di Montanelli che all’età di 85 anni si rimbocca le maniche alla ricerca, ancora una volta nella sua carriera, di uno spazio per scrivere da indipendente. Il distacco forzato dal suo Giornale gli imprime quella vigorosa spinta che concorre a creare un quotidiano molto giovane nella grafica, specchio della sua flessibilità e freschezza. L’innovativo lay out de la Voce rivela fin dai primi numeri un “giornale nuovo” a livello grafico, dotato di un carattere ben definito, coraggioso e con un progetto da raggiungere molto ambizioso, ma non utopico: far diventare i lettori proprietari del loro quotidiano. Il terremoto politico nell’era di Tangentopoli Il contesto storico in cui Montanelli matura la sofferta decisione di abbandonare la ‘sua creatura’ per fondare la Voce è particolarmente delicato. Nel 1992 un vero e proprio terremoto si abbatte sulla politica italiana travolgendo i vecchi equilibri e rivelando una diffusa corruzione a tutti i livelli della vita dei partiti: lo scandalo delle tangenti. Democrazia cristiana e Partito socialista subiscono le denunce più pesanti. Per arginare il problema si cercano soluzioni riformistiche. Il mondo cattolico è in fermento e reclama svolte decisive. La Dc guidata da Mino Martinazzoli dimostra due anime, una progressista e l’altra moderata: la Rete di Leoluca Orlando che si batte per la trasparenza della politica e per la lotta alla mafia, e il Movimento popolare di Mario Segni che concentra tutta la sua azione propagandistica nella richiesta di una riforma elettorale. Secondo il fondatore del Movimento, il rinnovamento del sistema politico e la fine della partitocrazia dipendono dall’abbandono del sistema proporzionale e dall’introduzione di quello maggioritario uninominale. La prima risposta degli italiani a Tangentopoli uscirà dalle urne il 18 e 19 aprile dell’anno successivo con l’adozione del sistema maggioritario per l’elezione del Senato e l’abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti. Durante l’autunno le voci sull’ingresso in politica di Silvio Berlusconi si susseguono con insistenza: il vuoto che con la crisi della Dc e del Psi si è prodotto al centro, l’eventuale vittoria delle sinistre insieme alle sue personali convinzioni politiche fondate sul liberismo economico, lo spingono a riflettere sulla possibilità di scendere in campo. È scontro aperto tra Berlusconi e Montanelli La nascita de la Voce si può considerare la diretta conseguenza della rottura del rapporto tra Berlusconi-editore e Montanelli, direttore e fondatore de il Giornale, dovuta alla decisione da parte dell’imprenditore di entrare in politica. In questo periodo della storia politica italiana, la persona che si proponeva come punto di riferimento per i moderati era Segni che aveva inferto un duro colpo alla legge proporzionale. 8 Il Giornale e Montanelli avevano sostenuto l’iniziativa, vedendovi la possibilità di riunificare le culture laico-democratiche e cattolicoliberali. Berlusconi invece, pur considerandosi un moderato, fu sempre contrario a quella linea. Il contrasto era già affiorato nel giugno del 1993 quando Berlusconi aveva esposto a Montanelli la sua analisi: il referendum, aperta la via al sistema elettorale maggioritario, imponeva l’unione di centro e di destra per battere la sinistra, potenzialmente avversa al Gruppo Fininvest. Ed egli stesso era tentato di costituire questa grande aggregazione. L’editore gli chiedeva di contribuire a formare una squadra compatta. In risposta Montanelli proponeva di cedere il Giornale, così da poterlo aiutare da indipendente. La fermezza del Direttore, suscitata dal timore di una limitazione della sua libertà d’azione, ribadiva il “patto tra gentiluomini” nato quando Berlusconi aveva rilevato le azioni de il Giornale: si erano circoscritte le rispettive competenze in quanto l’editore si sarebbe occupato della parte amministrativa, mentre la linea politica e la conduzione tecnica del quotidiano rimanevano prerogativa del direttore. Una successiva conferma si era avuta nell’agosto del ‘90 quando, secondo quanto prescritto dalla legge Mammì, il pacchetto di controllo de il Giornale dovette passare al fratello di Silvio, Paolo. Altri tempi. Ora il braccio di ferro si faceva più serrato: da una parte il consiglio d’amministrazione della società editrice comunicava, bilancio alla mano, tagli drastici al budget con la soppressione delle sedi di corrispondenza all’estero; dall’altra Montanelli prendeva in considerazione l’idea di acquistare la sua “creatura prediletta”, rivolgendosi a Enrico Cuccia, presidente onorario di Mediobanca, per convincere Berlusconi a vendere il pacchetto di maggioranza. Berlusconi non prese neppure in considerazione quell’offerta. L’affondo finale a Montanelli viene mosso dal Tg4: Emilio Fede gli intima in diretta di lasciare il Giornale, sostenendo che “se una persona sceglie una linea editoriale diversa, […] forse, per coerenza, dovrebbe rassegnare le dimissioni. Nonostante Montanelli sia padre del giornalismo e de il Giornale, non è probabilmente il suo padrone”. La sorte di Montanelli si decide l’8 gennaio, con “l’irruzione” di Berlusconi in redazione. Pur privo di ogni titolo per intervenire e senza preventivamente avvertire il Direttore, Berlusconi prende parte all’assemblea di redazione. Montanelli, assente dalla riunione, riceve il testo stenografato di quello che fu definito “il discorso della clava e del fioretto”. Il Cavaliere riconosce la sua voglia di indipendenza e che mai avrebbe potuto chiedergli di fiancheggiarlo, ma giunti al problema del depauperamento di mezzi in atto che non permetteva a il Giornale di contrastare “l’agguerrita coalizione” dei tre maggiori quotidiani del Paese, la sua risposta è eloquente: “Io credo che se il Giornale darà segni di voler combattere questa battaglia […], non mancheranno assolutamente i mezzi per un rafforzamento della [sua] linea. Ci sono certe guerre che vanno condotte col fioretto; è difficile affrontare col fioretto chi viene in campo col mitra”. Dunque il Giornale avrebbe potuto contare su nuovi investimenti solo se fosse stato disposto a diventare “un quotidiano da combattimento”. Per Montanelli l’intervento di Berlusconi è una “colossale gaffe” in quanto “l’editore per la legge non è lui. È suo fratello. Ma siccome Paolo Berlusconi non esiste, è venuto lui. […]. Lui vorrebbe che io usassi la clava, altro che la sciabola. Ma io rispetto il galateo polemico. Non ho mai mancato di salutare il mio avversario”. La fine del sodalizio viene annunciata da Montanelli alla sua redazione l’11 gennaio alle 11.30: accorrono tutti, giornalisti, impiegati, tipografi poiché la notizia delle sue dimissioni circola già da qualche ora. Quella riunione viene ancora ricordata da Giancarlo Mazzuca come “una cerimonia davvero toccante”. Montanelli esordisce con la solita schiettezza (“Dopo quello che [Berlusconi] ha fatto a mia insaputa […], voi capite che me ne devo andare”), senza promettere nulla ai suoi redattori (“ho dovuto abbreviare i tempi e non ho potuto preparare gli alloggiamenti per una ritirata”), ma annunciando di voler predisporre una scialuppa di salvataggio per coloro che non avrebbero accettato il nuovo corso (“Restate al Giornale! Se io riesco a fare qualche altra cosa, vi chiamo!”). Conclude con un’amara constatazione: “È un po’ tardi, ma alla fine mi sono convinto che di padroni non bisogna averne. Perché, anche quando iniziano bene, finiscono male”. Si ripeteva, così, ciò che era successo vent’anni prima per quei colleghi del Corriere che non avevano approvato la nuova linea politica impressa in via Solferino dalla proprietaria Giulia Maria Crespi e dal suo direttore Piero Ottone. Con Montanelli si dimettono contestualmente il condirettore Federico Orlando e il vice direttore Michele Sarcina. Le ultime ore da direttore, Montanelli le trascorre alla sua lettera 22 scrivendo il fondo “Al lettore - Vent’anni dopo”, con cui si congeda dal suo giornale. Deve spiegare perché non ha mantenuto fede alla promessa di “restare [al suo posto] finchè morte non sopravvenga. Nessuno mi ha scacciato. Sono io che mi ritiro per una di quelle situazioni d’incompatibilità fra me e l’editore”. Ma il fondo d’addio è solo un arrivederci: “Me ne vado. Ma non senza avvertire i lettori che manterrò l’impegno preso con loro. Fra poche settimane riavrete il nostro e vostro giornale, fatto dagli stessi uomini e nutrito dalle stesse idee, anche a costo di ridurlo per i primi numeri a poche pagine. Si chiamerà la Voce. In ricordo non di quella di Sinatra. Ma di quella del mio vecchio maestro di libertà e di indipendenza Prezzolini”. L’offerta di Gianni Agnelli: una rivincita mancata Inizialmente Montanelli scarta il progetto di un nuovo quotidiano perché lo considera eccessivo rispetto alle sue forze. Riflette invece più concretamente sul lancio un nuovo settimanale per cui c’era già la disponibilità della famiglia Rizzoli a finanziare l’iniziativa. I modelli a cui guardare erano due: Il Mondo di Pannunzio e Omnibus di Longanesi. Sarebbe stato un settimanale “sobrio e austero” e non troppo costoso, con una redazione di una decina di persone, e si sarebbe chiamato Il Caffè prendendo in prestito il nome da quello di Pietro Verri (“un giornale di dibattiti, una palestra del libero pensiero”). Ma in quei giorni di grande fermento creativo, giunge inaspettatamente a Montanelli la proposta di Giovanni Agnelli di assumere la direzione del Corriere. La mattina del 15 gennaio, Montanelli riceve una telefonata dell’avvocato che lo convoca nella sede di Mediobanca. Paolo Mieli gli cedeva la prestigiosa poltrona di direttore del Corriere: “La mia stanza, che è la stanza di Albertini, ti aspetORDINE 5 2004 durante l’ora di lezione, a non restituirmi più il quarto numero. Ricordo i primi articoli di un certo Severgnini, corrispondente da Washington. Un tipo, ho pensato, che farà strada. Ricordi insomma. E naturalmente ricordo Indro e tutto quello che mi ha insegnato attraverso e non solo, la lettura di quel giornale ma che ancora mi insegna attraverso Beppe e tutti coloro che scrivono qui su Italians. Chiedo scusa se ho disturbato. Di fronte a tutto quello che sta succedendo in questi tempi so bene che ci sono cose più serie e importanti di cui parlare. Per questo ora mi fermo qui. Grazie. Damiano Berti, [email protected] sinistra (che ci lodava, ma continuava a comprare i suoi giornali). Abbiamo formato una squadra piena di individualità, ma non sempre giocavamo insieme (come l’Inter): ognuno aveva progetti suoi, e non tutti i progetti risultavano chiari. Abbiamo cercato strade stilistiche fin troppo ardite: leggere Montanelli accanto a certi fotomontaggi era come vedere Lord Astor su uno skateboard. Aggiungo un mea culpa personale. Dopo aver curato il lancio della Voce (incarico affidatomi dal direttore), sono andato a Washington. L’ho fatto perché avevo capito che in redazione a Milano avrei potuto far poco, e mi sarei arrabbiato molto; e in America ho trascorso un periodo magico da molti punti di vista. Ma ogni tanto penso: forse il tenente non doveva abbandonare il generale, anche se non andava d’accordo coi colonnelli. Detto questo, ricordo la voglia di novità e la freschezza. I nervi, la grinta e il sudore di chi ci credeva, investendo speranze e soldi (mia madre volle comprare qualche azione: la cosa mi commuove, pensandoci). Ricordo Il Caffè, l’inserto che molti c’invidiavano. La cronaca che, senza averne i mezzi, dava filo da torcere a tutti i giornali di Milano. La Fortezza Bastiani degli esteri dove ogni giorno cercavano di inventarsi qualcosa. E, soprattutto, ricordo i lettori. Quei lettori che abbiamo illuso, confuso e - temo - deluso. È inutile, ormai, cercare di stabilire di chi sia la colpa: se i lettori della Voce alla fine fossero stati numerosi come le opinioni sulla fine della Voce, avremmo dato filo da torcere al Corriere. Invece abbiamo lasciato solo un’ombra lunga ed elegante: com’era quella di Montanelli, in fondo. Qui mi fermo. A chi volesse saperne di più, suggerisco non tanto i libri usciti sull’argomento (troppo appassionati), quanto due tesi di laurea che hanno raccolto testimonianze e studiato con affettuosa freddezza la questione: Cristina Luini ([email protected]) della Cattolica di Milano («La breve storia de La Voce di Montanelli»); e Marilisa Palumbo ([email protected]) dello Iulm ( «La Voce, storia di un giornale italiano»). Ciao Damiano, grazie di aver ricordato l’anniversario: speravo che qualcuno lo facesse. La Voce l’ho scritto, lo ripeto - è stata per noi una medaglia al valore, non una sconfitta. Un tentativo di trovare uno spazio nel momento del grande scontro destra/sinistra del 1994. Non ci siamo riusciti per oggettive difficoltà editoriali (lo spazio moderato era occupato con intelligenza dal Corriere di Mieli); per scelte azionarie (l’idea dell’azionariato popolare era nobile, ma prematura); per alcune manie di grandezza (troppi costi, troppe pagine: avremmo dovuto fare il Foglio indipendente); per vigliaccherie varie (fuga di azionisti e inserzionisti che temevano di inimicarsi il prossimo vincitore). Ma, soprattutto, abbiamo sbagliato il tono. Questo è imperdonabile. E infatti il lettore - l’unico padrone, come diceva il nostro slogan - non ce l’ha perdonato. La Voce, un giornale nato «senza amici e nemici a scatola chiusa», ha trasformato le proprie legittime convinzioni in un’ossessione. Questo è stato il vero errore: abbiamo spaventato i nostri lettori moderati, invece di prenderli per mano e spiegar loro i rischi dell’avanzata berlusconiana (molti adesso hanno capito; ma ci sono voluti dieci anni). Abbiamo accettato l’applauso interessato della raggio, ma anche di “generosi” errori ta!”. Montanelli in questo modo poteva trovare una comoda sistemazione per sé e per qualche giornalista che aveva già abbandonato il Giornale. Inoltre tornare al Corriere come direttore, dopo vent’anni, sarebbe stata “una rivincita colossale, un grande trionfo, una specie di apoteosi che avrebbe suggellato la mia carriera. Purtroppo dissi di no e non certo per un peccato d’orgoglio”. Principalmente per l’impressione che avrebbe dato al suo pubblico: “Se io accetto, chi toglierà di testa alla gente che ho rotto con Berlusconi e col Giornale perché avevo questa opportunità? Io alla mia faccia ci tengo!”. Ma soprattutto per la consapevolezza di dover abbandonare molti suoi redattori, disposti a seguirlo ovunque; la stessa preoccupazione che aveva bloccato l’iniziativa del settimanale. È così che prende corpo l’ipotesi del quotidiano. Afferma Montanelli: “Ero come il capitano di una nave che non poteva abbandonare i propri marinai al momento del naufragio e che doveva cercare una scialuppa per poterli portare in salvo verso lidi più tranquilli e sicuri. Perché […], non mi sono mai sentito come un vero direttore di giornale, ma piuttosto come un padre di famiglia con tanti figli da mantenere: un’intera redazione”. DIRETTORE I. Montanelli ORDINE 5 2004 I. De Michele Frigerio F. Orlando VICE DIRETTORI ART DIRECTOR G. Mazzuca, M. Sarcina V. Corona LETTERE AL DIRETTORE L.Bacialli CAPIREDATTORI CENTRALI A. Macchetta P. Fadda, L. Landò, G. Molossi M. Dal Fior V. Di Majo CRONACA S. Dell’Orso, P. Gomez, P. Longanesi, A. Lostia, S. Magnoli, C. Marchionni, E. Mastropiero, L. Moia, L. Moizzi, S. Regolini, R. Rietmann, A. Rozzi G. Garanzini A. Vitali CULTURA SPETTACOLI SPORT&MOTORI M. Ajello, P. Cheli, G. Piacentino N.Delbecchi, B. Masini, M.Papini C.Canzano, N. Roggero, N. Montanari R. Bagnoli M. De Marchi L’anelito all’indipendenza nel segno di Prezzolini Montanelli battezza il suo nuovo giornale la Voce perché sostiene che ciò che lega lui e Prezzolini è l’anelito all’indipendenza. Su un punto però si sente di differire: egli non si rassegna ad abbandonare il campo come “Prezzolini aveva fatto col fascismo fondando la setta degli ‘Apoti’, cioè di coloro che ‘non ci stanno’ e prendendono la via dell’esilio”. La Voce di Montanelli vuole porsi soprattutto come “eco di quella del Prezzolini prima maniera, protestatario, interventista e volontaristico”. Montanelli inoltre si ispira all’organizzazione essenziale di questa rivista: il fondatore non riceveva aiuti da nessuno, non aveva spese in quanto la faceva quasi da solo, con qualche collaboratore che lavorava gratuitamente. Qualche mese prima anche Vittorio Corona, per gli stessi motivi, aveva rinunciato alla poltrona di vice direttore di Studio Aperto, telegiornale di Italia Uno. Da quel momento, il giornalista inizia a sviluppare il progetto per un “nuovo giornale” che troverà sbocco ne la Voce. Elabora l’idea di un “quotidiano settimanalizzato”, con una rigida scelta delle notizie che permette di elevarne solo alcune ad “argomenti del giorno”, da trattare in maniera più ragionata, più profonda, più documentata. È in antitesi al “giornale-sacco” in cui si infilano tutte le notizie in maniera sciatta e fine a se stessa, con un ambizioso obiettivo: approfondire e riflettere. Ininzialmente Corona si pone un target preciso di lettori. La sua attenzione si posa in particolare sulle donne e i giovani: non potendo rubare lettori ad altri quotidiani, è convinto che l’unica speranza di sopravvivenza sia quella di catturare un pubblico di non lettori. Contemporaneamente punta a gente intellettualmente molto libera, capace di farsi stimolare dalle provocazioni. Nelle previsioni questo tipo di giornale si può realizzare con un ristretto numero di giornalisti (una trentina) adatti ad apportare quei contributi creativi di cui il giornale, per la sua formula, necessita. L’incontro tra Corona e Montanelli viene favorito da amici comuni. Il progetto del quotidiano SEGRETARIA DI REDAZIONE CONDIRETTORE ESTERI R. Copello, P. Delle Fratte, G. Donelli, L. Maisano ECONOMIA M.T. Cometto, M. Esposito,R. Iotti, F. Sarcina, M. Zacchè T. Resca ITALIA F. Battisini, A. Capece Minutolo, A. Lavazza, M. Natta, D. Passeri, F. Protti, S. Sarno, G. Sciacchitano, M. Travaglio INVIATI T. Abate, O. Eleni, A. Mazzuca, L. Offeddu, D. Righetti, B. Severgnini Struttura redazionale (come risulta dal colophon del primo numero). F. Gazzola REDAZIONE GRAFICA L. Cis, C. Negri, A. Possenti trova immediatamente l’approvazione del suo fondatore e l’obiettivo si sposta più in alto: creare un giornale per un target giovane che abbia come direttore il giornalista più vecchio d’Italia significa avvicinare il giornalismo forte, critico e lucido di Montanelli ad un mondo meno abituato a questo tipo di analisi. L’incarico di scegliere i componenti della redazione de la Voce (inizialmente 40) è affidato a Sarcina che cerca di ricomporre la squadra già affiatata de il Giornale. Ad eccezione di Orlando, lo stesso Sarcina e Mazzuca, il resto della redazione non abbandona via Negri in parte seguendo l’intimazione di Montanelli, in parte per l’approdo ancora troppo incerto. Contattati dal vice direttore, i giornalisti che da il Giornale passano a la Voce sono assunti gradualmente, nello stesso modo in cui hanno dato le dimissioni. Sarcina riconosce che questa modalità di ricerca del personale ha il vantaggio di creare il giornale in un paio di mesi, con persone che già hanno lavorato insieme: più che una redazione sembra una grande famiglia in cui anche i nuovi colleghi riescono facilmente ad amalgamarsi. La scelta dell’organico cade sulle persone più stimate da Montanelli. Sulla base di questo criterio di selezione, inevitabili si presentano malcontenti e tensioni tra gli esclusi. Infatti, non tutti quelli che vorrebbero seguire il Direttore vengono contattati ma c’è anche chi, invitato a far parte dell’equipaggio de la Voce, rifiuta (è il caso di Daniele Vimercati, firma della pagina politica de il Giornale). Outsider d’eccezione è Corona: non solo non proviene da via Negri, ma neanche da un’esperienza di quotidiani. La struttura economica che doveva reggere questa organizzazione si fondava sulla Piemmei, ambiziosa public company ad azionariato diffuso (4mila o 5mila soci) e capitale distribuito. L’intento di far partecipare il più ampio numero di soci all’impresa aveva anche il benefico effetto di ripararsi dai possibili interventi di grandi gruppi, evitando scalate ostili che avrebbero potuto portare all’ennesimo editore-padrone. L’incontro tra i fondatori (Luciano Consoli e Victor Uckmar) e Montanelli avviene il 17 dicembre 1993 ma i convenuti si lasciano senza alcuna promessa. Solo il 4 gennaio Consoli inizia seriamente a pensare ad un nuovo quotidiano da affidare a Montanelli dopo aver definitivamente rinunciato all’acquisto de Il Giorno. Montanelli accetta l’offerta solo dopo essere stato rinfrancato dall’adesione di Luciano Benetton: si era reso conto che “la Piemmei non è in grado da sola di prendere il largo” ma aveva bisogno di “altre mani” e capitali. Pur detestando trattare di argomenti finanziari, il vecchio giornalista organizza un incontro con Benetton che si dichiara disposto a comprare una quota del futuro giornale (2 miliardi e 400 milioni, il massimo consentito dalla public company, versata in due tranche). L’imprenditore veneto, mettendo in campo il suo nome, rianima finanziariamente la società e fa da volano per la raccolta di nuovi capitali. A dispetto della sua denominazione la nuova compagine editoriale ha mutato pelle: partecipano al capitale sociale, grandi industriali (Benetton, Vittorio Cecchi Gori e Leonardo Del Vecchio, entrambi con cinquecento milioni), una cordata di medi imprenditori (tra cui Giorgio Seragnoli, gli industriali tessili Miroglio di Alba, i titolari della Same Trattori e delle cucine Smeg) e piccoli azionisti in forma privata (pensionati, studenti, professionisti e il CALIM, Club Amici Lettori Indro Montanelli). Non si sottraggono nemmeno i redattori della futura Voce e si fanno avanti associazioni di categoria di ogni settore (Confapi, Confartigianato, Cna, Confedilizia, Clai) e associazioni di volontariato (Arci, Uip, Lega delle cooperative del Lazio). Dal 19 gennaio, la Voce ha una sede operativa a Milano in via Turati 28. Il trasferimento definitivo, invece, avviene il 21 febbraio in via Dante al 12, elegante palazzo di 1800 metri quadrati su cinque piani che prima del ciclone “Mani pulite” ospitava gli uffici di Silvano Larini. Il primo numero vende oltre mezzo milione di copie Annunciato inizialmente per l’8, spostato per motivi tecnici al 15, il debutto de la Voce avviene finalmente il 22 marzo 1994. Ed è subito un successo: 300mila copie sono stampate solo a Roma e Milano, 100mila in più rispetto all’obiettivo previsto. Tuttavia, poiché ogni tiratura viene subito assorbita, si continua a stampare fino alle 11 di martedì. Alla fine della giornata si calcola così che il primo numero de la Voce ha venduto 535mila copie. Per il secondo numero se ne stampano 506mila, di cui 475mila vendute. Un leggero 9 TESI DI LAUREA La Voce 1994 2004 calo delle vendite si verifica nei giorni successivi, ma a sorpresa la media si assesta sulle 300mila copie. Dopo il periodo delle elezioni politiche, la Voce ha una progressiva flessione e a fine maggio la diffusione media è di 106mila copie. Corona definisce la Voce un “giornale di gran battaglia”, un “vascello corsaro” che prende ferme posizioni fin dalla vigilia delle consultazioni elettorali. Per non incorrere in un possibile equivoco determinato dalla grafica, il Direttore si affretta a chiarire di essere fermamente contrario al “giornalismo urlato”, indubbiamente più propenso ad un “giornalismo perentorio”: “Non confondiamo l’urlo con la fermezza, sono due cose diverse. Io cercherò di fare un giornale molto fermo sulle sue posizioni, senza urlare. Perché l’urlo è di cattivo gusto, è sempre indizio di volgarità, e poi di urlare non c’è bisogno”. Le dichiarazioni di Montanelli presentano subito la Voce come un giornale d’opinione che ricerca una forte identificazione col lettore fornendogli già una considerazione sulla notizia. Per avere una visibilità forte in edicola e per sviluppare una propria identità, Corona ha puntato sulla “copertina-quotidiano”: tutti i giorni viene scelto l’argomento principale sul quale si costruisce la prima pagina con il sistema del fotomontaggio. Secondo la volontà del suo ideatore, esso è un’interpretazione ironica, sarcastica della notizia e contemporaneamente un commento alla stessa; ma può anche risultare violento al punto da far scaturire delle polemiche. Già nel secondo numero a molti lettori non piace la copertina, della Corsa al balcone (Bossi, Berlusconi e Fini con il fez e l’orbace, divisa dei generali fascisti). Così qualche giorno dopo, Montanelli sollecitato interviene per spiegare che il fotomontaggio è sempre una forzatura, per questo definito “clavata”. Non passa inosservata neanche la prima pagina del 31 marzo: sotto il celebre pulpito di piazza Venezia una folla fremente aspetta “l’uomo della provvidenza”, da identificarsi univocamente con il candidato premier Berlusconi. L’immagine, accompagnata dal titolo L’attesa, provoca Sgarbi che non perde occasione per insultare Montanelli, definendolo “mediocre, folcloristico, vigliacco, pavido, razzista, antisemita”. La copertina, però, che crea maggiori problemi al Direttore è quella del 26 aprile: Cuccia, l’orgia del potere. Accompagna l’immagine un violento articolo di Alberto Mazzuca. La Voce è il primo quotidiano che ha il coraggio di attaccare frontalmente l’ultima operazione del “grande vecchio dell’economia [...] un colossale scippo” compiuto ai danni dei piccoli azionisti con le privatizzazioni della Banca Commerciale e del Credito Italiano. Un’altra immagine riconosciuta persino dallo stesso Corona “eccessiva” è quella della parata della Rainvest goebbelsiana (20 gennaio): immediate sono le reazioni indignate dei direttori del Tg2 e Tg5, Clemente Mimun e Enrico Mentana. Quando le vendite del quotidiano cominciarono a calare e soprattutto quando si profilarono all’orizzonte nemici influenti, Montanelli indisse un’assemblea generale per confrontarsi con il parere dei redattori riguardo al tono dei fotomontaggi, ma a larga maggioranza si decise di continuare in questa direzione. In tutto l’anno di vita del quotidiano, il Direttore non cessa mai di ripetere che “le copertine devono essere intese come un’iperbole, un paradosso allo stesso modo delle vignette di Forattini su Repubblica”, una provocazione da leggere con ironia, ma a distanza di sette anni definisce alcuni fotomontaggi “digrignature di denti” riconoscendo l’errato approccio: “si deve essere cattivi, ma sembrando buoni”. Intanto, accanto ad alcuni prestigiosi collaboratori de il Giornale che sono passati in via Dante, la Voce si arricchisce di altre firme illustri come i giudici Davigo e Maddalena, il cardinale Tonini, l’economista Baldassarri, l’ex presidente del Consiglio Amato e l’ex presidente della Corte costituzionale Elia. 10 Nonostante le difficoltà societarie a luglio le vendite tornano a salire in coincidenza di due piccole novità editoriali: “Le interviste immaginarie” di Montanelli che danno voce a personaggi politici italiani del secondo dopoguerra (da De Gasperi a Togliatti, da don Vizzini a Nenni) e le strisce comiche di “Paperino&C”. “Lettori, alzate la voce” Vince il popolo dei fax Per evidenti ragioni di bilancio la promozione de la Voce, si affida per lo più alle sue idee. A movimentare il mercato le nette prese di posizione riguardo a due avvenimenti: l’approvazione del decreto Biondi da parte del governo “in un giorno in cui l’attenzione degli italiani era tutta concentrata sulla nazionale di calcio che giocava ai mondiali negli Stati Uniti” e il defenestramento della “Rai dei professori” a favore di un Consiglio che chiama direttori più vicini alla nuova maggioranza. La cronaca riporta che il 13 luglio viene firmato il decreto del Guardasigilli che modifica alcune norme del codice di procedura penale. Gli articoli più discussi riguardano la revisione della custodia cautelare e le disposizioni in materia di avviso di garanzia. La Voce si fa interprete del pensiero comune sostenendo che queste disposizioni mettono un bavaglio all’informazione e legano le mani al pool di Mani pulite. Il 15 luglio compare un appello in prima pagina che si ripresenta puntuale per tutta la settimana dal titolo “Lettori, alzate la voce”. Il quotidiano esprime la sua solidarietà ai magistrati e offre ai lettori la possibilità di fare altrettanto, con telefonate o fax. Dal giorno successivo in redazione giungono le adesioni che alla fine raggiungeranno quota 30mila. Le più significative sono pubblicate sotto il titolo: “Firmate, fermateli”. Il 20 luglio il governo decide per il disegno di legge in luogo del decreto e la Voce canta vittoria: “Decreto addio.” Hanno vinto i fax. È tale il successo di questa iniziativa che martedì 26 si allega un altro quotidiano di 32 pagine, la Vostra Voce, con i nomi, i pensieri e le illustrazioni di coloro che si sono battuti insieme a la Voce. L’iniziativa “Firmate, fermateli” diventa “una bandiera attorno a cui ci si può stringere nei momenti in cui è necessario che il popolo faccia sentire la sua vera voce”. Ancora maggior successo riscuote la campagna sull’informazione. Il 3 luglio l’articolo di spalla prospetta l’opportunità di discutere della libertà di parola in un incontro a Milano. Le adesioni a “Seconda Repubblica e Quarto Potere” giungono nei giorni successivi e si organizza un convegno al Teatro Nuovo; secondo Montanelli solo con un’informazione libera può esistere una società civile. Ogni azione che la Voce promuove ha un’enorme risonanza sui mezzi di comunicazione, amplificata dal sorgere di aspre polemiche: l’obiettivo promozionale è raggiunto. Anche per questo motivo la Voce, vissuta solo tredici mesi, è ancora molto radicata nella memoria di chi l’ha letta. A metà settembre, Montanelli decide di accettare l’invito a partecipare al dibattito sull’informazione, organizzato alla Festa dell’Unità a Modena. Nonostante l’invito aperto, la partecipazione dei direttori di giornali italiani è scarsa: suscita quindi fragore il suo intervento, tra i festeggiamenti del pubblico di sinistra. Non perde occasione di sottolineare di non sentirsi “uno di loro”, ribadendo: “Mi sono sempre professato e continuo a professarmi uomo di destra. Ma con la vera destra, quella patacca di destra che ci governa non ho nulla a che fare”. La precisazione è inutile perché questa visita, che i nemici di Montanelli sventoleranno come prova della sua deriva a sinistra, farà perdere al giornale, nel giro di pochi giorni, quasi 10mila copie. Anche Montanelli a posteriori confessò l’errore perché “diede adito a numerose strumentalizzazioni”. Ad agosto Montanelli, incitato da un lato dai finanziatori e pressato dall’altro dagli inserzionisti pubblicitari, decide di chiamare Gianni Locatelli, ex direttore Rai e del Sole-24 Ore, per sopperire alla mancanza di un vero manager editoriale. L’insediamento di Locatelli inizialmente si accompagna all’investitura di amministratore delegato, come testimoniato dalla lettera di benvenuto di Montanelli pubblicata su la Voce: “1) Avrai da me un incondizionato appoggio nei piani di ristrutturazione e di rilancio de la Voce. 2) Entro il 1995 sarai il mio condirettore responsabile con tutti i poteri”. Il suo piano triennale verte su tre punti: rimpinguare le casse delle Piemmei grazie all’allungamento dei tempi per la chiusura della sottoscrizione e alla ricerca di nuovi azionisti tra gli imprenditori, tagliare le spese eccedenti e varare nuove iniziative che abbiano un ritorno pubblicitario. Non riuscendo ad attirare nuovi soci e capitali freschi (la Consob respingerà la proposta di prolungare l’Ops), Locatelli imbocca la strada della compressione dei costi. Evidenzia subito al CdR che il costo giornalistico de la Voce è tra i più alti elevati in Italia e propone una riduzione delle retribuzioni del 10% o nove dimissioni incentivate: tagliando 500 milioni di guadagno netto annuo della redazione, l’azienda ne avrebbe beneficiato per un miliardo e quattrocento milioni. Nonostante Locatelli prospetti come alternativa la dichiarazione dello stato di crisi e la cassa integrazione, si trova di fronte il netto rifiuto della redazione. Fallisce il piano di risanamento e non si trovano nuovi sponsor Tra le altre proposte di ridimensionamento Locatelli propone il trasferimento in via Alserio (risparmio del 60% sull’affitto di un miliardo della sede di via Dante), la rinegoziazione del contratto settennale con l’editore Colasanto per la riduzione dei costi di stampa del 50% e la chiusura della lavorazione del giornale alle 22.30. Intanto accelera sulla ricerca di nuovi sponsor, anche in maniera trasversale: dal primo ottobre aumenta la foliazione da 32 a 36 pagine, in coincidenza delle sfilate milanesi del prêt à porter femminile, con il chiaro intento di attirare inserzionisti dal profittevole mondo della moda. Con lo stesso obiettivo, si annuncia a metà mese l’uscita di “Superodeon”, un inserto che sarebbe dovuto uscire quotidianamente con sette pagine, una sorta di “dorso di giornale” orientato all’intrattenimento e al tempo libero alla ricerca del pubblico più giovane e delle donne. Questa sorta di magazine, però, non decolla rendendo inutile l’investimento pubblicitario di oltre 300 milioni. Sempre a ottobre, si registrano buoni risultati sul fronte pubblicitario: il fatturato ha superato i nove miliardi, ben sopra i sei e mezzo previsti nel budget. Forti di questi dati, la società parla di rinegoziare, a condizioni più vantaggiose, il contratto con la concessionaria pubblicitaria. Altri cambiamenti coinvolgono l’ufficio di corrispondenza di Napoli che si trasforma in una vera redazione. L’obiettivo è quello di raggiungere le 10mila copie, cercando di catturare i lettori insoddisfatti del Mattino e de la Repubblica. Questa operazione (che vede la sua nascita l’8 novembre) avrà all’inizio un buon successo, anche grazie al prezzo promozionale di mille lire: due mesi dopo, a costo pieno, le copie vendute si dimezzeranno. Dal 16 marzo 1995 esce il primo fascicolo della riedizione dell’opera montanelliana di “Uomini contro”, una serie di biografie di personaggi storici allegate al quotidiano. Ottimi progetti, la maggior parte dei quali rimarrà però solo sulla carta. A dicembre due avvenimenti avevano rivitalizORDINE 5 2004 zato la diffusione de la Voce: le dimissioni del governo Berlusconi, ma soprattutto l’abbandono della toga da parte di Antonio Di Pietro che fa registrare una punta di 120mila copie! La tiratura quasi raddoppia, grazie anche allo speciale supplemento da staccare e conservare che il quotidiano dedica all’avvenimento. Ma la caduta di Berlusconi, con il passare del tempo penalizzerà la diffusione del giornale poiché sembra togliergli il principale bersaglio. Da questo momento la Voce non rialzerà più la sua media di vendite. A partire dal nuovo anno, si susseguono rapidamente forti terremoti che causeranno inevitabilmente la sospensione delle pubblicazioni. L’epicentro si individua ancora una volta in Locatelli. Secondo quanto concordato, l’amministratore delegato ai primi di febbraio assume la funzione di condirettore. Orlando, esautorato dalla sua carica, abbandona la Voce insieme ad altri giornalisti, provocando la reazione di molti lettori che scrivono al giornale per lamentarsi. La riorganizzazione promossa da Locatelli, provoca subito sospetti e malumori: si diffonde il timore che voglia relegare il Direttore ad una carica puramente onorifica. Montanelli, tuttavia, non rimane impassibile di fronte alle perdite dei suoi collaboratori e il 22 marzo scrive una lettera a Locatelli, ricordandogli che quando si era lanciato nell’avventura de la Voce, lo aveva fatto “per dare alloggio a quei compagni di lavoro che non volevano più stare a il Giornale”, non per lui che poteva sedersi sulla “comoda poltrona del Corriere”. In qualità di pater familias continua a dichiarsi loro garante e chiede al neo-condirettore di riconoscergli lo stesso ruolo. Accusa poi il “modo un po’ spicciativo” con cui è stato deciso il taglio di alcune persone che, sostiene, “per conto mio si potevano salvare” come Sarcina, Orlando e Bucci, l’allontanamento di alcune delle persone care, come Frigerio, Righetti e Abate, l’emarginazione di Mazzuca. La Voce perde un’altra importante firma: Mario Cervi comunica al Direttore e amico fraterno che non si sente più a suo agio in via Dante. La situazione si aggrava con l’iniziativa di Colasanto, in credito da dicembre, di bloccare le rotative il 28 marzo. La decisione fa scoppiare un caso politico, sollevato tra gli altri da la Repubblica e da Il Manifesto: si viene a conoscenza che Colasanto si presenterà alle regionali nelle liste di Forza Italia. Il quotidiano chiede ospitalità alla tipografia de Il Giorno che stampa la Voce con un forte fotomontaggio di copertina: il Direttore imbavagliato. La fine è solo rimandata al Consiglio di amministrazione del 5 aprile: si decide l’inderogabile sospensione delle pubblicazioni poiché il capitale sociale della Piemmei è vicino al minimo legale. Ci si aspetta la contromossa degli azionisti di mettere mano al portafoglio, ma ciò non accade e con un comunicato datato 11 aprile 1995 le pubblicazioni sono ufficialmente sospese, anche se verrà esaudito il desiderio di Montanelli di poter fare l’ultimo numero. Alle 11.30 dello stesso giorno si svolge l’ultima assemblea di redazione. Montanelli visibilmente commosso apre lapidario il suo discorso: “È andata male, chiedo scusa a tutti”. Ancora una volta manifesta il suo cruccio di sempre, cioè la sorte della sua “famiglia”: “L’anno scorso detti l’addio al Giornale con estrema disinvoltura perché ero convinto di rischiare poco e certamente non la vostra pelle. E sono uscito da quel giornale a testa alta. Anche oggi me ne vado a testa alta. Ma accompagnato dal tormento per il vostro futuro. Scusatemi ancora”. La Voce si congeda così dai suoi lettori il giorno dopo con un fotomontaggio dal titolo Il giorno degli sciacalli. Il Direttore, nel suo fondo d’addio “Uno straniero in Italia”, spiega i motivi della chiusura, puntando soprattutto il dito sul “vizio d’origine” che ha fatto della Voce “un giornale sbagliato, anzi un giornale straniero”: il rivolgersi ad una “destra fedele a se ORDINE 5 2004 stessa” che costituisce una “élite troppo esigua per nutrire un quotidiano”. Si dice segnato “nel morale e anche nel fisico” da questa battaglia di cui comunque va fiero, ma che gli ha lasciato troppe cicatrici. Chiede ai lettori di riconoscergli il “diritto al congedo”, confidando: “Mi mancheranno i lettori, quei lettori. Mi mancheranno terribilmente. Spero di mancare anch’io un po’ a loro”. Tramontate definitivamente le speranze di ricapitalizzazione, il 29 aprile l’assemblea dei soci decide la messa in liquidazione della compagnia editoriale. Quando finisce la benzina ...la macchina si ferma I motivi che determinano la sospensione delle pubblicazioni sono numerosi. Osservando freddamente i bilanci della società, la causa principale sembra di natura economica. Ma le analisi e le interpretazioni si rivelano molto sfaccettate. Mazzuca considera decisivi alcuni errori. Il primo che ha fatto nascere la Voce “con un vizio congenito al cuore” è di tipo gestionale: nonostante i 50 miliardi promessi da Consoli, la Voce parte con mezzi nettamente inferiori (al debutto sono solo 10), ma la redazione viene strutturata come se si possedesse quella disponibilità, con un organico di 80 giornalisti e con stipendi molto più alti rispetto a quelli de il Giornale. Montanelli condivideva il fatto che la Voce fosse fallita per la mancanza di capitali sufficienti ad arrivare al fatidico breakeven point. Quando decolla l’offerta pubblica di sottoscrizione si riaccendono le speranze di arrivare finalmente alla soglia dei 40 miliardi, ma anche in questo caso l’operazione parte con il piede sbagliato. Il messaggio promozionale diffuso da Consoli si rivela inefficace: trasformare la Piemmei in un gruppo multimediale. Prima di tendere ad un progetto così ambizioso, si doveva dotare la Voce di una “spina dorsale organizzativa”. A questa precaria situazione economica si aggiunge la mancanza di una strategia a lungo termine. Contagiati dall’euforia iniziale, non si cerca di consolidare il giornale. Appena le vendite iniziano a calare si propone di varare gli inserti firmati dal Direttore, ma ancora una volta manca uno sponsor che si accolli l’investimento iniziale. Mazzuca punta anche il dito su una decisione azzardata: aumentare il prezzo del giornale di duecento lire rispetto agli altri quotidiani in un momento in cui il panorama editoriale italiano subiva una perdita progressiva di copie. Un’altra causa è rintracciabile poi nella struttura della public company che, nel settore dell’informazione, si rivela una scelta sbagliata. Sono presenti tanti piccoli azionisti che si sentono in diritto di comandare: a lungo andare si avverte la mancanza di un editore vero che, pur rimettendoci economicamente sia disposto a garantire un orientamento sicuro. Anche Locatelli, conti alla mano, non manca di rimarcare che il fallimento dell’impresa è “strettamente economico in conseguenza ad un insuccesso editoriale [...]. Quando finisce la benzina, la macchina si ferma. Forse il motore consuma troppa benzina rispetto a quella che puoi pagare e bisogna trovare qualcuno che metta dentro il rifornimento”. Il carburante fornito dalle vendite del quotidiano si rivela insufficiente quando la linea editoriale non convince più i lettori. Locatelli conclude che alla Voce è mancata anche la forza di reggere alle forti provocazioni che hanno attirato così importanti inimicizie. “Io posso anche essere provocatorio, ma non posso pretendere che l’aggredito mi sia anche riconoscente” (con riferimento alla copertina Cuccia, l’orgia del potere [NdA]). Un’altra causa sottolineata tanto da Cervi quanto da Corona è la mancanza di un preciso target. Secondo l’editorialista molti lettori che inizialmente hanno comprato la Voce se ne sono rapidamente disaffezionati perché “avevano in mano un quotidiano che non era Montanelli!”. È diventata “una specie di organo radicale, di polemica violentissima” togliendo al quotidiano il terreno diffusionale nel quale poter trovare una propria nicchia di mercato. Anche Montanelli, pur non rinnegandole, considera alcune sue scelte la causa della defezione di molti lettori. Una grafica così innovativa bisognava “introdurla lentamente, senza traumatizzare il lettore, anche se i fotomontaggi sono stati la vera invenzione de la Voce”. La Voce è fallita perché “si rivolgeva ad un pubblico inesistente”. Anche Corona spiega che ci si può permettere di proporre un quotidiano “non mirato” solo quando si hanno alle spalle grandi finanziatori che assicurano la sopravvivenza al giornale. Purtroppo questo concetto aveva trovato notevoli resistenze, precludendogli la possibilità di lavorare al “prodotto” e di dargli il marketing giusto. Dal lato della redazione un altro fattore ha fatto parlare di “giornale schizzofrenico”: la coesistenza di due anime quella moderata di Montanelli, Cervi e altri e l’altra più radicale di Orlando e Corona in due mondi completamente separati. Ad un certo punto ha prevalso l’anima radicale e questo alla fine è stato uno scotto che si è pagato. Anche se lo stesso Montanelli alimenta questa opposizione interna considerandola come un “plus” del giornale: accostare un fondo di Cervi con un fotomontaggio di Corona era un gioco che amava molto. Serpeggiano poi voci di possibili azioni di disturbo da parte di avversari politici, come dichiara laconico Corona. Mazzuca si sbottona un po’ di più e racconta che, al momento della ricapitalizzazione della società, gli imprenditori che avrebbero dovuto mettere i soldi non hanno onorato la loro promessa. La Voce ha chiuso pur vendendo ancora 64mila copie e ipotizza che, salito al governo Berlusconi, gli azionisti che potevano infondere liquidi per la sopravvivenza del giornale, hanno avuto timore e si sono ritirati. Inaspettatamente, il colpo che atterra definitivamente il quotidiano è sferrato, secondo Aldo Vitali, dal suo stesso fondatore: deleterio è stato il ‘disengagement’ di Montanelli che, quando le cose si sono messe male, si è defilato velocemente togliendo la fiducia a Locatelli. In questo modo nessuno poteva prendere decisioni: quasi a dire “muoiano tutti con me!”. Questo atteggiamento del Direttore ha segnato nell’animo i redattori che si sono visti mancare di colpo il suo appoggio. Vitali è convinto che poteva trovare una soluzione intermedia, collaborando per il Corriere senza abbandonare la Voce. In realtà, Montanelli per lungo tempo ha nascosto alla redazione e ai suoi lettori le sue intenzioni. Se il 26 marzo rispondendo ad una lettera smentisce velatamente le voci che lo davano già al Corriere (“Non mi chieda smentite perché a furia di farne mi si è indolenzita la mano. Sono quasi vent’anni che si annunzia il mio ritorno al Corriere”), qualche anno dopo in occasione del suo novantesimo compleanno si scopre, da una lettera di auguri di Mieli, che già il 9 marzo aveva firmato per passare in via Solferino. Lavorando al suo fianco, Mazzuca nota che negli ultimi mesi Montanelli “non ha avuto la forza di fare il direttore: è andato in crisi, ha cercato un’altra collocazione al Corriere”. Rimasto molto deluso dall’andamento delle vendite, non è riuscito a riprendere in mano la situazione. Riconosce però che è disposto a tutto “pur di aiutare coloro che gli stanno più a cuore”, addirittura chiedendo a Berlusconi e al proprio successore Feltri di riprendere alcuni transfughi a il Giornale. Nonostante l’apparente fallimento, egli non rinnegherà mai questa esperienza, questo suo “generoso errore”, destinata come fuoco senza vento, a spegnersi tristemente. Cristina Luini 11 Segreto professionale dei giornalisti e perquisizioni nelle sedi dei giornali. Dopo le sentenze Goodwin e Roemen della Corte di Strasburgo GIORNALISMO E GIUSTIZIA EUROPEA Pm e giudici italiani devono indagare solo sui loro collaboratori (che “spifferano” le notizie) e non su chi riceve l’informazione di Franco Abruzzo* 1 Il giornalista come mediatore intellettuale tra il fatto e il lettore. Il segreto professionale gli consente di ricevere notizie, mentre le fonti sono “garantite” Non esiste il concetto giuridico di giornalismo. Il concetto, abitualmente estrapolato dall’articolo 2 della legge professionale n. 69/1963 (quello dedicato alla deontologia della categoria), si riassume nella frase “giornalismo=informazione critica”. Il primo comma dell’articolo 2, infatti, dice: “È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica.....”. Questo vuoto è stato, però, riempito dalla giurisprudenza: “Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso...... differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione” (Cass. Civ., sez. lav., 20 febbraio 1995, n. 1827). Dall’insieme delle norme si ricava che il giornalista raccoglie, commenta e elabora notizie legate all’attualità e che è tenuto ad assicurare (ai cittadini) un’informazione “qualificata e caratterizzata (secondo la sentenza n. 112/1993 della Corte costituzionale, ndr) da obiettività, imparzialità, completezza e correttezza; dal rispetto della dignità umana, dell’ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori nonché dal pluralismo delle fonti cui (i giornalisti, ndr) attingono conoscenze e notizie in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni, avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti”. Il pluralismo delle fonti a sua volta ha un’interfaccia che si chiama segreto professionale. Nel nostro ordinamento la tutela del segreto professionale viene tradizionalmente fatto risalire all’articolo 622 del Codice penale del 1930 (in vigore), che punisce la rivelazione del segreto professionale. Il divieto di divulgare la fonte della notizia è, invece, un principio giuridico, che ha festeggiato i 40 anni nel 2003. Giornalisti ed editori, in base all’articolo 2 (comma 3) 12 2 della legge professionale n. 69/1963, “sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse”. Tale norma consente al giornalista di ricevere notizie, mentre le fonti sono “garantite”. Anche l’articolo 13 (V comma) della legge sulla privacy (n. 675/1996) tutela il segreto dei giornalisti sulla fonte delle notizie, quando afferma che “restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia”. La violazione della regola deontologica del segreto sulla fonte fiduciaria comporta responsabilità disciplinare (articolo 48 della legge n. 69/1963). Il rispetto della segretezza della fonte fiduciaria della notizia, però, non appare assoluto. L’articolo 200 del Codice di procedura penale del 1988 stabilisce, per quanto concerne il rapporto tra obbligo a deporre avanti al giudice e segreto professionale, che il giornalista può opporre il segreto professionale sui nomi delle persone dalle quali egli ha avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata soltanto attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni. Il segreto professionale può, quindi, essere rimosso con “comando” del giudice a condizione che: a) la notizia che proviene dalla fonte fiduciaria sia indispensabile ai fini della prova del reato per cui si procede; b) l’accertamento della veridicità della notizia possa avvenire soltanto tramite l’identificazione della fonte fiduciaria (Tribunale di Alba, sentenza 25 gennaio 2001, n. 601/2000 Reg. gen.). In particolare il terzo comma dell’articolo 200 del Cpp enuncia: “Le disposizioni... si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’Albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare le fonti delle sue informazioni”. I pubblicisti e i praticanti, esclusi dai vincoli dell’articolo 200 del Codice di procedura penale, non possono, quindi, davanti al giudice, come i giornalisti professionisti, avvalersi delle norme citate per “coprire” la fonte fiduciaria delle loro notizie. Ma è pur vero che gli stessi sono tenuti a rispettare l’articolo 2 (comma 3) della legge n. 69/1963 sull’ordinamento della professione di giornalista: conseguentemente possono invocare il segreto sulle fonti. Segreto sulle fonti: “La norma assicura una piena tutela, consentendo una deroga soltanto in via di eccezione” (Tribunale penale di Treviso). Anche la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo protegge le fonti dei giornalisti Un giudice (mai un Pm) può ordinare, come riferito, a un giornalista professionista, in base all’articolo 200 del Cpp, di “indicare la fonte delle sue informazioni se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia”. Bisogna sottolineare che in sede giurisprudenziale è affiorato un orientamento più favorevole alle ragioni dei giornalisti: “La norma di cui al comma 3 dell’art. 200 Cpp deve intendersi riferita all’accertamento della fondatezza della notizia pubblicata, in quanto funzionale all’esame della sua veridicità che può trovare l’unico strumento nella identificazione della fonte fiduciaria. Solo in tale circostanza quindi il giudice, al fine di verificare la rispondenza della notizia indispensabile per la prova di un reato per cui si procede, potrebbe ordinare al giornalista di indicare la sua fonte, purché sia l’unico strumento investigativo a disposizione” (Pret. Roma, 21/02/1994). I giornalisti continuano, però, nonostante le timide aperture interpretative, ad opporre il segreto professionale, che è salvaguardato anche dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. L’articolo 10 (Libertà di espressione), - ripetendo le parole della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo del 1948 e del Patto sui diritti politici di New York del 1966 -, recita: “ Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere”. La libertà di ricevere le informazioni comporta, come ha scritto la Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo, la protezione assoluta delle fonti dei giornalisti. Una difesa forte del segreto dei giornalisti emerge dalla sentenza 14 gennaio 2000 del Tribunale penale di Treviso (n. 252/1999 Reg. gen.): “Nulla è risultato circa l’identità dell’informatore perché tutti i giornalisti indicati come testi si sono avvalsi del segreto professionale. Il Pm ha chiesto che gli stessi venissero obbligati, così come previsto dall’articolo 200 (terzo comma) Cpp, a deporre sul punto, ma il collegio ha respinto l’istanza. La norma appena menzionata assicura, invece, una piena tutela al segreto professionale dei giornalisti, consentendo una deroga soltanto in via di eccezione, e quindi di stretta interpretazione. Prevede l’imposizione dell’obbligo a deporre in presenza – congiunta – di due precisi requisiti: quello dell’impossibilità di accertare la veridicità della notizia se non attraverso l’identificazione della fonte della stessa e quello dell’indispensabilità della notizia ai fini della prova del reato per il quale si procede. Se questi sono gli stretti limiti di operatività della deroga, sembra evidente che l’obbligo a deporre sarebbe stato imposto non già ad accertare la veridicità della notizia (che pacificamente in questo caso erano vere e non richiedevano alcuna verifica in tal senso), bensì ad individuare l’autore del reato di rivelazione di segreti (del quale, oltretutto, il giornalista avrebbe potuto eventualmente essere anche partecipe), violando così la tutela del segreto sulle fonti giornalistiche accordata dal legislatore”. 3 C’è differenza tra il segreto professionale dei giornalisti e quello degli altri professionisti Medici, chirurghi, avvocati, sacerdoti, notai, consulenti tecnici, farmacisti e ostetriche, dottori e ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze sono tenuti a non divulgare notizie ricevute sotto l’impegno del segreto professionale. I giornalisti, invece, sono eticamente obbligati a rendere pubbliche (sulla stampa, per agenzia, per tv o per radio, per web) le notizie ricevute, ma, con gli editori, in base all’articolo 2 della legge professionale e all’articolo 13 della legge sulla privacy, sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse. Gli uni non divulgano le notizie, gli altri (i giornalisti) devono pubblicare e tutelare soltanto la fonte delle notizie pubblicate. Sentenza Goodwin: la Corte di Strasburgo difende il segreto professionale dei giornalisti (su questa linea anche il Parlamento europeo) 4 La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (legge 4 agosto 1955 n. 848) con l’articolo 10, come riferito, tutela espressamente le fonti dei giornalisti, stabilendo il diritto a “ricevere” notizie. Lo ha spiegato la Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo con la sentenza che ha al centro il caso del giornalista inglese William Goodwin (Corte europea diritti dell’Uomo 27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito, v. Tabloid n. 1/2000 n. Peron). William Goodwin, giornalista inglese, aveva ricevuto da una fonte fidata ed attendibile alcune informazioni su una società di programmi elettronici (la Tetra Ltd). In particolare il giornalista rivelò che tale società aveva contratto numerosi debiti e vertiginose perdite. La società Tetra per evitare i danni che sarebbero potuti derivarle dalla divulgazione di tali notizie presentò all’alta Corte di Giustizia inglese un ricorso con il quale non solo chiedeva che fosse vietata la pubblicazione ORDINE 5 2004 COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA Milano, 15 aprile 2004. Con riferimento ai drammatici odierni eventi dell’Irak, Franco Abruzzo ha dichiarato: “La pubblicazione di fotografie del cadavere della vittima di un omicidio può costituire reato se le immagini sono caratterizzate da particolari impressionanti e raccapriccianti, lesivi della dignità umana. La pubblicazione non rientra nel diritto di cronaca”. Franco Abruzzo richiama in particolare l’articolo 15 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 (sulla stampa) che punisce, con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila, la pubblicazione di “stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti”. Questo principio vale per tutti i media. L’articolo 15 della legge sulla stampa è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza 11-17 luglio 2000 n. 293 con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo, sollevata in riferimento agli articoli. 3, 21 (sesto comma) e 25 della Costituzione. In sostanza il divieto di pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante non contrasta con la Costituzione perché è diretto a tutelare la dignità umana. “La persona umana – ha precisato la Corte Costituzionale – è tutelata dall’articolo 2 dell’articolo in questione, ma chiedeva altresì che il giornalista fosse condannato a rivelare la fonte delle informazioni ricevute al fine di evitare nuove “fughe di notizie”. Le richieste della Tetra furono accolte sia dall’alta Corte che dalla Corte d’Appello, secondo le quali il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche ben può essere limitato “nell’interesse della giustizia, della sicurezza nazionale nonché a fini di prevenzione di disordini o di delitti”. Il giornalista, tuttavia, non eseguì l’ordine di divulgazione della fonte – posto che in tale modo la stessa si sarebbe “bruciata” – e presentò ricorso alla Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo, denunciando la violazione dell’articolo 10 della Convenzione. La Corte di Strasburgo, con sentenza 27 marzo 1996, muovendo dal principio che ad ogni giornalista deve essere riconosciuto il diritto di ricercare le notizie, ha ritenuto che “di tale diritto fosse logico e conseguente corollario anche il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche, fondando tale assunto sul presupposto che l’assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al giornalista, con la conseguenza che questi correrebbe il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni che potrebbero rivestire un interesse generale per la collettività”. Questa sentenza della Corte di Strasburgo è l’altra faccia di una sentenza (la n. 11/1968) della nostra Corte costituzionale: “Se la libertà di informazione e di critica è insopprimibile, bisogna convenire che quel precetto, più che il contenuto di un semplice diritto, descrive la funzione stessa del libero giornalista: è il venir meno ad essa, giammai l’esercitarla che può compromettere quel decoro e quella dignità sui quali l’Ordine è chiamato a vigilare”. La decisione del caso “Goodwin” è particolarmente interessante anche perché ha concorso a dissipare i dubbi nascenti da una interpretazione letterale dell’articolo 10 della Convenzione, che si limita a specificare che la libertà di espressione comprende sia il diritto passivo a ricevere delle informazioni sia il diritto attivo di fornirle, senza, però, che sia menzionato il diritto del giornalista di cercare e procurarsi notizie tramite proprie fonti di informazioni. Tale lacuna aveva, difatti, sollevato il quesito - attualmente sciolto dalla Corte – che quest’ultimo diritto non rientrasse nell’ambito del diritto alla libertà e pertanto non fosse ricompreso nell’ambito della sua tutela. Ma del resto la tendenza espressa dalla Corte con tale decisione trova ulteriore conferma e riscontro con le tendenze espresse al riguardo dallo stesso Parlamento Europeo, il quale – in una risoluzione del 18 gennaio 1994 sulla segretezza delle fonti d’informazione dei giornalisti - ha dichiarato che “il diritto alla segretezza delle fonti di informazioni dei giornalisti contribuisce in modo significativo a una migliore e più completa informazione dei cittadini e che tale diritto influisce di fatto anche sulla trasparenza del processo decisionale”. In sintesi il segreto professionale è indispensabile sia nello svolgimento della professione giornalistica che nell’esercizio del diritto di ogni cittadino a ricevere informazioni, mentre ORDINE 5 2004 Abruzzo: “Pubblicare foto raccapriccianti non è diritto di cronaca e costituisce reato. Questo principio vale per tutti i media” della Costituzione, in base al quale deve essere interpretato l’articolo 15 della legge sulla stampa; la descrizione dell’elemento materiale del fatto-reato, indubbiamente caratterizzato dal riferimento a concetti elastici, trova nella tutela della dignità umana il suo limite, sì che appare escluso il pericolo di arbitrarie dilatazioni della fattispecie, risultando quindi infondate le censure di genericità e indeterminatezza”. “Quello della dignità della persona umana – ha affermato la Corte - è, infatti, valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo e deve dunque incidere sull’interpretazione di quella parte della disposizione in esame che evoca il comune sentimento della morale”. La Cassazione (Sezione Terza Penale n. 23356 dell’8 giugno 2001, Pres. Malinconico, per contro le uniche eccezioni ammissibili devono essere ragionevoli e in ogni caso limitate, poiché “il mancato rispetto del segreto professionale limita in modo indiretto lo stesso diritto all’informazione”. 5 La Corte di Strasburgo, con la sentenza Roemen, impone l’alt alle perquisizioni negli uffici dei giornalisti e dei loro avvocati a tutela delle fonti dei giornalisti L’ordinamento europeo impedisce ai giudici nazionali di ordinare perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni dei giornalisti nonché nelle “dimore” dei loro avvocati a caccia di prove sulle fonti confidenziali dei cronisti: “La libertà d’espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, e le garanzie da concedere alla stampa rivestono un’importanza particolare. La protezione delle fonti giornalistiche è uno dei pilastri della libertà di stampa. L’assenza di una tale protezione potrebbe dissuadere le fonti giornalistiche dall’aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni d’interesse generale. Di conseguenza, la stampa potrebbe essere meno in grado di svolgere il suo ruolo indispensabile di “cane da guardia” e il suo atteggiamento nel fornire informazioni precise e affidabili potrebbe risultare ridotto”. Questi sono i principi sanciti nella sentenza “Roemen” 25 febbraio 2003 (Procedimento n. 51772/99) della quarta sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il segreto professionale dei giornalisti è tutelato solennemente dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, mentre l’articolo 8 della stessa Convenzione protegge il domicilio dei legali. I protagonisti di questa vicenda (causa Roemen e Schmit contro Lussemburgo) sono due cittadini lussemburghesi, il giornalista Robert Roemen e l’avvocato AnneMarie Schmit. La Corte di Strasburgo ha dichiarato che c’è stata la violazione degli articoli 8 e 10 della Convenzione e conseguentemente ha condannato il Granducato del Lussemburgo a pagare al giornalista e all’avvocato 4mila euro a testa per i danni morali nonché le spese (11.629 euro) al cronista. Il 21 luglio 1998, Robert Roemen ha pubblicato un articolo intitolato “Minister W. der Steuerhinterziehung überführt” (Il ministro W. accusato di frode fiscale) sul quotidiano “Lëtzëbuerger Journal”. Vi sosteneva che “il ministro aveva infranto il settimo, l’ottavo e il nono comandamento con frodi riguardanti l’IVA e osservava che ci si sarebbe potuti aspettare che un uomo politico di destra prendesse più sul serio i principi elaborati con tanta cura da Mosè. Precisava che il ministro era stato oggetto di una sanzione fiscale di 100.000 franchi lussemburghesi. Concludeva che un tale atteggiamento era ancor più vergognoso poiché proveniente da una personalità che doveva servire da Rel. Postiglione), richiamando l’indirizzo della Consulta, ha affermato - nella vicenda che vedeva coinvolti il direttore e due redattori del settimanale “Visto” (condannati dalla Corte d’Appello di Milano alla pena di tre mesi di reclusione e di lire trecentomila di multa ) che “l’esercizio del diritto di cronaca pur pienamente legittimo in una società democratica ed aperta, deve salvaguardare come valori fondamentali il comune sentimento della morale e la dignità umana tutelate dall’articolo 2 della Costituzione. I giudici di appello - ha osservato la Suprema Corte - hanno correttamente motivato la loro decisione rilevando che le immagini della vittima dell’omicidio sono tali da destare impressione e raccapriccio nell’osservatore di normale emotività, improntata ad impulsi di solidarietà umana, pietà per esempio”. La reazione del ministro era scattata sul fronte amministrativo e penale. Così i giudici avevano ordinato di perquisire gli studi e gli uffici del giornalista e dell’avvocato alla ricerca di indizi tali da portare gli inquirenti alla identificazione delle “gole profonde” annidate nell’amministrazione finanziaria del Granducato. Si legge nella sentenza: “Secondo l’opinione della Corte il presente caso si distingue dal caso Goodwin in un punto fondamentale. In quest’ultimo caso l’ingiunzione (di un tribunale inglese, ndr) aveva intimato al giornalista di rivelare l’identità del suo informatore, mentre nel caso in oggetto sono state effettuate perquisizioni presso il domicilio e il luogo di lavoro del giornalista. La Corte giudica che delle perquisizioni aventi per oggetto di scoprire la fonte di un giornalista costituiscono - anche se restano senza risultato un’azione più grave dell’intimazione di divulgare l’identità della fonte. Infatti, gli inquirenti che, muniti di un mandato di perquisizione, sorprendono un giornalista nel suo luogo di lavoro, detengono poteri d’indagine estremamente ampi poiché, per definizione, possono accedere a tutta la documentazione in possesso del giornalista. La Corte, che non può fare altro se non rammentare che “i limiti definiti per la riservatezza delle fonti giornalistiche esigono da parte [sua] (...) l’esame più scrupoloso possibile” (vedi sopra il provvedimento Goodwin citato, § 40), è quindi del parere che le perquisizioni effettuate presso il giornalista erano ancora più lesive nei confronti della protezione delle fonti di quelle adottate nel caso Goodwin.In considerazione di quanto precede la Corte giunge alla conclusione che il Governo non ha dimostrato che l’equilibrio degli interessi in oggetto, vale a dire, da un lato, la protezione delle fonti e, dall’altro, la prevenzione e repressione dei reati, sia stato salvaguardato. A tale scopo rammenta che “le considerazioni di cui devono tenere conto le istituzioni della Convenzione per esercitare il loro controllo nell’ambito del par. 2 dell’art.10 fanno pendere la bilancia degli interessi in oggetto in favore di quello della difesa della libertà di stampa in una società democratica” (vedi supra il provvedimento Goodwin citato, § 45)”. L’avvocato, invece, lamenta un’aggressione ingiustificata al suo diritto al rispetto del suo domicilio a causa della perquisizione effettuata presso il suo studio. Sostiene inoltre che il sequestro avvenuto in tale occasione ha violato il diritto al rispetto della “corrispondenza fra l’avvocato e il suo cliente”. La Corte riconosce che “il mandato di perquisizione concedeva quindi agli inquirenti dei poteri piuttosto estesi”. Inoltre, e soprattutto, la Corte è del parere che lo scopo della perquisizione era infine quello di svelare la fonte del giornalista: “Di conseguenza, la perquisizione della scrivania dell’avvocato ha avuto una ripercussione sui diritti garantiti al giornalista dall’articolo 10 della Convenzione. La Corte giudica peraltro che la perquisizione della scrivania è stata sproporzionata rispetto allo scopo previsto, sostanzialmente tenendo conto della rapidità con cui è stata effettuata”. la defunta, rispetto per la sua spoglia, repulsione istintiva verso le ferite efferatamente impresse, salvaguardia della dignità della persona già uccisa in quel modo ed ulteriormente oltraggiata dalla pubblica ostensione del suo corpo, naturale esigenza di riservatezza verso l’intimità fisica personale rinforzata dalla condizione mortale del soggetto”. Il direttore e due redattori del settimanale “Visto” avevano, in concorso con un pubblico ufficiale non identificato, realizzato e pubblicato un servizio dedicato alla morte per omicidio della contessa Alberica Filo della Torre, avvenuta nel luglio 1991, corredandolo con tre fotografie a colori raffiguranti il cadavere della vittima così come era stato rinvenuto nell’immediatezza del delitto, con particolari impressionanti e raccapriccianti delle tracce lasciate sul corpo nudo e sugli indumenti e delle modalità di esecuzione del crimine. Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e il Consiglio nazionale dell’Ordine hanno fatto proprio l’indirizzo della Corte costituzionale sul piano deontologico nella vicenda di “Libero”, conclusasi con la sanzione della censura per il direttore del quotidiano (radiato dall’Albo in primo grado). “Libero” aveva pubblicato il 28 settembre 2000 otto immagini raccapriccianti di bambini violentati. Il direttore ha patteggiato due mesi di reclusione per questi fatti e ha poi dichiarato al “Foglio” che non avrebbe mai in futuro ripetuto l’errore. La tutela delle fonti dei giornalisti a livello continentale 6 Con la raccomandazione n° R (2000) 7, adottata l’8 marzo 2000, anche il Consiglio d’Europa ha voluto tutelare solennemente le fonti dei giornalisti, affermando: “Il diritto dei giornalisti di non rivelare le loro fonti fa parte integrante del loro diritto alla libertà di espressione garantito dall’articolo 10 della Convenzione. L’articolo 10 della Convenzione, così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, s’impone a tutti gli Stati contraenti. Vista l’importanza, per i media all’interno di una società democratica, della confidenzialità delle fonti dei giornalisti, è bene tuttavia che la legislazione nazionale assicuri una protezione accessibile, precisa e prevedibile. È nell’interesse dei giornalisti e delle loro fonti come in quello dei pubblici poteri disporre di norme legislative chiare e precise in materia. Queste norme dovrebbero ispirarsi all’articolo 10, così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, oltre che alla presente Raccomandazione. Una protezione più estesa della confidenzialità delle fonti d’informazione dei giornalisti non è esclusa dalla Raccomandazione. Se un diritto alla non-divulgazione esiste, i giornalisti possono legittimamente rifiutare di divulgare delle informazioni identificanti una fonte senza esporsi alla denuncia della loro responsabilità sul piano civile o penale o a una qualunque pena cagionata da questo rifiuto”. Questa raccomandazione concorre, con la risoluzione del Parlamento europeo e con le sentenze della Corte dei Strasburgo, a formare uno “spazio giuridico europeo”, che fa del segreto professionale dei giornalisti un caposaldo della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all’informazione. 7 Le norme della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo sono di immediata operatività nel nostro Paese La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali rappresenta un meccanismo di protezione internazionale dei diritti dell’uomo particolarmente efficace. Le norme della Convenzione sono di immediata operatività nel nostro Paese: «Le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, salvo quelle il cui contenuto sia da considerarsi così generico da non delineare specie sufficientemente puntualizzate, sono di immediata applicazione nel nostro Paese e vanno concretamente valutate nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo che si è venuto a determinare in conseguenza del loro inserimento nell’ordinamento italiano; la ‘precettività’ in Italia delle norme della Convenzione consegue dal principio di adattamento del diritto italiano al diritto internazionale convenzionale per cui ove l’atto o il fatto normativo internazionale contenga il modello di un atto interno 13 Segreto professionale dei giornalisti e perquisizioni nei giornali Pm e giudici italiani devono indagare solo sui loro collaboratori (che “spifferano” le notizie) e non su chi riceve l’informazione completo nei suoi elementi essenziali, tale cioè da poter senz’altro creare obblighi e diritti, l’adozione interna del modello di origine internazionale è automatica (adattamento automatico), ove invece l’atto internazionale non contenga detto modello le situazioni giuridiche interne da esso imposte abbisognano, per realizzarsi, di una specifica attività normativa dello Stato» (Cass., sez. un. pen., 23 novembre 1988; Parti in causa Polo Castro; Riviste: Cass. Pen., 1989, 1418, n. Bazzucchi; Riv. Giur. Polizia Locale, 1990, 59; Riv. internaz. diritti dell’uomo, 1990, 419). Anche la Corte costituzionale (sentenza n. 10 del 19 gennaio 1993) si è pronunciata autorevolmente in tale senso, specificando che la legislazione con cui la Convenzione è entrata in vigore in Italia consiste in una normativa che, pur avendo forza di legge, deriva «da una fonte riconducibile a una competenza atipica» e pertanto risulta «insuscettibile di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria». Ribadiscono ancora i supremi giudici della prima sezione penale, che si pongono su di una linea di continuità con gli enunciati delle Sezioni unite del 1988: «Le norme della Convenzione europea, in quanto principi generali dell’ordinamento, godono di una particolare forma di resistenza nei confronti della legislazione nazionale posteriore» (Cass. pen., sez. I, 12 maggio 1993; Parti in causa Medrano; Riviste Cass. Pen., 1994, 440, n. Raimondi; Rif. legislativi L 4 agosto 1955 n. 848; Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, art. 86). La suprema magistratura civile è dello stesso avviso: «Le norme della Convenzione europea sui diritti dell’Uomo, nonché quelle del primo protocollo addizionale, introdotte nell’ordinamento italiano con l. 4 agosto 1955 n. 848, non sono dotate di efficacia meramente programmatica. Esse, infatti, impongono agli Stati contraenti, veri e propri obblighi giuridici immediatamente vincolanti, e, una volta introdotte nell’ordinamento statale interno, sono fonte di diritti ed obblighi per tutti i soggetti. E non può dubitarsi del fatto che le norme in questione - introdotte nello ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione, non possono ritenersi abrogate da successive disposizioni di legge interna, poiché esse derivano da una fonte riconducibile ad una competenza atipica e, come tali, sono insuscettibili di abrogazione o modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria» (Cass. civ., sez. I, 8 luglio 1998, n. 6672; Riviste: Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario, 1998, 1380, n. Marzanati; Giust. Civ., 1999, I, 498; Rif. legislativi L 4 agosto 1955 n. 848). Anche la giustizia amministrativa ritiene che «la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, resa esecutiva con la l. 4 agosto 1955 n. 848, sia direttamente applicabile nel processo amministrativo» (Tar Lombardia, sez. III, Milano 12 maggio 1997 n. 586; Parti in causa Soc. Florenzia c. Iacp Milano e altro; Riviste Foro Amm., 1997, 1275,, 2804, n. Perfetti; Colzi; Rif. legislativi L 4 agosto 1955 n. 848, artt. 6 e 13 L 4 agosto 1955 n. 848). La Convenzione deve il suo successo al fatto di fondarsi su un sistema di ricorsi – sia da parte degli Stati contraenti sia da parte degli individui - in grado di assicurare un valido controllo in ordine al rispetto dei principi fissati dalla Convenzione stessa. La Corte europea dei diritti dell’Uomo è in sostanza un tribunale internazionale istituito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali al quale può essere proposto ricorso per la violazione di diritti e libertà garantiti dalla Convenzione sia dagli Stati contraenti e sia dai cittadini dei singoli Stati. Non solo gli articoli della Convenzione quant’anche le sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell’Uomo, che della prima è diretta emanazione, sono vincolanti per gli Stati contraenti. «Le Alte Parti contraenti – dice l’articolo 46 della Convenzione – si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti». Va detto anche che gli articoli della Convenzione operano e incidono unitamente alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo ne dà attraverso le sentenze. Le sentenze formano quel diritto vivente al quale i giudici dei vari Stati contraenti sono chiamati ad adeguarsi sul modello della giustizia inglese. «La portata e il significato effettivo delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli non possono essere compresi adeguatamente senza far riferimento alla giurisprudenza. La giurisprudenza diviene dunque, come la Corte stessa ha precisato nel caso Irlanda contro Regno Unito (sentenza 18 gennaio 1978, serie A n. 25, § 154) fonte di parametri interpretativi che oltrepassano spesso i limiti del caso concreto e assurgono a criteri di valutazione del rispetto, in seno ai vari sistemi giuridici, degli obblighi derivanti dalla Convenzione… i criteri che hanno guidato la Corte in un dato caso possono trovare e hanno trovato applicazione, mutatis mutandis, anche in casi analoghi riguardanti altri Stati» (Antonio Bultrini, La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo: considerazioni introduttive, in Il Corriere giuridico, Ipsoa, n. 5/1999, pagina 650). D’altra parte, dice l’articolo 53 della Convenzione, «nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Paese contraente o in base ad ogni altro accordo al quale tale Parte contraente partecipi». Vale conseguentemente, con valore vincolante, l’interpretazione che della Convenzione dà esclusivamente la Corte europea di Strasburgo. Non a caso il Consiglio d’Europa, nella raccomandazione R(2000)7 sulla tutela delle fonti dei giornalisti, ha scritto testualmente: «L’articolo 10 della Convenzione, così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, s’impone a tutti gli Stati contraenti». Su questa linea si muove il principio affermato il 27 febbraio 2001 dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo: “I giudici nazionali devono applicare le norme della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo secondo i principi ermeneutici espressi nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo” (in Fisco, 2001, 4684). Conclusioni. I giornalisti italiani devono rifiutarsi di rispondere ai giudici sul segreto professionale, invocando, con le leggi nazionali, la protezione dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e le sentenze Goodwin e Roemen della Corte di Strasburgo. Il Codice di procedura penale (articolo 200) deve recepire Strasburgo. Pm e Gip devono indagare soltanto su chi (pubblico ufficiale) “spiffera” la notizia e non su chi (giornalista) la riceve Belgio: sì alla nuova legge sulla tutela delle fonti (ma perplessità sulle eccezioni) Bruxelles, 31 marzo 2004. L’International Federation of Journalists ed il suo organo regionale, l’European Federation of Journalists, hanno accolto con favore i passi in avanti fatti dal Belgio per adottare una legge che protegga le fonti giornalistiche, temendo tuttavia che le eccezioni previste operino a discapito dei giornalisti. “Questo è un importante passo avanti”, ha dichiarato Aidan White, segretario generale dell’IFJ e dell’EFJ. “Certamente, il raid della polizia all’interno dell’abitazione e dell’ufficio di Bruxelles di un reporter della scorsa settimana ha dato una forte spinta all’adozione di tale legge”. L’atteggiamento della polizia contro HansMartin Tillack, reporter della rivista tedesca Stern, ha suscitato risentimento tra gli addetti stampa locali, sollevando il timore di nuove pressioni politiche sui giornalisti. Il giornalista, che si è occupato a lungo della corruzione all’interno dei circoli dell’Unione Europea, è stato oggetto di ritorsioni in seguito alla richiesta fatta alle autorità locali dall’OLAF- l’unità europea che si occupa di sanzionare gli imbrogli. I giornalisti hanno generalmente accolto con favore l’adozione unanime del disegno di legge sulla protezione delle fonti del 24 marzo, pur temendo per le eccezioni previste in caso di temi concernenti la sicurezza di stato, la famiglia reale e lo spionaggio. “Dobbiamo assicurare che il principio di protezione delle fonti venga difeso quanto più possibile” ha dichiarato White. “E mentre capiamo la necessità di eccezioni per quanto riguarda la sicurezza nazionale ed il benessere pubblico, riteniamo che le eccezioni politiche siano un’altra cosa. Tuttavia, le autorità non potranno ignorare ancora a lungo il principio di protezione delle fonti”. L’unione dei giornalisti, la Belgian Association for Professional Journalists (AGJPB/AVBB), ha invitato il Parlamento ed il Senato ad eliminare le eccezioni di tipo politico in occasione delle prossime deliberazioni. Negli ultimi anni gli attacchi alla riservatezza delle fonti hanno avuto luogo in Belgio più che in ogni altro paese dell’ovest Europeo. Non essendoci ancora disposizioni legali per la protezione delle fonti, alcuni casi sono stati portati davanti alla Corte europea per i Diritti umani di Strasburgo. 14 8 È diritto insopprimibile dei giornalisti quello di raccontare quel che accade, fatti e notizie su questioni di interesse generale. Questo principio, che è l’incipit dell’articolo 2 della legge professionale dei giornalisti italiani, è consacrato in una sentenza della Corte di Strasburgo. La libertà di scrivere è sacra e cammina di pari passo con l’osservanza della deontologia. Il rispetto del segreto professionale è una regola fondamentale perché sul rovescio garantisce il diritto dei cittadini all’informazione: “È diritto dei giornalisti quello di comunicare informazioni su questioni di interesse generale, purché ciò avvenga nel rispetto dell’etica giornalistica, che richiede che le informazioni siano espresse correttamente e sulla base di fatti precisi e fonti affidabili; costituisce, pertanto, un limite irragionevole alla libertà di stampa la condanna per ricettazione di giornalisti che, attenendosi alle norme deontologiche, abbiano pubblicato documenti di interesse generale pervenuti loro in conseguenza del reato di violazione di segreto professionale da altri commesso (nella specie, copia delle denunzie dei redditi di un importante manager francese)” (Corte europea diritti dell’Uomo, 21 gennaio 1999; Parti in causa Comm. europea dir. uomo c. Governo francese e altro; Riviste: Foro It., 2000, IV, 153). La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e le sentenze di Strasburgo rendono forte il lavoro del cronista. Le vicende Goodwin e Roemen sono episodi che assumono valore strategico. Quelle sentenze possono essere “usate”, quando i giudici nazionali mettono sotto inchiesta, sbagliando, i giornalisti, che si avvalgono del segreto professionale. I giornalisti devono rifiutarsi di rispondere ai giudici in tema di segreto professionale, invocando, con le norme nazionali (legge n. 69/1963 e dlgs n. 196/2003), la protezione dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo nonché le sentenze Goodwin e Roemen della Corte di Strasburgo. Questa linea è l’unica possibile anche per evitare, come scrive il Tribunale penale di Treviso, di finire sulla graticola dell’incriminazione per violazione del segreto d’ufficio in concorso con pubblici ufficiali (per lo più ignoti), cioè con coloro che, - magistrati, cancellieri o ufficiali di polizia giudiziaria -, hanno “spifferato” le notizie ai cronisti. In effetti l’eventuale responsabilità, collegata alla fuga di notizie, grava solo sul pubblico ufficiale che diffonde la notizia coperta da vincoli di segretezza e non sul giornalista che la riceve e che, nell’ambito dell’esercizio del diritto-dovere di cronaca, la divulga. Va affermato il principio secondo il quale il giornalista, che riceva una notizia coperta da segreto, può pubblicarla senza incorrere nel reato previsto dall’articolo 326 del Cp. È palese la differenza con il reato di corruzione, che colpisce sia il corrotto sia il corruttore. L’articolo 326, invece, punisce solo chi (pubblico ufficiale) viola il segreto e non chi (giornalista) riceve l’informazione e la fa circolare. Ferma restando, ad ogni modo, la prerogativa del giornalista di non rivelare l’identità delle proprie fonti. Il giornalista, che svela le sue fonti, rischia il procedimento disciplinare al quale non può, comunque, sfuggire per l’evidente violazione deontologica. Una lettura ragionevole dell’articolo 326 del Cp evita l’incriminazione (assurda) del giornalista per concorso nel reato (con il pubblico ufficiale..loquace) e le perquisizioni, arma ormai spuntata dopo la sentenza “Roemen” della Corte di Strasburgo.. Il Codice di procedura penale, in base alla relativa legge-delega, “deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale”. Il Parlamento in sostanza deve calare nel Codice le sentenze Goodwin e Roemen nonché l’articolo 10 della Convenzione, abolendo il potere del Gip di interrogare il giornalista. Finirà la storia dei giornalisti arrestati e condannati perché difendono il segreto professionale anche come cittadini europei? L’articolo 200 del Cpp afferma il diritto del giornalista professionista al segreto sulle sue fonti fiduciarie, ma nel contempo autorizza il giudice a interrogarlo sulle sue fonti fiduciarie. Potere, questo, che fa a pugni con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Il Parlamento deve sancire una volta per tutte la regola in base alla quale il giornalista ha diritto al segreto professionale come gli altri professionisti. Punto e basta. Non una parola in più. Strasburgo ha spiegato perché è necessaria ed urgente questa svolta. *presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e docente di Diritto del giornalismo e dell’editoria all’Università Iulm di Milano Milano, 28 febbraio 2004 Francesco Chiavarini neopresidente Gag Legnano, 21 marzo 2004. Francesco Chiavarini, 32 anni, redattore del settimanale cattolico „Luce‰, è il nuovo presidente del Gruppo Altomilanese Giornalisti „Mauro Gavinelli‰, associazione fondata nel 1993, che riunisce diversi operatori dell‚informazione che lavorano o risiedono nella zona che va da Pero a Gallarate. Chiavarini è stato nominato presidente dal Direttivo del sodalizio rinnovato per il prossimo triennio lo scorso 21 marzo. La vicepresidenza è andata al presidente uscente Mauro Tosi. Mentre Gianni Borsa è il nuovo tesoriere. Il prossimo appuntamento del Gag è l‚assegnazione della terza edizione del Premio nazionale giornalistico „Mauro Gavinelli‰, riservato ai giovani giornalisti (fino a 35 anni d‚età). La scadenza per la consegna degli articoli concorrenti è fissata al 30 aprile. ORDINE 5 2004 Inpgi: il Cda ha nominato le Commissioni consultive Inpgi - Carlo Gariboldi è il fiduciario lombardo Carlo Gariboldi è il nuovo fiduciario lombardo dell’Inpgi. Il vice è Guido Besana. La sede dell’Inpgi è in via Sandro Sandri,2 - 20121 Milano (tel. 02/29004708; fax. 02/6598903). Le nomine sono state fatte dal Consiglio d’amministrazione dell’Istituto. Presidente Vice Presidente Componenti Sindaco Assegnazione alloggi ed affitto immobili Acquisti e dismissioni immobili Appalti Marcella Ciarnelli Daniele Carlon Virgilio Povia Giovanni Negri Roberto Seghetti Paolo Saletti Marcello Ugolini Occupazione Roberto Reale Stefania Conti Previdenza Contributi e Vigilanza Prestazioni Integrative Enrico Castelli Guido Besana Silvia Garambois Luciano Azzolini Giovanni Negri Silvana Mazzocchi Mutui e Prestiti Savino Cutro Marcello Ugolini Finanza, Bilancio, Programmazione e Investimenti mobiliari Personale e Contratto Riccardo Venchiarutti Francesco Gerace Giacomo Lombardi d’Aquino, Elio Felice, Andrea Lazzeri, Giuseppe Nicotri Stefania Conti, Maurizio Bernasconi, Achille Scalabrin, Giuseppe Nicotri Giacomo Lombardi D’Aquino, Marco Volpati (esperto), Antonio De Vito, Roberto Sabatini Umberto Nardacchione, Claudio Scarinzi, Francesco Tropea, Roberto Cilenti Franco Siddi, ......(Fieg)**, ......(Fieg)**, Maurizio Bernasconi .......(Fieg)**, ......(Fieg)**, Roberto Seghetti, Mauro Masi Romano Bartoloni (esperto), Giorgio Di Nuovo, Lodovico Petrarca, Giacomo Lombardi D’Aquino Umberto Nardacchione, Lodovico Petrarca, Antonio Visentini, Domenico Marcozzi Daniela Stigliano (esperto) Marina Macelloni, Massimo Marciano, Michele Peragine Vittorio Fiorito Paolo Chiarelli Informatica Paolo De Anna Carlo Gariboldi Rapporti con il Parlamento Maurizio Andriolo e le Istituzioni Provveditorato Edmondo Rho Ezio Berard Statuto e Regolamento Edmondo Rho Gabriele Cescutti Roberto Carella Edmondo Rho, Giovanni Rossi, Roberto Carella, Domenico Marcozzi Claudio Scarinzi, Vincenzo Varagona, Alfio Di Marco, Antonio De Vito Giancarlo Zingoni, Mimmo Liguoro, Marcella Ciarnelli, Maria Grazia Molinari (esperto) Marcello Ugolini, Vincenzo Galiano, Letizia Gonzales, Vittorio Fiorito Massimo Signoretti, Mauro Masi, Claudio Schirinzi, Giancarlo Zingoni Michele Romano Guido Bossa Guido Bossa Stefania Cresti Adriano Velli Virgilio Povia Riccardo Sabbatini, Attilio Raimondi Michele Romano, Riccardo Sabbatini, Adriano Velli Attilio Raimondi Riccardo Sabbatini Stefania Cresti Michele Romano Stefania Cresti ** Lo Statuto Inpgi prevede che la composizione delle Commissioni “Previdenza” e “Contributi e Vigilanza” sia integrata dalla presenza di due rappresentanti della Fieg, ad oggi non ancora designati. Inpgi/2 e redditi autonomi 1996: come rispondere alle pretese sbagliate dell’ente Soltanto l’Inps può pretendere il 12% per i redditi autonomi del 1996, ma l’Inps ancora oggi non chiede alcunché (ai cittadini senza Albo) per le prestazioni occasionali e per le collaborazioni giornalistiche regolate dalla cessione dei diritti d’autore. L’Inpgi in sostanza dice: “Ho acquisito i dati reddituali 1996 nel 2003 e , quindi, la prescrizione decorre dal 2003”. Bisogna dire NO a questa pretesa!!!! A distanza di 9 mesi dal luglio 2003, un’altra pioggia terrificante di lettere raccomandate si abbatte sulla testa dei giornalisti. Questa volta le lettere sono firmate dalla dirigente del Servizio contributi dell’Inpgi/2. La gestione Inpgi/2 provoca stress e lo stress va risarcito: è un danno alla salute! di Franco Abruzzo presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia 1. Premessa. Il luglio 2003 rimarrà indelebile nella memoria dei giornalisti italiani, sui quali si è abbattuta una pioggia terrificante di lettere. Le lettere sono firmate dal direttore generale dell’Inpgi. In breve viene comunicato che l’Agenzia delle entrate (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha trasmesso all’Istituto i “dati reddituali” denunciati relativamente al 1996 da ogni singolo giornalista al Fisco “per attività di lavoro autonomo”. Il direttore generale scrive che “qualora la somma in questione fosse in tutto o in parte derivante da attività autonoma di natura giornalistica, su di essa sarebbero dovuti alla gestione separata dell’Inpgi i contributi del 12 per cento……Nel suo interesse, La preghiamo di indicarci l’ammontare del reddito riferito ad attività giornalistica. Ciò al fine di poter verificare l’esistenza dell’obbligo assicurativo e conseguentemente determinare l’esatto ammontare dei contributi da versare. La presente vale anche ai fini interruttivi della prescrizione”. Attimi di panico e smarrimento tra i 18mila giornalisti professionisti e i 50mila giornalisti pubblicisti, perché l’ente non spiega chi è tenuto (e chi non è tenuto) a iscriversi alla gestione separata dell’Inpgi (o Inpgi-2) e perché l’ente dimentica stranamente che “la prescrizione dei contributi dovuti all’Istituto interviene con il decorso di 5 anni” (art. 7 del Regolamento Gestione separata Inpgi). L’Inpgi avrebbe dovuto acquisire i dati reddituali nel 1997 e non nel 2003. Avendo acquisito i dati reddituali con incredibile ritardo, oggi l’Inpgi non può invocare l’articoORDINE 5 2004 lo 2935 del Codice civile, che, in tema di decorrenza della prescrizione, così testualmente dispone: "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". L’Inpgi in sostanza dice: “Ho acquisito i dati reddituali 1996 nel 2003 e , quindi, la prescrizione decorre dal 2003”. Bisogna dire NO a questa pretesa ingiusta e sbagliata!!!! A distanza di 9 mesi dal luglio 2003, un’altra pioggia terrificante di lettere raccomandate si abbatte sulla testa dei giornalisti. Questa volta le lettere sono firmate dalla dirigente del Servizio contributi dell’Inpgi/2. BASTA!!!! È vero che l’Inpgi ha cambiato amministratori, ma i metodi, però, sono gli stessi. L’Inpgi ha approvato un condono previdenziale per gli anni 1997-2001. “In quell'occasione – ha scritto Giuseppe Rodà su “Il Sole 24 Ore” del 9 agosto 2003 - il 1996 è stato considerato "chiuso". Inoltre, nella lettera inviata ai giornalisti, pubblicisti e professionisti, si parla del contributo integrativo per il 1996 del 2% e del contributo di maternità, entrambi stabiliti successivamente”. Il punto è un altro: l’Inpgi-2 è nato l’11 giugno 1997, quando la Gazzetta Ufficiale ne ha pubblicato il Regolamento. Nella circolare 10 luglio 1997 (http://www.inpgi.it/inpgi/inpgi.nsf) il presidente dell’Inpgi, Gabriele Cescutti, ha scritto: “Come vi è noto, il decreto ministeriale di ratifica dello Statuto e del Regolamento, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno scorso. Da questa data decorrono i tre mesi di tempo (scadenza 11 settembre '97) che ogni giornalista interessato alla Gestione separata ha a disposizione per provvedere all'iscrizione, utilizzando il modulo a suo tempo trasmesso a tutti gli iscritti al nostro Ordine professionale”. L’obbligo d’iscrizione all’Inpgi-2 (per i cococo) risale, quindi, all’11 giugno 1997. Il Regolamento non ha forza retroattiva. L’ente, quindi, non può bussare a quattrini per il 1996, perché il 12% del 1996 va versato soltanto all’Inps. L’Inps, però, ancora oggi continua a escludere dalla gestione separata sia chi svolge lavori occasionali sia chi cede i diritti d’autore (impostazione condivisa da Gabriele Cescutti con la circolare 16 maggio 1996). 2. Prospettive. Bisogna avviare una grande battaglia politico-giudiziaria e costringere l’Inpgi, impiegando soltanto la forza civile della legge, a rispettare la normativa generale dell’Inps come l’ordinamento impone e come hanno sancito sentenze della Corte costituzionale, della sezione lavoro della Cassazione e del Tar Lazio. Bisogna travolgere l’Inpgi con decine e decine di cause. Non possiamo subire nuove offese alla nostra dignità! Utilizziamo subito il diritto costi- tuzionale di difesa in maniera attiva e penetrante!!! L’Inpgi privatizzato non significa diritti tagliati e negati per i giornalisti! La Costituzione non consente discriminazioni e trattamenti economici diseguali. Bisogna alzare la testa e dire no. Non è soltanto disubbidienza civile. E, qualcosa di più. Giuseppe Rodà su Il Sole 24Ore del 9 agosto 2003 ha prospettato l’ipotesi che i free lance (soprattutto pubblicisti) si dimettano dall’Ordine per sfuggire alle ingiuste e illegittime tassazioni dell’Istituto. Questa è una soluzione facile, come è facile costituire, con l’aiuto di commercialisti, una società alla quale conferire le proprie attività giornalistiche. Tanti pensionati, ai quali l’Inpgi nega illecitamente la libertà di cumulo, sono costretti a nascondersi in maniera legittima dietro il paravento di una società per continuare a esercitare la professione. Questa “tecnica elusiva” farà proseliti tra i liberi professionisti, anche se tale risposta è meramente difensiva sul piano individuale. 3. Una possibile risposta alla dirigente Servizio contributi Inpgi2. Suggerisco, con gli opportuni adattamenti personali, questa risposta: “Gentile Signora, La informo che ho cestinato la mia documentazione tributaria del 1996, perché il Fisco mi obbliga a conservarla per 5 anni e che ho letto a suo tempo le circolari firmate da Gabriele Cescutti (datate 16 maggio 1996 e 10 luglio 1997) secondo le quali i giornalisti autori e occasionali non avevano l’obbligo di iscriversi all’Inpgi-2. L’obbligo di aderire all’Inpgi-2 è peraltro scattato soltanto l’11 giugno 1997. Soltanto l’Inps, quindi, può pretendere il 12% per i redditi autonomi del 1996, ma l’Inps ancora oggi non chiede alcunché (ai cittadini senza Albo) per le prestazioni occasionali e per le collaborazioni giornalistiche regolate dalla cessione dei diritti d’autore. Lei dovrebbe fare autocritica pubblica per l’errore commesso, avendo “corretto” il suo presidente con 8 anni di ritardo!!! Come può sollecitare autodenunce a chi ha seguito fedelmente e con fiducia le istruzioni del presidente dell’ente? L’Inpgi è tenuto a rispettare le regole che sono dell’Inps (punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000). L’Inpgi non è una “repubblica indipendente”. Le segnalo anche, qualora non fosse informata, che, in base al comma 2 dell’articolo 61 del Dlgs n. 276/2003 (“legge Biagi”) e al comma 2 dell’articolo 44 della legge n. 326/2003, sono occasionali le prestazioni di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente oppure retribuite con un compenso annuo complessivamente non superiore a 5mila euro. L’avverto che la sua richiesta – essendo lei persona incaricata di un pubblico servizio -potrebbe configurare ipotesi di reato (610 Cp? 323 Cp?). Mi riservo, comunque, di agire in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni collegati allo stress, che mi provocano le sue lettere raccomandate ingiuste ed errate. Lo stress è un danno alla salute”. ------------------------------------Nel sito dell’OgL (www.odg.mi.it) due studi di Franco Abruzzo sulle prestazioni occasionali (http://www.odg.mi.it/inpgi2_imbroglio.htm) e sulle prestazioni regolate dalla cessione del diritto d’autore (/www.odg.mi.it/inpgi2_circolari.htm). 15 (23) PROFESSIONE C’è una ragionevole soluzione: “Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì – dice l’articolo 47-bis del dlgs 29/1993 (oggi dlgs 165/2001), - le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva siano affiliate”. La Fnsi ha un “patto di alleanza” con Cgil, Cisl, Uil e Ugl. L’Aran potrebbe considerare i rappresentanti della Fnsi “incorporati” nella delegazione confederale. Uffici Stampa della Pa e trattative Fantoni ha ragione formalmente, ma Serventi Longhi ha dalla sua due articoli della Costituzione, che prevalgono sulle leggi, e il “patto di alleanza” con Cgil, Cisl, Uil e Ugl. La “vendetta” di Franco Bassanini ha reso problematica l’applicazione della legge n. 150/2000 Analisi di Franco Abruzzo La notizia. Fantoni (Aran) sugli Uffici stampa della Pa: “La Fnsi è esclusa dalle trattative”. Al tavolo per l’accordo quadro dei giornalisti che lavorano nelle pubbliche amministrazioni, previsto dalla legge 150 del 2000, «la Fnsi non compare tra i sindacati rappresentativi da convocare». Lo ha dichiarato Guido Fantoni, presidente dell’Aran (l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) durante un’intervista a TelePa, la web tv del ministero della Funzione Pubblica. «La trattativa è ferma - ha spiegato Fantoni per un’imperfezione della legge, che prevede che siano i contratti collettivi, stipulati previo consenso della Federazione nazionale della stampa, a regolamentare alcuni aspetti della professione». Ma questo «non è tecnicamente possibile - aggiunge il presidente dell’Aran - perché il sistema del pubblico impiego prevede che al tavolo delle trattative si siedano solo le rappresentanze sindacali del comparto e, fra queste, non figura la Fnsi». Oltretutto «i sindacati rappresentativi hanno espresso un parere formale negativo alla nostra richiesta di coinvolgere il sindacato dei giornalisti, perché questo potrebbe creare un pericoloso precedente per altre categorie, ad esempio gli avvocati e gli ingegneri». Per Fantoni vista «la difficoltà di stipulare un accordo quadro, credo che dovremo riproporre la questione con accordi di comparto». (Adnkronos) 1 La reazione di Paolo Serventi Longhi (segretario generale della Fnsi): “I giornalisti degli uffici stampa aspettano da oltre cinquant’anni l’applicazione del contratto di categoria. Le speranze suscitate dalla Legge 150, dopo quattro anni, vengono ora frustrate dalle dichiarazioni del Presidente dell’ARAN che rappresentano un attacco a tutti i giornalisti. Le motivazioni addotte appaiono speciose: Fantoni afferma che la Fnsi non è ammessa alla contrattazione nel pubblico impiego; ma non tiene conto della esclusiva rappresentatività del Sindacato dei giornalisti anche nel settore della pubblica amministrazione. È difficile comprendere perché la Legge 150 non debba essere applicata in quanto considerata in contrasto con altre norme. Non ci risulta, peraltro, che i sindacati rappresentativi abbiano espresso un parere formale negativo, anzi, almeno fino a questo momento, hanno istaurato con la Fnsi un dialogo costruttivo. Per questo chiediamo l’intervento del Ministro Mazzella, il cui Dicastero è intervenuto a favore dell’applicazione della legge in tutte le sue parti, e del Parlamento che ha approvato la 150. In assenza di immediate e positive risposte ai giornalisti italiani non resterà che ricorrere ai Tribunali amministrativi regionali ed eventualmente al Consiglio di Stato per ottenere giustizia. Nel frattempo la Fnsi mobiliterà tutte le strutture del sindacato ed i colleghi degli uffici stampa a sostegno del contratto di lavoro”. (da www.fnsi.it) 2 Fantoni (Aran) ha ragione formalmente, ma Serventi Longhi (Fnsi) ha dalla sua due articoli della Costituzione, che prevalgono sulle leggi, e il “patto di alleanza” con Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Sulle mansioni che negli uffici stampa saranno assegnate al “personale iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti” si dovrebbe svolgere la contrattazione, con la presenza della Fnsi, in sede Aran. La contrattazione collettiva punta alla “individuazione e alla regolamentazione dei profili professionali”. Assisteremo, però, a una strana contrattazione sul ruolo di “non dipendenti”, ma di collaboratori collocati in strutture (gli uffici stampa) della pubblica amministrazione. Il compenso - che dovrà essere adeguato all’“importanza dell’opera e al decoro professionale” (articolo 2233 Cc) nonché alla “provata competenza” - è per ora un capitolo aperto, che sarà riempito con il ricorso alle tariffe stabilite dall’Ordine dei Giornalisti (articoli 2225 e 2233 Cc). Va detto che, comunque, del Cnlg 2001-2005 fa parte la figura del collaboratore coordinato e continuativo. Questa novità fa da 3 16 (24) interfaccia all’articolo 7 (comma 6) del Dlgs n. 165/2001 (già Dlgs29/1993), il quale prevede incarichi individuali ad “esperti di provata competenza” (con contratto coordinato e continuativo di cui agli articoli 2222 e seguenti del Cc). Ma l’ordinamento giuridico offre, in alternativa, la possibilità di inquadrare i giornalisti con contratti a tempo indeterminato o determinato. Tale possibilità dovrà essere oggetto di contrattazione e non può essere lasciata in mano al “mercato”. Un mercato, quello delle pubbliche amministrazioni, che conosce superficialmente le peculiarità del lavoro giornalistico. L’articolo 51 (secondo comma) della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) afferma: “Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono abrogate le norme che disciplinano il procedimento di contrattazione collettiva in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni”. In sostanza, secondo l’articolo 47-bis del dlgs 29/1993 (oggi Dlgs 165/2001), “l’Aran ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito considerato. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate”. Per ora nelle pubbliche amministrazioni non esiste il comparto degli Uffici stampa e degli Urp e che, ove esistesse, la Fnsi difficilmente potrebbe raggiungere la percentuale del 5 per cento, considerando che in questo nuovo comparto non opererebbero soltanto giornalisti. L’Aran, che rappresenta il Governo come datore di lavoro, ha deciso di non convocare la Fnsi per discutere l’applicazione del contratto ai giornalisti impiegati negli Uffici stampa, ignorando che la Fnsi stessa è unita da un “patto di alleanza” con Cgil, Cisl, Uil e Ugl (articolo 16/l dello Statuto della Fnsi). Rappresentanti delle quattro Confederazioni sono presenti di diritto nel Consiglio nazionale della Fnsi. Va detto anche che l’articolo 51 fa salve “le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”. L’articolo 39 detta “disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time”. Il Consiglio dei ministri, - anche se la legge 449/1997 impegna il Governo alla riduzione progressiva del numero dei dipendenti pubblici -, può sempre deliberare nuove assunzioni (tramite concorsi pubblici) negli apparati pubblici “dopo una istruttoria diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l’impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all’adozione di misure di razionalizzazione interna” e quando vengono creati “nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all’utenza”. Dal punto di vista formale, Guido Fantoni (presidente dell’Aran) ha ragione, ma anche Serventi Longhi ha ragione, invece, sotto il profilo dell’esame sistematico dell’ordinamento giuridico della professione giornalistica. Procediamo con un esempio illuminante. Le aziende editoriali (che fanno riferimento ai sub-contratti Frt, Uspi e grafico editoriale) dal primo gennaio 1996 sono, comunque, tenute a versare i contributi sui minimi previsti dal contratto Fnsi-Fieg in base al comma 25 dell’articolo 2 della legge n. 549/1995 (che è la legge finanziaria per il 1996). Dice il comma 25: “In caso di pluralità di contratti di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi nella categoria”. Per quanto riguarda la categoria dei giornalisti, il contratto più rappresentativo è quello Fnsi-Fieg. C’è da precisare che le aziende, comunque, sono tenute per legge ad assicurare esclusivamente con l’Inpgi i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, che lavorano a tempo pieno. La morale alla Fedro di questo esempio si può riassumere così: niente da dire sulla libertà costituzionale delle imprese di non iscriversi alla Fieg (e di non applicarne il contratto stipulato con la Fnsi), ma la casa previdenziale dei giornalisti è, comunque, l’Inpgi. Lo stesso ragionamento deve guidare chi è chiamato a sbrogliare la matassa Aran-Fnsi. I lavoratori hanno pari dignità sociale (art. 3 Cost.) e hanno libertà di associazione (art. 18 Cost.). È evidente che l’articolo 51 della legge 388/2000, limitando la capacità contrattuale ai sindacati presenti nelle pubbliche amministrazioni che toccano la soglia del 5 per cento, viola i principi della pari dignità sociale e della libertà di associazione. In sostanza Paolo Serventi Longhi deve prepararsi ad impugnare davanti ai giudici del lavoro il veto dell’Aran, che nega la capacità contrattuale della Fnsi. Ai giudici i legali della Fnsi dovranno chiedere di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’articolo 51. L’altra via è una norma interpretativa approvata dal Parlamento, ma questa seconda via appare difficile (il Parlamento è ingolfato). Anche su tale punto c’è una morale alla Fedro che si può riassumere così: niente da dire sulla libertà costituzionale dei giornalisti di aderire alla Fnsi e di farsi rappresentare soltanto dalla Fnsi. L’Aran, però, non può non prenderne atto e chiamare la Fnsi alle trattative. Altrimenti l’Aran si porrebbe in conflitto con gli articoli 3 e 18 della Costituzione. C’è infine un’altra ragionevole soluzione: “Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì – dice l’articolo 47-bis del dlgs 29/1993 (oggi dlgs 165/2001), - le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate”. La Fnsi ha un “patto di alleanza, come riferito, con Cgil, Cisl, Uil e Ugl. L’Aran potrebbe considerare i rappresentanti della Fnsi “incorporati” nella delegazione confederale. La “vendetta” di Franco Bassanini ha reso problematica l’applicazione della legge n. 150/2000. Le difficoltà per la Fnsi sono state costruite tutte dall’ex ministro alla Funzione pubblica Franco Bassanini (e dall’ex sottosegretario al Tesoro Piero Giarda). Bassanini e Giarda hanno subito il varo della legge 150/2000 e di quell’articolo 9, che prevede la presenza di giornalisti negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni. La loro vendetta è il comma 2 dell’articolo 51 della legge n. 388/2000, che esclude formalmente la Fnsi dalle trattative, perché priva di rappresentanza nel comparto. Quel comma è stato infilato di soppiatto nella legge e nessuno ne ha compreso le ripercussioni. Bassanini non era solo: era in compagnia di Giuseppe Tesauro (Antitrust), Mario Pirani (Repubblica) e Ferpi (Federazione relazioni pubbliche italiane). La storia successiva al varo della legge 388/2000 va ricostruita così. L’emanazione del regolamento (7 febbraio 2001) è stata preceduta da una vivace polemica all’interno del Governo Amato tra il ministro Franco Bassanini e il sottosegretario Raffaele Cananzi (mentre Mario Pirani “sparava” bordate di piombo dalle colonne di “Repubblica” contro la legge 150). Nel regolamento, si prevede che le attività di informazione (uffici stampa) saranno riservate ai giornalisti professionisti e pubblicisti, mentre quelle di comunicazione (Urp) ai laureati in Relazioni pubbliche e Scienze della comunicazione. Cananzi ha difeso lo spirito della legge 150 e soprattutto l’articolo 9, che disciplina l’accesso esclusivo dei giornalisti negli uffici stampa. Cananzi nel dicembre 2000 aveva contestato in particolare la decisione, ispirata da Bassanini, di far presentare, tramite il sottosegretario al Tesoro Giarda, un emendamento all’articolo 51 della Finanziaria, che, una volta approvato, avrebbe snaturato completamente la legge 150. Quell’emendamento avrebbe sostituito i giornalisti con i laureati in relazioni pubbliche. Quell’emendamento, però, è stato dichiarato “inammissibile per materia” dall’allora presidente del Senato, Nicola Mancino. Poche ore dopo Giarda ha presentato il testo dell’emendamento n. 2 dell’articolo 51, che, invece, è passato. Il 26 luglio 2001, MF e Ansa riferiscono che Giuseppe Tesauro, presidente dell’Antitrust, con una segnalazione ai 4 ORDINE 5 2004 Roma, 26 marzo 2004. Se un giornalista già condannato per diffamazione torna a commettere lo stesso reato nei successivi cinque anni dovrà essere interdetto dall’esercizio della professione per un periodo che va da uno a sei mesi. È quanto prevede un emendamento presentato dalla relatrice Isabella Bertolini (FI) al provvedimento sulla diffamazione ora all’e- Fnsi/Aran presidenti del Senato e della Camera nonché al presidente del Consiglio e al ministro della Funzione pubblica, si è scagliato contro la presenza obbligatoria di giornalisti negli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche prevista dalla legge n. 150/2000. Si sa che il Consiglio dei Ministri il 2 agosto successivo (il ministro della partita frattanto è Frattini, padre della legge 150 con Di Bisceglie) dovrà recepire in un Dpr il regolamento della legge 150, dopo il disco verde dato il 21 maggio dal Consiglio di Stato (“Lo schema di regolamento, in linea con le previsioni e le finalità fissate dalla richiamata norma primaria, prevede in dettaglio i requisiti di professionalità specifica che devono possedere i dipendenti addetti ai servizi di informazione e comunicazione. Il provvedimento e suddiviso in due previsioni, quella futura, e quella temporale-transitoria relativa alla situazione attuale. Sul contenuto del provvedimento, che appare conforme agli scopi previsti dalla normativa, la Sezione esprime parere favorevole”). Il siluro è tempestivo. Tesauro - che è sulla linea della Ferpi, di Bassanini e Giarda - vuole allargare l’offerta, come scrive, ai laureati in relazioni pubbliche e in scienze della comunicazione. In particolare l’Antitrust ritiene che alcune disposizioni della legge 150 “producano ingiustificate restrizioni della concorrenza e del libero mercato subordinando il reclutamento del personale degli uffici stampa all’iscrizione nell’Albo dei giornalisti”. L’Ordine dei Giornalisti della Lombardia ribatte subito, osservando preliminarmente che “i laureati in relazioni pubbliche e in scienze della comunicazione non sono vincolati per legge al rispetto di una deontologia professionale” e ricordando che “questa manovra, portata avanti dall’ex ministro Franco Bassanini, è già fallita in Parlamento in sede di approvazione della Finanziaria 2001”. Nel comunicato dell’Ordine di Milano si legge ancora: “Strano destino quello del professor Tesauro, che nel giro di 4 anni ha perso tutte le battaglie ingaggiate contro gli Ordini professionali italiani e contro i professionisti italiani. È stato abbandonato al suo destino dal Governo Amato, che nel settembre-novembre 2000 ha presentato un progetto di riforma degli Ordini, che prevede l’esistenza di tutti gli Ordini in essere, mentre con la direttiva sul commercio elettronico (approvata il 4 maggio 2000 dal Consiglio europeo), la Ue ha dato una serie di regole che riguardano le libere professioni e ha chiamato gli Ordini italiani a vigilare su Internet. Il nuovo Governo, per bocca del ministro Maurizio Gasparri, ha già comunicato che non ha alcuna intenzione di sopprimere gli Ordini e in particolare quello dei giornalisti”. “Colpisce - afferma ancora l’Ordine - che a un giurista del valore di Giuseppe Tesauro sfuggano le ragioni in base alle quali il Parlamento ha deciso di affidare, con una legge, gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni ai giornalisti iscritti nell’Albo. I giornalisti hanno una deontologia fissata per legge e hanno il dovere di comunicare con correttezza. Le pubbliche amministrazioni, contrariamente a quello che pensa Tesauro, hanno l’obbligo di comunicare ai cittadini, principio costituzionale trasfuso nella legge 241/1990, nel dlgs n. 29/1993 (oggi n. 165/2001) e nella legge 150/2000. Soltanto i giornalisti, secondo il Parlamento, possono garantire una informazione tempestiva, corretta e di qualità sui “fatti” che riguardano le pubbliche amministrazioni”. Il 2 agosto successivo il Consiglio dei ministri trasforma il Regolamento in Dpr (che poi sarà identificato con il n. 422/2001). La proposta è illustrata dal ministro della Funzione pubblica, Frattini. Il Governo boccia le argomentazioni dell’Antitrust e per Tesauro la sconfitta, come gli era stato vaticinato, è molto amara. Il professore napoletano si rende conto che le sue prediche sono davvero inutili e che nessuno lo ascolta, perché la legge 150 non viola il principio della concorrenza. E alla fine anche la Ferpi lo abbandona, dicendosi “molto soddisfatta dell’approvazione del regolamento di attuazione della legge 150 e soprattutto della possibilità di partecipare con le sue strutture ai percorsi formativi previsti dalla stessa legge” (fonte: puntocom, 8 agosto 2001), In sostanza la Ferpi rinuncia al ricorso in sede comunitaria. I giornalisti hanno vinto anche questa battaglia. Ora, però, bisogna vincere la guerra, conquistando il contratto per gli addetti agli Uffici stampa della Pubblica amministrazione. Franco Abruzzo ORDINE 5 2004 same della commissione Giustizia della Camera. Il giornalista non è punibile, si legge in un altro emendamento della relatrice Isabella Bertolini (FI), se entro due giorni, da quando l’ha ricevuta, pubblica la rettifica o la dichiarazione dell’offeso. Il termine per la presentazione degli emendamenti al testo sulla diffamazione scade lunedì prossimo alle 18. (Ansa) Diffamazione: FI, interdizione per giornalisti se recidivi Serventi Longhi: “Meglio evitare sanzione sospensione” Il segretario della Fnsi Paolo Serventi Longhi interviene sugli emendamenti alla proposta di legge sulla diffamazione affermando che “sarebbe meglio che fosse evitata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione giornalistica, e che comunque, questa fosse comminata dall’Ordine dei giornalisti e non dal magistrato”. Gli emendamenti, presentati oggi in commissione dalla relatrice Isabella Bertolini, “mi sembra - sostiene Serventi Longhi - che non stravolgano negativamente il precedente testo, frutto del lavoro di deputati di maggioranza e dell’opposizione sul quale il sindacato dei giornalisti aveva manifestato una valutazione favorevole”. Ma sulla sospensione dalla professione in caso di reiterazione del reato, il segretario Fnsi invita i parlamentari a valutare questo ALLEGATO 1 Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione (C. 26 Stefani, C. 385 Volontè, C. 1177 Anedda, C. 1243 Pisapia, C. 2084 Pecorella, C. 588 Cola, C. 539 Siniscalchi, C. 3021 Giulietti e C. 2764 Pisapia). aspetto “con attenzione nel rispetto del principio dell’autogoverno deontologico della professione”. Al di là del contenuto degli emendamenti, “in ogni caso - sostiene Serventi Longhi - il problema principale mi sembra sia quello dei reiterati tentativi di alcuni settori del Parlamento di far saltare il disegno di legge o di ritardarne l’approvazione”. Questa situazione, aggiunge il segretario Fnsi, “nell’attuale gravissima situazione di decine di giornalisti incriminati per il reato di diffamazione e sotto la spada di Damocle di pesanti sanzioni risarcitorie sia in sede penale sia in quella civile”. Insomma, conclude il segretario Fnsi, “é indispensabile che sia subito approvato un testo compatibile con l’autonomia dei giornalisti e la libertà dell’informazione”. (ANSA) a verità, il giudice tiene conto della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l’entità del danno non patrimoniale non può eccedere la somma di euro 25.000. 6-ter. Nei casi previsti dalla presente legge, l’azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla pubblicazione». TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE AGGIORNATO AL 28 MARZO 2004 ART. 1. (Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47). 1. Dopo il primo comma dell’articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto il seguente: «2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti internet aventi natura editoriale». 2. Dopo l’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente: «Art. 8-bis - (Risposte e rettifiche nel caso di stampa non periodica o altro mezzo di diffusione) - 1. Nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 595 del codice penale, l’autore della pubblicazione ovvero i soggetti di cui all’articolo 57 bis del codice penale, sono tenuti a richiedere la pubblicazione, a proprie spese, su almeno due quotidiani a tiratura nazionale, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità. La richiesta di pubblicazione di cui al comma precedente è inviata entro tre giorni dal ricevimento della dichiarazione o della rettifica. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al commi 1, 4 e 5 dell’articolo 8. Nei casi previsti dall’articolo 595, comma terzo, del codice penale, si applica la pena della multa non superiore a euro 375 se è adempiuta la richiesta di pubblicazione di cui al primo comma». 3. L’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente: «Art. 13 - (Pene per la diffamazione) - 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 2.000 a euro 7.500. 2. Alla condanna consegue la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nell’ipotesi di cui all’articolo 99, comma 2, del codice penale. 3. L’autore dell’offesa non è punibile se adempie, ai sensi dell’articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche, entro due giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’interessato. 4. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale. 5. Il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari». 4. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono inseriti i seguenti: «6-bis. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblica azione ritenuta lesiva della reputazione o contraria 5. L’articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato. ART. 2. (Modifiche agli articoli 57, 594, 595, 596 e 597 del codice penale). 1. L’articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 57 - (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva e altri mezzi di diffusione) - 1. Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, rispondono dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo». 2. L’articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 594 - (Ingiuria). Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 650. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della multa fino a euro 950 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone». 3. L’articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 595 - (Diffamazione). Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 1.500. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato si applica la pena della multa fino a euro 2.500. Se l’offesa è arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 500 a euro 2.500. L’autore dell’offesa non è punibile se, entro due giorni dalla richiesta dell’interessato, pubblica con identica evidenza tipografica e con la stessa diffusione una completa rettifica del giudizio o del contenuto offensivo. Alla condanna consegue la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nell’ipotesi di cui all’articolo 99, comma 2, del codice penale. Se l’offesa è arrecata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate sino al triplo». 17 (25) NEL DOPOGUERRA INTRODUSSE IN ITALIA IL GIORNALISMO MODERNO M E M O R I A Nel 1945 abbandonò la professione di medico per diventare giornalista. Missiroli ne apprezzava l’intelligenza ma ne temeva gli articoli impegnati e caustici. Nel 1956 fondò il Giorno, un foglio rinnovatore nei testi e nella grafica che minacciò il primato di via Solferino. Temerario e risoluto, attaccò il presidente della Fiat Vittorio Valletta e il capo del Governo Antonio Segni che chiese e ottenne da Enrico Mattei il suo licenziamento. Arrestato per lo scandalo del Banco di Sicilia, fu assolto dopo un processo durato tre anni quando la sua salute era ormai compromessa da un male crudele. Morì nel 1971, a sessant’anni. Gaetano Baldacci di Enzo Magrì Il 3 marzo 1944, giorno in cui i sindacati clandestini stavano realizzando il primo sciopero generale a Milano, due Gaetani si incontrarono ai Giardini Pubblici di via Palestro. Uno era Gaetano Afeltra, ventinovenne, amalfitano, redattorecapo del “Corriere della Sera”; l’altro Gaetano Baldacci, un trentatreenne medico di origine messinese. Il regime di Salò stava per entrare in agonia. Afeltra e Mario Borsa (un autorevole giornalista antifascista, uscito dal “Corriere” nel ‘25 insieme con Luigi Albertini, poi corrispondente dall’Italia del “Times” di Londra), si stavano adoperando clandestinamente per preparare il giornale che sarebbe uscito subito dopo la Liberazione. Come aveva fatto nei precedenti incontri, anche in quell’appuntamento il Gaetano più vecchio non aveva mancato di caldeggiare la sua candidatura a redattore del nuovo Corriere della Sera. Diversamente dalle altre volte, quando la sollecitazione di Baldacci aveva riscosso in Afeltra solo vaghi e indecifrabili sorrisi, questa volta il giovane amalfitano raccolse la provocazione. Chiese: “ma tu, cosa verresti a fare di preciso al Corriere: il collaboratore oppure il redattore vero e proprio?” Risoluto, l’altro replicò: “vorrei fare qualcosa che sta a cavallo tra don Luigi Sturzo e Giuseppe A. Borghese”. “Hai detto niente” pensò tra sé e sé il campano. Tuttavia questi, apprezzando le qualità giornalistiche del medico, qualche giorno più tardi riferì a Mario Borsa i desiderata dell’amico. “Sai che Baldacci aspira a venire al Corriere?. “Oh Dio, ma se l’è un duttur!” rispose l’altro, incredulo. Un giovane medico appassionato di editoria Assistente del professor Cesa Bianchi, all’istituto di Fisiologia e d’Igiene della regia università di Milano, il giovane medico nutriva un’indomabile passione per la carta stampata. Il suo interesse per l’editoria era cosi forte che in quell’anno 1944 aveva addirittura fondato una casa editrice, la Gentile (dal cognome della madre) che insieme a diverse pubblicazioni stampava la rivista politica clandestina “Lo Stato Moderno”. Sull’opuscolo, vicino alle posizioni del partito d’Azione, scrivevano e dibattevano sul futuro dell’Italia il suo direttore Mario Paggi, Mario Borsa, Vittorio Arbasini Scrosati, Enrico Bonomi, Giuliano Pischel, Sergio Solmi, Cesare Spellanzon ed altri intellettuali appartenenti a diverse formazioni politiche. Il sanitario, che più volte aveva rischiato di essere arrestato dai nazifascisti, si firmava, senza troppa fantasia, con lo pseudonimo di Sicanus. Anche se era un’apprezzata pubblicazione politico-letteraria, “Lo Stato Moderno” non soddisfaceva sicuramente le ambizioni del siciliano il cui desiderio era quello di buttare il camice bianco e di entrare stabilmente in una redazione. Con il giornalismo attivo aveva convissuto sin dalla nascita. Era figlio di Giulio Baldacci, un bolognese, redattore del “Giornale d’Italia”, che, inviato a Messina nel 1908 per stendere una serie di articoli sul terremoto, in mezzo ai lutti e alla storica devastazione aveva trovato l’anima gemella 18 (26) L’uomo del Giorno nella signorina Franca Gentile che nel 1911 gli aveva dato un figlio: proprio lui, Gaetano. Sottraendosi all’idolatria che i suoi familiari, come molte famiglie borghesi siciliane professavano per la carriera d’avvocato, il giovanotto, appena diciassettenne, fonda “I Siciliani”, una rivista letteraria uscita alla fine degli anni Venti. Il giornale incappa più volte nella censura fascista tanto che è soppresso dalla prefettura messinese. Gaetano s’iscrive alla facoltà di Scienze Politiche, alla Sapienza. Ma anche a Roma i suoi rapporti con il fascio sono conflittuali. Dapprima fischia un discorso del segretario del PNF Augusto Turati. Quindi è fermato quale responsabile dell’organizzazione d’una manifestazione studentesca antifascista all’interno dell’ateneo. Un po’ per la repulsa verso il metodo con cui venivano insegnate le dottrine politiche e un po’ per via del fermo che lo aveva bollato quale eversore, il giovanotto abbandona Scienze Politiche e s’iscrive a Medicina, a Messina. Confida a un amico: “Mi piacerebbe fare il giornalista, ma se il regime diventa ancora più stupido, voglio avere la possibilità di campare con un altro mestiere”. A dimostrazione della serietà che contraddistinque il suo impegno scolastico, il giovanotto si laurea nel 1935 con 110 e la lode. Sul tram numero 33 nasce il grande amore Per eccellere durante il fascismo, i giovani, anche molti di coloro che contestavano il regime, avevano poche opportunità: una di queste era l’utilizzo delle occasioni che la dittatura metteva a loro disposizione organizzando competizioni culturali, artistiche e sportive a livello universitario e nazionale. Queste destre congiunture erano rappresentate dai Littoriali, certami aperti ai giovani iscritti ai Guf, gruppi universitari fascisti, che avevano lo scopo di formare all’ideologia i frequentatori degli atenei italiani. Nell’anno della laurea, il giovane Gaetano risulta vincitore dei Prelittoriali con Giuliano Vassalli, Luigi Preti, Paolo Emilio Taviani, Alberto Lattuada e Michelangelo Antonioni. L’anno successivo, forse per spirito d’avventura (almeno così credo), non certo per sentimenti guerreschi o colonialisti (che mal si concilierebbero con le posizioni politiche del nostro prima e dopo quell’evento), presenta domanda d’arruolamento volontario per partecipare alla campagna d’Abissinia. Probabilmente a causa dei trascorsi antifascisti, la sua richiesta non è accolta. A quel punto non gli resta che impegnarsi nella professione medica se vuole fare carriera. Nel 1940 si trasferisce a Milano dove trova sia un posto di medico, come assistente all’università, sotto la direzione del professor Cesa Bianchi, sia l’amore. Incontrata sul tram numero 33 una giovane e bella ragazza, Luisa Angeloni, figlia d’un piccolo industriale meneghino, la “tampina” con tale amabile e originale insistenza che la ragazza è costretta a cedere. Alla giovane sposa, durante la luna di miele che la coppia trascorre a Taormina nell’ottobre del 1941, non può fare a meno di confidare davanti al verde Ionio che egli non ha alcuna intenzione di occuparsi di Medicina per tutta la vita. “Voglio fare il giornalista” confida. Dettaglia: “Voglio fare un giornale tutto mio”. La liberazione di Milano, gli consente di realizzare la prima delle due aspirazioni. Memore del desiderio dell’amico medico, il 25 aprile del 1945, Afeltra, appena mette piede in redazione telefona, al duttur.” “Gaetano, vieni subito. Questa notte si fa il primo Corriere della Liberazione”. Dieci minuti più tardi, Baldacci giunge in via Solferino inforcando una bicicletta. La prima cosa che esterna ad Afeltra è il suo radicato proposito: “Da questo momento sono solo un giornalista”. A dimostrazione che fa sul serio, s’iscrive subito nell’albo dei direttori redigendo un pezzo che ha il taglio di un articolo di fondo. Il titolo è: Il calvario; e cioè, la Resistenza. Alto, fisico snello, baffi neri, inflessione sicula e trascinante irruenza, l’ex medico è il propugnatore d’un giornalismo militante in contrapposizione a quello burocratico e passivo che la società italiana del dopoguerra ha ereditato dalla censura fascista. La sua scrittura è asciutta. L’ essenzialità del suo stile non è condivisa dall’amico e contraddittore Leo Longanesi secondo il quale da un pezzo di Baldacci, zeppo di notizie e di informazione, se ne possono ricavare almeno tre. “Sei troppo sintetico” gli rimprovera il direttore del “Borghese”. L’irruenza dialettica del siculo è sostenuta da impegnate letture ma è resa vulnerabile da indeterminatezze esistenziali e politiche. Non per niente, sempre Longanesi, che lo frequenta al Covino, una piccola birreria di via Verdi, ritrovo di letterati e giornalisti negli anni Cinquanta (dove a volte irrompe anche il ventiseienne Giovanni Spadolini in missione a Milano da Firenze con cappello e bastone, “vestito da vecchio”), gli dedica un epitaffio: “Qui non giace Gaetano Baldacci, uscito da questa marmorea dimora alla ricerca di se stesso”. Il giovane messinese attraversa la direzione di Mario Borsa e quella di Enrico Emanuel cavalcando una pervicace vocazione alla polemica che non risparmia neanche gli stessi collaboratori del giornale. Il 4 aprile 1948, se la prende con lo scrittore Corrado Alvaro il quale, aderendo al Fronte Popolare e all’Alleanza della Cultura, ha rilasciato dichiarazioni che secondo il siculo “suonavano offesa ai quotidiani indipendenti italiani come il Corriere”. Per protesta, l’autore di Gente in Aspromonte si dimette e lascia la testata. Ma le pene peggiori, l’ex medico le fa patire a Mario Missiroli. Inviato speciale in un’Italia e in un’Europa che soffrono ancora per le ferite della guerra, Baldacci non manca di esprimere giudizi critici verso governi e governanti. Le sue continue provocazioni scuotono la voglia di placidità dell’autore de La monarchia socialista, la cui maggiore aspirazione è quella di dare ragione a tutti nello stesso articolo: governanti e oppositori; datori di lavoro e lavoratori, politici di destra e uomini di sinistra. Impresa che pare gli sia riuscita una volta, tanto che se n’era vantato lasciando lo studio del giornale. Baldacci gli piaceva ma i suoi articoli coraggiosi e irriguardosi verso gli establishment lo allarmavano tanto che spesso li temperava cassando giudizi perentori e affermazioni categoriche. Una sera, afflitto per l’ennesima presa di posizione di quel baffuto Rodomonte, ne invitò a cena la giovane sposa. Sperando di ORDINE 5 2004 1. Giuseppe Valieri 2. Gianni Cossu 3. Francesco Francavilla 4. Franco Nasi 5. Tommaso Besozzi 6. Luigi Arduino Gobbato 7. Bruno Giordano Bazzocchi 8. Fausto Carulli 9. Achille Campanile 10. Giorgio Zampa 11. Roberto de Monticelli 12. Angelo Rozzoni 13. tipografo Giancarlo Figini 14. tipografo Piero Gennizzi 15. tipografo Carlo Pozzi 16. Romeo Giovannini 17. proto Augusto Ghisalberti 18. proto Umberto Raimondi 19. Giorgio Susini 20. Gaetano Baldacci 21. tipografo Mauro Caselli trovare in Luisa Angeloni una complice nella difficile opera di mitigazione dell’impetuosità che il suo inviato manifestava nei pezzi, si dolse: “Ma perché quando Gaetano è via mi fa soltanto articoli di politica polemici?” Baldacci, quella volta, si trovava in Germania. Il direttore del “Corriere”, sperando in un intervento in suo favore della indulgente ospite presso il marito, le chiese ancora. “Adesso per esempio Gaetano si trova a Weimar. Perché, mi chiedo, non mi scrive un articolo dalla casa di Goethe?” “Caro amico, il Corriere non fa più per te” Il siciliano si mostrava sordo ai consigli di ponderatezza che gli rivolgeva costantemente il suo direttore. Sostenuto da uno spirito competitivo, odiava il giornalismo didascalico da Baedeker anche se vi ricorse una sola volta durante un soggiorno in Grecia. Tuttavia per non tradire se stesso, scrisse un pezzo critico contro il Partenone. Per un’estremista dell’equilibro qual era Missiroli, quella dovette rappresentare un’impertinenza che colmava la misura della sua pazienza. Un giorno convocò il suo inviato e gli parlò senza infingimenti: “Caro amico, il Corriere non fa per te. Hai bisogno d’un giornale tuo”. Per spingerlo a seguire la vocazione che riteneva di avere individuato nel suo incoercibile inviato e per sollecitarne il congedo, gli vaticinò: “Sono sicuro che come direttore d’un giornale tuo faresti grandi cose”. L’esortazione di Mario Missiroli corrispondeva alla vecchia aspirazione dell’ex medico d’inventare un foglio suo. A Milano, dal 1930, anno in cui aveva chiuso i battenti Il Secolo (dapprima leader della carta stampata in Lombardia, poi damigella d’onore del Corriere di Luigi Albertini), parecchi editori pubblici e privati avevano tentato di misurarsi con la testata di via Solferino senza successo. Anche alla fine della guerra, a dispetto dall’apparente incompatibilità che si sarebbe potuta scorgere tra il “Corsera”, che aveva sostenuto il regime, e l’impegno politico progressista dell’elettorato milanese, il vecchio logo (con e senza l’aggettivo nuovo) aveva riacquistato i suoi antichi lettori e pure parte dei loro discendenti attestandosi ancora al primo posto nelle vendite. L’ultimo tentativo di contrastarne il primato in edicola era stato realizzato dal Corriere di Milano dell’editore Aldo Palazzi, direttore Filippo Sacchi, due trasfughi del “Corriere”. Nonostante gli adeguati finanziamenti, l’iniziativa s’era rivelata deludente. Nel 1953, mentre è ancora inviato del “Corriere”, Baldacci in cerca di un editore incontra Enrico Mattei. Anche il neopresidente dell’Eni ambisce ad avere un giornale suo. I due si piacciono; l’ex partigiano s’entusiasma al progetto del messinese ma a questi non garba di fare “il giornale di Mattei”. L’incontro si conclude senza esito. La situazione si sblocca dopo una serie di contatti del giornalista con l’editore francese di origine italiana, Cino Del Duca. Dagli incontri che seguono viene fuori una combinazione a tre: Baldacci mette la testata (e la testa), metà delle spese sono assunte da Del Duca, l’altra da Enrico Mattei, sotto forma di elargizioni pubblicitarie. ORDINE 5 2004 22. proto Mario Stucchi 23. un tipografo 24. Gianni Brera 25. Rino Felappi 26. Mario Fossati 27. Beniamino dal Fabbro 28. Pietro Bianchi 29. Paolo Murialdi 30. Roberto Tabozzi 31. Giovanni Filippini 32. Ubaldo Bertoli 33. Gian Mario Maletto 34. Gianni Roghi 35. Giuseppe Grazzini 36. Giorgio Pecorini 37. Enrico Rizzini 38. Umberto Segre 39. Antonio De Falco 40. Alfredo Bogardo 41. Marco Montaldi 42. Pilade del Buono 43. Enrico Forni 44. Giancarlo Galli 45. Gaetano Gadda 46. Gigi Melega 47. Enzo Peru 48. Gian Carlo Fusco 49. Ulisse Corno 50. Antonio Pitta 51. Pietro Tarantino 52. un tipografo 53. Paolo Calzini 54. Erika Kaufmann 55. Pier Paolo De Monticelli 56. Mario Bandini 57. Michele Ranchetti 58. Vittorio Orilia 59. Patrizio Fusar Imperatore 60. Gabriele Benzan 61. Un tipografo 62..Tipografo Rodolfo Strada 63. Tipografo Bonvini Un’idea temeraria al limite dell’utopia Concordi nel voler fare un giornale nuovo, i tre sono divisi dalle motivazioni che spingono ciascuno di loro verso la realizzazione del progetto. Il presidente dell’Eni intende utilizzare il foglio come uno strumento per rompere un certo ordine economico che si è instaurato in Italia dopo la Liberazione. L’editore italo-francese, aspira a promuovere una testata a carattere popolare che attraverso le vendite raggiunga al più presto l’autonomia finanziaria. L’idea di Baldacci è temeraria, al limite dell’utopia: pensa di fare un giornale “che non s’inchini davanti al potere politico ma che con le sue inchieste e le sue denunce sia un continuo stimolo per il miglioramento della società italiana”. Del foglio che vuole stampare ha registrato da qualche anno il logo, Il Giorno. È la stessa testata usata da Matilde Serao nel 1904 a Napoli dopo che, separatasi dal marito Edoardo Scarfoglio, aveva lasciato Il Mattino. Chiuso dal fascismo nel 1927, il quotidiano era rinato nel 1944, sempre nel capoluogo campano, con una linea politica monarchico qualunquista ma era sparito dal panorama giornalistico italiano nel 1946. Trovato l’accordo agli inizi del 1956, Il Giorno è preparato in tre mesi. Se la ricerca dei finanziatori s’era rivelata abbastanza faticosa la individuazione della formula giornalistica era apparsa agevole perché questa era chiara nella mente del siculo che pensava a quel giornale da anni. Anche l’impaginazione del nuovo foglio era ben distinta nella sua testa tanto che ad un certo punto licenzia il grafico Giuseppe Trevisani il quale non applica alla lettera i suoi suggerimenti. Per la reda- zione, il messinese raccoglie transfughi dei giornali cittadini gran parte dei quali sono giovani. Con evidente sufficienza e mal dissimulata derisione, un giornale scrive: “Vi sono riuniti un certo numero di disoccupati; altri redattori sono stati presi dai quotidiani del pomeriggio e altri ancora dai rotocalchi. Non vi sono firme di spicco”. Non per necessità ma per disegno, quella era la redazione ideale di Baldacci che evidentemente non voleva maestri del vecchio giornalismo. Quando il 21 aprile 1956 escono le edizioni del Giorno del mattino e quella della sera sono in parecchi coloro che nel mondo della carta stampata profetizzano: “Gli dò tre mesi di tempo. Poi chiuderà.” Ma a dispetto delle molte, biliose, Cassandre, la testata di via Settala ottiene un successo formidabile anche se non riuscirà mai a superare per vendite il “Corriere della Sera”. Al lettore italiano della seconda metà degli anni Cinquanta il nuovo quotidiano si presenta con connotazini giornalistiche nuove, moderne, originali per il mercato della Penisola. Per la prima volta un giornale è settimanalizzato attraverso inserti che investono il mondo della cultura e quelli dei motori e dei ragazzi. Le notizie economiche sono raggruppate in un’unica pagina, soluzione che s’era però vista nell’“Ambrosiano”, un giornale fascista degli anni Venti, diretto da Umberto Notari. Scompare la terza pagina che Alberto Bergamini aveva inventato sul Giornale d’Italia nel 1901 all’indomani della presentazione della Francesca da Rimini di D’Annunzio, a Roma. Umorale e imprevedibile, Baldacci è scrupoloso nel realizzare il giornale che ha in testa. Ama la scrittura asciutta e odia il dannunzianesimo negli articoli. In redazione recita il ruolo del giornalista padrone. Se un pezzo scritto da un collaboratore oppure da un redattore non gli piace si mette alla macchina per scrivere e lo rifà. Gli ripugnano (sul giornale) la parola mamma e le similitudini che hanno un vago sapore letterario. Una sera il critico Roberto De Monticelli, che peraltro era suo amico, scrisse che le parole d’una commedia sembravano pesci vivi. Le urla del siculo arrabbiato si sentirono fino in tipografia. Incline alla collera per un pezzo che non funzionava, era pronto ad entusiasmarsi quando scopriva dei talenti fra i suoi giovani redattori. Amante delle macchine di grossa cilindrata, spesso, “chiuso” il giornale alle 4 del mattino, ingaggiava per le strade deserte di Milano una competizione con qualcuno dei suoi redattori che, per non dargli un dispiacere (le cui conseguenze avrebbero potuto interferire con la carriera), prudentemente si rassegnava a perdere. Altre volte (insieme con Giancarlo Fusco, Carletto Colombo, direttore dell’Avanti e con Roberto De Monticelli), tirava mattina tra la fumosa atmosfera di uno dei numerosi nitght club cittadini. tazione critica su una sua interpretazione. Baldacci, presente alla scena, non potendosi rivalere sull’artista, si vendicò con il suo accompagnatore. “Lei è con la signorina?” chiese all’uomo che stava accanto alla diva. Alla risposta affermativa, gli mollò uno schiaffo. Uno schiaffo vendicatore alla Mostra di Venezia All’avanguardia nel campo delle formule e del modo di fare un giornale, si rivelava però un passatista come uomo di mondo. Durante la Mostra cinematografica di Venezia, una sua redattrice era stata schiaffeggiata da un’attrice che non aveva accettato un’anno- Battaglie politiche coraggiose e temerarie Sì, il direttore del “Giorno” apparteneva alla schiera dei giornalisti protagonisti. Uomini dotati di talento professionale e di particolare forza polemica nella quale mescolano inclinazione manageriale e forti dosi di spregiudicatezza. Un tipo di professionista ben radicato nel nostro giornalismo (ve ne sono parecchi anche oggi) che ha avuto quale modello nazionale Edoardo Scarfoglio. Come ricordava un giorno Arturo Tofanelli, apprezzato direttore ed editore, Baldacci era afflitto da un grave neo: “la difettosa padronanza del pedale del freno, insignificante per uno che è abituato ad andare piano, qualità essenziale per chi invece corre”. Questa mancanza di senso dell’opportunità (e della misura) segna il suo destino. Alcune battaglie politiche e di costume che egli promuove sul suo giornale sono coraggiose; altre alquanto temerarie per un foglio che appartiene ad un’industria di Stato. Attorno al terzo anno di vita, Il Giorno attacca Vittorio Valletta, il presidente della Fiat. L’articolo provoca notevole sconcerto nel mondo politico e in quello imprenditoriale, ma non ha conseguenze. Fatale per la carriera del direttore messinese risultano invece alcune note che appaiono sul giornale contro il presidente del consiglio, il democristiano Antonio Segni. 19 (27) Gaetano Baldacci L’uomo del Giorno M E M O R I A Nell’agosto del 1944, durante la Resistenza, affrontando su “Lo Stato Moderno” il tema del ruolo dei giornali nell’Italia liberata, Baldacci aveva sostenuto la necessità che il Comitato di Liberazione Nazionale espropriasse le testate giornalistiche e le assegnasse ai partiti. Cosi, a suo parere, si sarebbe evitato il pericolo che queste ricadessero “nelle mani di gruppi apparentemente indifferenti, ma in realtà loscamente interessati al gioco politico”. Affidando, almeno nei primi tempi, i quotidiani alle organizzazioni politiche si sarebbe evitato che “quei gruppi potessero monopolizzare le varie correnti della democrazia popolare in una fase schiettamente rivoluzionaria, a fini prettamente conservatori o reazionari”. Al giovane medico aveva risposto Mario Borsa il quale aveva bollato di illiberalismo la formula “a ogni partito il suo giornale”. Il giornalista auspicava una sana epurazione dei redattori compromessi, ma considerava opportuno che il grande foglio d’informazione “dovesse essere lasciato in vita con la sua testata e nell’integrità della sua organizzazione”. La quota di Del Duca passa a Mattei Paradossalmente, Baldacci sperimenterà personalmente cosa sarebbe accaduto ai liberi giornalisti direttori se le testate fossero finite in mano alle fazioni. Il suo Giorno non apparteneva ad una formazione politica bensì al ministero delle Partecipazioni statali che era, come dire, a tutti i partiti che formavano il governo. Chiusa dopo tre mesi dalla nascita del quotidiano l’edizione del pomeriggio per motivi economici (anche se vendeva oltre centoventimila copie), Del Duca, non si sa bene se per via d’un disegno prestabilito oppure se a causa d’intervenute complicazioni economiche, si disfa della sua quota proprietaria che finisce nelle mani di Mattei. Questi ambiva da sempre a possedere tutto il quotidiano e da tempo faceva pressioni su Baldacci perché gli vendesse il logo considerando un paradosso che uno come lui “investisse tanti soldi in un giornale senza essere il proprietario della testata”. Il messinese resisteva illudendosi che il foglio, pur appartenendo ad un’azienda a Partecipazione statale, potesse assecondare l’indirizzo politico che egli gli voleva imprimere. Le operazioni per estrometterlo cominciano 1957. Andandosene in vacanza, il messinese aveva sospeso la Situazione, l’editoriale non firmato nel quale sinteticamente, in una sessantina di righe, dava conto ai suoi lettori delle coordinate politiche, sociali e di costume del momento. Il presidente della Segisa, allo scopo evidente di “spersonalizzare” la testata, ripristina la rubrica con il pezzo d’un prestigioso redattore. Baldacci, trascinandosi dietro Fusco, è costretto a lasciare la Versilia e a fare un’incursione notturna nel giornale per evitare il colpo di mano. I contrasti che affliggono i vertici della testata sono anche d’ordine politico: mentre il direttore condivide la posizione di Amintore Fanfani, Mattei, temendo lo strapotere del “cavallo di razza”, se n’è allontanato da tempo. I conflitti della dirigenza si riverberano sulla redazione. Una Il grafico è giornalista quando concorre ad elaborare il messaggio 20 (28) tensione interna spacca il foglio dove si formano due partiti. L’attacco di Baldacci a Segni, offre a Mattei l’occasione che aspettava. Il presidente del Consiglio (che proprio quell’anno 1959 ha vinto il congresso democristiano sconfiggendo la linea di Fanfani, sostenuta dal “Giorno”) è un uomo mite. Ma la critica rivoltagli dal giornale milanese gli sveglia dentro alcune asprezze del carattere sardo. Egli esige il licenziamento del giornalista. Il presidente dell’Eni temporeggia. L’ultimatum del capo del Governo subìsce brevi rinvii. Alla fine Mattei è costretto a sbarazzarsi del geniale direttore. L’esonero è preceduto da un incontro tra l’uomo politico e il siculo. Convocato a palazzo Chigi, Baldacci, ammesso alla presidenza di Segni, intravede “nei suoi occhi grigiastri e spenti una sorta di cupo rancore”. Il premier gli rimprovera l’attegiamento critico del foglio verso il Governo. Il direttore non nega. Replica: “Sì è vero. Ma il giornale appartiene allo Stato non al governo”. Il Segni ribatte: “Il Governo rappresenta lo Stato. Criticando il Governo si critica lo Stato”. Ancora il giornalista “Ma ammetterà che vi sono oggi due governi nello stesso governo: un governo e l’antigoverno”. Antonio Segni offre al direttore del “Giorno” un trattamento di liquidazione eccezionalmente largo in cambio delle dimissioni volontarie. In caso affermativo, l’ordine della liquidazione sarebbe stato passato alla direzione della Segisa per l’immediata attuazione. Ma Baldacci rifiuta la buonuscita: almeno questo è quanto racconterà negli anni Ottanta la vedova, signora Luisa, al giornalista Luciano Simonelli. Sempre per ottenere un disimpegno non traumatico del direttore dal giornale, Mattei offre al siciliano (qualora presenti le dimissioni) addirittura una cattedra alla facoltà di Medicina. Caparbio, Baldacci ci tiene ad accreditarsi come vittima sacrificale d’un mondo politico che professa democrazia e pluralismo solo nelle carte dei congressi. Esige il licenziamento che gli arriva il 31 dicembre 1959 insieme con una liquidazione di centocinque milioni di lire. Nell’articolo di commiato che il 1° gennaio compare sul “Giorno” egli scrive: “I motivi per i quali sono costretto a lasciare la direzione del “Giorno” non li dirò. Non li dirò ora. Tra Il lavoro del grafico ha natura giornalistica quando contribuisce al contenuto del messaggio mediante la scelta delle modalità di presentazione dell’informazione. Il lavoro del giornalista è costituito da una “prestazione di lavoro intellettuale, diretta alla raccolta, alla personale ed originale elaborazione od al commento di un fatto destinato a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d’informazione” (Cass. 1.6.98 n. 5370, e precedenti, nei quali trova man mano risonanza: Cass. n. 899/96, n. 1827/95, n. 536/93, n. 2166/92, n. 4547/90). Il carattere fondamentale di questa attività è definibile in tal modo come il personale contributo che il giornalista conferisce al nudo fatto, prima di offrirlo al destinatario: questo contributo è costituito dal pensiero, quale patrimonio di idee, cultura e sensibilità con cui egli percepisce ed interpreta il fatto stesso. Con questo contributo, la sua attività, quale mediazione tra il fatto e la relativa diffusione, diventa un’interpretazione del fatto. Questo pensiero può essere manifestato con i comuni mezzi di informazione: lo scritto, la parola, il suono, l’immagine, il disegno, la grafica (e con la moderna tecnologia la potenzialità espressiva di questi mezzi va man mano aumentando). In questo quadro è da valutare anche l’attività del grafico. Questa può esaurirsi nel mero conferimento della necessa- qualche mese i miei lettori li sapranno e li sapranno da me. Qualcuno a un certo momento doveva pagare. E io pago. La storia d’Italia si sta trasformando. Bisogna che qualcuno tenga duro (per poi riprendere in altro modo) nella lotta che riguarda più che noi stessi i nostri figli, il loro avvenire”. Inseguendo un’immediata, rabbiosa rivalsa, il siculo impiega subito la grossa somma nella creazione d’un nuovo giornale al quale nel 1961 associa l’editore Enzo Sabato. Fonda “ABC”, un settimanale che, come il quotidiano, mette in mostra una grafica nuova per l’Italia, sul modello dei giornali popolari inglesi. Vendicativo qual è, Baldacci non manca di raccontare nei primi numeri del sua rivista la vicenda (Parliamo del Giorno di Mattei) che ha patito infoltendo la schiera dei suoi nemici. “La storia del nostro Paese si sta trasformando” aveva scritto nell’addio ai lettori del Giorno. La frase era stata però censurata. Il periodo completo suonava cosi: “La storia del nostro paese si sta trasformando da politica in giudiziaria”. L’annotazione si rivelerà profetica. Tanto più che sarà proprio lui, uno dei primi interpreti della sconcertante svolta che effettivamente si registra da quel momento negli annali italici. Il 26 marzo 1967, domenica di Pasqua, l’ex direttore del Giorno è arrestato all’Hotel Saint George di Beirut e rinchiuso nell’inferno dei Sablons, le terribili carceri libanesi. Dalle cronache dei giornali, gli italiani apprendono che il giornalista è coinvolto nello scandalo del Banco di Sicilia, accusato di peculato. Uno scandalo che viene da molto lontano “Questa disgrazia viene da molto lontano” dice a se stesso il giornalista mentre è ancora in manette davanti all’inconsapevole commissario di polizia libanese che lo interroga. Secondo l’accusa, tra il 1960 e il 1963 Baldacci ha costretto il presidente del banco palermitano Carlo Balzan a concedergli cinquantadue milioni di lire per interrompere una campagna di stampa di “Abc” contro l’istituto di credito. Formalmente la banca gli avrebbe assegnato ventotto milioni quale finanziamento della pubblicità d’una rivista mai realizzata e altri ventiquattro milioni come compenso pattuito con la fondazione Mormino di Palermo, sovvenzionata dall’istituto, perché egli preparasse e organizzasse “una pubblicazione a carattere culturale” che avrebbe dovuto anche dirigere ma che non aveva mai visto la luce. Tradotto l’anno successivo in Italia, il direttore di “Abc” è condannato a tre anni e sei mesi di reclusione. Il 28 dicembre del 1970 è però assolto con formula piena da tutte le accuse. L’inventore del moderno Giorno non assapora per molto tempo l’esultazione per la sua riabilitazione. La terribile esperienza vissuta nelle carceri libanesi e tre anni di processi hanno compromesso irreversibilmente la sua salute. Colpito da un male insorabile, si spegne a Milano il 5 aprile del 1971, a sessant’anni. Enzo Magrì ria forma al messaggio (da comunicare), ovvero estendersi ad una scelta. In questa seconda ipotesi, nella misura in cui la “forma” (pur meramente grafica) del messaggio diventa “contenuto”, l’attività assume natura giornalistica. Adoperare un certo carattere tipografico e non altro ovvero riportare il fatto in una determinata colonna od in una determinata pagina (e non in altre), essendo il prodotto della valutazione delle potenzialità racchiuse nel fatto stesso (nei confronti dell’interesse del destinatario del messaggio), costituisce di per sé, quale mediazione fra fatto e comunicazione, un contributo al contenuto del messaggio: un’interpretazione. In questa seconda ipotesi, assume ovviamente rilievo (ai fini del riconoscimento della predetta natura) la misura (quantitativa e qualitativa) di questo contributo, nel quadro complessivo dell’attività svolta. Ed assume rilievo la sottoposizione al potere gerarchico d’un art director: questa presenza non esclude la natura giornalistica dell’attività grafica solo nella misura in cui non limiti gravemente la creatività del lavoratore subordinato e non gli precluda la possibilità di partecipare attivamente all’elaborazione del messaggio: non escluda il suo contributo di pensiero (Cassazione Sezione Lavoro n. 5162 del 12 marzo 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Cuoco). (da: www.legge-e-giustizia.it) ORDINE 5 2004 Dal Corriere della Sera del 7 aprile 2004 I NOSTRI LUTTI È morto l’inviato del Corriere della Sera Ettore Botti. Aveva 53 anni. Lascia la moglie, Isabella Bossi Fedrigotti, e due figli, Vittorio ed Eduardo Il coraggio della notizia La lezione di Ettore Botti di Giangiacomo Schiavi Anche se faceva di tutto per non darlo a vedere, per molti di noi era sempre il Capocronista, il numero uno, il capitano coraggioso di una squadra di giornalisti che ne riconoscevano il carisma e il rigore. In ogni gesto, in ogni parola, in ogni articolo, Ettore Botti lasciava intendere un’innata propensione al comando, quasi che dirigere gli venisse naturale. Freddo, preciso, determinato, era entrato giovanissimo nella parte, quando la cronaca d’assalto la facevano i giornali del pomeriggio e i reporter dovevano arrivare in redazione con la notizia tra i denti. Maturò in quegli anni, nella Milano grigia del ‘69, la sua vocazione di giornalista, tra le sirene della celere e i cortei degli operai, quando Turatello gestiva le bische clandestine e i clan malavitosi seminavano di cadaveri le periferie cittadine. Un precoce battesimo alla Notte, con la arma in prima pagina sulla bomba di piazza Fontana, concessa dal mitico direttore Nino Nutrizio per essere stato tra i primi a entrare nella Banca nazionale dell’Agricoltura, 16 morti, una strage. Poi il passaggio al Corriere d’Informazione, straordinaria palestra di talenti e anticamera per quello che era l’obiettivo finale: il Corriere della Sera. Ci arrivò da inviato speciale sul finire degli anni Settanta, con i galloni conquistati sul campo per capacità di scrittura e cura dei pezzi, un pedigree da cronista di razza con incursioni nella letteratura e con un romanzo che sintetizzava le sue passioni: «Portiere uno rosso dispari», calcio, azzardo e fantasia. Passò alla redazione degli «Interni», seduto al tavolone della sala Albertina a dividere agenzie e passare pezzi dei colleghi. Fu un esercizio di rigore e umiltà che anticipò una futura vocazione, ma consumò anche un imprevisto divorzio: nel 1983 Indro Montanelli lo chiamò alla cronaca del Giornale, per mettere carica ed energia alle sue pagine milanesi. Gli piacevano le caratteristiche di quel giorna- che usava la politica come scorciatoia per fulminanti carriere o ricchezze esagerate. Toccò proprio ad Ettore, dalle pagine del Corriere, lanciare il primo segnale d’allarme a Palazzo Marino, sede di un’amministrazione che in passato era stata “laboratorio” e adesso sforava nell’illecito: «Bisogna sbarrare il passo ai faccendieri, e sicuramente non ne mancano nella folla di imprenditori e mediatori d’affari, burocrati e politici di seconda fila, rappresentanti della cultura e delle professioni che premono alle porte del Comune...” scriveva, anticipando i magistrati della Procura. Moralità, indipendenza e integrità diventarono Addio al giornalista che guidò la Cronaca del Corriere lista napoletano trapiantato a Milano che aveva lasciato la carriera da avvocato ai primi esami di giurisprudenza e si segnalava per il suo carattere deciso e severo, da ufficiale di un esercito che non indietreggia mai. Fu un passaggio importante, e diventò la scorciatoia per quella che era una destinazione quasi naturale: la cronaca di via Solferino. Nel 1987 Milano era quella da bere, frizzantina e leggera come un aperitivo alla moda, spavaldamente rampante e ingenuamente incosciente, corrosa da una politica litigiosa e arrogante che navigava a vista tra i problemi. Era la città degli appalti agli amici degli amici, il distintivo della sua cronaca, una cronaca scomoda per il palazzo ma attenta ai diritti dei cittadini. Avvertì i sinistri scricchiolii di Tangentopoli quando le prime mazzette sfiorarono gli assessorati all’Edilizia e all’Urbanistica, cavalcò la protesta antiRoma del prefetto Caruso con un’intervista a tutta pagina: “Roma frena la Milano europea» e ottenne l’impegno del governo a snellire la burocrazia soffocante che paralizzava il modello ambrosiano. Ma fu con via Bianchi che trovò la sintesi del miglior giornalismo d’inchiesta: una battaglia ingaggiata dalla cronaca del Corriere per salvare una strada divenuta ostaggio dei banditi, per dare una speranza ai cittadini onesti delle case popolari che da anni vivevano nella paura e nel terrore. Fu una scossa per tutti, politici, forze dell’ordine, sindacati e imprenditori, rivelò l’esistenza a Milano di un Bronx da abbattere e portò alla rivincita della legalità. Chissà come prenderebbe oggi questa cronaca, il nostro Ettore. Lui che era severo con gli altri ma più ancora con se stesso, si schermirebbe assai, direbbe che al Corriere ha fatto soltanto il suo dovere. Come faceva a Madrid, quando era corrispondente nella Spagna del nuovo corso, o in India e in Argentina quando era inviato speciale. 0 come faceva negli ultimi tempi, quando scriveva editoriali per la Cultura e si appassionava alla storia e ai suoi personaggi. Forse taglierebbe il pezzo e aggiungerebbe che la sua vita era anche altrove. Vicino a Isabella, e ai suoi adorati figli, Vittorio ed Eduardo. Magari al San Paolo di Napoli, ad applaudire ancora Careca e Maradona. Gli chiedo scusa se stando al posto che era suo non sono stato all’altezza. L’uomo era speciale, il suo carattere anche. Nella malattia che ha affrontato a viso aperto, da duro, da combattente nato, non ha mai perso la lucidità: le sue analisi sono rimaste taglienti fino all’ultimo, la geometria dei suoi discorsi era come quella delle sue pagine. Doveva scrivere altri articoli. Non arriveranno più. Romano Biolchini scriveva di auto e motori, “di box e dintorni” Era un ragazzo del ‘29, Romano. Alto, longilineo, sempre sorridente e con una lieve inflessione modenese, che ne svelava le origini emiliane, nonostante fosse arrivato a Milano nel ‘58, era iscritto dal 1974 all’Ordine dei Giornalisti (pubblicisti) fino allo scorso 9 marzo, quando un tremendo tumore se lo è portato via in meno di un anno. È sempre difficile parlare o scrivere di un amico che non c’è più, se poi questo è stato un Maestro di professione e vita, e spiritualmente una sorta di papà adottivo, l’impresa emotiva diventa titanica. Romano Biolchini, con il quale ho condiviso diciotto anni d’amicizia, con pazienza e dedizione, mi ha seguito e incoraggiata nei miei primi passi quando mi affacciavo alla professione, dandomi consigli, suggerimenti e soprattutto correggendomi i pezzi, proprio come facevano un tempo i “vecchi” giornalisti verso le nuove leve. Insegnamenti preziosi, che hanno conseguito a far sì che diventassi una quindicina d’anni fa giornalista freelance, specializzata in turismo. Per onore di cronaca, devo riconoscere che i risultati ottenuti nel corso del tempo, li devo proprio a Romano, se non ci fosse stato lui all’inizio, francamente non so se avrei raggiunto certi traguardi. E di successi professionali la vita di Biolchini, Biolca per gli amici, era ricolma. La passione per le auto e i motori, lo avevano portato da giovane a lavorare nella sua città natale come tecnico meccanico nel reparto corse della Maserati. Erano gli anni Cinquan- ta, quando la vera tecnologia risiedeva nella testa, nel cuore e nelle braccia dei meccanici della Maserati, che si fregiava di avere piloti come Fangio, Moss e De Tommaso. Conclusa dopo sei anni l’avventura alla Maserati, Biolchini, trasferitosi a Milano, lavorò come capo officina e collaudatore per diverse case automobilistiche, finché nei primi anni Settanta la passione di scrivere di auto e motori, da hobby si trasformò in professione giornalistica a tempo pieno. La sua grande esperienza nel settore, lo portò a collaborare con riviste prestigiose, fra queste ricordo Quattroruote, Gente Motori e Ruoteclassiche, ma anche a scrivere oltre 15 libri, di cui l’ultimo “Quelli dei box e dintorni” (1999), che raccoglie le testimonianze dei meccanici della Formula 1 e offre uno spaccato di vita delle corse da dietro le quinte, www.ecostampa.it RASSEGNA STAM PA AncheHTML atostra in foprm er la vo net Intra ORDINE 5 2004 L’ECO della STAMPA è tra i più importanti operatori europei nell’industria del MEDIA MONITORING. Essere un partner affidabile per chi - in qualsiasi struttura pubblica o privata - operi nell’area della comunicazione o del marketing è, ormai da 100 anni, la nostra mission. Anche grazie ai servizi di ECOSTAMPA Media Monitor SpA (media monitoring, software, web press release, media analysis, directories…) ogni giorno migliaia di nostri Clienti accrescono l’efficacia delle loro Direzioni Marketing e Comunicazione, disponendo di maggiori risorse interne da dedicare alle attività con più alto valore aggiunto. rimane il testamento letterario di Biolchini più prezioso e completo. Ma non solo. Pensando ai giovani meccanici, Romano, fondò insieme a un gruppo di tecnici l’Aca (Associazione collaudatori automobili), volta a promuovere un corso teorico di base per la formazione di collaudatori diagnostici di automobili. Alle capacità professionali, inoltre, si univano quelle umane, merce rara di questi tempi, che si riassumono in poche parole: Romano era una persona perbene. Il mio abbraccio, ora, va alla moglie Bianca, con la quale formava una fantastica coppia, molto unita nonostante quasi 50 anni di matrimonio, ai figli Barbara e Stefano, dei quali ho “invidiato” benevolmente di avere un papà come Romano e ai nipoti, perché hanno avuto un nonno, anzi un amico, veramente straordinario. Se desiderate saperne di più …o fare una prova, contattateci! Tel 02.748113.1 - Fax 02.748113.444 E-mail [email protected] ® L’informazione ritagliata su misura. Nominativo .............................................................................. Azienda .............................................................................. Indirizzo .............................................................................. Cap/Città .............................................................................. Telefono/Fax .............................................................................. E-mail .............................................................................. OG di Gianna Testa ECOSTAMPA MEDIA MONITOR SpA 21 (29) Pietro Verri, Storia di Milano. A cura di Francesco Ogliari, prefazione di Giuliano Urbani, Edizioni De Ferrari, pagine 590, euro 45. LIBRERIA DI TABLOID Ristampata l’opera di Pietro Verri Storia di Milano di Francesca Romanelli “Nomina sunt consequentia rerum”, recita un antichissimo adagio latino. E se nel nome è racchiusa la natura profonda, l’essenza di ogni cosa, un erudito illuminista quale Pietro Verri non sfugge a ricercare nell’etimologia origini ed escatologia di una città. La sua. Quella Milano austera e severa che si alterna, nei secoli, a capitale d’Italia e della modernità. Ne scandaglia l’anima storica, i registri dei tempi, il comune sentire, il progresso materiale insieme a quello civile. E lo fa con la sua monumentale “Storia di Milano”, testo illuminista di indagine diacronica e critica edito nel 1779 ma soprattutto ripubblicato oggi, a due secoli di distanza, in un momento di prepotente rinascita d’interesse verso la dimensione “locale”. Ora che sui piatti della bilancia del mondo pesano da una parte il globalismo e dall’altra, come avrebbe detto Machiavelli, “il particulare”. Ne nasce una testimonianza di italiano quasi contemporaneo, pulito e vibrante, seppure agli sgoccioli del Settecento. Ne scaturisce la testimonianza di un giornalista ante litteram (padre de “Il Caffè” insieme al fratello Alessandro e a Cesare Beccaria) che trasforma l’accaduto, il passato, in un documento da affidare al presente. Capace di ricostruire l’albero genealogico della città che sarà, in un futuro anteriore, patria dell’editoria; che ha sempre voluto essere, per vocazione, prima inter pares; che ha costruito il suo primato sociale sull’operosità. Il tutto raccontato con uno spirito di accorata e pensosa milanesità. serie di circostanze senza un fondatore, e mi pare che dalla condizione d’un povero villaggio gradatamente ampliatasi divenne insensibilmente una città, senza che uomo alcuno avesse concepita l’idea dapprincipio di farla tale”, aggiunge Verri. Finché questo scorcio pianeggiante di Gallia cisalpina diventa romana, con la conquista dell’Insubria operata dai consoli Cneo Cornelio Scipione e Marco Marcello. Cogliendo Verri l’occasione di un excursus storico sulla dominazione latina, contrapposta alla vile crudeltà soggiogante dei barbari: “Il dominio adunque di Roma non distrusse le città dei vinti, ma ve ne edificò di nuove: rese il clima più adatto a essere abitato, liberandolo dalle paludi; dallo stato di barbarie c’incalzò a quello di una società civile; e perfine da sudditi che ci aveva resi la forza, la beneficenza romana ci fece liberi: e membri di un’illustre repubblica, fummo capaci delle magistrature di Roma”. Quelle genti in fuga dalla pianura saccheggiata I capitani Medio e Olano e il Paese di maggio “Della etimologia di Milano vi sono pure varie opinioni: oltre quella dei due capitani Medio e Olano (cui risalirebbero rispettivamente la prima e la seconda pianta della città ndr), v’è chi la deriva dal tedesco Mailand (così chiamasi Milano in Germania); e questa voce significa paese di maggio, paese di primavera: denominazione che comunque conviene poco a una provincia in cui gli aranci non reggono scoperti, e in cui “ne’ sei mesi dell’anno che cominciano in novembre e terminano al fine d’aprile l’altezza media del termometro è al di sotto del temperato, e dove in quella metà dell’anno la terra è soggetta al gelo ed alle nevi”, scrive Verri nelle prime pagine della sua opera. Scandaglia l’humus territoriale della futura metropoli per trovarne le radici che lo conducano al germe natale, insabbiato nelle nebbie della storia. E passa in rassegna tutte le pagine del tempo, anche le più scolorite, andando a trovarvi una scheggia di verità. “La più comune sentenza fa nascere la voce Mediolanum da un mostro che si vide nel luogo in cui è fabbricata, e questo era un porco mezzo coperto di lana”. Questa una delle ventitré versioni sull’origine del nome della città: la “scrofa semilanuta”, con una fascia più chiara sul dorso, la cui pelle i Galli erano soliti mostrare alle porte degli agglomerati urbani di loro fondazione. Una leggenda rimasta negli antichi simboli cittadini e visibile in un bassorilievo di marmo al Palazzo della Ragione. Tracce queste, che Verri calca con citazioni originali di Claudiano e Sidonio Apollinare, senza tuttavia dimenticare l’apporto di Tito Livio che ascrisse la genesi milanese al condottiero gallico Belloveso. Anche se l’ipotesi più probabile, a posteriori, rimane il connubio latino-celtico di medio e lan (corrispondente al planus latino) da cui Mediolanum, città di mezzo. Protagonista di se stessa, senza fondatori o generali a darle un nome. “Milano mi sembra formata per una 22 (30) allo stile corinzio rivelato dai capitelli. Una Milano imperiale, in cui “nel quarto secolo molto dimorarono i Cesari”. E in cui, durante quella stessa epoca, Verri fissa quasi profeticamente la nascita di Milano capitale morale. Comincia infatti a divenirlo con il vescovo Ambrogio (il termine arcivescovo sarà introdotto molto più tardi, puntualizza l’autore), “uomo per la dottrina, per la pietà, per la fermezza e per ogni sorta di virtù celebratissimo”, sin da quando cacciò l’imperatore Teodosio dalla chiesa perché resosi colpevole di un omicidio. Il rito ambrosiano dell’autorevolezza, della Milano che si fa grillo parlante contro gli abusi, inizia qui: “dirò bensì che, ogni volta che i ministri della religione hanno alzata la loro voce coraggiosa contro i pubblici delitti, l’umanità intera ha tributato a essi l’ammirazione”, afferma inconsapevolmente Verri. Il “volto” della città con le sue nove porte Attento all’urbanitas latinamente intesa come “civiltà”, e all’urbanistica, Verri parla inoltre del volto di Milano: “...probabilmente allora non v’erano che nove porte della città. La Romana era poco lontana da San Vittorello; la Erculea era fra il monastero della Maddalena e quello di Sant’Agostino; la Ticinese era al Carrobbio; la Vercellina era vicina a San Giacomo de’ Pellegrini, e perciò la chiesa poco lontana ha il nome di Santa Maria alla Porta; la Giovia era vicina al monastero di San Vincenzino; la Comasina era poco discosta da San Marcellino; la Porta Nuova stava collocata più interna, prima della chiesa de’ Minimi; la Porta Argentea, ora Renza, era prima di giungere alla colonna così detta del Leone; la Porta Tosa era al fine della via di San Zenone”. Tanto che già Ausonio, poeta romano del quarto secolo, poteva dire “Et Mediolani mira omnia, copia rerum...”, Milano abbonda tutta di cose meravigliose. “Copia rerum”: una condizione, quella de “l’abbondanza di cose”, che rimarrà il suo tratto caratteristico fino alla contemporaneità di capitale del commercio e dell’economia. Si inginocchia, Verri, alle bellezze della città. Come le colonne di San Lorenzo, “pezzo di così nobile e grandiosa architettura”, ispirate L’età di mezzo rappresenta, per la “città di mezzo”, la caduta degli dèi. Arriva l’epoca delle invasioni barbariche, degli Attila, Vitige e Uraia che Verri considera come i più deleteri per la città. “Gl’italiani erano una nazione che da conquistatrice passò a essere colta, e dalla cultura erasi degradata alla mollezza; e una schiera di arditi selvaggi non può temere resistenza da una nazione corrotta”. Gli imperatori dunque abbandonano Milano e anche le genti fuggono da una pianura saccheggiata quanto pericolosa, andando a rifugiarsi sulle isolette dell’Adriatico e a fondare Venezia. L’imperatore Zenone, da Costantinopoli, affida la cura della penisola al re Teodorico, figlio del re dei Goti, ariano, che “tuttavia protesse i cattolici contro ogni violenza”. E questa stirpe governa la pianura dal 493 al 553. Vengono poi i longobardi e “furono trenta questi piccoli tiranni, che col titolo di duca si appropriarono una parte del regno, e Milano diventò suddita di Alboino, al quale si attribuisce d’avere fabbricato il suo alloggio in una parte di Milano vicina al centro, che oggidì chiamasi Cordùs, nome derivato, a quanto pretendesi, dal latino Curia Ducis”. E con un altro tocco, spiega la denominazione di molti siti ambrosiani: “v’era l’orto dell’arcivescovo in quello spazio che ora occupa la regia ducal corte, che perciò si nominò il Broletto vecchio dalla voce brolo, che ne’ secoli bassi significava appunto orto”. Denominazione che ancora oggi distingue la chiesa di San Nazaro in brolo e che caratterizzava Santo Stefano, entrambi altari inglobati nel bosco che l’arcivescovo possedeva appena fuori le mura dell’allora metropoli. Per cinque secoli, dice Verri, Milano rimase in ombra. Intanto, però, la dominazione longobarda finisce nel 774 quando si insediano i Franchi, con re Carlo Magno chiamato in soccorso da Adriano papa. Desiderio finisce monaco in Francia, terra dei conquistatori. Ansperto costruisce l’atrio di Sant’Ambrogio E Milano riprende lentamente vita: è il vescovo Ansperto da Biassono a costruire l’atrio della chiesa di Sant’Ambrogio, “il più antico pezzo di architettura che abbiamo dopo i romani”, commenta Verri. Poi furono gli unni, e l’età carolingia. Ma la lingua? Come si parlava a Milano e dintorni? Chiaro, secondo Verri, che “ne’ bassi tempi scrivessero quella lingua che chiamavano latina, mentre parlavano il dialetto proprio”, non molto dissimile da quello in uso al tempo dell’autore “e ciò perché le vocali u ed eu pronunziate con l’accento francese, non mi sembrano inserti fatti ORDINE 5 2004 Pietro Verri, un giornalista ante litteram Non è solo un legame di nascita quello che lega il pensatore illuminista Pietro Verri a Milano. E non è, nemmeno, soltanto un fil rouge elettivo che si dipana nelle 582 pagine della sua opera. È qualcosa di ancora più stretto, una consonanza morale e ideale con una metropoli senza fondatori, costruita dall’ingegno degli uomini per la vita degli uomini, secondo la lezione antropocentrica dell’età dei Lumi. Ma è anche una contiguità casuale e imprevedibile. Come quella che legge nel cognome di questo letterato, poiché “verro” significava porco, il simbolo stesso della città rappresentata dalla “scrofa semilanuta” di matrice gallica. L’albero genealogico dello scrittore parla della sua origine dal patriziato ambrosiano, con il padre Don Gabriele vicario di provvisione e la madre Barbara Dati Somaglia. Nacque nel 1728, studiò dai Barnabiti a Milano, dagli Scolopi a Roma, dai Gesuiti di nuovo a Milano fino a diventare osservatore e politico della sua realtà cittadina. Il ritratto che in una pagina della “Storia di Milano” dedica al fratello Alessandro sembra cucita sulla sua stessa vita: “...un uomo che, nel fiore della gioventù, ha posposti i piaceri, che le grazie della persona e dello spirito potevano cagionargli, ai men volgari piaceri d’illuminare i suoi simili, e di lasciare una durevole memoria alla posterità”. La sua giovinezza, infatti, è contraddistinta dall’opposizione al conformismo culturale e familiare: di un padre che lo vuole avvocato; di una società che vuole la sua classe dirigente cauta e conservatrice. Diviene così militare e si dedica alla “Società dei Pugni” che già solo nel nome ne identificava l’anticonformismo sociale nel periodo di dominazione asburgica. Del 1764 è l’avventura giornalistico-letteraria de “Il Caffè” insieme al fratello Alessandro e al Cesare Beccaria autore di “Dei delitti e delle pene”. Una pubblicazione coraggiosa perché, in un panorama pret- con la dominazione dei franchi, ma una emanazione dell’antica lingua gallica originale”. La girandola di re e usurpatori ruota senza sosta, in un’antologia di nomi, fatti e date che Verri annota minuziosamente. Con loro, sulle sue pagine, trovano posto anche simboli del nord che diverranno inoltre vessilli politici. È il caso del Carroccio, inventato secondo Verri dall’arcivescovo Ariberto. Uno strumento militare, che stava sui campi di battaglia, poiché i vescovi stessi allora erano più “militari” che “religiosi” in senso stretto. “Io credo che piuttosto debba riguardarsi come una invenzione militare assai giudiziosa, posta la maniera di combattere di que’ tempi. Nel tempo in cui dura un’azione, è sommamente importante il sapere dove si trovi il comandante, acciocché colla maggior prestezza a lui si possa riferire ogni avvenimento parziale (...). Terminata la guerra, si riponeva il Carroccio nella chiesa maggiore, come cosa “sacra e veneranda”. Non solo ...anche le altre città della Lombardia, quando coll’esempio de’ milanesi acquistarono l’indipendenza, e si ressero col loro municipale governo, adottarono ciascheduna il proprio gran vessillo, ossia Carroccio. Si mangiava lardo, scrive Verri, in questo periodo. Solo più tardi, intorno all’anno Mille, si preferivano polli e carni arrosto. L’origine dei Navigli nell’età del Barbarossa Di quell’epoca l’usanza di regalare alla futura sposa, verso la quale si era fatta la promessa di matrimonio, “un anello, ovvero una corona, un cinto, ovvero una veste o un drappo”. Consuetudine rimasta poi nell’iconografia mondiale del fidanzamento. “I cognomi cominciarono a formarsi nel secolo XI, e nel XII erano generalmente praticati”. Nell’età del Barbarossa, che distrusse la chiesa di Sant’Eustorgio e trafugò nel duomo di Colonia gran parte delle reliquie dei Re Magi, Verri pone l’origine dei Navigli: “Frattanto però, che stavamo rendendoci più odioso ai vicini, e dal lontano nemico, la sola cosa ragionevole che femmo si fu di munire d’un valido fossato, ossia di una linea di circonvallazione, tutta la città (...). Questo fossato è precisamente quello per cui ora scorre il canale del naviglio”. In seguito, Verri prende ad analizzare la formazione della lega lombarda, il giuramento di Pontida e la rinascita di Milano. Anche se la riscossa dura poco: “Verso la metà del XIII secolo l’impero era immerso nell’anarchia e nella confusione”, tanto che le monete coniate su suolo ambrosiano riportavano unicamente l’effigie di Sant’Ambrogio e il nome Mediola- tamente letterario, incentrava il dibattito su temi d’attualità come la scienza, l’agricoltura e quant’altro fosse di “varia utilità”. Ma, come diceva San Francesco d’Assisi, spesso “l’amore non è amato”. E la sua instancabile passione civile si scontrò con la prevalente indifferenza del pubblico e gli scarsi riconoscimenti politici. Ripiegò così nel matrimonio, durante il 1776, quando sposò una nipote di appena ventuno anni che lo rese padre di due figli, anche se il secondo morì. Poco dopo perse anche la moglie e il padre. Di quegli anni è il progetto della “Storia di Milano”. Quasi uno scatto d’orgoglio e di impegno nei confronti di una vita che spegne gli entusiasmi. Ancora scarso il riscontro presso l’opinione pubblica. Nelle sue pagine c’è lo spirito dell’Illuminismo, dell’uomo che esce “dallo stato di minorità che deve imputare a se stesso”, come disse il filosofo di Koenisberg, Immanuel Kant. C’è la fiducia nei confronti delle persone e della ragione, visibile quando afferma che “È finalmente vero che la umana natura non è spinta, nemmeno fra i barbari, a superflua crudeltà”. C’è la presa di distanza dalle gerarchie ecclesiastiche e dalla dimensione religiosa, non contestata; semplicemente insondabile: “...né mi propongo di trattare di cose sacre”. C’è l’elogio del presente, quando davanti all’“età caliginosa” del medioevo ricorda ai lettori la fortuna di vivere nella modernità. Il secondo volume uscirà dopo la sua scomparsa, avvenuta durante una seduta della Municipalità milanese che rappresentava una sorta di comune ante litteram. La sua fama però, grazie ai posteri, gli sopravviverà. Perché “il linguaggio della storia è quello della verità”. Che è “nemica di quella cinica invidiosa maldicenza, che cerca di trovare la malignità nella debolezza”. Francesca Romanelli num, senza profili e nomi regali. “La pulizia e l’ordine cominciarono a comparire nella città”, afferma. Verri parla intanto della dinastia Torriani con tutti i suoi possedimenti e fissa l’origine della casata Visconti nell’anno 1261. Di questi, lo stemma con la vipera in atto di inghiottire un saraceno, detta poi più spesso biscione. All’origine di questa immagine, racconta una nota al testo, forse un’effigie longobarda sovrappostasi nelle forme al serpente di bronzo custodito nella basilica di Sant’Ambrogio. Di questa dinastia, più tardi, Azzone Visconti si distinse per l’amore verso pittura e scultura, tanto che “allora appena spuntava l’aurora delle belle arti”. Fra le sue realizzazioni, la torre della chiesa di San Gottardo, poco dietro il Duomo. “Anche un altro motivo rende quella torre degna di osservazione; ed è che ivi Azzone fece collocare un orologio che batteva le ore, macchina allora affatto nuova e sorprendente, dalla quale prese nome la via delle ore, come anche in oggi viene chiamata”. Una macchina inventata “da un monaco benedettino inglese” e “posta a uso pubblico in Londra l’anno 1325”. Probabilmente, dice Verri, “ancora non ve n’era alcuna nell’Italia”. Vicino a piazza Mercanti, in quell’epoca, “alloggiava il podestà”. Poco distante, alle scuole palatine, il giudice si affacciava per pronunciare le sentenze di morte che venivano eseguite fuori città, passando oltre Porta Vigentina. Azzone, in quegli anni, riuscì a portare a Milano perfino un letterato del talento di Francesco Petrarca: “egli alloggiava dicontro a Sant’Ambrogio (...) Si dice che Giovanni Boccaccio, per amore del suo Petrarca, vivesse qualche tempo con lui in Milano”. Di questa città, l’illustre poeta fiorentino celebrò soprattutto la “salubrità dell’aria”. Non c’erano, al tempo, le moderne coltivazioni di riso. “Quest’irrigazione adunque serviva ai soli prati, e forse allora il clima di Milano era più salubre di quello che ora non lo è, da che si è ogni anno sempre più dilatata l’irrigazione, e introdotta singolarmente la coltura de’ risi”. Ecco il Duomo, il più grande e ardito del mondo Ma poi Petrarca partì, a causa della pestilenza. A metà trecento, poi, una drammatica carestia. Sotto la dominazione Visconti nasce il ducato di Milano. Con il progetto del Duomo a firma di Gian Galeazzo. “Allora non v’era in Roma la superba chiesa di San Pietro, né in Londra quella di San Paolo; e il tempio che disegnò Gian Galeazzo, ed innalzò in Milano, per que’ tempi era il più grande, il più ardito e il più magnifico del mondo, senza eccettuare Santa Sofia di Costantinopoli (...) Il duca volle fare questo tempio abbandonando la simetria degli ordini eleganti di architettura, e seguendo il gusto di fabbricare della Germania”, lo stile gotico. Una curiosità recita che la costruzione del Duomo venne cominciata dall’abside, praticamente dal retro, come era consuetudine allora. Dopo la morte dell’ultimo Visconti si instaura la repubblica, rappresentata da una bandiera crociata su cui campeggia un cerchio più scuro con la figura del patrono cittadino. È proprio qui che Francesco Sforza si mette al servizio di Milano, viene nominato comandante delle armi milanesi e “capitano generale della repubblica”. È lui che assedia la città e vi entra il 26 febbraio 1450. È lui “propose quindi alla deliberazione della città medesima il determinare, se dovesse per tutela di lei riedificarsi il castello. (...) L’Ospedal Maggiore “casa” di chi soffre Si fecero adunanze del popolo in ciascuna parrocchia per deliberare su tale inchiesta”. Di questi anni la costruzione di quella che oggi é l’università Statale: “Intraprese e condusse a fine la fabbrica dell’Ospedal Maggiore, aperto indistintamente a sollievo dell’egra umanità, senza riguardo a patria né religione. Il turco, l’ebreo, il cattolico, l’acattolico, purché siano ammalati e poveri, ivi trovano ricetto e assistenza”. A Milano, Francesco Sforza lasciò “un canale navigabile, un grandioso e ricco ospedale, due magnifiche fabbriche, il casello e la corte ducale, e le vie della città riattate”. Verri passa poi ad analizzare le gesta di Lodovico il Moro, che “fabbricò il vastissimo claustro del Lazzaretto secondo l’uso di que’ tempi” ed “eresse la facciata del palazzo arcivescovile”. In questo periodo, la presenza a Milano di Bramante e Leonardo Da Vinci. Verri narra poi delle alterne vicende del Moro e una nota al testo racconta della costruzione della torre del Castello, avvenuta nel 1904 ad opera di Achille Beltrame su progetto originale del Filarete. Il resto, è storia degli intrighi e dei repentini cambi ai vertici dell’amministrazione meneghina. Un racconto che si ferma al dicembre 1524, con l’assedio di Pavia. E si fermano, nella seconda parte del testo, anche le notazioni di vita quotidiana con cui Verri aveva punteggiato all’inizio il suo volume. Più la storia si avvicina al suo tempo, più Verri affronta il dettaglio politico e abbandona la società. I quartieri della città da Porta Romana a Porta Vercellina Continua ancora oggi il filone letterario “storico-urbanistico”, potremmo dire, inaugurato da Pietro Verri e incentrato su Milano. Prosegue con una serie preziosa quanto sconosciuta di piccoli testi che la fortuna può concedere di scovare in piccole librerie del centro. Sono curati da Bruno Pellegrino e, pubblicati dalla casa editrice “Libreria Milanese”, sono divisi per zone della città: da Porta Romana a Porta Vercellina, passando per tutti i quartieri della città. Quello che sembra affascinare maggiormente l’autore è senza dubbio il primo, Porta Romana, che a pochi passi dal Duomo accoglie la parte più luminosa della città. Questa fetta di Milano che comprende anche Porta Vigentina e Ludovica, racconta l’autore attento storico e osservatore delle testimonianze che il passato ha lasciato incastonate nella metropoli, trasse il suo nome dal varco che interrompeva la cerchia di mura all’altezza di piazza Missori. Da lì, fino alla Crocetta, l’imperatore Massimiano “distese” nel III secolo “un duplice filare di portici” denominato via Porticata: maestoso accesso a Milano ormai capitale d’Occidente. Ancora pochi milanesi sanno poi, ad esempio, che la via Laghetto vicina alla chiesa di Santo Stefano (appena riaperta al pubblico) si chiama così perché nel 1388 i cittadini vollero costruire un piccolo porto, “con tanto di banchina e magazzini”. Un laghetto artificiale detto di Santo Stefano e rimasto intatto fino a Ottocento avanzato, quando lo si volle eliminare perché considerato poco salubre vicino a un ospedale come il Maggiore. Ed è proprio qui, nell’intensa serenità che si ritrova fra i chiostri di via Festa del Perdono ORDINE 5 2004 (oggi sede dell’università Statale), che si esplora un altro tassello di milanesità. Con la “festa del perdono” che si teneva, tutti gli anni dispari, il 15 di marzo giorno dell’Annunciazione. Obiettivo della celebrazione la raccolta di denaro che interessava al fondatore Francesco Sforza per completare l’ospedale, soldi che venivano raccolti con le offerte per l’assistenza ai malati e le visite alla cappella del nosocomio in cambio di una “speciale indulgenza” introdotta da papa Pio II”. E se San Nazaro è la più antica basilica paleocristiana della metropoli, inizialmente distrutta dal condottiero barbaro Uraia tanto disprezzato dal Verri, la bella e raccolta basilica di San Calimero veniva frequentata nell’antichità per chiedere al santo il dono della pioggia. In Porta Vigentina, invece, Pellegrini ricorda come fino al 1971 sorgesse la chiesa di San Bernardo che “all’ennesimo sferragliare d’un tram, brontolando s’accasciò”. Soltanto, “all’indomani due righe di circostanza sulla cronaca del Corriere”. E nessuno che ricostruì quest’altro gioiello della città. A poca distanza, nella chiesa di Santa Maria al Paradiso, venne conservato fino 1872 la croce votiva che ornava il Carroccio. Quell’anno, per duemila lire, venne passata al Duomo per essere collocata sul sepolcro del vescovo Ariberto. La festa più antica di Milano, infine? Quel “tredesin de marz” che ricorda con un tripudio di fiori il 13 marzo del 52 d.C., quando si tramanda che San Barnaba “avrebbe piantato la sua rozza croce a simboleggiare l’evangelizzazione della città”. Fra.Ro. 23 (31) L A L I B R E R I A Vittorio Giovanelli Le tribù della tivù di Emilio Pozzi Quanti sassolini si è tolto (per uno, lo ammette lui stesso a pagina 222)? Con questo libro-confessione su una vita spesa per la tv (prima in Rai come organizzatore di produzione e poi, dopo piccole tappe a Mondadori e a Alto Milanese, con Berlusconi nelle sue reti, raggiungendo i vertici della carriera dirigenziale) Vittorio Giovanelli dà uno spaccato del sistema televisivo italiano che non si ritrova in tanti altri libri. Di questo non si può, così la penso, dare un giudizio globale, seguendo la consueta metodologia del recensore, pur scrupoloso e pignolo. E tanto meno separare il grano dal loglio. Non potrà diventare un testo universitario perché manca di sistematicità scientifica e va visto come un reality book ma, indubbiamente, a saperlo leggere, si trovano tante ri- sposte alle domande curiose che la gente si fa sul dietro le quinte della televisione. E quindi è più interessante di un ponderoso testo sociologico. È un libro sincero che traspira umanità. Anche nelle pagine che apparentemente non sembrano interessanti perché sono infarcite di decine e decine di nomi, quelli di colleghi con i quali ha condiviso le prime esperienze e che sono rimasti al palo, anche se sono apparsi innumerevoli volte nei titoli di coda, che nessuno legge. In tv soddisfano le ambizioni dei più bassi livelli professionali ma che calcolati nella durata del programma servono biecamente a diminuire il costo-minuto della produzione. Una autentica furbata degli amministratori. Devo, a questo punto, dire per chiarezza che Vittorio Giovanelli, l’ho conosciuto, molti anni fa, in Rai, proprio quando svolgeva le mansioni di organizzatore di Giovanni Giovannini Dalla selce al silicio di Emilio Pozzi Da vent’anni, Giovanni Giovannini, che ha saputo unire una prestigiosa professionalità a una felicissima e originale capacità manageriale alla guida della Fieg, accompagna la veloce mutazione dei mass media con un testo, scritto a più mani da specialisti, aggiornato di novità in novità, ad ogni edizione: una piccola Bibbia che unisce i precetti di base sulla comunicazione a quello che c’è da sapere di nuovo. Siamo ora alla quinta edizione e il libro tradotto in undici lingue è sta- to aggiornato e completamente riscritto negli ultimi capitoli. Vi hanno messo mano Enrico Carità, Carlo Lombardi, Nicoletta Castagni, Barbara Giovannini e Carlo Sartori. “Ad ogni nascita di un novum ordo, niente è chiaro, tutto appare confuso” ricorda Giovannini nella sua introduzione. “Tanto più il lettore vorrà apprezzare questo nostro sforzo per identificare al termine di una storia della comunicazione alcune grandi, probabili linee di sviluppo”. Quale sarà il futuro? Ce lo chiediamo, dopo aver mentalmente ripassato sulla D I TA B L O I D percepite e arricchiscono l’aneddotica ma non sono, mi pare, smentibili. E le frecciatine a Bruno Vespa, troveranno sodali. Leggere per confutare. Quello che piacerà, in questo lungo monologo, è la freschezza della memoria, per mille particolari, e l’implicita offerta al lettore di essere giudice tra i protagonisti. Giovanelli sa però mettersi in discussione, quando azzarda opinioni estetiche e giudizi morali. Su una persona sola non ha dubbi, in questo molto in linea con Emilio Fede: Berlusconi gli ha aperto la strada del successo e al Berlusconi-pensiero, con il quale comincia il libro, dedica le ultime pagine. Però come ogni self made man che guardandosi allo specchio si compiace per la strada fatta - in salita, molto spesso - il narratore non bada a mezze misure e la sua prosa appare, per usare un termine gergale poco “sorvegliata”. Come avesse improvvisato davanti a un registratore, riducendo al minimo le correzioni di stile. E l’incaricato dell’editing fosse andato a sgranchirsi le gambe. Ma si fa ancora l’editing? Vittorio Giovanelli, Le tribù della Tv, Mursia, Milano 2003, pagine 402, euro 16,00 scorta dell’indice cinque millenni di storia: l’alba della conoscenza, la mirabile invenzione di Gutenberg fino al giornale on line, radio e televisione, da Marconi all’era digitale e le altre più recenti conquiste, dal computer al cellulare, fino alle nanoteconologie. Le aggiornatissime statistiche ci possono sbalordire ma anche indurre a qualche riflessione. Nella postfazione, dedicata all’esplosione della conoscenza, si cita il parere di Edoardo Boncinelli, biologofisico di fama mondiale. “I nostri progenitori sono stati per un milione di anni a scheggiare le pietre, e sempre nello stesso modo; noi abbiamo imparato ad addomesticare i primi animali, 14-12 mila anni fa, a seconda delle zone, e la scrittura non è più vecchia di 5-6 mila anni. Sotto gli occhi ci scorre ogni giorno un’esplosione di conoscenza, e non riesco ad immaginare come sarà il mondo tra quat- tro o cinque generazioni. Non lo vedremo, io che parlo e voi che leggete. Per me ho una grande nostalgia al futuro”. Nelle righe finali della postfazione si citano alcune cifre che vale la pena di memorizzare: nel 2007 si prevede la presenza di un miliardo e 150 mila computer, il doppio di quanti ce ne fossero nel 2001, con il primo posto conquistato dall’area AsiaPacifico (367 milioni di pc) mentre l’Europa è passata al secondo posto (285 milioni). Gli Stati Uniti sono al terzo posto (251 milioni). L’Africa è quasi assente. “Centinaia di milioni di persone vivono e vivranno fuori dal tempo in un’epoca che altrove è finita”. Giovanni Giovannini Dalla selce al silicio (Storia della comunicazione e dei mass media) Libri Scheiwiller, Milano 2003 pagine 248, euro 19,00 Non ha torto chi afferma che per raggiungere la condizione spirituale di apertura alla poesia è indispensabile un’alleanza tra autore e lettore. Il testo naturalmente è l’elemento trainante e decisivo perché l’alleanza si realizzi. Ma è anche vero che il processo è facilitato dall’educazione letteraria del fruitore. Se si considera che in questo ultimo ventennio in poesia (o, meglio, nei tentativi di poesia) c’è posto per tutto e per il contrario di tutto, bisogna riconoscere che l’alleanza poeta/fruitore non avviene frequentemente e, quando si verifica, non è sempre senza fatica. È questione di sapienza compartecipativa. Queste premesse per entrare nella poesia di Giovanni Bianchi che ha pubblicato la sua ottava raccolta di versi. Si tratta di una poesia che non è facile e pertanto non è coinvolgente in prima lettura. Ma dove sta scritto che la poesia deve essere facile? E “facile” che cosa vuole dire? La scrittura poetica di Bianchi richiede ripetute letture e raggiunge pienamente quell’alleanza, di cui si diceva, se si accetta la sua tendenza ad una forma di provocazione che è di natura etica ed estetica. Senza prepotenza Bianchi dapprima insinua, poi di fatto impone, profondi convincimenti. L’autore introduce e porta avanti le sue tematiche con circospezione, mediante sapienti sospensioni di discorso o con interrogazioni su problematiche esistenziali a volte più sussurrate che esplicitate. La poesia verte su modi possibili dell’esistenza e riesce a determinare un clima, contemplativo oppure esortativo, di consonanza tra umanità e natura. Comunque è sempre lui, l’autore, a condurre il gioco, un gioco estremamente serio nel quale mondo esterno certa Isabella, che lei chiama Isabrutta, non la vuole questa nuova madre, anche perché ha già trovato altre braccia tra le quali scaldarsi: la passione per le scarpette a punta. Il sogno di fare la bellerina è il suo rifugio per poter tornare a vivere e crescere, nonostante la perdita subita. La poetica di questo libro, anche se ben dichiarata solo alla fine, è che “vale sempre la pena di coltivare un sogno”. La vita, in fondo, non è altro che un sogno, no? Anche a prezzo di sacrifici, insicurezze e opposizioni dure al mondo degli adulti, che cercano sempre di andare contro corrente e di creare una bambagia di sicurezza e di normalità di aspirazioni attorno ai figli, attorno al mondo incompreso dell’infanzia. Non pensando, invece, che il bambino per diventare adulto deve compiere il suo cammino di iniziazione dentro la vita. E nessun cammino è uguale all’altro. È così che Aurora Marsotto, giornalista de Il Sole 24 Ore e di altre testate, critico di danza, crea Ivy. Ma questo libro è bello anche perché è pieno di musicalità, con citazioni di “Heine Kleine Nacht Musich” di Mozart, de “La campanella” di Listzt, della “Polonaise” di Chopin, de “La Sérénade mélancolique” di Ciaikovski. La musica classica entra in punta di piedi nell’immaginario infantile di Ivy e vi sosta per “educarla”, rassicurarla. La musica come il ballo è in fondo il ritmo della vita. Il battito cardiaco del nostro andare, a volte, correre. Come insegna bene Calvino, le favole sono la somma dei destini dati ad un uomo nel corso della vita, cioé anche delle soluzioni offerte quando si naviga dentro i problemi, il dolore. “Da grande farò la ballerina” insegna che al sogno di che farò da grande non si rinuncia mai. Pena la perdita del ritmo della vita. Anche se il sogno non riesce, come in effetti potrebbe essere stato per l’autrice (ci piacerebbe Aurora Marsotto Da grande farò la ballerina di Paola Pastacaldi Semplicità narrativa, con lo stile del diario intimo, a tratti dolente, ma anche frizzante, vero, intenso. È il testo di una ragazzina di nove anni, che ha perso la mamma e il cui papà si rifidanza dopo un viaggio a Parigi. Ciò che spira da questo piccolo volume della collana “il Battello a vapore”, la casa editrice apprezzata per le sue scoperte 24 (32) narrative per l’infanzia, è un’aria di musicalità così intensa da far pensare che questo volumetto potrebbe anche piacere agli adulti, tanto è metafora di un modo di essere eternamente fanciulli che, come insegnano le medicine dello spirito, non bisognerebbe abbandonare mai, nemmeno da vecchi. La storia è presto detta. Ivy che ha perso la mamma e che si trova un padre improvvisamente innamorato di una Giovanni Bianchi La lingua arrugginita produzione. Poi non ci siamo più incontrati. Non sono rimasto nella sua memoria, per mia fortuna. Meglio ignorati e dimenticati che messi, magari ingiustamente, nel gruppo come è capitato per qualche persona che avrebbe meritato, accanto al nome, almeno un aggettivo (penso a Gianfranco Bettetini, per fare un nome). Il libro sembrerebbe prendere l’avvio dall’insistente domanda (‘Dai, racconta!’) di qualche amico. Meglio di una nipotina che vuol sapere dal nonno come sono veramente i personaggi che appaiono sul video. E allora, il bravo nonno snocciola tutto quello che sa, lasciandosi andare a confidenze e a giudizi che per anni ha tenuto per sé. Gli amici restano amici e quelli ai quali hai dovuto sorridere o che ti hanno fatto inghiottire bocconi amari, beh è arrivato il momento di togliersi il peso dallo stomaco. I ritratti di alcuni personaggi inquadrati nella realtà di episodi vissuti, non sono compiacenti o complici. Quello che Giovanelli racconta di Mike Bongiorno o di Maurizio Costanzo, o anche di Enzo Biagi, messi a fuoco (qualcuno anche sulla graticola) in precise circostanze di lavoro, confermano impressioni già di Pierantonino Berté e problematiche dell’io si alternano e si fondono. Alcune righe di Bianchi. Ecco una provocazione: “Il corpo inconsistente dell’infanzia…/ Tutto sembri mettere in quieta naftalina…/ e anche il niente ha un’ombra/ e una tattica forse.// Dalla camera alla tavola/ è il mesto pellegrinaggio.” Un’interrogazione decisiva: “Piace a Dio davvero/ essere vinto dai suoi figli?”I tre versi che compongono “Domenica delle palme”: “Io sento l’invecchiare di lontano/ della mia carne/ e non so la risurrezione che festa sia” “Il vuoto” è una poesia molto utile per capire: “Il nostro è vuoto d’ispirazione// Dai campi sofferenti/ s’alzano gonfie e piovorne nubi di sera/ Soffia da un’ora Orlando/ l’olifante sotto le alberature di periferia/ alla barba fiorita di Carlo./ Magia dei grattacieli in bilico/ delle utilitarie spente…// Quanto mi costa intenerirmi!”. Una confessione: “Io non evado mai, galeotto della vita.” Ancora nella stessa atmosfera “…In un paesaggio sull’attenti/guardi tutti,/ e non so se sia breve riso/ o una smorfia di dolore.” E qui un Bianchi di facile alleanza: “Gli alberi/ non avendo nulla da dire/ si lasciano nevicare. //Vorrei sognare il risvolto/ di tutti i punti che hanno/ una dimensione (lo so di scienza infusa)/ e le orme / che non ci siamo accorti/ d’aver lasciato…// Eppure già Lui /il Cacciatore/ vi cammina senza affanno/ senza ansia. // E ci avrà.” Gli ultimi due versi della raccolta sono rivelatori: “…Sapessi come la ruggine/ sa essere intensa.” Guido Oldani, a sua volta significativo poeta, in una intelligente prefazione dà conto della poetica dell’autore, ne accetta e condivide il modo di fare poesia. Giovanni Bianchi, La lingua arrugginita, Scriptorium editrice, pagine 90, euro 12,00. saperlo!) che fa oggi la giornalista e la critica di danza. Ma riesce con una semplicità assoluta a scrivere una favola quasi “musicale” sulla vita. E lo fa incantando i bambini di nove, dieci anni (anche con delle schede dove insegna le scuole ragionate di ballo, i passi e persino l’abbigliamento). E creando quelli che potremmo chiamare i luoghi dell’anima, i paesaggi entro cui collocarsi da bambini e da adulti bambini, che sono più importanti persino delle scelte materiali. Le illustrazioni argute e piene di humour sono di una delle più conosciute illustratrici italiane di libri per ragazzi, Desideria Guicciardini. Aurora Marsotto, Da grande farò la ballerina, Il Battello a vapore Piemme Junior, euro 7,50 ORDINE 5 2004 L A L I B R E R I A Roberto Zaccaria Televisione: dal monopolio al monopolio di Emilio Pozzi Una voce autorevole scesa in campo contro la legge Gasparri, e non poteva essere diversamente, è stata quella di Roberto Zaccaria. Esperto in Diritto pubblico, Diritto costituzionale generale e in Diritto dell’informazione (materie che insegna nelle Università di Firenze e Perugia-Terni) e profondo conoscitore della Rai (consigliere d’amministrazione dal 1977 al 1993 e presidente dal 1998 al 2002). Nell’arco degli anni ha scritto molto sull’argomento. Tra gli altri, oltre a quelli strettamente scientifici o ai più lontani, precedenti alla Riforma del ‘75 vanno citati tre testi: Rai la televisione che cambia (1984, Sei Torino) e i contributi a raccolta di saggi pubblicati da Laterza, curati, il primo nel ‘92 da Jader Jacobelli Per una nuova riforma della Rai, il secondo curato da Paolo Barile nel ‘95 Idee per il governo- sistema radiotelevisivo. A prescindere dal tormentato iter che ha dominato le cronache e i dibattiti, non soltanto parlamentari, ma dell’opinione pubblica per mesi e mesi, il libro di Zaccaria è un utile riferimento per la memoria storica della tv in quanto ripercorre cronologicamente le vicende del sistema radiotelevisivo a partire dalla riforma del 1975, con la quale, nonostante il marchio di “lottizzazione” coniato da Alberto Ronchey, si era tentato lo sganciamento dal Governo del servizio pubblico, con il passaggio al controllo del Parlamento e l’avvio di un decentramento ideativo e produttivo. Tutte le tappe successive, giuridiche e politiche, alle quali sono sempre stati associati i nomi di qualche personaggio (Mammì, Maccanico, Craxi, Berlusconi e, da qualche tempo, Gasparri) sono puntualmente ripercorse con spirito critico con riferimenti precisi alla lettera delle norme giuridiche. Si rievoca il Far West televisivo che, per le anomalie del sistema richiamò l’attenzione di tutte le altre emittenti, europee, americane e giapponesi, con la calata di “troupes” che venivano a documentarsi, si giunge ai discorsi sulla par condicio, sul conflitto d’interessi, si illustrano gli interventi della Corte Costituzionale, con polemica chiarezza. Fra i problemi, e gli errori commessi, Roberto Zaccaria rispolvera il mancato accordo su RaiWay che definisce “un sogno non realizzato” e che ha impedito alla Rai di avere oggi in cassa 724 miliardi di lire in più. Riporto, per memoria: nell’aprile 2001, dopo una gara durata un anno e mezzo,con il controllo di ben cinque consulenti di altissimo livello, la Rai cede alla società texana Crown Castle, uno dei colossi mondiali degli impianti di trasmissione e delle “torri” il 49 per cento della società Rai Way, appositamente costituita un anno prima, con la prospettiva di creare alleanze. La cifra pattuita per la Rai è di ben 724 miliardi di lire, al netto delle imposte. Descritta la trafila delle procedure e il raggiungimento di tutti i pareri favorevoli, arriva un alt: il governo di centro sinistra (Amato presidente) arrivato al termine del suo mandato non se la sente di pronunciarsi e rinvia tutto al nuovo Governo. Non c’erano problemi sia da quello giuridico che da quello operativo. La nuova società era già operativa e il suo vertice tecnico aveva già disegnato un primo business plan molto positivo. I 724 miliardi di lire erano già stati versati preso la Chase Manhattan Bank… Il nuovo Governo si presenta subito con un atteggiamento molto polemico verso il vertice della televisione pubblica. Giorgio D’Ilario Dizionario legnanese di Vito Soavi Nell’immediato dopoguerra, Piazza del Duomo aveva ripreso il suo ruolo di ritrovo per i milanesi che volevano fare quattro passi in Galleria, dopo l’aperitivo al Camparino o allo Zucca, o che si raccoglievano sotto il monumento a Vittorio Emanuele II per commentare i fatti della politica, ancora inebriati dalla riconquistata libertà. ORDINE 5 2004 Tra la folla si aggirava un certo Pollini, singolare e ieratico personaggio, che apostrofava i presenti lanciando provocazioni contro il mondo della politica; diceva: “i deputati, lo dice la parola stessa, sono i figli delle putte... il presidente, prende il dente per mangiare...”. Raggiunto un certo gruppo di ascolto iniziava una sconclusionata ma divertente arringa traendo ispirazione dall’etimologia, intesa come scien- D I TA B L O I D Domenico De Maio Percorrenze Roberto Zaccaria, Televisione. Dal monopolio al monopolio, Baldini, Castoldi e Dalai, Milano 2003, pagine 204, euro 11,80 Più che un libro è una boccata d’aria pura, scritto com’è in uno stile estremamente scorrevole, quasi giornalistico, che tuttavia conserva una certa eleganza letteraria e spesso indulge al vezzo della citazione di qualche adagio latino o al preziosismo di qualche vocabolo ormai desueto. Domenico De Maio, medico psichiatra, racconta le sue “percorrenze”, il suo viaggio di uomo e di medico. Nato, nel 1929, a Polistena, un grosso centro nella piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria (ma per restituirgli un preziosismo verrebbe voglia di scrivere Reggio di Calabria, quasi contrapposto a Reggio nell’Emilia). Donna Nata, una signorotta del paese, a quello che abbiamo capito, prevedeva per lui un avvenire di “bravu mastriceddu”, di bravo operaio. Ma l’intelligenza del ragazzo, i risultati scolastici e, soprattutto, i sacrifici del padre sfatarono la profezia. Dopo le elementari e le medie, troviamo il De Maio al ginnasio-liceo di Palmi e, nel 1946, finalmente, matricola all’università di Messina, facoltà di medicina. Disagi economici consueti per una famiglia che ha un figlio all’università, soprattutto negli anni dell’immediato dopoguerra in cui tutta una nazione aveva problemi pecuniari, ai quali i De Maio cercavano di porre un minimo di riparo con il contrabbando del sale tra la Sicilia (dove il sale era fuori monopolio) e la Calabria. Poi una gita a Milano (1947), l’innamoramento per questa città, la convinzione che l’ambiente milanese gli avrebbe aperto orizzonti diversi, il desiderio di trasferirvisi e di proseguire gli studi nel capoluogo lombardo. Ancora la lungimiranza del padre, che assecondò il figlio, il trasferimento a Milano, l’ingresso in un appartamento di Via Montegani giusto l’antivigilia di Natale del ‘48. De Maio rievoca con passione (forse con un pizzico di nostalgia) i primi tempi milanesi:Città degli Studi, la facoltà di medicina, così come oggi, sparsa un po’ per la città (tra Via della Passione, ex Collegio delle Fanciulle, e via Mangiagalli), il provvidenziale ricorso al commercio dei libri usati, (un’attività in decollo in quegli anni, intrapresa da Aldo Cortina, che poi divenne un vero e proprio imprenditore del ramo), le passeggiate serali in Galleria, il cappotto e i vestiti fatti con le stoffe dono dell’UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration). La laurea e l’internato in ospedale, al Fatebenefratelli, i difficili rapporti con i “baroni”, un posto sfumato, assegnato ad un “paracadutato” quando stava per essere suo (a chi non è accaduto?), l’uscita dal “Fatebene” sbattendo la porta nel 1956 e lo sbarco al manicomio di Mombello, visto il suo crescente interesse per la psichiatria. Comincia allora la sua carriera come “Dutur di matt”, come dicono a Milano, in quell’ospedale psichiatrico nella ex Villa Pusterla-Crivelli di Mombello dove, nel 1797, subito dopo la pace di Campoformio, vi si era trasferito Napoleone che la trasformò in una sorta di Trianon italiano. A questo punto, il libro è un po’ da addetti ai lavori. È un po’ il passaggio di Domenico De Maio da studente “terun” a professor Domenico De Maio, specializzato in psichiatria. Ricerche, pratiche mediche (fra cui l’elettroshock), pratiche farmacologiche, congressi medici, pubblicazioni. In sintesi il passaggio dalla psichiatria umanistico-filosofica a quella scientifica. Ma il diario di De Maio ripercorre anche le tappe della sua evasione dalla routine giornaliera. Relazioni femminili, soprattutto, la sua passione per la campagna, la viticoltura e la vinificazione a Moasca, nel Monferrato. Pagine di taglio bucolico cosparse di riflessioni scientifico-filosofiche, soprattutto sul suicidio, sul mistero di za aleatoria della nostra lingua. Mi è tornato in mente questo episodio leggendo l’introduzione del rinnovato Dizionario Legnanese di Giorgio D’Ilario, che è stata redatta dall’illustre prof. Augusto Marinoni che dalla ricerca delle origini e dei significati delle parole è sempre riuscito a ricostruire delle certezze assolute. Marinoni usa questa sua straordinaria intuizione per dimostrare che ogni dialetto lombardo è giusto proprio lì dove lo si parla; le differenze di pronuncia o di grafia fra due glosse risente dell’influenza culturale delle popolazioni che vi hanno transitato e soggiornato nei secoli passati. Di più, rivalutando il bistrattato dialetto locale, mette in risalto la ricchezza del suo vo- cabolario. In bustocco, ad esempio, la nebbia si può chiamare nèbia, caligu, brògia, scighea, luèsa, e possiamo trovare ben diciotto vocaboli per tradurre la parola “feci”... I nuovi insediamenti multietnici che hanno contribuito alla formazione delle odierne grandi aree metropolitane e lo straordinario sviluppo dei mezzi di informazione e comunicazione, hanno sottoposto il nostro stile di vita ad un ritmo di frenesia che è andato a scapito del riconoscimento del ruolo che hanno avuto gli eventi del passato, in termini di contributo al progresso ed al cammino culturale. Ecco perché abbiamo finalmente riscoperto il valore della memoria, ed il dialetto diviene allora uno strumento fra i più validi per farla riaffio- rare, in quanto custode delle nostre tradizioni, dei nostri costumi, e quindi della nostra storia. Per questo le pagine del Dizionario legnanese aprono spazi generosi ai proverbi, ai modi di dire, alle cantilene, a mestieri e professioni, ai soprannomi, ai luoghi e rioni, e quant’altro contribuisca a fissare nel tempo le belle realtà del passato. Parlare in dialetto è dunque più che una moda, un obbligo e una necessità, non solo per apprezzare, per esempio quanto ci propone il teatro dialettale, del quale I Legnanesi di Felice Musazzi rappresentano una perla di raro godimento, ma perché consente, come è avvenuto al nostro autore, insediato dall’Abruzzo a Legnano per sposare felicemente una au- Il ministro Gasparri forse non riesce a distinguere tra il piano contingente e quello prospettico, forse ci riesce e deliberatamente decide di affossare l’accordo nella convinzione che una televisione pubblica resa più debole economicamente sia anche più malleabile sui contenuti. Il ministro non incontra neppure i vertici della Rai, mentre dialoga e scrive ai vertici di Crown Castle, che, nel frattempo, per la crisi economica scoppiata negli Usa dopo l’11 settembre, mostrano una netta preferenza verso l’abbandono. La vicenda si conclude negativamente e la Rai deve restituire i 724 miliardi. Il resoconto di Zaccaria è molto particolareggiato, cronistico. Metterebbe conto di rileggere questo episodio ammonitore anche per comprendere il perché della pregiudiziale opposizione al ddl Gasparri. Comunque vada (o sia andata a finire la revisione in Parlamento) Zaccaria sostiene e lo scrive nel sottotitolo del libro “la legge Gasparri azzera il pluralismo ed è pericolosa per la democrazia”. Ecco quindi spiegato il senso del titolo dato al libro “Televisione. Dal monopolio al monopolio”. E un progetto di riforma alternativa, dovrà basarsi su due leggi che riguardano il nodo dell’informazione e potrebbe, anzi dovrebbe far parte del programma di un nuovo governo. “ La domanda chiave, la domanda pregiudiziale verterà sempre sulla disponibilità a ridurre la concentrazione nei poteri e nello Stato”. di Giuseppe Prunai questa molla sconosciuta che spinge un uomo a tuffarsi nel nulla, citando Adorno e Pavese, nato a pochi chilometri dalla cascina di Moasca. Il libro si conclude con la narrazione della sua esperienza di medico paziente nell’ospedale romano di San Giovanni per un intervento chirurgico resosi necessario per “un quadro radiologico da occlusione intestinale”. Non si dice altro della sua malattia, ma si intuisce la sua gravità. Il racconto fa rivivere le sofferenze dopo l’intervento, le ansie, i timori dell’uomo alle prese con il male. Il suo stile da vero scrittore trasmette la tristezza e l’angoscia esistenziale di fronte al male, all’ignoto, all’incertezza della sua sorte decisa altrove già prima della sua comparsa sulla terra.Ma la descrizione della convalescenza e del faticoso recupero riescono a indurre un consolatorio sentimento di speranza e di fede nell’uomo e nella scienza. Bello questo capitolo nella semplicità della narrazione della routine ospedaliera: la visita mattutina del primario con il codazzo di aiuti e assistenti, le medicazioni, le terapie, gli accertamenti diagnostici, i rapporti con gli altri degenti, con il personale ma soprattutto la solitudine del malato in ospedale, assimilabile a quella dell’abitante dei quartieri dormitorio, degli “spettrali condomini”, la solitudine – dice testualmente – “di chi vede nella morte il pericolo della propria esistenza e di chi identifica nella morte la fine delle proprie sofferenze”. Finalmente, il sollievo della dimissione, il ritorno a casa a Milano, la vita che rifluisce come se la circolazione del sangue si fosse interrotta all’improvviso e all’improvviso fosse ripresa. E poi, il ritorno a Mosca. Inevitabilmente, De Maio si paragona a Ulisse che navigò fra le insidie dei due mari della Calabria, il Tirreno e lo Jonio. A me ha ricordato i versi finali di un sonetto di Foscolo dedicato all’isola dove nacque, Zacinto (l’attuale Zante): “…bello di fama e di sventura, baciò la sua petrosa Itaca, Ulisse”. Domenico De Maio (con la collaborazione di Doriana Guazzi), Percorrenze – Tabella autobiografica “di un viaggio” nella molteplicità di vicende e significati di una vita, Laruffa Editore, pagine 184 tentica legnanese, di comunicare con lei in vernacolo per sentirsi veramente a casa sua. Il trasporto di D’Ilario verso questa parlata, così lontana da quella delle sue origini, gli ha consentito di curare in modo vincente anche la seconda edizione di quest’opera;lo testimonia l’accoglienza ed il successo di vendita già al limite dell’esaurito. Per recensire questo Dizionario possiamo solo dire che si compone di 3063 vocaboli, tutto quì. Per apprezzarlo bisogna solo usarlo, e tutti i legnanesi assicurano che ne vale la pena. Giorgio D’Ilario, Dizionario legnanese, Edizioni Artigianservice Legnano, novembre 2003, pagine 309, euro 27,00. 25 (33) L A L I B R E R I A D I TA B L O I D Camillo Albanese Roberta Cordani A proposito (a cura di) degli spropositi Milano nei palazzi privati di Giacomo de Antonellis “Le style est l’homme meme”, precisava a fine ‘700 il conte George-Louis Leclerc che aldilà di questo adagio, ci ha lasciato - firmando con il titolo di Buffon - la più grandiosa opera in età moderna sulla Storia naturale. Lo stile distingue l’uomo, dunque, a cominciare dalla scrittura. E il mondo della stampa dovrebbe tenere conto di tale monito. Non sempre accade, come amabilmente rileva l’amico e collega Camillo Albanese con il recente “A proposito degli spropositi” (Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2003, pagine 96, euro 8) un volumetto che dovrebbe trovarsi accanto alla tastiera di ogni computer onde evitare dubbi lessicali e strafalcioni grammaticali a tanti giornalisti. La lingua italiana, più o meno come le altre, presenta trabocchetti ad ogni riga. “Nessuno nasce imparato” sembra suggerire l’autore ricorrendo ad un altro suo fortunato titolo di qualche anno fa, ma basta avere un po’ di accortezza per evitare figuracce. Per quanto mi riguarda ho deciso di farlo inserendo questo opuscolo tra il Devoto-Oli e il Dizionario dei sinonimi e dei contrari. Mi servirà almeno come memorandum sull’uso corretto (per esempio, e non “ad esempio”, di accenti, acronimi, abbreviazioni, apostrofi e così via) oltre in chiave di fustigatore sia per sciatterie idiomatiche (tipo “attimino, nella misura in cui, vero e proprio”) sia per tautologie assurde (breve sintesi, ironia sarcastica, pretesto artificioso, attuazione pratica” e infiniti altri modi di ribadire lo stesso concetto con due parole collegate). Con semplicità e chiarezza, Albanese ci spiega cose dimenticate che pur dovrebbero appartenere al bagaglio corrente di chi scrive, come quelle sfuggenti e terribili “figure retoriche” di liceale memoria che sfido chiunque a definire su due piedi in poche battute: alliterazione, amplificazione, anacoluto, anadiplosi, anafora, anastrofe, anfibologia, antitesi, antonomasia, brachilogia, calembour, catacresi, endiadi, epitesi, eufemismo, iperbole, litote, metafora, metonimia, ossimoro, perifrasi, sineddoche, zeugma. I curiosi sono invitati a rinfrescare le proprie cognizioni con l’ausilio di uno strumento adatto. Il lavoro svolto da Albanese non intende porsi come un “bignamino” e neppure come una grammatica, una sintassi, un dizionario, un manuale di stile: è piuttosto un manuale da tenere a portata di mano per gli inevitabili assalti di dubbio e 26 (34) per quei momenti di stanchezza che normalmente riflettono la vita di chi scrive per diletto o per dovere. A questo… proposito, mi piace segnalare una rivista prodotta da italiani all’estero. Si chiama “Forum democratico” e viene stampata a Rio de Janeiro con servizi sia in portoghese-brasiliano sia nel nostro idioma. Tra le altre rubriche mia figlia Raffaella - chiedo venia per la paterna citazione - vi cura una encarte especial dedicata a chi vuole approfondire la lingua di Dante. Prendendo spunto da un buon racconto o da un articolo rileva e, vengono messe in chiaro talune difficoltà linguistiche o anomalie grammaticali attraverso una serie di simboli grafici che indicano locuzioni regionali, richiami storici, analogie espressive, contesti grammaticali (l’ultimo numero, in particolare, illustrava la funzione della particella “ci” e alla mia età ho scoperto che ne esistono ben sette diversi utilizzi). In fondo lo scrivere è un’arte: certo, si può affrontare con la meticolosità di un autodidatta che rispetta le regole del colore e della prospettiva, con la spigliatezza del fantasista che ignora congiuntivi e punteggiature, oppure con la pedanteria del burocrate (tipico esempio le sentenze dei tribunali) che introduce parole altisonanti e inventa locuzioni oscure per mascherare la vacuità del costrutto e gonfiare inutilmente il testo. L’esatto contrario della ricetta che un purista della nostra lingua, Demetrio Ferrari, dettava ai primi del Novecento: “Ama un periodare non artificioso come i latini, né spezzato come i francesi moderni, ma largo, con esposizione corretta, ordinata , evidente, di pensieri ben concepiti e logicamente raccolti in uno stesso periodo armonioso che permette, senza dissonanze, di passare dalla semplicità alla grandiosità, ma rifugge dalla costruzioni inverse e dall’abbondanza delle figure che lo fa presto degenerare in ampolloso”. In poche parole, scrivere restando con i piedi per terra, come sottolinea l’autore di questo ottimo vademecum di cui condivido tutto l’orrore per la ripetizione dei genitivi che - ahimè - troviamo disseminati a profusione sulla nostra stampa, e persino nell’intestazione del nostro “Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti di Lombardia” (benché riconosca che non si può cambiare, essendo un’intestazione ufficiale). Camillo Albanese, A proposito degli spropositi, Edizioni Scientifiche Italiane, pagine 96, euro 8,00 di Mario Pancera Milano va guardata dal basso in alto e da un marciapiede all’altro. In questo modo la si vede meglio e, molto spesso, la si scopre. Parlo soprattutto del centro della città, interna alla prima cerchia dei Navigli, che ha strade strette e strettissime, ancora d’impronta medioevale, e ti costringono, purtroppo, a guardare avanti e non attorno. Gli sventramenti, le ricostruzioni, le restaurazioni, dovute a particolari concetti urbanistici, alle guerre, a idee a volte giuste a volte bizzarre, mostrano una città che non è antica né moderna. Non è bella, nel senso che si dà di norma a questo aggettivo (Firenze, Venezia), non è grande né signorile (Londra, Parigi), tanto meno ha la grandiosità della metropoli (New York, Tokio) e la sua definizione urbanistica, nonostante la dinamicità e le buone intenzioni di sempre, è più dovuta al disordine che a norme precise e moderne. È una sfortuna, ma è così. Tuttavia presenta angoli suggestivi e notevoli testimonianze per l’arte e l’architettura dal Quattrocento ai nostri giorni. Ne parla uno che l’ama e la conosce dagli anni Trenta del Novecento avendola vista e percorsa fin da bambino, prima e dopo la seconda guerra mondiale. Un ponderoso ed elegante volume sui palazzi privati milanesi, curato da Roberta Cordani, con l’aiuto di uno stuolo di esperti e ottime stampe e fotografie ci racconta di cortili, giardini e salotti che sono veri tesori. Si vive l’aria di Stendhal e di Napoleone, e quella di Verdi, di Manzoni, del Beccaria, Carlo Porta, Gadda, Bacchelli, Montale e Marinetti, Steinberg e perfino Albert Einstein… Si passa nelle strade della storia o, almeno, di una gran parte della storia del nostro Paese. Per averne conferma occorre un po’ di pazienza e avere la faccia tosta di entrare dentro i portoni, per la verità talvolta chiusi o protetti da custodi severi, ma non inflessibili. Spesso, infatti, costoro comprendono la curiosità dell’ interrogante e ne assecondano il desiderio di sapere. Queste case si incontrano andando dal corso Magenta al Carrobbio o, viceversa, a via Meravigli (con l’intrico che sta intorno e dietro Sant’Ambrogio) oppure tra San Babila e Porta Venezia, tra il Castello, Foro Buonaparte, il Cordusio, piazza Duomo e via Larga, tanto per dare qualche indicazione. Sono edifici che reggono i secoli. Perfino Leonardo si era cimentato con disegni di palazzi per la città. Gli stili, com’è ovvio, sono diversi. Edifici costruiti dal Piermarini piuttosto che dai Coppedè, da Portaluppi piuttosto che da Giò Ponti; sono cinquecenteschi, barocchi, barocchetti, neoclassici, liberty o razionalisti e via dicendo; portano nomi di famiglie importanti, a volte più cognomi l’uno dopo l’altro a indicare i casati che, per eredità o con acquisti, ne sono divenuti proprietari: dai Visconti ai Borromeo, dai Belgioioso ai Bagatti Valsecchi, dai Trivulzio ai Castelbarco, ai Litta, ai Poldi Pezzoli, ai Cicogna Mozzoni… Nomi potenti per nobiltà o per denaro (o per entrambi, naturalmente). Sono di principi, duchi, conti, marchesi oppure mercanti, talvolta colti mecenati, lombardi ma anche stranieri come quello del nobile magiaro Batthyany, che abitava tra Porta Venezia e i Giardini. Non parliamo naturalmente del Castello sforzesco o della Villa reale, oggi pubblici, ma nati come residenze private: anzi la seconda, che oggi ci sembra immensa, era a suo tempo, appunto, una villa. E all’interno ci sono biblioteche, pinacoteche, Wunderkammer, cortili fioriti e discreti, giardini e colonnati (le colonne, spesso, si trovano anche sulle facciate, non solo a terra, ma ai piani superiori: vedi, ad esempio, Palazzo Serbelloni, oggi sede del Circolo della Stampa) cioè meraviglie per gli occhi e per la mente, con nomi di artisti che vanno da Giambattista Tiepolo a Fra’ Galgario, a Mosè Bianchi, da Tibaldi ad Arnaldo Pomodoro. Si possono, praticamente, scegliere tutti i nomi che si vogliono. Se per caso si vuol vedere un’opera di Wildt, senza entrare in un museo, è sufficiente superare la soglia di casa Berri Meregalli, una specie di imponente monumento liberty in via Cappuccini: nell’atrio c’è una sua assai drammatica “Vittoria alata”. Il “milanese” Stendhal ci spiega che rendeva di più, anche in termini monetari, avere una bella casa che darsi alla politica. Passeggiava volentieri per Milano, frequentava Palazzo Marino, ammirava la casa “degli Omenoni”, poteva guardarsi attorno con calma, e scriveva: “Ciò che più mi piace a Milano sono i cortili interni degli edifici. Vi trovo un affollarsi di colonne e per me le colonne sono in architettura quello che il canto è per la musica”. Lo scrittore affermava che i milanesi erano nati per il bello. Erano. Sono passati duecento anni. Roberta Cordani (a cura di), Milano nei palazzi privati. Cortili giardini salotti, Edizioni Celip,Milano, s.i.p. pagine 430 Claudio Stroppa La cultura urbana tra passato e futuro. Una ricerca sociologica a Milano, Budapest e Praga di Margherita Santagostino Tutte le città esprimono cultura e questa è una realtà antica come l’esistenza stessa delle città: si pensi solo a Roma o Atene o Gerusalemme, ma anche alle città inca, maya, azteche, cinesi, assiro-babilonesi, e così via. Lo testimoniano i manufatti creati dall’uomo: Parigi è Notre Dame ma anche la Sorbona e la Tour Eiffel; Londra il Parlamento ma anche i ponti sul Tamigi; Granata l’Alhambra; Vienna la Cattedrale di santo Stefano ma anche il Prater, e a questo punto si potrebbero citare città a partire da Berlino sino ad arrivare a Palermo, da Salisburgo a Cracovia, col timore di dimenticarne altre innumerevoli e altrettanto belle. Claudio Stroppa è un sociologo urbano che insegna nell’Università di Pavia, e già nel passato si era cimentato in libri sulla cultura urbana, da “Città amore mio” del 1982 con la prefazione dell’allora sindaco di Milano, Carlo Tognoli a “Le città del sogno”, con la prefazione dell’attuale sindaco di Pavia, Andrea Albergati. Ha pubblicato con l’editore Franco Angeli nell’autunno 2003 un volume dal titolo “La cultura urbana tra passato e futuro. Una ricerca sociologica a Milano, Budapest e Praga”, in cui accosta queste tre città mitteleuropee. Il tema di fondo che si pone nella ricerca è la conoscenza culturale che non tanto la gente comune, il turista ad esempio, ma esperti del settore hanno della realtà culturale di queste tre città. E in tale prospettiva egli ha intervistato sia architetti professionisti che docenti universitari, che studenti delle Facoltà di Architettura, in un campione a carattere motivazionale (cioè interviste aperte eseguite da collaboratori dell’Università di Pavia e Milano, e degli Istituti di Sociologia delle Accademie delle Scienze ungherese e ceca, su una traccia loro fornita). Il risultato è un po’ relativo in quanto prevale il “nazionalismo” nelle risposte, con una maggiore conoscenza in Ungheria e nella Repubblica ceca rispetto al nostro Paese: gli italiani hanno una ridotta conoscenza degli altri due Paesi. Ma il libro analizza anche altri argomenti: la città come spazio simbolico e il ruolo della pianificazione sociale. A tale proposito si sono presi, solo per quel che riguarda l’aspetto esteriore, palazzi e case appartenenti a tre differenti periodi: il primo definito borghese, che va dal 1910 sino al 1920-30; il secondo, in cui si considerano le case ORDINE 5 2004 L A L I B R E R I A Francesco Anfossi e Aldo Maria Valli I giorni della colomba. Viaggio nella pace possibile Dalla fine della seconda guerra mondiale a oggi i vari conflitti scoppiati in diverse parti del pianeta hanno provocato non meno di 27 milioni di morti e 35 milioni di profughi. La particolarità sulla quale riflettere è che il 90 per cento delle vittime è composto da civili. L’esatto contrario della prima guerra mondiale, quando solo il 5 per cento dei 15 milioni di morti era rappresentato da civili. Il coinvolgimento sempre più massiccio di civili nei conflitti tendenzialmente planetari è testimoniato dall’impressionante numero di rifugiati. E il panorama “bellico” è tuttora desolante, se è vero che in questo momento esistono nel mondo da 36 a 50 focolai di guerra. Queste e altre riflessioni, sempre ben argomentate e corredate da autorevoli punti di vista, sono contenute in un pregevole e snello volume scritto a quattro mani da Aldo Maria Valli, vaticanista del Tg3, e Francesco Anfossi, giornalista e membro dell’ufficio centrale di “Famiglia Cristiana”. Il libro, appena sfornato dalle edizioni San Paolo, intende stimolare una riflessione sulle atrocità che si consumano ogni giorno nel mondo, a tutte le latitudini, e, soprattutto, sulla consistenza e la genuità di certo fenomeno pacifista, emerso in maniera nitida, spontanea e travolgente con le grandi manifesta- zioni del 15 febbraio 2003. Quel movimento è stato paragonato all’unica sola superpotenza in grado di resistere a quella americana e, forse, un giorno, perfino di sconfiggerla. L’inchiesta dei due scrupolosi giornalisti scandaglia a fondo il movimento pacifista, soprattutto quello italiano, uno dei più robusti del mondo, ne ricostruisce la storia, ne ripercorre le radici millenarie, raccoglie le testimonianze dei suoi protagonisti, soffermandosi sul magistero di Giovanni Paolo II, sul ruolo dei cattolici e sull’azione svolta dalla diplomazia italiana. Quel 15 febbraio 2003 è sicuramente uno spartiacque anche nella concezione della pace, vissuta, non come utopia irraggiungibile, come miraggio fuorviante, ma come stile, modo d’essere, comportamento e consapevolezza matura nelle persone. La pace emerge dal volume come orizzonte in costruzione, progetto in via di costante e laboriosa gestazione rispetto al quale tutti gli esseri umani sono chiamati a dare un fattivo e sentito contributo. Attraverso le parole di uno degli intervistati, don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, che biasima la scelta della Rai di ignorare la più grande manifestazione della storia, quella del 15 febbraio 2003, gli autori lasciano intravedere anche l’idea-guida del movi- mento pacifista, fatto di operatori e promotori di pace, motivati a gettare un seme per un futuro di pace vera, nonostante i pregiudizi ideologici che spesso hanno travisato il significato del movimento stesso, sminuendone la portata, soprattutto nelle ricostruzioni dei mass-media. Una sfumatura del problema la coglie certamente Andrea Riccardi, della comunità di Sant’Egidio, che agli autori del volume segnala quella che secondo lui è la questione cruciale: come far continuare il movimento pacifista oltre gli entusiasmi del 15 febbraio 2003 e oltre il sopito conflitto in Irak. Ma Francesco Anfossi e Aldo Maria Valli, nelle conclusioni del volume, danno già una risposta a quest’obiezione: “Nei mesi successivi alla fine del conflitto iracheno ci si è chiesti da più parti se il compito del movimento per la pace fosse finito. Se quella gigantesca candela della storia fosse destinata a spegnersi, per poi magari riaccendersi in un tempo futuro, ignoto all’umanità. In realtà la scintilla ha acceso in chi ha preso parte, nelle diverse forme, al movimento, una nuova consapevolezza difficilmente estinguibile”. Francesco Anfossi e Aldo Maria Valli, I giorni della colomba. Viaggio nella pace possibile, edizioni San Paolo, 2003, pagine 184, euro 11,00 o i palazzi iniziati anche negli anni precedenti al 1930 e sino al 1945-50, in due differenti regimi, il fascismo e il socialismo-comunismo (per quest’ultimo periodo si considerano anche negli anni successivi per quanto riguarda l’Ungheria e la Repubblica ceca), e infine il terzo periodo, definito come il “capitalismo” o “società tecnologica”, dove sia Milano che le altre due città, accelerando gli ultimi tempi, hanno assunto aspetti quasi similari. Tutto ciò è riscontrabile nelle trentasei fotografie inserite nel volume. A contraddistinguere il XX secolo, sono stati inseriti (anche costoro con fotogra- fie e disegni) tre modelli “classici” di cultura urbana: Leon Battista Alberti, Andrea Palladio e Le Corbusier, e nel capitolo concernente l’architettura “fascista”, si è riscoperto un sociologo di quel periodo, Sincero Rugarli, che ha il merito di aver fatto conoscere in Italia i contributi di Wirth, Park e McKenzie, i sociologi della famosa “Scuola Ecologica” di Chicago, come parimenti, avendo trattenuto rapporti con Oppenheimer e Von Wiese, ha evidenziato i temi affrontati dalle scuole di Francoforte e di Colonia (il Reugarli ha diretto, tra il 1927 e il 1940, la “Rivista di Sociologia”). Un capitolo è dedicato al famoso architetto italiano Renzo Piano, definito un “mito” in Italia e nel resto del mondo. Stroppa sottolinea che non esiste più la città “chiusa” ma non è ancora chiara la fisionomia della città “aperta”. Già altre epoche hanno assistito alla scomparsa di un tipo di città e la nascita di un altro tipo che meglio corrispondesse ai valori espressi da una nuova società civile e dai bi- sogni che essa aveva, sia da un punto di vista di obiettivi, di indirizzi operativi e di strutture per abitare. Sul finire del secondo millennio, come si accennava, un’inedita trasformazione culturale ha percorso tutte le strutture della società civile (amministrative, politiche, religiose, sociali, di ricerca, formative ecc.): la città ne è lo scenario più efficace. Ma in questa città sono preposti dai mezzi di comunicazione di massa tre potenti elementi disgregatori della società civile: la frammentazione culturale e gestionale, la tendenza alla separatezza e ad un’etica di tipo individualistico, la crescita economica che punta solo sui fattori quantitativi, un sistema di valori negativi che sfocia nell’isolamento e nel nichilismo, il crollo delle istituzioni “conchiglia” (la famiglia, la parrocchia), al punto che i giovani hanno la percezione di vivere in un deserto di valori senza certezze, di sentirsi cioè come esuli nella società. Sul tema della cultura urbana, attivando una specie di dibattito, nella seconda parte di Ruben Razzante ORDINE 5 2004 D I TA B L O I D Antonio Lucarelli Il Sergente Romano. Brigantaggio politico in Puglia dopo il 1860 di Massimiliano Ancona “Uccidetemi da soldato! No, muori da brigante!”: ottanta anni fa lo storico Antonio Lucarelli, originario di Acquaviva delle Fonti (in provincia di Bari), pubblicava una monografia su “una delle più formidabili masnade, quella del sergente Romano di Gioia del Colle che capeggiava circa duecento ribelli e la cui memoria è ancora tanto viva nelle popolazioni della Puglia”. Lo studio di Lucarelli, valutato in modo positivo – tra gli altri da Benedetto Croce e da Gaetano Salvemini, si è impostato nel tempo come uno dei classici della letteratura meridionalista. “Il sergente Romano”, già ripubblicato da Laterza (1946) e da Longanesi (1980), è stato opportunamente ristampato dalla casa editrice Palomar (pagine 203, euro 11) in occasione del 130° anniversario della nascita di Lucarelli (20 marzo 1874). Nella prefazione al volume, Giuseppe Giacovazzo, giornalista e direttore della collana “Classici del Meridionalismo” della giovane casa editrice barese, nel considerare gli aspetti più rilevanti del dibattito sul fenomeno del brigantaggio meridionale, sostiene che la vicenda dell’ex militare borbonico, “sceso in armi contro i sequestratori piemontesi”, riassume emblematicamente il grande malessere politico e sociale nel mezzogiorno pre del volume sono inseriti i saggi di Alessandro Bosi, sociologo dei processi culturali dell’Università di Parma, di Maria Antonietta Crippa, storica dell’architettura del Politecnico di Milano, di Petr Kratochvil, storico dell’arte dell’Accademia ceca delle scienze, di Vittoria Szirmai e Gabriella Barath, sociologhe dell’Accademia ungherese delle scienze, e dell’architetto Domenico Scarcella, il cui saggio “Idee per Milano” compie un excursus storico dai progetti illuministici per l’Arena (1807), alla carta di Milano di Brenna e Ronchi (1850), esaminando il piano regolatore di Berruto (18841889), sino alla costruzione di quartieri nuovi (ad esempio il Gallaratese) e la sistemazione dell’area metropolitana. Claudio Stroppa, La cultura urbana tra passato e futuro. Una ricerca sociologica a Milano, Budapest e Praga, Franco Angeli, Milano 2003, pagine 237 e post-unitario. Giacovazzo indica anche alcuni aspetti antropologici e culturali della vicenda del sergente Romano, che non implicano ovviamente alcuna rivalutazione o messa in discussione della vicenda storica che fu alla base della costruzione dello Stato unitario: “Il sergente Romano – scrive – combatte per la restaurazione del Borbone, ma sogna di tornare a una vita normale. Insomma non è il volgare brigante. Spera in una vita non molto diversa da quella del padre, pastore di greggi nei boschi della Murgia”. L’interpretazione del Brigantaggio come forma di ribellione sociale degli strati più poveri e disgregati del mondo rurale è in linea con una serie di studi non solo in Italia. Lo storico inglese Eric Hobswam, per esempio, nelle sue opere I ribelli e I banditi, tradotte da Einaudi nel 1959 e nel 1969, considera il fenomeno del “ribelle”, espressione tipica non solo del Meridione d’Italia, ma di altri Paesi europei, dove a partire dal XVII secolo si innnescò un processo di ridistribuzione della proprietà della terra, provocando in diverse situazioni un peggioramento delle condizioni di vita dei contadini. “Nelle province meridionali, a partire dalle riforme del periodo murattiano – scrive ancora Giacovazzo – le terre demaniali non furono distribuite ai contadini ma date in fitto ai galantuomini. E dal possesso all’usurpazione il passo fu breve”. Altro apetto peculiare della vicenda del Mezzogiorno d’Italia fu la violenta repressione esercitata dall’azione militare (“i briganti andavano uccisi tutti e subito”) che ebbe l’effetto di rendere ancor più estraneo alle masse rurali la struttura del nuovo Stato. Contadini e massari venivano fucilati per il semplice sospetto di favoritismo. “Si assassinavano i miseri contadini solo perché portavano in campagna un pezzo di pane più grosso di quanto si era creduto fosse necessario al proprio bisogno di una giornata”. Con la legge Pica s’introdusse nell’ordinamento giudiziario l’istituto del domicilio coatto che divenne in seguito uno strumento di controllo di ogni forma di dissidenza nelle mani dell’esecutivo. “Antonio Lucarelli – si legge nella prefazione di Giacovazzo – condivise il giudizio che Pasquale Villari aveva dato di questi eventi nelle sue “Lettere meridionali”, secondo cui dalla miseria e dall’oppressione nacquero le forme della disgregazione sociale nel Mezzogiorno: la camorra a Napoli, la mafia in Sicilia, il brigantaggio nelle altre province meridionali.” Antonio Lucarelli, Il Sergente Romano. Brigantaggio politico in Puglia dopo il 1860, Edizioni Palomar, pagina 203, euro 11,00 L’ECO DELLA STAMPA ECO STAMPA MEDIA MONITOR S.R.L. Via Compagnoni 28, 20129 Milano Tel. 02 74 81 131 Fax. 02 76 11 03 46 27 (35)
Scaricare