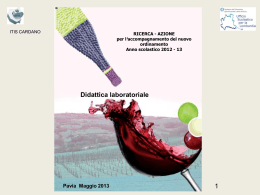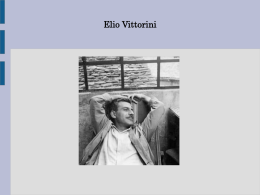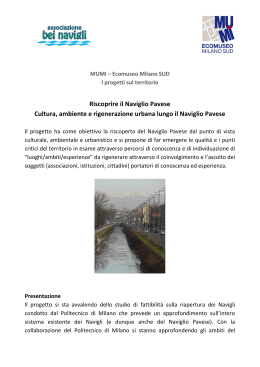UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E STORIA UNIVERSITA’ DI NAPOLI DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA MODERNA “SALVATORE BATTAGLIA” “IO ERO, QUELL’INVERNO, IN PREDA AD ASTRATTI FURORI” GIORNATA DI STUDI PER ELIO VITTORINI Cassino, 27 gennaio 2009 a cura di TONI IERMANO 1 ANTONIO CATALFAMO (UNIVERSITÀ DI MESSINA) PAVESE, VITTORINI, LA NUOVA ITALIA E IL «PARADOSSO» DELL’«IMPEGNO» Premessa Nel 2008 ricorreva il centenario della nascita di Cesare Pavese e di Elio Vittorini. Questo anniversario non è stato foriero, per entrambi, di grandi novità critiche. Ma se Vittorini, quand’era in vita – e negli anni immediatamente successivi alla morte – inaugurò una «scuola», nel senso che ebbe, in ambito letterario, molti estimatori ed imitatori, Pavese, che – com’egli stesso sottolineò in occasione dell’uscita delle poesie di Lavorare stanca – fu una delle voci più isolate del panorama letterario suo contemporaneo, com’era nel suo stile, è prevalso alla distanza. Difatti, oggi la sua opera è maggiormente studiata rispetto a quella vittoriniana, non soltanto in Italia, ma anche e soprattutto all’estero. E il centenario, pur nei limiti sopra indicati, che riguardano entrambi gli scrittori, da questo punto di vista ha rappresentato una conferma. L’ «oscuramento» nei confronti di Vittorini è stato senz’altro maggiore. Ma v’è di più. Oggi prevale nettamente, nel campo della narrativa, lo stile pavesiano su quello vittoriniano, il «filone dantesco» sul «filone petrarchesco», i quali, secondo la felice impostazione di Gianfranco Contini, hanno attraversato tutta la nostra storia letteraria, per sette secoli e più. Ma su questo punto ritorneremo più avanti. Nel corso del presente saggio, prendendo spunto dal centenario, ci proponiamo, attraverso un’analisi serrata dei testi, di individuare il ruolo che ciascuno dei due scrittori ebbe, nell’immediato secondo 2 dopoguerra, nella nascita di una nuova letteratura in Italia, dopo il periodo fascista, nonché la diversa concezione della cultura di cui essi furono portatori e degli strumenti attraverso cui lo scrittore può contribuire al cambiamento della società. Non si tratta di questione datate, ma che – com’è facile capire – si proiettano nel presente, nel modo di concepire la funzione dell’intellettuale, i suoi rapporti con le istituzioni culturali e con il potere, nonché con la massa dei lettori e con la gente comune, agli inizi di questo travagliato terzo millennio. Due biografie a confronto: «essere» e «fare» Vittorini, a quattordici anni, è precoce «agit-prop». Non solo frequenta i gruppi anarchici siracusani, ma ha anche un ruolo significativo nell’attività di propaganda e di opposizione al fascismo incipiente. A tal proposito, abbiamo una preziosa testimonianza di Alfonso Failla, seggiolaio, uno dei massimi dirigenti del movimento anarchico italiano, antifascista confinato a Ponza e a Ventotene. Egli scrive: Quando nel 1922 in Italia ebbe inizio la dittatura fascista, a Siracusa la resistenza più decisa ed intransigente andò costituendosi intorno ai gruppi anarchici locali. Composti di artigiani, contadini, operai, studenti, in gran parte giovani e adolescenti, raccolsero quanti, dopo l’esperienza dolorosa della guerra del 1915-’18, cercavano una soluzione radicale del problema sociale e delle guerre ricorrenti a scadenza sempre più ravvicinata. In uno di questi gruppi avemmo con noi il quattordicenne Elio Vittorini. Frequentava allora l’Istituto Tecnico siracusano in cui un agguerrito gruppo di giovani anarchici, Archimede Grasso, Turiddu Amenta, Michele Gallo, Luciano Miceli, alcune allieve della compagna Eva Balleriano che vi insegnava inglese, ed altri, svolgevano intensa attività ideologica anarchica insieme a una decisa agitazione antifascista che fronteggiava lo squadrismo che era apparso, come fenomeno concreto, a Siracusa soltanto dopo che il fascismo era al governo1. A. FAILLA, Elio Vittorini con gli anarchici di Siracusa, in «Il Ponte», luglio-agosto 1973, ora in P. FINZI (a cura di), Insuscettibile di ravvedimento. L’anarchico Alfonso Failla (1906-1986). Carte di polizia, scritti, testimonianze, Ragusa, La Fiaccola, 1993, p. 300. 1 3 Failla delinea il percorso umano e psicologico che ha portato Vittorini ad aderire agli ideali anarchici, dopo aver assistito ai drammi della prima guerra mondiale, con il suo carico di morti innocenti, e, poi, alla violenza delle squadracce fasciste, che si abbatte sugli oppositori: Elio Vittorini non ebbe bisogno di sforzi iniziatori perché la sua maturazione in senso rivoluzionario e libertario era avvenuta in lui attraverso l’esperienza della guerra che da noi si osservava quotidianamente sul mare prospiciente l’isola di Ortigia, con gli attacchi da parte dei sottomarini austro-tedeschi ai convogli di navi alleate; lo spettacolo dei naufraghi delle navi affondate e dei cadaveri alla deriva sospinti sugli scogli e sulle spiagge circostanti, confrontato con la retorica patriottarda degli eroi dell’«armiamoci e partite» fecero maturare precocemente molti di noi, allora meno che adolescenti. Elio ha descritto l’affondamento di una nave da lui osservato quando aveva meno di dieci anni. Di famiglia tendente alla borghesia per la condizione del padre, capostazione, Elio scelse decisamente il suo posto tra i lavoratori con i quali aveva vissuto durante le peregrinazioni all’interno della Sicilia e che amava di amore spontaneo perché la sua famiglia, come le nostre, affondava le sue origini nel popolo lavoratore isolano. Lo spettacolo indecente, vile ed abietto di popolani, e studenti figli di popolani, in camicia nera al servizio degli ultimi rampolli della nobiltà (oggi estinta nel siracusano) e della borghesia, che si davano da fare, con la protezione governativa contro le sedi operaie e contadine, contro gli oppositori del fascismo, ci empiva di sdegno e volgevamo le spalle agli antifascisti, più o meno elettorali della vigilia, che ci raccomandavano la rassegnazione. Intorno ai gruppi anarchici si strinsero tutti coloro che non volevano piegarsi al fascismo2. Failla descrive, inoltre, un Vittorini assiduo frequentatore della sua bottega d’artigiano seggiolaio – nella quale si riuniscono a discutere e a «complottare» numerosi militanti anarchici, giovani e meno giovani – , «parco di parole, profondo nei concetti»3, accanito lettore dei volumi raccolti nella biblioteca messa in piedi dai compagni («Elio scriveva sulle prime pagine bianche dei libri»4), giovane promessa dell’anarchismo, verso la quale «contadini e Ivi, pp. 300-301. Ivi, p. 301. 4 Ibidem. 2 3 4 operai sentivano amore fraterno sincero e spontaneo»5 e ne erano ricambiati dal giovane. Vittorini pagò caro il suo impegno nel movimento anarchico e nelle proteste studentesche. Nel gennaio del 1923, Giovanni Gentile, ministro della Pubblica istruzione, varò una «riforma dell’esame di Stato», che prevedeva che nelle scuole superiori non potevano più essere conseguiti diplomi senza esami, se non dagli studenti che avessero riportato negli scrutini finali dell’anno il sette in tutte le materie. Montò la protesta studentesca, così descritta da «Il Corriere di Sicilia»: I giorni 30 e 31 [gennaio, nda] furono i più turbolenti del mese, al punto da far sembrare che una piccola rivoluzione stile bolscevico fosse scoppiata in città. Gli studenti secondari della nostra città hanno continuato a scioperare per protestare contro il progetto Gentile che annienta quasi ogni probabilità nelle promozioni senza esami. Gli studenti dell’Istituto tecnico, anziché presentarsi alle lezioni, hanno bloccato i locali del LiceoGinnasio, barricandone l’entrata per impedire alle scolaresche di accedervi. Il diversivo tattico non è dispiaciuto ai liceali, i quali si sono recati all’Istituto tecnico, sbarrandone il portone6. Lo stesso giornale, il 4 febbraio, informa i lettori sull’epilogo della vicenda: Il consiglio dei Professori […] ha severamente punito parecchi studenti che sarebbero i maggiori responsabili […]. Due giovani sono stati puniti rispettivamente con 30 giorni di sospensione […]. Un altro con 65 giorni7. Lo studente che ha ricevuto la sospensione più pesante è proprio il quindicenne Vittorini, che venne rimandato a settembre in tutte le materie, si preparò da solo agli esami di riparazione e fu promosso. Gli studi dello scrittore siciliano procedono in maniera accidentata, fino alla sospensione prima del diploma. L’amicizia di Vittorini con Alfonso Failla dura per tutta la vita. Il rivoluzionario anarchico ricorda la viva emozione che provò, al Ibidem. «Il Corriere di Sicilia», 1° febbraio 1923; ora in R. CROVI, Il lungo viaggio di Vittorini. Una biografia critica, Venezia, Marsilio, 1998, pp. 32-33. 7 «Il Corriere di Sicilia», 4 febbraio 1923; ora in R. CROVI, op. cit., p. 33. 5 6 5 confino di Ventotene, assieme agli altri compagni, quando lesse Conversazione in Sicilia, cogliendone appieno le allusioni contro il regime fascista: Tra i ricordi di Vittorini che si affollano alla mia mente la gioia provata al confino, a Ventotene, durante l’ultima guerra, nell’avere tra le mani la copia di Conversazione in Sicilia meriterebbe uno scritto particolare. Intorno a quest’opera si accanì il conformismo paludato di pseudo rivoluzionarismo con il quale Elio dovrà ancora scontrarsi in avvenire. Però vi fu un’eccezione illustre. La maggior parte dei lavoratori che costituivano la collettività dei confinati ed internati politici di Ventotene sentirono subito che Elio era uno di loro, che esprimeva le loro stesse insofferenze e soprattutto non era «passatempo piccolo borghese» quel genere di letteratura. Conversazione in Sicilia fu certamente il romanzo più letto dai confinati di Ventotene negli anni 1940-’458. Pavese non ha avuto un’adolescenza politicamente turbolenta come Vittorini. A Torino frequenta il ginnasio inferiore al «Sociale», gestito con un certo rigore dai gesuiti a beneficio dei rampolli della borghesia sabauda. Secondo la testimonianza del suo compagno di banco, il futuro padre della filosofia della scienza italiana, Ludovico Geymonat, eccelle solo in italiano e studia quanto basta le altre materie. Quando esce una nuova edizione del vocabolario italiano se ne rimane a casa a studiare le nuove parole. Il professore lo perdona, a condizione che spieghi le novità linguistiche riscontrate ai compagni di classe. Pavese più che agire preferisce, oltre che leggere, osservare. Venuto dalla campagna, passa intere giornate a studiare la città, i comportamenti della gente che la popola. E qui il nostro è testimone di se stesso. Alcuni racconti e poesie, scritti negli anni successivi, ripercorrono l’esperienza adolescenziale, riproponendo il metodo tanto caro a Pavese, consistente nel «realismo simbolico», cioè nel filtrare la realtà attraverso la propria coscienza, per trarre da questo processo di razionalizzazione e di «riduzione a chiarezza» conclusioni esistenziali di carattere generale. Nel racconto La città, compreso in Feria d’agosto, così lo 8 A. FAILLA, op. cit., p. 301. 6 scrittore descrive la sua ritrosia di contadino «inurbato», che ama guardare senz’essere visto: Noialtri di campagna siamo così: ci piace guardare di là dalla siepe, ma non scavalcarla9. L’adolescente conquista, a poco a poco, con l’occhio e con la mente, la città: Dopo il primo anno, che la città ci fu meglio nota in tutte le ore e le strade, provavamo un piacere anche più vivo a guardarci d’attorno bighellonando per i fatti nostri, o aspettando su un angolo. Anche l’aria dei viali e delle singole vie adesso s’era fatta accogliente, e quel che, io almeno, non cessavo mai di godere era la faccia sempre diversa della gente sui cantoni più familiari. Tanto più bello era sapere che in certe ore bastava entrare in un caffè, fermarsi a un portone, fischiare in una viuzza, e i vecchi amici sbucavano, ci si metteva d’accordo, si andava, si rideva10. Pavese esce di casa dopo il pranzo e va in giro, da solo o con gli amici, senza lasciar detto alla madre la sua destinazione. Queste esperienze di conquista progressiva della città vengono rievocate nel racconto I mendicanti: Anni dopo Geri si fece un amico che si chiamava Achille con cui giravano per le strade qualche ora dopo la scuola, e dicevano poi a casa che ciascuno era stato in casa dell’altro a studiare. Senza Achille, Geri tutt’al più sarebbe corso nel più vicino cinematografo, dove in ciascun intervallo chiedeva ansiosamente l’ora a qualche soldato o altro spettatore. Achille invece amava mescolarsi ai passanti; e camminare fendendo la folla e volgendosi sovente a scambiare una frase con l’amico; ma sopratutto gli piacevano spedizioni che pareva inventare lì per lì e invece si capiva che già da tempo aspettava l’occasione e conosceva i luoghi. Una volta era entrare in un caffè dove frequentavano prostitute; un’altra attendere davanti alle Carceri mangiando noccioline caso mai arrivasse qualche delinquente ammanettato; un’altra ancora assistere all’uscita delle apprendiste da una grande sartoria, dove c’era del buono11. C. PAVESE, La città, in Feria d’agosto, Torino, Einaudi, 1946; ora in Tutti i racconti, a cura di Mariarosa Masoero, Torino, Einaudi, 2002, pp. 101-102. 10 Ivi, p. 100. 11 C. PAVESE, I mendicanti, in Racconti, Torino, Einaudi, 1960; ora in Tutti i racconti, cit., pp. 672673. 9 7 Pavese adolescente apprende, dunque, che in città, oltre alla gente benestante e ben vestita, ci sono i poveri, come in campagna: I poveri che gli facevano veramente pena e anche un poco d’invidia erano invece i cenciosi della strada, i vecchi dalla faccia lacrimosa da ubriaco, le donne col bambino sporco come un fagotto, ma soprattutto i suonatori ambulanti, che suonavano suonavano sull’angolo senza parlare e senza guardare, poveri che non chiedevano nulla e abbassavano gli occhi se qualcuno si fermava12. Il processo di razionalizzazione e di «riduzione a chiarezza» della realtà continua. Il Nostro scopre le dinamiche di classe, scopre le fabbriche e gli operai. Gli avvenimenti storici contemporanei (il «biennio rosso» 1919-’20, il movimento torinese de «L’Ordine Nuovo», le violenze dello squadrismo fascista) sembrano essergli estranei, ma non è così. Essi si fissano nella pellicola della mente e riemergono, a distanza di anni, nella solita chiave chiarificatrice e razionalizzante. Nella poesia Una generazione (1934) trova eco «l’eccidio di Torino», compiuto il 18 dicembre 1922 alla Barriera di Nizza dagli squadristi di Piero Brandimarte, i quali, prendendo a pretesto l’uccisione di un fascista da parte di un altro fascista per questioni di donne, ne attribuirono la responsabilità ai «rossi», lanciandosi in una serie di devastazioni e di omicidi ai danni di dirigenti sindacali e comunisti13. Protagonista della poesia è un ragazzo che va a giocare scalzo, con gli altri ragazzi che vi abitano, nei prati delle periferie urbane. Un ragazzo che guarda, ascolta, e registra nella mente gli spari lontani, provenienti dalla città, che mettono paura e fanno tacere la gente comune: Ivi, p. 672. Per una ricostruzione storica dell’eccidio, nonché delle circostanze che permettono di ricollegare ad esso la poesia di Pavese si veda: D. LAJOLO, Il «vizio assurdo». Storia di Cesare Pavese, Milano, Il Saggiatore, 1960, ma si cita dall’edizione: Milano, Oscar Mondadori, 1974, pp. 41-43. Per un’analisi approfondita delle poesie pavesiane dedicate al mondo degli operai torinesi si veda: A. CATALFAMO, Cesare Pavese e la «triade fatale»: nichilismo, solipsismo, formalismo, in A A. V V., Cent’anni di solitudine? «Rompere la crosta». Ottava rassegna di saggi internazionali di critica pavesiana, a cura di A. CATALFAMO, Santo Stefano Belbo (Cuneo), I Quaderni del CE.PA.M., 2008, pp. 22-35. 12 13 8 Un ragazzo veniva a giocare nei prati dove adesso s’allungano i corsi. Trovava nei prati ragazzetti anche scalzi e saltava di gioia. Era bello scalzarsi nell’erba con loro. Una sera di luci lontane echeggiavano spari, in città, e sopra il vento giungeva pauroso un clamore interrotto. Tacevano tutti. Le colline sgranavano punti di luce sulle coste, avvivati dal vento. La notte che oscurava, finiva per spegnere tutto e nel sonno duravano solo freschezze di vento14. Il cervello dell’adolescente (Pavese, all’epoca dei fatti, ha dodici anni) registra, come «flashes», i particolari e li riproduce a distanza di tempo, anche notevole: le macchie di sangue ricoperte, al mattino, sulle strade, la vita che ritorna in città ai suoi ritmi consueti. Ma il ragazzo attende la notte per ascoltare nuovi «clamori», che gli fanno presagire fatti drammatici, altri eccidi efferati compiuti al buio dal regime, altri arresti: In prigione c’è operai silenziosi e qualcuno è già morto15. E i misfatti del regime si ripetono, anche a distanza di anni dall’ «eccidio» del lontano 18 dicembre 1922: In prigione ci sono gli stessi. E ci sono le donne come allora, che fanno bambini e non dicono nulla16. Vittorini è stato ampiamente coinvolto con la cultura fascista, attraverso la collaborazione alle riviste del regime, come «Il Bargello», settimanale della federazione fascista di Firenze, diretto da Alessandro Pavolini, futuro responsabile del Ministero della Cultura Popolare, il famigerato Minculpop. Dal ’31 al ’37, lo scrittore C. PAVESE, Una generazione, in Lavorare stanca, Firenze, «Solaria», 1936; ma si cita da Le poesie, Torino, Einaudi, 1998, p. 55. 15 Ibidem. 16 Ibidem. 14 9 siciliano affida a questa rivista note politiche, di critica letteraria, cinematografica, artistica, traendone il proprio sostentamento, seppur attraverso mille ristrettezze economiche. Egli appartiene a quello che è stato definito «fascismo di sinistra», collocato su posizioni anticonformiste e di «fronda», oculatamente sfruttato dallo stesso regime per darsi una copertura culturale e una dimensione «socialisteggiante», nonché per assorbire al proprio interno eventuali dissensi. Difatti, nel ’36 pubblica su «Il Bargello» un articolo in cui esalta il «corporativismo» in senso antiproprietario, anticapitalistico e collettivistico: Tale è l’essenza del capitalismo: salvarsi individualmente, fabbricarsi ognuno un cartello di sicurezza personale. Mentre l’idea corporativa non ammette che le salvezze collettive, ed è a questa idea di salvezza collettiva, di sicurezza per tutto il popolo, che devono essere riservate […] le possibilità economiche dell’Etiopia17. Vittorini pubblica, inoltre, sul «Bargello», una serie di interventi politico-culturali incentrati sul problema del rapporto tra mondo della cultura e mondo del lavoro e sulla necessità di una formazione culturale uguale per tutti, di una cultura unitaria e popolare, che miri all’elevazione spirituale dell’uomo. La guerra di Spagna apre gli occhi allo scrittore siciliano, così come a tanti altri giovani, ed egli progetta con Pratolini di raggiungere i fuoriusciti antifascisti che difendono la Repubblica. Sfuggendo miracolosamente alle maglie della censura, riesce a pubblicare un articolo in cui esorta i giovani fascisti a schierarsi contro Franco per coerenza con i loro ideali rivoluzionari. E’ minacciato di assegnazione al confino ed espulso dal partito fascista. Ma la sua analisi del fenomeno fascista non è di natura storica, bensì morale. Ha scritto giustamente Carlo Salinari: Tra il 1937 ed il 1940, di fronte alla crisi spagnola e a quella che portò alla seconda guerra mondiale, di fronte alla prepotenza che sembrava premiata, alla forza che sembrava prevalere sul diritto, alla barbarie che sembrava oscurare la civiltà, il problema del fascismo e dell’antifascismo E. VITTORINI, Ragioni dell’azienda collettiva, in «Il Bargello», a. VIII, n. 40, maggio 1936; citato in A. ASOR ROSA, Scrittori e popolo, Roma, Samonà e Savelli, 1972, p. 122. 17 10 si trasferisce dal piano della politica a quello della morale, dal piano della storia a quello delle categorie universali. Il mondo si divide in uomini e non uomini: uomini che sono i perseguitati, non uomini quelli che perseguitano; uomini sono coloro che hanno coscienza di doveri che trascendano la loro persona, e le leggi della società costituita, non uomini coloro che sono fermi ai propri interessi. La miseria, la malattia – nella forma drammatica con cui si presenta presso i poveri – la guerra, l’oppressione sono tutti aspetti della persecuzione. E con la persecuzione coincide il fascismo: che è appunto violenza, soppressione della libertà, miseria, guerra, non essere uomini18. Da questo punto di vista, l’«ideologia» di Vittorini non è innovativa rispetto a quella che ha preceduto il fascismo e, per certi aspetti, lo ha accompagnato. Egli continua a ragionare, crocianamente, in termini di «categorie universali», parla genericamente di «uomini», che sfuggono a qualsiasi determinazione sociale e classista, di valori che sembrano eterni. Salinari non è d’accordo con noi sul riferimento a Croce, perché, secondo lui, ciò che distinguerebbe lo scrittore siciliano dal filosofo sarebbe un «libertarismo» e un «umanitarismo»19, anch’essi generici, che, come tali, non bastano, a nostro avviso, a recidere il cordone ombelicale con le concezioni filosofiche «neoidealistiche» e crociane e a contribuire a quello svecchiamento della cultura italiana che la Resistenza impose. Ben diversa – come vedremo – è la posizione di Pavese. Salinari evidenzia, però, un importante punto di contatto tra l’«ideologia» di Vittorini e quella liberale e crociana: l’interpretazione soggettiva del fascismo, che non gli permette di scorgerne le basi oggettive, le quali rivelavano già allora alle coscienze più aperte ed attente il suo carattere di classe, di reazione violenta delle classi proprietarie per rendere impossibile l’avvento al potere delle classi lavoratrici. Vittorini, così, si lascia sfuggire l’essenza storica più profonda del fascismo che pure era stata analizzata non solo da Gramsci, ma intuita da Gobetti, e, ad un certo momento, fatta propria da Carlo Rosselli: e questo nonostante che sulla natura del fascismo si fosse creato in quegli C. SALINARI, L’ideologia di Vittorini, in La questione del realismo, Firenze, Parenti, 1960, pp. 159160. 19 Ivi, p. 160. 18 11 anni un giudizio comune di tutta la sinistra italiana, dai comunisti al movimento di Giustizia e Libertà. Egli, in sostanza, si limita – sia pure con un accento particolare – alla condanna morale del regime poliziesco, del malcostume, dell’ingiustizia, del fascismo come male, come offesa, come violenza, restando fuori dal movimento imponente di critica radicale al regime borghese e alle sue stesse basi che pure si andava sviluppando negli stessi anni e rimanendo disponibile – non appena esaurita l’urgenza della lotta antifascista – verso le suggestioni liberali e libertarie. Per lui si potrebbe ripetere – pur nei mutati termini storici – quel che Lenin rimproverava agli amici del popolo: di non aver compreso come non fosse sufficiente «mostrare l’oppressione delle masse nel regime esistente», vagheggiare un regime ideale che corrispondesse «alla natura umana, al concetto di una vita razionale e giusta», come fosse dannoso e inutile domandarsi in astratto che cosa sia la società, che cosa sia il progresso, che cosa sia l’uomo, come non siano gli ordinamenti giuridico-politici (il potere con la sua violenza) a determinare gli ordinamenti economici, ma viceversa20. Secondo Salinari, i limiti «ideologici» sopra esposti si manifestano anche in Conversazione in Sicilia, che dovrebbe sancire una svolta nel pensiero di Vittorini: Vittorini, dunque, già in Conversazione in Sicilia ha una concezione non storica del fascismo, una concezione categoriale, che trasforma il fascismo in una categoria del bene e del male, sottratto al tempo e allo spazio; a cui si deve opporre la vera natura umana e la coscienza di nuovi doveri. Vale a dire una concezione di piccolo-borghese (e qui piccolo-borghese vuol essere solo una definizione storica e non un giudizio di valore) della quale gli atteggiamenti libertari e umanitari (che notoriamente hanno radici e caratteristiche di quel genere) sono manifestazioni illuminanti21. Vittorini passa al fronte opposto, diventa comunista e prende parte attiva alla lotta clandestina ed alla Resistenza. Entra in contatto con Pajetta, Ingrao, Negarville, Banfi e viene arrestato, il 26 luglio 1943, dai badogliani. Dopo l’armistizio dell’8 settembre si occupa della composizione tipografica e della diffusione clandestina del giornale comunista «L’Unità», sul quale pubblica l’articolo Tedeschi e fascisti complottano contro il nostro paese. Diviene amico di 20 21 Ivi, pp. 161-162. Ivi, p. 162. 12 Eugenio Curiel e partecipa alla fondazione del Fronte della Gioventù. Rifugiatosi in montagna, scrive Uomini e no. Nei giorni a cavallo della Liberazione e per qualche mese diviene redattore capo dell’edizione milanese de «L’Unità» e diventa in seguito direttore di «Milano sera». E’, dunque, organicamente legato al Partito comunista italiano, tanto da essere candidato nelle sue file alle elezioni per la Costituente (1946), nel collegio di Milano. Cesare Pavese, a differenza di Vittorini, non è stato per nulla coinvolto nella politica culturale del regime fascista e nella collaborazione alle principali riviste attraverso le quali essa è stata diffusa. Nel ’35, mentre si accinge a sostenere gli esami per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola pubblica, viene arrestato, non per l’ «amore di una donna», come è stato detto e ripetuto, disconoscendo importanti documenti probatori in senso contrario, ma in quanto legato al gruppo di intellettuali antifascisti che ruotavano attorno alla casa editrice Einaudi e alla rivista «La Cultura», da lui stesso diretta. La polizia fascista è ben informata sul ruolo di ciascuno, perché ha un infiltrato d’eccezione, lo scrittore Pitigrilli. Viene condannato al confino, da scontare a Brancaleone Calabro. Al ritorno non ottiene nessuno sconto dal regime, tanto che non può insegnare nella scuola pubblica e viene assunto in una scuola privata, il liceo «Giacomo Leopardi», dall’ex compagno di banco Ludovico Geymonat. Continua a frequentare gli ambienti antifascisti e comunisti. Ma Pavese – anche qui a differenza di Vittorini – non è un uomo d’azione. Quando i suoi amici salgono in montagna per partecipare alla Resistenza, si rifugia nel Monferrato, tra Casale e Serralunga di Crea, dove svolge le mansioni di istitutore presso il collegio «Trevisio», gestito dai padri somaschi. Il periodo monferrino, però, non si svolge all’insegna del completo isolamento. Pavese entra in contatto con alcuni partigiani che operano «in loco» e pubblica tre articoli su «La Voce del Monferrato», firmandoli Partito Comunista. Subito dopo la Liberazione inizia la sua collaborazione all’edizione torinese de «L’Unità», animata da Davide Lajolo (il comandante «Ulisse» della guerra partigiana), con un articolo intitolato Ritorno all’uomo. 13 Pavese non ragiona in base a categorie «universali» ed «astratte». L’uomo di cui egli parla è l’uomo storico, che vive in un determinato contesto economico-sociale, e cerca attraverso la letteratura la soluzione di problemi concreti. Egli scrive: Altro è l’uomo, altro gli uomini. Ma è del resto una sciocca leggenda che poeti, narratori e filosofi si rivolgano all’uomo così in assoluto, all’uomo astratto, all’Uomo. Essi parlano all’individuo di una determinata epoca e situazione, all’individuo che sente determinati problemi e cerca a modo suo di risolverli, anche e soprattutto quando legge romanzi. Sarà dunque necessario, per capire i romanzi, situarsi nell’epoca e proporsi i problemi22. Lo scrittore langarolo analizza in fenomeno fascista in chiave classista già in uno dei tre articoli succitati, scritti nel periodo trascorso nel Monferrato dopo l’armistizio dell’8 settembre 43, e firmati per conto del Partito comunista. L’articolo si intitola Il Nemico non è morto23 e in esso Pavese denuncia il sostegno dato al fascismo dal padronato italiano, il quale, quando le sorti della guerra s’invertirono, «cambiò cavallo» e sostenne certi settori dell’antifascismo, pronto, in qualsiasi momento, a «voltare gabbana», per l’ennesima volta, quando i suoi interessi saranno contrastati, com’è inevitabile che avvenga nel nuovo assetto istituzionale e sociale determinato – o, meglio, che dovrebbe essere determinato – dalla lotta di Liberazione. Egli scrive, appunto, del fascismo: Non è morto, perché gli sopravvivono certi gruppi e persone [che ne hanno fi]nanziati gli inizi, giustificati gli arbitrii e le violenze, sostenuto le prime usurpazioni, e in seguito, quando esso s’impadronì di tutta la Nazione e pretese di essere diventato la Nazione, ne sfruttarono le posizioni di monopolio, in combutta coi gerarchi, lasciando ad essi la ribalta del potere e contentandosi dei profitti. Questi ceti, questi gruppi e queste persone hanno sempre saputo, meglio degli antifascisti, che il fascismo non era altro che una banda C. PAVESE, Leggere, articolo pubblicato su «L’Unità» di Torino, 20 giugno 1945; ora in La letteratura americana e altri saggi, a cura di I. CALVINO, Torino, Einaudi, 1951; ma si cita sin d’ora dall’edizione: Milano, Il Saggiatore, 1978, p. 217. 23 ID., Il Nemico non è morto, in «La Voce del Monferrato», Ufficiale per gli Atti del Comitato di Liberazione Nazionale, a. I, n. 1, Casale Monferrato, 4 maggio 1945, p. 1. 22 14 armata incaricata di terrorizzare il popolo italiano per meglio sfruttarne le braccia e la volontà. E finché il sistema rappresentò un buon affare, finché le gerarchie servirono ad appoggiare e coprire i loro privilegi e le loro rapine, non si commossero. Non si commossero quando l’innaturale avvicinamento ai tedeschi diede i suoi primi frutti e produsse la persecuzione razziale. Non si commossero quando la guerra finalmente scatenata dalle insane provocazioni dei due dittatori coinvolse il nostro paese. Non si commossero quando le prime bombe cominciarono a cadere e far vittime innocenti. Le vittime servirono anzi alla propaganda ufficiale dell’entusiasmo e dell’odio. Ma il giorno in cui il popolo italiano per non dubbi segni manifestò di averne abbastanza e di cominciare a capire, a osar di capire, questi ceti e queste persone seppero fare il voltafaccia e darsi l’aria di combattere il fascismo andando (anche loro!) verso il popolo. In realtà andavano e vanno in cerca di nuovi profitti e di nuovi privilegi. Venne l’8 settembre e la reazione repubblicana. Ma questi signori sono troppo astuti per appoggiarsi a un trave tarlato e seppero tenersi in disparte; anzi seppero giudiziosamente barcamenarsi e perfino caldeggiare e finanziare movimenti di resistenza. Qualcuno di loro potrà anche presentarvi il consuntivo delle angherie sofferte. Il fascismo non è morto! Gli antifascisti, e cioè i lavoratori, devono stare in guardia. E’ bastato il combattimento, l’aperto combattimento per le montagne, per le colline e sulle strade, a sbaragliare i briganti neri, che come tutti i feroci erano essenzialmente stupidi. Ma stupidi non sono i ceti e i gruppi che a suo tempo finanziarono il fascismo. Non sono stupidi e non sono morti. Se costoro hanno mollato il fascismo, è perché non rendeva più. Ora finanziano la libertà, perché li libera dall’incomodo. Ma guai a toccar loro le posizioni acquisite nel famoso ventennio. Vi diranno che le hanno occupate e difese per sottrarle al fascismo. E per difenderle ne faranno un altro. Il Comitato del Partito comunista Questi concetti non sono isolati, vengono ripresi da Pavese nel saggio Il comunismo e gli intellettuali, che risale al 194624, nel quale leggiamo, sempre a proposito del «trasformismo» del padronato italiano: ID., Il comunismo e gli intellettuali, inedito, datato 14-16 aprile 1946, di cui si ignora la destinazione; ora in La letteratura americana e altri saggi, cit., pp. 223-232. 24 15 Esiste ora in Italia una precisa situazione – una struttura istituzionale e produttiva molto scossa, interessi e persone sopravvissuti a una bufera che doveva spazzarli e invece li ha soltanto storditi – questi interessi si riorganizzano, sono gli stessi che han voluto o tollerato che si desse il colpo di grazia alla nostra prima malaticcia democrazia prefascista, sono dispostissimi a rifarlo un’altra volta e per gli stessi comprensibili motivi25. Il saggio riprende anche l’idea, espressa nell’articolo già citato, che le forze economiche reazionarie, che «ora finanziano la libertà», reagiranno ferocemente, mostrando il loro vero volto, allorquando saranno toccati i privilegi da esse acquisite nel corso del ventennio fascista. Leggiamo, difatti, in esso: Va da sé che in quest’opera [di rinnovamento del Paese, di cui il Partito Comunista dev’essere il perno, nda] si prenderanno decisioni che offenderanno quei tali interessi e quelle tali persone che tutti sappiamo; si faranno delle leggi che non a tutti torneranno comode; si spazzeranno molte stalle e palazzi26. Il saggio del ’46 riprende, infine, l’idea, già contenuta nell’articolo Il nemico non è morto, che è il fascismo ad «andare verso il popolo» per fare demagogia, mentre gli intellettuali comunisti «sono popolo». Scrive in esso Pavese : Ora, in questo atteggiamento è latente un pericolo: quello di «andare verso il popolo». Specialmente in Italia. Verso il popolo ci vanno i fascisti. O i signori. E «andarci» vuol dire travestirlo, farne un oggetto dei nostri gusti e delle nostre degnazioni. Libertà non è questo. Non si va «verso il popolo». Si è popolo. Anche l’intellettuale, anche il «signore», che soffrono e vivono l’elementare travaglio del trapasso da una civiltà d’impedimento e di spreco a quella organizzata nella libertà della tecnica, sono popolo e preparano un governo di popolo. Che è ciò che vuole il comunismo. Democrazia significa questo governo27. Non troviamo in Pavese gli «astratti furori» di Vittorini, che pure egli vanta come elementi peculiari della poetica dello scrittore Ivi, p. 227. Ivi, p. 228. 27 Ivi, p. 232. 25 26 16 siciliano. Quest’ultimo è un «intuitivo»: ha intuito, innanzitutto, che l’«autarchia» culturale praticata dal fascismo è una «camicia di forza» destinata a saltare e che il mito dell’America e della libertà è veramente suggestivo per le nuove generazioni. Lo stesso Pavese, in una lettera del 27 maggio 1942, riconosce il legame tra la pubblicazione, da parte di Vittorini, dell’antologia Americana – seppur «corretta» attraverso l’introduzione «canagliesca» di Emilio Cecchi, imposta dalla censura di regime per annacquare il mito americano che da essa emergeva – e la poetica degli «astratti furori» che sta alla base di Conversazione in Sicilia: Caro Vittorini, ti sono debitore di questa lettera perché penso ti faccia piacere sentire che siamo tutti solidali con te contro Cecchi. La sua introduzione è canagliesca – politicamente e criticamente – e tutto il pregio e il senso dell’Americana dipende dalle tue note. In dieci anni dacché sfoglio quella letteratura non ne avevo ancora trovata una sintesi così giusta e illuminante. Voglio dirti questo, perché certamente quando le tue note correranno il mondo in Piccola storia della cultura poetica americana, salterà su chi rileverà che esse sono estrose sì ma fantasiose. Ora, va gridato che appunto perché fanno racconto, romanzo se vuoi, invenzione, per questo sono illuminanti. Lascio stare la giustezza dei singoli giudizi, risultato di altrettante intime monografie informatissime, e voglio parlare del gioco tematico della tua esposizione, del dramma di corruzione purezza ferocia e innocenza che hai instaurato in quella storia. Non è un caso né un arbitrio che tu la cominci con gli astratti furori, giacché la sua conclusione è, non detta, la Conversazione in Sicilia. In questo senso è una gran cosa: che tu vi hai portato la tensione e gli strilli di scoperta della tua propria storia poetica, e siccome questa tua storia non è stata una caccia alle nuvole ma un attrito con la lett. mondiale (quella letterat. mondiale che è implicita, in universalità, in quella americana – ho capito bene?), risulta che tutto il secolo e mezzo americ. vi è ridotto all’evidenza essenziale di un mito da noi tutti vissuto e che tu ci racconti. […] In 50 pagine hai scritto un gran libro. Non devi insuperbirti, ma per te esso ha il senso e il valore che doveva avere per Dante il De Vulgari. Una storia letteraria vista da un poeta come storia della propria poetica28. C. PAVESE, Lettera a Elio Vittorini del 27 maggio 1942, ora in Officina Einaudi. Lettere editoriali 1940-1950, Torino, Einaudi, 2008, pp. 51-52. 28 17 Vittorini ha intuito, inoltre, che l’Italia ha bisogno di una letteratura nuova, nelle forme e nei contenuti, ma le soluzioni da lui adottate, su l’uno e sull’altro fronte, non sono in grado di assicurare quella rottura netta con il passato ottocentesco e primonovecentesco che la nuova realtà, nata dai fermenti della Resistenza e della Liberazione, impone. Sul piano formale, Vittorini s’inserisce in quello che Contini ha definito il «filone petrarchesco» della letteratura italiana, pervenendo ad una lingua «aulica», determinando uno stile – il «vittorinismo», appunto – che è risultato vincente. Pavese s’inserisce, invece, nel «filone dantesco», usa una lingua «mescidata», che attinge ampiamente al dialetto, pervenendo ad una soluzione che richiama la «tecnica della bilancia» verghiana: abbassa, da un lato, la lingua e innalza, dall’altro, il dialetto. Pavese, rispetto a Vittorini, ha avuto ben pochi seguaci, non ha certo inaugurato uno «stile» diffuso, anche se si avverte, a partire dall’ultimo scorcio del Novecento, una parziale inversione di tendenza. Sul piano contenutistico ed «ideologico», Vittorini rimane legato – come abbiamo rilevato – a concetti «astratti» ed «universali», come «uomo», «natura», «letteratura», che sfuggono ad ogni determinazione storica, spazio-temporale. E’ sempre Pavese a sottolineare i limiti di Vittorini, la sua «fretta», il suo fermarsi all’«intuizione», all’«azionismo», alla «voglia di fare» ad ogni costo. In una pagina diaristica del 29 dicembre 1949, egli annota: La fama americana di Vitt. ti ha fatto invidioso? No. Io non ho fretta. Lo batterò sulla durata. In fondo Vitt. è stato la voce (anticipata – questo è il grande) del periodo clandestino – amori nudi e vitali, astratti furori che s’incarnano, tutti in missione eroica. Ha sentito l’epoca e le ha dato il suo mito. Come D’Annunzio presentì l’epoca «imperiale» e la «civiltà letteraria» del ventennio. Entrambi sono e furono stoffa di portavoce. Crearono uno stile di vita, di discorso, di sentire, di fare. Tu miri a uno stile di essere29. ID., Il mestiere di vivere (Diario 1935-1950), Torino, Einaudi, 1952; ma si cita sin d’ora dall’edizione Einaudi 2000, p. 382. 29 18 A questo punto è necessaria una precisazione. Per Pavese creare uno «stile di essere» non significa cadere nell’«estetismo», costruire la propria vita come un’opera d’arte, al pari di D’Annunzio, appunto. Difatti egli scrive in una nota diaristica del 7 maggio 1949: In qualunque mestiere e professione si può vivere secondo il cliché del mest. o profess., «facendo» quella parte. Da scrittori e artisti no. Si sarebbe bohémiens, fessi e insopportabili. Perché? Perché l’arte e lo scrivere non sono mestieri. Almeno in quest’epoca30. E’ questa la migliore risposta a quanti, in questi anni, hanno descritto Pavese come un «uomo-libro», che identifica «arte di scrivere» e «arte di vivere»31, prescindendo da quella ch’egli stesso ha definito «realtà rugosa». L’essere di Pavese s’identifica con la costruzione non «artificiosa» della propria personalità, bensì realizzata attraverso un processo razionale che ha come punto di partenza e di arrivo la realtà concreta. Egli «introietta» la realtà, la sottopone ad un processo di riflessione critica e di «riduzione a chiarezza», alla luce della ragione e dell’esperienza interiore, cosciente o sub-cosciente (tra i suoi progetti c’è anche quello dell’analisi razionale dell’inconscio). Segue un processo di «estroversione». Dal processo di «introversione» e di «razionalizzazione» il Nostro ricava, difatti, una concezione generale del mondo, che non tiene per sé, ma offre all’intera collettività come strumento per cambiare la società. Se si può parlare di «esistenzialismo» a proposito di Pavese, punto di riferimento ideologico dev’essere per noi il pensiero del giovane Luporini, nella sua fase «esistenzialista», che lo scrittore langarolo cita in una pagina del diario (17 settembre 1942)32, richiamando significativamente un capitolo, intitolato Responsabilità e persona, di Situazione e libertà nell’esistenza umana33. Per Luporini – e per Pavese – l’armonia dell’individuo con il mondo circostante non dipende dall’assunzione di un atteggiamento passivo da parte del Ivi, p. 370. S. PAUTASSO, Cesare Pavese oltre il mito. Il mestiere di scrivere come mestiere di vivere, Genova, Marietti, 2000. 32 C. PAVESE, Il mestiere di vivere, cit., p. 244. 33 C. LUPORINI, Situazione e libertà nell’esistenza umana, Firenze, Le Monnier, 1942, pp. 143-147. 30 31 19 singolo. Egli, al contrario, attraverso tutta una serie di «atti di volontà», interviene nella realtà e qualifica il suo «essere nel mondo» – per usare un’espressione tanto cara agli esistenzialisti – , dà concretizzazione ai suoi «valori», dai quali emerge la sua concezione generale del mondo. Così possiamo comprendere le riflessioni di Italo Calvino34 sul «fare» di Pavese, che, inteso come abbiamo chiarito, non è in contrasto con l’«essere», ma è una sua estrinsecazione e concretizzazione. Anche lo «scoiattolo della penna», con riferimento al suo maestro, parla di un processo lento e travagliato di «autocostruzione»35 razionale della propria personalità, di «ostinata autodefinizione»36, per pervenire ad uno stile di vita, che Calvino configura giustamente come «scelta d’un sistema di coordinate essenziali per esprimere» il suo «rapporto col mondo»37. L’«autocostruzione» non è, dunque, fine a se stessa, semplice atto «estetico». Essa mira al fare, all’azione concreta per intervenire nella realtà e modificarla, in concorso con gli altri uomini. In altri termini, ad esplicitare un modo d’«essere tragico», laddove la tragicità deriva dal non sentirci in armonia col mondo esterno, che determina la lotta, il conflitto per cambiarlo. Lo stesso Pavese, in una pagina del diario, datata 20 aprile 1936, parla di questa dimensione tragica: La lezione è questa: costruire in arte e costruire nella vita, bandire il voluttuoso dall’arte come dalla vita, essere tragicamente38. E’ sempre Calvino a spiegarci come l’«essere tragicamente» pavesiano si concretizzi nel «fare»: Essere tragicamente vuol dire condurre il dramma individuale – anziché spenderlo come moneta spicciola – a una forza concentrata che impronti di sé ogni tipo di azione, d’opera, ogni fare umano, vuol dire trasformare il fuoco d’una tensione esistenziale in un operare storico, fare della sofferenza o della felicità privata, queste immagini della nostra morte I. CALVINO, Pavese: essere e fare, in «L’Europa letteraria», n. 5-6, dicembre 1960; ora in Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, Torino, Einaudi, 1980, pp. 58-63. 35 Ivi, p. 58. 36 Ivi, p. 59. 37 Ivi, p. 58. 38 C. PAVESE, Il mestiere di vivere, cit., p. 34. 34 20 (ogni felicità individuale, in quanto porta in sé la fine, ha una controparte di dolore), degli elementi di comunicazione e di metamorfosi, cioè delle forze di vita39. Pavese conduce un’operazione che è insieme «poetica e morale» e che consiste, appunto, nel trasferimento di valori dall’essere nel fare, dalla vita nell’opera, dall’esistenza nella storia. Pavese appartiene a una stagione della cultura mondiale tesa a integrare l’esperienza esistenziale con l’etica della storia40. E allora il suo pensiero e la sua opera vanno letti come quelli dei grandi tragici del mondo classico: Pavese ci sollecita a un modo di lettura di cui purtroppo la letteratura contemporanea ci dà occasioni più uniche che rare: cioè vuole essere letto come si leggono i grandi tragici, che in ogni rapporto, in ogni movimento dei loro versi condensano una pregnanza di motivazioni interiori e di ragioni universali estremamente compatta e perentoria. E’ un modo di inserirsi nel reale e viverlo e giudicarlo che abbiamo concretamente perduto; e nell’averlo – per sue vie laboriose e solitarie – raggiunto, sta il valore unico di Pavese oggi nella letteratura mondiale41. Anche se può sembrare paradossale, «essere» e «fare» hanno coinciso anche nell’ultima, tragica fase della vita dello scrittore. E’, ancora una volta, Calvino a testimoniarlo: La morale dei suoi classici, la morale del fare, Pavese riuscì a renderla operante anche nella propria vita, nel proprio lavoro, nella partecipazione al lavoro degli altri. Per noi che lo conoscemmo negli ultimi cinque anni della sua vita, Pavese resta l’uomo dell’esatta operosità nello studio, nel lavoro creativo, nel lavoro dell’azienda editoriale, l’uomo per cui ogni gesto, ogni ora aveva una sua funzione e un suo frutto, l’uomo la cui laconicità e insocievolezza erano difesa del suo fare e del suo essere, il cui nervosismo era quello di chi è tutto preso da una febbre attiva, i cui ozi e spassi parsimoniosi ma assaporati con sapienza erano quelli di chi sa lavorare duro. Questo Pavese non è men vero dell’altro, del Pavese I. CALVINO, Pavese: essere e fare, cit., p. 61. Ivi, pp. 61-62. 41 Ivi, p. 63. 39 40 21 negativo e disperato, e non è solo consegnato ai ricordi degli amici, e a un’attività al di fuori delle pagine scritte; era quello l’uomo che «faceva», l’uomo che scriveva i libri; i libri della maturità portano questo segno di vittoria e addirittura di felicità, sia pur sempre amara. C’è pure una storia della felicità di Pavese, d’una difficile felicità nel cuore della tristezza, d’una felicità che nasce con la stessa spinta dell’approfondirsi del dolore, fin che il divario è tanto forte che il faticoso equilibrio si spezza42. L’intellettuale, la letteratura e il partito: il caso «Politecnico» Arriviamo all’immediato secondo dopoguerra. Vittorini fonda il «Politecnico». In polemica con Palmiro Togliatti, contesta la concezione dell’ «intellettuale organico» di gramsciana memoria. Dopo varie schermaglie, il confronto più diretto tra il segretario del Pci e lo scrittore siciliano si ebbe nei numeri 33-34 (settembredicembre 1946) della rivista, che ospitano un articolo di Togliatti, e nel numero 35 (gennaio-marzo 1947), che pubblica la famosa Lettera a Togliatti di Vittorini. C’è un passaggio, nell’intervento di quest’ultimo, che evidenzia quanto poco innovativa e realistica sia la sua posizione: Rivoluzionario è lo scrittore che riesce a porre attraverso la sua opera esigenze rivoluzionarie diverse da quelle che la politica pone; esigenze interne, segrete, recondite dell’uomo ch’egli soltanto sa scorgere nell’uomo, che è proprio di lui scrittore scorgere, e che è proprio di lui scrittore rivoluzionario porre, e porre accanto alle esigenze che pone la politica, porre in più delle esigenze che pone la politica43. Va, inoltre, ripresa l’affermazione vittoriniana secondo la quale la politica fa «cronaca», mentre la cultura fa «storia». Tutta una serie di influenze del passato si assommano nel brano sopra citato. Innanzitutto la pretesa illuministica della «superiorità» dell’intellettuale, dotato di un «naturale diritto a dirigere», della capacità di trovare soluzioni universali, che valgano, cioè, per tutti. In secondo luogo, il mito decadente del «poeta-vate», il quale, grazie ad una sorta di potere medianico di comunicare – egli solo – con un Ivi, p. 60. E. VITTORINI, Lettera a Togliatti, in «Politecnico», n. 35, gennaio-marzo 1947, ora in G. GRONDA (a cura di), Per conoscere Vittorini, Milano, Mondadori, 1979, p. 287. 42 43 22 mondo superiore, è in grado di cogliere i «nessi segreti» della realtà, che sfuggono agli altri uomini. E ancora: il mito anarchico – che trova radici nella formazione giovanile – dell’intellettuale isolato che si affida alla «propaganda del gesto». Infine, il «vitalismopopulismo» dei «vociani» e il «messianesimo culturale» degli «unitari» di Salvemini, che, secondo Gramsci, si rivolgono indistintamente a «tutti gli uomini di buona volontà», nella convinzione che, spiegando loro come stanno veramente i fatti, essi si convincano e convertano al cambiamento. Tutto ciò dimostra che l’illusione del «partito degli intellettuali», su cui la nostra storia culturale si è dipanata dal Settecento al Novecento, è tutt’altro che infranta. Anche Franco Fortini fu fautore dell’ «autogoverno degli intellettuali», della loro «autonomia culturale» da qualunque organizzazione di massa.. Se si identifica, come fa Vittorini, la «civiltà» con la «cultura», l’intero processo storico finisce per essere ricondotto ad una dialettica di posizioni intellettuali; e così si scambia la battaglia delle idee per i valori supremi della civiltà, cui riportare tutte le scelte politiche, economiche e sociali. E’ questo l’ «idealismo utopistico» di Vittorini. Il pericolo della sua proposta sta nel fideismo, nell’illusione che la cultura possa modificare da sola le strutture, che le innovazioni formali e la carica morale pedagogica possano influire sulla società sì da trasformarla. E’ questa l’eredità del crocianesimo che lo porta a usare categorie universali e «metastoriche» come «uomo», «cultura», «civiltà». Se Togliatti è un «loico sottile», Vittorini è un «passionale»44. In lui prevalgono la «passionalità», l’ «astratto intellettualismo», il «radicalismo», che è anche quello dei personaggi dei suoi romanzi. Dalla polemica tra il segretario del Pci e lo scrittore siciliano nacque un dibattito a largo raggio, nell’ambito della sinistra italiana, sulla funzione degli intellettuali e sul loro rapporto con i partiti. Ci sembra meritevole di menzione, per il suo equilibrio, l’intervento di Cesare Luporini, pubblicato sul n. 5 di «Società» (1946), che fornisce la giusta impostazione del rapporto tra politica e cultura. Se «nuova G. PETRONIO, Racconto del Novecento letterario in Italia (1890-1990), Milano, Oscar Mondadori, 2000, vol. II, pp. 63-66. 44 23 cultura» significa «nuovo rapporto di ciascuno di noi, come uomini, con la propria cultura, ossia con la cultura della propria epoca» (che dunque si fa «ipso facto» vecchia cultura), c’è da chiedersi come sia possibile formulare il disagio da cui scaturisce l’esigenza del nuovo, mediante i mezzi della vecchia cultura, che sono ancora gli unici disponibili. In altri termini, se la cultura è «autosufficiente», «autonoma» dalla storia economica e sociale di un Paese (com’è nell’impostazione «idealistica» di Vittorini), allora una nuova cultura richiede un’analisi critica della vecchia cultura, che paradossalmente dovrebbe realizzarsi con i vecchi strumenti analitici, che sono gli unici a disposizione dell’uomo. Per uscire da questo vicolo cieco, secondo Luporini, bisogna far coincidere la cultura con la stessa «storicità» dell’uomo, con la sua lotta nella società per imporre determinati rapporti economici. Sicché la crisi di una cultura è la crisi della società di cui essa è espressione, dei rapporti di classe che ne stanno alla base. Ed è questa crisi delle vecchie strutture socio-culturali ad imporre una nuova società e una nuova cultura. L’uomo di cui stiamo parlando non è l’uomo «astratto», «universale», ma l’uomo «storico» con ben determinati connotati di classe. Questa visione classista è estranea alla concezione di Vittorini. Il Pci togliattiano fu accusato di aver decretato la morte del «Politecnico», ma la rivista rimase vittima delle proprie contraddizioni, della confusione programmatica che la caratterizzò. Il progetto iniziale era addirittura di creare una rivista «sperimentale» fatta insieme da intellettuali ed operai, affissa come foglio murale nelle fabbriche. Ma l’ipotesi sperimentale di Vittorini fallisce, perché alla base di essa c’è ancora una concezione della cultura «autonoma» e «privilegiata» rispetto alla prassi, dotata di una sua propria carica «rivoluzionaria», una sua propria capacità di «intervento diretto» nella trasformazione della realtà sociale. Inevitabili sono i rischi e i risvolti «paternalistici» di un tale modo di istituire il rapporto tra intellettuali e masse, nonostante la volontà contraria dei redattori; inevitabile anche il carattere di «gruppo», di «sodalizio culturale» che viene ad assumere l’iniziativa, agli antipodi cioè di una ipotesi sperimentale di massa quale sarebbe nel programma della rivista. Essa finirà, quindi, per assolvere soprattutto ad un compito di 24 «svecchiamento» culturale, riuscendo stimolante per certe anticipatrici proposte di «pluridisciplinarietà» che collocavano le une accanto alle altre le scienze e le arti, le indagini sociologiche rispondenti alle esigenze «documentaristiche» del neorealismo e la storia illustrata della Rivoluzione d’Ottobre, i grandi poeti europei e i giovani scrittori italiani, le inchieste alla FIAT ed Hemingway, il futurismo russo e la Bauhaus, l’America roosveltiana e la Francia del Fronte popolare, Brecht e le avanguardie storiche, Croce e Dewey45. Pur criticando la vecchia cultura, Vittorini rimane ancorato alla visione crociana del «primato» della cultura, e ciò impedisce un rapporto fecondo con le masse lavoratrici. Il «Politecnico» rimane una rivista di intellettuali, riesce ad esercitare un ruolo preminentemente letterario (certo, da non sottovalutare) di svecchiamento, di apertura alla letteratura europea e americana, dopo l’ «autarchismo» fascista, ed alle nuove generazioni di scrittori. Lo stesso Vittorini, nel prosieguo della polemica, ammette il limite dell’ «enciclopedismo» che caratterizzò la rivista. Lo scrittore siciliano, appena redatto il programma del «Politecnico», lo manda al gruppo di intellettuali torinesi raccolti intorno alla casa editrice Einaudi. Ottiene il plauso e la promessa di collaborazione da parte di Massimo Mila, che risponde subito all’appello con una lettera, nella quale leggiamo: Caro Vittorini, ho visto con ammirazione l’immenso progetto per il «Politecnico» (o il Nuovo Politecnico). E’ una summa del mondo moderno. Per parte mia ti aiuterò ben volentieri nella parte di mia competenza; per il resto posso vedere di fare, senza impegno, quello che posso46. Di segno opposto la risposta di Pavese, il quale, in una lettera del 27 giugno 1945, scrive: Caro Vittorini, E. CHICCO VITZIZZAI (a cura di), Il neorealismo. Antifascismo e popolo nella letteratura dagli anni Trenta agli anni Cinquanta, Torino, Paravia, 1977, pp. 46-47. 46 M. MILA, Lettera a Vittorini, in Archivio Einaudi (AE, cart. 221), ora in C. PAVESE, Officina Einaudi, cit., p. 160. 45 25 il tuo programma di partenza è ciclopico e fa sospirare tutti. Tutti dicono: ma se è così la rivista è già fatta. Ti faremo presto le nostre deduzioni in merito. Per ora scrivo in fretta per avvertirti che sul mio conto qualcuno ti ha ingannato. Io non mi sento di fare il redattore responsabile a Torino. Ne ho già anche troppo della parte di redattore editoriale Einaudi47. Vittorini non si arrende, come risulta da una lettera del 3 luglio 1945: Caro Pavese, ho avuto le tue lettere del 27 e 28 giugno, ma mi convinco che per corrispondenza non potremo arrivare ad un’intesa concreta. Perciò la prima volta che Misha verrà a Torino prenderò posto accanto a lui e così ci troveremo tutti a discutere della cosa. Intanto tu avrai visto Giulio e avrai potuto conoscere quello che lui pensa dell’impresa. Ti raccomando di pregare tutte le persone indispensabili a una collaborazione da Torino per «Il Politecnico» di rendersi reperibili il giorno della nostra venuta, che ti comunicheremo telefonicamente48. Lo scrittore siciliano non si rassegna, continua ad insistere negli anni per avere una collaborazione di Pavese al «Politecnico», tanto che quest’ultimo, in una lettera del 7 ottobre 1947, conferma il proprio rifiuto: Caro Vittorini, ringrazio per l’invito a «Politecnico» ma pensa che faccio fatica a scrivere ogni sei mesi una noterella sull’«Unità». va da sé che se mi riesce il pezzo adatto è per voi49. Vittorini capisce finalmente l’antifona ed esprime tutto il suo rammarico in una lettera del 17 ottobre 1947: Caro Pavese, mi dispiace di apprendere che tu non abbia nessun bisogno di dire qualcosa in «Politecnico», e cioè non abbia nessun bisogno di «Politecnico»50. C. PAVESE, Lettera a Elio Vittorini del 27 giugno 1945, ivi, p. 159. E. VITTORINI, Lettera a Cesare Pavese del 3 luglio 1945, ivi, p. 160. 49 C. PAVESE, Lettera a Elio Vittorini del 7 ottobre 1947, ivi, p. 297. 50 E. VITTORINI, Lettera a Cesare Pavese del 17 ottobre 1947, ivi, p. 298. 47 48 26 La collaborazione di Pavese al quotidiano comunista «L’Unità» e al mensile del partito, «Rinascita», è meno saltuaria di quanto egli modestamente vorrebbe far credere, così come le motivazioni del suo rifiuto a scrivere sul «Politecnico» sono ben diverse e più profonde di quelle addotte. Una lettera del 27 aprile 1946, indirizzata a Giulio Einaudi, dimostra quanto Pavese tenesse alla collaborazione all’ «L’Unità»: Io credo che alla domenica scriverò qualche cosetta sull’Unità di Torino (vecchio amore) – e questa mi pare l’unica attività giornalistica cui si dovrebbero dare i membri della Casa51. Ed è proprio agli articoli apparsi su «L’Unità» e su «Rinascita», nonché ad alcuni scritti, rimasti in un primo momento inediti e poi oculatamente pubblicati da Italo Calvino ne La letteratura americana e altri saggi, che bisogna far riferimento per capire meglio la posizione di Pavese e le differenze rispetto a quella di Vittorini in merito alla funzione dell’intellettuale e al suo rapporto col partito e con le masse. Questi articoli sono spesso trascurati dalla critica, ma per capire appieno Pavese è necessario analizzare e valutare l’intero «corpus» della sua opera. Fondamentale ci pare, a tal proposito, lo scritto intitolato significativamente Il comunismo e gli intellettuali. Se per Vittorini il Partito comunista rappresenta un ostacolo al pieno esplicarsi della libertà intellettuale, per Pavese è, al contrario, lo strumento principe attraverso il quale tale libertà può affermarsi: Se ora in buon numero gli intellettuali – e dei migliori – vengono al comunismo, quasi a sciogliere un voto formulato nella stretta di questi anni terribili, ciò significa che molti tra loro ci trovano soprattutto una condizione di libertà, un avvio a esperienze e creazioni che gli altri sistemi non consentono o non promettono altrettanto ricche. Sia la promessa una diversa e più efficiente vita collettiva su cui innestare la propria vita interiore, sia una fede o, come si dice, un’ideologia vera e propria per cui lavorare e spendersi – fatto sta che in tutt’Europa, e in America e nel mondo, uomini di pensiero, di fantasia, di coscienza, illustri e oscuri, 51 C. PAVESE, Lettera a Giulio Einaudi del 27 aprile 1946, ivi, p. 231. 27 scelgono di celebrare la loro libertà in una prassi comunista. Ciò significa qualcosa. Anzitutto significa che per questi uomini una maggiore libertà intellettuale non era sinora esistita. Qui non si parla del nazifascismo, bensì di quel complesso di resistenze, d’interessi, di storiche situazioni fatte che l’hanno preceduto in tutto il mondo, e in sostanza l’equivalevano come il mandante di un delitto ne equivale l’esecutore manesco52. Bisogna soppesare le parole di Pavese, condurre un’analisi testuale stringente, per capirne appieno il significativo. Ed è proprio questa analisi stringente che spesso è mancata alla critica, che pure si autodefiniva «testuale», mentre il suo operare concreto contraddiceva le autodefinizioni altisonanti. Si badi bene: Pavese attribuisce non solo al Partito comunista italiano, così come si è venuto affermando nella realtà italiana, attraverso la «prova del fuoco» della Resistenza, il merito di dare realizzazione alla libertà intellettuale, ma anche all’ideologia comunista («un’ideologia vera e propria per cui lavorare e spendersi»), al comunismo come «sistema» politico, economico e sociale. Tant’è che non solamente nel nostro Paese, ma «in tutt’Europa, e in America e nel mondo», gli uomini di cultura «scelgono di celebrare la loro libertà in una prassi comunista». Nel contempo, lo scrittore non attribuisce la compressione delle libertà fondamentali, compresa quella intellettuale, solo al nazi-fascismo, ma all’intero sistema capitalistico, che ha con la dittatura nazi-fascista lo stesso rapporto che «il mandante di un delitto» ha con l’esecutore materiale di esso. Certo la realtà italiana ha una sua specificità. Gli intellettuali italiani credono di essere liberi sol «perché possono scegliere di perpetuare la squisita e futile accademia», e «quando popolareggiano, essi riescono in sostanza folcloristici»53. E’ questo il carattere non «nazional-popolare» della cultura italiana, di cui parla Gramsci. Ma v’è di più. Per molti italiani la libertà intellettuale è stata un «vuoto formalismo», e questo si spiega col fatto che «libertà politica vera da noi non c’è stata né ora né mai»54. Pavese esprime una netta ID., Il comunismo e gli intellettuali, cit., p. 224. Ivi, p. 225. 54 Ibidem. 52 53 28 condanna non solo del regime fascista, ma anche del regime che l’ha preceduto e che si definiva contraddittoriamente «liberale»: Che la cultura italiana abbia potuto sotto il fascismo continuare sostanzialmente il suo corso, significa che della libertà – le fosse o no consentita – non ebbe neanche prima quel largo gusto che parrebbe. Le inferriate che il fascismo impose vigevano prima pressoché sottintese, e se l’Italia non se ne accorse in modo clamoroso fu perché ebbe sempre il buon naso di non batterci dentro. Tant’è vero che appena accennò a far sul serio – fu, com’è giusto, sul terreno istituzionale e sociale – gli sportelli si chiusero – storia dal ’19 al ’25. Vigeva in Italia una dittatura di classe fattasi forte sui compromessi del Risorgimento, sulle cilecche del ’48, sugli incontri a Teano e sui trasformismi di dopo – e che questa dittatura non si fosse ancora rimangiate la libertà di stampa e d’associazione, non volle però dire che la stampa e l’associazione si muovessero autonome e sicure del fatto loro. Del resto non mancarono né il sangue né i domicili coatti. La cultura italiana, e lo si vide a occhio nudo nel ventennio, era nella sua quasi totalità, nel suo tono, soddisfatta di liberamente trattare davanti ai soliti ascoltatori i suoi soliti temi – e quei pochi che ebbero l’intemperanza di andar oltre e immaginarsi che il paese fosse maturo per una libertà più sostanziosa e operante – Gramsci, Gobetti – vennero a tempo e luogo spacciati. E’ ingenuo – in Italia, sciocco addirittura – supporre che l’esercizio della libertà intellettuale autentica, la quale non si stanca mai di gettar luce negli angoli più vergognosi e riposti di una società, non inciti alla rappresaglia chi ha colpa e interesse nello stato di cose vigente55. E allora il Partito comunista in Italia – così come il movimento comunista in generale – ha avuto il merito di dare libertà intellettuale a tutta una nazione, dopo il fascismo ed il «Risorgimento da operetta», ben descritto da Gramsci. E per Pavese la libertà intellettuale ha ben precisi connotati. E’ «corpo a corpo» con la «realtà rugosa», ricerca della verità assieme al popolo, rispetto al quale non bisogna assumere un atteggiamento da saccente, ma – anche qui gramscianamente – di reciproco scambio di esperienze. Chi ha esperienza di masse comuniste, o semplicemente organizzate e avviate a sollevarsi dalla torva brutalità veramente materiale in cui le hanno tenute tanto tempo i governanti della terza Italia, sa che tra loro la viva cultura, la sollecitudine competente e operosa di un intellettuale, è 55 C. PAVESE, Il comunismo e gli intellettuali, cit., pp. 225-226. 29 salutata e benaccetta come un tempo fra i loro avi la presenza di un sacerdote. Quasi sempre l’intellettuale esce fuori sgomento da quella stretta di cordialità fiduciosa che gli suona come un impegno terribile. Il primo incontro con un compagno di base ha suonato per molti come un richiamo del destino. Si sente il bisogno di rivedere tutta una serie di abitudini mentali, e l’accento è uno solo: come orientarsi nello spirito affinché la sua più alta attività non lasci cadere nessuna delle esigenze del compagno uomo nuovamente scoperto. […] Si cerca, nell’attrito con loro, la concreta libertà di un’azione da compiere, di una norma da seguire. Respirare del loro respiro non vuol dire altro56. E allora c’è un errore fondamentale da evitare: quello di «andare verso il popolo»: Ora, in questo atteggiamento è latente un pericolo: quello di «andare verso il popolo». Specialmente in Italia: verso il popolo ci vanno i fascisti. O i signori. E «andarci» vuol dire travestirlo, farne un oggetto dei nostri gusti e delle nostre degnazioni. Libertà non è questo. Non si va «verso il popolo». Si è popolo. Anche l’intellettuale, anche il «signore», che soffrono e vivono l’elementare travaglio del trapasso da una civiltà d’impedimento e di spreco a quella organizzata nella libertà della tecnica, sono popolo e preparano un governo di popolo. Che è ciò che vuole il comunismo. Democrazia significa questo governo57. L’analisi testuale sin qui condotta ci fa capire perché Pavese non ha voluto collaborare al «Politecnico», mentre ha collaborato a «L’Unità» e a «Rinascita». La rivista di Vittorini, nonostante i propositi del fondatore, è per pochi intimi, non consente quel rapporto fecondo con grandi masse che, secondo Pavese, è uno degli elementi caratterizzanti la libertà intellettuale. E’ proprio lo scrittore langarolo ad usare questa parola: «masse». Anzi, egli parla di «masse comuniste», accentuando, in tal modo, la necessità di una «mediazione» da parte del partito nel rapporto simbiotico tra intellettuale e popolo. Elemento fondamentale della libertà dell’intellettuale, come abbiamo già detto, è il rapporto con la realtà, ma anche – occorre 56 57 Ivi, p. 231. Ivi, pp. 231-232. 30 precisarlo – la lotta per cambiarla in senso rivoluzionario. Scrive, infatti, Pavese, sempre ne Il comunismo e gli intellettuali: La libertà non consiste nel permettere a qualcuno di esser sempre ciò che un giorno è stato, ma nel porre tutti i vivi in grado di determinare e costruire la loro nuova realtà58. Questi concetti sono approfonditi in un altro inedito pavesiano, pubblicato postumo dal solito Calvino, la cui preziosa opera ci ha consentito di ricostruire l’«ideologia» dello scrittore langarolo cimentandoci direttamente con i suoi testi, al di là delle interpretazioni fantasiose di certa critica. Leggiamo: E’ possibile che uno s’accosti al comunismo per amore di libertà? A noialtri è successo. Per uno scrittore, per un «operaio della fantasia», che dieci volte in un giorno corre il rischio di credere che tutta la vita sia quella dei libri, dei suoi libri, è necessaria una cura continua di scossoni, di prossimo, di concreta realtà. Noi rispettiamo troppo il nostro mestiere, per illuderci che l’ingegno, l’invenzione, ci bastino. Nulla che valga può uscirci dalla penna e dalle mani se non per attrito, per urto con le cose e con gli uomini. Libero è solamente chi s’inserisce nella realtà e la trasforma, non chi procede tra le nuvole. Del resto, nemmeno i rondoni ce la fanno a volare nel vuoto assoluto. Ora, di tutte le realtà che riempiono le nostre giornate, la più conseguente, la più concreta e liberatrice ci pare, e non da oggi, la lotta ingaggiata dal Partito Comunista Italiano. Gli intellettuali divisi sulla questione della libertà, dovrebbero chiedersi sinceramente che cosa intendono fare con quella libertà di cui sono a ragione solleciti. E vedrebbero che – tolte le pigrizie, tolti gli interessi inconfessati di ciascuno – non esiste istanza in cui, se davvero cercano il progresso dell’uomo, diano una risposta diversa da quella collettiva dei lavoratori. Sappiamo per esperienza che ogni individuale adesione a una parola, a un richiamo politico (anche astenersi è un prender parte) inserisce chi la fa in un gioco di botta e risposta, in una scottante trincea; ma proprio per questo non c’illudiamo che esista un «paradiso dei rondoni» dove si possa essere insieme progressivi e liberali. Nemmeno gli anarchici riescono a tanto. La nostra libertà è la libertà di chi lavora – di chi ha da fare i conti con l’opaco materiale, con la sua compattezza e durezza59. Ivi, p. 229. C. PAVESE, inedito, datato 13 novembre 1947, ora in La letteratura americana e altri saggi, cit., pp. 232-233. Calvino ci informa che «Pavese era stato invitato, dalla direzione del Pci, insieme ad 58 59 31 Se Vittorini usa concetti «astratti», «universali», «metastorici», Pavese, per converso, considera la libertà storicamente determinata, ossia condizionata dalla realtà politica, economica e sociale di un dato momento storico, dalla quale nessuno può prescindere, «nemmeno i rondoni», che per volare hanno bisogno dell’aria. Chi, come i comunisti, vuol veramente cambiare la realtà deve confrontarsi con «l’opaco materiale», con la sua «durezza». Per questo, talvolta, si possono considerare «illiberali» i comunisti, se si ha, appunto, una visione astratta della libertà, che prescinda dalle asprezze del reale e della lotta contro resistenze che hanno radici secolari. Per questo, ancora, non si può «essere insieme progressivi e liberali». E Pavese, tra la spinta progressiva verso il cambiamento radicale della società e il liberalismo astratto, preferisce chiaramente la prima, che rappresenta l’essenza del comunismo, anche «suo». Pavese si schiera apertamente contro la letteratura «intimistica»: lo scrittore, se vuole dare un senso alla sua opera, deve nutrirsi, da un lato, dei «succhi» della vitalità collettiva e, dall’altro lato, rendere partecipi le masse lavoratrici dei «frutti» del proprio lavoro. Leggiamo, sempre ne Il comunismo e gli intellettuali: E qui parliamo della vita di noialtri, della vita intellettuale di milioni, che tende naturalmente a crearsi una respirabile atmosfera di salute e di scambio, a gettare radici negli strati più sordi, a nutrirsi dei succhi di tutto ciò che è umano e vitale e parteciparne i frutti a ciascuno. Quando un pensiero o una parola sono espressi in solitudine o quasi, quando essi si adeguano a una piccola società, e manca loro l’attrito e il respiro degli strati sociali che più immediatamente vivono l’inconscio travaglio del presente, questo pensiero e questa parola risulteranno anemici, oziosi, arretrati60. Su un punto Vittorini e Pavese sono d’accordo: la cultura è sacrificio, anche per il popolo, deve rifuggire dalle facili semplificazioni. Scrive il primo, nella Lettera a Togliatti, descrivendo altri scrittori e uomini di cultura iscritti al Partito, a rispondere con un breve scritto alla domanda: Perché sono comunista. Le risposte dovevano essere raccolte in un opuscolo di propaganda» (ivi, p. 233). 60 ID., Il comunismo e gli intellettuali, cit., p. 224. 32 il travaglio culturale che lo accomunò ai suoi compagni anarchici negli anni trascorsi a Siracusa: Io rido di chi riduce il problema della cultura popolare a un problema unicamente di semplificazione, se penso a come l’ho visto risolvere, avendo tredici, quindici, sedici anni, dal gruppo di giovani operai siracusani con i quali mi scambiavo libri e gusti. Noi non esitavamo dinanzi a nessuna difficoltà di lettura. Prendevamo, ad esempio, La Scienza Nuova del Vico e se alla prima lettura non comprendevamo nulla, leggevamo una seconda volta e comprendevamo qualchecosa, leggevamo una terza e comprendevamo di più…E quei miei compagni di studi trovavano tempo di far questo dopo otto ore ogni giorno di lavoro manuale. Né erano dei geni. Ora sono semplicemente degli operai che possono affrontare qualunque lettura e dare del filo da torcere a qualunque professore crociano61. Anche Cesare Pavese, in uno scritto pubblicato su «Rinascita»62, critica la «cultura facile», che sta alla base di operazioni divulgative come quella condotta dalla rivista «Selezione», che si ispira al modello usato in America per trasmettere la «cultura in pillole» alle masse popolari, un modello che appare al Nostro tutt’altro che democratico: A farla breve, secondo noi, la colpa di «Selezione» non è tanto di difendere un capitalismo volgare quanto di arrivarci avvilendo, nel modo più volgare, il concetto di cultura. O meglio, speculando su una diffusa abitudine di falsa cultura che ha ormai investito tutta la nostra società. Giacché la cultura non è quella cosa facile, di tutto riposo, condensabile tra una barzelletta e una réclame, che sembrano ritenere i redattori di essa rivista. Se così fosse, allora noi dichiariamo di preferire i calendari tipo Chiaravalle o perché no? addirittura la vecchia «Domenica del Corriere», pubblicazioni meno pretenziose e nella loro banalità non prive di un certo provinciale rispetto per la vita vera. Ma farsi una cultura è cosa almeno altrettanto seria e impegnativa che imparare un mestiere, una qualsiasi tecnica; una tecnica non s’impara sfogliando manuali e meno ancora racimolando notizie «condensate» sull’argomento – s’impara creandola, E. VITTORINI, Lettera a Togliatti, cit., pp. 264-265. C. PAVESE, Cultura democratica e cultura americana, in «Rinascita», febbraio 1950, ora in La letteratura americana e altri saggi, cit., pp. 279-282. 61 62 33 inventandola un’altra volta, producendo cioè lavoro in quel campo determinato. C’è quindi un solo mezzo per popolarizzare la cultura: mettere in grado il popolo, tutto il popolo, di produrre questa cultura, di farsela per suo conto. […] Le più svariate e peregrine cognizioni (tanto peggio se «condensate») non fanno cultura se non in quanto diventano carne e sangue di un mestiere, di una tecnica di lavoro in cui ciascun uomo fa consistere la sua giornata e la sua dignità. Una cultura che non costi fatica, che non sia, vale a dire, lavoro vivo, non significa nulla 63. Il metodo democratico della divulgazione culturale consiste, dunque, nel mettere il popolo – «tutto il popolo», sottolinea il Nostro – nella condizione di produrre cultura da sé. Ma per Pavese – non così per Vittorini – questo metodo presuppone, per affermarsi e per poter operare concretamente, un partito che si faccia fautore di una società nuova. Difatti così conclude il suo articolo su «Rinascita»: Noi crediamo invece che in mezzo al sangue e al fragore dei giorni che viviamo vada articolandosi una diversa concezione dell’uomo. Tecnicamente specializzato ma radicato in una società il cui ideale non può non essere la sempre maggiore consapevolezza di ciascuno – il che significa la massima efficienza del lavoro di ciascuno, ma consapevole del lavoro di tutti – l’uomo nuovo sarà rimesso in grado di vivere la propria cultura e cioè di crederci e di produrla anche per gli altri, non in astratto ma in uno scambio quotidiano e fecondo di vita. Inutile dire che questa società sarà quella socialista, e i suoi sviluppi futuri saranno nel senso di un sempre più profondo e consapevole socialismo64. Un compito immane, che non può essere affidato all’intellettuale isolato o ad un utopistico «partito dei letterati», bensì ad un partito politico profondamente radicato nella società e in seno alla classe lavoratrice, che sia in grado, con l’ausilio degli intellettuali, come Pavese, di andare al di là sia del modello culturale umanistico, che ha ispirato la scuola italiana, nel suo passaggio dallo Stato liberale al fascismo (nell’ambito del quale fu solamente un «addobbo festaiolo»65) e alla nascente, incerta Repubblica, ma anche del 63 Ivi, p. 280. 64 Ivi, pp. 281-282. Ivi, p. 281. 65 34 modello americano (che il nostro definisce «reazionario»66), fondato sulla specializzazione di ciascuno e sull’affidamento della cosiddetta «alta cultura» ai pochi che detengono le leve del potere. Un partito capace di creare una società nella quale ognuno sia specializzato nel proprio lavoro, ma, nel contempo, «consapevole del lavoro di tutti». Una società che Pavese definisce apertamente «socialista». Conclusioni Nel titolo del presente saggio abbiamo accennato al «paradosso» dell’«impegno». Difatti, Vittorini è stato molto attivo politicamente, dall’esperienza anarchica adolescenziale alla partecipazione alla Resistenza, alla militanza nel Partito comunista. Pavese lo è stato molto meno. E’ stato un «osservatore», che, attraverso un processo di razionalizzazione della realtà, ha «costruito» la propria personalità, ha maturato una concezione generale del mondo, che, come i tragici del mondo classico, ha offerto, tramite i suoi scritti, alla riflessione collettiva. E il «paradosso» sta proprio qui. Pur essendo stato molto meno attivo sul piano della militanza rispetto a Vittorini, ha saputo offrire soluzioni più praticabili e «realistiche», oltre che più innovative sul piano politico e culturale. Vittorini non ha saputo liberarsi dal peso della cultura ottocentesca e primo novecentesca. Ha riproposto categorie «universali» e «metastoriche». Ha rispolverato, nella polemica con Togliatti, l’idea utopistica del «partito degli intellettuali», senza individuare le «gambe» attraverso le quali esso poteva comunicare con le «masse», al di là del «messianesimo». Pavese ha elaborato, per converso, concetti «storici» di uomo, di cultura e di libertà, e ha individuato anche il «soggetto» attraverso il quale essi potevano concretizzarsi, vale a dire il partito politico, anche se, ufficialmente, è stato un «compagno di strada» dei comunisti, seppure fornito di tessera. Meno «impegnato», dunque, ma «paradossalmente», «più impegnato», in quanto maggiormente capace di coniugare – per dirla con Calvino – «essere» e «fare». Sul piano strettamente letterario, ha dato concretizzazione a quel «plurilinguismo», che, 66 Ibidem. 35 contrapposto al «monolinguismo» di Vittorini, è prevalso sulla distanza e ha trovato oggi piena realizzazione. Antonio Catalfamo 36
Scarica