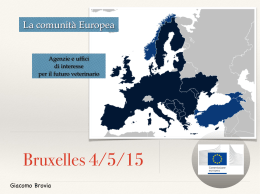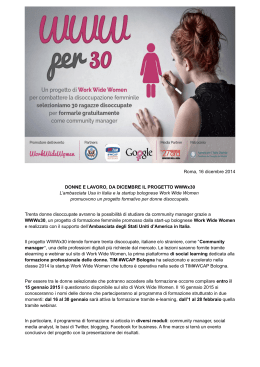Numero 23 – luglio 2013 Femminismo e questione animale Issue 23 – July 2013 Feminism and Animal Question Guest Editor: Annalisa Zabonati DEP, Deportate, esuli, profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, n. 23, luglio 2013 Femminismo e questione animale Indice Ricerche/La riflessione Alicia Puleo, Presentazione p. 1 Bruna Bianchi, “Come i secchi nel pozzo”. Scienza ed etica negli scritti contro la vivisezione delle femministe britanniche (1870-1910) p. 4 q. Melanie Bujok, Animals, Women and Social Hierarchies: Reflections on Power Relations p. 32 Maneesha Deckha, Animal Advocacy, Feminism and Intersectionality p. 48 Lisa Kemmerer, Ecofeminism, Women, Environment, Animals p. 66 Alicia Puleo, Uno sguardo econfemminista alla tauromachia p. 74 Agnese Pignataro, Allevamento di animali domestici ed etica del care: armonia o conflitto? p. 84 Documenti Josephine Donovan, Diritti animali e teoria femminista p. 100 Strumenti di ricerca Femminismo e questione animale. Bibliografia orientativa e strumenti di ricerca sul web, a cura di Annalisa Zabonati p. 123 Recensioni, interventi, resoconti Hypatia vol. 27, no. 3, Summer 2012, Animal Others (Erika Battocchio-Annalisa Zabonati) p. 134 Women of Color in Critical Animal Study, “Journal of Critical Animal Study”, VIII, 3, 2010 (Chiara Corazza) p. 139 Marti Kheel, Nature Ethics: An ecofeminist perspective (Erika Battocchio - Annalisa Zabonati) p. 143 Jimena Rodríguez Carreño (ed.), Animales no humanos entre animales humanos (Alicia Puleo) p.148 Michela Pezzarini, “Il cane o tua figlia?” Riflessioni sull’etica del care e la vivisezione p. 154 Femminismo, economia, beni comuni, Resoconto convegno internazionale Economics and the Common(s), Berlino (Bruna Bianchi) p. 159 Federica Frediani - Ricciarda Ricorda -Luisa Rossi (a cura di) Spazi Segni Parole. Percorsi di viaggiatrici italiane (Silvia Camilotti) p. 163 Silvia Camilotti, Ripensare la letteratura e l’identità (Ricciarda Ricorda) p. 166 Presentazione di Alicia H. Puleo Questo numero di DEP affronta un tema che in tempi recenti ha ricevuto una crescente attenzione ed è diventato di grande attualità: il trattamento degli animali. A partire dalla pubblicazione dell’opera Animal Liberation del filosofo australiano Peter Singer, negli anni Settanta, il movimento internazionale in difesa degli animali – una causa considerata giusta e urgente da migliaia di persone, molte delle quali donne – ha guadagnato sempre maggiore importanza. Si può dunque affermare che la questione animale sia un problema del nostro tempo, un tempo in cui l’Occidente inizia a prendere coscienza della straordinaria affinità che unisce tutti gli esseri viventi, umani e non umani. Eppure, la condizione attuale degli animali è forse la peggiore di tutti i tempi. Da un lato, la crisi ecologica generata dal modello di sviluppo capitalistico sta conducendo all’estinzione molte specie animali. Dall’altro, non cessa di crescere quel sistema mostruoso di campi di sterminio in cui milioni di animali sono privati di ogni libertà e sono sottoposti a terribili sofferenze e alla morte a fini alimentari o di sperimentazione. Il femminismo ha qualcosa da dire in proposito? Nel mondo anglosassone, negli ultimi decenni, alcune autrici e attiviste hanno risposto affermativamente. Tuttavia, non tutte le ecofemministe hanno abbracciato questa causa, preferendo in molti casi, optare per un olismo che si preoccupa, sì, per gli ecosistemi e per le specie animali, ma non considera gli animali come individui. Benché alcune abbiano rifiutato il razionalismo dei teorici dei diritti degli animali e abbiano accolto con favore l’etica della cura di Carol Gilligan, l’opposizione individuo/ecosistema continua a causare divisioni e tensioni concettuali tra ambientalisti e animalisti . La prospettiva ecofemminista comporta la revisione di una serie di dualismi centrali del nostro pensiero: natura/cultura, emozione/ragione, corpo/mente. Nel corso della storia, questi dualismi sono stati collegati alla definizione patriarcale della differenza tra i sessi. Si tratta di una delle più rilevanti connessioni teoriche che l’approccio femminista – alla questione ontologica, etica e politica, e al rapporto tra esseri umani e altri esseri viventi – ha avuto il merito di esplorare. I vari contributi raccolti in questo numero affrontano la questione animale da un punto di vista femminista, una prospettiva poco indagata, soprattutto nei paesi di cultura latina. Apre la rubrica Ricerche il saggio di Bruna Bianchi “Come i secchi nel pozzo”. Scienza ed etica negli scritti contro la vivisezione delle femministe britanniche (1870-1910). Prendendo le mosse dalla condizione animale nella capitale britanni© DEP ISSN 1824 - 4483 Alicia H. Puleo DEP n. 23 / 2013 ca all’inizio del secolo diciannovesimo, il saggio ricostruisce l’attivismo femminile nelle campagne per la protezione degli animali, in particolare contro la vivisezione, e analizza i temi della riflessione teorica di alcune femministe (Frances Power Cobbe, Anna Kingsford, Mona Cairg, Vernon Lee, Elizabeth Blackwell, Lind af Hageby) sul rapporto tra genere e scienza, sul nesso tra violenza alle donne e violenza agli animali, sul significato del progresso umano e in generale sul decadimento del senso di responsabilità della classe medica. Segue il saggio di Melanie Bujok, sociologa e attivista animalista dal titolo Animals, Women and Social Hierarchies: Reflections on Power Relations. L’autrice propone una lettura dei meccanismi di dominio e sfruttamento occidentali che accomunano le donne e gli animali secondo il modello proposto da Pierre Bourdieu. Nel pensiero occidentale, scrive l’autrice, gli animali e le donne appartengono alla polarità sociale opposta e svalutata rispetto agli uomini e a tutto ciò che li riguarda. Donne e animali sono così in antitesi alla cultura, alla civilizzazione, alla ragione e al progresso. Questo posizionamento ne legittima la sottomissione e il loro uso come strumenti materiali e simbolici ai fini dell’accumulazione capitalistica. Maneesha Deckha, docente di Diritto all’Università di Victoria, studiosa di femminismo postcoloniale, Critical Animal Studies e bioetica, nel suo contributo Animal Advocacy, Feminism and Intersectionality, espone le ragioni per cui la “questione animale” dovrebbe essere inserita a pieno titolo nella riflessione e nel movimento femminista alla luce del concetto di intersezionalità. L’intersezionalità, spiega l’autrice, è una teoria e una metodologia “che esamina la natura delle identità sociali e delle relazioni di potere, il modo in cui queste si generano e si integrano vicendevolmente, e le gerarchie che producono”, ovvero una chiave di lettura che si concentra sull’intreccio delle differenze e sulle modalità con cui, attraverso di esse, si esercita l’oppressione. Lisa Kemmerer, docente di Filosofia al Montana State University Billings ed attivista ecofemminista, nel suo saggio dal titolo Ecofeminism, Women, Environment, Animals si sofferma sulla riflessione di alcune autrici – Josephine Donovan, Carol Adams, Greta Gaard e Marti Kheel – che hanno proposto di includere nel pensiero femminista ed ecofemminista, accanto al tema del dominio sulle donne e sulla natura, anche quello che si esercita sugli animali nonumani. La divisione dei ruoli e del lavoro che relega le donne a mansioni subordinate, infatti, favorisce nel contempo anche l’estensione dello sfruttamento alla natura e agli animali. E questo accade soprattutto perché i corpi femminili, umani e nonumani, sono usati e consumati nel complesso “industriale sessuale” e nel complesso “industriale zooagricolo”. Nella convinzione che tutte le forme di oppressione siano collegate e che debbano rientrare negli obiettivi di decostruzione del complesso sistema di sfruttamento, l’ecovegfemminismo, enfatizza la questione della dieta. Dal canto mio, in Uno sguardo ecofemminista alla tauromachia ho cerato di offrire alcuni spunti di riflessione sulla tradizione cruenta della corrida. Le donne che hanno voluto intraprendere la carriera taurina hanno trovato sempre molti ostacoli, e spesso hanno dovuto nascondere il proprio sesso per poter entrare a far parte di questa élite cruenta. Negli ultimi decenni si sono blandamente socchiuse le porte alle torere che rifiutano il femminismo e che descrivono la lotta con il toro come un esercizio di bravura e di controllo delle emozioni. 2 Alicia H. Puleo DEP n. 23 / 2013 La corrida e tutto ciò che le ruota attorno ha una forte valenza androcentrica, in cui si esaltano le virtù maschili della forza, del coraggio e dello sprezzo del pericolo e della vita, “virtù” che esercitano il loro fascino su molti uomini, ma anche su molte donne, tra cui Simone de Beauvoir. La convinzione che le donne possano accedere a posizioni finora di esclusivo appannaggio maschile sembra sia una grande fonte di soddisfazione per certa parte del femminismo riformista che vede nella politica delle “pari opportunità” l’unica via da seguire per non rimanere ai margini. La nostra diffusa dell’“uomo” come dominatore della “Natura” ha un’oscura storia patriarcale e limiteremmo di molto le potenzialità della teoria femminista se esigessimo solo di partecipare al circolo dei dominatori. Possiamo, e a mio avviso dobbiamo, tentare una trasformazione della nostra autoconsapevolezza come specie, una ridefinizione etico-politica dei concetti di “Natura” e di “essere umano”. Questa nuova rivoluzione copernicana non implica l’abbandono della ragione. Al contrario, significa svilupparne la forza critica oltre il nostro presente storico e oltre i pregiudizi, connettendola con i sentimenti, che sono stati femminilizzati e svalutati”. Agnese Pignataro, dottoranda in Filosofia Morale presso gli Archives Husserl dell’École Normale Supérieure di Parigi e fondatrice direttrice scientifica della rivista online Musi e Muse, presenta un saggio dal titolo Allevamento di animali domestici ed etica del care: armonia o conflitto? In esso la studiosa propone una rilettura dell’ “etica del care” così come è stata teorizzata da Carol Gilligan. Il saggio prende l’avvio dall’analisi critica di alcune studiose francesi che negano la connessione tra etica del care e vegetarismo; a loro parere infatti il vegetarismo sarebbe un’astrazione universalizzante; l’allevamento non intensivo, invece, si rivelerebbe come una relazione di cura. Seguendo le indicazioni di Josephine Donovan e Carol Adams e in generale dell’ecovegfemminismo, l’autrice sostiene che l’etica della cura esige che si ascoltino le “voci differenti” degli animali. L’allevamento pertanto, qualsiasi forma esso presenti, è impensabile come etica della cura perché nega la profonda discriminazione e disuguaglianza che incarna. Il tema dell’etica della cura è al centro del saggio di Josephine Donovan, Diritti animali e teoria femminista, che viene qui proposto per la prima volta in traduzione italiana nella rubrica Documenti. Il saggio, pubblicato originariamente nel 1990 nella rivista femminista “Signs” col titolo Animal Rights and Feminist Theory, è lavoro pionieristico e rimane un punto di riferimento fondamentale sul tema delle connessioni tra femminismo e animalismo. Il pensiero e le teorie femministe sono il punto di partenza per riflettere sul modo di accostarsi alla “questione animale” da parte delle donne e propone il punto di vista dell’ “etica del care”, un punto di vista che si stacca nettamente dalle posizioni teoriche maschili diffuse nel movimento animalista e di liberazione animale. Nella rubrica Strumenti, accanto a una bibliografia orientativa, si descrivono alcuni siti internet utili per l’approfondimento e l’aggiornamento. 3 “Come i secchi nel pozzo”. Scienza ed etica negli scritti contro la vivisezione delle femministe britanniche (1870-1910) di Bruna Bianchi Abstract: The theme of the relationship between ethics and science was at the centre of the debate on vivisection that took place in Britain in XIX Century. Many prominent feminists, some of them active social reformers, played a major role, both in terms of activism and of theoretical elaboration. They questioned the Victorian faith in science and progress, revealed the inherent moral weakness of the doctrine of the survival of the fittest and envisioned a world in which the development of human moral capacities was the most important value. Only compassion and revulsion from pain, violence and domination could inform human behaviour. Therefore animal advocacy was a natural extension of their feminist principles. Based on an extensive analysis of the writings of Anna Kingsford, Mona Caird, Vernon Lee, Loiuse de la Ramée and, above all, Frances Power Cobbe, the paper briefly reconstructs the terms of the antivivisectionist debate, gives an account of women’s activism in antivivisectionist campaigns and dwells on the themes of feminist theoretical reflection on the relationship between gender and science, violence against women and violence to animals, on the meaning of human progress and on the ways to achieve it. “L’intelletto e le emozioni sono come i secchi del pozzo. Quando l’intelletto è in ascesa, le emozioni spariscono dalla vista; quando le emozioni si affacciano alla superficie le nostre menti attive si addormentano”. Così scriveva Frances Power Cobbe nel 1888 in The Scientific Spirit of the Age1. Con il termine emozioni la femminista britannica intendeva il senso estetico e morale, le più elevate facoltà umane, ignorate e svilite dalla nuova idolatria della scienza. Il tema del rapporto tra etica e scienza fu posto al centro del dibattito sulla vivisezione che si svolse in Gran Bretagna a partire dalla metà del secolo da alcune femministe. Anna Kingsford, Mona Cairg, Vernon Lee, Elizabeth Blackwell, Lind af Hageby e, soprattutto, Frances Power Cobbe, ebbero un ruolo di grande rilievo, sia sul piano dell’attivismo che dell’elaborazione teorica. Il dibattito assunse fin dall’inizio una connotazione di genere molto marcata. Se infatti le donne costituivano la maggioranza dei membri delle società antivivisezioniste, medici e fisiologi si schierarono per lo più a difesa di una sperimentazione di laboratorio senza limiti. Nelle donne essi videro i loro principali avversari e per indebolire la forza della loro protesta non esitarono a definirle “un pugno di 1 Pubblicato in “Contemporary Review”, vol. 54, 1888, pp. 131-132. © DEP ISSN 1824 - 4483 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 ipocrite impostore e di vecchie zitelle isteriche”2. Dal canto loro gli studenti di medicina manifestarono apertamente contro le antivivisezioniste, facevano irruzione nelle loro assemblee e riunioni tanto da meritarsi l’appellativo di “medical hooligans”. La controversia, infatti, assunse molto accesi: per i fisiologi la vivisezione era il simbolo della libertà della scienza, un principio che non ammetteva eccezioni; per le antivivisezioniste era il simbolo della frattura tra etica e scienza, l’espressione estrema della volontà di dominio sulla natura. Coloro che promossero e parteciparono alle campagne antivivisezioniste condividevano la preoccupazione che le nuove pratiche mediche costituissero una minaccia anche per l’integrità fisica delle donne, in particolare delle donne povere, vittime, al pari degli animali, della stessa oppressione patriarcale, dello stesso processo di oggettivazione e sfruttamento3. Nelle pagine che seguono mi propongo di rendere conto dell’attivismo femminile per la protezione degli animali, di illustrare alcuni temi che emergono dagli scritti delle antivivisezioniste, in particolare la loro riflessione sul rapporto tra genere e scienza, sul nesso tra violenza alle donne e violenza agli animali, sul significato del progresso umano e in generale sul decadimento del senso di responsabilità della classe medica e della sensibilità individuale e sociale di fronte alla sofferenza. Se gli orrori della vivisezione si praticavano nel segreto dei laboratori, i maltrattamenti inflitti agli animali a scopi economici o di svago erano sotto gli occhi di tutti per le vie delle grandi città e in particolare a Londra che nella prima metà del secolo crebbe tumultuosamente4. La mia ricostruzione prende le mosse dalla condizione animale nella capitale britannica e dalla percezione che ne avevano i contemporanei. Urbanesimo, progresso economico e sfruttamento degli animali La loro presenza era una funzione del crescente dominio finanziario della metropoli, dei consumi di lusso, dello sviluppo delle infrastrutture e del miglioramento architettonico. Era la sempre maggiore competizione tra i commercianti e i proprietari a condurre allo sfruttamento dei cavalli da tiro; era l’incremento delle costruzioni e dei progetti di ingegneria ad esaurire le loro forze5. Nessun aspetto della vita cittadina poteva fare a meno della fatica degli animali, dalle attività edilizie e commerciali, ai trasporti di materiali e persone, e le strade risuonavano costantemente dello schioccare della frusta e dei colpi del bastone. 2 Elie De Cyon, The Anti-vivisection Agitation, in “Contemporary Review”, vol. 43, 1983, p. 500. 3 Come era accaduto nella mobilitazione femminile contro i Contagious Diseases Acts, che imponeva controlli umilianti sulle prostitute. Si veda su questo tema: Mary Pooley, “Scenes of Indelicate Character”: The Medical Treatment of Women, in “Representation”, vol. 14, 1986, pp. 137-168. 4 La popolazione della capitale passò da 959.310 abitanti nel 1801 a 2.363.341 nel 1851, per raggiungere l’apice nel 1901: 4.536.267. Ben Weinren-Christopher Hibbert, The London Encyclopedia, Papermac, London 1993, passim. Dati leggermente diversi in Harold James Dyos-Michael Wolf (eds.), The Victorian City: Images and Realities, Routledge, London 1973, p. 4. 5 Diana Donald, ‘Beastly Sights’: the Treatment of Animals as a Moral Theme in Representations of London, c. 1820-1850, in “Art History”, vol. 22, 1999, 4, p. 516. 5 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 Mentre la campagna e il paesaggio naturale si allontanavano dalla vista degli abitanti della metropoli, gli animali diventavano via via più visibili, come si può leggere in quel magistrale affresco della città tracciato da Henry Mayhew nel 1851, London Labour and the London Poor. Cavalli, asini e cani erano utilizzati come bestie da soma o da traino; pappagalli e altri animali esotici erano comprati venduti, esposti negli zoo; la loro cattura e doma erano erette a simbolo della potenza conquistatrice britannica. Scimmie e cani ammaestrati si esibivano in danze e acrobazie al seguito di suonatori ambulanti, per le vie, nei circhi e nei teatri; tori, galli e cani erano costretti ai combattimenti; polli e maiali venivano allevati nelle case più povere, a migliaia le pecore e i bovini, attraverso le vie centrali della città, erano condotti al mercato di Smithfield dove intorno agli anni Quaranta venivano venduti annualmente quasi due milioni di animali, animali trascinati dalle lontane campagne, sfiniti dalla fame, torturati dalla sete, storpiati dalle percosse, come rivelano tante stampe dell’epoca6. Charles Dickens in Oliver Twist ci ha lasciato una descrizione di quel mercato in cui ogni particolare rievoca la violenza tra gli uomini e degli uomini sugli animali. Era una mattina di mercato. Uno strato di fango che arrivava alle caviglie copriva il terreno e un fitto vapore continuava a levarsi dal bestiame maleodorante e, mescolandosi con la nebbia, che sembrava appoggiarsi alla cima dei comignoli, rimaneva sospeso, greve, in alto. Tutti i recinti al centro del vasto spiazzo e tutti quegli altri recinti temporanei che avevano potuto trovar posto nel rimanente spazio libero, erano gremiti di pecore; legate a pali disposti lungo il rigagnolo, si trovavano tre o quattro interminabili file di buoi. Contadini, macellai, carrettieri, ambulanti, ragazzi ladri, oziosi e vagabondi della più infima specie, si mescolavano formando una massa brulicante; i fischi dei proprietari di bestiame, i latrati dei cani, i muggiti dei buoi, i belati delle pecore, i grugniti e gli strilli dei maiali, le grida degli ambulanti, gli urli, le bestemmie e i litigi da ogni parte, i rintocchi delle campane e il vociare che scaturiva da ogni taverna, la folla che sbraitava e urlava spingendosi, incalzandosi, picchiandosi, il frastuono orrendo e discordante che si levava da ogni angolo del mercato e le sagome sporche, squallide, con la barba lunga e non lavate che correvano avanti e indietro, irrompendo fuori della ressa e di nuovo scomparendo in essa, tutto ciò faceva sì che quella scena caotica e turbinosa stordisse i sensi7. Lo sviluppo urbano, la crescita del potere d’acquisto delle classi medie, i nuovi stili di vita, le nuove abitudini alimentari, la diffusione dei nuovi sport e dei diver6 La stampa di sinistra, dal titolo Smithfield market-cows & calves, è del 1849 di autore sconosciuto; la stampa di destra, dal titolo Smithfield market sheep drovers, sempre del 1849, è di H. Vizetelly. http://www.antiquaprintgallery.com. 7 Charles Dickens, Le avventure di Oliver Twist, Mondadori, Milano 2012, pp. 194-195. 6 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 timenti a basso costo per le classi lavoratrici, aumentarono progressivamente lo sfruttamento degli animali; è stato calcolato che oltre mille cavalli, ammalati, ridotti allo stremo, non più in condizioni di lavorare, venissero settimanalmente condotti alle cosiddette “boiling houses” per essere uccisi, trasformati in candele, cibo per gatti e altri “materiali” di uso quotidiano8. Eppure, quella sofferenza e quei maltrattamenti, per molti anni non sollevarono la preoccupazione dell’opinione pubblica. Nel 1800, quando per la prima volta fu presentata alla Camera dei Comuni un progetto di legge che prevedeva di abolire le lotte tra cani e tori, l’aula era semideserta e i pochi che intervennero, nel respingere il progetto, lo derisero. In quell’occasione il futuro primo ministro George Canning affermò che “il divertimento ispirava coraggio, induceva sentimenti nobili ed elevava la mente”9. Nel 1809 una proposta di legge volta a punire la crudeltà nei confronti degli animali da traino fu ugualmente respinta. Solo nel 1822 sarà approvata una legge che imponeva multe e carcerazione fino a tre mesi a coloro che avessero maltrattato cavalli, buoi e asini. I tori, tuttavia, continuarono ad essere esclusi dal provvedimento di protezione a causa della popolarità delle lotte con i cani. Era la prima volta che lo stato interveniva a favore degli animali, ma il cammino verso un comportamento più rispettoso nei loro confronti si presentava irto di difficoltà. Nel 1835 la proibizione dei maltrattamenti si estese agli animali domestici, ma il concetto stesso di domesticazione era ben lontano dall’essere messo in discussione. Ancora nel 1837 il naturalista William Swainson definiva il processo di domesticazione non già come un intervento umano, ma come il risultato di “una propensione innata degli animali, inculcata loro da Dio a sottomettersi, volontariamente e gioiosamente”10. Ugualmente inosservata e sottovalutata la condizione animale nelle inchieste sociali. Nel 1845 nell’opera La Situazione della classe operaia in Inghilterra Friedrich Engels deprecò l’abitudine introdotta dagli irlandesi di allevare i maiali e altri animali nelle abitazioni e menzionò la raccolta dello sterco dei cavalli come risorsa estrema di sopravvivenza per la “popolazione superflua”. Nell’opera gli animali fanno la loro comparsa a dimostrazione della vita di degrado, ai confini dell’umano, condotta dalla classe operaia urbana, soprattutto immigrata. Solo Flora Tristan nel 1840, in Promenades dans Londres, nell’intento di fustigare le classi elevate per i loro divertimenti oziosi, e in particolare per la nuova passione per le corse dei cavalli, stigmatizzava con queste parole la degradazione degli animali: Povera bestia! Non hanno rispettato in te l’opera di Dio; tu sei la creatura delle loro mani. Infelici! Come ti hanno trattato! Ti hanno voluto senza criniera e senza coda; hanno modificato le tue forme, annientato alcune delle tue facoltà per esagerarne delle altre; ora non sei che un 8 Diana Donald, ‘Beastly Sights’, cit., p. 528. Harriet Ritvo, Animal Estate: The English and the Other Creatures in the Victorian Age, Harvard University Press, Cambridge 1987, p. 128. 10 William Swainson, On the Natural History and Classification of Quadrupeds, Longman, London 1837, p. 137. 9 7 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 essere gracile che ha perduto il suo profilo primitivo: povera bestia! Come ti hanno avvilito! ti hanno ridotto ad una macchina locomotiva [...] Povera bestia! Uomini cattivi!11. Nell’opinione pubblica, tuttavia, un senso di disagio per la condizione degli animali si andò progressivamente facendo strada e venne rappresentata nelle pagine dei giornali popolari e delle riviste satiriche con intento moraleggiante e di denuncia. Nelle vignette e nelle caricature pubblicate in “Punch”, “Comic Almanack”, “Sunday in London”, “Life in London”, in particolare quelle dell’illustratore e caricaturista politico George Cruikshank, la violenza agli animali era il simbolo dei mali della società e dell’economia urbana12. Un’opinione condivisa da Lewis Gompertz13, segretario onorario della Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) fondata nel 1824 per iniziativa di un gruppo di umanitari evangelici. Sostenitore del veganismo, Gompertz si rifiutava di viaggiare su vetture trainate da cavalli e in molte occasioni deprecò lo sfruttamento animale causato dallo sviluppo economico. A proposito del London Bridge, ammirato come un meraviglioso prodotto del genio umano, scrisse: “Se la tortura e la morte che esso ha causato ai poveri cavalli che hanno trasportato pietre e detriti fossero portati alla luce, che emblema del crimine sarebbe quel bellissimo ponte!”14. Simili posizioni apparvero troppo radicali per una società i cui membri provenivano dalle classi medie e Gompertz dovette ben presto lasciare il proprio incarico. A parere della società la responsabilità dei trattamenti crudeli non doveva essere fatta risalire all’organizzazione sociale ed economica, ma ai comportamenti delle classi lavoratrici – vetturini, manovali, trasportatori, macellai, venditori ambulanti – ed era dovere delle classi superiori porre un limite ai loro eccessi15. Le misure volte a prevenire e punire i maltrattamenti degli animali erano dunque il principale impegno della SPCA che intendeva dare il suo contributo al progresso della società, al controllo e alla moralizzazione della classe lavoratrice e a questo scopo si dotò di un corpo di polizia privato per pattugliare le strade della capitale e in seguito di altre città. L’attenzione dedicata alle lotte dei galli, dei cani e dei tori rispecchiava la preoccupazione per l’ozio e la passione per il gioco che allontanavano la classe operaia dall’etica del lavoro, dalla parsimonia e dalla moderazione16. 11 Flora Tristan, Promenades dans Londres, ou l’aristocratie et les proletaires anglais, Centre d’histoire du syndicalisme, Maspero, Paris 1978, p. 214. 12 Per le illustrazioni rimando al già citato saggio di Diana Donald, ‘Beastly Sights’, cit. 13 Lewis Gompertz (1784-1861), autore di origine ebraica pubblicò nel 1824 la sua opera più importante: Moral Inquiries: On the Situation of Man and of Brutes, una delle prime opere sul tema dei diritti degli animali. Ammiratore del cooperativismo owenita, diede le dimissioni dalla SPCA perché accusato di diffondere principi anti-cristiani. Gompertz fondò allora la Animals’ Friendly Society che diresse fino al 1846. Oxford Dictionary of National Biography (d’ora in poi ODNB), voce curata da Lucien Wolf, http://www.oxforddnb.com/view/article/10934. 14 Diana Donald, ‘Beastly Sights’, cit., p. 516. 15 La storiografia recente ha posto un’enfasi particolare sui pregiudizi di classe della RSPCA e sul rafforzamento del controllo delle classe inferiori. Si veda James Turner, Reckoning with the Beast: Animals, Pain and Humanity in the Victorian Mind, John Hopkins University Press, Baltimora 1980; Harriet Ritvo, The Animal Estate, cit. 16 Sull’attività della RSPCA si veda: Brian Harrison, Animals and the State in Nineteenth Century England, in “English Historical Review”, vol. 88, 1971, pp. 786-820. 8 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 La crudeltà proveniva dalla sregolatezza, dall’imprevidenza, dall’incapacità di accettare la disciplina del lavoro. Tra il 1857 e il 1860 l’82% delle persone incriminate in base alla legge del 1822 apparteneva alla classe lavoratrice, in particolare macellai e carrettieri17. La (R)SPCA, infatti si astenne dal condannare le pratiche diffuse tra le classi elevate come la caccia e le corse, guadagnandosi in questo modo la simpatia della corona che nel 1840 l’autorizzò a fregiarsi del titolo di “reale”. La società mantenne un atteggiamento di grande moderazione anche nel corso delle campagne antivivisezioniste. Benché avesse invocato l’applicazione della legge del 1822 nei confronti di tre medici che alla riunione annuale della British Medical Association del 1874 avevano iniettato dell’alcol nelle vene di un cane, non si pronunciò per l’abolizione, ma per la regolamentazione ed evitò accuratamente di screditare la classe medica e di ledere la sua rispettabilità. Attivismo femminile e protezione degli animali L’istinto che si risveglia, che sente l’appello degli animali e dice: “Sono la voce dei senza voce. Attraverso di me i muti possono parlare”, è un fenomeno moderno che non può essere negato. Si concretizza nel movimento per la riforma alimentare da una parte e nella forte protesta contro i metodi crudeli di ricerca sperimentale, dall’altra. Entrambi sono all’unisono con le richieste avanzate dalle donne18. Benché le donne costituissero la maggioranza dei membri della RSPCA (50% nel 1850, 69% nel 1900), esse furono escluse dalla partecipazione attiva e dal General Council fino al 189619. Ugualmente marginalizzate all’interno della Humanitarian League20, fondata nel 1891 dal socialista Henry Salt. L’associazione protestò contro la distruzione del paesaggio, l’inquinamento, la caccia e la crudeltà nei confronti degli animali, l’obbligatorietà delle vaccinazioni, l’esclusione delle donne dal suffragio, la vivisezione, ma, ad esempio, si impegnò assai debolmente contro l’alimentazione forzata a cui all’inizio del Ventesimo secolo furono sottoposte le suffragiste21. La volontà di far sentire la propria voce e di agire in prima persona condusse nella seconda metà del secolo al sorgere per iniziativa femminile di decine di società a protezione degli animali. Nel 1875 Frances Power Cobbe, in aperta opposizione alla RSPCA, fondò la Society for the Protection of Animal Liable to Vivisection 17 Tra il 1830 e il 1839 vennero discusse 1.357 cause; negli anni Novanta il loro numero salì a 71.657. Charlotte Despard, Theosophy and the Woman’s Movement, Theosophical Publishing Society, London 1913, p. 44. 19 Mary Ann Elston, Women and Anti-vivisection in Victorian England, 1870-1900, in Nicolaas A. Rupke (ed.), Vivisection in Historical Perspective, Croom Helm, New York 1978, p. 267. 20 Dan Weinbren, Against All Cruelties: the Humanitarian League, 1891-1919, in “History Workshop”, n. 38, 1994, pp. 86-105. La società rappresentò il tentativo di collegare vari propositi riformatori dell’epoca: antivivisezionismo, riforma delle prigioni e abolizione della pena di morte, riforma delle leggi sui poveri, della dieta, del lavoro, per l’umanizzazione della professione medica. 21 Hilda Kean, “The Smooth Cool Men of Science". The Feminist and Socialist Response to Vivisection, in “History Workshop Journal”, vol. 40, 995, pp. 16-38. 18 9 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 – la prima società per l’abolizione della vivisezione, in seguito denominata Victorian Street Society (VSS) – e il suo organo “The Zoophilist”. Le donne costituivano il 70% dei membri ed erano rappresentate nella Executive Committee (nel 1876 vi erano cinque donne e otto uomini). Nel 1891 sorse la Royal Society for the Protection of Birds per iniziativa di Emily Williamson ed Eliza Phillips. L’associazione, che si proponeva di limitare l’importazione di uccelli tropicali (oltre 400.000 all’anno negli anni Ottanta) per sfruttarne le piume nell’industria dell’abbigliamento. Nel 1898 contava 20.000 iscritte e migliaia furono le donne che sottoscrissero l’impegno a non indossare abiti o cappelli adornati di piume22. Scrittrici e poetesse nelle loro opere denunciarono l’indifferenza nei confronti della sofferenza animale; tra i più noti il romanzo di Anna Sewell, Black Beauty (l’autobiografia di un cavallo che poteva essere letta come l’autobiografia di una donna), pubblicata nel 1877, e quello contro la caccia di Florence Dixie, Horrors of Sport (1892). Anche nelle associazioni femminili per il suffragio si andò diffondendo una sensibilità nuova rispetto alla condizione animale, alla vivisezione e al vegetarismo e nel 1898 nacque la Women’s Vegetarian Society. Le leader più radicali del movimento suffragista, come Constance Lytton ed Eva Gore-Booth, si rifiutavano di contribuire alla “morte innaturale” degli animali, ovvero di mangiar carne e di indossare indumenti di lana. Il nesso tra vegetarismo e femminismo sarà tema discusso dalla rivista “Shafts” a partire dagli anni Novanta, insieme a quello della caccia e della vivisezione. La dieta vegetariana era presentata come il primo passo verso il rifiuto di ogni forma di violenza ed era sentita come una questione femminista23. Ricordando un episodio di maltrattamento nei confronti di una vecchia pecora fuggita da un macello, Constance Lytton annotò nella sua autobiografia: [L’episodio] mi rivelò per la prima volta la posizione delle donne nel mondo. Mi resi conto di quanto spesso le donne sono disprezzate perché al di fuori dei confini della dignità umana, escluse o recluse, derise e insultate a causa di condizioni di cui non hanno responsabilità, ma che sono dovute a ingiustizie fondamentali nei loro confronti e agli errori di una civiltà alla cui formazione esse non sono libere di partecipare24. Violenza agli animali e violenza alle donne L’identificazione della donna con l’animale maltrattato, così frequente negli scritti femminili, rimandava alla loro uguale condizione: esseri privi di diritti, impotenti, imprigionati nelle stesse strutture di protezione e dominio25. 22 Barbara T. Gates (ed.), In Nature’s Name. An Anthology of Women’s Writing and Illustration, 1870-1930, The University of Chicago Press, Chicago-London 1996, p. 93. In particolare sulla RSPB si veda: Robin W. Doughty, Feather Fashions and Bird Preservation: A Study in Nature Protection, University of California Press, Berkeley 1975. 23 Leah Leneman, The Awakened Instict: Vegetarianism and the Women’s Suffrage Movement in Britain, in “Women’s History Review”, vol. 6, 1997, 2, pp. 271-287. 24 Ivi, p. 279. 25 Su questo tema rimando al saggio di Josephine Donovan, Diritti animali e teoria femminista che compare nella rubrica Documenti di questo numero di DEP. 10 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 Il nesso tra violenza alle donne e violenza agli animali ricorre anche nella letteratura della prima metà dell’Ottocento, si pensi alle opere di Charles Dickens: Sketches by Boz, Oliver Twist, Little Dorrit, a quella di Wilkie Collins, Woman in White, per citare le più note26. L’equiparazione della donna all’animale è al centro dell’immaginario sessuale violento, tema costante della letteratura pornografica che a partire dagli anni Settanta ebbe un grande sviluppo. Il linguaggio della pornografia – ha osservato Coral Lansbury che ha analizzato un gran numero di romanzi pubblicati tra il 1870 e il 1910 – è il linguaggio della stalla: briglie, morsi, lacci, fruste, simboli della privazione della libertà, sono onnipresenti; il culmine del piacere maschile è raggiunto quando le donne sono legate e immobilizzate e il potere del più forte che si impone al debole riduce la sua vittima alla condizione animale27. L’immaginario sessuale era solo una delle espressioni di pulsioni violente nei confronti delle donne. Nel corso del secolo si registrò un progressivo aumento della violenza domestica; numerosi gravissimi episodi venivano riportati quotidianamente dalla stampa e a partire dal 1850 si moltiplicarono le pressioni per aggravare le pene ai mariti violenti. Nel 1868 le pene per le percosse inflitte alla moglie o ai bambini fu aumentata ad un anno di carcere e l’anno precedente il nesso tra condizione di inferiorità politica delle donne e oppressione maritale era stata posta all’attenzione pubblica da John Stuart Mill che nel suo discorso alla Camera a favore del suffragio femminile aveva menzionato le donne che ogni anno erano “picchiate a morte” dai loro “protettori maschi”28. Nel corso delle discussioni sui vari provvedimenti legislativi volti a limitare la violenza nei confronti e delle donne degli animali venne spesso citata l’opera di William Hogarth: I quattro stadi della crudeltà (1751) in cui l’artista aveva raffigurato la connessione tra la brutalità verso gli animali e verso le donne. Benché molto note, vale la pena soffermarsi brevemente su quelle incisioni, anticipatrici dei temi che saranno al centro della riflessione femminista nel secolo successivo. Il primo stadio della crudeltà, illustrato dalla prima incisione, è quella che si compie nei confronti degli animali domestici; il secondo stadio è lo sfruttamento animale a scopi economici. Nella seconda incisione in primo piano è raffigurato un 26 Per un commento alle opere letterarie di questi anni si veda: Lisa Surridge, Dogs’ Bodies, Women’s Bodies: Wives as Pets in Mid-Nineteenth-Century Narratives of Domestic Violence, in “Victorian Review”, vol. 20, 1, 1994, pp. 1-34. 27 Coral Lansbury, Gynaecology, Pornography, and the Antivivisection Movement, in “Victorian Studies”, vol. 28, 1985, 3, pp. 413-437. Gli strumenti di contenzione che appaiono nei romanzi pornografici sono simili a quelli usati in ginecologia e in vivisezione. 28 Mary Lyndon Shanley, Feminism, Marriage, and the Law in Victorian England, 1850-1895, Princeton University Press, Princeton 1989. 11 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 cavallo caduto sotto il peso di un carretto sovraccarico di merci sulla strada in salita di Holborn presso il mercato di Smithfiels, nota per la fatica che comportava per gli animali. Il cavallo ha la zampa spezzata, è piagato e piangente e viene percosso da un vetturino. Sulla destra un agnello viene bastonato a morte. In secondo piano si scorge Inns of Court, la sede dell’avvocatura, e sullo sfondo quella del potere politico aristocratico, a ricordare che tutte le classi sociali erano coinvolte nella crudeltà. Il terzo stadio, Cruelty in perfection, è la violenza alle donne, il culmine della violenza. Nella terza incisione una donna incinta giace a terra, uccisa dal marito, e infine la quarta incisione ritrae la sorte dell’autore del crescendo di atti brutali, Tom Nero, l’antieroe dell’opera, steso sul tavolo anatomico, sezionato dai medici e circondato da numerosi e attenti osservatori: The reward of cruelty. Le intenzioni didattiche dell’artista sono così illustrate nelle sue note autobiografiche: 12 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 Le stampe sono state incise nella speranza di correggere, in qualche modo, quel trattamento barbaro degli animali la cui vista rende le strade della nostra metropoli così penosa per ogni animo sensibile. Se hanno avuto questo effetto, e limitato l’aumento della crudeltà, sono orgoglioso di esserne stato l’autore, molto più di quanto lo sarei se fossi stato io a dipingere i quadri di Raffaello29. Sarà Frances Power Cobbe30, femminista, giornalista, riformatrice, antivivisezionista a connettere violenza domestica, oppressione femminile, crudeltà nei confronti degli animali e dei poveri da parte della classe medica. Alcuni suoi scritti ebbero una grande influenza e contribuirono a mutare la legislazione matrimoniale: Criminals, Idiots, Women and Minors. Is the Classification Sound? (1868); A Discussion on the Law Concerning the Property of Married Women (1869) e, soprattutto Wife-torture (1878). Nel primo scritto Cobbe si soffermava sulla violenza insita nel matrimonio che imponeva alle donne una dipendenza completa, in primo luogo economica. “Niente più del portafoglio, in mancanza del bastone, può assicurare il dominio in modo assoluto e permanente”31, un dominio che si fondava sulla convinzione dell’inferiorità morale, intellettuale e fisica delle donne. La legislazione non proteggeva le mogli dalla povertà, dagli abusi fisici e morali, al contrario, sottraeva loro il controllo della loro stessa proprietà e conferiva agli uomini privilegi supplementari. Nel paragonare la condizione delle donne all’animale rinchiuso in gabbia, faceva la parodia delle guide dei gruppi di visitatori al giardino zoologico e scriveva: Questo, signore e signori, è un uccello inoffensivo, la Mulier Anglicana. Il becco è fragile, inadatto a rimuovere la terra. Sembra che la sua intelligenza si limiti alla costruzione del nido e al prendersi cura dei piccoli, ai quali è particolarmente devota, e del suo compagno. Per il 29 Anecdotes of William Hogarth Written by Himself, J. B. Nichols, London 1833, p. 65. 30 Su Frances Power Cobbe (1822-1904) la bibliografia è ormai vastissima. Si veda in primo luogo la sua autobiografia: Life of Frances Power Cobbe, by Herself (1894), Thoemmes, Bristol 2003; Moira Ferguson, Animal Advocacy and Englishwomen, 1780-1900: Patriots, Nation and Empire, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1998, pp. 105-124; Sandra J. Peacock, The Theological and Ethical Writings of Frances Power Cobbe, 1822-1904, Mellen Press, Lewiston, N.Y. 2002; Sally Mitchell, Frances Power Cobbe: Victorian Feminist, Journalist, Reformer, University of Virginia Press, Charlottesville 2004; Lori Williamson, Power and Protest: Frances Power Cobbe and Victorian Society, Independent Publisher Group, London-New York-Chicago 2005; Susan Hamilton, Frances Power Cobbe and Victorian Feminism, Palgrave Macmillan, New York-Basingstoke 2006. Si veda inoltre l’ampio profilo nel volume di Barbara Caine, Victorian Feminists, Oxford University Press, Oxford 1992, pp. 103-142. In particolare, sullo scritto Wife-torture si veda: Carol BauerLawrence Ritt, “A Husband is a Beating Animal”. Frances Power Cobbe Confronts the Wife-abuse Problem in Victorian England, in “International Journal of Women’s Studies”, vol. 6, 1983, 3, pp. 99118; Susan Hamilton, Criminals, Idiots, Women, and Minors: Victorian Writing by Women on Women, Broadview Press, Peterborough 1995; Ead., Making History with Frances Power Cobbe: Victorian Feminism, Domestic Violence, and the Language of Imperialism, in “Victorian Studies”, vol. 43, 2001, 3, pp. 437-460; Janice Schroeder, “Narrat[ing] Some Poor Little Fables”: Evidence of Bodily Pain in “The History of Mary Prince” and “Wife-torture in England”, in “Tulsa Studies in Women’s Literature”, vol. 23, 2004, 2, pp. 261-281; Emilie Dardenne, “Un épagneul, une femme et un noyer, plus nous les battons, meilleurs ils sont”: Frances Power Cobbe, la féminité, l’altérité, in “Revue LISA/LISA e Journal”, 2005, http://lisa.revues.org/890. 31 Frances Power Cobbe, Criminals, Idiots, Women and Minors. Is the Classification Sound? A Discussion on the Law Concerning the Property of Married Women, in “Fraser’s Magazine”, December 1868, p. 8. 13 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 resto è un esemplare di uccello molto semplice che raccoglie ogni briciola gli si voglia gettare [...]. Pertanto vedete, signore e signori, poiché è così indifeso, abbiamo messo una grossa catena alla sua zampa e l’abbiamo legato al nido e abbiamo messo sbarre eccezionalmente forti alla sua gabbia. Per quanto riguarda le sue ali rudimentali, noi le tagliamo sempre molto presto, per maggiore sicurezza, benché abbiamo sentito dire dal professor Huxley che è sua convinzione che in nessun caso potrebbe volare lontano32. Certamente, concludeva Cobbe, la pretesa degli uomini alla superiorità morale appariva assurda al massimo grado. I vizi più odiosi: la crudeltà, l’ubriachezza e la lussuria – si chiedeva – erano più diffusi tra le donne o tra gli uomini? Leggete i rapporti della Società per la prevenzione della crudeltà sugli animali e vedete se sono in maggior numero le donne o gli uomini ad essere denunciate per torture agli animali domestici. Il lettore pensa forse che la devozione alla scienza da parte di una donna la possa condurre a praticare la vivisezione?33 In Wife-torture la femminista irlandese affrontando il tema della violenza fisica esercitata sulle donne e tracciava una analogia con la vivisezione. Ho intitolato questo saggio Wife-torture perché voglio che sia ben chiaro al lettore che il termine usuale di percosse trasmette un’idea dell’estrema crudeltà esercitata altrettanto remota dell’espressione “grattare la coda a un tritone” usata dai nostri candidi ed ingegnosi vivisezionisti quando si riferiscono all’atto di bruciare vivi dei cani o di recidere loro i nervi o di torturare una novantina gatti in una serie di esperimenti34. Come nel caso della vivisezione la brutalità maschile era ignorata, legittimata, trivializzata. Di violenza domestica si parlava con accenti umoristici e di condiscendenza, era presentata nella letteratura e negli spettacoli popolari come fonte di divertimento attraverso la figura dell’intollerabile moglie-megera che ben meritava la sua sorte. La necessità della violenza consuetudinaria era prescritta dai proverbi: “Un cane, una donna, un noce, più li batti e più migliorano”. A quel “divertimento occulto” la femminista irlandese contrappose in tutta la sua crudezza la descrizione dei segni della violenza sui corpi delle donne, così come emergevano dalla documentazione giudiziaria35. Le donne, infatti, non erano solo battute, bensì torturate, prese a calci, mutilate, ustionate, accecate, uccise. Raramente i mariti si limitavano agli schiaffi, agli spintoni, agli sputi, ma si lasciavano andare ad un crescendo di maltrattamenti e di crudeltà. A questi episodi (1500 casi di aggressioni particolarmente brutali discussi ogni anno nelle aule dei tribunali, ovvero quattro ogni giorno) erano dedicati innumerevoli trafiletti sulla stampa quotidiana, sparsi “qui è lì”, privi di qualsiasi commento che richiamasse l’attenzione e il giudizio morale del lettore. Benché Cobbe non sottovalutasse il ruolo della povertà, dell’alcolismo e delle misere condizioni abitative in quelli che chiamava i kicking districts nel favorire gli 32 Ivi, pp. 16-17. Ivi, p. 26. 34 Wife-torture in England fu pubblicato nel numero di aprile-giugno del 1878 della “Contemporary Review”, pp. 55-87. 35 L’attenzione al particolare, tuttavia, non ha nulla di compiaciuto, ma è inserita in una narrazione dagli intenti etici. Si veda su questo specifico aspetto: Susan Hamilton, A Whole Series of Frightful Cases: Domestic Violence, the Periodical Press and Victorian Feminist Writing, in “Topia”, vol. 89, n. 13, pp. 89-101. 33 14 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 scatti d’ira, individuava le vere cause della violenza nella svalutazione e nell’oggettivazione. Come gli animali, le donne erano considerate creature inferiori, non degne di rispetto, oggetti di proprietà. È una radicale alterità – spiega la femminista irlandese – che conduce alla tortura. Il “linciaggio domestico” si perpetuava attraverso la consuetudine e l’indifferenza; i figli che assistevano agli abusi erano portati a pensare alle donne come esseri inferiori, come a un cavallo frustato o un cane preso a calci. Per queste ragioni la legge del 1857 (Matrimonial Causes Act), che rendeva possibile il divorzio nei casi di abuso (incesto, stupro, bigamia e crudeltà), era rimasta lettera morta, come pure era rimasta inascoltata la denuncia del colonnello Edgerton Leigh alla Camera dei Comuni nel 1874. Nemmeno il rapporto ufficiale del Parlamento del 1875 (Reports to the Secretary of State for the Home Department on the State of Law Relating to Brutal Assaults) fu seguito da una iniziativa legislativa. Lo scritto di Frances Power Cobbe ebbe una vasta risonanza e contribuì all’approvazione del progetto di emendamento presentato da Leigh nel maggio 1878 (An Act to Amend the Matrimonial Causes Act) che garantiva la protezione e/o il divorzio nel caso di maltrattamenti, prevedeva l’affidamento dei figli alla madre e obbligava il marito a versare un contributo settimanale. La legge era innovativa poiché spostava l’attenzione dalla punizione del colpevole alla protezione della vittima. Nel 1894 Cobbe scriverà nella sua autobiografia: La parte del mio impegno per le donne che ricordo con maggior soddisfazione è quello che ha portato alla protezione delle povere mogli picchiate, storpiate, mutilate, calpestate dai loro mariti brutali36. Sia gli animali che le donne – a parere di Cobbe – erano torturati in luoghi lontani dallo sguardo pubblico, nel segreto dei laboratori e delle pareti domestiche ed essa avrebbe illuminato quei luoghi oscuri, come scriverà nel 1888 in Light in Dark Places. Nella maggior parte dei suoi pamphlet divulgherà immagini tratte dai manuali di fisiologia e, come aveva fatto per la violenza domestica, nominerà la violenza perpetrata sui tavoli di vivisezione con parole precise, crude, mai allusive, quelle che i fisiologi stessi usavano nei loro trattati: “segare la spina dorsale, sezionare e irritare tutti i nervi principali, inserire cateteri lungo le vene e le arterie, inoculare le peggiori malattie, fare a pezzi l’intestino, cuocere a fuoco lento, versare nello stomaco acqua bollente, congelare a morte, ridurre il cervello a ‘un campo di patate appena zappato’”37. Come donna sentiva di avere un contributo speciale da dare al mondo. Portatrici di un messaggio morale, le donne avrebbero dovuto riconoscere negli animali gli esseri che maggiormente avevano bisogno del loro aiuto. Come donna, o meglio come donna anziana, il culmine della debolezza e dell’inutilità, affermo di avere maggior diritto di essere ascoltata in questa questione rispetto a un uomo, anche 36 Frances Power Cobbe, Life of Frances Power Cobbe, by Herself, vol. 2, Houghton-Mifflin, BostonNew York 1894, p. 534. 37 Ead., The Janus of Science, Office of the Society for the Protection of Animal from Vivisection, London 1882, p. 5. 15 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 rispetto a un prete. Se il mio sesso ha una qualche missione, è sicuramente quella di addolcire questo vecchio, duro mondo, così come gli uomini (preti inclusi) lo hanno lasciato38. Quando Cobbe scrisse Wife-torture il suo impegno contro la vivisezione risaliva al 1863 quando, ad Aix les Bains, venne a sapere che alla Scuola veterinaria ad Alfort si praticava la vivisezione; fino a 60 operazioni dolorose al giorno per ciascun animale. La Società per la prevenzione della crudeltà agli animali fin dal 1846 aveva presentato petizioni alla regina e al re di Francia, senza alcun risultato39. Già nel 1855, in Intuitive Morals, Cobbe aveva messo in discussione il principio che gli esseri umani avessero il diritto di dominare la natura e gli animali: La loro felicità è lo scopo per cui sono stati creati [...]. Assurdo al massimo pertanto l’antico concetto che il fine primario dell’esistenza di ogni creatura senziente possa essere il beneficio di un’altra, e che gli animali siano stati creati espressamente per servire gli esseri umani40. Ma sarà a partire dal 1874 che il suo impegno per l’abolizione della vivisezione assorbirà tutte le sue energie. Regolamentazione o abolizione? Cronaca di una controversia La vivisezione è un pratica antica. Caduta in disuso nel Medioevo, iniziò a diffondersi nel XVII secolo, ma solo a partire dagli ani Settanta dell’Ottocento, quando fu istituzionalizzata e numerosi fisiologi la introdussero a Oxford e Cambridge, si sviluppò un vero e proprio movimento di protesta che raggiunse il culmine nel 1874, quando la British Medical Association promosse un confronto con i sostenitori dei diritti degli animali. In quell’occasione il fisiologo francese Eugène Magnan indusse un attacco epilettico in due cani, ma il presidente del Royal College of Surgeon di Irlanda scioglie i legacci che immobilizzavano gli animali e chiese la sospensione della seduta. L’episodio risvegliò l’attenzione dell’opinione pubblica e unì in un unico fronte i vari gruppi di antivivisezionisti. Cobbe scrisse: Need of a Bill e Reason for Interference. Erano i primi pamphlets anti-vivisezione in cui si chiedeva solo che la pratica non fosse dolorosa. Il 2 febbraio 1875 sul “Morning Post” apparve una lettera del dott. George Hoggan, un medico che aveva abbandonato la pratica della vivisezione, in cui ne descriveva gli orrori e invocava una commissione di inchiesta. Cobbe si mise in contato con Hoggan e, incoraggiata da lui, stese un progetto di legge presentato alla Camera dei Comuni il 4 maggio 1875. Era una proposta di regolamentazione che prevedeva l’uso di anestetici, l’iscrizione ad un albo e definiva le modalità per l’ottenimento dei permessi. La petizione per la restrizione ottenne un migliaio firme. Cobbe si rivolse fiduciosa a Charles Darwin, il quale così motivò il suo rifiuto: Credo che alla fine la fisiologia condurrà a incalcolabili benefici e che possa progredire solo sperimentando su animali vivi. Qualsiasi restrizione fermerà ogni progresso in questo paese e me ne rammaricherei profondamente [...] Non posso non rimanere colpito dall’ingiustizia con 38 Ead., The Ethics of Zoophily, in “Contemporary Review”, vol. 68, 1895, pp. 497-498. 39 Lori Williamson, Power and Protest, cit., pp. 112-115. 40 Frances Power Cobbe, Essay on Intuitive Morals, Longman, London 1955, p. 35. 16 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 cui si parla dei fisiologi, considerando che coloro che sparano agli uccelli per puro piacere [...] non sono biasimati, mentre dei fisiologi si dice che sono “demoni usciti dall’inferno”41. Darwin e Huxley presentarono un progetto alternativo a quello di Cobbe in base al quale la vivisezione era considerata una pratica lecita e garantiva che coloro che la praticavano non sarebbero incorsi nelle pene previste dalla legge del 1822. I fisiologi, inoltre, avrebbero potuto ottenere un permesso per praticare la vivisezione anche senza anestetici. La comunità medica, sollecitata dai due autorevoli naturalisti, accolse il loro progetto e il 22 maggio “The Lancet” accusò coloro che volevano regolamentare la vivisezione di ristrettezza mentale e incompetenza. Nel 1875 fu istituita la prima commissione parlamentare di inchiesta sulla vivisezione; furono ascoltati 53 testimoni, la maggior parte medici favorevoli alla pratica. La commissione concluse che la vivisezione era necessaria al progresso scientifico e portava ad esempio le scoperte sulla circolazione del sangue rese possibili dall’osservazione “dal vivo”; l’abolizione era impossibile e irragionevole e nel 1876 fu approvata la prima legge di regolamentazione che consentiva la pratica anche senza ricorso ad anestesia quando questa avesse compromesso i risultati scientifici42. Nel 1881 il congresso internazionale di medicina tenuto a Londra rivelò una vasta solidarietà internazionale a favore della vivisezione. In quell’occasione gli antivivisezionisti furono definiti degli agitatori ignoranti, isterici, pieni di pregiudizi43 e nel marzo 1882 nacque la Association for the Advancement of Medicine by Research (AAMR). Da allora le sperimentazioni di laboratorio non fecero che aumentare; se nel 1862 – osserverà Elizabeth Blackwell nel 1902 – erano pochi i laboratori in cui si poteva vivisezionare, nel 1892 il numero delle persone autorizzate era salito a 180 e quello delle vivisezioni a 3.960. Ora quasi ogni scuola di medicina ha la sua scorta di creature viventi imprigionate che attendono la loro fine, dai grandi rospi importati dalla Germania, ai topi, ai conigli, ai gatti, ai cani di provenienza nazionale, ai carichi di scimmie portate nel nostro clima nebbioso dall’Africa tropicale44. Ma anche la campagna di opposizione si estese e si radicalizzò; eminenti personalità politiche, religiose e letterarie si espressero a favore dell’abolizione. Nel 1884 John Ruskin diede le dimissioni dalla sua cattedra a Oxford in segno di protesta per l’aperura di un laboratorio di vivisezione all’Università. La Victorian Street 41 Citata in Lori Williamson, Power and Protest, cit., p. 116. Per una analisi della legge che, in pratica, lasciava mano libera ai fisiologi, si veda Mona Caird, The Inquisition of Science (1903), in Susan Hamilton, Animal Welfare and Anti-vivisection 1870-1910, Nineteenth Century Woman’s Mission, vol. 2, Routledge, London-New York 2004, pp. 82-105. 43 Brooke Montgomery, “Those Candid and Ingenuous Vivisectors”: Frances Power Cobbe and the Anti-vivisection Controversy in Victorian Britain, 1870-1904, tesi di dottorato sostenuta presso la Calgary University, 2000, p. 52. 44 Elizabeth Blackwell, Scientific Method in Biology, in Essays in Medical Sociology, vol. 2, Ernest Bell, London 1902, pp. 109-110. 42 17 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 Society45, guidata da Cobbe, produsse centinaia di opuscoli, promosse campagne per la completa abolizione, denunciò le crudeltà efferate, le illegalità e, soprattutto, mise in discussione la filosofia e i metodi della scienza medica. Laureate in medicina46, letterate, scrittrici apportarono il proprio punto di vista sul rapporto tra scienza ed etica. “Prurigo secandi”: la sperimentazione sulle donne e sugli animali Un tema ricorrente negli scritti contro la vivisezione è l’analogia tra la violenza che donne e animali subivano per mano dei medici, la preoccupazione per la progressiva ingerenza medica in ogni aspetto della vita delle donne, in particolare nella sfera riproduttiva. A partire dall’inizio del XVIII l’introduzione del forcipe aveva esteso il potere medico alla pratica ostetrica portando a compimento quel processo di esclusione delle donne dalla scena del parto che aveva preso avvio nel Medioevo. Mentre l’affermazione nelle specializzazioni ostetrica e ginecologica dava ai medici accesso quasi incondizionato ai corpi delle donne, le scienze biologiche, antropologiche e psichiatriche teorizzavano l’inferiorità femminile e offrivano una giustificazione scientifica all’esclusione sociale e politica delle donne: il ruolo “naturale” della donna, si disse, si limitava esclusivamente alla sfera riproduttiva; esse erano governate dalla fisiologia, dal corpo. Era convinzione di medici e psichiatri, infatti, che ovaie e utero presiedessero a tutte le funzioni dell’organismo femminile47. Poiché, si diceva, tutti i processi vitali sono rivolti al fine della riproduzione, non poteva sorprendere che gli organi sessuali fossero determinanti nella vita, nella salute e nello stato mentale delle donne. “È come se il Signore, nel creare il genere femminile avesse preso un utero e vi avesse costruito intorno la donna”48. La periodicità del ciclo mestruale si rifletteva in una instabilità nervosa che poneva le donne nella condizione di dover essere costantemente controllate e dominate. Dominio, controllo, svalutazione, oggettivazione orientavano dunque la pratica medica che si era proclamata maschile, guidata da valori maschili. Le prime donne laureate in medicina scoprirono con indignazione il trattamento irrispettoso e degradante inflitto alle donne povere nei reparti dei charity hospitals: immobilizzate da strumenti di contenzione, con la pelvi sollevata e le gambe divaricate, esposte all’osservazione degli studenti e alle loro battute salaci. Una vera tortura per donne a cui si predicava la “modestia” e la riservatezza nel comporta45 Alla società aderirono autorevoli personalità politiche e letterarie (Lord Shaftesbury, noto per il suo impegno contro lo sfruttamento dei bambini, era il presidente, Thomas Carlyle e il cardinale Manning erano i vice presidenti; tra gli aderenti: Charles Dickens, Wilkie Collins e John Stuart Mill). 46 Furono almeno 50 le donne che avevano avuto una formazione in medicina che presero parte a manifestazioni contro la vivisezione. Mary Ann Elston, Women and Anti-vivisection in Victorian England, cit. 47 Elaine Showalter, Female Malady: Women, Madness, and English Culture, 1830-1980, Pantheon, London 1985. 48 Citato in Mary Poovey, “Scenes of indelicate Character”: The Medical “Treatment” of Victorian Women, in “Representations”, vol. 14, 1982, p. 145. 18 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 mento e nel vestire e che negli ospedali erano considerate, al pari degli animali, “materiale clinico”, “soggetti adatti per esperimenti dolorosi”. Scrive Anna Kingsford: Una donna sta morendo di tisi. È all’ultimo stadio. Entrambi i polmoni sono compromessi e il petto è pieno di liquido. Per molte ore è stata incosciente e se fosse stata lasciata sola sarebbe morta relativamente in pace, senza tornare alla coscienza. Ma non sarebbe stato così. Doveva affrontare ancora un’altra lezione in cambio della carità ricevuta e come punizione per essere povera. Piegato su di lei il medico le grida di aprire gli occhi. Lei cerca inutilmente di obbedirgli. Allora lui prende uno spillo dal suo camice e lo conficca sotto la superficie di ciascuna palpebra. Lei grida e lui sottrae lo spillo dicendo: “lo senti, vero? Allora perché non apri gli occhi?”. Quindi punge le mani e le gambe e ogni puntura provoca un debole gemito e un tentativo di resistenza. Poi, con l’aiuto degli studenti la solleva dal letto: sta morendo ed è assolutamente incapace di muoversi49. Per i poveri, come per gli animali, non si ricorreva all’anestesia, neppure per le cauterizzazioni. E questo valeva tanto più per le donne che si pensava fossero meno sensibili al dolore. Nei manuali di ginecologia e fisiologia si poteva leggere che le donne erano uomini incompleti; instabili ed eccitabili per natura, non avrebbero dovuto essere curate da altre donne: per guarire avevano bisogno della fermezza, dell’equilibrio e della calma maschile. Pertanto ad Anna Kingsford e ad Elizabeth Blackwell l’accesso ai reparti di ginecologia e di ostetricia non fu consentito. Elizabeth Blackwell e il ruolo delle donne in medicina Fu Elizabeth Blackwell50, la prima donna iscritta all’albo dei medici in Gran Bretagna, a soffermarsi sul nesso vivisezione e accanimento chirurgico sulle donne. Nella sua opera Scientific Method in Biology, nel capitolo Prurigo Secandi, Blackwell scriveva: “Un altro grave pericolo etico connesso alle sperimentazioni senza limiti sugli animali è l’enorme aumento di audaci operazioni chirurgiche sugli esseri umani”. Operazioni che comportavano sempre gravi menomazioni fisiche, avevano un tasso elevato di mortalità e che erano diffuse soprattutto in Francia dove la vivisezione, ovvero “l’irrazionale mutilazione di creature vive e senzienti”, la furie opératoire era libera da ogni vincolo. Blackwell si riferiva all’enorme aumento delle ovariectomie che chiamava “la castrazione delle donne”: oltre 500.000 in Fran49 Edward Maitland, Anna Kingsford: Her Life, Letters, Diary and Work, George Redway, vol. 1, London 1886, vol. 1, p. 82. Si veda il breve profilo biografico di Anna Bonus Kingsford alla nota 57. 50 Elizabeth Blackwell (1821-1910) nacque e crebbe a Bristol. Il padre, attivo nel movimento abolizionista, favorì l’istruzione delle figlie. Nel 1831 la famiglia si trasferì a New York dove il padre riprese la sua attività nel ramo della raffineria dello zucchero e nella protesta antischiavista. Nel 1849, dopo essere stata rifiutata da molte istituzioni scolastiche, si laurea in medicina, un evento che fece sensazione sia in Inghilterra che negli Stati Uniti. Nel 1849 si iscrisse alla Maternité di Parigi, alla specializzazione ostetrica e quindi si trasferì aa Londra al St. Bartholomew Hospital, dove non le fu concesso di accedere ai reparti dove erano ricoverate le donne. Nel 1850 ritornò negli Stati Uniti e nel 1853 aprì un ambulatorio per donne e bambini poveri che divenne poi la New York Infirmary for Women. A Londra, dove fece ritorno nel 1858, fu iscritta all’albo dei medici, la prima donna a ricevere un tale riconoscimento. Suffragista, attiva nel movimento per l’abolizione del Contagious Diseases Acts e anti-vivisezionista, si impegnò per l’ingresso delle donne in medicina, convinta che esse avessero un insostituibile contributo da offrire alla professione, soprattutto nell’igiene e nella prevenzione. ODNB, voce curata da Mary Ann Elston, http://www.oxforddnb.com/view/article/31912. 19 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 cia nel 1896. Sulla base delle fonti mediche da lei utilizzate Blackwell valutava che in Europa una donna su 250 fosse stata sottoposta all’operazione51. Il potere di distruggere la capacità riproduttiva femminile era la più brutale delle affermazioni di dominio. Disturbi banali, di carattere nervoso o mestruale, interpretati come strettamente connessi alle funzioni ovariche, potevano condurre all’ovariectomia. Fu questa mutilazione di massa a fare di Blackwell una appassionata antivivisezionista, ad identificare la chirurgia sessuale con la tortura degli animali, a convincerla che medicina era stata fuorviata dai suoi fini. Solo le donne, il cui lavoro distintivo era la “creazione gioiosa” della vita, che erano le “incarnazioni della grande vita materna”, avrebbero potuto riportare la professione medica entro i confini morali che le erano propri e farne una scienza di vita e non di morte. “La natura femminile”, ovvero “il potere spirituale della maternità” faceva delle donne “le guide morali della vita”. Scorgiamo un’indicazione di questo provvidenziale impulso all’azione morale nella grande e crescente devozione delle donne al sollievo della sofferenza sociale e nella loro tenace opposizione alle pratiche sbagliate che caratterizzano la nostra epoca. Queste madri spirituali del genere umano sono spesso le incarnazioni più vere della grande vita materna, rispetto alle madri nel senso fisico del termine52. Per assolvere al loro compito di guide spirituali le donne avrebbero dovuto avere il coraggio di affermare il proprio punto di vista e abbandonare la convinzione che il genere umano fosse rappresentato dagli uomini. Troppe studentesse e laureate, che finalmente intravedevano la possibilità di farsi strada nella professione, accettavano acriticamente di ciò che veniva insegnato nelle Università, inclusa la sperimentazione spregiudicata su animali ed esseri umani. La vivisezione, capovolgimento dei fini dell’arte di guarire, era lo studio della morte; essa era inutile dal punto di vista terapeutico, gratificava la curiosità morbosa, dava una direzione distorta dell’attività mentale e distruggeva quella “intelligente empatia” con la persona che soffre. Il ruolo delle donne in medicina dunque, sarebbe stato in primo luogo quello di sanare la frattura tra etica e scienza. Nessun intervento medico – sosteneva Blackwell – si può sottrarre a considerazioni di carattere morale; ignorare l’aspetto etico avrebbe comportato un grave danno alla professione, agli individui e alla società. Solo le donne avrebbero potuto contrastare il materialismo che portava a considerare importante solo l’aspetto puramente fisico della vita e che considerava esseri umani e animali al pari di macchine da studiare. Sono portata a concludere riguardo alla nostra professione che il culto dell’intelletto, o della cosiddetta conoscenza, sia un fine in se stesso, indifferente ai mezzi necessari per raggiungerlo. È l’errore più grave che la scienza possa commettere. Questo falso principio, se fatto proprio dalla professione medica, la degraderebbe53. L’autentico progresso umano, a parere di Blackwell, si misurava sull’accrescimento del rispetto per la vita. “La nostra reverenza per il principio del51 Elizabeth Blackwell, Scientific Method in Biology, cit., p. 120. Elizabeth Blackwell, The Influence of Women in the Profession of Medicine (1889), in Ead., Essays in Medical Sociology, cit., p. 10. 53 Ivi, p. 22. 52 20 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 la vita cresce con l’estendersi della nostra percezione intellettuale della sua universalità e del suo illimitato potere di sviluppo”54. Quando l’intelligenza si separa dalla coscienza l’essere umano si trasforma in una forza distruttiva. Un errore morale conduce sempre ad un errore intellettuale e la medicina, attraverso metodi violenti non avrebbe mai potuto penetrare i segreti della vita. Un’altra conseguenza distruttiva della vivisezione era quella che essa esercitava sulla psiche di medici e studenti, minacciando la loro integrità morale e mentale, era l’indifferenza. L’abitudine a maneggiare strumenti di contenzione per soffocare la resistenza di una creatura vivente aveva un effetto demoralizzante; essi si allenavano all’indifferenza di fronte al dolore e l’influenza dannosa si estendeva a tutti coloro che inventano gli strumenti di tortura, li compravano e li vendevano e a coloro che procuravano, imprigionavano gli animali. Conversando con gli studenti [...] mi sono resa conto che la loro esperienza è sempre la stessa: prima il trauma e la repulsione, poi la tolleranza e poi l’indifferenza [...] Ma gli uomini considerano la loro progressiva imperturbabilità come un segno di forza mentale, e ne provano orgoglio55. Controllare le proprie emozioni e subordinarle alla ragione era solo uno dei volti della scienza, aveva osservato Cobbe nel 1882 in The Janus of Science. Tra l’indifferenza, il distacco e il piacere di infliggere dolore, il passo era breve. La separazione tra desiderio di conoscenza fine a se stessa e scopi puramente umani quali la volontà di curare era alla radice di una tale perversione. [Nei vari trattati] non ci imbattiamo mai una volta in un appello contro la ripetizione di esperimenti dolorosi, in un invito alla cautela nelle torture estreme, o in una espressione di pietà o rammarico [...], al contrario troviamo ripetutamente frasi come “esperimenti molto interessanti”, “meravigliosa infiammazione cerebrale”56. Anna Bonus Kingsford: spiritualizzare la vita Come Cobbe e Blackell, anche Anna Bonus Kingsford, nel corso della sua esperienza professionale aveva ripetutamente sentito definire la vivisezione come un’arte, un’ “investigazione artistica” 57. La critica alla scienza medica da un punto di vista femminista è centrale anche nel pensiero di Anna Kingsford, anch’essa laureata in medicina. A differenza di 54 Ead., Scientific Method in Biology, cit., p. 92. Ivi, pp. 112-113. 56 Frances Power Cobbe, The Janus of Science, cit., p. 5. 57 Anna Bonus Kingsford (1846-1888), laureata in medicina, suffragista e spiritualista, nacque a Maryland Point, nell’Essex, da una famiglia di origini italiane. Scrisse di teosofia, vegetarismo e vivisezione. All’età di 24 anni si convertì al cattolicesimo e criticò la Chiesa per il suo silenzio sulla questione della vivisezione. Nel 1872 acquistò e diresse il periodico “The Lady’s Own Paper” che pubblicò un intervento di Frances Power Cobbe sulla vivisezione. Nel 1874 decise di intraprendere gli studi di medicina, si recò in Francia e si laureò nel 1880; la sua tesi di laurea, The Perfect Way in Diet, fu pubblicata a Londra l’anno successivo; nel 1882 apparve il saggio The Uselessness of Vivisection e Notes by a Medical Student. Si veda la voce a cura di Lori Williamson in ODNB, http://www.oxforddnb.com/view/article/15615. 55 21 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 Blackwell che era giunta a posizioni antivivisezioniste in seguito alla sua esperienza clinica, Anna Kingsford aveva intrapreso la professione con il preciso intento di opporsi alla vivisezione. Uno dei temi cari all’autrice, e che percorre con vari accenti anche molti altri scritti femministi contro la vivisezione, è il tema del limite. Esiste un limite morale nell’uso dei mezzi volti ad acquisire conoscenza. L’accettazione del limite proveniva dalla rinuncia all’idea del dominio. Il vero progresso umano, infatti, non derivava dal dominio, dal sacrificare gli altri al proprio benessere, bensì dal sacrificio di sé per gli altri. “Se l’unico modo che l’umanità ha individuato per la sua salvezza è il sacrificio di altri esseri viventi, forse non merita di essere salvata”58. Da che cosa derivava la separazione della scienza dall’etica? Dalla negazione di quella che Kingsford chiamava l’“unità filosofica”, “l’unità della natura morale dell’essere umano”. La separazione tra corpo, psiche e mente – spiega – impediva la reale comprensione dei fenomeni che la scienza pretendeva di studiare e comprendere, degradava il livello morale degli esseri umani, distruggeva la dignità dei sentimenti e della responsabilità. La responsabilità era intesa da Kingsford come un “privilegio” degli esseri umani e si doveva rivolgere a tutti i viventi. Infatti, nella visione della teosofa la scelta del vegetarismo era cruciale59. Occorreva riconoscere che la vivisezione era il prodotto di una cultura che ammetteva l’uccisione degli animali per l’alimentazione umana. Il fondamento della vera giustizia è il senso della solidarietà. Tutte le creature, dalla più elevata alla più semplice, si danno la mano di fronte a Dio. Non cominceremo mai a spiritualizzare le nostre vite e i nostri pensieri, ad elevarci e illuminarci, finché non riconosceremo questa solidarietà, finché non guarderemo alle creature della mano di Dio, non come oggetti di caccia, da macello o da laboratorio, ma come anime viventi60. “Una scienza basata sulla tortura – continuava Kingsford – non è una vera scienza così come una religione basata sulla tortura non è una vera religione. E invocava l’avvento di una nuova Riforma, questa volta nel campo della scienza”61. Gli strumenti usati nei nostri laboratori di vivisezione sono molto simili a quelli usati ai tempi del Medioevo. Il moderno arsenale è completo come lo era quello dei tempi di Isabella di Spagna – ora l’animale muto e innocente sostituisce l’ebreo o l’eretico, e le creature che l’uomo giudica inferiori a sé sono legate alla ruota e torturate, con la speranza di estorcere loro i segreti della vita, ignorando il fatto che la Natura, oltraggiata e agonizzante, risponde come la vittima umana alla ruota, più sovente con una bugia che non con la verità62. 58 Edward Maitland, Anna Kingsford, cit., p. 80. 59 Cobbe e Blackwell, come si vedrà in seguito, non includevano nella loro condanna morale l’allevamento e la macellazione degli animali. L’essere umano per Blackwell è capo del mondo animale ed ha una responsabilità precisa verso le “creature inferiori”. “L’uomo non è il padrone del mondo, ma solo un anello nella catena della vita animale”. 60 Anna Bonus Kingsford, Addresses to Vegetarians, John M. Watkins, London 1912, p. 150. 61 Ead., Unscientific Science. Moral Aspects of Vivisection (1882), in Anna Bonus Kingsford-W. J. Colville, Spiritual Therapeutics or Divine Science, Educator Publishing, Chicago 1888, p. 301. 62 Ibidem. 22 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 La crudeltà è sempre crudele – continuava Kingsford –, e nella controversia sulla vivisezione vedeva risorgere l’antico “assioma ecclesiastico” che subordinava i mezzi al fine. Nello scritto The Uselesness of Vivisection, dopo aver riportato numerose testimonianze mediche sull’inapplicabilità delle osservazioni sugli animali all’organismo umano, si chiedeva quali fossero le ragioni di una difesa tanto tenace da parte della classe medica di una pratica che conduceva a deduzioni erronee. La vivisezione è il rifiuto del sentimento religioso, dell’empatia, e della dottrina della responsabilità umana come dettata dalla superstizione e insostenibile. È la determinazione assoluta di dissociarsi da tutti tranne da coloro che si uniscono in questo ripudio e di fare della pratica della vivisezione l’espressione di questa determinazione63. Le risposte dei medici sulla questione della vivisezione che aveva raccolto nel corso della sua esperienza professionale le avevano rivelato che quell’ostinazione derivava dalla volontà di potere e dall’ambizione. La vivisezione era diventato il simbolo della libertà della scienza da considerazioni etiche e da interferenze esterne. “Il lavoro del fisiologo – le confessò un medico – è quello della scienza pura e meno egli si preoccupa di questioni umanitarie e più sarebbe migliorato come artista”64. “Noi – aveva affermato un altro fisiologo – dobbiamo rivendicare il diritto di praticare la vivisezione non perché è stata o è utile, ma perché potrebbe esserlo in futuro [...] Se noi permettessimo a moralisti e clerici di porre limitazioni alla scienza, cederemmo a loro la nostra fortezza”65. Una fortezza resa inespugnabile dal potere corporativo della professione medica, come aveva scritto Cobbe nel 1881 in The Medical Profession and Its Morality. Come spiegare altrimenti lo schierarsi di tutta classe medica “per un libero tavolo di vivisezione”? La crescente influenza dei medici in ogni ambito della vita sociale, scriveva la femminista irlandese, stava assumendo il carattere del dispotismo e nei medici si poteva osservare il “tono del dominio, per non dire 66 dell’arroganza” che stava conducendo alla medicalizzazione della vita. Da dove derivava il loro potere? Una professione redditizia che aveva alle spalle studi relativamente poco costosi, composta da parvenus che faceva dell’ateismo e del materialismo utilitarista e volgare la propria filosofia, che portava a non curarsi delle “anime umane” se queste abitavano i corpi delle persone disprezzate e marginalizzate. Medici pronti a sacrificare il benessere dei pazienti alla propria affermazione, all’acquisizione di abilità manuali nel campo della chirurgia e non da ultimo al guadagno personale come le pressioni per rendere obbligatorie le vaccinazioni ben esemplificavano. Professionisti uniti da un corporativismo omertoso che copriva con le menzogne e i silenzi le morti causate da vaccini o da operazioni audaci e inutili come l’ovariectomia. Un corporativismo sessista che si opponeva in ogni modo, anche con le proteste pubbliche, all’ingresso delle donne in medicina e che metteva a rischio le libertà individuali, minacciava di uccidere il senso morale nella 63 Ead., The Uselessness of Vivisection, in “Nineteenth Century”, February 1882, p. 183. Ivi, p. 182. 65 Ibidem. 66 Frances Power Cobbe, The Medical Profession and Its Morality, in “Modern Review”, 1881, 2, p. 297. 64 23 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 società, distruggeva il valore della sollecitudine nella medicina e, come scriverà nel 1895 Mona Caird, conduceva ad ignorare le cause sociali della malattia. L’aria pura, il cibo genuino, le abitudini semplici, le attività intellettuali, il lavoro, lo svago, la ricreazione, i piaceri della socialità sono cose che determinano la salute e la loro mancanza causa malattia. Io so purtroppo che per gran parte della popolazione queste necessità umane sono irraggiungibili. Ma ciò non muta la legge naturale che ne fa condizione di salute né ci autorizza a vincere la malattia attraverso il nostro vile abuso di potere nei confronti degli animali67. La vivisezione non faceva che posticipare il raggiungimento delle giuste condizioni della salute e del benessere in un futuro lontano, quello “che non viene mai”. E intanto si andava radicando la convinzione della supremazia della forza e la tentazione di infliggere torture ad altri esseri umani diventava di giorno in giorno più forte. Frances Power Cobbe: la “Religione del Futuro” La riflessione sui caratteri della scienza moderna è presente con vari accenti in tutti gli scritti delle antivivisezioniste, ma è Frances Power Cobbe che più di ogni altra autrice si sofferma sugli esiti micidiali della separazione tra scienza ed etica. Il culto della scienza era, a parere di Cobbe, la superstizione moderna di fronte alla quale si arrestava il giudizio critico e si chinava in modo reverente il capo. A differenza di quanto accadeva per la religione e il diritto, si pretendeva che le leggi della medicina poggiassero su fondamenti scientifici non soggetti a giudizio morale, un nefasto nonsenso che proteggeva medici e fisiologi dalla responsabilità. Così il sapere si riduceva a fredda conoscenza e la conoscenza ad una forma di potere, ad uno strumento di controllo sulla natura e gli altri esseri umani, un sapere incapace di valutare criticamente i suoi stessi presupposti e obiettivi, che ignorava i propri limiti e si riduceva ad una macchina accumulatrice di fatti. Possiamo pensare alla verità come a una immensa pila di fatti sovrapposti ordinatamente in una piramide di una scienza come la piramide di teschi di Timur? Collezionare un milione di fatti, verificarli, classificarli e tramandarli alla generazione successiva che aggiungerà altre migliaia di fatti e ricostruirà la piramide su una base diversa e con un piano diverso? Se questa è la verità di cui la scienza può vantarsi, allora ha raggiunto il suo scopo68. Ad essere inquietante al masso grado era il “nuovo vizio della crudeltà scientifica”. Non si trattava dell’antico vizio della crudeltà fine a se stessa, quella che si compie in preda ad impulsi passionali o sotto l’influenza dell’alcol; chi la esercitava non era il rozzo carrettiere o il macellaio, bensì uomini istruiti, ben nutriti e ben vestiti, calmi, freddi, determinati, che sapevano quello che facevano; erano uomini 67 Mona Caird, Vivisection, Miller, London 1895, p. 3. Su Mona Caird, autrice, fino a tempi recenti, assai trascurata dagli studi, si veda: Ann Heilmann, Mona Caird (1854-1932): Wild Woman, New Woman, and Early Radical Feminist Critic of Marriage and Motherhood, in “Women’s History Review”, vol. 5, 1996, 1, pp. 67-95. 68 Frances Power Cobbe, The Scientific Spirit of the Age, in “Contemporary Review”, vol. 54, 1888, p. 133. 24 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 di scienza che speravano di trovare la “Religione del Futuro” e di lasciare la propria impronta nel loro tempo69. Nel 1883 nella volontà di fustigare i fisiologi, Cobbe scrive il suo saggio più mordace: Science in Excelsis. In questa breve pièce teatrale ella immaginava che gli angeli, dopo secolari speculazioni sul libero arbitrio e la predestinazione, che non avevano portato ad alcun risultato, si rivolgessero alla scienza e in particolare ai metodi della fisiologia e decidessero di praticare la vivisezione su esseri inferiori, non già sugli umani, ma su quegli eminenti fisiologi che avevano dedicato la loro vita all’avanzamento del sapere scientifico. Era giunto il momento di verificare se i risultati delle sperimentazioni sugli animali avessero validità per gli umani, un quesito che, nonostante il sacrificio di un numero enorme di esseri viventi, era rimasto insoluto. La parte centrale dello scritto è un dialogo serrato tra l’arcangelo Raffaele e i fisiologi. Noi siamo angeli e voi siete uomini; e in base alla vostra stessa logica abbiamo il diritto di fare di voi ciò che vogliamo [...]. Inoltre le scimmie, come voi stessi avete dimostrato, sono molto vicine a voi, mentre noi angeli rifiutiamo ogni legame con voi miserabili mortali [...] Siamo più forti e abbiamo intenzione di trattarvi nella stessa maniera con cui voi avete trattato i cani. [...] La Pietà è fuggita di fronte alla Scienza che sola, d’ora in avanti, guiderà le nostre azioni70. La conseguenza più tragicamente distruttiva, a parere di Cobbe, era l’annientamento del sentimento di compassione, negato, deriso e calpestato dalla nuova idolatria della scienza. Nei suoi numerosissimi scritti non si stancherà di portare le prove – immagini e parole – di questo crimine contro la sensibilità umana. Nel 1888, in The Scientific Spirit of the Age, Cobbe sosterrà che lo spirito scientifico del tempo, assertivo e analitico, stava sottraendo all’umanità i suoi valori più elevati e stava invadendo ogni aspetto della vita. Non sono così cieca da ignorare gli splendidi risultati della scienza fisica moderna, né i benefici che le numerose applicazioni dello spirito scientifico hanno portato in molti campi. È l’intrusività e l’oppressione dello spirito scientifico in ambiti che non gli sono propri e ancora più spesso il suo predominio in sfere in cui il suo posto dovrebbe essere subordinato contro cui è necessario protestare71. Quali erano i metodi della scienza? Si chiedeva Cobbe, dichiarando di volersi limitare solo alle “scienze fisiche”. L’osservazione, l’accuratezza, l’induzione erano facoltà che possedevano anche gli animali: una volpe è una acuta osservatrice, è capace di interpretare la realtà, i pericoli, le probabilità e di raggiungere una vera conoscenza, per esempio del funzionamento delle trappole. Ma gli esseri umani, al fine di raggiungere la completezza della loro personalità, avrebbero dovuto coltivare l’immaginazione, il sentimento poetico, artistico e religioso. 69 Ead., Life of Frances Power Cobbe, by Herself, vol. 2, cit., pp. 606-607. Frances Power Cobbe, Science in Excelsis. A New Vision of Judgement, in Barbara T. Gates, In Nature’s Name. An Anthology of Women’s Writings and Illustrations, University of Chicago Press, Chicago-London, pp. 145-154. 71 Frances Power Cobbe, The Scientific Spirit of the Age, cit., p. 128. 70 25 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 Con il suo materialismo, la negazione dell’etica ridotta a “comoda regola per ogni categoria di animali intelligenti”, il darwinismo aveva distrutto la possibilità “di reverenza” per i dettami della coscienza. Lo spirito scientifico aveva minato i fondamenti stessi della morale, era una dottrina mortifera che riduceva ogni cosa ad un principio utilitaristico, che impoveriva la vita e interpretava la società come un teatro di lotta. Ci si sarebbe aspettati che la dottrina darwiniana dell’origine dell’uomo avrebbe causato un nuovo slancio di simpatia verso altri popoli e verso gli animali. Ogni biologo oggi conosce decine di ragioni migliori di quelle di San Francesco per chiamare gli uccelli e gli animali “piccoli fratelli e sorelle”. Al contrario, invece di instillare la dolcezza del santo di Assisi, la scienza ha insegnato ai suoi devoti cultori a guardare al mondo come una scena di lotta universale, in cui la regola deve essere: “ognuno per sé e Dio per tutti”72. La clinica stessa si stava trasformando in un laboratorio, simbolo e misura della scientificità della disciplina. La vivisezione era il macabro rituale dell’ideale del progresso, celebrazione della morte e del dolore. Impossibile dunque riconciliare la scienza con l’umanità aveva scritto nel 1884 in The Right of Tormenting. La scienza ignora l’umanità e non si riconcilierà con nulla che possa rallentare la sua invasione di un centimetro”73. Io non nego, proseguiva Cobbe, che un rimedio per le malattie del nostro “tabernacolo di carne” rappresenti un grande beneficio, ma il prezzo prospettato è troppo alto. Il sollievo dal dolore, il prolungamento della vita non sono i beni più importanti a cui aspirare. Il tema della consapevole rinuncia a un vantaggio sulla base di principi morali era stato avanzato due anni prima anche da Vernon Lee74. Vernon Lee: la vivisezione come retrocessione morale e disonore Nel 1882, infatti, Vernon Lee era intervenuta sulla legittimità della vivisezione, una questione che l’aveva a lungo assillata e che voleva affrontare rifuggendo dalla “deplorevole alternativa del progressivo e disgustato allontanamento dalla scienza o della sofisticazione compiaciuta del giudizio morale”75. Nelle argomentazioni avanzate dagli antivivisezionisti, nelle loro critiche alla scienza Vernon Lee intravedeva il riproporsi di un nuovo dualismo. Coloro che condannavano la pratica sul piano morale erano indotti a rifiutare la scienza e a rivolgersi all’inintelligibile. Come una persona che crede nel metodo scientifico, nello sviluppo umano e nell’evoluzione della morale, desidero rivolgermi a coloro la cui indignazione e ripugnanza io condivido pie72 Ivi, p. 136. The Right of Tormenting, Victoria Street Society, London 1884, p. 55. 74 Violet Paget (pseudonimo Vernon Lee) (1856-1935), storica dell’arte e scrittrice, nacque in Francia presso Boulogne. Con la famiglia soggiornò a lungo in Italia, Francia, Germania e Svizzera, acquisendo una profonda conoscenza di quattro lingue e una sensibilità internazionalista. Importanti i suoi studi pionieristici di psicologia e teoria estetica e i suoi saggi di viaggio. Femminista e pacifista, durante il Primo conflitto mondiale fu tra le prime a denunciare il blocco navale da parte della Gran Bretagna nei confronti della Germania e previde con lucidità fin dal 1915 le conseguenze del conflitto. S. Oldfield, Doers of the Word. British Women Humanitarians 1900-1950, Continuum, London 2006. 75 Vernon Lee, Vivisection: An Evolutionist to Evolutionists, in “Contemporary Review”, vol. 41, 1882, p. 788. 73 26 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 namente, ma il cui disgusto di fronte ad un abominio favorito dalla scienza li sta portando a cercare un credo filosofico nell’inintelligibile, un codice morale nell’arbitrarietà e un futuro ideale nell’impossibile76. La questione doveva essere compresa evitando rigide contrapposizioni, analizzandola come un dilemma morale che presentava due anomalie di fondo. La prima anomalia della vivisezione risiedeva nella relazione tra creature separate in modo netto nei loro interessi e diseguali nel loro potere: da una parte le vittime che non ricevevano alcun beneficio e pativano tutte le pene, dall’altra coloro che compivano il sacrificio e che erano al tempo stesso i soli colpevoli, accusatori e giudici. Una asimmetria che rendeva “i fisiologi inadatti a valutare la legittimità morale della vivisezione”. La seconda anomalia risiedeva nel fatto che ci si trovava di fronte non già ad un male ereditato dal passato che poteva essere eliminato con l’avanzamento del progresso umano, ma di una pratica nuova, che avrebbe potuto svilupparsi indefinitamente, fondata su una filosofia che prometteva un futuro prospero e una coscienza sicura. Vernon Lee richiamava l’attenzione sulle enormi possibilità di legittimazione che la pratica medica rischiava di ottenere in un mondo che aveva abbandonato le antiche certezze e che tendeva ad avere un atteggiamento di “acquiescenza apatica” nei confronti della nuova religione della scienza. La necessità di produrre prove e di sottoporle a verifica è condizione di ogni scienza. La storia, come la chimica, la botanica richiedono l’acquisizione di fatti, dati, statistiche e le leggi dell’evidenza sono comuni ad ogni disciplina. La fisiologia è una scienza e il modo di ottenere, verificare, discutere e dimostrare i fatti non può che essere dal punto di vista intellettuale, simile a tutte le altre scienze e come tutte le altre scienze poteva portare dei vantaggi all’umanità. Convinta che la vivisezione potesse rivelarsi utile al genere umano, si proponeva di dimostrare che si trattava di un vantaggio al quale si doveva rinunciare. La maggior parte degli antivivisezionisti facevano appello a un senso astratto di giustizia e di compassione, cadevano in un sentimentalismo che non era in grado di incrinare la fiducia nella scienza. Il vero orrore della vivisezione era quello che si provava di fronte a qualcosa di disonorevole, l’indignazione verso l’inganno, la prevaricazione, a tutto ciò offende il senso profondo della giustizia. È lecito infliggere sofferenza a pochi per il vantaggio di molti? Sì, se i pochi fanno parte dei molti e condividono equamente con gli altri la possibilità di soffrire ed equamente condividono la possibilità del vantaggio; No se i pochi sono separati dai molti, se solo loro perdono e soltanto loro sono nell’impossibilità di vincere77. Tenere tutti i vantaggi per sé a spese di altri è disonorevole. Affermare che la vivisezione è disonorevole significava per la scrittrice affermare che era contraria agli esiti dell’evoluzione umana, ovvero a quelle caratteristiche morali che si sono lentamente formate nel tempo, al principio morale della reciprocità dei benefici. La vivisezione era dunque una retrocessione nel cammino dell’evoluzione morale, un cedimento nella percezione del male che compiamo verso gli altri per i nostri desideri, mentre la nostra migliore qualità è quella di rinunciare ai nostri desideri per 76 77 Ivi, p. 796. Ivi, p. 800. 27 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 un senso di giustizia. Preferendo la soddisfazione di un desiderio alla giustizia deformiamo la nostra natura morale e intellettuale e degradiamo la coscienza. La tentazione di riconoscere la vivisezione come una pratica legittima è una tentazione molto grande; la vivisezione rappresenta lo strumento più valido, o meglio la scorciatoia più valida per ottenere una conoscenza, a cui sono connessi non solo un gran numero di problemi fisici e spirituali, della nostra vita presente e futura, di salute morale e malattia che hanno quasi un’importanza religiosa per noi che abbiamo rinunciato alle nostre antiche convinzioni, ma [...] non ancora temprati dalla forza di una nuova fede che ci chiede semplicemente di fare il bene e sopportare il dolore senza ricompensa – è in realtà un elisir mentale con cui riscaldiamo le nostre anime gelide, nel calore spirituale di una religione della scienza e dell’umanità che ha sostituito la vecchia religione di Cristo e delle sue ferite fino a che il mondo non sarà pronto per la giustizia78. Vernon Lee spostava l’attenzione dalla crudeltà insita nella pratica alla distorsione del comune sentire, a quell’indebolimento del giudizio morale che intravedeva nella società contemporanea. La tentazione a cui cedono coloro che non hanno la forza di mettere in discussione la fiducia incondizionata nel progresso umano e preferiscono dare per scontato che tutti i suoi aspetti siano buoni e non sottoporli ad una analisi morale, cedevano ad un atteggiamento di acquiescenza apatica. Per contrastarlo non era sufficiente l’appello alla compassione, ma era necessario rafforzare il senso della giustizia. Se il principio della necessità dell’avanzamento della scienza in vista di una futura diminuzione delle sofferenze umane si fosse radicato nelle coscienze, se fosse diventato “il test morale più elevato”, non ci sarebbe stato più limite al sacrificio, di vite umane e animali, per raggiungere questo bene assoluto. E non ci sarebbe stato limite alla deformazione della verità. Lind van Hageby e il Brown Dog Affair A partire dai primi anni del secolo, l’opposizione alla vivisezione cambiò i suoi caratteri. Nel 1898 Cobbe si dimise dalla VSS, che lei stessa aveva fondato, perché i suoi membri erano ormai disposti al compromesso, ovvero ad accettare una qualche forma di regolamentazione. Fondò la British Union for the Abolition of Vivisection (BUAV), organizzazione attiva ancora oggi, e dopo poco si ritirò dalla scena. La personalità di maggior rilievo nel movimento a partire dai primi anni del secolo fu Lind af Hageby79. Nipote del ciambellano del re di Svezia e fondatrice nel 1906 della Anti-vivisection and Animal Defence Society, si impegnò per una medicina alternativa che prendesse in considerazione anche l’origine sociale della malattia. La associazione da lei fondata tentò, benché con scarso successo, di dar vita e viluppo ad un istituto di ricerca fisiologica e patologica, senza ricorso alla vivise78 Ivi, p. 806. Lind af Hageby (1878-1963), si trasferì a Londra nel 1902, scrisse regolarmente per quaranta anni sulla “Anti-vivisection Review” che lei stessa aveva fondato nel 1906. Organizzò il primo congresso internazionale antivivisezionista che si tenne a Londra nel 1909. Durante la Grande guerra fondò il Purple Cross Service per la cura dei cavalli feriti. ODNB, voce curata da Mary Ann Elston, http://www.oxforddnb.com/view/article/40998. Per un elenco delle sue opere più importanti rinvio alla Bibliografia a cura di Annalisa Zabonati nella rubrica Strumenti di ricerca in questo numero della rivista. 79 28 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 zione. Non bastava più, a parere della femminista svedese, deridere e diffamare i fisiologi-torturatori, “i demoni usciti dall’inferno”, ora l’attivista doveva essere preparata/o dal punto di vista scientifico, acquisire una conoscenza approfondita del mondo animale, sapere di chimica, geologia, e così via. Hageby inoltre univa l’impegno contro la vivisezione a quello per la diffusione della dieta vegetariana e per il pacifismo e credeva nella connessione e nel rafforzamento reciproco di queste istanze. La questione del vegetarismo fino ad allora era stata la meno condivisa tra le antivivisezioniste. Dalle autrici di maggior rilievo, ad eccezione di Anna Bonus Kingsford, il tema della dieta era per lo più evitato. Cobbe, ad esempio, aveva rinunciato al suo sport preferito, la pesca, ma, come Blackwell, faceva una distinzione tra uccisione degli animali a scopo alimentare – lecita – e tortura – illecita – e tra allevamenti rispettosi del benessere degli animali e il loro sfruttamento indiscriminato. Esse, infatti, non abbandonarono mai completamente l’idea della superiorità degli esseri umani rispetto agli animali che nei loro scritti vengono spesso denominati “lower animals” o “brutes”. Hageby, inoltre, inaugurò un nuovo modo di protestare, quello delle manifestazioni pubbliche di massa, manifestazioni che si susseguirono, in particolare dal 1906 al 1910 durante il brown dog affair. Iscrittasi con l’amica Liesa von Shartau alla London School of Medicine for Women, assistette a numerose sperimentazioni su animali. Nel 1903 apparve il diario della loro esperienza in cui veniva descritto un episodio di una sperimentazione su un piccolo cane nero, sottoposto a ripetuti interventi senza anestesia dai fisiologi William Bayliss e Esnest Starling. I due fisiologi facevano ampiamente ricorso alla vivisezione per verificare se il sistema nervoso controllasse le secrezioni pancreatiche. Al cane, dopo numerose operazioni, venne asportato il pancreas e infine fu consegnato ad uno studente che lo uccise con una pugnalata al cuore. Le rivelazioni delle due antivivisezioniste diedero avvio al caso giudiziario tra i più noti dell’epoca; esso ebbe una vastissima risonanza sulla stampa e si concluse con la completa assoluzione di Bayliss80. Nel 1906 l’erezione di un monumento di bronzo al brown dog a Battersea per iniziativa degli antivivisezionisti diede inizio a una serie di tumulti in cui gli studenti universitari tentarono di abbattere la statua fino a che nel 1910 non fu demolita nottetempo dal Battersea Council. 80 Starling, infatti, decise di non sporgere querela, per diffamazione. Per una ricostruzione minuziosa del caso si veda: Coral Lansbury, The Old Brown Dog. Women, Workers, and Vivisection in Edwardian England, The University of Winsconsin Press, 1985. Su Ernest Starling (1866-1927), colui che coniò il termine ‘ormoni’, si veda: John Henderson, A Life of Ernest Starling, Oxford University Press, Oxford-New York 2010. 29 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 Dopo il processo l’editore del diario consegnò a Bayliss tutte le copie del libro, ripubblicato nel 1913 dalla Anti-vivisection Society, con un ampio resoconto del processo. Il capitolo che fece sensazione, Fun, descriveva il divertimento, i motti di spirito, quello stato d’animo a cui Frances Power Cobbe l’anno precedente aveva 81 dedicato lo scritto Schadenfreude . Stiamo ascoltando un interessante resoconto di “sham-feeding”. Il docente descrive certi esperimenti sui cani tra le risate dei presenti. L’esofago era stato tagliato ed era stata prodotta una fistola, così il cibo ingerito cadeva sul pavimento invece di passare nello stomaco. I cani mangiavano e mangiavano e mangiavano – erano terribilmente affamati – ed erano molto sorpresi nel vedere il cibo cadere; tentavano ancora con lo stesso risultato. Potevano andare avanti in quel modo per ore. Che divertimento! Quanto abili erano i fisiologi che avevano predisposto tutto questo! Quanto stupidi erano gli animali! Durante il processo, gli stomaci dei cani producevano succhi gastrici. Questo è un esempio di “secrezione psichica”. Tremendamente interessante! Che splendida abilità!82 Quando Ernest Starling, come era solito fare, manifestava il proprio orgoglio per le sue ricerche e affermava che gli esperimenti di vivisezione allo stomaco avevano fatto avanzare la conoscenza dei processi digestivi più di quanto non avessero fatto le ricerche di anatomia umana per oltre un secolo, si riferiva agli esperimenti di sham feeding oggetto dell’ilarità degli studenti83. Il suo lavoro fu ripetutamente criticato sulle riviste antivivisezioniste “Animal’s Defender” e “Zoophilist” e la pratica di sham-feeding divenne il simbolo della crudeltà, della inutilità e del cinismo dei fisiologi. Di fronte alle ripetute accuse che da decenni gli antivivisezionisti rivolgevano ai medici, ovvero la crudeltà e il disinteresse completo per la terapia, era importante poter dimostrare che le sperimentazioni avevano una qualche utilità terapeutica, non erano dettate da pura brutalità o da curiosità perversa. Al centro del dibattito erano le sperimentazioni sullo stoma81 Frances Power Cobbe, Schauenfreude, in “Contemporary Review”, vol. 81, 1902, pp. 655-666. Lind af Hageby-Leisa K. Shartau The Shambles of Science: Extracts from the Diary of Two Students of Phisiology, Bell, London 1903, p. 25. 83 Ian Miller, Necessary Torture? Vivisection, Suffragette Force-Feeding, and Responses to Scientific Medicine in Britain 1870-1920, in “Journal of the History of Medicine an Allied Sciences”, vol. 64, 2009, 3, pp. 348-349. 82 30 Bruna Bianchi DEP n. 23 / 2013 co, in particolare l’uso della sonda gastrica, una pratica dolorosa che i medici ancora non padroneggiavano e che intimoriva i pazienti. La vivisezione umana – ha scritto Ian Miller – sembrò divenire realtà quando la sonda gastrica iniziò ad esse utilizzata come presunto strumento di tortura e crudeltà nel corso dell’alimentazione forzata delle suffragiste imprigionate a partire dal 1909, una situazione che implicava numerose questioni morali e che fu discussa a livello internazionale84. Nel 1909 l’estendersi della protesta delle suffragiste nelle prigioni britanniche attraverso lo sciopero della fame, indusse il Ministero dell’interno a ricorrere all’alimentazione forzata, una pratica che si protrasse fino al 1913. Essa si configurò come una forma di punizione, di tortura e di sperimentazione; molte di coloro che la subirono (anche centinaia di volte) non si ripresero più. L’alimentazione forzata era paragonata dagli stessi medici alla pratica “di ingozzare galline” ed era applicata in modo doloroso e brutale85. Le analogie tra l’animale vivisezionato e le militanti sottoposte all’alimentazione forzata, tra il laboratorio e il carcere, divennero un tema ricorrente nel discorso suffragista. Gli spasimi, il senso di impotenza e di soffocamento, l’umiliazione per gesti e parole, l’angoscia per l’indomani, sono ricorrenti nei racconti delle suffragiste che comparvero sulla stampa e nelle memorie pubblicate negli anni successivi86. Le pratiche mediche nate dall’esperienza del laboratorio avevano dunque assolto a una funzione di stato e si erano proposte come utili strumenti per stroncare la resistenza delle suffragiste. Ancora una volta le affermazioni della medicina erano state raggiunte attraverso il dolore su individui non consenzienti. Da allora sperimentazioni sui viventi e vivisezioni non hanno cessato di aumentare e una concezione della scienza che molte femministe britanniche avevano messo in discussione nella seconda metà dell’Ottocento sembra essersi saldamente affermata87. Ancora oggi gli scritti di Cobbe, Kingsford, Blackwell e molte altre sul divorzio tra etica e scienza, sul rapporto mezzi e fini, sulla svalutazione della compassione e dell’empatia nell’esercizio della professione medica, sulla medicalizzazione di ogni aspetto della vita, si rivelano illuminanti; la loro forza morale, il loro rigore critico, la loro lungimiranza ci possono ancora guidare nell’impegno per un mondo che, come affermava Blackwell, consideri l’accrescimento del rispetto per la vita la sola misura del progresso umano. 84 Ivi, p. 337. June Purvis, The Prison Experiences of Sufragettes in Edwardian England, in “Women’s History Review”, vol. 4, 1995, 1, pp. 103-133; Ian Miller, Necessary Torture?, cit.; Jennian F. Geddes, Culpable Complicity: The Medical Profession and the Forcible Feeding of Suffragettes, 1909-1914, in “Women’s History Review”, vol. 17, 2008, 1, pp. 79-94; Mary Ann Elston, Women and Antivivisection in Victorian England, cit. 86 Constance Lytton, Prisons and Prisoners. Some Personal Experiences, Heinemann, London 1914. 87 Sulla critica contemporanea alla scienza medica rinvio a Ivan Illich, Nemesi medica. L’espropriazione della salute (1976), Macro Edizioni-Red Edizioni, Como 1991. 85 31 Animals, Women and Social Hierarchies: Reflections on Power Relations by Melanie Bujok* Abstract: It has been noted by several writers such as Mütherich (2003) that in western thought animals as well as women form the opposite and societal devalued pole to men and, with that, to all characteristics ascribed to men. Even more than women, animals eventually become the antithesis of culture, civilization, reason and progress. This positioning legitimates their subjugation and use as material and symbolic instruments for men's accumulation of capital. While analysis of social structures and hierarchies has examined why and how women are often deprived of valued resources usable in pursuing social advantage, very few approaches have taken into account the question of how the social structure interacts with and is affected by the human-animal relationship and how animals themselves are located in the social structure. This paper explores the potential of Bourdieu’s approach to power and capital for comparing differences and similarities in the present state of material and symbolic power relations between men and women and between men and animals in western societies. I. There is hardly a social field to be found in the societies of human beings where animals do not appear as corporeal agents, reified commodities, material artifacts or signs. At the two poles of human-animal relations, humans face animals on the one side as someone – an individual and interacting “subject of a life”1 – with animals on the other side as something – an object with specific meanings attributed by society and its culture (Wiedenmann 2002, pp. 19-21). The complexity of the relatedness of societal material and symbolic products to nonhuman animals might be derived from what Rainer E. Wiedenmann explains as “animal-related communication structured by two layers: on the one hand we * Melanie Bujok (Germany), social scientist, teaches Critical Human-Animal Studies, recently at the University of Hamburg and Bielefeld. Furthermore she oversees and runs a project of the extracurricular youth education. She is author of numerous essays on human-animal relationship. Contact: [email protected]. 1 This term was formed by the American philosopher Tom Regan in The Case for Animal Rights, University of California Press, Berkeley/L.A., 1983. © DEP ISSN 1824 - 4483 Melanie Bujok DEP n. 23 / 2013 humans communicate with animals, on the other hand we communicate about and through animals” (Wiedenmann 2002, p. 19 [emphasis in original]). Moments in which humans interact with animals as being someone with intentions, goals, interests, social and physical needs and feelings2 are, however, rare. Rather, animals are regarded more as strange or even dangerous beings, still not understood, the very other, specimens, valorized things or anonymous typifications. Therefore humans communicate mostly about and through animals and, in doing so, they are conducting a monolog. This monolog, the fact that “it is […] still the human being who palavers” (Latour 2010, p. 103), is not the consequence of animal individuals not having vocal abilities, nor of them not having anything to say, but of humans not having tried to find qualified interpreters3. With that, animals as a group, more than any other social groups, are at the mercy of societal ascriptions. While, at least in the scientific discourse of today and after women have intervened in discursive practices long dominated by men, it is recognized that there are no “natural” gender relations but that these are only naturalized power relations, it is still regarded that human-animal relations are the result of natural conditions and that it lies in the “nature” of animals to serve humans (and in the “nature” of humans to dominate animals)4. In the course of this, not only are social characteristics and “roles” ascribed to animal individuals, e.g. to be “livestock”, to be a “working animal”, to be “game”, to be “a pest” or to be a “pet”, which are all social categories of a certain society to a certain time and are therefore anything but natural5, but also to belong to the category “animal” which is contrasted to “man”. We will return to this later. Although animals are rendered subject to any ascription by human society, I do not agree with Rainer E. Wiedenmann that in this context the animal “is no more than a symbolic canvas for ascribing socio-cultural meaning” (2002, p. 21) The canvas changes. The denial that animals are someone and not something, is made difficult by the fact that in all the discourses in which systematizations of knowledge are made explicit and are ascribed on animals’ bodies, the animals do not stay in the (social) position in which the dominant culture perceives or wants to 2 The social sciences have so far ignored the results of the cognitive ethology that certain animals possess highly developed cognitive and social skills. Against the state of the art, social scientists adopt uncritically and almost with one voice, the obsolete ideas of animals as being dull, reduced to instincts, without self-consciousness and passive material. A good introduction into the new relevant scientific evidence of the cognitive ethology can be found in the anthology Der Geist der Tiere. Philosophische Texte zu einer aktuellen Diskussion, edited by Dominik, Perler and Markus Wild, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2005. 3 Latour then reminds us that the “discovery of new vocal apparatus so as not to fail to consider all non-human animals” (ibid.) would mean to stand collectively against civilization “that [is] no longer surrounded by a nature and other cultures, but is able, in a civil way, to embark on the developing composition of the mutual world” (ibid., p. 301). 4 A thought that goes back to Aristotle (384-322 BCE) who asserted in Politics, William Heinemann, London n.d., that there is a natural hierarchy and that in accordance with this, the women must serve the men, the slave must serve the master and the animal must serve the human. 5 It depends on the culture, for example, which animals are perceived as edible, if meat plays an important role at all, and which animals are used for work or to live in the family or with single human persons as companion animals. 33 Melanie Bujok DEP n. 23 / 2013 see them, as the writing culture debate has generally described this to be for the cultural stranger (see Moebius 2009, p.115). The animal subject does not react to human actions, she or he replies to them. The animals’ own, spontaneous movements lead humans to attempt to mislead, threaten or please them, to install traps and to fix them in carceral architectures such as cages, tethers or apparatus used to immobilize animals during experimental procedures. Humans use violence against animals, do harm unto them, empathize with the animal victims and show solidarity, despise or adore them. And that is why it makes no sense to put animals into categories with things or “nature”. Humans do not feel challenged or threatened in their social status by a grass stalk or by a rock. They do not compete with them for resources. They are not in social conflict with them as they are with non-human animals. The historical development of society has brought this conflict to a conclusion for the moment: they have excluded animal individuals from competition to the greatest possible extent by coercive force: the use of weapons and by means of destruction. And they have excluded them from acts of solidarity and considerations of justice. Simultaneously humans have included animals in their societies by means of coercion: by using them as means of production, productive forces and means of consumption. The stables, boxes, cages, nets, tanks, leashes and so on prevent their escape or any form of exit. Consequently, animals are the locked-in outcasts of the human social world. Although animals are unrecognized as subjects and social beings and human-animal relations are ones of power, most human individuals have enough personal experiences with animal individuals in face-to-face interactions to make forgetting that animals are individuals always connected to a remembering and therefore about rejecting as a product of societal labor. As a result of this, humans attempt to legitimate the oppression of non-human members of society in interhuman communications: animal-related religious justifications, scientific discourses, everyday conversations, while the reaction of people, the state and enterprises on the oppositional discourse of the animal rights and liberation movement demonstrate this most clearly. In the legitimating discourse, as already stated above, power relations are often justified with reference to a “divine” or “natural” order so that these relations appear to be unalterable and unquestionable. Animals and women, as well as other oppressed groups, for instance humans from non-western cultures, people of color, with disabilities or with different sexual orientations, are often assigned the category “nature” and contrasted to culture. This needs some further explanation. II. With modernization at the latest, society produced its means of subsistence against the backdrop of rationalization of the economy and, as a consequence, of lifestyles. Since efficiency and usefulness became the guiding principles of the developing industrialized and administered society, and human progress became equated with technological progress and increased utilization of “natural” resources and labor power, all living beings and all things became subordinated to material interests, instrumental reason and purposive rationality. All those humans who do 34 Melanie Bujok DEP n. 23 / 2013 not possess means of production and must therefore offer their labor power, but who cannot take part in this production process under these labor relations or who are opposed to them are thus regarded as being not or less worthy, useless or even dangerous. These production relations are the causes for the developing divisions of labor, for example into the spheres of production and reproduction, with women still largely expected to be at the disposal of both, yet widely excluded from good and just employment and even more from leadership positions. This leads some women to be heavily dependent and others to have no or not enough income from employment, which, in the extreme, forces them into labor conditions akin to slavery and into the trafficking of human beings, and increasingly for women into sexual exploitation. For the poor, for women, for those excluded from advantaged positions in society, the body – not understood here as an organ of the workforce but as a material thing – is sometimes the only resource left with which they can secure their existence. The body becomes a consumer good, is valorized, measured, quantified and either desired and demanded or rejected and devalued as inadequate according to economic norms and, as an effect of this, to what is socially desirable. I will go on to discuss the importance of the body in more detail below. In the history of ideas6, which reflect and result from the economic and social transformations of the respective periods7, the body, and all beings reduced to corporeality, have been associated with “nature” and ascribed the characteristics projected onto “nature”, such as lacking reason, being passive, undeveloped, mere matter, brutish, wild, libidinous, and finally dangerous. Women and animals belong to those groups ascribed to “nature” with the legitimation of which they became devalued in the civilizing process which was opposed to the “natural state”. Functionalist theories, especially, like that of Talcott Parsons or Norbert Elias’s The Civilizing Process (1939/2000) regard modernization as a form of social change for the better. These theories subscribe to a rather linear progress, whereby the new stage is better and overcomes the old one which was deficient. In this view, animals, tribal and non-western societies, and in part, women are viewed as being a deficiency that western society would have to overcome, annihilate or control and subject to its rule. Apparent advancement through the domination of nature particularly rationalized the domination and sacrifice of animals. As I have described elsewhere (Bujok 2007): 6 Not just since Descartes (1596-1650) separated the body (res extensa) from the mind, the cognitive substance (res cogitans). 7 See also Nibert, David in Animal Rights, Human Rights. Entanglements of Oppression and Liberation. Rowman & Littlefield. Lanham, 2002 and Maurizi, Marco in “Die Zähmung des Menschen”, edited by Susann Witt-Stahl, Das steinerne Herz der Unendlichkeit erweichen. Beiträge zu einer kritischen Theorie für die Befreiung der Tiere, Alibri Verlag, Aschaffenburg, pp. 109-124 with regard to their arguments that against the assumption of many writers in the field of Human Animal-Studies such as Peter Singer in Animal Liberation (1975) or Tom Regan in The Case for Animal Rights (1983) the causes of the societal and systematic oppression of animals are not to be found in ideas, prejudges or believe systems of people but in the materialist organization of society and its social structures. 35 Melanie Bujok DEP n. 23 / 2013 The institution of sacrifice, a “historical catastrophe”, an “act of violence, which befalls humanity and nature equally”, as Max Horkheimer and Theodor Adorno point out in Dialectic of Enlightenment (1944), is accepted in current society, as, so to say, a natural part of its selfimage. Acts of violence against animals are consecrated as reasonable, furthering advancement, or even as necessary, according to the critique of the Frankfurt School. This, because civilisation-historically, the human individual, emerging from the domination of nature, hopes to find his or her own self-preservation in the death of the animal, or even to circumvent his or her own death. From this perspective, animal research laboratories and slaughterhouses are the sacrificial alters of old and new. (pp. 313-4) Following the victims of the Holocaust and the many other recent man-made catastrophes, the older modernization theories’ belief in historical linear progress through rationalization, technology and materialism was unveiled as the myth of the Enlightenment. It was the Frankfurt School, with its representatives Theodor Adorno, Max Horkheimer and Herbert Marcuse, who, more than any one else, stated that the causes of these catastrophes are not to be found in something that is outside of or opposed to modernization, but which is caused by modernization. It is the central thesis of the Frankfurt School's Critical Theory that the advancement of society to a better one always contained within it the germ of repression, in that it was based on the domination of nature instead of its comprehension. The deception of the domination of nature is that it does not eliminate the blind natural context in order to reconcile nature with itself through historical labor, but that human society has conformed to the natural growth, imitated and rationalized it (Horkheimer/Adorno 1944/1997). Western societies thus grounded their advancement on the twofold domination of nature: the domination of the ‘outer nature’ such as animals and simultaneously of the ‘inner nature’ of humans. The domination of ‘inner nature’ in the form of self-control, rationalization of life and suppression of drives and mimetic impulses was seen by western society as essential for civilization – and this always means first and foremost for economic development following the interests of power. Norbert Elias (1939/2000) and Michel Foucault (1975/1995), especially, showed modern society that following the process of social differentiation, the conduct of individuals was decreasingly affected by external control, and especially less by direct external physical violence, but more by an apparatus of self-control. Those who do not act for the purposes of and adjusted to the given social order, those who fail to bring their mind and body under control, are said to behave like “animals”. The animal metaphor, according to Birgit Mütherich (2003, pp. 32-38), serves as a stigma that is frequently used to dehumanize human individuals or groups and to exclude them from moral considerations and, essentially, from access to valued resources. She argues that the “antithetical idea of ‘the animal’ and its construction as a stranger provide a basis for the stabilization and legitimation of ‘natural’ hierarchies, including interhuman ones, as well as structures of exploitation and violence, which are practiced and reproduced in the context of the traditional human-animal relationship” (2003, p.17). Picturing non-human animals as the antithesis of man could only become fully effective by drawing one straight line between the two that strictly separated the man from the animal without leaving any animal individual in between. As with 36 Melanie Bujok DEP n. 23 / 2013 other binary orders of dualist oppositions8 such as man/woman, white/person of color, the binary order man/animal made it possible to attribute schemes of inferiority uniquely to the other (here: the non-human animal, the woman, the person of color) and of superiority to the self in order to legitimate the oppression of the other. Zygmunt Bauman suggests that in modernity there “is a fight of determination against ambiguity, of semantic precision against ambivalence” (1991, p. 7). The insertion of all species except the human species under the term “the animal”, in the singular, is a social taxon, a political act to mask diversity and to place all other animals at distance. This is because “the animal” does not, in fact, exist. In the view of Derrida, the differences and similarities between animals (including the human animal) could be imagined as a “plural and repeatedly folded frontier” (2008, p. 30) rather than a single line. It cannot, however, be questioned that there are differences between the human and other animals9. However, it is of sociological interest and of socio-political brisance to ask why, in which context, on which basis, to which extent and with which consequences for whom does society make a distinction out of a difference, to refer to Stefan Hirschauer. (2010, pp. 208-9) Or in Adorno's words: an “emancipated society [...] would be [...] the realization of universality in the reconciliation of differences”; and therefore would be “one in which one could be different without fear” (1951/2003, p. 116). III. With differences between the species and between “male” and “female” being contingent and arbitrary, “the animal” as well as “the woman” are social constructions correlating with accepted social norms. The normalization of nonhuman animals and women, however, fitting them into society in conformity with the given social norms and values, is based on different social processes. Pierre Bourdieu maintains that masculine domination and control is not visible and regarded as such – not even by women themselves – so that women submit to masculine domination and sustain it. As Bourdieu writes in The Masculine Domination, through a “stroke of violence, the social world” inscribes itself on human individuals’ bodies in the form of “a real program of perception, appreciation and action” that “functions like a (second, cultivated) nature, i.e. with the authoritative and (apparently) blind force of the (constructed) drive or phantasma” (1997 p. 168). Bourdieu (2007) concludes that the incorporation of unconscious structures, and with it of repressive social constraints, finally acts as symbolic violence, “a gentle violence”, upon dominated human agents like women who then perceive the social order as acceptable, just and natural. In Distinction: A Social Critique of the 8 See, for instance, Val Plumwood, Feminism and the Mastery of Nature, Routledge, New York 1993, p. 41 or Birgit Mütherich, Das Fremde und das Eigene. Gesellschaftspolitische Aspekte der MenschTier-Beziehung, in: Tiere beschreiben, edited by Andreas Brenner, Harald Fischer Verlag, Erlangen 2003, pp. 16-42. 9 Always taking into account, though, that the differences between a human being and a pig are smaller than between a pig and a butterfly, for example. 37 Melanie Bujok DEP n. 23 / 2013 Judgment of Taste (1979/1984), he explains that during that “somatization of the social relations of domination” the human individual internalizes its own social position, which generates a habitus related to that position. The habitus is a set of acquired schemes, dispositions, tastes and sensibilities, and with that is, as Bourdieu points out, also “a structuring structure, which organizes practices and the perception of practices” (ibid, p.170). The social position of an individual, its class fraction, is thereby at the same time both result and origin of accumulation of social, cultural, economic and finally symbolic capital. When taking into account that the human-animal relationship is part of these social relations of domination, Bourdieu’s approach explains why the oppression of animal individuals is also regarded as a natural relationship and why it is reproduced and remains so stable over time. Arguing along the lines of Bourdieu, societal human-animal relations, and with them the exploitation of animals, are so solid precisely because human individuals pre-reflexively and mainly without physical coercion subordinate their socialized bodies to the social world. As mentioned before, Bourdieu explains that the social world inscribes itself on individuals’ bodies in the form of schemes of perception, appreciation and action and what Bourdieu calls habitus. When people perceive animals as things and commodities and treat them correspondingly, they are doing so because of their habitus orientated towards animals, because they are socialized in a social world which is structured by relations of violence towards animals. These social schemes do not determine the individual, but rather shape its behavior and practices by the primary institutions of socialization such as the family and by the re-socialization throughout day-to-day activities, by which the individual accumulates capital and confirms or – very occasionally – changes its social position. It is part of the habitus of people socialized in the so called western culture to think in terms of dualism, as discussed before. These “principles of vision and division”, as Pierre Bourdieu calls this “embodied social program of perception [which is] applied to all things of the world” (2007, p.11) follow the social structures of hierarchization of living beings into the vertical opposition of top/bottom. Max Horkheimer took the social situation of animals into account in his aphorism “The Skyscraper” (Der Wolkenkratzer, 1931/1934) in which he described the hierarchical architecture of the capitalist society of his time. The building has several storeys with the “trust magnates of the different capitalist groups of power” on top and the enslaved dying at the bottom. Under these would be “the indescribable, unthinkable suffering of the animals, which symbolizes the animal hells of human society, the sweat, the blood and the despair of the animals” (1931/1934, pp. 132-3). Most sociologists do not want to speak of a class society of that kind today. They think to recognize a “Social Inequality without Stratification” (Wrong 1976, quoted in Kreckel 2004, p. 142). They state that members of society are no longer part of a socio-cultural integrated class (see, for instance, Kreckel 2004, p. 141 and 1991). There are no more clearly antagonistic interests; as a result, there is no class consciousness and therefore it will never come to a class struggle. Rather, members of society would have different interests with sometimes different social positions within the various social fields. Furthermore, it is criticized that 38 Melanie Bujok DEP n. 23 / 2013 “Conventional” theories of structured social inequality consider the occupational order as “the backbone of the class structure” [Parkin (1971, p. 18)] in advanced industrial society; societies are treated as “work societies” (Arbeitsgesellschaften). Therebye, all those members of society who hold no position in the labour market, such as housewives, students and pensioners, are removed from immediate consideration (Kreckel 1991, p. 2). Today therefore, in social structure analysis, one prefers to speak of “social conditions” (Lebenslagen), “social mileus” or lifestyles. In view of Horkheimer’s skyscraper, it is thus asserted that the whole architecture has changed, with different stairwells and elevators to lead from one level to another, or doors which lead from one room to another. Up to now social structure analysis has said nothing of the situation of animals in human society. The cellar remains locked, without so much as a glance inside. There are no stairs or elevators down there, social mobility is not made possible for animals, not even through achievement. Other than for women, breaking the door down would also seem to be impossible. IV. Is an examination of animals as a social category in inequality studies valid? As with other social categories – such as people of color, refugees or the longterm unemployed – “the animals” as a whole obviously do not represent any one social group. Typical attributes of a social group are lacking, such as them entering regularly into social relationships with each other, so that a certain degree of integration can be ascertained. Much less can they become conscious of their situation within human society and so become anything like “a class for themselves”, develop a feeling of belonging together as “animals in the human society” and organize in their mutual interests10 against their human oppressors. It must, of course, be noted that the terms of social structure analysis, with which the various types of social inequality in industrial and post-industrial societies are described (class, milieu and lifestyle) don’t quite want to fit. This miss-fitting emerges out of the anachronism of the extreme oppression of members of nonhuman species within a modernism, which requires a critique of violence, and takes the demands of the enlightenment as its value orientation: freedom, autonomy, reason, equality and inclusion11. Under another aspect it also seems difficult to identify animals or membership of a species as a dimension of social inequality. Taking a look at the means that humans employ to reach their goals and compete with each other for, and at the goals themselves that social structure analysis usually examines, there seem to be numerous arguments that would speak against looking at animals as a part of structures of social inequality: Animals neither share the human goals of wealth, political participation or their consumption desires, such as the ownership of entertainment electronics or cars, nor do they reach for the means of educational qualifications, job success or salaries in order to fulfill their goals. Nor are they 10 With reference to interests of animals, I follow Regan’s account (1983, p. 87-88). See also Michael Fischer for this point in Differenz, Indifferenz, Gewalt: Die Kategorie ‘Tier’ als Prototyp sozialer Ausschließung, in “Kriminologisches Journal”, 2001, 33 (3), pp. 170-188. 11 39 Melanie Bujok DEP n. 23 / 2013 persuaded through the norms and values of human society that they have internalized and recognize to prefer particular goals or means and to reject others. It is, however, the case that social hierarchies and inequalities are formed by the relational configuration of individuals or groups, which is the result of the distribution of “valuable goods” (Hradil 2005, p. 30). While those with a higher social position, and with it a higher status, have access to resources of social value and to social chances with only few restrictions, the social groups at the bottom are often deprived of them. Economic capital12 such as cash, financial assets and property, that can be used in many fields in capitalist societies are part of those resources of social value. However, the accumulation of labor and social relationships of exchange are not limited to the economic market. Also cultural capital is used by individuals as a resource to improve their social position or to maintain it, such as cultural goods (cultural capital in its objectified state), education and cultivation and with that, educational qualifications (institutionalized cultural capital) or the embodied forms of cultural capital, such as knowledge, taste and what Bourdieu termed the “practical sense for what is to be done in a given situation” (1998, p. 25). Even social relationships and networks can constitute a type of capital, that is social capital, that allows members to access resources that are possessed by agents they are connected with. Finally, the legitimate and recognized forms and uses of these types of capital is symbolic capital. Sometimes it is used as a synonym for prestige. Exactly which kind of material or symbolic resources are valuable and help the individual to achieve her or his goals depends on the biophysical living conditions, and above all on the socially structured conditions of action which are not under her or his control and which therefore impose restrictions on the scope of action. Resources serve to meet ones interests and needs. Hartmut Esser (1999, pp. 92-98) argues that there are two basic needs: social recognition (a need of human beings) and physical well-being (a need of humans and animals). While these needs arise from the constitution of the organism, it is the society that defines which meaning is given to these needs and which characteristics, resources and actions lead to social recognition and physical well-being (see Esser 1999, p. 98). Resources are not distributed equally, though, and those who have accumulated most of them – who are usually human, male, white, citizen of a capitalist, postindustrial society – are not only able to appropriate profits but also to determine the value of a good or a service and to enforce the “rules of the game” (Bourdieu 1997, p. 58) under which capital and with it the social structure is reproduced and held stable over time. Therefore there is no situation of “perfect competition and perfect equality of opportunity (…), so that at each moment anyone can become anything” as the classical market theories claim, according to Bourdieu (ibid., pp. 49-50) In this way, the individuals who are in a privileged position and live under this similar condition, the dominating class, find themselves in a power relation towards the other individuals. 12 In the following, I refer to Bourdieu’s (1997) forms of capital. 40 Melanie Bujok DEP n. 23 / 2013 Since possessing a huge amount of the different types of capital13 conveys advantages in a society based on competition, it is in the interests of the dominating class to monopolize social chances, to control important resources and to pursue strategies of social closure (see Rössel 2009, pp. 69-85). The resulting social inequalities and dependencies are institutionally secured and legitimized, for example by political measures and the rules of law, by religious beliefs and ideologies. Since it is the dominating class that determines the rules, as mentioned above, the full scope of the power relations emerges. V. It goes without saying that most animals that are used as resources are accumulated economic capital. They are subordinated to material interests. Possessing animal individuals or parts of their bodies, exploiting their labor power or their bodies enables the human actor to compete against others in the social field and maybe to improve her or his social position. The economy is not only historically built on the exploitation of animals, but animals and animal products also still play an important role in the circulation of goods. But serving as material goods does not cover the whole meaning of the use of animals. Animals also serve as symbolic goods and dominating them helps achieve social recognition. Being a symbol of power, the animal commodity can also be transformed into symbolic capital and function as a distinctive sign by demonstrating prestige and social status. Accordingly, the animal commodity can contribute to the reproduction of interhuman social relations. As “condensed symbols”, meat and other “animal products”, reflect the power of human society over “the animal”, as Nick Fiddes argues in his book Meat: a natural symbol (1991). Being a resource of power, meat is capital to which male actors, especially, want access, as Carol Adams describes in her book The Sexual Politics of Meat (1990). According to Max Weber, power is “the probability that one actor in a social relationship will be in a position to carry out his own will despite resistance, regardless of the basis on which this probability rests” (Theory of Social & Economic Organization, p. 152). And that is why plants or mushrooms extremely seldom constitute symbolic capital: you cannot have power over them. As stated at the beginning, they react to actions of power but animal individuals respond to it, resist, since they are in the possession of an own will. Acting against this will and subjugating it is what distinguishes social power from merely physical force. This is particularly evident, for instance, when people take photos of animals they shot or fished or when they display the antlers of a killed animal prominently in their own house. People do not very often publish photos in magazines or on the internet of them having gathered berries in the woods. And very rarely will you be able to watch them nailing the roots of the bush on the wall as a sign of trophy. 13 In capitalist societies, especially economic capital and objectified cultural capital in the form of the means of production. 41 Melanie Bujok DEP n. 23 / 2013 The same applies to meat on the plate, fur or leather trimming on the coat, animals in zoos or elephants performing handstands in a circus; the domination of animals is made visible, to be looked at and to be socially shared, affirmed and perceived as legitimate. Experiencing the oppression of animals in the company of other human individuals can help to build new social networks or to consolidate existing social connections. Examples here include the hunting clubs which male hunters in particular use to increase their social capital. Another example would be the dinner party, a micro-social image of society, that replicates the ritual of nature domination, in this case, the subjugation of the animal individual as a “sacrificial animal” through the consumption of this. Anyone refusing complicity to power over animals abnegates these interspecific power structures. Anyone not eating meat (or other parts of animals’ bodies) does not get a seat at the same table and rejects that important source of social capital, especially when eating animals is celebrated in the context of a festival. This explains society’s disapproval of vegans, why they are imputed variously of militancy, illness or bad taste, because they so vividly prove, and therefore make undeniable and visible, that the animal victim is not a necessity for selfpreservation, and therefore endanger the spell, the “fetish character of [the animal] merchandise”, to use the words of Adorno (1973, p. 346). In western societies even infants become accustomed to eating animal products in order to form an appropriate taste which suits their social position and one that, within the human-animal relationship, is part of the dominating “class” of human beings. From picture books like “Farm Animals” – probably the first book most of us got to see – children learn the social order, for example the gender relations, but especially the human-animal relations. This knowledge, as well as the taste for animal products thereafter become embodied forms of cultural capital, habitus. Animals are presented in these books as having to serve humans and as if the subjugation of animals were even carried out with their consent. But there is no consent; animals do not recognize human domination as women, in contrast, recognize masculine domination. In practice, since animal individuals, as opposed to humans, do not internalize the social constraints of human society, the constraints on them are purely external and therefore especially violent. For them, social force is not symbolic but physical violence that directly impairs their physical integrity. Their behavior and bodies are adjusted to the social norms and economic interests by leashes, bridles, spurs, whips, restraining apparatus, chains, electric shocks, fences, nets, boxes, cages and a plethora of other coercive instruments. Human society has developed many means of force to increase its power to injure and to do physical harm to humans as well as animals. Due to the body's vulnerability to injury (see Popitz 1986/2009) and its immediacy, as well as the fact that the body cannot be possessed by anyone other than oneself and cannot be left or accumulated, the body is the most restricted resource. VI. At this point I would like to refer back to my accounts on the body. Even though, as we have seen, many of the resources that are valuable for humans in 42 Melanie Bujok DEP n. 23 / 2013 current social relations make no sense for animals (such as money), this determinant, the body as resource, also makes sense for the lives of animals. It is the precondition for one’s capabilities. The determination over one’s own body is of the highest importance in one's ability to act and for this reason should be mentioned in social structure analysis at the forefront of the “valuable goods”. Sociology has taken the body for granted when examining social structures and social inequalities instead of including it in its considerations (see von Trotha 1997, p. 27), even though the body is the indispensable prerequisite for the capacity to act. In sociology – even in the action theory – the body, as the individual’s supposed constantly available resource, is always thought of as a given, instead of being thematized. (von Trotha 1997, p. 27). Aspects of the social that pertain to the body may be regarded as “new” determinants and dimensions of social inequality – those properties attributed to the body such as gender, age, skin color, or access to health and nutrition, living situation, threat from environmental dangers and the results for one's quality of life – but even here the meaning of the body remains unexplained. Humans and non-human animals have their corporeality in common, through the sensuality of which they are aware of and can experience themselves and their environment, which enables their own actions and which makes them suffer under the actions of others that are carried out against their own bodies. At least the ability to suffer and to have preferences – and as we have seen with Esser, the basic need for physical well-being – is a commonality between humans and animals that provides reason for a relationship of equality and activates modernity's enlightened demands for equal treatment that would make it sensible to draw the social life conditions of animals into questions of social inequality in the first place. The representatives of the Frankfurter School also recognized this when they saw that what connected humans and animals is the commonality of happiness, misery and pain. Horkheimer wrote pointedly, “In pain, everything becomes level, everyone becomes the same as everyone else, human and human, human and animal”(Horkheimer 1970, p. 52). The avoidance of pain, suffering, injuries and killing reasonably belong to the goals of any sentient individual, and humans know about the vulnerability of animals’ bodies: Social discourses, norms and – especially ritual – practices deal with questions of the legitimacy of injuring or killing animals from their very beginnings. Their susceptibility to hurt is intersubjectively perceptible to humans, the damage is visible as wounds. Animal individuals have those “tormentable bodies” that Bertold Brecht once spoke of and which experience violence through destructive treatment; which, in the words of Heinrich Popitz, make them to victims of an “act of power that leads to [...] [their] deliberate physical injury” (2009, p. 48). The experience of violence, having to tolerate intentionally delivered damage to the own body by humans (e.g. through experiments in animal research or through imprisonment in agricultural systems) or the threat of the same (e.g. in circuses and racing), prevents animals from freely proceeding in their bodies or to use them as means of acting. Actions of power by humans therefore form restrictions on acts, which strongly limit animals’ scope of activity in any situation, causing a relevant disadvantage. If the situation is especially characterized by animals being unable to 43 Melanie Bujok DEP n. 23 / 2013 leave it, due to imprisonment and physical force, these restrictions intensify to that specific state in which a majority of the animal members are forced to live in and which is characterized by an extreme asymmetric balance of power. The animals are highly vulnerable and are subject to a total temporal and spatial control of their behavior up to oppression and death. Thereby it is not the violence that is an “everyman’s resource”, as Trutz von Trotha (1997, p.18) would like it to be understood as, but the body that can carry out acts of violence or refrain from this, or that can be prevented from using force to defend itself. For neither is the body itself a distributive resource, that could be unequally shared out, accumulated or be exchanged for other resources (everyone has precisely one body); yet society differently enables members of society the abilities and chances to employ the body in a particular way, to move, act, educate and to experience according to affiliation. This applies all the more to those objects that can be used as means of force and for the social norms of who may legitimately use force and against whom. The power to injure, as Popitz also refers to the power of action, i.e. the ability to hurt another, in the “human-animal relationship” is for animals rather limited in the face of the aforementioned instruments of control, through chains, electric fences, and training devices to firearms, tazars and other distance weapons, which are humans’ means of force. The imprisonment of animals in crates and cages, the transport to the slaughter house, the slaughter that takes place there, and so much more, are the manifest expressions of the power to injure that animals suffer because they are sentient. Even for this reason alone, the philosophical explanation of a just exchange of fear of death, which is not only repeated unreflectedly in academic discourse but has become part of common sense is false when applied to human-animal relations and shows itself up to be fraudulence (see Bujok 2007). When we look at the remarks of Jörg Rössel, for instance, who defines social inequality as “the socially produced distribution of resources for and restrictions on actions in the population of the unit in question” (2009, p. 21; [emphasis in original])14, the meaning of the body becomes apparent: one who is made to tolerate or cease actions by means of force or whose life is threatened by means of destruction, his or her life-chances have sunk to a level at which it is not even possible for the basic needs to be met. For access to valuable resources, first of all the absence of violence as an extreme form of action restriction is necessary. The experience of violence is therefore an extreme form of disadvantage that receives too little attention in social structure analysis15. 14 While Rössel uses action resources as the term for the abilities and objects that one uses to help one to reach a goal and on the application of which one decides oneself, the restrictions are the nonchangeable social and material action conditions of a situation that limit the choice of actions (2009, pp. 35-51). 15 C.f. Critiques on the lack of consideration on the life-long concept and gender studies e.g. Uta Enders-Dragässer, Allein erziehen als weibliche Lebeslage, in Veronika Hammer ed., Alleinerziehende: Stärken Probleme. Impulse für eine handlungsorientierte Forschung. Tagungsband. LIT-Verlag, Münster 2002. 44 Melanie Bujok DEP n. 23 / 2013 Conclusion Animals represent important aspects of social structure analysis in two ways. For one, as social subjects, that are devalued because of their species and are denied access to valuable goods and even to their own bodies as the most important resource, they are part of the social structures of social inequality. In the social hierarchy they are even further below the position of women, although both groups are often categorized as “nature” in the binary order. At the same time, with animals, one can not speak so much of a social position as a social positioning. For animal subjects clearly do not take a social role in the sense that they understand the social expectations that have been placed upon them and orient themselves on these expectations. Attempts are made to legitimize their status in society, similarly to women, as explained earlier, with reference to their “biological” characteristics; however animal individuals do not internalize their social positions as human actors do in the form of habitus, rather their behaviors are fitted to the social rules through physical interventions by human actors. This results in a form of domination over animals that is not based on recognition and for this reason corresponds with Foucault’s old physics of power and not Bourdieu’s “gentle violence” (c.f. Bujok 2007, pp. 315-22). Even though human power relations, as a direct relationship of force, remain for them purely external and as a result they can – easier than women – perceive the oppression as such, they lack the possibilities to organize their interests and, as a struggling class, to alter their situation through changing the social relations fundamentally. Whilst animals are never examined as a social (or at least an objective) class within the discourses on social inequality, it is also denied that women form a class (see Kreckel 2004, p. 213). That gender is generally seen as a horizontal, rather than a vertical structural characteristic of social inequality, i.e that, in practice, the ascription of the gender “woman” socially disadvantages; yet it is not the main criterion in social closure. A clear, socially constructed male above and female below does not (any longer) exist. Other than in human-animal relations, in which animals (as a group, “the animal”16) still have to live in the cellar of society’s building that Horkheimer described, gender relations are seen to have a different pattern, a pattern of pluralization of life conditions. Animals are also important for social structure analysis in the aspect that they are used by humans to reach their goals. Animals also have a part in the social structure as economic, cultural, social and symbolic capital. There are important interrelations between human-animal relations and socially structured interhuman relations of inequality, such as gender relations, in that the domination of animals makes them a valuable power resource, above all a resource of male domination viewed as legitimate. If one examines the different forms of oppression of animals, it is notable that it is usually male actors – the hunter, the breeder, the slaughter man, the ring master, the matador, the vivisector – who carry 16 Of course there are animal individuals that live together with humans in solidary communities of choice and are better positioned and treated. 45 Melanie Bujok DEP n. 23 / 2013 out the acts of violence against animals and/or who benefit from them. The act of violence, the oppression of animals, the extinguishing of life, is what makes it potent as a power resource. Eating meat (see Adams 1990, Fiddes 1991) for example, like the presentation of oppressed live animals or killed animals, is an expression of both human and male domination. References Adams, Carol J. 1990. The Sexual Politics of Meat: A Feminist-Vegetarian Critical Theory. London/N.Y.: Continuum. Adorno, Theodor W. 2003. Minima Moralia, Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Rolf Tiedemann, Gretel Adorno, Susan Buck-Morss, and Klaus Schultz. Gesammelte Schriften. 4. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Adorno, Theodor W. 1973. Negative Dialectics. Trans. E.B. Ashton. London, Part III. Models. World-spirit and Natural History Excursus on Hegel. http://www.efn.org/~dredmond/ndtrans.html. (accessed March 2012). Bauman, Zygmunt. 1991. Modernity and ambivalence. Cambridge: Polity Press. Bourdieu, Pierre. 2007. Masculine Domination. Trans. Richard Nice. Cambridge: Polity Press. Bourdieu, Pierre. 1998. Practical Reason. Stanford, California: Stanford University Press. Bourdieu, Pierre. 1997. “Die männliche Herrschaft,” in Dölling Irene, Krais, Beate, eds., Ein alltägliches Spiel. Geschlechterkonstruktion in der sozialen Praxis. pp. 153-217. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Bujok, Melanie. 2007. “Zur Verteidigung des tierlichen und menschlichen Individuums. Das Widerstandsrecht als legitimer und vernünftiger Vorbehalt des Individuums gegenüber dem Sozialen.” in Susann Witt-Stahl, Das steinerne Herz der Unendlichkeit erweichen. Beiträge zu einer kritischen Theorie für die Befreiung der Tiere. pp. 310-343. Aschaffenburg: Alibri Verlag. Derrida, Jacques. 2008. The Animal that Therefore I Am, Marie-Louise Mallet. ed.. Trans. David Wills. New York: Fordham UP. Esser, Hartmut. 1999. Soziologie. Spezielle Grundlagen. 1 (Situationslogik und Handeln). Frankfurt a.M./N.Y.: Campus. Fiddes, Nic. 1991. Meat: A Natural Symbol. London: Routledge. Foucault, Michel. 1995. Discipline & Punish: The Birth of the Prison. Trans. Alan Sheridan. New York: Vintage Books. Hirschauer, Stefan. 2010. “Die Exotisierung des Eigenen. Kultursoziologie in ethnografischer Einstellung.” Monika Wohlrab-Sahr. ed. Kultursoziologie. pp. 207225. Wiesbaden: VS-Verlag. 46 Melanie Bujok DEP n. 23 / 2013 Horkheimer, Max, Theodor W. Adorno. 1997. Dialectic of Enlightenment, Trans. John Cumming. London/N.Y.: Verso. Horkheimer, Max (under the pseud. Regius H.). n.d. “Der Wolkenkratzer.” Horkheimer, Max. ed. Dämmerung. Hradil, Stefan. 2005. Soziale Ungleichheit in Deutschland, 8th edition. Wiesbaden: VS-Verlag. Kreckel, Reinhard. 1991. The Concept of Class. Its Uses and Limitations in the Analysis of Social Inequality in Advanced Capitalist State-Societies. http://www.soziologie.uni-halle.de/kreckel/docs/class-1.pdf. (accessed March 2012). Kreckel, Reinhard. 2004. Politische Soziologie der sozialen Ungleichheit. 3rd edition. Frankfurt a.M./N.Y.: Campus. Latour, Bruno. 2010. Das Parlament der Dinge. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Moebius, Stephan. 2009. Kultur. Bielefeld: Transcript. Mütherich, Birgit. 2003. “Das Fremde und das Eigene. Gesellschaftspolitische Aspekte der Mensch-Tier-Beziehung.” Brenner, Andreas. ed. Tiere beschreiben. pp. 16-42. Erlangen: Harald Fischer Verlag. Norbert, Elias. 2000. The Civilizing Process. Sociogenetic and Psychogenetic Investigations. Trans. Edmund Jephcott. Oxford: Blackwell Publishers. Popitz. Heinrich. 2009. Phänomene der Macht. 2nd edition. Tübingen: Mohr Siebeck. Rössel, Jörg. 2009. Sozialstrukturanalyse. Eine kompakte Einführung. Wiesbaden: VS-Verlag. Trotha, Trutz v. 1997. “Zur Soziologie der Gewalt.” Trotha, Trutz v. ed. Soziologie der Gewalt. special edition 37/1997, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. pp. 9-58. Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. Weber, Max. 1947. Theory of Social & Economic Organization. Intro. Talcott Parsons. New York: The Free Press. Wiedenmann, Rainer E.. 2002. “Die Fremdheit der Tiere und der Prozeß gesellschaftlicher Differenzierung: zum Wandel soziokultureller Ambivalenzkonstruktion.” Wiedenmann, Rainer E. ed. Die Tiere der Gesellschaft. Studien zur Soziologie und Semantik von Mensch-ier-Beziehungen. pp. 15-39. Konstanz: UVK. 47 Animal Advocacy, Feminism and Intersectionality by Maneesha Deckha* Abstract: The gendered and intersectional dimensions of the animal advocacy movement provide an important reason for “the animal question” to be embraced as a feminist issue and, concomitantly, for feminists to consider animal identity and human privilege as acceptable elements of an intersectional analysis. I argue that the animal advocacy movement should be regarded as a women’s movement as it gives rise to gendered, class, and racialised practices that impact the lives and experiences of its disproportionately female membership. Accordingly, the animal advocacy movement, including its central attention to species difference, should be of feminist and intersectional concern. Thus, the goals that the movement aims to advance should be understood as feminist issues not just because of the links between the oppression of marginalized humans and animals that existing animal theory has already demonstrated, but also because the majority of animal advocates are women whose experiences with animal advocacy is adversely inflected by gendering and other differentiating dynamics and processes. After arguing for this association of the animal advocacy movement as a women’s movement, I revisit some of the current internal debates within intersectional theory about is proper parameters. I do so to explain why concerns advanced in these debates do not foreclose the consideration of species difference as one of the sites/axes/grounds of difference to which intersectionalists should attend. Introduction Intersectionality is a theory and methodology that instructs its adherents to examine the mutually generative and integrative nature of social identities as well as the power relations and the structures and hierarchies of difference to which they give rise. It signals a commitment to integrative analyses that assume that social forces that construct difference come into being through each other and it resists unidimensional analyses that study identities and difference-based oppressions in isolation or to the exclusion of each other (Hancock 2007). Sirma Bilge (2010) notes how intersectionality as academics have practised it thus far operates on two * Maneesha Deckha is Associate Professor of Law at the University of Victoria. Her research interests include critical animal studies, postcolonial feminist theory, health law and bioethics. Her work has appeared in the Canadian Journal of Women and the Law, Ethics & the Environment, the Harvard Journal of Gender and Law, the Journal for Critical Animal Studies, the Medical Law Review, and Sexualities among other publications. She has received grants from the Canadian Institutes of Health Research and the Social Sciences and Humanities Research Council. In 2008 she held the Fulbright Visiting Chair in Law and Society at New York University. © DEP ISSN 1824 - 4483 Maneesha Deckha DEP n. 23 / 2013 levels: the macrosociological level regarding multiple systems of power and oppression and the microsociological level regarding the effects on individual lives. Although some scholars have criticised intersectionality literature as too focused on one of the levels at the expense of the other, the theory in general has enjoyed widespread support. Most scholars working in the area of feminist studies embrace the notion of intersectionality in the area of feminist studies as important to understanding gendering processes and the lives of women (Yuval-Davis 2006, Bedolla 2007). As a concept, intersectionality currently enjoys a global and interdisciplinary academic reach (Nash 2011, Choo 2012). Indeed, some suggest that intersectionality has now attained the status of a “buzzword” for scholars to use to indicate a stance that involves recognizing multiple and intersecting markers of identity, as opposed to an additive approach, while leaving space for what this recognition entails (Davis 2008, p. 68, 75, 77-79). Intersectionality’s open-endedness also generates breadth in the theory’s attention to differences. Some scholars suggest that intersectionality does not have to focus on particular modalities of difference, but rather can be broadly applied to understand society (Hancock 2007, Dhamoon 2010). Where the dynamics of specific differences are the focus, breadth is also apparent in the selection of differences that have been analyzed. Although the analytical focus tends to coalesce on the “race-class-gender trinity (Hancock 2004, p. 234)” studies have also included other categories such as sexual identity and nationality by focussing on transgendered identities and migrants (Hines 2010, Bürkner 2011). As Paul Scheibelhofer and Vince Marotta (2012, p.8) discuss, some scholars have defended this trinity as especially important while others argue that these three categories should operate as a baseline into which other markers of difference should be integrated given the particular project at issue. This internal discussion on which differences should constitute the theory’s focus demonstrate its maturity as a theory. It is now sufficiently secure in its academic stature and expansive reach that theorists committed to it are comfortable identifying flaws and engaging in debates about its shortcomings. Other debates also circulate and concern further issues about how to conceptualize intersectionality and define its parameters; they address the scope of the theory and its methodology as well as the ways in which scholarship on intersectionality is or should be mobilized for political purposes (Bilge 2010; Dhamoon 2010; Walby, Armstrong and Strid 2012). These debates reflect a difference in comfort level with intersectionality’s conceptual open-endededness (Davis 2008). Some argue that it is this very ambiguity that has led intersectionality to be successful and embraced as a central component of feminist scholarship (Choo and Ferree 2010). While intersectionality’s unspecified boundaries may be one of its attractive qualities, it has also generated calls for further definition regarding what intersectionality is and how it should be conceptualized and applied to global contexts (Scheilbelhofer and Marotta 2010). Within these interrogations, determining the role of categories and the end intersectionality should serve are all questions on which many scholars seek further certainty. Yet, despite all of these internal debates about intersectionality’s purpose, one boundary has remained certain: the anthropocentric focus of even recent literature 49 Maneesha Deckha DEP n. 23 / 2013 in this area. Within the debate about proper parameters and conceptual scope, the focus on human lives is uncontested. While important self-reflection has occurred among intersectional theorists about the theory’s limits, discussion has not yet encompassed considerations of human species privilege or the oppression of animals. This general failure to focus on nonhuman lives and integrate species as a site of difference, identity, privilege, and oppression into the intersectional mix is interesting given the rise of posthumanist studies in academia (Castricano 2008; Oliver 2009; Wolfe, 2010; Pedersen 2012). However, the non-interrogation of species difference is particularly interesting considering the theory’s essential commitment to recognizing unexcavated, underappreciated, and marginalized differences and identities. It is striking that a theory whose signature trait is encouraging consciousness of how lives are mediated by multiple axes of difference and dominance, has not incorporated species difference into its fold or extended its horizon past human lives even though its open-endedness would facilitate that inclusion. Elsewhere, I have addressed how the integration of species identity and animal issues into intersectionality is an extension that is acutely compatible with intersectionality’s main tenets and underlying theoretical orientation (Deckha 2008). I have also explained how many issues identified as women’s issues, and thus quickly accepted by feminists as normalized areas of feminist study, also involve animal/species dimensions and implicate posthumanist concerns about power and justice. Conversely, I have discussed how those issues seen as “animal rights” issues also intensely relate to issues of race, gender, ethnicity and class that normally capture feminist attention (Deckha 2006). These are three ways in which posthumanist analyses can properly reside within intersectionality and enrich its contributions to theorizing injustice. Here, I want to develop a further reason for feminists to consider animals as “natural” objects of “feminist concerns” by focussing on the social movement of animal advocacy. The gendered and intersectional dimensions of the animal advocacy movement (broadly defined here to include welfarist and abolitionist activism)1 in economically affluent geopolitical spaces establish yet another link for “the animal question” to be embraced as a feminist issue and, concomitantly, for feminists to consider animal identity and human privilege as acceptable elements of an intersectional analysis. Particularly, I argue that the animal advocacy movement should be regarded as a women’s movement as it gives rise to gendered, class, and racialised practices that impact the lives and experiences of its primarily female membership. Accordingly, the animal advocacy movement, including its central attention to species difference, should be of feminist and intersectional concern. Thus, the goals that the movement aims to advance (better regulation or abolition of factory farming, animal research, use of animals for 1 Animal advocates and scholars disagree about the legitimacy of welfare initiatives (those activities that try to reduce animals’ suffering but not end the industry in which they are being exploited) as a meaningful route to address animal suffering (See Francione and Garner 2010). My use of the term animal advocacy encompasses welfare initiatives not to signal the endorsement of these initiatives, but to include them for the concern about animals and the work of women movement participants they represent - both of which I argue deserve greater recognition by feminist intersectionalists. 50 Maneesha Deckha DEP n. 23 / 2013 entertainment, etc.) should be understood as feminist issues not just because of the links between the oppression of marginalized humans and animals that existing animal theory has already demonstrated, but also because the majority of animal advocates are women whose experiences with animal advocacy is adversely inflected by gendering and other differentiating dynamics and processes. After arguing for this association of the animal advocacy movement as a women’s movement, I want to revisit some of the current internal debates within intersectional theory canvassed above. I do so to explain why concerns advanced in these debates do not foreclose the consideration of species difference as one of the sites/axes/grounds of difference to which intersectionalists should attend. That is to say, current concerns expressed by intersectionalists regarding the scope of intersectionality should not act as a bar to including species difference as an acceptable and routine ground within intersectionality theorizing and politics. As this Part will reveal, there is no theoretical impediment for feminists to take up the animal question and engage with animality and species differentiation as part of a feminist intersectional analysis. While, of course, conflicts may arise between how to proceed on any specific issue (as they do in current intersectional situations where multiple difference-based interests may be at stake), there is no general drawback to intersectionality’s stated goals to view the animal advocacy movement as a women’s movement giving rise to feminist intersectional issues. To recap, I thus have two central and related arguments: 1. the animal advocacy movement is a women’s movement (and, thus, this is a further reason that intersectionality should incorporate species as an axis of difference as part of its theoretical model); and 2. there is no substantive barrier preventing the adoption of species difference into feminist intersectional understanding of social issues, which, in turn, enables the recognition of the animal issues as feminist ones. With this in mind, in Part I, I will first briefly explore what are considered typical women’s issues and then go on to articulate how the animal advocacy movement is gendered and intersectional. In Part II, I will explain why the internal debates within intersectionality pose no theoretical impediment to the inclusion of species as a recognized axis of difference. As such, feminist intersectional praxis is not imperiled by the recognition of the animal advocacy movement (hereafter animal movement) as a feminist movement or of the issues it champions to end animal suffering as, broadly speaking, feminist ones. Part I. The Animal Movement as a Women’s Movement A sampling of the gender, race, and class issues prominent within the animal movement helps to educe the movement’s qualification as a women’s movement. Various academic scholarship has already illuminated the significant links between oppressions of animals and marginalized human groups, such as women (Adams 1990, 2003; Gaard 1993; Adams and Donovan 1995; Donovan and Adams 2000, 2007; Donovan 2006; Gruen 2008; Kheel 2008; Oliver 2009). How these intersectional issues circulate within the animal movement provide another reason the mainstream feminist humanist community should view animal issues as feminist issues and animal advocacy as a women’s movement. However, before 51 Maneesha Deckha DEP n. 23 / 2013 delving into this feminist and intersectional reading of the animal movement as a women’s movement, it is useful to consider the types of issues that have been embraced as typical women’s issues. a. Typical Women’s Issues While there is disagreement over what exactly qualifies as a women’s issue or women’s interest (Molyneux 1998), a perusal of academic texts introducing students to women’s studies reveals the repetition of certain standard subjects as women’s issues (Mazur 2002; Grewal and Kaplan 2006). In her paper on why bankruptcy should be considered a women’s issues, Elizabeth Warren (2002) outlines two categories of what gets labelled as typical women’s issues: 1. physical differences between sexes, such as abortion and birth control, and 2. issues related to sexual violence and care work. Along these lines, Maxine Molyneux (1998) makes the distinction between practical and strategic interests. The former are centred on the satisfaction of needs arising from women’s societal placements, whereas the latter are claims to transform social relations and enhance women’s positions within society. Molyneux (1998, p. 233) notes that the “formulation of interests, whether strategic or practical, is to some degree reliant on discursive elements, and is always linked to identity formation”. Pressing a similar point, a number of scholars have advocated for the extension of the boundaries of women’s issues beyond the “typical” ones of abortion, sexual assault, domestic violence, childcare, and others (Finley 1989; Kim 2009, Saguy 2012). Moreover, attention has shifted to conceptualizing women’s interests as gendered interests, a move meant to signal recognition of a fluid, historically contingent and socially constructed concept of women’s interests, as well as an interest in recognizing women’s efforts to address multiple systems of social injustice (capitalism, globalization, racism, etc.) as part of a feminist agenda (Molyneux 1998; Maddison 2004; Vincent, 2010). While these articles attempt to significantly extend what is conventionally defined as a women’s issue, they retain humanist parameters to the exclusion of nonhuman animals. The plight of female nonhumans and their oppressions are cast as disconnected to women’s issues. Furthermore, and the point I which to emphasize here, the typical women’s issues do not incorporate the women within the animal rights movement. These women face gendered and intersectional issues that should be recognized as women’s issues such that their experiences and aims as a movement should qualify the animal movement as a women’s movement. b. Animal Movement is Gendered and Intersectional The animal movement is gendered and intersectional in a number of ways. First, participation in the movement is gendered with women making up the vast majority of activists. Second, women’s experiences within the movement reflect gendered and intersectional issues. I. Gendered Participation Women have historically and continue to participate in disproportionately higher numbers than men in various forms of animal advocacy (Herzog and Golden 52 Maneesha Deckha DEP n. 23 / 2013 2009; Gaarder 2011). Emily Gaarder in her book, Women and the Animal Rights Movement (2011), cites a number of academic studies from the United States that show women outnumbering men among activists engaged in the animal rights movement; these studies indicate participating rates ranging from 68% to 80%. This is reflective of the historical prominence of women in the most prominent early British animal protection organizations where they made up 70% to 75% of participants. Another example illustrating women’s dominance in the movement is that 78% of subscribers to The Animal Agenda, an animal advocacy news magazine in circulation for the past 25 years, are women (Herzog 2007). This disproportionate participation of women is also reflected in attitude surveys about animal issues indicating that women are more supportive of animal movement causes across a range of cultural contexts (Herzog, Betchart and Pitmann 1991; Galvin and Herzog 1992; Kendall, Lobao and Sharpe 2006; Herzog and Golden, 2009; Phillips et al., 2011). II. Gendered and Intersectional Issues that Women Face While women dominate in animal movements across the world, they still encounter gendered experiences in the movement, which, are further complicated by class and race dimensions. These issues are present within the movement, how the movement is received, and in the rational-emotional dichotomy that undergirds women’s participation. Within the Movement The gendered division within the movement is publicly reflected in the fact that the leadership and well-known figures within the movement tend to be men, even though women clearly represent the majority of the movement. Herzog (2007) captures this pattern by highlighting that 60% of the authors reviewed in The Animal Agenda are men and 60% of the activists profiled were men. Furthermore, he cites how 65% of the intellectual and political leaders written about in Animal Rights: History and Scope of a Radical Social Movement were men. While Lyle Munro (2001) affirms that there has been a gradual shift towards more women leaders in the movement, they continue to be underrepresented compared to their numbers. Interestingly, Herzog notes that organizations focused on animal rights are more likely to be led by women than those with an animal welfare or shelter orientation, which he suggests may reflect different financial resources. This potentially reflects another gendered element, in that women reach leadership positions in organizations that tend to have fewer financial resources and less influence as a result. While the numbers represent an obvious gendered division of labour, the differential values associated with the work that women and men do further enforces this division. Gaarder’s study (2011) demonstrates how women manage day-to-day tasks, while men perform acts that get labelled as “heroic”. In particular, men do the more confrontational and often illegal activities that capture attention and establish reputations. In this way, women’s labour and roles within the movement tend to be marginalized. Women face traditional sexist attitudes again in the advertising campaigns employed by certain factions of the movement, 53 Maneesha Deckha DEP n. 23 / 2013 which employs sexist imagery to create sensationalist advertisements in the hopes of raising awareness. It is, however, difficult for women to complain about these issues for fear of risking the movement’s reputation and focus. For example, Gaarder notes how challenges to masculinist leadership positions are shut down for fear of detracting from the goals of advocating animal rights. Women who wish to illuminate the sexual harassment by men in the movement to receive the same dismissive response, being told that they are raising a “human concern,” which detracts from the animal movement (Gaarder 2011, p. 100). Those who wish to stand against various forms of oppression along with speciesism are also marginalized. Reception Outside of the Movement In addition to the gendered and intersectional issues within the movement, there are a number of these issues present in how the movement is received more broadly. These revolve around the credibility and legitimacy of the movement. The following aspects of the movement’s public status illustrate its gendered and otherwise differentiated dynamics: 1. how activists and the movement are stigmatized, 2. the gendered significations and public expectations of the movement, and 3. how women animal movement participants themselves understand the movement’s legitimacy. Stigmatization of Activists and the Movement The stigmatization of the animal movement is widespread (Sorenson 2009, 2011). A significant generator of the stigma applied to animal advocacy occurs through identitarian claims whereby activists are depicted as lacking credibility because of their social status in society. Rachel Einwohner (1999) documents, for example, how hunters dismiss activists as ill-informed about hunting because of their (higher) class and (feminine) gender. As Gaarder notes (2011), at times, negative responses to activists can rise to the level of overtly discriminatory (sexist, racist and homophobic) remarks. Calls for the adoption of animal-free diets have also been met by vigorous critiques about the race and class privilege of activists advocating for vegan and vegetarian diets (Bailey 2007). Indeed, where a advocacy for a particular animal-free practice such as veganism is perceived (rightly or wrongly) by the mainstream animal-eating public to be aligned or associated with an elite racial, culture and/or class group, those activists who are from non-elite race, cultural and/or class groups can face a certain degree of exclusion from these identity groups to which they otherwise belong. To illustrate, Gaarder (2011, p. 72) cites the case of a Mexican-American woman who is labelled as giving up her cultural identity and becoming “whitened” for her involvement in the animal rights movement. She also cites an example of a lesbian woman being told her involvement in the animal rights movement “would give gays and lesbians a bad name”. These experiences of stigmatization reflect intersecting discrimination. Gendered Significations and Expectations of the Movement In addition to the stigmatization of activists and the movement, there are gendered expectations from outside the movement regarding women’s roles and 54 Maneesha Deckha DEP n. 23 / 2013 their proclivity to take up animal work and ethical living in relation to animals that shape women activists’ experiences in the animal movement. For example, Einwohner’s study (1999) shows how circus patrons confronted by animal rights activists associated compassion and nurturing aspects with the women activists. Moreover, women in Gaarder’s study (2011) indicated that it appeared easier for them to choose ethical diets because of larger social gendered expectations disciplining women to control and limit their diets to conform to body image ideals for women to which they were habituated. Here, it is instructive to recall how closely meat eating is associated with power and both mirrors and advances patriarchal values in western societies (Adams 1990). Traditional notions of dominant femininity thus affect the mainstream public’s comprehension of why individuals would choose to advocate for animals against conventional practices as well as how activist women understand their own animal activism. These gendered expectations of women within the movement draw from problematic naturalized idealizations of women with affective labour and docile, diminishing bodies. Moreover, they affect how women within the movement assess their own (impaired) credibility as advocates and contextualize their strategically formed views that the movement would benefit from increasing the participation of men (Gaarder 2011). Such strategies, however necessary, exemplify the continued marginalization of women due to the tightly gendered significations of animal advocacy. Rational-Emotional Dichotomy These conceptualizations of credibility belie the rational-emotional dichotomy that pervades the discourses surrounding the animal advocacy movement and is, perhaps, its most unshakeable association. Under Cartesian dualistic thinking, notions of rationality, reason, and who in society possessed the ability to reason, were prime rationales to exclude whole categories of humans and nonhumans from moral and legal personhood. The residual legacy of the Cartesian premium on reason and corresponding abjection of its understood opposite – emotion – continues to taint those humans and nonhumans who are associated more strongly with emotion than (if, at all) with reason. This residual effect on affect is apparent in the image the animal movement seeks to project in the public sphere. Gaarder (2011) notes how the initial impetus for all the women in her study to join the movement was an affective/emotional one, followed by a process of learning and reading more tightly connected to reason only later. Yet, while the women’s reasons for joining the movement were based on affective responses to animal suffering, once in the movement, they nonetheless attested to a need to employ intellectual and scientific arguments to convince the public of the legitimacy of their claims. To fortify the association of their cause with reason and rationality, animal organizations often chose (white, educated) men to speak for the group. Moreover, Sorenson (2010) discusses how exploitation of animals associated with minoritised racialised cultures have received disproportionate attention within mainstream media even when they are not much different in terms of the pain and suffering involved from mainstream methods of exploiting animals. 55 Maneesha Deckha DEP n. 23 / 2013 These examples illustrates how the traditional disparaged association of women and racialised others with emotions, along with the concomitant privileged association of white men from a certain class with reason, shapes the public messaging of the movement in terms of who serves as its spokespersons and which causes receive favourable attention in the public sphere. The rational-emotional dichotomy plays a significant role in creating and perpetuating the influence of multiple axes of difference within the animal movement. The purpose of this brief snapshot of the types of issues women participants grapple with in the animal movement demonstrates the gendered and intersectional dimensions integral to it. These dimensions confirm why the animal movement should be recognized as a feminist movement in addition to the fact that women disproportionately populate the movement’s rank and file. While further intersectional scholarship and incorporation of intersectional oppressions within the politics of the movement would be valuable to more fully address the power differences shaping the movement, the gendered and intersectional issues that are already apparent provide sufficient reason for feminists to consider the animal movement as an intersectional women’s movement worthy of feminist support. The next section considers whether any reasons exist given recent debates in intersectional theory that should bar this consideration. Part II. Species as an Axis of Difference within Intersectionality While intersectionality is unique in its open-ended approach to which differences matter, there is relatively little written on species as a critical social differentiator. Indeed, a presumptive norm of the literature is anthropocentrism. As I argue in this section, this ongoing paradoxical exclusion of the nonhuman is not necessary to the goals of intersectionality and can, instead, undermine them. I return to several major recent internal debates within intersectionality introduced earlier to outline some of the theory’s most pressing current concerns and show how none pose barriers for an intersectional analysis to move beyond its human limit and transcend the systemic species boundary intersectionality has so far maintained. A path is thus clear to consider the animal movement, and its concern about animals’ lives, as a feminist movement. a. Recent Debates within Intersectional Literature There are multiple, recent points of debate concerning intersectionality (Garry 2011). Here, I focus on three that engage the proper parameters of the theory. In particular, it is not clear whether intersectionality is a theory, a concept, a heuristic device, or a reading strategy for doing feminist analysis; it has been used in all of these ways (Davis 2008). This ambiguity regarding what intersectionality is has stimulated specific debates about the following: what imagery should be employed to conceptualize intersectionality; the role of categories; and whether a specific marker of difference should be central to an intersectional analysis. Each debate is discussed below. First, agreement on the best image to illustrate intersectionality has proven elusive. The first conceptualization in the literature that Kimberlé Crenshaw (1988) 56 Maneesha Deckha DEP n. 23 / 2013 presented was a traffic metaphor of roads intersecting. Nira Yuval-Davis (2007) argues that this crossroads imagery is inherently additive and fails to capture how interacting identities are inseparable and mutually reinforcing. Along similar lines, Julia Jordan-Zachery (2007, pp. 260-261) argues that the conceptualization of intersectionality as “interlocking” oppressions implies that the systems can be disentangled, which fails to recognize that they are enmeshed and intertwined. On the other hand, as Dhamoon (2010) discusses, other scholars prefer the “interlocking” model as it recognizes how systems of oppression are locked together in various forms of hierarchical ordering. Some scholars have criticized this range of theoretical variation, worrying that it precludes a standard methodological approach to researching intersectionality. Others argue that there is no need for a single, universally agreed upon concept and that the focus should be on an awareness of the critical capacity of the chosen concepts and openness to changing these models as theories develop (Garry 2011). The different models for conceptualizing intersectionality reflect a second element of the debate, which involves the critical role of categories (Hancock 2010, Garry 2011). Some scholars have argued that the categories of difference around which the theory revolves reproduce the very essentialisms that intersectionality seeks to redress. Instead of being viewed as dynamic processes, they come across as relatively fixed categories. Richard Delgado (2011) indicates that this may be inherent to intersectionality, suggesting that it presupposes essentialism largely because of its focus on categories of difference. On the other hand, Jennifer Nash (2008) views categories as more of a problem of academic practice rather than inherent to intersectionality as a concept. She argues that the way scholars perform intersectionality research tends to apply additive approaches that produce essentialised categories, but that this approach can be revised. Dhamoon (2010, p. 233) also recognizes the essentialising effect of categories in noting how an intersectional analysis “can end up reiterating the very norms it aims to challenge”. She argues that a focus on processes and systems instead of individuals and groups can help avoid this situation. Echoing this sentiment, Lisa García Bedolla (2007) argues that models of intersectionality need to be mindful of essentialising the very categories that are being challenged. In addition to the concern about the reification of categories, a third point of debate is whether a particular marker of identity or a particular object should be at the centre of an intersectional analysis. For example, some have argued that class should command the centre in a hierarchy of oppressions as the principal social axis of difference, with others falling below it (Bilge 2010; Walby, Armstrong & Strid 2012). Others are reluctant to accept a presupposition of which inequality is central and argue for leaving this as an empirical question as each issue is addressed (Walby 2007). This point about analytical primacy underscores a larger critique that intersectionality’s methodology is seriously undertheorised; indeed, some contest whether it is even a methodology, distinguishing it instead as a framework (Garry 2011). While it has achieved “theoretical dominance as a way of conceptualizing identity” (Nash 2011, p. 3), its methodology/framework, as well as the conceptualization and categorical queries above, suggest considerable room for the theory to gain greater clarity and focus (Garry 2011; Nash 2011). 57 Maneesha Deckha DEP n. 23 / 2013 b. Why Species should be included as a Marker of Difference This brief review of several main debates about the scope of intersectionality reveals that there is nothing within them to argue against the inclusion of species difference or the consideration of nonhuman lives at the individual or institutional level. The first concern about the ideal metaphor to capture the theory’s central thesis is neutral about which differences should matter. Rather, it is simply a concern about how to signal the mutual constitution of differences and their complex interactivity in an accessible way. If species difference were included in the mix as easily as gender, race, and class are, we would quickly acknowledge that our human species identity mixes inextricably with these other “classic” differences such that our experiences as a gendered, racialised and classed being, for example, take their timbre from our equally relevant identity as a human. Indeed, that so many human claims to injustice pivot on experiences of dehumanization and the stigma of being perceived as subhuman or animal by the dominant human community illustrates how much concepts of gender, race, and class are inflected with species significance as well as how productive including species as an analytic can be for unpacking marginalizing dynamics. The second conceptual debate canvassed above pertaining to the tendency of some intersectional theorists to reify categories of difference despite contrary intentions, also does not contain any strong argument as to why species difference needs to be excluded when intersectionalists consider difference. If anything, challenging the human-nonhuman boundary would undo a key essentialised category within the theory. As many writing in relation to the field of animal studies have shown, the human is not a stable marker of identity, but a fiercely historically and culturally contingent one (Castricano 2008; Wolfe, 2010; Pedersen 2012). Moreover, treating this species status as an identity in need of deconstruction along with norms of whiteness, masculinity, heterosexuality, and other privileged identities, would reduce essentialising within intersectionality rather than promote it. Furthermore, adding species as another entry to the list of markers of difference to consider within an intersectional analysis is not to suggest that it be a pre-eminent factor or always important to analyzing a particular phenomenon. Rather, it could simply be another category of difference to bear in mind where relevant. With respect to the third debate about which difference merits more prominence in the theory, it is difficult to defend a position that discounts the salient of species identity in shaping our cultural, legal and political treatment. If race and gender have widespread influence, surely species is implicated in power differentials as well. To take a dramatic example, humans are legally classified as persons with rights while animals are classified as property (the object of rights) in the law. It is true that the cultural divide between humans and animals contains more scope for movement across the species boundary line than the legal one. Consider the “humanized animals” that are treated as family members and the “animalized humans” whose humanity is not recognized to the same extent as those seen as fully humans (Wolfe 2003, p. 101). Yet, despite the presence of animals who are treated like humans and humans who are treated like animals, strong cultural codes 58 Maneesha Deckha DEP n. 23 / 2013 continue to teach us to value humans at a higher level than animals such that we immediately understand the negative implication in treating someone “like an animal”. The animal is the cultural marker by which we define that what it means to be human, a definition that carries cultural values of human superiority and privilege (Oliver 2009). Even if it is conceded that species is a supremely salient difference, equivalent or exceeding the ubiquity of race, gender and class, it is necessary to ask would a further entry to the list of socially relevant differences present another problem to intersectional analysis. Delgado (2011) presents an interesting criticism of intersectionality as a double-edged sword where it may permit organization of the marginalized but can also be utilized by conservative forces to further marginalization. Delgado argues that intersectionality may undercut progressive arguments by delegitimizing analyses that may have missed a particular category of difference. He seems to argue that no matter how in-depth your analysis is, it is likely a smaller unit of analysis is possible. In other words, further intersections can be found within your categories of analysis, thus exposing intersectional arguments to attack for excluding these smaller units. Moreover, the focus on smaller and smaller units of analysis may prevent a more complete account of systemic and systematic patterns of oppression. These aspects of intersectionality go towards serving powerful interests by paralyzing progressive arguments. In this way, a focus on multiple (and never-ending) differences can be a tool of empowering the powerful. Delgado raises an important concern about the political risk of further complexifying intersectionality through the addition of yet another difference axis. However, an intersectional analysis need not require attention to each and every possible different marker. Rather, an intersectional analysis could be a framework for deconstructing power relations within society. Ange-Marie Hancock (2007) reinforces this view by articulating how over time her initial conception of intersectionality as a content-based specialization on specific identities and subjectivities has shifted to understanding it as a normative and empirical paradigm. In other words, intersectionality can be applied more broadly from studying particular groups exhibiting intersecting marginalized identities to examining institutional interactions and contexts. Indeed, Hancock asserts that intersectionality has traditionally taken racialised women as its favoured group study, but that its potential as a normative paradigm reaches much further. The specific differences that a researcher should focus on will come into view with the particularities of each given project. Although the risk remains that an intersectional analysis can be undermined for not being intersectional enough, it still seems a more palatable option than a unidimensional analysis because it better captures realities of power relations and more fully illustrates the complexities of identities. Furthermore, the integration of posthumanist concerns into intersectionality counters the critique that scholarship in the field tends to neglect studies about the analysis of identities that are either wholly or partially privileged. Scholars have articulated the need for problematizing relationships of power for unmarked categories, such as whiteness, masculinity, heterosexuality, and other privileged 59 Maneesha Deckha DEP n. 23 / 2013 markers of identity (Choo & Ferree 2010; Garry, 2011; Nash 2011). Dhamoon (2010, p. 235) identifies this problem when she says that research should shift from “the Othered identity and category of Otherness to a critique of the social production and organization of relations of Othering and normalization”. She further discusses how the focus on uncovering oppressions among humans tends to present static understandings of individuals that preclude recognition of agency. Instead, Dhamoon (2010, p. 238) argues for an approach that studies interactive processes and structures in which “meanings of privilege and penalty are produced, reproduced, and resisted in contingent and relational ways”. Others have echoed this call to encourage research that focuses on how situations are dynamic and relational as well as studies that address how privilege and power can reside in and shape experiences of marginalization (Nash 2011). A consideration of human relationships with animals and the circuits of power that flows in them would go a long way to generating this shift in focus. It would demand (human) exploration of our privileged identities vis-à-vis other species given our highly anthropocentric world. It would also illuminate how we all exercise agency in our relationships with animals no matter how oppressed we may be ourselves. Considering species as part of the regular repertoire of differences to which intersectional analyses normally attend could also reduce the impugned phenomenon of the “Oppression Olympics,” in which groups seek to define themselves as the “most oppressed” for political purposes (Hancock 2007; YuvalDavis 2012). The extent of violence that humans perpetrate on animals on a daily and global basis makes any claims about being the “most oppressed” difficult to justify. As is apparent from this brief review of recent conceptual debates in intersectionality theory, there no compelling reason exists to justify the current exclusion of species from the difference mix that animates intersectional critiques. In fact, including species difference and animal lives as elements of theorization and mobilization help complicate understandings of privilege and forward the impact of intersectionality as a normative paradigm – to use Hancock’s term – to handle cutting-edge, particularly post-humanist, questions of justice. Conclusion My goal in this article has been to present two interconnected arguments: 1. the animal movement is a feminist movement; and 2. species should be incorporated as a relevant marker of difference within the discourses in the intersectionality literature, thus enabling this response to the animal movement. In Part I, I discussed the multiple reasons that the animal movement should be seen as a feminist and women’s movement. The movement is dominated by women who experience gendered and intersectional issues, both within the movement and from outside. Within the movement, women endure highly gendered patterns such as the division of labour between leaders and the ordinary members of the movement. Responses to the movement and women activists within it are also strongly shaped by traditional gendered roles as well as the reason/emotion divide that has been a foundational othering logic for multiple marginalized groups, both human and 60 Maneesha Deckha DEP n. 23 / 2013 animal. For these reasons, women’s experiences and aims should be acknowledged as fitting the general paradigm of a women’s movement. The qualification of the animal movement as a women’s movement serves to fortify the overall case why species as an axis of social difference should matter to feminists committed to intersectionality. This case has already been made by ecofeminists and other animal studies scholars who have demonstrated the interconnectedness of sexism, racism, colonialism, etc. with oppression against animals. The gendered and intersectional dynamics of the movement itself as discussed here provide a further reason that intersectionality should move past its humanist parameters. Despite the expansive consideration of intersectionality as a theory and the shortcomings it needs to address, humanism or an anthropocentric speciesist orientation has not been seen to be a weakness of intersectionality. The literature to date has remained focused on humanist parameters. This is particularly disconcerting since intersectionality is focused on incorporating elements of difference and how those differences fit into systems of oppression. A review of recent conceptual debates within the literature on intersectionality illustrate that there is no theoretical impediment to the inclusion of species difference within the discourse. Moreover, this type of posthumanist extension would further the goals of intersectional scholarship. References Adams, Carol, Josephine Donovan, eds. 1995. Animals and Women: Feminist Theoretical Explorations. Durham: Duke University Press. Adams, Carol. 1990. The Sexual Politics of Meat: A Feminist-Vegetarian Critical Theory. New York: Continuum. Adams, Carol. 2003. The Pornography of Meat. New York: Continuum. Bailey, Cathryn. 2007. “We Are What We Eat: Feminist Vegetarianism and the Reproduction of Racial Identity.” Hypatia 22(2): 39-59. Bedolla, Lisa Garcia. 2007. “Intersections of Inequality: Understanding Marginalization and Privilege in the Post-Civil Rights Era.” Politics & Gender 3(2): 232-248. Bilge, Sirma. 2010. “Recent Feminist Outlooks on Intersectionality.” Diogenes 57(1): 58-72. Bürkner, Hans-Joachim. 2012. “Intersectionality: How Gender Studies Might Inspire the Analysis of Social Inequality among Migrants.” Population, Space and Place 18 (2): 181-195. Castricano, Jodey. 2008. Animal Subjects: An Ethical Reader in a Posthuman World.: Waterloo, ON.: Wilfrid Laurier University Press. Choo, Hae Yeon and Myra Marx Ferree. 2010. “Practicing Intersectionality in Sociological Research: A Critical Analysis of Inclusions, Interactions, and Institutions in the Study of Inequalities.” Sociological Theory 28 (2): 129-131. 61 Maneesha Deckha DEP n. 23 / 2013 Choo, Hae Yeon. 2012. “The Transnational Journey of Intersectionality.” Gender & Society 26(1): 40-45. Crenshaw, Kimberlé. 1988. “Race, Reform and Retrenchment: Transformation and Legitimation in Antidiscrimination Law.” Harvard Law Review, 101(7): 13311387. Cudworth, Erika and Stephen Hobden. 2011. Posthuman International Relations. London: Zed Books. Davis, Kathy. 2008. “Intersectionality as Buzzword: A Sociology of Science Perspective on what makes a Feminist Theory Successful.” Feminist Theory 9(1): 67-85. Deckha, Maneesha. 2010. “Teaching Posthumanist Ethics in Law School: The Race, Culture, and Gender Dimensions of Student Resistance.” Animal Law 16(2): 287-315. Deckha, Maneesha. 2008. “Intersectionality and Posthumanist Vision of Equality.” Wisconsin Women’s Law Journal 23(2): 249-268. Deckha, Maneesha. 2006. “The Salience of Species Difference for Feminist Legal Theory.” Hastings Women’s Law Journal 17(1): 1-38. Delgado, Richard. 2011. “Rodgrigo’s Reconsideration: Intersectionality and the Future of Critical Race Theory.” Iowa L Rev 96(4): 1247. Dhamoon, Rita Kaur. 2010. “Considerations on Intersectionality.” Political Research Quarterly 64(1): 230-243. Mainstreaming Donovan, Josephine & Carol Adams. 2000. Beyond Animal Rights: A Feminist Caring Ethic for the Treatment of Animals. New York: Continuum. Donovan, Josephine, Carol Adams, eds. 2007. The Feminist Care Tradition in Animal Ethics: A Reader. New York: Columbia University Press. Donovan, Josephine. 2006. “Feminism and the Treatment of Animals: From Care to Dialogue.” Signs 31(2): 305-329. Einwohner, Rachel L. 1999. “Gender, Class, and Social Movement Outcomes: Identity and Effectiveness in Two Animal Rights Campaigns.” Gender & Society 13(1): 56-76. Finley, Lucinda. 1989. “A Break in the Silence: Including Women’s Issues in a Torts Course.” Yale Journal of Law & Feminism 1(1): 41-74. Francione, Gary, Robert Garner. 2010. The Animal Rights Debate: Abolition or Regulation? New York: Columbia University Press. Gaard, Greta. 1993. ed, Ecofeminism: Women, Animals, Nature. Philadelphia: Temple University Press. Garry, Ann. 2011. “Intersectionality, Metaphors, and the Multiplicity of Gender.” Hypatia 26(4): 826-850. 62 Maneesha Deckha DEP n. 23 / 2013 Galvin, Shelly L., Harold A. Herzog. 1992. “Ethical Ideology, Animal Rights Activism, and Attitudes Toward the Treatment of Animals.” Ethics & Behaviour 2(3): 141-149. Grabham, Emily et al, “Introduction” in Emily Grabham, Davina Cooper, Jane Krishnidas, and Didi Herman, eds. 2009. Intersectionality and Beyond: Law, Power, and the Politics of Location, pp. 1-18, Oxford, UK: Routledge-Cavendish. Gruen, Lori. 1993. “Dismantling Oppression: An Analysis of the Connection between Women and Animals,” in Greta Gaard, ed. Ecofeminism: Women, Animals, Nature, pp. 60-90, Philadelphia: Temple University Press. Herzog, Harold A., Lauren L. Golden. 2009. “Moral Emotions and Social Activism: The Case of Animal Rights.” Journal of Social Issues 65(3): 485-498. Herzog, Harold A, Nancy S Betchart, and Robert B. Pittman. 1991. “Gender, Sex Role Orientation, and Attitudes Toward Animals.” Anthrozoös 4(3): 184. Herzog, Harold. 2007. “Gender Differences in Human-Animal Interactions: A Review.” Anthrozoös 20(1): 7-21. Hines, Sally. 2010. “Sexing Gender; Gendering Sex: Towards an Intersectional Analysis of Transgender,” in Yvette Taylor, Sally Hines and Mark E Casey, eds. Theorizing Intersectionality and Sexuality, pp. 140-152. New York: Palgrave Macmillan. Inderpal Grewal, Caren Kaplan. 2006. An Introduction to Women’s Studies: Gender in a Transnational World. Boston: McGraw-Hill Higher Education. Jordan-Zachery, Julia S. 2007. “Am I a Black Woman or a Woman Who Is Black? A Few Thoughts on the Meaning of Intersectionality.” Politics & Gender 3(2): 254-263. Kendall, Holli A, Linda M. Lobao, and Jeff S. Sharp. 2006. “Public Concern with Animal Well-Being: Place, Social Structural Location, and Individual Experience.” Rural Sociology 71(3): 399-428. Kheel, Marti. 2008. Nature Ethics: An Ecofeminist Perspective. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers. Kim, Mijoo. 2009. “Disability Issues are Women’s Issues.” Development 52(2): 230-232. Levine-Rasky, Cynthia. 2011. “Intersectionality Theory Applied to Whiteness and Middle-Classness.” Social Identities 17(2): 239-253. Maddison, Sarah 2004. “Young Women in the Australian Women’s Movement.” International Feminist Journal of Politics 6(2): 234-256. Mazur, Amy. 2002. Theorizing Feminist Policy. Oxford: Oxford University Press. 63 Maneesha Deckha DEP n. 23 / 2013 Molyneux, Maxine. 1998. “Analysing Women’s Movements.” Development and Change 29: 219-246. Munro, Lyle. 2001. “Caring about Blood, Flesh, and Pain: Women’s Standing in the Animal Protection Movement.” Society & Animals 9: 1-43. Nash, Jennifer. 2011. “’Home Truths’ On Intersectionality.” Yale Journal of Law and Feminism 23(2): 445-470. Oliver, Kelly. 2009. Animal Lessons: How they teach us to be human. New York: Columbia University Press. Pedersen, Helena. 2012. “Is ‘the Posthuman’ Educable? On the Convergence of Educational Philosophy, Animal Studies, and Posthumanist Theory.” Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education 31(2): 237-250. Phillips, Clive et al. 2011. “An International Comparison of Female and Male Students’ Attitudes to the Use of Animals.” Animals 1: 7. Saguy, Abigail. 2012. “Why Fat is a Feminist Issue.” Sex Roles 66: 600-607. Scheibelhofer, Paul and Vince Marotta. 2012. “Intersectionality: Legacies and Controversies.” Introduction to Intersectionality Virtual Special Issue of Journal of Intercultural Studies http://www.tandf.co.uk/journals/pdf/spissue/cjis-vsiintersectionality-fullintro.pdf. Sorenson, John. 2009. “Constructing Terrorists: Propaganda About Animal Rights.” Critical Studies on Terrorism 2(2): 237-256. Sorenson, John. 2010. About Canada: Animal Rights. Halifax & Winnipeg: Fernwood Publishing. Sorenson, John. 2011. “The Myth of ‘Animal Rights Terrorism’.” The Brock Review 12(1): 69-99. Vincent, Louise. 2010. “A Question of Interest: Women as Opposition.” Democratization 8(1): 69-84. Walby, Sylvia. 2007. “Complexity Theory, Systems Theory, and Multiple Intersecting Social Inequalities.” Philosophy of the Social Sciences 37(4): 449-470. Walby, Sylvia, Jo Armstrong, and Sofia Strid. 2012. “Intersectionality: Multiple Inequalities in Social Theory.” Sociology 46(2): 224-240. Warren, Elizabeth. 2002. “What is a Women’s Issue? Bankruptcy, Commercial Law, and Other Gender-Neutral Tropics.” Harvard Women’s Law Journal 25: 1956. Wolfe, Cary. 2003. Animal Rites: American Culture, The Discourse of Species, and Posthumanist Theory. Chicago: University of Chicago Press. Wolfe, Cary. 2010. What is Posthumanism?. Minneapolis: University of Minnesota Press. 64 Maneesha Deckha DEP n. 23 / 2013 Yuval-Davis, Nira. 2006. “Belonging and the Politics of Belonging.” Patterns of Prejudice 40(3): 197-214. Yuval-Davis, Nira. 2007. “Intersectionality, Citizenship and Contemporary Politics of Belonging.” Critical Review of International Social and Political Philosophy 10(4): 561-574. Yuval-Davis, Nira. 2012. “Dialogical Epistemology - An Intersectional Resistance to the ‘Oppression Olympics’.” Gender & Society 26(1): 46-54. 65 Ecofeminism, Women, Environment, Animals by Lisa Kemmerer* Abstract: Feminist thinkers, focused on moving toward sex equality, turned their attention to the root causes of sexism and the oppression of women. In the process, thinkers and authors such as Carol Adams, Josephine Donovan, Greta Gaard, and Marti Kheel unearthed common ground between feminists, environmentalists, and animal activists, connecting with and advancing a comparatively new school of thought, Ecofeminism. Systems of Oppression In their quest to ascertain and expose the causes of sexism, feminists explored dualistic thinking and a tendency to form hierarchies. Over time, these ways of viewing and ordering individuals and the world came to be understood as foundational forces undergirding and backing sexism. Ecofeminists eventually pointed out that these same forces create and support systems of oppression that affect, among other things, women, the natural environment, nonhuman animals. Dualism Dualism is a way of ordering the world through the use of opposites such as male/female, civilization/nature, and human/animal. Dualism fosters an understanding of the world whereby anything and anyone that/who does not qualify for a particular category is excluded from that category and becomes “other.” Dualism thereby divides living beings into two sex categories. All males are lumped together at birth based on visible protruding genitalia, and these individuals are considered separate and distinct from individuals who do not have protruding genitalia – “the opposite” sex. Dualism is evidenced in our English * Lisa Kemmerer is a philosopher-activist dedicated to working against oppression, whether on behalf of the environment, nonhuman animals, or disempowered human beings. Her recent books include Sister Species: Women, Animals, and Social Justice, Speaking Up for Animals: An Anthology of Women’s Voices, and Animals and World Religions. She is currently associate professor of philosophy and religions at Montana State University Billings, and is working on several publications, including a book (likely titled Eating Earth) that explores links between dietary choice and environmental degradation. Kemmerer has hiked, biked, kayaked, and backpacked extensively, including a wonderful visit to Italy whilst studying in Europe. You can learn more about her work at lisakemmerer.com. © DEP ISSN 1824 - 4483 Lisa Kemmerer DEP n. 23 / 2013 language: We do not have a gender neutral pronoun for humans, who are necessarily categorized as either male or female. In a similar manner “nature” is distinguished from civilization, culture, and human beings. Nature is that which is not affected by humanity, and to be human is to be civilized and cultured. This is further evidenced in our dualistic tendency to view humans as separate and distinct from all other animals. Dualism also divides mind from body and reason from emotion, treating each as distinct and separate. These supposedly exclusive categories of male/female, nature/culture, and human/animal, do not properly reflect the complexity of the world in which we find ourselves. For example, though dualism holds that there are only two sexes, defined as 46, XX and 46, XY (46 chromosomes, 23 from the mother and 23 from the father, XX for females and XY for males), human beings come with a variety of karyotypes: 45, X; 47, XXX; 48, XXXX; 49, XXXXX; 47, XYY; 47, XXY; 48, XXXY; 49, XXXXY; and 49, XXXYY. Despite such obvious shortcomings, dualistic divisions of “male” and “female” remain the most fundamental methods by which we categorize human beings. Also problematic, we are neither separate nor distinct from nature or “other” animals: Humans are primates, mammals…animals. We are part of the animal world, and part of nature. Similarly, minds cannot exist without bodies and reason and emotion work together in any well-balanced human being. Hierarchy Dualistic thinking is foundational in the Western world, as in many other civilizations. Through dualism, men, human beings, civilization, culture, mind, and rational thought are envisioned as holding a particular set of esteemed characteristics, relegating females, nonhuman animals, untamed wildness, bodies, the material world, emotions, and intuition to a separate and lesser category. In The Pornography of Meat, ecofeminist Carol Adams aptly uses the terms “A” and “Not A” to describe this dualistic categorization. Feminists and ecofeminists noticed that dualism was not merely a division of individuals and things into separate but equal categories. Anything and anyone in the “Not A” category was considered mutually interconnected and lesser. Those envisioned as belonging to the “Not A” category are envisioned as being more closely linked with one another than with those in the “A” category: Women and nonhuman animals tend to be understood as more about bodies than minds, emotions than reason, and of course closer to “Mother” nature than are male humans. As an extension of this process, all things associated with those in the “Not A” category tend to be viewed as lesser and/or in a negative light, such as domestic work, menstruation, emotive responses, barnyards, paddocks, tails, and walking on four legs. In contrast, those in the “A” category are associated with all things considered good. For example, they tend to be heralded as the backbone of civilization and the epitome of reason and culture, evidenced by the fact that religious elites, powerful leaders, and those considered to be the finest artists and scientists tend to be male in Western societies. Again, the English language supports this conclusion: Denigrating terms used to refer to women are often simultaneously used to refer to nonhuman animals, 67 Lisa Kemmerer DEP n. 23 / 2013 including “cow,” “chick,” “heifer,” “kitten,” “hen,” “biddy,” “sow,” “kitten,” “cougar,” and “vixen.” In comparison, males have few animal-related references, and among these, a good option are positive, such as “stud” – a strong, virile, handsome animal who is generally held in high esteem in Western societies. In contrast, derogatory adjectives stemming from animal terms, such as “catty” and “bitchy,” are generally reserved for women. Men might be called “dog” or “pig”, but these terms can be a matter of pride rather than denigration, which is rarely the case with “bitch” or “catty.” Women are also visually connected with nonhuman animals, bodies (as opposed to minds), and nature when portrayed as sex objects such as the mermaid and the playboy bunny. Animals – especially those exploited as commodities – are depicted with distinctly feminine (“sexy”) physical traits, such as large eyes, batting eyelashes, smooth legs, and curvaceous bodies, as powerfully demonstrated in The Pornography of Meat. Oppression Through dualism and hierarchy, individuals, attributes, and physical objects are separated into two distinct groups. One group, “A,” is given precedence over the other, which is formed by default – “Not A.” This results in a hierarchy favoring those in the “A” category, who thereby gain esteem, power, and control in relation to those in the “Not A” category. This esteem, power, and control are reflected in sexism, anthropocentrism, and speciesism. Sexism oppresses women because they are women – not because they are inherently unworthy or lesser, but simply because they were not born with external, protruding genitalia. Clearly the nature of ones genitals is not a morally relevant difference such that men should be granted opportunities and powers that are denied those not born with external protruding genitalia. Similarly, anthropocentric people tend to assume that all things human – culture, civilizations, and humans themselves – ought to hold power and precedence over all things nonhuman - the natural world and all that dwells therein. Again, there is no morally relevant distinction between all-things-human and all-things-not-human such that the former ought to be held in more esteem or granted power and privilege over the latter. Nonetheless, all things human have been granted esteem in relation to all things natural, and as a result, it has been assumed right and proper that the natural world be viewed as “natural resources” for human use, and that humans exploit, control, and manipulate the natural world for their personal ends. And again, notbeing-human does not constitute a morally relevant distinction such that all other animals are rightly exploited, controlled, and manipulated by and for human beings, yet humans have been granted precedence, and all other animals are, indeed, manipulated by and for human beings. Despite a lack of any morally relevant distinction between males and not-males, between human beings and their civilizations and the rest of nature, and between human beings and the rest of the animal world, males and humans hold place of privilege and power, controlling and manipulating others and the world around them. This is the definition of sexism, anthropocentrism, and speciesism: All beings and things that have been lumped together in the “Not A” category – women, nature, nonhuman animals – are 68 Lisa Kemmerer DEP n. 23 / 2013 unjustly denigrated and oppressed by, on behalf of, and in relation to those in the “A” category. This situation simultaneously invites and justifies “A” control. Those in the “A” category are apt to be thought to be rightly in charge, to rightly gain advantages, and to rightly exploit “Not A” individuals – to be sexist, anthropocentric, and speciesist. For example, if women are understood to be more about bodies than minds, and more about emotion than reason, it makes sense that males are favored for higher education and many job opportunities. It thereby makes sense that women be relegated to the home, domestic labor, reproduction, and to childbearing. If women are less cultured and less civilized, it makes sense that men control their lives. Similarly, if cows and chickens lack reason and culture, and are more about bodies than minds, they are also rightly controlled by those in the “A” category, and used for “higher” purposes by those in the “A” category. Through this process “Not A” individuals are viewed as/become dependent on those in the “A” category. Women are viewed as/become dependent on men for protection and financial support; nature is viewed as/becomes dependent on human beings to cultivate and “manage” untamed wilderness (wildlife numbers, water flow, and wild fires, for example), and eventually to protect nature from obliteration; and nonhuman animals are viewed as/become dependent on human beings to “manage” (as in wildlife management), protect, and provide sustenance and medical care (domestic animals). In return for protection, management, and provisions, those in the “Not A” category are expected to service the needs of those in the “A” category - to cook and clean and provide sexual satisfaction, offer produce and grazing lands, and provide offspring, milk, eggs, and flesh, for example. Women, nature, and animals are all similarly envisioned as lesser, dependent, and as rightly controlled and exploited. In fact, because “Not A” individuals are deemed irrational dependents, many in the “A” category feel justified in controlling those in the “Not A” category with violence. They feel, consciously or subconsciously, that an overlay of strength and culture and reason is rightly brought to those in the “Not A” category by those in the “A” category, and that women, nature, and nonhuman animals must be subservient and provide those in the “A” category in certain ways. As it turns out, even when those in the “A” category do not provide anything to those in the “Not A” category, “A” individuals maintain a sense of power and control over “Not A” individuals. Until recently it was not even possible for a wife to accuse her husband of rape; raping the earth continues to be legal; animal abuse is only starting to be recognized and treated as a serious crime (as reflected in more stringent sentences as we have come to understand that such offenders are also dangerous to human beings). Not surprisingly, domestic violence, harassment, date rape, and animal abuse remain stubbornly (and unnervingly) common. Women and Animals - Bodies for Exploitation Because they are more similar to one another than to a tree or a stream, parallels of oppression are particularly striking with regard to women and nonhuman animals. Those who hold power (“A” individuals) have a tendency to control and exploit female bodies, especially female reproductive biology – whether woman, 69 Lisa Kemmerer DEP n. 23 / 2013 sow, cow, or hen. A husband’s long-held authority over his wife, and her historic inability to accuse him of rape or to claim her children against her husband’s will, exemplify “A” control over “Not A” individuals. Women and children have long been treated as the exclusive property of husbands- his woman, and therefore his vagina to access, his womb to fill, his sons born to carry on his name, lineage, work, and property. Similarly, those practicing “animal husbandry” envision cattle and pigs and turkeys as their personal property - their cow and sow, and therefore their vagina to access, their womb to fill, and their offspring to use for personal gain. Just as men practice “husbandry” with farmed animals, holding these individuals in a position of forced dependence, using their physical bodies for their own ends, impregnating them and claiming their offspring, husbands traditionally held wives in a position of forced dependence, used their physical bodies for their own ends, impregnate them and claimed their offspring. Many still do. While traditional marriage provides ample evidence of “A” control over “Not A” individuals, sex trafficking is a particularly apt example of this phenomenon. Women caught in the web of sex trafficking are victimized because their bodies are viewed as a commodity that might be gainfully exploited by and for those in the “A” category. Women who fall victim to sex trafficking are exploited because they have a woman’s legs, breasts, face, hands, buttocks, and of course a woman’s vagina and womb, and because they are “Not A” individuals. As “Not A” individuals, they are viewed by “A” individuals as controllable and exploitable, as property, and some “A” individuals will purchase and thereby “own” a particular “Not A” individual. Usually such “property” is purchased for the explicit purpose of gaining access to a female body for sexual pleasure, and also for domestic labor. Other “Not A” individuals are also purchased, and their bodies and labor exploited by “A” individuals who wish to gain access to female bodies for personal ends, usually profit. Like those caught in the sex trafficking industry, farmed animals are exploited specifically because of their female biology. Cows, pigs, turkeys, and hens are perpetually forced to reproduce by “A” individuals, for “A” individuals, and cows and hens are additionally exploited for their nursing milk and reproductive eggs. Cows in the Dairy Industry The “breasts” (teats, mammary glands, udders) and nursing milk of cows are owned, accessed, and controlled, for the sake of profit, by those who own and run dairy farms. Mammals only lactate after giving birth, so dairy farmers use what they term a “rape rack” to artificially inseminate cows, pushing their hand far up her vagina to forcibly impregnate her, resulting in a nine month pregnancy. When her calf is born, the farmer takes her baby away, despite the desperate mother’s best attempts to defend her young, and despite her ongoing lament at the loss of her newborn. Her calf is sold for veal, or raised to be similarly forcibly impregnated and milked for dairy products. Bereft of her offspring, a cow bawls for days, but all the while machines are busy pumping her calf’s milk, which will be sold as yogurt, ice cream, cheese, or milk. Like women and girls caught in the sex industries, the stress and misery that cows experience on dairy farms takes its toll. Though cows can live twenty to even 70 Lisa Kemmerer DEP n. 23 / 2013 twenty-five years in farmed animal sanctuaries, cows in the dairy industry are “spent” after just five or six years of forced impregnation, birthing, loss of a calf, and perpetual milking, at which time she follows her calves to slaughter, usually while pregnant. Because their bodies have been brutally exploited, they frequently arrive as “downers,” unable to stand or walk, and are drug or pushed off of transport trucks at the slaughterhouse. Cows suffer on dairy farms because they are females – because they lactate when they give birth – and because dairy farmers feel entitled to manipulate and exploit female biology for personal profit. Dairy farmers profit from a cow’s mammary secretions, her offspring, and eventually from her body when she is sold for hamburger. Chickens and the Egg Industry Like cows, hens are exploited specifically because of their female biology, because their bodies harbor and pass eggs for reproduction. When hens are mature and ready to nest, they pass eggs daily until they establish a clutch of eggs, which they then incubate until the eggs hatch. But of course this is not what happens with hens or eggs in the egg industry, where both are controlled and exploited by “A” individuals. In the egg industry, eggs are hatched in a stark environment far from the mother hen. Instead of being hatched in the dark, under the warm fluff of her mother, and to the sounds of her mother’s clucking, a chick is hatched onto a hard surface under a bright and silent neon light. She will spend her entire life in an artificial setting, without the sky overhead or grass and dust underfoot, without fresh air or natural light, in close confinement with other hens. No doubt a newly hatched chick peeps for her mother, but her mother is perhaps thousands of miles away, and though the mother hen would no doubt love to fluff her feathers around her newly hatched offspring, she is not permitted to do so – if in fact she is even still alive. The newly hatched chick soon finds herself moving along a conveyor belt, where males are scooped off the belt and either thrown into the trash (where they suffocate), or tossed into a grinder (alive) (where they are transformed into fertilizer). Roosters are of no use to the egg industry. No doubt the little new-born chick hears the desperate and dying peeps of the males as she continues down the belt, where she is roughly snatched, this time to be thrust into a machine that sears off a significant portion of her beak. From that day on she cannot eat naturally or preen her feathers properly. Debeaking is very painful, but is deemed necessary for hens trapped in such crowded, miserable conditions that they are likely to peck one another, perhaps even to death. If she survives debeaking, the chick is placed in a gigantic shed with thousands of other chicks, where she is left to grow for five months. If she survives to sexual maturity, she is then placed in a battery cage about the size of a microwave oven, usually with five other hens, where she will remain, standing on wire in a tiny cage with four or five cage-mates, in a gigantic shed with 100 thousand hens, until she is sent to slaughter. Cages are arranged in long rows piled as many as eight high. Excrement from hens on top drops onto hens below. Over time her feathers become broken and filthy. Sometimes a cage-mate dies, and she is forced to live with a 71 Lisa Kemmerer DEP n. 23 / 2013 corpse. Her flesh rubs on the wire cage, causing open wounds. Her lungs are damaged by ammonia that accumulates in the long, crowded, increasingly filthy shed. The cage is designed to rob the young hen of her precious eggs, which roll away from her warm body and into a trough, and are transported for processing. For about a year the hen continues to lay eggs that roll away as soon as they are laid, frustrating every natural instinct. When her egg cycle begins to wane, the food in front of her cage runs dry. For one to three weeks the hen starves in her cage, alongside her cage-mates, in what chicken farmers call “forced molt”. The hens that survive live among and on top of dead and dying cage-mates. Those who survive are shocked into another egg-laying cycle as soon as their food is restored. Again the hen lays eggs daily which are taken from her. She is never allowed to nurture young, create relationships with her offspring, or share their companionship in a larger, natural community of hens and roosters. Eventually her egg cycle wanes once more, and though she would naturally begin another cycle, given time, the industry does not wish to feed her when she is not laying. Especially given that her body can be sold. She is roughly pulled from her cage by a wing or a foot, by her head or tail, often breaking bones and dislocating joints, and is either ground up and sold as fertilizer, buried (perhaps alive), or trucked whatever distance is required to reach a slaughterhouse. If sent to slaughter, she will again be seized, this time to be hung upside down, legs secured in shackles. In this way she travels along the kill floor until someone slits her throat – or not, in which case she reaches the scalding tank alive, and is boiled to death. A hen in the egg industry suffers all of this misery simply because she is born with female reproductive organs into a society – our society – where “A” individuals feel entitled to manipulate and exploit her body and her female reproductive system for their own purposes. As sexist men sometimes feel entitled to control and exploit women and girls, speciesist humans feel entitled to control and exploit farmed animals, invading vaginas and filling wombs, claiming (and exploiting) offspring, depriving individuals of their freedom, and ultimately taking their lives. Shared Oppression, Shared Liberation Ecofeminists recognized and understood shared causes of oppression, such as dualism and hierarch, leading to overarching systems of oppression. Ecofeminists came to see that women, nature, and nonhuman animals are similarly devalued in relation to those in the “A” category, similarly controlled by those in the “A” category, and similarly exploited by and on behalf of those in the “A” category. Ecofeminists first noticed that female animals - whether women or cows or hens were similarly devalued in relation to their oppressors, were often associated with one another as “Not A” individuals, and were similarly exploited by those in the “A” category, particularly in relation to their female bodies and reproductive anatomy. In unearthing these parallels, ecofeminists came to see that it is inappropriate to seek to liberate only one oppressed group without concern for the many others who 72 Lisa Kemmerer DEP n. 23 / 2013 are relegated to the “Not A” category, and who are thereby systematically oppressed and exploited by “A” category individuals. For ecofeminists who recognize linked oppressions, extricating just one oppressed group is a narrow and selfish response. In light of the systems of oppression exposed by ecofeminists, the task at hand was clearly one of uprooting common causes and dismantling these deep-rooted, pervasive systems of oppression. In addition to feminism – in solidarity against the control and exploitation of females - there are at least five other compelling reasons to reject animal products: 1. To protect the environment. 2. To protect your health – heart disease, cancer, strokes, and obesity are linked with consumption of animal products. 3. On behalf of animals – refuse to take part in the suffering and premature death of farmed, hunted, or fished animals. 4. On behalf of human rights – refuse to augment world hunger (70% of U.S. grains and 60% of E.U. grains are fed to farmed animals while people starve). 5. Religious commitment – no religion encourages choices that contribute to any of the above. Summary Women, nature, and nonhuman animals are similarly devalued, controlled, and exploited in the Western world, where it has long been assumed right and proper that women serve men as nurses, waitresses, and wives, that humans exploit, control, and manipulate the natural world, and that humans similarly control and exploit nonhuman animals. Most noticeably, women and farmed animals are manipulated and exploited because of their female biology in the sex industries (and often through marriage) as in animal agriculture. Insightful ecofeminists simultaneously recognized that any attempt to liberate only those who look like ourselves – who are our species, for example – is not only selfish and narrow, but cannot succeed: women will not and cannot be freed from oppression and exploitation until overarching systems of oppression and exploitation are dismantled, systems that undergird all forms of oppression, including but not limited to sexism, anthropocentrism, and speciesism. Consequently, many ecofeminists adopted a vegan diet, refusing to support the egg, dairy, and flesh industries, and joined environmentalists and animal advocates, intent on helping to end oppression and exploitation in all of its insidious forms. 73 Uno sguardo ecofemminista alla tauromachia di Alicia H. Puleo! Abstract: The paper offers some critical arguments on the bloody tradition of the bullfight, a concentration of androcentrism and anthropocentrism. The women that wanted to undertake the taurine career have always found many obstacles, and some feminists use the concept of “equal opportunies” to tear the wall that divide women from the taromachy. The bullfighting exalts the machos values and ambiguously considers the animals, the bull, but also the horses and the calves used during the exercises such as instruments of exercise of the power. Cosa hanno da dire il femminismo e l’ecofemminismo sulla tauromachia, questo particolare spettacolo originario della Spagna e dichiarato nel 2011 “bene culturale immateriale di Francia”? Nella penisola iberica, nella Francia meridionale e nei paesi ispanoamericani che non hanno ancora proibito le corride1, i movimenti femministi e animalisti sono universi che si ignorano reciprocamente. Credo, tuttavia, che uno sguardo (eco)femminista possa portare contributi interessanti al dibattito sulla conservazione o l’abolizione della corrida. Il dibattito sulla tauromachia non è nuovo. Nel XVIII secolo, l’Illuminismo criticò la violenza gratuita contro gli animali non umani. In generale, ne giustificava però l’uso a fini scientifici e alimentari. In questi casi si raccomandava di infliggere la minore sofferenza possibile. Furono criticate la tortura e la morte per divertimento. Erano considerate non solo un errore etico, ma anche usanze totalmente contrarie alle virtù necessarie per una cittadinanza libera e responsabile. Nel XIX secolo, in paesi come il Cile, l’Uruguay e l’Argentina, i legislatori di orientamento illuminista, proibirono le corride, considerandole un atto di crudeltà e ! Alicia H. Puleo è docente di Etica e Filosofia politica presso l’Università di Valladolid (Spagna), dove ha diretto per oltre dieci anni il Centro per gli Studi di Genere. Ha pubblicato numerosi libri e articoli sulla filosofia femminista e l’ecofemminismo. Il suo ultimo libro è Ecofeminismo para otro mundo posible (Ediciones Cátedra, Madrid, 2011). La traduzione del presente saggio è di Annalisa Zabonati 1 Nei paesi latinoamericani che ancora consentono le corride, si stanno valutando iniziative abolizioniste. L’Ecuador le ha proibite nel 2011. Alcune amministrazioni comunali hanno proibito le corride nelle loro giurisdizioni in Messico, Venezuela e Perù, paesi in cui sono ancora legali. © DEP ISSN 1824 - 4483 Alicia Puleo DEP n. 23 /2013 di barbarie, che svilivano gli spettatori. Per tale ragione, alcuni critici spagnoli della tauromachia si lamentano e rimpiangono, che dopo la morte di Franco, la “Transizione” verso la democrazia, non sia stata in grado di sradicare le corride2. Negli ultimi anni, l’attivismo animalista si è sviluppato e ha raggiunto un’intensità senza precedenti. Però, come citato in precedenza, non ci sono ambiti di dialogo importanti con il femminismo. Partendo da questo, descriverò la tauromachia da una doppia prospettiva. Nella prima parte la esaminerò da un punto di vista di critica al sessismo, data la difficoltà che incontrano le donne nel mondo della tauromachia. Nella seconda parte, invece, ne indagherò l’androcentrismo e l’ottica patriarcale. La discriminazione sessista nel mondo taurino Nelle reti sociali, in cui si rivelano le tendenze d’opinione, ho osservato manifestazioni di forte misoginia da parte dei difensori degli animali contro le donne che non esprimono compassione per gli animali. Ho anche assistito a conversazioni informali tra ragazze con simpatie femministe, che rifiutano le corride perché feriscono i loro sentimenti verso gli animali, però non approfondiscono l’argomento né collegano questi sentimenti con la loro posizione femminista. Sono poche le femministe in Spagna sostenitrici della tauromachia, ma sono poche anche coloro che credono che questo sia un tema che meriti attenzione. Le opinioni critiche cui mi riferisco si sono inibite quando si è posta la questione del sessismo patito dalle torere. Immediatamente si sono serrate le fila contro la discriminazione. A fronte di questa tendenza, si deve tuttavia segnalare la nascita nel 2012 di una Rete Ecofemminista che si schiera a difesa degli animali. In alcuni siti internet, i sostenitori della corrida criticano il “machismo” tradizionale del mondo taurino e lodano i meriti dell’unica donna della corrida, divenuta una figura di spicco. È indubbio che, agli occhi della società, l’accettazione e l’integrazione delle donne darebbero un tocco di modernità alla sanguinosa tradizione della tauromachia3, che attualmente è in piena decadenza a causa della perdita di spettatori. Un sondaggio dal titolo Interessi per la corrida in Spagna, svolta nel 2008 a cura di IG-Investiga, ha dimostrato che il 67,2% della popolazione non mostra nessun interesse per gli spettacoli taurini4. Particolarmente interessante risulta, per la nostra disamina, la differenza per sesso e per età: il disinteresse arriva al 73% tra le donne, e nei giovani tra i 15 e i 24 anni arriva all’85,7%. È importante notare che in un’inchiesta del 1971, chi affermava di non interessarsi “per niente” alla tauromachia era il 43%. La cosiddetta “festa 2 Antonio Elorza, Pan y Toros, “El País”, 8/5/2010. Riprodotto in Sin Permiso. Per una rassegna della storia della tauromachia in Spagna e delle polemiche tra difensori e detrattori che l’accompagnano, vedere Jesús Mosterín, “La tortura como espectáculo”, in Marta Tafalla (ed.), Los derechos de los animales, Idea Books, Barcelona 2004, pp. 239-248; Carmen Méndez, Tauromaquia, el mal cultural, Carmen Méndez editora, Madrid 2012; Alfonso Lafora, El trato a los animales en España, ed. Oberón, Madrid 2004, cap. 6. 4 In “Público”, 18 dicembre 2009. 3 75 Alicia Puleo DEP n. 23 /2013 nazionale” conserva i suoi fasti solo grazie alle cospicue sovvenzioni pubbliche che tutti noi contribuenti elargiamo con le nostre tasse. Per sessismo intendo l’ideologia che considera un sesso inferiore all’altro e che porta alla discriminazione, tendendo ad escludere le donne da attività considerate nobili, in ragione della loro incapacità, della loro particolare fragilità, per motivi di decoro, etc.. Nel caso di cui ci occupiamo, c’è stato, e continua ad esserci, sessismo, dato che tradizionalmente è stato impedito con vari mezzi la possibilità di esercitare il mestiere di “matador” alle donne che lo desideravano. Non sembrava un mestiere adeguato per coloro che danno la Vita. La “Donna” era considerata priva di coraggio e forza, sufficienti per essere un guerriero, che combatte questa battaglia particolare contro le forze della Natura. Ne Il secondo sesso, testo classico del femminismo, Simone de Beauvoir ha sviluppato l’idea che la cultura patriarcale condanna le donne all’immanenza ciclica dell’ordine naturale e riserva al maschio la storicità e l’accesso all’essere quale dimensione progettuale specifica dell’umano. Per la filosofia esistenzialista, questa esclusione è intimamente collegata all’assenza della donna dall’attività guerriera. Rielaborando la dialettica servo-padrone di Hegel, de Beauvoir sostiene che rischiare la vita nel combattimento significa disdegnare la difesa del proprio corpo e affermare così il primato dei valori dello spirito. Il valore del guerriero permette perciò che l’umanità sia separata dalla mera animalità, che invece aspira a conservare la Vita. Da questa prospettiva, uccidere in un combattimento eroico è l’attività da cui si sviluppano i valori della Cultura, al posto di quelli della Natura. Quest’ultima appare come l’ambito della monotona attenzione per la vita, in cui è rimasto rinchiuso il femminile collettivo. Per emarginare le donne dalla corrida sono state utilizzate le due figure dell’Eterno Femminino: la madre e la prostituta. Per realizzare questo, è stato ampiamente utilizzato il meccanismo dell’erotizzazione come inferiorizzazione. Nel XIX secolo, la figura delle “señoritas toreras” implicava connotazioni sessuali licenziose. Per evitare gli scandali, nel 1910 fu proclamato un Editto Reale che proibiva la corrida alle donne. Alcuni storici della tauromachia sostengono che un’antica torera avesse continuato la sua attività in arene minori con nome maschile. Il catto-nazionalismo, vigente durante il regime di Franco, presentava un’ideologia di genere estremamente bipolare, in cui non entravano le torere, le donne che uccidevano invece di dare la vita. Questo sarà espresso nel Regolamento degli Spettacoli Taurini, che proibirà esplicitamente che le donne, ammesse come torere a cavallo, affrontassero il toro a piedi5. Il ruolo delle donne nel mondo dei tori si limitava a quello di spettatrice, che ammira e incoraggia il valoroso cavaliere. Questi le offriva, e continua ad offrire, la morte del toro. Benché nel 1974 sia stato abrogato l’articolo 49 che affermava questa proibizione, le donne cercarono senza successo di aprirsi il cammino verso le corride. Gli spettacoli in cui partecipavano erano considerati di scarso profilo, ridicole imitazioni della vera corrida virile. Il pubblico vi assisteva con animo ilare, come fossero corride 5 Luis Gilpérez Fraile, La vergüenza nacional. La cara oculta del negocio taurino, Penthalon, Madrid 1991. 76 Alicia Puleo DEP n. 23 /2013 burlesche (charlotadas) con toreri nani, che continuano tutt’oggi a essere presenti nei programmi delle feste e delle sagre di città e paesi, in incredibile continuità con la figura del nano di corte. I commentatori taurini erano implacabili con le torere: non erano capaci di realizzare l’autentica arte della corrida. Tuttavia il paradigma delle pari opportunità dei sessi ha impregnato anche gli ambiti più patriarcali. Nel 1996 nelle arene di Nîmes, in Francia, la matadora Cristina Sánchez (nata a Villaverde, provincia di Madrid, nel 1972) divenne la prima donna in Europa a ricevere l’investitura, atto in cui un torero di fama ne riconosce uno più giovane, permettendogli da quel momento di condividere il cartellone con altri toreri già noti. Il fatto fu ampiamente testimoniato dai media. Tutto ciò a consacrazione di una carriera ostacolata sin dall’infanzia, che andava contro la volontà del padre, insegnante in una scuola taurina di Madrid, della madre e del mondo taurino6. Nonostante ciò, molti toreri rifiutarono di “compartir cartel7” con lei. In un’intervista del 1999, per la rivista Mujer de hoy, lei assicura che di tutti i commenti sessisti che ha sentito dagli spalti, il più sgradevole è stato: “Le donne vadano a pulire”. E aggiunge: “Ho dimostrato che serviamo anche per altro oltre che a pulire”8. Femminismo taurino? No. Solo pari opportunità. Semplicemente, è concedere alle donne lo sviluppo di certe attività che non colpiscono in assoluto, a suo dire, il rapporto tra i sessi. “Mi piace che l’uomo mi protegga, mi difenda, mi vizi, mi prenda il cappotto, scosti la sedia e mi aiuti a sedermi”. Quando la giornalista che la intervistava osserva che si tratta di un discorso “molto poco progressista per una donna torero”, lei risponde: “Io non sono femminista né progressista, sono una donna molto normale. Mi piacerebbe che non si perdessero queste differenze tra uomo e donna”9. Per la famosa matadora, l’integrazione passa attraverso il superamento dei pregiudizi dell’inferiorità delle donne: “Le donne hanno tanto coraggio quanto gli uomini, accade però che il coraggio sia sempre attribuito all’uomo”. E, senza saperlo, riprende l’aspirazione di molte femministe, di cui non ha mai letto nulla e con cui non vuole essere confusa: non essere ridotta al genere, smettere di essere vista come l’Altra. Alla domanda su quali commenti avesse preferito, risponde: “A Siviglia una volta un signore mi disse: sono venuto per vedere una donna e ho visto un torero. Ne sono rimasto colpito”10. Di fatto, inizialmente questa matadora non gradiva essere chiamata “torera”, ma “torero”. Alla fine accettò il sostantivo femminile per la difficoltà di impedirne l’uso generalizzato nei mezzi di comunicazione. La smentita della sua alterità è conseguita grazie al superamento della paura di perdere la vita. Nel discorso taurino, la paura sembra inscritta nell’ambito della Natura. La paura “si annusa, si conferma, è l’arena e lo sporco, e l’odore che ti 6 Cristina Sánchez y Dulce Chacón, Matadora. La increíble historia de la primera mujer matadora de toros de España, Planeta, Barcelona 1998. 7 Compartir cartel è un’espressione del mondo taurino riferita alla partecipazione alle corride con altri toreri. Durante le corride i toreri sono vari e alcuni sono più famosi di altri. I tori utilizzati di solito sono sei. 8 Intervista alla torera Cristina Sánchez, “Mujer de hoy”, 1999. 9 Ibidem. 10 Ibidem. 77 Alicia Puleo DEP n. 23 /2013 trasmette il toro quando passa. Quando lo senti, anche se impercettibile, ti dà la sensazione di paura, di rispetto. Mi piace il rischio, provare paura e superarla. Mi piace sentirmi al limite tra la vita e la morte, senza arrivare ad essere consapevole che la morte possa essere lì. Sai di poter morire, però non ci pensi”11. E alcuni commentatori taurini concordarono nel far risaltare il suo coraggio, che faceva dimenticare che si trattava di una donna. Era un autentico torero. Benché il riconoscimento dell'uguaglianza rappresenti una facilitazione, non assicura un percorso per coloro che oggi sono nelle scuole taurine12, tuttavia la strada è stata aperta. Cristina Sánchez abbandonò la corrida nel 1999 perché i suoi colleghi si rifiutavano di “compartir cartel” con lei. Possiamo parlare di esercizio di sorellanza quando Cristina Sánchez ha conferito il titolo di “matador de toros” (sic) a Mari Paz Vega, di Malaga, grazie al toro Carpintero – protagonista involontario della cerimonia – il 29 settembre 1997, a Cáceres? Fu il primo conferimento concesso ad una donna in una plaza spagnola. La sua madrina, infatti, lo ottenne solo in Francia. All’inizio del luglio del 2005, dopo una brillante carriera in alcuni paesi latinoamericani che non hanno ancora abolito la tauromachia, l’iniziata confermò il suo conferimento ne la Plaza de las Ventas. Il fratello della nuova torera afferma che Mari Paz ha dovuto lottare contro molti ostacoli per arrivare a essere un torero: “Un po’ più degli altri, per il fatto di essere donna, senza dubbio”13. Questa figlia di un mandriano di torelli ha manifestato la sua vocazione a 9 anni, e a 14 aveva già ucciso il suo primo torello. Se il cacciatore contemporaneo, secondo le ricerche ecofemministe, uccide un animale per ritualizzare la separazione dalla madre e dal femminile, possiamo supporre che la torera uccida per identificarsi con il padre e accedere al mondo maschile. In alcuni siti web di allevatori di bestiame per corrida, si è paventato che le donne sono state incoraggiate a divenire soggetti e non più semplici testimoni della tauromachia. È stata criticata la reticenza degli esperti taurini nei confronti delle torere ed è stato reclamato un mondo dei tori aperto a “tutti e tutte”, in cui le donne partecipino attivamente allo spettacolo, svolgendone tutti i ruoli (matador, mandriano, aiutante, ecc.), ammettendo l’uguaglianza tra i sessi, come negli altri ambiti della società contemporanea. Questo, si chiarisce, non sarebbe “femminismo taurino”, ma “pari opportunità”. Ringraziamo per questa precisazione. Tuttavia, si stanno utilizzando concetti più chiari per l’uguaglianza di genere al fine di difendere l’integrazione delle donne nel mondo della tauromachia. Così nel 2007, nel ciclo di conferenze Mujer y Tauromaquia (Donne e Tauromachia), tenutosi a Siviglia, è stato affermato che era necessario superare il “veto maschilista” e andare “oltre il genere”. L’incontro includeva tavole rotonde dai titoli suggestivi, come “Dalla mantiglia14 allo stocco15”, che fa esplicito riferimento al desiderio di non limitarsi a far parte del pubblico, rivendicando un proprio posto nell’arena. E 11 Ibidem. Carmen Sánchez y Dulce Chacón, op.cit. 13 Commento raccolto nell’articolo di Antonio Lorca Mari Paz cumplió su sueño, in “El País”, 4 luglio 2005. 14 Scialle tradizionale indossato dalle donne spagnole (NdT). 15 Spadino utilizzato nelle corride (NdT). 12 78 Alicia Puleo DEP n. 23 /2013 Anabel Moreno, prima donna presidente della Reale Maestranza di Siviglia16, ha affermato: “Noi donne siamo il 50% della popolazione e vogliamo essere più numerose nel partecipare alla nostra festa nazionale”17. Dopo questa rapida scorsa dello stato dell’arte della questione, dalla prospettiva della discriminazione sessista, possiamo ora considerare la tauromachia dal punto di vista della critica all’androcentrismo. Per una cultura non androcentrica L’androcentrismo è il punto di vista maschile parziale che ritiene il maschio e la sua esperienza la misura di tutte le cose. Celia Amorós indica l’androcentrismo come la “fase dell’olfatto” […] momento in cui ci chiediamo “che odore ha talvolta quello che pare essere semplicemente l’universale?”18. Per questa filosofa: “scoprire il sottinteso del genere universale è possibile solo quando si è potuto verificare quell’orizzonte”19. Per questo, osserva, tale fase si sviluppa quando il ciclo avanza fino alla rivendicazione dell’uguaglianza. In generale, sessismo e androcentrismo sono inestricabilmente uniti. Se il sessismo interiorizza e tende a discriminare o escludere le donne, l’androcentrismo fissa degli standard di ciò che è umano, a partire da un’identità maschile definita storicamente all’interno dei limiti del sistema di genere. Ordunque, ci si deve chiedere: “La corrida ha una declinazione maschile?” Troveremo molte risposte affermative. Abbiamo già visto che per alcuni dei suoi sostenitori, la corrida rappresenta la virilità. Così pure per i suoi detrattori: “Nel cuore della tauromachia, c’è un culto della morte del debole, nello schernire in pubblico […]. È un rituale che esalta alcune caratteristiche di virilità, di maschilità”20. Per contro, Simone de Beauvoir, che dedica diverse pagine del suo La force des choses a commentare con entusiasmo (come Hemingway, George Bataille e altri intellettuali stranieri) le corride a cui assistette durante i suoi viaggi nella Spagna franchista, ne vide solo l’essenza umana universale. E nonostante affermi che la annoino le interpretazioni intellettuali, sia di condanna che di apologia della corrida, non cessa di darne una sua propria. Secondo la sua opinione, il senso originale e la grandezza della corrida risiedono nel fatto che un animale intelligente ne vinca un altro, più forte ma privo della ragione. Non commenta l’assenza delle donne nella tauromachia di quel tempo, ma potrebbero essere sue le dichiarazioni fatte dalla matadora Cristina Sánchez, verso la fine del XX secolo: “La corrida è cervello e flessibilità, perché la forza è dalla parte del toro. Però la gente equivoca su questo. Si pensa che la corrida sia una forza brutale, esagerata, che la donna non possiede. Ed è vero che 16 La più antica “Plaza de toros” della Spagna, in cui si celebra la Feria de Abril, uno dei più noti festival di corride al mondo (NdT). 17 Intervista di Isabel García, “La mujer pide paso en el ruedo”, 11 ottobre 2007. http://www.amecopress.net/spip.php?article501 (consultato il 19 aprile 2013). 18 Cèlia Amorós, La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias... para las luchas de las mujeres, ed.cit., p. 44. 19 Ibidem. 20 Luis Saavedra, “El País”, 8 agosto 1990. 79 Alicia Puleo DEP n. 23 /2013 non ce l’ha, ma non le serve. Per toreare con il toro serve il cervello”21. Davanti ad un toro indomito, la maggior forza fisica di un uomo non è un vantaggio, nemmeno nel momento di ucciderlo, quello di cui c’è bisogno è disciplina, tecnica e autocontrollo: “Per uccidere si deve avere capacità decisionale e preparazione, se non si tocca un osso, la carne del toro è tenera”22. La corrida appare quindi come la rappresentazione dei dualismi Natura/Cultura, Mente/Corpo, Ragione/Emozione. Per godere della corrida, come torero o torera, è necessario controllare la paura; come spettatore o spettatrice si deve scollegarsi dalla compassione, processo facilitato in questo caso dal timore e dal disprezzo dell’Altro. Temere per il proprio corpo e patire con chi soffre sono due sentimenti tradizionalmente considerati femminili e pertanto disprezzati. Due sentimenti poco adatti ai compiti del dominio. In tutte le società patriarcali, i riti di passaggio per diventare un maschio adulto, cercano di reprimerli. Il “soggetto iniziatico”23 maschile non esiste solo nelle società etnologiche. Nel caso in questione, tale soggetto si distanzia dal timore quando è nell’arena, e si gode lo spettacolo quando è sulle gradinate, e se è un intellettuale concettualizza tranquillamente il dolore e la morte come il giusto trionfo della ragione su un essere inferiore. Horkheimer e Adorno in Dialettica dell’Illuminismo, affermano che le creature irrazionali hanno sempre sperimentato la ragione sul proprio corpo, nelle arene, nei mattatoi e nei laboratori, sia in guerra che in pace. Potremmo precisare, sulla strada indicata da questi filosofi nel 1947, che queste creature hanno sperimentato la ragione patriarcale, una ragione misera, che ha espulso dalla definizione di umano superiore tutti coloro che non rientrano nella costituzione iniziatica maschile. La corrida, oltre ad essere un affare, è una messa in scena reale e simbolica di quella cornice concettuale oppressiva, che Karen Warren chiama la logica del dominio, una logica che concepisce la differenza in termini gerarchici di inferiorità e superiorità, legittimando la sottomissione e la violenza. Un insieme di credenze, valori e atteggiamenti socialmente costruiti, attraverso cui interpretiamo la realtà, la logica del dominio mantiene e rinforza i vincoli di subordinazione tra gli umani (sessismo, razzismo, classismo…) e tra gli umani e la Natura24. L’arroganza ontologica dell’antropocentrismo che nega tutta la considerazione morale verso i non-umani ha profonde relazioni con l’androcentrismo o l’ottica culturale maschile. La nostra visione del’“uomo” come dominatore della “Natura” ha un’oscura storia patriarcale, e limiteremmo molto le possibilità della teoria femminista se esigessimo solo di partecipare al circolo dei dominatori. Possiamo, e a mio avviso dobbiamo, tentare una trasformazione della nostra autoconsapevolezza come specie, una ridefinizione etico-politica dei concetti di “Natura” e di “essere umano”. Questa nuova rivoluzione copernicana non implica l’abbandono della ragione. Al contrario, significa svilupparne la forza critica oltre 21 Cristina Sánchez, “El Norte de Castilla”, 1 agosto1996. Cristina Sánchez, in “Mujer de hoy”, 1999. 23 Dal nome maschile, che risulta dai riti e dalle pratiche considerate, derivano gli uomini, che confermano così la separazione dalla dipendenza materna e dai suoi significati. Vedere Cèlia Amorós, Tiempo de feminismo, op.cit. 24 Karen Warren, Ecofeminist Philosophy, Rowman & Littlefield, Oxford 2000. 22 80 Alicia Puleo DEP n. 23 /2013 il nostro presente storico e oltre i pregiudizi, connettendola con i sentimenti, che sono stati femminilizzati e svalutati. Ma torniamo alla visione della corrida di Simone de Beauvoir. Ne abbiamo visto l’interpretazione razionalista, in cui l’intelletto sottomette la forza fisica. Però non è tutto, c’è un’altra interpretazione di carattere vitalista, che, in modo più semplice, è utilizzata di solito nelle apologie della tauromachia. De Beauvoir afferma che, come filosofa materialista, le pare interessante il combattimento tra l’uomo e il toro. Si tratterebbe di un’immersione nella natura e nel corpo, come avviene per la sessualità. Per questo, respinge la critica di sadismo affermata dai difensori degli animali, che lei considera “borghesi” scandalizzati per l’identificazione popolare con le pulsioni25. Appare affascinata, come altri pensatori considerati d’avanguardia come Georges Bataille, dalla violenza irrazionale quale manifestazione pura della vitalità del popolo. De Beauvoir individua nella Spagna dei tori e dei tamburelli, ciò che Michel Foucault vedrà, successivamente, nell’antico circo romano: il senso dello spettacolo, l’intensità della vita pubblica, la prossimità sessuale nelle feste, i riti sanguinosi che restituiscono vigore e unità sociale26. Come indicato più sopra, Bataille, un altro appassionato di corrida, nel commentare l’opera di Nietzsche oppone il “vertice morale” (sommet moral) alla “decadenza” (déclin)27. Il “vertice morale” si caratterizza per il dispendio smodato di energia e per la violazione dell’integrità degli esseri, per un’esuberanza che non rispetta i limiti proclamati dalla morale ordinaria. Dall’altro lato, la decadenza emergerebbe dalla preoccupazione per la conservazione e l’accrescimento dell’essere. È il momento in cui si obbedisce alle norme morali, quando si perde la potenza giovanile. Per Bataille, la vita, quale valore supremo, può essere solo al posto del male. La vita non è altro che comunicazione, fluire di energia. Viviamo solamente se possiamo entrare nel gioco che pone il nostro essere e quello degli altri in situazioni di rischio. A suo parere, non si capisce il “vertice morale” quando si sopporta stoicamente il male, ma quando lo si desidera, quando si accetta che il destino esiga che alcuni muoiano perché altri vivano. L’asceta e il borghese si trovano, così, agli antipodi di questa morale di sacralizzazione dell’istante. Non sono in grado di godere di tutto questo perché si sforzano di reprimere le pulsioni per raggiungere le loro rispettive mete future. Non riescono a sperimentare la sensazione di superiorità che produce la trasgressione. Da questa prospettiva filosofica, i sentimenti positivi verso l’Altro e l’impegno di attenzione per la propria vita, appaiono come decadenti e frutti effeminati della repressione e della domesticazione. Solo la violenza e il dominio sono esperienze ontologiche originarie e autentiche? Non si tratta di una definizione dell’umano realizzata esclusivamente a partire dal pathos del guerriero e dalla sua mistica patriarcale dello scontro e dell’aggressività? Perché l’esperienza della superiorità sarebbe migliore del mutuo aiuto o della cura? Dato che le democrazie borghesi impediscono l’esperienza della superiorità esigendo il reciproco rispetto dei diritti 25 Simone de Beauvoir, La force des choses, tome II, Gallimard, Folio, Paris 1963, p. 74. Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, Paris 1975. 27 Georges Bataille, Sur Nietzsche. Oeuvres Completes. tome VI, Gallimard, Paris 1973. 26 81 Alicia Puleo DEP n. 23 /2013 individuali, Bataille vede nell’erotismo e nella corrida due modi per soddisfare la “sete di infinito” che caratterizza l’uomo. Entrambi i fenomeni sono dei sacrifici rituali che rivelano la continuità di esseri apparentemente discontinui. La donna e l’animale sono sacrificati, i loro limiti sono negati. La donna in modo simbolico, e l’animale nella realtà. Entrambi rappresentano la natura materiale che abbiamo abbandonato con la Cultura. Quali soggetti trascendenti “ci disturba uscire dalla vita, dalla carne, da un’immondizia sanguinolenta28”. Le viscere sarebbero il vero oggetto del desiderio. Per questo, secondo Bataile, l’erotismo è sempre sadico e un rito sadico come la corrida sarebbe erotica. De Beauvoir invece non ha individuato nella corrida connotazioni erotiche, siccome sarebbero state contraddittorie per la sua teoria femminista. Tuttavia, queste affinità sono puntualizzate da molti appassionati di tauromachia. Normalmente, il torero è concepito come il paradigma della virilità, il che spiegherebbe lo scandalo, in un mondo così tradizionalista, suscitato quando trapelò l’orientamento omosessuale di qualche torero29. Ci sono però intellettuali che danno altre interpretazioni. Nella letteratura specializzata, alcuni autori vedono nel torero la rappresentazione della femminilità, fragile e seduttiva, che attrae il poderoso maschio e finisce col dominarlo. Altri ancora ne tracciano una figura intersessuale. Con il personaggio della torera nel film misogino Parla con lei (che ebbe più successo in Francia che in Spagna e per le cui prove si uccisero quattro tori30) Almodóvar gioca esteticamente con queste connotazioni sessuali, dando alle corride un alibi postmoderno di pseudo-progressismo. Il fascino generato dal torero ha forti componenti sadomasochiste. Ricordiamo, ad esempio, quando nel 1994, ad Aranjuez, un giovane torero in cerca di fama, organizzò una corrida “solo per donne”. Ottomilacinquecento spettatrici di varie età e classi sociali, arrivate da varie parti, provocarono uno scandalo mediatico per le oscenità che gridarono mentre lanciavano al torero fiori, reggiseni, mutande, orsacchiotti di peluche, incoraggiandolo ad infilzare il toro che stava agonizzando al suolo. Gli appassionati tradizionalisti? si indignarono per la “discriminazione positiva” che non aveva permesso l’accesso agli uomini sulle gradinate e per la mancanza di decoro di quelle donne che gridavano il proprio appetito sessuale davanti alle telecamere. Qualche giornalista donna le difese in nome dell’uguaglianza: Perché le donne non possono divertirsi dicendo delle oscenità a un uomo, come hanno sempre fatto gli uomini con le donne?31 Di fronte al suo idolo, incarnazione della maschilità massimamente patriarcale, superba e insensibile, rivendicavano la loro libertà o le loro catene? Il gruppo delle donne dei Verdi condannò l’evento, perché rinforzava gli stereotipi di sesso. Possiamo chiederci se fomentare una cultura della violenza e del dominio favorisca le donne, 28 Georges Bataille, Histoire de l’érotisme, Oeuvres Complètes, tome VIII, ed.cit., p. 52. Luis Gilpérez Fraile, op.cit. 30 Sul rifiuto che provocò questo fatto, vedi Pilar Rahola, “A Pedro Almodóvar sobre la crueldad. La defensa de los animales es sencillamente una lucha a favor de la ética”, en Marta Tafalla (ed.), Los derechos de los animales, op.cit., pp. 249-250. 31 Rosa Villacastín, La gesta de Jesulín, “El Semanal”, 23 ottobre 1994. p. 104. 29 82 Alicia Puleo DEP n. 23 /2013 quando i numeri delle vittime della violenza di genere rivelati dai giornali e dagli studi specialistici sono così elevati. Sicuramente la risposta è negativa. L’integrazione delle donne in un’attività barbara, fortemente criticata è una strategia per conferirle prestigio e legittimità. Le torere e le spettatrici sembrano una confutazione vivente dell’empatia femminile indicata dal primo ecofemminismo. Non si commuovono davanti al sangue e alle urla di dolore del toro, al contrario godono della violenza. Come ogni neofita, alcune donne saranno militanti entusiaste. Bloccando la tendenza alla compassione che in termini statistici solitamente caratterizza l’atteggiamento delle donne, credono di elevarsi nei ranghi del genere e si sentono gratificate per l’identificazione con le figure maschili che ammirano. Atena nasce dalla coscia di Zeus e difende l’ordine patriarcale stabilito. Dobbiamo applaudire o disapprovare la consacrazione di una torera nel mondo iper-patriarcale della tauromachia? Dobbiamo appoggiare i nuovi “divertimenti” di un pubblico femminile affascinato dal potere e dalla violenza? Le corride e le altre torture pubbliche di animali, sono il luogo simbolico – e, disgraziatamente, molto reale nel dolore e nel sangue – in cui si incrociano l’antropocentrismo e l’androcentrismo. È più colpevole la torera del torero, la spettatrice dello spettatore? Tutti sono invischiati nella mistica della virilità, o della definizione storica del maschile e dell’umano come dominio sulla “Natura”. La sofferenza dell’animale nell’arena è uguale. L’etica e la filosofia politica femministe devono rivendicare l’uguaglianza tra i sessi, ma procedere al contempo a una critica all’androcentrismo. Entrambi gli ambiti, se intesi come progetti escludentesi, racchiudono gravi pericoli. Così come le etiche della cura possono giungere al conformismo, all’impotenza e all’esaltazione delle virtù prodotte dalla sottomissione, l’assunzione acritica di una trasgressione pseudo liberatoria implica l’accettazione dei valori che nascondono il genere sottinteso. Non si tratta di desiderare che la tauromachia continui ad essere un mondo esclusivamente maschile, tanto meno di applaudire l’ammissione delle donne, ma di denunciare l’ottica patriarcale di questa subcultura sanguinaria, abietta logica del dominio che la legittima, per esigerne l’abolizione. Se vogliamo ampliare la concezione dell’umano con quegli aspetti che furono svalutati come femminili, se vogliamo avanzare verso una società in cui il soggetto autonomo non ha bisogno di dominare e umiliare per affermare la propria identità, né che la sua soddisfazione si basi sull’estrema sofferenza e morte dell’Altro, il femminismo ha molto da dire sulla corrida. Penso che, come femministe, non dobbiamo reclamare le virtù di genere per le donne, ma dobbiamo esaminare il genere delle virtù, per avanzare verso un altro mondo possibile. 83 Allevamento di animali domestici ed etica del care: armonia o conflitto? di Agnese Pignataro* Are animal husbandry and the ethics of care compatible or opposed? From the Nineties on, a number of American vegetarian feminists have proposed an alternative formulation of animal ethics inspired by Carol Gilligan’s ethics of care, rejecting the focus on reason and on abstract rules typical of traditional animal rights theories. However, this link between care and vegetarianism has been criticized by some French scholars on the basis of arguments supposedly inspired by the ethics of care itself: vegetarianism, they hold, is inconsistent with the care perspective because it represents an abstract and universalizing rule; the concept of animal liberation is in contradiction with this perspective because it implies severing the human-animal relation; and other similar arguments. Instead, according to these scholars, animal husbandry can be seen as a relation of care, on the condition that it be amended from its current industrial form: non intensive animal husbandry would display its “relational and emotional rationality”. I will discuss the consistency of this interpretation: is animal husbandry in its essence, independently of its capitalistic outcome, really compatible with that attitude of attention towards the “other” and of consideration for the point of vue of all individuals involved in a moral conflict, that Carol Gilligan theorized in the notion of care? Or instead, as suggested by Josephine Donovan, Carol Adams and the other vegetarian feminists, can we not, when we listen to the “different voice” of the animal, but recognize its desire to live, and henceforth reject meat and other animal products? What is the relationship between animal husbandry and care ethics? Are they compatible or opposed? Negli ultimi anni le teorie etico-politiche anglosassoni fondate sulla nozione di care, teorizzata da Carol Gilligan nel celebre libro In a Different Voice1, hanno suscitato nel mondo accademico francese un sempre maggiore interesse di cui * Agnese Pignataro è dottoranda in Filosofia Morale presso gli Archives Husserl (École Normale Supérieure di Parigi) sotto la direzione di Florence Burgat. Le sue ricerche intendono costruire una critica politica dell’allevamento di animali domestici attraverso il pensiero del care. Collabora con riviste italiane e francesi ed è fondatrice e direttrice scientifica della rivista on line Musi e Muse (www.musiemuse.org). 1 Carol Gilligan, In a Different Voice. Psychological Theory and Women’s Development, University Press, Harvard 1982/1993. tr. it. Con voce di donna. Etica e formazione della personalità, trad. di Adriana Bottini, Feltrinelli, Milano 1987. Le traduzioni da questo come da altri testi citati sono nostre. © DEP ISSN 1824 - 4483 Agnese Pignataro DEP n. 23 / 2013 testimonia la recente pubblicazione di diversi volumi collettivi ad esse consacrati2. Così come già avvenuto negli Stati Uniti, anche in Francia l’etica del care si sta intersecando con gli studi sulla questione animale, i cui sviluppi francesi sono significativi nelle loro articolazioni ontologiche e morali. Ma, contrariamente a quanto proposto da alcune femministe vegetariane statunitensi come Josephine Donovan e Carol Adams, secondo le quali sulla nozione di care è possibile fondare una teoria della liberazione animale alternativa a quella dei diritti animali, in Francia gli esiti sono per il momento diversi. È stato affermato dalla filosofa Catherine Larrère che una posizione etica ispirata al care non comporta un obbligo al vegetarianesimo, ma suggerisce piuttosto l’opportunità di preservare le pratiche di domesticazione a scopo utilitario in quanto luogo privilegiato della relazione umano-animale; Larrère, seguendo le analisi della studiosa dell’allevamento Jocelyne Porcher, propone di ripensare quest’ultimo secondo criteri non produttivisti e non intensivi per ritrovarne il potenziale relazionale e affettivo. Tenteremo di mettere alla prova questa tesi attraverso una esposizione dell’etica del care che ne chiarisca gli elementi fondamentali (dissipando fraintendimenti che la confondono con un’etica della “cura”3, o ancora che la interpretano come un’etica genderizzata al femminile) ed esaminando poi tanto le obiezioni mosse da Larrère nei confronti delle femministe vegetariane quanto la visione della domesticazione propria a Porcher e la sua compatibilità con un atteggiamento di care: questo confronto ci permetterà di avanzare una valutazione sia della validità delle critiche che della coerenza della proposta. 1. Carol Gilligan e la voce del care La nascita della ethic of care viene convenzionalmente fatta risalire alle prime pubblicazioni di Carol Gilligan, nelle quali veniva criticata la teoria dello sviluppo morale di Lawrence Kohlberg. Questi aveva identificato una serie di stadi progressivi nella crescita psicologica umana nel corso dei quali il ragionamento morale si evolve in senso sempre più universalizzante fino ad arrivare al riconoscimento dell’esistenza di norme etiche assolute. Tale scala poteva esprimere il grado di sviluppo morale degli individui sulla base delle loro risposte a dilemmi etici che venivano loro posti nel corso di interviste; ma nelle classifiche operate da Kohlberg, bambine e ragazze ottenevano risultati inferiori a quelli dei maschi perché meno propense a fornire risposte imparziali: le femmine venivano quindi ritenute moralmente meno mature. Gilligan, allieva di Kohlberg, mise in dubbio il presupposto secondo il quale l’orientamento etico preso a modello da Kohlberg (quello kantiano) fosse l’unico valido. Secondo Gilligan, il fatto che le femmine 2 Patricia Paperman-Sandra Laugier (dir.), Le souci des autres. Éthique et politique du care, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 2005; Pascale Molinier-Sandra LaugierPatricia Paperman (dir.) Qu’est-ce que le care? Souci des autres, sensibilité, responsabilité, Payot, Paris 2009; Vanessa Nurock (dir.), Carol Gilligan et l’éthique du care, PUF, Paris 2010. 3 La parola inglese care non è sovrapponibile all’uso attuale della parola “cura” in italiano: essa infatti intende non solo il “prendersi cura” ma anche l’“avere a cuore”. Scegliamo quindi di evitare una traduzione che necessiterebbe di una pesante perifrasi per risultare completa, e conserviamo il termine inglese (seguendo in questo l’uso stabilito nell’ambiente accademico francese). 85 Agnese Pignataro DEP n. 23 / 2013 siano riluttanti ad adottare regole astratte nei conflitti etici, ma prediligano risposte adattate alla trama delle relazioni tra gli individui coinvolti, non manifesta una loro debolezza morale ma un altro modo di designare e interpretare i dilemmi morali, una “voce diversa” La voce diversa che descrivo è caratterizzata non dal genere ma dal tema. La sua associazione con le donne è un’osservazione empirica ed è fondamentalmente attraverso le voci delle donne che traccio il suo sviluppo. Ma questa associazione non è assoluta, e i contrasti tra la voce maschile e quella femminile sono qui presentati per evidenziare una distinzione tra due modalità del pensiero e per focalizzare un problema di interpretazione, non per rappresentare una generalizzazione su ogni sesso. […] Non pretendo di spiegare le origini delle differenze descritte o la loro distribuzione in una popolazione più larga, in diverse culture o epoche. È chiaro che queste differenze sorgono in un contesto sociale nel quale fattori di status sociale e di potere si intersecano con la questione biologica della riproduzione per plasmare le esperienze di maschi e femmine e le relazioni tra i sessi4. Tale voce è contraddistinta dunque non dall’essere intrinsecamente femminile ma dal suo contenuto, dalla visione del mondo che veicola, improntata al care. Laddove le teorie che tendono all’identificazione di regole astratte e imparziali (le “etiche della giustizia”) vedono il soggetto come uno spazio psicologico che si delimita per separazione dagli altri, la voce del care esprime un Sé definito dall’essere in connessione con gli altri. Di qui due concezioni diverse della responsabilità: il soggetto “separato” intende la responsabilità come una non interferenza nello “spazio” individuale, mentre quello “connesso” la intende come un intervento benefico nelle vite dei soggetti5. Traducendo tali concezioni in termini morali, la responsabilità come non interferenza diviene il rispetto dei diritti, mentre quella intesa come intervento benefico corrisponde alla soddisfazione dei bisogni. Nel primo caso si avranno teorie morali basate su ragionamenti formali e astratti volti a determinare l’estensione e l’applicazione dei diritti, mentre nell’altro si preferiranno modalità di ragionamento più morbide, affidate a narrazioni contestuali nelle quali non sarà raro l’emergere di sentimenti personali6. Gilligan espone le modalità di apprensione e soluzione dei dilemmi morali basate sul care attraverso lo “studio sull’aborto”, condotto su 29 donne incinte. La decisione se proseguire o no una gravidanza investe più soggettività oltre quella della donna stessa: si tratta di un conflitto che ogni donna tenta di portare a soluzione in modo personale, esaminando la propria biografia e le proprie relazioni. La difficoltà risiede nel superare una visione del dilemma ispirata ai valori convenzionali della società patriarcale, che vogliono la donna completamente dèdita agli altri7. Si tratta per le donne di prendere atto del fatto che riconoscere i propri bisogni non è “egoista” ma “onesto e giusto”, e di trovare il giusto equilibrio tra la responsabilità nei confronti di se stesse e le responsabilità assunte nei confronti degli altri. È necessario insomma che la posizione morale del care inglobi un ritorno verso il Sé, per liberarsi dal potenziale autodistruttivo della sua interpretazione convenzionale. Le etiche della giustizia devono, dal canto loro, 4 Ivi, p. 2. Ivi, pp. 34-38. 6 Ivi, pp. 19-22 e 25-31. 7 Ivi, pp. 70-71. Cfr. anche p. 79. 5 86 Agnese Pignataro DEP n. 23 / 2013 accettare di dare spazio al coinvolgimento nei confronti dell’altro e all’attenzione al contesto: “lo sviluppo per entrambi i sessi sembrerebbe implicare un’integrazione di diritti e responsabilità attraverso la scoperta della complementarità di queste diverse visioni”8. Questa rapida esposizione della tesi di Carol Gilligan consente di riconoscere che l’etica del care non è un’etica femminile ma un atteggiamento accessibile a tutti9; non è neanche un’incitazione all’abnegazione in nome della cura degli altri, ma un appello alla considerazione dei bisogni di tutte le persone coinvolte nei dilemmi morali; infine, non è neanche una forma di etica che soppianterebbe ogni forma di giustizia e di universalità: i due paradigmi sono complementari. 2. Joan Tronto: l’ineguaglianza riconoscere l’interdipendenza per denunciare La tesi di Carol Gilligan provocò negli anni ’80 una vasta discussione tra specialisti di filosofia morale e di teoria politica, in particolar modo femminista; diverse autrici svilupparono gli spunti di Gilligan. Fra queste Joan Tronto, oggi professore di Scienze Politiche alla University of Minnesota, che interpreta la nozione di care come un vero e proprio concetto politico in vista di una trasformazione democratica della società10. Tronto dedica molte energie alla critica dell’idea di una morale specifica alle donne ed essenzialmente migliore (più altruista e cooperativa, meno portata alla violenza) di altre forme di morale associate agli uomini. Da un lato, nota Tronto, la voce diversa che Gilligan ha riscontrato nelle donne può essere ricondotta anche a modelli di comportamento di altre categorie sociali (classi popolari, gruppi etnici non europei11); dall’altro, l’ideale della donna “buona” è più o meno apertamente legato all’immagine della madre di famiglia bianca e borghese ed esclude quindi tutte le altre donne (di colore, immigrate, povere, lesbiche...)12. Secondo Tronto, quindi, è necessario abbandonare l’idea di un’etica femminile e procedere piuttosto a un ridisegnamento dei confini morali che permetta di includere come fondamentali nel campo della morale e della politica i valori tradizionalmente assegnati alla sfera femminile. 8 Ivi, p. 100. In compenso essa può essere considerata un’etica femminista per la sua critica della femminilità convenzionale e per la sua inscrizione nell’ideale di una democrazia pluralista che accordi lo stesso riconoscimento a tutte le “voci diverse” in essa presenti (cfr. Carol Gilligan, “Une voix différente. Un regard perspectif à partir du passé”, in Vanessa Nurock [dir.], Carol Gilligan et l’éthique du care, cit.). 10 Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care, Routledge, New York 1993-2009 (tr. it. di Nicola Riva. Diabasis, Confini morali. Un argomento politico per l’etica della cura, a cura di Alessandra Facchi, Reggio Emilia, 2006). 11 Ivi, pp. 82-84. Si veda anche Sandra Harding, The Curious Coincidence of Feminine and African Moralities: Challenges for Feminist Theory, in Eva Feder Kittay - Diana T. Meiers (eds..), Women and Moral Theory, Rowman and Littlefield, Lanham 1987. 12 Ivi, pp. 1-2 e 85. Si veda anche Joan Tronto, Beyond gender difference. To a theory of care, in “Signs”, 12, 4, 1987. 9 87 Agnese Pignataro DEP n. 23 / 2013 Tale ridisegnamento richiede per prima e fondamentale mossa un cambiamento della nostra nozione di individuo, a partire da una definizione del care come “una forma di attività che include tutto ciò che facciamo per mantenere, sostenere e riparare il nostro ‘mondo’ affinché possiamo vivere in esso nel migliore dei modi”13. Questo fa del care un elemento essenziale della vita di ogni essere umano e implica che “gli umani non sono interamente autonomi, ma devono sempre essere concepiti in una condizione di interdipendenza”14. Laddove la cultura liberale moderna costruisce il suo modello di umanità sulla base di concetti come la libertà e l’autonomia, e vede la dipendenza come un mero stato temporaneo proprio di categorie marginali (bambini, anziani, malati), Tronto ribadisce che la dipendenza, in forme e gradi diversi, è un aspetto costante della condizione umana. Tale visione della società come una trama in cui ognuno dà e riceve care porta a scalfire l’idea del care come esperienza di tipo diadico e privato: questo fraintendimento è dovuto alla consuetudine di prendere come modello del care la relazione madre-bambino idealizzata, e soprattutto intesa come unico paradigma possibile dell’educazione dei bambini, ignorando le numerose culture in cui questo non è affatto responsabilità esclusiva della madre15. L’interdipendenza degli esseri umani è dunque una realtà di fatto che si attua nella vita di ogni giorno. Questo però non implica in modo automatico che essa si realizzi in relazioni eque. Anzi, sostiene Tronto, è tutto il contrario: la struttura di elargizione e fruizione del care nelle società attuali rivela relazioni di potere sistematicamente asimmetriche. Difatti, i care givers (datori di care) provengono sempre dalle classi e dai gruppi più vulnerabili (sono in grande maggioranza donne, in particolar modo proletarie e immigrate), mentre beneficiano del loro lavoro individui appartenenti alle classi privilegiate (per lo più uomini di ogni classe, ma anche donne della media e alta borghesia). Emerge una contraddizione profonda: l’elargizione di care, pur essendo una pratica necessaria per preservare le vite umane, non è riconosciuta socialmente e si traduce in professioni sottovalutate e malpagate. “Si installa un circolo vizioso: il care viene sminuito e le persone che svolgono il lavoro di care vengono svilite”16. La denigrazione del care può essere ricondotta in particolare modo a due fattori. Il primo è l’associazione del care alla sfera corporea, essa stessa vista in modo negativo: il lavoro di care più disprezzato in assoluto è la pulizia dei locali destinati alle escrezioni fisiologiche. Il secondo è la visione del soggetto umano paradigmatico, quale ente autonomo. L’immagine dell’autosufficienza nell’esercizio del potere gioca profondamente, perché la relazione stessa di potere, per potersi conservare, impone di disconoscere in chi domina qualunque forma di dipendenza dai soggetti dominati. Ecco quindi emergere quella che Tronto chiama l’“irresponsabilità privilegiata” dei gruppi dominanti: la prerogativa di ignorare le pratiche di cura di cui si è oggetto e, di conseguenza, di evitare di chiedersi se i bisogni dei care-givers sono a loro volta soddisfatti. Ne consegue un’invisibilità 13 Ivi, p. 103. Ivi, p. 162. 15 Ivi, p. 103. Un paradigma sviluppato in particolare da Nel Noddings e criticato da numerose autrici. 16 Ivi, p. 114. 14 88 Agnese Pignataro DEP n. 23 / 2013 del care che permette di nascondere l’asimmetria della sua distribuzione17. Infine, il meccanismo di svalutazione del care ricorre a un’identificazione dei care-givers con i loro ruoli di cura, fondata sull’idea che questi siano i loro ruoli “naturali”18. Il pensiero di Joan Tronto non si limita alla critica, ma intende offrire la base teorica per un cambiamento, in senso sempre più democratico. Mettendo in evidenza la dimensione primaria delle attività di care e denunciando al tempo stesso l’asimmetria del loro concretizzarsi nelle società attuali, Tronto chiama a un’azione politica volta al bilanciamento tra care-givers e care-receivers, in cui si riconosca l’uguale diritto dei membri della società ad esprimere i propri bisogni e ad ottenerne il soddisfacimento. Ciò condurrebbe tra l’altro a una riduzione della dipendenza dei soggetti vulnerabili, difatti uno degli obiettivi del care è dar fine alla dipendenza e non farne uno stato permanente. [...] Solo se le pratiche di care si realizzano nel contesto di un ordine sociale democratico la dipendenza umana può essere riconosciuta come una necessità ma anche come una condizione da superare19. Il care in questa prospettiva non si limita ad affermare l’esistenza della differenza, ma esige una riflessione sull’ineguaglianza politica che spesso la differenza accompagna e occulta, e pone l’uguaglianza come fine da realizzare attraverso una continua negoziazione delle relazioni. 3. Quale care per l’etica animale? Le femministe vegetariane e la critica di Catherine Larrère A partire dagli anni Novanta, diverse autrici, i cui contributi sono riuniti in alcune antologie curate da Josephine Donovan e Carol Adams20, hanno riflettuto su un’elaborazione alternativa dell’etica animale che prendesse spunto dalla teoria del care: rifiutando il razionalismo e l’astrattezza di teorie come quella dei diritti animali di Tom Regan, o quella dell’antispecismo (l’uguale considerazione degli interessi degli individui indipendentemente dalla loro specie) di Peter Singer, esse hanno particolarmente riflettuto sul ruolo dell’empatia, della relazione, dell’attenzione all’altro e al contesto, come punto di partenza per un nuovo approccio alla questione del trattamento degli animali. Nell’introduzione a The Feminist Care Tradition in Animal Ethics, Donovan e Adams enumerano cinque punti problematici21 proprî alle teorie dei diritti animali22. Il primo risiede nel fare appello a correnti di pensiero (giusnaturalismo, utilitarismo) nate nell’età moderna e nel mutuarne una concezione dell’essere umano tipica di quell’epoca: quella di un agente razionale autonomo e 17 Ivi, pp. 120-122 e 174. Ivi, p. 174. 19 Ivi, p. 161. 20 Tra le quali, Beyond Animal Rights, Continuum, New York 1996, e la più recente e completa The Feminist Care Tradition in Animal Ethics, Columbia University Press, New York 2007. 18 21 The Feminist Care Tradition in Animal Ethics, cit., pp. 4-6. Si intendano per animal rights theories tutte le teorie della liberazione animale, e non solo quelle di tipo giusnaturalistico. 22 89 Agnese Pignataro DEP n. 23 / 2013 indipendente da proteggere dalle ingerenze altrui. Il secondo problema consiste nell’applicare questa concezione – che già, come abbiamo visto, è contestabile per gli esseri umani – agli animali non umani. Si tratta di un procedimento che assume la somiglianza tra umani e animali come base dell’etica animale cancellando le differenze e rischiando quindi di non cogliere con precisione il punto di vista e le preferenze degli animali in quanto tali. Il terzo punto è il presupposto dell’autonomia del soggetto, ancora più problematico nel caso degli animali, che di fatto sono largamente dipendenti dagli esseri umani (da alcune loro scelte nel caso degli animali selvatici e dall’elargizione vera e propria del sostentamento nel caso degli animali domestici). Il quarto problema deriva dal disconoscimento del ruolo delle nostre emozioni nei confronti degli animali. Il quinto elemento problematico delle teorie dei diritti animali è il loro carattere astratto e formalistico, che impedisce loro di apprezzare l’importanza delle situazioni contestuali e della biografia degli individui coinvolti. Un’esposizione dettagliata dei contenuti dell’antologia sarebbe impossibile, ma ci interessa sottolineare un passaggio nell’introduzione di Donovan e Adams che concerne il potenziale politico di un’etica animale basata sul care. Questo approccio non si limita ad evidenziare il valore del legame (personale, affettivo...) con il singolo animale; l’esame del contesto in cui tale legame si colloca porta infatti a svolgere una più ampia analisi dei sistemi politici ed economici che gestiscono, e spesso distruggono, le vite degli animali23. Non si tratta, allora, semplicemente di intervenire per alleviare la sofferenza in modo puntuale, ma di partire dall’esperienza personale, lasciandosi coinvolgere nell’incontro con soggetti non umani e nell’ascolto della loro voce, per sviluppare poi una critica radicale del dominio degli esseri umani sugli animali. Esempi di questa linea argomentativa sono il contributo di Lori Gruen, “Empathy and Vegetarian Commitments” e quello di Josephine Donovan, “Caring to Dialogue”24. Scrive Donovan: “se si prova simpatia nei confronti di un animale che soffre, si è portati a porre la domanda: perché questo animale sta soffrendo? La risposta può aprire un’analisi politica delle ragioni del disagio dell’animale”25. Il che porta le autrici e gli autori che si riconoscono nell’approccio del care non solo ad adottare individualmente un’alimentazione vegetariana26, ma più globalmente a schierarsi contro lo sfruttamento degli animali a scopo alimentare. È proprio quest’ultima conclusione a essere contestata da Catherine Larrère, specialista francese di filosofia morale e politica e studiosa delle etiche ambientali, 23 Ivi, p. 3. Donovan e Adams fanno esplicito riferimento a Joan Tronto. Si veda anche Dianne Romain, Feminist Reflections on Humans and Other Domesticated Animals, in “Between the Species”, 6, 4, 1990. 25 The Feminist Care Tradition in Animal Ethics, cit., p. 365. 26 Le autrici in questione usano spesso il termine “vegetarismo” come includente il veganismo, ovvero l’esclusione di latte e uova, prodotti ottenuti dallo sfruttamento del sistema riproduttivo delle femmine animali e per questo particolarmente problematici in una prospettiva femminista (cf. Deane Curtin, Toward an Ecological Ethic of Care, in The Feminist Care Tradition in Animal Ethics, cit., p. 99). 24 90 Agnese Pignataro DEP n. 23 / 2013 nel presentare le applicazioni dell’etica del care al di là della sfera umana27. In primo luogo, Larrère sostiene che la convergenza delle posizioni delle femministe vegetariane con quelle di Regan e Singer è contraria alla stessa nozione di care: tali autrici “si limitano a denunciare la sofferenza animale”, che concepiscono in modo uniforme, senza soffermarsi sulla diversità delle situazioni relazionali, culturali, specie-specifiche; si “irrigidiscono sul vegetarismo”, quindi nella teorizzazione di un obbligo morale formale; e trascurano “l’analisi dei rapporti affettivi e reciproci con gli animali” stessi28. Così facendo, secondo Larrère, esse contraddicono lo spirito dell’etica del care, adottando principi astratti e universali al modo delle etiche della giustizia alle quali il care si vuole alternativo: “il care, in queste condizioni, si riduce all’empatia per la sofferenza, e l’etica animale, così definita, è un’etica della denuncia alquanto astratta che, di fatto, non esplora le relazioni tra gli umani e gli animali”29. Per di più, continua Larrère, la visione di un care finalizzato alla liberazione animale contrasta con la preservazione della relazione, fondamento stesso del care: “la liberazione degli animali consisterebbe piuttosto a liberarci degli animali”30. La fine delle relazioni utilitarie con gli animali domestici porterebbe a una separazione radicale tra il loro mondo e il mondo umano che, così “de-animalizzato”, finirebbe mutilato dell’apporto emotivo e simbolico offerto dalla presenza di tali animali. Larrère, seguendo le intuizioni di Mary Midgley, intende invece preservare la presenza di altre specie nelle comunità umane, a patto di ripensare le nostre relazioni nei loro confronti riconoscendo e ritrovando in esse una dimensione di care. In questa ottica si prendono a modello le tesi di Jocelyne Porcher, una studiosa francese di “scienze animali” ed ex allevatrice che non si richiama alle teorie del care, ma secondo Larrère, se ne avvicina. Porcher sostiene la necessità di ripensare l’allevamento secondo criteri non produttivisti e non intensivi per ritrovarne la razionalità relazionale31 e affettiva32, occultata dalla sua forma industriale attuale; nella sua lettura, un allevamento correttamente praticato sarebbe produttore di senso sia per l’allevatore che per l’animale, permettendo di praticare l’incontro e la comunicazione con l’ “altro”, così come di raggiungere una comune realizzazione attraverso il lavoro. Tale visione dell’allevamento sembra dunque a Larrère più coerente con i principî dell’etica del care di quanto lo siano le posizioni delle femministe vegetariane statunitensi. Questa lettura è accettabile? La pratica d’allevamento è realmente conciliabile con quell’atteggiamento di attenzione per “l’altro” che Carol Gilligan ha teorizzato nella nozione di care? Oppure, come affermano le femministe vegetariane, l’ascolto della “voce diversa” dell’animale non può che 27 In “Au-delà de l’humain: écoféminismes et éthique du care”, Carol Gilligan et l’éthique du care, cit. 28 Ivi, pp. 159-160. 29 Ibidem. 30 Ivi, p. 168. 31 Jocelyne Porcher, Bien-être animal et travail en élevage, Editions Quae, Paris 2004, p. 173. 32 Eadem, Vivre avec les animaux. Une utopie pour le XXIe siècle, Éditions La Découverte, Paris 2011, p. 40. 91 Agnese Pignataro DEP n. 23 / 2013 portare al riconoscimento del suo desiderio di vivere, e quindi al rifiuto dell’alimentazione carnea? Quale rapporto tra allevamento e care: armonia o conflitto? 4. Discussione 4.1 Capitalismo e generalizzazione della sofferenza Come abbiamo appena visto, la prima critica di Catherine Larrère concerne la dimensione “generica” della denuncia della sofferenza animale da parte delle femministe vegetariane: tale denuncia non terrebbe conto della specificità dei contesti in cui si sviluppano le relazioni tra esseri umani e animali. Ma tale critica ha senso se le relazioni sono interpretate esclusivamente in chiave diadica, facendo astrazione dal contesto più ampio in cui esse si collocano. La determinazione del contesto di una specifica relazione di care non può esimersi dall’esame del modo in cui tale relazione si inserisce in una più ampia rete di relazioni simili da cui essa trae alcuni dei suoi caratteri fondamentali. Per quanto riguarda l’allevamento di animali a scopo alimentare, è impossibile interpretarlo come un insieme di relazioni esclusivamente personali tra l’allevatore e i suoi animali, dal momento che l’allevamento è una relazione di tipo economico: dunque la contestualizzazione della singola relazione di allevamento non può prescindere dalla considerazione del modo di produzione proprio alla società in cui tale relazione si attua. Nel caso delle società occidentali si tratta di un modo di produzione altamente uniformizzato, quello capitalistico: gli allevamenti attuali sono parte di un sistema produttivo caratterizzato dallo spiegamento di procedure il più possibile standardizzate nei tempi, nei metodi, nella selezione delle materie prime e nella riduzione dell’apporto umano a mera, indifferenziata “mano d’opera”. Gli stessi studi di Jocelyne Porcher mostrano che l’attuale industria zootecnica impone ai singoli allevatori l’adozione di criteri produttivi sempre più uniformi33. Di conseguenza, le femministe vegetariane hanno ragione di denunciare in modo generalizzato la sofferenza degli animali allevati nei Paesi occidentali, dal momento che le loro condizioni di vita sono esse stesse generalizzate e uniformate dal sistema capitalista. Per questo le autrici di The Feminist Care Tradition in Animal Ethics, che sostengono il vegetarismo in una forma “contestuale”34, lo presentano come inaggirabile nelle società occidentali: “se c’è un contesto – scrive Deane Curtin – in cui il vegetarismo morale è assolutamente obbligatorio in quanto espressione di un’etica del care è quello in cui vivono le persone benestanti nei Paesi tecnologicamente avanzati”35. Proprio in virtù di tale contesto la rivendicazione vegetariana è suscettibile di essere letta come un atto di care nei confronti degli animali: nel mondo capitalista essa è l’unica opzione che possa esprimere in modo 33 Cfr. Bien-être animal et travail en élevage, cit., pp. 42-51. Tale posizione non coincide con un mero relativismo o arbitrio personale, ma vale per tutti gli individui che si trovino a vivere in condizioni analoghe. 35 Deane Curtin, Toward an Ecological Ethic of Care, in The Feminist Care Tradition in Animal Ethics, cit., p. 98. 34 92 Agnese Pignataro DEP n. 23 / 2013 coerente un atteggiamento di sollecitudine per i non umani. In effetti, qualunque posizione etica e politica che contempli forme di allevamento non intensive e “tradizionali” si scontra inesorabilmente con i limiti imposti dalle condizioni di vita delle società umane attuali: il capitalismo, la globalizzazione, l’aumento vertiginoso della popolazione mondiale sono fattori che impediscono di pensare che una tale opzione sia realisticamente possibile. A questo punto si potrebbe obiettare che basterebbe avanzare una proposta politica anticapitalista per risolvere la questione. Arriviamo così al cuore del problema: l’allevamento è o no una pratica di care? E se lo fosse, ciò basterebbe a fondare la sua giustificazione etica? 4.2 I pericoli del care Da quanto abbiamo visto del pensiero di Gilligan e di Tronto possiamo dare una risposta immediata alla seconda domanda: non tutte le relazioni possono essere difese in nome del care. È anzi obiettivo di una teoria politica del care indicare le possibili involuzioni e regressioni a cui possono portare delle relazioni di care che non rispettino condizioni globalmente democratiche ed egalitarie. Tronto indica in particolare due pericoli: il paternalismo/maternalismo, che consiste nella tendenza del care-giver a prendere decisioni al posto del care-receiver, e il campanilismo, cioè la tendenza a considerare come eticamente primarie le relazioni in cui si è personalmente coinvolti. Quest’ultimo pericolo è particolarmente in agguato nel momento in cui si prenda a modello come etica del care la relazione madreinfante36. Anche la femminista Sarah Lucia Hoagland37 insiste sulla necessità di criticare un’etica del care che veda come paradigmatiche relazioni fondamentalmente asimmetriche, come la maternità, l’insegnamento, la terapia: si tratta infatti di relazioni basate sull’autorità del care-giver, sulla dipendenza del care-receiver, e sull’assenza di una vera reciprocità. In questo tipo di situazioni, nota Hoagland, “tendiamo a giustificare relazioni in cui il potere è sbilanciato, in base al presupposto secondo cui tali relazioni esprimono una differenza di abilità”38; in realtà, le relazioni asimmetriche non si basano su una differenza di competenze, ma sull’assunzione di un’incapacità dell’altro di agire in modo autonomo. Si tratta, in definitiva, di contesti in cui si invoca la differenza per giustificare l’ingerenza nella vita dell’altro/a. Secondo Hoagland, la teoria del care deve invece appellarsi a relazioni eque e non caratterizzate da autorità: solo in questo caso potrà svolgere una funzione critica nei confronti di quelle apparenti relazioni care che occultano situazioni di subordinazione e ineguaglianza. 4.3 L’allevamento: un care reciproco ma asimmetrico Per valutare se e in quale forma l’allevamento comporti una dimensione di care è necessario assumere una prospettiva ampia, che legga questa pratica in senso 36 Joan Tronto, Moral Boundaries, cit., pp. 142, 145-146 e 170-171. Sarah Lucia Hoagland, Some Thoughts about Caring, in Claudia Card (ed.), Feminist Ethics, University Press of Kansas, Lawrence 1991. 38 Ivi, p. 251. 37 93 Agnese Pignataro DEP n. 23 / 2013 collettivo (relazione tra la società e le specie allevate) oltre che semplicemente individuale (relazione tra l’allevatore e i suoi animali). Ciò permette di portare alla luce l’esistenza di almeno tre direzioni di esercizio del care, inteso come attività volta alla conservazione dell’esistenza altrui. La prima è quella dell’allevatore nei confronti dei suoi animali: egli se ne prende cura, garantendo loro sostentamento e condizioni di vita adeguate (almeno idealmente). La seconda è quella degli animali allevati nei confronti della società che li alleva, cui essi forniscono nutrimento. La terza è quella dei singoli animali nei confronti dei rispettivi allevatori, cui assicurano un reddito. Tali relazioni possono arricchirsi di una dimensione emotiva nelle relazioni individuali tra allevatore e animale, ove possono svilupparsi legami affettivi personali. Notiamo immediatamente che il care esercitato dall’allevatore attraverso il mantenimento in vita degli animali è subordinato al care che gli animali forniscono a lui e alla società. Le autrici francesi si sforzano di sottolineare la reciprocità di queste tre relazioni. Porcher si richiama alla teoria del dono dell’antropologo Alain Caillé, secondo il quale l’atto del dono, nella sua dimensione socialmente fondativa e antropologicamente pregnante, si inserisce in una catena di mutua accettazione e contraccambio: per cui “gli allevatori hanno l’impressione di avere un debito verso i loro animali […] La gratitudine, che prende la forma della vita buona, rappresenta ciò che l’allevatore offre in cambio del lavoro e della vita donati dagli animali”39. Ma questa lettura presuppone una rete di attori astrattamente posti su un piano di eguaglianza, liberi di entrare o meno nella catena del dono. Nel caso degli animali d’allevamento, il carattere fittizio di questo schema non potrebbe essere più evidente. La loro stessa venuta al mondo è programmata in vista della soddisfazione di bisogni umani preesistenti: non solo è impossibile per loro, dal punto vista strettamente pratico, sottrarsi all’elargizione coatta dei loro doni, visto lo stato di appropriazione di cui sono oggetto (sistemi di contenzione e status legale di proprietà dell’allevatore), ma la loro stessa identità ontologica è vincolata alla loro funzionalità economica. Questo stato di fatto consegna le vite degli animali all’arbitrio dei bisogni umani e delinea un considerevole squilibrio di potere a favore di questi ultimi. Soffermiamoci ancora sulla “vita buona” che l’allevatore è tenuto a dispensare ai suoi animali. Porcher sostiene che l’uccisione finale degli animali d’allevamento è accettabile solo a condizione che abbiano avuto “la possibilità di vivere la loro vita e se questa vita è stata il più possibile buona, e in ogni caso migliore di come sarebbe stata senza di noi: più pacifica, più interessante, più ricca di senso e di relazioni”40. Tale vita buona è associata a una dimensione emancipatrice dell’allevamento che, afferma Porcher in polemica con i sostenitori della liberazione animale, occorre riscoprire e valorizzare; difatti, l’allevamento significa per queste specie l’emancipazione dal loro status di preda41. 39 Jocelyne Porcher, Vivre avec les animaux, cit., p. 35. Ivi, p. 34. 41 Ead., Ne libérez pas les animaux! Plaidoyer contre un conformisme ‘analphabête’, in “Revue du MAUSS”, La Découverte, 29, 2007/1, p. 582. Considerazioni analoghe sono svolte da Catherine et Raphaël Larrère, Le contrat domestique, in “Le Courrier de l’environnement”, 30, 1997. 40 94 Agnese Pignataro DEP n. 23 / 2013 Si tratta però di chiarire in che modo il giudizio sulla vita degli animali, sulla sua qualità e sul suo senso, possa essere stabilito: su quali criteri basarsi per giungere a una valutazione attendibile? A questo proposito, Josephine Donovan suggerisce di integrare l’etica del care con la standpoint theory42. Di tradizione marxista, la standpoint theory è stata sviluppata da alcune autrici femministe per sostenere che, come il proletariato, anche la classe socio-economica delle donne ha un particolare accesso epistemico e non ideologico alla realtà, in virtù della propria posizione di classe sfruttata43. Secondo Donovan anche gli animali, reificati come e più degli operai nel processo produttivo capitalista44, possiedono un punto di vista che necessita di essere colto ed espresso da quegli esseri umani che accettino di allacciare un dialogo con loro: occorre sforzarsi di leggere e interpretare il linguaggio del corpo (movimenti degli occhi, espressioni facciali, tono della voce) degli individui animali con i quali si è in relazione, universalizzando poi quanto osservato agli altri individui della stessa specie, coinvolti in contesti analoghi. Donovan non sottovaluta la difficoltà del compito, una difficoltà simile a quella di chi cerchi di comunicare con esseri umani gravemente handicappati, ma confida nell’efficacia di un atteggiamento di attenzione affinato dalla pratica45. L’attenzione è un elemento chiave dell’etica del care: Joan Tronto spiega come per cogliere i bisogni dell’altro occorra “mettere in sospeso i propri obiettivi, ambizioni, progetti di vita e preoccupazioni, al fine di riconoscere l’altro e di avere attenzione per lui”46. Cosa è, invece, del punto di vista degli animali nella nozione di “vita buona” proposta da Jocelyne Porcher? Laddove l’attenzione e il dialogo portano, secondo Josephine Donovan, a intuire che gli animali “non vogliono essere macellati né trattati in modo doloroso, né essere sfruttati”47, Porcher si limita a chiedere, retoricamente e provocatoriamente: “chi può sapere cosa vogliono gli animali domestici?”48 Di fatto la studiosa francese è lungi dall’assumere il distacco teorizzato da Tronto e da Donovan, ma, al contrario, presta agli animali le intenzioni che meglio aggradano gli interessi degli umani che beneficiano del loro 42 In Feminism and the Treatment of Animals: from Care to Dialogue, in “Signs: Journal of Women in Culture and Society”, 31, 2, 2006; riprodotto in versione ridotta con il titolo “Caring to Dialogue. Feminism and the Treatment of animals” in The Feminist Care Tradition, cit. 43 Per una presentazione e discussione della standpoint theory femminista si veda Alison Wylie, Feminism in philosophy of science: Making sense of contingency and constraint, in Miranda Fricker, Jennifer Hornsby (eds.), The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 2000. 44 Sull’alienazione degli animali di allevamento nella società capitalista si veda Barbara Noske, Beyond Boundaries – Humans and Animals, Black Rose Books, Montréal 1989-1997, cap. 2 “Domestication Under Capitalism”. 45 Josephine Donovan, Caring to Dialogue, cit., pp. 363-364. 46 Joan Tronto, Moral Boundaries, cit., p. 128. 47 Josephine Donovan, Caring to Dialogue, cit., p. 362. 48 Jocelyne Porcher, Bêtes de somme, in “Ravages”, n. 3: Adieu bel animal, Editions Descartes & Cie, novembre 2009, p. 131. 95 Agnese Pignataro DEP n. 23 / 2013 care49; il suo è un dialogo a senso unico in cui l’umano usa il suo ruolo di caregiver per decidere cosa è meglio per l’animale, definendo “vita buona” la protezione accordatagli in cambio della gestione della sua vita e dell’appropriazione del suo corpo. Non solo le valutazioni di Porcher e Larrère sono dense di paternalismo, ma questo tipo di posizioni è in totale contraddizione con le teorizzazioni politiche del care da noi esaminate, che tendono piuttosto al superamento della dipendenza: l’esistenza addomesticata segna infatti l'impossibilità intrinseca dell’autonomia degli animali. Ciò che abbiamo tentato di mettere in luce finora attraverso la nostra analisi concettuale è del resto espresso apertamente dalle due autrici francesi. I loro appelli alla conservazione della relazione con gli animali, alla valorizzazione delle emozioni che ci legano a essi e all’assunzione di responsabilità in merito al loro benessere, teoricamente riconducibili a un atteggiamento di care, si incarnano in una pratica, l’allevamento, di cui è riconosciuta la dimensione asimmetrica50, gerarchica e inegalitaria51. Larrère precisa esplicitamente che tale relazione “è in grado di caratterizzare ciascuno nell’eccellenza della sua propria virtù, della funzione che riempie”52: si riconoscono all’opera sia il meccanismo concettuale denunciato da Hoagland, ovvero l’uso strumentale della nozione di differenza per qualificare relazioni di care caratterizzate da disuguguaglianza e disproporzione di potere, sia l’identificazione dei care-givers con i loro ruoli di cura, in cui Tronto vede un dispositivo di denigrazione del care. 4.4 Morte dell’individuo e morte delle relazioni La morte degli animali resta un punto opaco in tutte le versioni riformiste dell’etica animale. Nell’etica del care, sarà centrale interrogarsi su ciò che la morte implica per l’animale stesso e per le relazioni in cui è coinvolto. Abbiamo visto come per Josephine Donovan sia possibile cogliere il rifiuto dell’animale di fronte alla morte, e anche come la volontà dell’animale sia un elemento centrale della risposta etica alla questione del mangiar carne. Ma, anche assumendo di non conoscere il punto di vista degli animali, si può facilmente osservare che l’uccisione è un atto inaccettabile dal punto di vista del care nella misura in cui interviene a troncare, in modo brusco e prematuro, l’esistenza e le relazioni di un soggetto, laddove il care è per definizione un’attività volta alla loro preservazione. D’altra parte, quale spessore etico potranno mai avere relazioni che per loro essenza si dipanano in un periodo cortissimo? Per gli animali “da carne”, la relazione con l’allevatore dura pochi mesi, coincidenti con la loro giovinezza: non conosceranno mai l’età adulta, né saranno mai conosciuti in quanto adulti 49 Si veda ad es. Jocelyne Porcher-Tiphaine Schmitt, Les vaches collaborent-elles au travail? Une question de sociologie, in “Revue du MAUSS”, La Découverte, 35, 2010/1, in cui l’analisi del punto di vista degli animali consiste nell’osservazione della loro collaborazione o meno nelle pratiche di allevamento: si tratta di un punto di vista catturato già all’interno della relazione con l’essere umano. 50 Jocelyne Porcher, Vivre avec les animaux, cit., p. 37. Catherine Larrère-Raphaël Larrère, Le contrat domestique, cit.; Catherine Larrère, Des animauxmachines aux machines animales, in Jean Birnbaum (dir.), Qui sont les animaux?, Gallimard, Paris 2010, p. 107. 52 Catherine e Raphaël Larrère, Le contrat domestique, cit. 51 96 Agnese Pignataro DEP n. 23 / 2013 dall’allevatore. Questi resterà in relazione con loro poche settimane o pochi mesi. Non è un caso che Jocelyne Porcher basi le sue riflessioni sul carattere relazionale dell’allevamento quasi esclusivamente sull’esperienza di allevatori di animali – come le mucche “da latte”53 – che restano in allevamento per diversi anni prima di finire al mattatoio. Cosciente del problema, Porcher lo risolve diluendo il dramma della morte individuale nel più ampio sistema delle relazioni collettive A seconda della scala di riferimento, vita e morte non hanno lo stesso senso. [...] il rispetto e lo scambio non sono gli stessi con animali riproduttori, come le mucche, le maiale, le pecore, e con animali come i vitelli, gli agnelli, i porcellini, venduti più o meno rapidamente. Il rapporto di dono si colloca in dimensioni temporali differenti e circola tra gregge e individui, tra tipi di animali e tra vita e morte. […] Gli allevatori danno la vita e infine la riprendono per nutrire gli esseri umani, ovvero per mantenere la vita. […] se l’allevatore ha rispettato i termini dello scambio [… ] la morte dei suoi animali trova senso e lascia il posto alla vita: innanzitutto la sua vita economica, condizione della sua sopravvivenza come allevatore, ma anche la vita del suo gregge, poiché l’animale continua a esistere nei suoi discendenti, nella sua filiazione54. Tale soluzione, che esprime perfettamente l’asimmetria di potere tra allevatore e animali già delineata, dovrebbe convincerci, secondo Porcher, dell’opportunità di accettare il male minore per ottenere un bene più grande: i singoli animali devono morire, con scadenze diverse, per assicurare la permanenza del loro gruppo (assicurando il reddito all’allevatore) e della società umana che li ospita (fornendole sostentamento in forma di cibo). Ma questa soluzione è davvero l’unica possibile? Non si potrebbe immaginare una società che riconosca il carattere superfluo del sostentamento “donato” dagli animali e decida di evolvere in senso vegetariano, aiutando gli allevatori a trovare la loro sopravvivenza economica in attività di tipo diverso? Una tale ipotesi non porta danno a chi oggi beneficia dell’allevamento, e al tempo stesso presenta il vantaggio di evitare il male subìto dagli animali: si tratta di una soluzione che media il punto di vista di tutti gli attori coinvolti e dunque perfettamente in linea con il care. Come mai allora essa non è contemplata da Porcher e da Larrère? La risposta si trova nell’ultima delle obiezioni che Larrère muove al care vegetariano: quella di tendere alla recisione delle relazioni tra gli esseri umani e gli animali domestici, cancellando la presenza di queste specie animali dalla vita umana e cadendo così in contraddizione con lo spirito dell’etica del care. Si tratta di un’obiezione che Larrère mutua da Porcher stessa che in un pamphlet intitolato Non liberate gli animali! denuncia la volontà delle teorie della liberazione animale di rompere il nostro legame con gli animali domestici, da cui risulterebbe “un mondo senza animali, ovvero l’inferno”55. In altre parole, la morte del singolo animale sarebbe necessaria per lasciare in vita la comunità della nostra specie con altre specie. Questo discorso si basa su una incredibile confusione di piani, giacché sottintende che la fine dell’allevamento coincida con la fine di ogni possibile 53 Cfr. Les vaches collaborent-elles au travail? Une question de sociologie, cit., e Être bête, scritto in collaborazione con l’etologa Vinciane Despret (Actes Sud, Paris 2007). 54 Jocelyne Porcher, Vivre avec les animaux, cit., p. 34 e segg. 55 Ead., Ne libérez pas les animaux! Plaidoyer contre un conformisme ‘analphabête’, cit., p. 579. 97 Agnese Pignataro DEP n. 23 / 2013 relazione con gli animali. Tuttavia questi due esiti non sono logicamente coincidenti. A condizione di provarci, è possibile immaginare una preservazione della comunità di vita della nostra specie con altre specie; si tratta di definirne le condizioni di possibilità materiali e di accettare la scoperta di nuove modalità del vivere insieme agli animali, diverse da quelle di allevamento. È una realtà che in parte conosce già realizzazione nei santuari di animali sottratti al maltrattamento. In realtà, alcuni passaggi degli scritti di Porcher sono rivelatori del fatto che il suo obiettivo è difendere un solo e preciso tipo di prossimità tra umani e animali, quella realizzata dall’allevamento non industrializzato, mentre l’idea di inventare nuovi tipi di coabitazione viene da lei scartata: “la maggior parte di noi si sente legata agli animali di allevamento da un filo storico, familiare, sentimentale, che rende difficile prospettare un avvenire nel quale l’allevamento avrebbe una mera funzione di zoo animale e culturale”56. Questa volontà ostinata di evitare la “morte” dell’allevamento, e solo di quello, esemplifica bene il rischio presente in una nozione di care non declinata politicamente: quello di poter essere strumentalizzata per la conservazione di uno status quo. Come abbiamo ripetuto più volte, non si può giustificare qualunque relazione in nome del care. Non è sufficiente che una relazione sia “in vita” – cioè esista, abbia un passato, ispiri emozioni e partecipi a costruire l’identità dei suoi protagonisti – per provare che quella relazione è degna di continuare a “vivere”, se appare che una delle parti ne riceve danno nella sua autonomia e integrità fisica. Il femminismo offre numerosi esempi di relazioni di questo tipo: quelle di donne con uomini violenti, o ancora quelle delle mammies, schiave afroamericane destinate al compito di nutrici, con i loro padroni bianchi. Si tratta di relazioni in cui l’attaccamento sentimentale, o il senso del sé derivato dalla subordinazione, occultano rapporti reali di dominio e di sfruttamento57. E qui si coglie l’errore in cui incorre Larrère nel momento in cui contesta il parallelismo tra le lotte di liberazione umana e quella di liberazione animale: Larrère avanza l’argomento secondo cui mentre le prime avevano come scopo di permettere a tutti, dominanti e dominati, di continuare a vivere insieme in una società resa giusta, la seconda intenderebbe al contrario troncare le relazioni tra dominanti (gli umani) e i dominati (i non umani) e sciogliere la comunità mista originata dalla domesticazione58. In realtà, affinché dominanti e dominati umani possano realisticamente pensare di vivere insieme in modo democratico, è cruciale la “messa a morte” di quelle loro relazioni nelle quali si dispiega l’eccesso di potere; è necessario cioè rinunciare ad alcune forme di vita comune, alle quali siamo attaccati per ragioni storiche e sentimentali ma che costituiscono la cornice dell’oppressione. Per restare nell’ambito della sfera femminista, basti pensare alla criticità della famiglia monogamica eterosessuale e alla necessità di inventare nuove forme di relazionalità erotica e di allevamento dei figli. Lo stesso discorso vale per le relazioni con gli animali: per evitare la morte del concreto individuo animale, è necessario “uccidere” la forma della sua relazione con l’umano che tale 56 Ead., Bien-être animal et travail en élevage, Editions Quae, Paris 2004, p. 251. Si veda anche Barbara Houston, Caring and Exploitation, in “Hypatia”, 5, 1, 1990, pp. 115-119. 58 Catherine Larrère, Au-delà de l’humain: écoféminismes et éthique du care, cit., pp. 167-168. 57 98 Agnese Pignataro DEP n. 23 / 2013 morte rende necessaria, e che entrambi, l’animale e l’umano, trovino nuove forme di vita comune in cui l’affetto e la condivisione non esigano dal primo l’alto prezzo della privazione della vita. 5. Conclusione La nostra analisi ci porta a riconoscere che il legame tra care e allevamento è ambiguo: l’allevamento può essere interpretato come una pratica di care solo a condizione di intendere quest’ultimo in un modo conservatore. I difetti di una simile visione del care sono: – il tradizionalismo: si accettano le relazioni come dati di fatto legittimati dalla storia passata e da motivi nostalgici; – il rifiuto dei valori riconducibili alle etiche “della giustizia”: nella valutazione delle relazioni non si tiene conto di valori fondamentali, come la democrazia, l'uguaglianza, l'autonomia; – la parzialità della contestualizzazione: si accentuano i caratteri personali delle relazioni, legati alla biografia e alla cultura dei singoli che le vivono, e si omette il loro contesto politico, la dipendenza da particolari modi di produzione e l’intersezione con forme collettive di ineguaglianza e discriminazione. Tale visione conservatrice impedisce sia di riconoscere l’esatto valore del care e la sua potenzialità politica, sia di farlo entrare in dialogo con le etiche “della giustizia”, viste come dicotomiche al care, alle quali in tal modo si nega l’opportunità di “correggere” le loro tendenze all’astrazione, sia infine di farlo collaborare con altre forme di pensiero politico. Solo l’adozione di una prospettiva critica e progressista permette al care di evitare queste pericolose degenerazioni e di diventare un motore (anche se non l’unico) del cambiamento verso una società più giusta. Una tale prospettiva mette in luce l’incompatibilità tra care e allevamento. L’etica del care diventa in questo senso alleata dell’etica della giustizia nella critica delle relazioni utilitarie tra esseri umani e animali domestici. Laddove l’etica del care è vista da Catherine Larrère come uno strumento di opposizione alle posizioni della liberazione animale, essa può invece rappresentare un fattore di rinnovamento delle tradizionali animal rights theories, cui essa è in grado di offrire gli strumenti necessari per affrontare la questione della preservazione delle relazioni tra esseri umani e animali in un quadro egalitario e democratico. 99 Diritti animali e teoria femminista di Josephine Donovan* Nel saggio che segue (tratto da “Signs: Journal of Women in Culture and Society” XV, 1990, 2, pp. 350-375) l’Autrice affronta la questione dei diritti animali a partire dalla critica delle teorie di Tom Regan sul diritto naturale e di Peter Singer sulla filosofia utilitarista. Donovan critica l’approccio dei due autori, perché dichiaratamente “razionale”, poiché questa presa di posizione è quella utilizzata dall’epistemologia scientifica, a partire dai suoi primissimi teorizzatori, quali Bacone e Cartesio, che ne hanno fatto il fondamento per giustificare la tortura degli animali con pretesti scientifici, come la vivisezione. L’approccio femminista, analizzato nelle diverse sfaccettature, offre invece un’etica di relazione tra umani e animali che parte dalla loro comune condizione. Donne e animali, nella logica dominatrice della scienza patriarcale sono considerati esseri non razionali, da soggiogare (e annientare). La solidarietà e il forte legame tra donne e animali perciò sono affrontati in diversi studi femministi, ma anche nella letteratura femminile, in cui si dà maggior rilievo ai sentimenti e all’empatia. È dunque questo il punto di partenza, secondo Donovan, per costruire un nuovo modo di pensare e relazionarsi con le altre forme di vita, ovvero il riconoscimento da parte degli umani della capacità, condivisa da tutte le creature, di poter provare sentimenti, ed anche dolore. *** Peter Singer, nella prefazione al suo trattato pionieristico Animal Liberation (1975) esordisce con un aneddoto circa una visita fatta insieme alla moglie a una donna che sosteneva di amare gli animali; essa aveva sentito che l’autore stava scrivendo un libro sull’argomento, e per questo li aveva invitati a prendere il tè. * Josephine Donovan (1941), Ph.D. degree in letteratura comparata presso l’Università di Madison nel 1971, ha insegnato in diverse università e da poco ha rinunciato alla cattedra di Inglese presso l’Università del Maine, rassegnando le dimissioni per dedicarsi interamente alla scrittura. Autrice ed editrice di diversi volumi, predilige i campi di interesse quali l’etica animalista, la critica e la teoria femminista, la letteratura americana femminile moderna e contemporanea. Alcune opere di rilievo sul tema “donne e animali” sono: Animals and Women: Feminist Theoretical Explorations, Duke University Press, Durham, N.C. 1995; Beyond Animal Rights: A Feminist Caring Ethic for the Treatment of Animals, Continuum, New York 1996, entrambi co-curati assieme a Carol J. Adams; e il presente articolo, il cui titolo originale è Animal Rights and Feminist Theory, considerato una lettura essenziale per chi voglia avvicinarsi al tema del femminismo e questione animale. La traduzione dall’inglese è di Chiara Corazza. © DEP ISSN 1824 - 4483 Josephine Donovan DEP n. 23 / 2013 L’atteggiamento di Singer nei confronti della donna è sprezzante: “Aveva invitato anche un’amica che amava gli animali ed era ansiosa di incontrarci. Quando arrivammo la nostra ospite era già lì, e […] certamente desiderava parlare degli animali. ‘Io amo gli animali’, cominciò […] e si allontanò. Mentre si serviva il rinfresco fece una pausa e prese un sandwich al prosciutto, e ci chiese quali animali domestici avessimo”1. Lo scopo di Singer non è solo di condannare l’ipocrisia della donna che sosteneva di amare gli animali mentre mangiava carne, ma anche di dissociarsi da un approccio di tipo sentimentale nei confronti del benessere degli animali. Parlando anche a nome della moglie, spiega: “Noi non avevamo particolare interesse ‘negli animali’. Nessuno dei due è mai stato smisuratamente appassionato per cani, gatti o cavalli […] Noi non ‘amavamo’ gli animali […]. Rappresentare chi protesta contro la crudeltà verso gli animali come dei sentimentali e degli emotivi ‘amanti degli animali’ [ha significato] escludere la questione nel suo insieme […] da un serio dibattito, politico ed etico”. In altre parole, egli teme che associare la causa dei diritti animali con un sentimento “effeminato” avrebbe significato banalizzarlo2. Le preoccupazioni di Singer circa l’immagine e le strategie degli attivisti per i diritti animali sono condivise da un altro grande teorico contemporaneo dei diritti animali, Tom Regan. Nella sua prefazione a The Case for Animal Rights (1983), Regan sottolinea che “tutti coloro che lavorano per la causa degli interessi degli animali hanno familiarità […] con la trita accusa di essere ‘irrazionali’, ‘sentimentali’, ‘emotivi’, o peggio; noi possiamo smentire queste accuse solo facendo un serio sforzo per non indulgere nelle nostre emozioni o nell’espressione dei nostri sentimenti. E questo richiede un impegno duraturo per un’analisi razionale”3. In un successivo articolo Regan si difende dalle accuse di essere eccessivamente razionale, sostenendo che “la ragione – non il sentimento, non l’emozione – la ragione ci obbliga a riconoscere l’eguale valore innato degli […] animali e […] il loro eguale diritto di essere trattati con rispetto”4. Il rifiuto dell’emozione di Regan e Singer e il loro timore di essere considerati sentimentalisti non sono casuali; piuttosto espongono il pregiudizio insito nella teoria contemporanea per i diritti animali verso il razionalismo che, paradossalmente, ha stabilito nella forma dell’oggettivismo cartesiano, la principale giustificazione teorica al maltrattamento degli animali. Le teoriche per i diritti animali sembrano, al contrario, aver sviluppato un mag1 Peter Singer, Animal Liberation, Avon, New York 1975, pp. ix-x. Da qui in poi utilizzerò il termine riassuntivo di “teoria dei diritti animali” per riferirmi a ogni teorizzazione sul trattamento degli animali da parte degli umani, privo di riguardo per le sue radici filosofiche. Vorrei riconoscere il contributo di Gloria Stevenson, che mi ha introdotta al concetto di diritti animali anni fa, e del mio cane Jessie. 2 Nell’Etica, Spinoza sottolinea che l’opposizione alla macellazione degli animali era basata sulla “superstizione e la pietà propria delle donne” piuttosto che sulla ragione (come già citato in Mary Midgley, Animals and Why They Matter, Universtiy of Georgia Press, Athens 1983, p. 10). Questo è il tipo di accusa che Singer teme. 3 Tom Regan, The Case for Animal Rights, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1983, p. xii. 4 Id., The Case for Animal Rights, in In Defense of Animals, edited by Peter Singer, Basil Blackwell, New York 1985, p. 24. 101 Josephine Donovan DEP n. 23 / 2013 gior senso di solidarietà emotiva nei confronti degli animali come base per le loro teorie, più evidente che nella produzione maschile. Per esempio, Mary Midgley, teorica contemporanea dei diritti animali, suggerisce: “Ciò che rende i nostri compagni esseri viventi degni di considerazione di base, non è di certo la loro capacità intellettuale, ma piuttosto la partecipazione emotiva”. Gli animali, osserva l’autrice, esprimono “una complessità sociale ed emotiva nella formazione di profonde, sottese e durevoli relazioni”5. Costantia Salomone, una femminista ed attivista di primo piano per i diritti animali, condanna apertamente il pregiudizio razionalista e maschilista dell’attuale teoria dei diritti animali6. Nel diciannovesimo secolo, le attiviste del movimento antivivisezionista, come Francis Power Cobbe, consideravano il “freddo e razionale materialismo” della scienza, che percepivano come una minaccia “che poteva congelare l’emotività e la sensibilità umane […] un antagonista. L’antivivisezionismo […] difendeva il cuore, lo spirito umano dalla degradazione di una scienza priva di sentimenti”7. L’aneddoto di Singer dimostra inoltre che non ci si può semplicemente riferire alle donne, in modo acritico, come a un gruppo, o a un sistema di valori femminili quale fonte per un’etica della relazione umana con gli animali. Se le donne sono state indubbiamente meno colpevoli degli uomini nell' abuso e nella distruzione attiva degli animali (come osserva Virginia Woolf nelle Tre Ghinee: “Una gran maggioranza degli uccelli, e degli animali sono stati uccisi da te; non da noi”)8, sono state tuttavia complici di questo abuso, nell’utilizzo diffuso di prodotti di lusso che comporta la sofferenza degli animali e la loro morte (come per esempio le pellicce) e nel consumo di carne. Charlotte Perkins Gilman, femminista e sostenitrice del benessere animale, criticò questa ipocrisia decenni prima di Singer, nel suo A Study in Ethics (1933). Condannando la moda femminile di indossare “come ornamento la carcassa di un animale”, Gilman evidenzia una sconvolgente incongruenza, il fatto che “donne civilizzate e cristiane, sensibili alla crudeltà, affezionate ai loro animali domestici, sostengano sistematicamente la più grande crudeltà esistente nei confronti di milioni di indifese piccole creature […]. Le pellicce si 5 Mary Midgley, Persons and Non-Persons, in In Defense of Animals, p. 60. Costantia Salomone, riprodotto da una lettera, luglio 1986. 7 James Turner, Reckoning with the Beast: Animals, Pain and Humaity in the Victorian Mind, Johns and Hopkins University Press, Baltimore 1980, pp. 101, 103; Roswell C. McCrea nel testo The Humane Movement: A Descriptive Survey (1910), McGrath, College Park, Md.1969, p. 117, nota che il contrasto tra sentimentalismo e razionalismo come fondamento della teoria dei diritti animali fosse un tema presente nella campagna per i diritti animali nel diciannovesimo secolo: “Di norma gli scritti [e] il lavoro umani sono basati su una ‘fede’ piuttosto che su uno schema di fondamenti razionali. La base emotiva è comune, e il corretto trattamento degli animali è considerato desiderabile per se stesso”. Eccezione era la Lega Umanitaria di Henry Salt, che cercava di porre “i principi umani su una base razionale e concreta”. Si fondava “non su un puro sentimento di gentilezza, quale prodotto del cuore invece che del cervello”. Ciononostante, Francis Power Cobbe e altre teoriche del tempo non temevano di privilegiare il cuore. Per un’introduzione alle loro idee, si veda Coral Landsbury, The Old Brown Dog: Women, Workers, and Vivisection in Edwardian England, University of Wisconsin Press, Madison 1985. 8 Virginia Woolf, Three Guineas (1938), Harcourt Brace, New York 1963, p. 6. L’osservazione di Virginia Woolf presente in questo passaggio suggerisce il fatto che l’autrice avesse condotto delle ricerche sul tema. 6 102 Josephine Donovan DEP n. 23 / 2013 ottengono mediante l’uso delle trappole. Questo significa ogni agonia possibile dell’animale, cattività, inedia, sofferenza per fame e gelo, paura terribile e dolore. Se una donna legasse ed appendesse centinaia di gattini, ognuno per una zampa, nel suo cortile di casa durante la stagione invernale, lasciandoli lottare e agitarsi nel freddo, miagolando acutamente per l’angoscia e il terrore, e con le pellicce così realizzate potesse ‘adornare’ qualcosa […], sarebbe considerata un mostro”9. Riconoscendo che tali problemi sono impliciti nella storica relazione tra donne e animali, credo che il femminismo culturale, riconoscendo la teoria dei diritti animali, possa proporre un fondamento teorico per un’etica del trattamento animale più consono di quello attuale. Le teorie contemporanee per i diritti animali includono due approcci teorici principali, uno basato sulla teoria dei diritti naturali, l’altro sull’utilitarismo. Il massimo teorico della posizione dei diritti naturali è Tom Regan, la cui principale dichiarazione appare in The case for Animal Rights. In questo lavoro, imponente, anche se talvolta sofistico, Regan sostiene che gli animali – in particolare i mammiferi adulti – siano delle entità morali con alcuni diritti inalienabili, come gli esseri umani, secondo la dottrina dei diritti naturali enunciata nel XVIII secolo (in particolare da Locke)10. Regan costruisce la sua tesi a partire dalla confutazione di Kant, che aveva stabilito nella sua seconda formulazione dell’Imperativo Categorico che “l’uomo e in genere ogni altro essere razionale esiste come un fine in se stesso, non puramente come un mezzo”, che esseri razionali posseggono “valore assoluto, e hanno il diritto di essere trattati come dei fini”11. Nell’argomentazione di Locke e dei creatori della Dichiarazione di Indipendenza e della Costituzione degli Stati Uniti d’America, non tutti gli esseri umani erano considerati sufficientemente razionali, tali da poter essere ritenuti “persone” con dei diritti; solo i bianchi proprietari maschi erano sufficientemente degni di essere inclusi nella categoria di persona. Certamente, la maggior parte dei movimenti per i diritti delle donne nel diciannovesimo secolo erano impegnati a stabilire che anche 9 Charlotte Perkins Gilman, A Study in Ethics, Schlesinger Library, Radcliffe College, Cambridge, Mass. 1933, dattiloscritto. Pubblicato con il permesso della Schlesinger Library. È doveroso notare che le donne criticate da Singer e Gilman sono colpevoli di omissione più che di compiere atti; non perpetrano attivamente le atrocità nei confronti degli animali. Il loro errore è dato dall’ignoranza e dall’abitudine, elementi presumibilmente rimediabili con un’educazione morale. In questo articolo metto a fuoco principalmente l’ideologia razionalista della scienza moderna, poiché la sua epistemologia oggettivante, che trasforma gli animali in “cose”, è diventata una visione degli animali diffusa e comune, di conseguenza legittima altre forme di abuso sugli animali come l’industria agroalimentare. 10 Nonostante il suo accento sull’analisi rigorosamente razionale, Regan usa in tutto il suo scritto il termine inaspettato come una sorta di clausola di recesso, sebbene la ragione deduttiva di per sé risulti essere inadeguata. Un esempio in cui l’argomentazione di Regan diventa (almeno a mio avviso) illogica è l’ipotesi della scialuppa di salvataggio, in cui egli sostiene che, tra quattro adulti normali e un cane, sia quest’ultimo a dover essere sacrificato. Il suo ragionamento qui sembra nascondere una sottesa gerarchi, in cui gli uomini rimangono sempre all’apice. Si veda Tom Regan, The Case of Animal Rights (1983), pp. 324-325. Si veda inoltre la critica di Peter Singer in Ten Years of Animal Rights Liberation, in “New York Review of Books”, April 25, 1985, p. 57. 11 Immanuel Kant, Theory of Ethics, in Kant Selections, edited by Theodore M. Greene, Scribner’s, New York 1927, pp. 308-309. 103 Josephine Donovan DEP n. 23 / 2013 le donne dovevano essere considerate come persone nella Costituzione12. Qui, come altrove, nella teoria politica occidentale, le donne e gli animali sono entrambi esclusi. Aristotele, per esempio, associò le donne agli animali nell’Etica Nicomachea escludendoli dalla partecipazione alla vita morale. E Keith Tomas illustra come il dibattito durato secoli sulla questione se le donne avessero l’anima procedesse in parallelo a simili discussioni sullo status morale degli animali13. Nel costruire la sua tesi per i diritti animali, Regan estende la categoria di coloro che hanno il merito assoluto o valore intrinseco per includervi anche le creature non razionali, seppur intelligenti. Egli elabora una distinzione tra agenti morali (coloro i quali sono in grado di esprimere dei giudizi etici e razionali) e pazienti etici (coloro i quali non possono fare tali formulazioni, ma che tuttavia sono meritevoli di essere trattati come dei fini). Tutto ciò contrariamente a Kant, che afferma che “gli animali […] sono puramente dei mezzi per un fine. Questo fine è l’uomo”14. Regan espone la sua teoria, negando quella di Kant che sostiene che pazienti etici come alcuni esseri umani (chi è gravemente ritardato, bambini molto piccoli o chi è incapace di ragionamento) non possano essere trattati come dei fini. Ciò, a parere di Regan è inconcepibile. Inoltre, se si accetta che agenti e pazienti etici siano portatori del rispetto fondamentale, ciò implica la nozione di diritti, così come afferma Regan, da cui ne consegue che i pazienti etici non umani (gli animali) debbano essere inclusi nella categoria di coloro che hanno il diritto di essere trattati come dei fini. Un’argomentazione diversa è specista, ovvero che assume arbitrariamente che gli umani abbiano maggior valore rispetto ad altre forme di vita. Lo specismo è un concetto preso in prestito dal femminismo e dalla teoria delle minoranze. È analogo al sessismo e al razzismo poiché privilegia un gruppo (umani, maschi, bianchi o ariani) su un altro15. Regan, inoltre, mantiene una posizione deontologica assolutamente non consequenzialista; trattare gli animali come dei fini è – scrive – un dovere etico. Si tratta di una questione di giustizia, non di gentilezza16. Sebbene Regan rifiuti la determinazione della razionalità di Kant come base per entrare nel “regno dei fini”, egli precisa che coloro i quali hanno “valore intrinseco” debbano avere una conoscenza soggettiva – debbano essere “soggetti di una vita” – e/o avere l’insieme della consapevolezza riconoscibile nei mammiferi adulti17. Questo criterio lascia aperta la questione degli umani ritardati, di coloro che sono in coma irreversibile, dei feti, e persino dei bambini molto piccoli. Il criterio di Regan infatti privilegia chi ha una completa consapevolezza rispetto a chi ne è 12 Si veda la successiva discussione di Josephine Donovan, Feminist Theory: The Intellectual Traditions of American Feminism, Ungar, New York 1985, pp. 4-5. 13 Keith Thomas, Man and the Natural World: A History of the Modern Sensibility, Pantheon, New York 1983, p. 43. Per le esposizioni successive sul “simbolismo culturale” che unisce donne ed animali, si veda Mary Midgely, op. cit, pp. 78-79. 14 Immanuel Kant, Duties to Animals and Spirits, cit. in The Case of Animal Rights (1983), p. 177. 15 Ivi, p. 155; il termine specista era stato coniato, secondo Regan, da Richard D. Ryder in Victims of Science, Davis-Poynter, London 1975. Si veda inoltre Peter Singer, Animal Liberation, cit., pp. 7, 9. 16 Tom Regan, The Case of Animal Rights (1983), p. 280. 17 Ivi, p. 243. 104 Josephine Donovan DEP n. 23 / 2013 privo18. Inoltre, sebbene rifiuti il razionalismo kantiano, la teoria di Regan dipende dalla nozione di pensiero, richiamando di conseguenza il criterio della razionalità. Non sono in disaccordo con l’idea che i mammiferi adulti abbiano un’intelligenza molto sviluppata che può essere paragonata al raziocinio umano; piuttosto metto in discussione la validità del criterio della razionalità. La difficoltà di Regan sembra in parte frenare la teoria del diritto naturale, che privilegia il razionalismo e l’individualismo, ma può anche esprimere la sua decisa presa di distanza dai sentimenti nella ricerca intellettuale “seria”. A questo proposito, da un punto di vista femminista, la posizione sviluppata dai teorici utilitaristi dei diritti animali è più plausibile perché lascia da parte il criterio dell’intelligenza, insistendo al contrario sulla capacità di provare sentimenti – o la capacità di soffrire – come criterio con cui determinare chi può avere il diritto di essere trattato come un fine. La posizione utilitaristica nella teoria dei diritti animali è stata sviluppata principalmente da Peter Singer. Certamente il suo coraggioso ed ammirevole libro, Animal Liberation, ha ampiamente incoraggiato l’attuale movimento per i diritti animali. La premessa centrale di Singer deriva dal passaggio chiave dell’Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789) di Jeremy Bentham. Durante la massima espressione della dottrina del diritto naturale, la Rivoluzione Francese, Bentham scrisse: Potrebbe venire un giorno in cui il resto degli animali acquisirà quei diritti che non avrebbero mai potuto essere negati se non dalla mano della tirannia […]. Potrebbe venire un giorno in cui essere riconosciuti dal numero delle gambe, dalla peluria della pelle, o dalla terminazione dell’osso sacro, siano ragioni […] insufficienti per abbandonare un essere sensibile al suo destino. Cos’altro potrebbe tracciare l’insuperabile confine? È la facoltà della ragione, o forse la facoltà del linguaggio? Ma un cavallo o un cane adulti, sono senza dubbio più razionali e comunicativi di un bambino appena nato che abbia un giorno o una settimana, o persino un mese di vita. Ma supponiamo che la situazione fosse altrimenti, a che servirebbe? La questione non è “Possono ragionare?”, né, “Possono parlare?” ma, “Possono soffrire?”19. Un simile passaggio si trova nel Discourse on the Origin of Inequality (1755) di Rousseau. Sembra in parte essere una risposta alla visione cartesiana degli animali come macchine, discussa precedentemente. Potremmo porre fine all’antico dibattito sulla partecipazione degli altri animali alla legge di natura; semplicemente gli animali non conoscono quella legge, anche se si vuole riconoscere loro raziocinio e volontà; ciononostante, poiché essi condividono in qualche misura la nostra natura, in virtù della sensibilità di cui sono dotati, potremmo ben immaginare che debbano condividere similmente il beneficio della legge naturale, e che l’uomo ha dei doveri nei loro confronti. Infatti se ho l’obbligo di non danneggiare alcun essere vivente, non è dovuto al fatto che sia un essere raziocinante, ma al fatto che è un essere sensibile20. Pertanto sia Bentham che Rousseau sostengono che i diritti naturali, o 18 Ivi, pp.77, 247, 319. Jeremy Bentham, Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789), in The English Philosophers from Bacon to Mill, edited by Edwin A. Burtt, Modern, New York 1939, p. 847. 20 Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract and Discourse on the Origin and Foundation of Inequality among Mankind, edited by Lester G. Crocker, Washington Square, New York 1967, p. 172. Si veda anche Mary Midgley, op. cit., p. 62. 19 105 Josephine Donovan DEP n. 23 / 2013 l’appartenenza al regno dei fini di Kant, siano accordati alle creature che possano provare sentimenti. Entrambi sostengono che la comune condizione che unisce gli umani agli animali sia la sensibilità, la capacità di provare sofferenza e piacere. La posizione utilitarista scaturisce da questa premessa e stabilisce che se una creatura è senziente ha degli interessi, al pari di ogni altra creatura senziente, quali l’eguale diritto alla considerazione, qualora gli esseri umani prendano delle decisioni sul loro benessere. Con le parole di Singer “la capacità di soffrire e provare piacere è un prerequisito per avere degli interessi21. Una pietra, ad esempio, non ha interessi sul fatto di essere calciata, perché non può soffrire, mentre un topo li ha poiché può provare dolore”. “Se un essere vivente soffre”, sostiene Singer, “non può esserci una giustificazione etica al rifiuto di prenderne in considerazione la sofferenza. […] Il principio di eguaglianza richiede che la sua sofferenza debba contare egualmente come la sofferenza […] di ogni altro essere vivente”. In breve, “dolore e sofferenza non sono desiderabili e dovrebbero essere prevenuti o minimizzati, senza badare alla razza, al sesso, o alla specie dell’essere vivente che soffre”22. Questa è l’essenza della posizione utilitarista nei diritti animali. La teoria utilitarista dei diritti animali ha il pregio di permettere una certa flessibilità nelle scelte, si oppone alla posizione assolutista di Regan, che afferma che la sofferenza degli animali non sia mai giustificabile. Come utilitarista, Singer sostiene, ad esempio, che la consapevolezza delle conseguenze può e dovrebbe influenzare la valutazione del destino di un individuo, in ogni situazione data. Questo lo conduce ad ammettere che “ci potrebbero essere verosimilmente delle circostanze in cui un esperimento su un animale potrebbe ridurre notevolmente la sofferenza tanto da accettare di realizzarlo, anche se implicasse arrecare dolore all’animale [anche se] fossero esseri umani”23. Altrove egli sostiene che se la sofferenza di un animale avesse come risultato la cura di tutte le forme di cancro, questa sofferenza potrebbe essere giustificabile24. La posizione fondamentale di Singer sostiene che “simili interessi debbano contare egualmente, senza dare peso alle specie degli esseri coinvolti. D’altra parte, se il processo di qualche esperimento facesse del male allo stesso modo a un uomo e a un maiale, e non ci fossero delle conseguenze rilevanti […] sarebbe sbagliato dire che noi dovremmo usare il maiale perché la sua sofferenza conta meno della sofferenza dell’essere umano”25. Inoltre, sebbene Singer usi il termine “diritti animali”, le sue modifiche prendono distanza dalla dottrina tradizionale dei diritti naturali, più di quanto non lo faccia Regan nelle sue riconcettualizzazioni. Non è un problema di diritti politici o di cittadinanza razionale, come il diritto di libera espressione o il diritto di voto, né si tratta del diritto che ha una creatura intelligente di essere trattata come un fine (in 21 Peter Singer, Animal Liberation, cit., p. 8. Ivi, p. 8, 18. 23 Peter Singer-Tom Regan, The Dog in the Lifeboat: An Exchange, in “New York Review of Books”, 25 April 1985, p. 85. Si noti che sebbene Regan e Singer non siano d’accordo nella teoria, essi lo sono nella pratica: entrambi si oppongono alla sperimentazione sugli animali, il loro sfruttamento per il cibo e per l’abbigliamento, l’industria agroalimentare, le trappole, la caccia, i rodei e il circo. 24 Peter Singer, Ten Years of Animal Liberation, cit., p. 48. 25 Ibidem. 22 106 Josephine Donovan DEP n. 23 / 2013 termini kantiani). Si tratta piuttosto del diritto di una creatura senziente di avere interesse a non ricevere sofferenza, considerata in modo eguale quando presa in esame contro l’interesse di un’altra creatura senziente26. L’insistenza di Singer sul fatto che gli animali abbiano interessi uguali a quelli degli umani rende le sue argomentazioni eticamente convincenti, quanto l’opinione di Regan che gli animali abbiano dei diritti. Tuttavia, ci sono alcune debolezze nella posizione utilitarista. La prima è che non è previsto un preciso standard di valori per prendere una decisione o ponderare su degli interessi, il che insinua dei pregiudizi non presi in esame. In secondo luogo, essa richiede una quantificazione della sofferenza, una “matematicizzazione” degli individui etici, che ricade nella sfera scientifica che giustifica il sacrificio degli animali. Pertanto, mentre riconosce la sensibilità o la percezione di sentimenti come fondamento per il loro trattamento quali entità etiche, la posizione utilitarista resta ancorata al modo di ragionare razionalista e calcolatorio, che distanzia le entità etiche dal soggetto della scelta decisionale, reificando gli animali in termini di sofferenza quantificata. Proprio come la teoria dei diritti naturali proposta da Regan privilegia in modo inerente la razionalità, l’utilitarismo di Singer ricade in un dominio manipolatorio che non è diverso da quello usato dagli sperimentatori scientifici e dai medici per legittimare gli abusi sugli animali, come la vivisezione. È per questa ragione che dobbiamo rivolgerci al femminismo culturale come teoria alternativa. Il femminismo culturale ha una lunga storia. Durante la “prima ondata” del femminismo, diverse pensatrici come Margaret Fuller, Emma Goldman e Charlotte Perkins Gilman articolarono una critica all’individualismo atomista e al razionalismo della tradizione liberale27. Esse proposero una visione che enfatizzava collettivamente l’unione emotiva e il concetto di vita organica (od olistica). In Woman in the Nineteenth Century (1845), ad esempio, Fuller sosteneva che la “liberazione” 26 Id., Ethics and Animal Liberation, in In Defense of Animals, cit., pp. 1-10. Storicamente l’utilitarismo si sviluppò come parte di un’ondata di sentimentalismo che emerse verso la fine del diciottesimo secolo in Europa, che costituì le premesse intellettuali per il movimento di protezione animale del diciannovesimo secolo. Si veda in James Turner, op. cit., pp. 31-33; e Keith Thomas, op. cit., pp. 173-180. La crescente partecipazione delle donne nella vita culturale del diciottesimo secolo senza dubbio contribuì alla comparsa del sentimentalismo e alla crescente empatia per gli animali visti nelle asserzioni di Rousseau e Bentham. 27 Per un completo dibattito si veda Josephine Donovan, op. cit., pp. 31-63. L’altra maggiore tradizione teorica per idee alternative riguardanti la relazione umana con il mondo naturale è il marxismo; ciononostante, come intuitivamente sottolinea Isaac D. Balbus in Marxism and Domination: A Neo-Hegelian, Feminist, Psuchoanalitic Theory of Sexual, Political and Technological Liberation, Princeton University Press, Princeton, N. J. 1982, il marxismo si fonda su una filosofia di dominio. Marx, infatti, vedeva l’identità umana come formata dal lavoro che manipola un mondo oggettivato e fisico. Balbus si rivolge invece a Hegel, che suggerisce che “tutta la sostanza è soggetto”, vale a dire che è motivata da una teleologia specifica, anche se non tutte le sostanze sono identiche (p. 285). “Né la ragione strumentale, né la pura intuizione o il sentimento, quanto piuttosto una nuova forma di ragione empatica e strumentale guideranno le interazioni tra gli umani e il mondo da cui essi dipendono” (p. 286). Tale “coscienza post-oggettivante” (p. 285) emergerà, crede Balbus, quando si saranno sviluppate nuove pratiche per educare i bambini, pratiche che intervengono nel processo di maturazione maschile che prevede lo sviluppo di ostilità nei confronti della madre. Perciò nell’ultima parte del suo libro Balbus si rivolge alla teoria culturale femminista neo-Freudiana – in modo specifico quella che è stata sviluppata da Dorothy Dinnerstein – per convalidare la sua tesi. 107 Josephine Donovan DEP n. 23 / 2013 delle donne e la loro integrazione nella vita pubblica dovesse passare attraverso una femminilizzazione della cultura, che avrebbe significato un regno di “gentilezza delicata”, uno stato di armonia e pace, la fine di ogni tipo di violenza (incluso, specifica, la macellazione degli animali per il cibo) e l’istituzione del vegetarianismo (sostituendo, suggerisce, “i legumi [fagioli] al cibo animale)28. Gilman afferma una simile visione nel suo romanzo utopico Herland (1911). Oltre a Fuller e Gilman, c’è un lungo elenco di femministe della prima ondata che sostenevano il vegetarismo o una riforma per il benessere animale, tra cui Mary Wollstonecraft, Harriet Beecher Stowe, Lydia Maria Child, Elizabeth Blackwell, Elizabeth Stuart Phelps Ward, Susan B. Anthony, Victoria Woodhull, Elizabeth Cady Stanton, le sorelle Grimké, Lucy Stone, Fraces Willard, Frances Power Cobbe, Anna Kingsford, Caroline Earle White e Agnes Ryan29. Nella seconda ondata della teoria femminista si registrano alcuni articoli che collegano specificatamente il femminismo con i diritti animali: negli anni ‘70, gli articoli di Carol J. Adams sul vegetarianismo e il saggio Reweaving the Web of Life (1982) di Costantia Salomone30. Molti altri lavori hanno collegato il femminismo 28 Margaret Fuller, Woman in the Nineteenth Century, (1845) Norton, New York 1971, p. 113. Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman (1792), Penguin, Baltimore 1975, pp. 291-292; Ead., Original Stories from Real Life, J. Johnson, London 1788; Harriet Beecher Stowe, Rights of Dumb Animals, in “Hearth and Home”, vol 1, 2, 1869, p. 24; Elizabeth Blackwell, Essays in Medical Sociology, Longmans Green, London 1909; Elizabeth Stuart Phelps Ward, Loveliness: A Story, in “Athlantic Monthly”, 84, August 1899, pp. 216-219; Ead., Tammyshanty, in “Woman’s Home Companion”, 35, October 1908, pp. 7-9; Ead., Trixy, Houghton Mifflin, Boston 1904; Ead., Though Life Do Us Part, Houghton Mifflin, Boston 1908, e vari articoli sulla vivisezione; Francis Power Cobbe, The Modern Rack, Swann, Sonnenshein, London 1899; Ead., The Moral Aspects of Vivisection, Williams & Margater, London 1875; Anna Bonus Kingsford, The Perfect Way in Diet, Kegan, Paul, Trench, London 1885; Ead., Addresses and Essays on Vegetarianism, Watkins, London 1912; diverse fonti ricordano che Anthony, Woodhull, le sorelle Grimké, Stone e Williard sono state vegetariane, e che Child è stata impegnata nella protezione degli animali. Si veda Peter Singer, Animal Liberation, cit., p. 234. Elizabeth Griffith, nella sua biografia In Her Own Right, Oxford, New York 1984, nota che in gioventù Elizabeth Cady Stanton aveva adottato un regime alimentare Grahamita (strettamente vegetariano), seguendo l’esempio delle sorelle Grimké (pp. 34-35). Ruth Bordin, in Frances Willard: A Biography, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1986, p. 122, sostiene che Frances Willard credesse che il mangiar carne fosse “cosa selvaggia” e che “i mortali illuminati del ventesimo secolo [sarebbero] stati sicuramente vegetariani”. Inoltre c’è un’interessante connessione tra l’astinenza dal mangiar carne del diciannovesimo secolo e i movimenti umanitari. Nel 1891 il WTCU di Philadelphia (probabilmente sotto l’egida di Mary F. Lowell) sviluppò un “Dipartimento della Compassione” dedicato all’antivivisezionismo. Nelle Letters of Lydia Maria Child (1883), Negro Universities Press, New York 1969, Child scrive di far parte dello SPCA e di sostenere il movimento umanitario. Facendone una logica personale, l’Autrice sottolinea la vicina solidarietà tra animali ed umani (lettera del 1872, pp. 213-214). Caroline Earle White era una delle principali attiviste animaliste della Philadelphia del diciannovesimo secolo; scrisse numerosi articoli sull’argomento. Parecchio del materiale di Agnes Ryan è contenuto, inedito, nella Schlesinger Library di Cambridge. In esso è incluso un romanzo sui “diritti animali”, Who Can Fear Too Many Stars?; Charlotte Perkins Gilman scrisse numerosi articoli sui temi animalisti, incluso The Beast Prison, in “Forerunner”, 31, November 1912, pp. 128-130 e Birds, Bugs and Women, in “Forerunner”, 4, May 1913, pp. 131-132. Una fonte successiva e molto utile circa il movimento delle donne, negli Stati Uniti del diciannovesimo secolo, per il benessere degli animali è Sydney H. Coleman, Humane Society Leaders in America, Humane Association, Albany, N.Y. 1924. 30 Carol J. Adams, The Oedible Complex: Feminism and Vegetarianism in The Lesbian Reader edited by Gina Covina and Laurel Galana, Amazon, Oakland, Calif. 1975, pp. 145-152; Ead., 29 108 Josephine Donovan DEP n. 23 / 2013 più in generale con l’ecologia, come ad esempio quelli di Susan Griffin, Carolyn Merchant, Rosemary Radford Ruether, Marilyn French, Paula Gunn Allen, Chrystos e Ynestra King31. Dal punto di vista culturale femminista, il dominio sulla natura, radicato nella psicologia maschile, postmedievale ed occidentale, è la causa sottesa del maltrattamento degli animali, tanto quanto lo sfruttamento delle donne e dell’ambiente. Nel suo studio pioneristico, The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution, Carolyn Merchant riconosce che “dobbiamo riesaminare la costruzione di una visione globale e di una scienza che, riconcettualizzando la realtà come macchina piuttosto che come organismo vivente, ha sancito la dominazione sia della natura che delle donne”32. Le critiche alle falsità insite nell’epistemologia scientifica non sono nuove. Wittgenstein aveva già dimostrato la natura tautologica del giudizio analitico nel suo Tractatus del 1911, un punto che anche Hume sostenne nella Ricerca sull’intelletto umano nel 1748. Ma fu la critica proposta da Max Horkheimer e Theodor Adorno nella loro Dialettica dell’Illusminismo (1944) che per prima creò una connessione tra ciò che Husserl aveva chiamato la “matematizzazione del mondo”33 e la denigrazione di donne e animali34. Vegetarianism: The Inedible Complex, in “Second Wave”, 4, 1976, pp. 36-42; Costantia Salomone, The Prevalence of Natural Law: Women and Animal Rights in Reweaving the Web of Life: Feminism and Non Violence, edited by Pam McAllister, New Society, Philadelphia 1982, pp. 364-375. Si vedano anche gli articoli di Janet Culbertson, Cynthia Braningan, Shirley Fuerst in Special issue: Feminism and Ecology, “Heresies”, 13, 1981; Joan Beth Clair (Newman), Interview with Connie Salamone, in “Woman of Power”, 3, Winter/Spring 1986, pp. 18-21; Andrée Collard, Freeing the Animals, in “Trivia”, 10, Spring 1987, pp. 6-23; Karen Davis, Farm Animals and the Feminine Connection, in “Animals’ Agenda”, VIII, 1, January/February 1988, pp. 38-39, che espone un’importante critica femminista alla vena machista nei movimenti ecologisti; e Andrée Collard con Joyce Contrucci, Rape of the Wild: Man’s Violence against Animals and the Earth, Indiana University Press, Bloomington 1989; Carol J. Adams, The sexual politics of Meat: A FeministVegetarian Critical Theory, Continuum, New York; Alice Walker ha recentemente abbracciato la causa dei diritti animali. Si veda il suo Am I Blue?, in “Ms”, July 1896; ristampato in Through Other Eyes: Animal Stories by Women, edited by Irene Zahava, Crossing, Freedom, Calif. 1988, pp. 1-6; Ellen Bring, Moving toward Coexistence: An Interview with Alice Walker, in “Animals’ Agenda”, VIII, 3, April 1988, pp. 6-9. 31 Susan Griffin, Woman and Nature: The Roaring Inside Her, Harper & Row, New York 1978; Carolyn Merchant, The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution, Harper and Row, New York 1980; Rosemary Radford Ruether, New Woman/New Earth: Sexist Ideologies and Human Liberation, Seabury, New York 1975; Ead., Sexism and God-Talk. Toward a Feminist Theology, Beacon, Boston 1983; Marylin French, Beyond Power: On Women, Men and Morals, Summit, New York 1985; Paula Gunn Allen, The Sacred Hoop. Recovering the Feminine in American Indian Traditions, Beacon, Boston 1986; Chrystos, No Rock Scorns Me as Whore, in This Bridge Called Me Back. Writings by Radical Women of Color, edited by Cherrìe Moraga and Gloria Anzaldùa, Persephone, Watertown, Mass. 1981; Ynestra King, Feminism and the Revolt of Nature, in “Heresies”, 13, 1981, pp. 812-816. 32 Carolyn Merchant, op. cit., p. xviii. 33 Come citato nella postfazione di Colin Gordon a Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977, di Michel Foucalt, Pantheon, New York 1980, p. 238. 34 Max Horkheimer - Theodor F. Adorno, Dialectic of Enlightenment, Herder&Herder, New York 1972. 109 Josephine Donovan DEP n. 23 / 2013 Il metodo scientifico o sperimentale trasforma la realtà in entità matematiche modellate sull’universo fisico che, come visto nelle leggi di Newton, è vincolato all’immagine di un meccanismo che opera secondo atti ripetitivi. Nessuna distinzione è fatta tra forme di vita, come i corpi umani e animali, considerati alla stregua di macchine secondo il punto di vista cartesiano, e le forme inanimate, come le rocce. Horkheimer e Adorno sostengono che l’imposizione di un modello matematico alla realtà riflette una psicologia di dominazione. “Nel pensiero [scientifico] gli uomini prendono le distanze dalla natura per proiettarla in modo immaginario – al solo scopo di trovare i modi per dominarla”. Ricorrendo al termine “illuminismo” per riferirsi al pensiero scientifico, essi notano che “l’illuminismo è totalitario quanto ogni altro sistema”; opera “come un dittatore nei confronti degli uomini. Li conosce al punto di poterli dominare”35. La propensione dell’universalità della conoscenza scientifica e del carattere generalizzante della metafora della macchina, comporta che le differenze e le particolarità siano eliminate, soggiogate, dominate. “Nell’imparzialità del linguaggio scientifico, tutto ciò che è debole perde completamente ogni possibilità di espressione”36. Come notava Max Scheler, “Quegli aspetti che non possono essere rappresentati nel linguaggio simbolico e arbitrario della matematica […] sono ricondotti a uno status differente: appartengono all’ambito di ciò che è ‘soggettivo’ e ‘ascientifico’”37. Pertanto, tutto ciò che è anomalo – che è vivo e non prevedibile – è cancellato o soggiogato nel paradigma epistemologico newtoniano/cartesiano. L’anomalo e il debole includono le donne e gli animali, entrambi parte di quelle soggettività e realtà eliminate o convertite in oggetti manipolabili – “la materia del dominio”38 – alla mercé del manipolatore razionalista, il cui valore è stabilito proprio dal fatto che sottomette il suo ambiente. “Ogni cosa – persino l’individuo umano, per non parlare dell’animale – è trasformato in un processo ripetitivo, sostituibile, in un puro esempio per i modelli concettuali del sistema”39. Horkheimer e Adorno concludono che questa epistemologia scientifica è una forma ideologica basata sulle condizioni materiali di dominazione sociale – in particolare quella degli uomini sulle donne. Nei loro “nauseanti laboratori di fisiologia” gli scienziati “strappano [l’informazione] dagli indifesi [animali]. La conclusione che essi traggono da quei corpi mutilati [è che], poiché sono loro a danneggiare gli animali, sono loro e soltanto loro ad agire volontariamente in tutto il creato. […] La ragione […] appartiene all’uomo. L’animale […] può provare solo terrore irrazionale”40. Ma lo scienziato non prova compassione o empatia per le sue 35 Ivi, pp. 9, 24, 39. Ivi, p. 23. 37 Come citato in William Leiss, The Domination of Nature, Braziller, New York 1972, p. 111. Analogamente, Sandra Harding ha osservato che “è la voce del soggetto scientifico che parla con autorità generale e astratta; gli oggetti di indagine ‘parlano’ solo in condizioni e situazioni storiche specifice”, in The Science Question in Feminism, Cornell University Press, Ithaca, N.Y. 1986, p. 124. 38 Max Horkheimer - Theodor F. Adorno, op. cit., p. 84. 39 Ibidem. 40 Ivi, p. 245. 36 110 Josephine Donovan DEP n. 23 / 2013 vittime perché “per gli esseri razionali […] provare dispiacere per una creatura irrazionale è un’occupazione futile. La civiltà occidentale ha affidato questo alle donne [attraverso] la divisione del lavoro imposta dall’uomo”41. L’associazione postmedievale del divario tra ragione ed emozioni con la divisione del lavoro, e in particolare con il sorgere del capitalismo industriale, è una tesi nota, in particolare presso i teorici marxisti. Eli Zaretsky, in Capitalism, the Family and Personal Life (1976), suggerisce che la reificazione della vita pubblica causata dall’alienante lavoro industriale avrebbe comportato che le relazioni personali fossero relegate alla sfera privata: “Nella società il divario tra ‘sentimenti personali’ e ‘produzione economica’ è stato integrato dalla divisione sessuale del lavoro. Le donne sono state identificate con la vita emotiva, gli uomini con la lotta per la sopravvivenza42”. La connessione delle donne alla vita economica è stata quasi universalmente di “produzione per l’uso” piuttosto che di “produzione per lo scambio” – significa che il loro lavoro consiste nella preparazione di beni per il consumo immediato nella sfera domestica piuttosto che per l’uso come merce per uno scambio o per un pagamento pecuniario. Tale pratica, argomentano i teorici, tende a creare una psicologia che valuta gli oggetti di produzione in modo emotivo così da non poter esserci uno scambio per la produzione alienata. Dal momento che in epoca capitalistica sono per lo più le donne ad impegnarsi nella produzione del valore d’uso, questa può essere una base per un’epistemologia contestualmente e relazionalmente orientata, che i teorici contemporanei ascrivono alle donne occidentali43. La pratica di confinare le donne, le emozioni e i valori alla sfera privata, ai margini, ha permesso alle attività maschili di occupare la sfera pubblica, politica e scientifica, come Horkheimer, Adorno ed altri hanno notato, di agire in modo amorale, “oggettivamente”, senza l’equilibrio delle considerazioni relazionali “soggettive”, in ogni caso eliminate o represse dalle discipline dominanti. Come riconoscono Carolyn Merchant, Horkheimer e Adorno, la caccia alle streghe della prima età moderna era sintomatica di un nuovo bisogno di cancellare e soggiogare la natura anomala, disordinata (e perciò femminile). Horkheimer e Adorno sostengono che l’annientamento delle streghe sancì “il trionfo della società maschile sugli stadi preistorici, matriarcali e mimetici dello sviluppo” e dell’istinto di sopravvivenza [nel] dominio sulla natura”44. Merchant suggerisce che le streghe 41 Ivi, p. 248; si veda inoltre pp. 14, 21. Eli Zaretsky, Capitalism, the Family and Personal Life, Harper & Row, New York 1976, p. 64. 43 Nancy C. M. Hartstock, Money, Sex and Power. Toward A Feminist Historical Materialism, Longman, New York 1983, pp. 152, 246. Sulla produzione del valore d’uso si veda Karl Marx, Capital, in Karl Marx: Selected Writings, edited by David McLennan, Oxford University Press, Oxford 1977, pp. 422-423. Per un utile riassunto di ciò che lei definisce “le epistemologie dal punto di vista femminista” si veda Sandra Harding, op. cit., pp. 142-161. Esse sono radicate, nota Harding, nell’affermazione derivata dal concetto di Hegel sulla coscienza di padrone/schiavo che “la posizione di ‘dominate’ delle donne determina la possibilità di una comprensione più completa e meno perversa”, p. 26. L’esperienza storica del silenzio delle donne della loro posizione di “schiave”, vis-àvis con il “padrone”, può determinare la base per l’empatia con le altre voci messe a tacere, come quelle degli animali. 44 Max Horkheimer - Theodore F. Adorno, op. cit., p. 249. 42 111 Josephine Donovan DEP n. 23 / 2013 rappresentassero quell’aspetto della natura che non si inseriva nello schema ordinario del paradigma matematico; inoltre erano viste come delle pericolose ribelli: “le donne indocili, come la natura caotica, dovevano essere controllate”45. Merchant osserva come Bacone, uno dei padri del metodo sperimentale, avesse usato l’analogia dell’inquisizione verso una strega per spiegare come gli scienziati manipolavano la natura per carpirne informazioni. Egli scriveva: “Non devi che seguirla, come se dovessi braccare la natura nelle sue peregrinazioni, e sarai in grado quando vorrai di condurla e guidarla di nuovo allo stesso punto”46. L’immagine della natura come una donna che deve essere dominata non può essere più esplicita. Il paradigma matematico impose l’immagine della macchina su tutta la realtà. Fu Descartes a sviluppare pienamente l’idea che le forme di vita non raziocinanti funzionino come macchine, che alcuni dei suoi seguaci portarono all’estremo (La Mettrie ne L’homme machine). Tom Regan critica ampiamente la visione cartesiana in The Case for Animal Rights47. È chiaro che l’idea degli animali come robots inconsapevoli e privi di sentimenti (che Rousseau, tra gli altri, rifiutò – si veda sopra) legittimava (e continua a farlo) l’atroce sperimentazione scientifica. Un primo critico anonimo di Descartes osservò: “Gli scienziati [cartesiani] percuotevano i cani con completa indifferenza e si prendevano gioco di chi si impietosiva verso quelle creature, giacché queste provavano dolore. Essi dicevano che gli animali erano degli orologi; che le urla che emettevano quando venivano colpiti erano solamente il suono di una piccola molla che era stata toccata, e che il loro intero corpo non provava emozioni. Essi inchiodavano i poveri animali per le zampe, su delle tavole per vivisezionarli, per vedere la circolazione del sangue, oggetto di gran dibattito”48. In un recente articolo, The Cartesian Masculinization of Thought, Susan Bordo descrive l’oggettivismo cartesiano come “un’aggressiva ‘fuga intellettuale dal femminile’”49. “La grande ‘ansia cartesiana’ [specialmente nelle Meditazioni] è preoccupata di separare l’universo organico femminile medievale e rinascimentale. L’oggettivismo cartesiano [è] una risposta difensiva all’ansia da separazione”50. In questo processo “l’originaria terra femminile diventa una res extensa inerte: una natura morta, che interagisce meccanicamente […]. ‘Lei’ diventa ‘una cosa’ – e la ‘cosa’ può essere compresa. Naturalmente, non grazie alla condivisione, ma solo in virtù della reale oggettività della ‘cosa’”51. La teoria dei diritti naturali, similmente al razionalismo illuminista, impone un sistema meccanicistico alla realtà politica ed etica. Le teoriche femministe contemporanee hanno criticato le pretese neutrali ed oggettive della teoria tradizionale che escludono il contesto irregolare in cui accadono gli eventi, imbrigliandoli invece in griglie astratte che distorcono e ignorano 45 Carolyn Merchant, op. cit., p. 127. Ivi, p. 451. 47 Tom Regan, op.cit., pp. 3-33. 48 Ivi, p. 5. 49 Susan Bordo, The Cartesian Masculinization of Thought, in “Signs: Journal of Women in Culture and Society”, XI, 3, Spring 1986, pp. 439-456, 441. 50 Ibidem. 51 Ivi, p. 451. 46 112 Josephine Donovan DEP n. 23 / 2013 la condizione storica. Per esempio, Catharine A. MacKinnon ha criticato la tradizionale interpretazione liberale della Costituzione statunitense per il suo approccio neutrale alla giustizia. L’Autrice suggerisce che “cambiamo una delle dimensione di liberismo quando incarna la legge, quale definizione di giustizia neutrale tra categorie astratte”, pertanto questo approccio ignora i “sistemi fondamentali” – vale a dire le reali condizioni in cui operano le astrazioni. MacKinnon inoltre rifiuta, per utilizzare un suo esempio, l’idea che “rafforzando la libertà di parola del Klan, si rafforzi la libertà di parola dei Neri”52. L’autrice sostiene che questa tesi è infondata perché equipara “la mancanza fondamentale di potere con il potere fondamentale”53 attraverso l’uso del modello concettuale meccanicistico. Pertanto MacKinnon, come le femministe culturali viste precedentemente, rigetta le elisioni “matematicizzanti” del razionalismo illuminista in favore di un’ottica che “percepisce” il contesto ambientale. Se i vivisezionisti descritti prima avessero consentito questo passaggio epistemologico, presumibilmente avrebbero “percepito” il dolore – la sofferenza e le emozioni – degli animali, ignorato dalla lente dell’astrazione meccanicistica attraverso cui stavano osservando. Sfortunatamente, i teorici contemporanei dei diritti animali, affidandosi alla teoria di derivazione meccanicistica dell’epistemologia illuminista (diritti naturali nel caso di Regan, utilitarismo nel caso di Singer) e la loro soppressione/negazione del sapere emozionale, continuano ad adoperare i modelli cartesiani, od oggettivisti, anche quando condannano le pratiche scientifiche che ne discendono. Tra i primi critici del meccanicismo cartesiano vi sono state due donne: Margaret Cavendish, duchessa di Newcastle (1623-1673) e Anne Finch, Lady Conway (1631-1679). Finch rifiutò in modo empatico la visione cartesiana, convinta che gli animali non erano “composti da ‘pura struttura’ o ‘materia inerte’, ma che avessero uno spirito, e ‘fossero dotati di conoscenza, sensazioni, amore, e varie altre facoltà e proprietà spirituali’ ”54. Cavendish, donna geniale sebbene non istruita, sfidò Descartes direttamente. Lo incontrò mentre era con suo marito in esilio in Francia, negli anni ‘40 del XVII secolo, e più tardi ebbe uno scambio epistolare con lui sul suo Trattato sugli Animali. In una delle sue lettere, datata 23 Novembre 1646, Descartes si vede costretto a difendere la sua nozione di animali come macchine: “Io non posso condividere l’opinione di Montaigne e di altri che attribuiscono pensiero o cognizione agli animali”55. Keith Thomas (in Man and the Natural World) riconosce che Cavendhish sia stata una delle prime persone ad articolare l’idea dei diritti animali56. Il suo biografo, Douglas Grant, nota: “I suoi scritti […] illustrano continuamente la sua sensibilità per la natura [e] per le sue creature: cosa provasse per il ‘povero leprotto’ brac52 Catharine A. MacKinnon, Pornography, Civil Rights and Speech, in “Harvard Civil Rights/Civil Liberties Law Review, XX, 1, Winter 1985, p. 4. 53 Ivi, p. 15. Si veda inoltre Donovan, op. cit., pp. 2-3, 28-30. 54 [Anne Finch], The Principles of the Most Ancient and Modern Philosophy (1690), citato in Carolyn Merchant, op. cit., p. 260. 55 René Descartes, Philosophical Letters, translated and edited by Anthony Kenny, Oxford University Press, Oxford 1975, p. 44. 56 Keith Thomas, op. cit., pp. 128, 170, 173-174, 280, 293-294. 113 Josephine Donovan DEP n. 23 / 2013 cato […] e il cervo; la sua pietà per le loro inutili sofferenze la portavano a levare la sua voce in loro difesa in un secolo in cui le violenze sugli animali erano comuni”57. “Un uomo che caccia gli animali fino alla morte con il pretesto dello sport, dell’esercizio e della salute”, lei si chiedeva “non è più crudele e selvaggio di un uccello da preda?”58. Io ritengo che la resistenza di Finch e Cavendish alle imposizioni della scienza moderna non fossero eventi isolati. Infatti, se noi accettiamo l’argomentazione di Michel Foucault che la supremazia delle discipline scientifiche e le loro relative istituzioni siano un processo storico di colonizzazione che si intensificò durante il periodo postmedievale, raggiungendo un picco nel diciannovesimo secolo, dovremmo leggere le critiche di Finch e Cavendish come una prima forma di resistenza femminista a un processo che inevitabilmente ha significato la distruzione degli insoliti mondi delle donne. La soppressione delle realtà sociali delle donne dovute alle teorie mediche pseudoscientifiche (specialmente quelle dei sessuologi) di fine ‘800 è stato l’ultimo stadio di ciò che Foucault ha etichettato come “medicalisation de l’insolite” – la medicalizzazione dell’insolito59. Questo processo coinvolse l’imposizione sociale dei paradigmi della sessuologia in modo analogo all’imposizione scientifica del paradigma del meccanicismo matematico su tutte le forme di vita. Forse è per questo che le donne di quell’epoca sembrano avere provato solidarietà con gli animali. Entrambi erano cancellati (nel migliore dei casi) o manipolati (nel peggiore dei casi) per comportarsi secondo i paradigmi imposti dai signori del razionalismo – fossero vivisezionisti o sessuologi. Le donne, infatti, divennero le principali attiviste e diedero forza al movimento antivivisezionista del diciannovesimo secolo, che, come propongo, deve essere visto come una manifestazione della resistenza anti-egemonica intrapresa dalle donne contro le violazioni causate dalle nuove discipline. Così come i sessuologi anatomizzavano il mondo delle donne fatto “di amore e rituali”, “entomologizzandolo” (per usare il termine di Foucault) in varie specie e sottospecie di devianza, così i vivisezionisti trasformavano i corpi degli animali in macchine per la dissezione. Nello studio del movimento antivivisezionista del diciannovesimo secolo, The Old Brown Dog, Coral Lansbury racconta come le donne attiviste si identificassero con il cane vivisezionato: “Ogni cane o gatto bloccato con le cinghie a disposizione della lama del vivisezionista ricordava alle donne la loro condizione”. Era 57 Douglas Grant, Margaret the First, Toronto University Press, Toronto 1957, p. 44. Ivi, p. 124. La principale fonte per gli scritti sui diritti animali di Margaret Cavendish sono le sue Poems and Fancies (1653), Philosophical Letters (1664), e The World’s Olio (1655). La sua immaginazione empatica si estende alla vita delle piante, a cui lei attribuisce una forma di consapevolezza (si veda Dialogue between an Oake and a Man cutting him downe in Poems and Fancies). 59 Michel Foucault, La Volonté de Savoir, vol. 1, Histoire de la sexualité, Gallimard, Paris 1976, p. 61 (la traduzione è mia). Per gli studi della devianza sessuale femminile, così come è stata definita dai sessuologi del diciannovesimo secolo si veda George Chauncey Jr., From Sexual Inversion to Homosexuality. Medicine and the Changing Conceptualization of Female Deviance, in “Salamagundi”, 58/59, Fall 1982/Winter 1983, pp. 114-145; e Lillian Faderman, The Morbidification of Love between Women by Nineteenth-Century Sexologists, in “Journal of Homosexuality”, IV, 1, Fall 1978, pp. 73-90. 58 114 Josephine Donovan DEP n. 23 / 2013 un’immagine di dominazione. Infatti, Elizabeth Blackwell, pioniera donna medico, vedeva l’ovariectomia e altre operazioni chirurgiche ginecologiche come “un’estensione della vivisezione”. Per le suffragette “l’immagine del cane vivisezionato si sfocava per diventare quella di una suffragetta militante, nutrita forzatamente nella prigione di Brixton”60. Il dominio sulla natura, sulle donne e sugli animali insito nell’epistemologia scientifica, che richiede che l’altro e il diverso sia forzato in schemi ordinati, può essere radicato nel processo di maturazione maschile occidentale che richiede che gli uomini stabiliscano la propria autonomia dal materno/femmile. La recente analisi di Hanna Fenichel Pitkin sullo sviluppo psicologico di Macchiavelli, un pensatore modello del secolarismo postmedievale, è molto significativa a questo proposito. L’autrice rivela che “gli scritti di Macchiavelli dimostrano una preoccupazione continua per l’umanità maschile”61. “Se la virtù [maschile] è la qualità preferita di Macchiavelli, effeminato […] è uno degli epiteti più caustici e frequenti”62. Nel Principe Macchiavelli sostiene che un leader sia regolato “o dalla fortuna o dall’abilità (virtù)”63. La virtù implica razionalità manipolatoria e una certa propensione machista per esercitare il controllo militare. La fortuna, d’altra parte, rappresenta il non razionale, ciò che è imprevedibile, ben lontana dall’esercizio del controllo razionale e di dominazione maschile. In un altro celebre passaggio del Principe, Macchiavelli sostiene: “La fortuna è una donna e, perché possa essere dominata, deve essere colpita e sconfitta”64. In un testo incompiuto che racconta della leggenda di Circe, Macchiavelli oppone il mondo delle donne, della natura e degli animali al mondo civilizzato dell’ordine pubblico, il mondo degli uomini. Pitkin nota come Circe sia vista quale una strega che ha il potere di trasformare gli uomini in bestie. È molto evidente il contrasto espresso da Macchiavelli tra “il mondo naturale e femminile, e il mondo degli uomini che è politico ed è il prodotto dell’artifizio umano […]. Accanto al mondo maschile della legge e della libertà, [c’è] il mondo della foresta il luogo in cui gli uomini sono trasformati in animali e tenuti prigionieri in dipendenza perenne”65. “La cultura maschile”, inoltre, “simboleggia il controllo sulla natura”66. Pitkin conclude: “La civiltà […], la storia, la cultura, l’intero vivere civile che costituiscono il mondo dell’autonomia umana adulta, sono […] imprese maschili ottenute e sostenute contro il potere femminile – l’opprimente madre […] la donna quale ‘altro’ […]. La lotta per sostenere la civiltà […] pertanto riflette la lotta dei 60 Coral Landsbury, op. cit., p. 24, 82, 89. Hanna Fenichel Pitkin, Fortune Is a Woman: Gender and Politics in the Thought of Niccolò Macchiavelli, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1984, p. 125. L’analisi di Pitkin si fonda sul lavoro delle “relazioni oggettuali” delle femministe neo-freudiane come Nancy Chodorow, Dorothy Dinnerstein e Jane Flax. 62 Ivi, p. 25. 63 Niccolò Macchiavelli, The Prince and Selected Discourses, edited by Daniel Donno, Bantham, New York 1966, p. 13. 64 Ivi, pp. 86-87. 65 Hanna Fenichel Pitkin, op. cit., pp. 124, 128. 66 Rosemary Radford Ruether, Sexism and God-Talk, p. 76. 61 115 Josephine Donovan DEP n. 23 / 2013 ragazzi che devono diventare uomini”67. In modo analogo, in Genere e Scienza (1978) Evelyn Fox Keller sostiene che l’autonomia e l’oggettività dello scienziato maschile riflette la dissociazione basilare dal mondo affettivo femminile richiesto nel processo evolutivo maschile68. Oltre questa teoria ontogenetica esiste la tesi filogenetica sviluppata da Rosemary Radford Ruether, per cui la civiltà patriarcale è costruita su un’emergenza storica della coscienza dell’ego maschile che si solleva contro la natura, vista come femminile. Il sessismo, nota l’Autrice, è radicato in questa “‘guerra contro la madre’, la lotta dell’ego trascendente per liberare se stesso dal legame con la natura”69. Sviluppando la definizione esistenzialista del pour soi trascendente e maschile, e dell’immanente femminile en soi (e così rifiutando la tesi di Simone de Beauvoir in Le Douxième Sexe), Ruether suggerisce che l’ininterrotto tentativo di trascendere il femminile ha condotto all’attuale crisi etica ed ecologica. Il difetto fondamentale dell’“ideologia maschile del dualismo trascendente” è il modello unico di dominio. “La visione dell’altro da sé non si presenta come un dialogo tra due soggetti, ma, piuttosto, come la conquista di un oggetto considerato insolito. L’intrattabilità dell’altro lato del dualismo, in risposta alle sue richieste, non significa che l’‘altro’ abbia una ‘natura’ propria, che necessita di essere rispettata e con dialogare. Piuttosto, questa intrattabilità è vista come quella di una ribellione disobbediente”. Perciò “la religione patriarcale sfocia […] in una percezione di un indocile cosmo finito e malvagi” contrario al progresso scientifico e tecnologico70. Nel suo recente libro Beyond Power (1985) Marilyn French sostiene che “il patriarcato sia un’ideologia fondata sul fatto che l’uomo si distingue dall’animale e ne è superiore. La base per questa superiorità è il contatto dell’uomo con una conoscenza/potere superiori definite dio, ragione, o controllo. La motivazione dell’esistenza per l’uomo è di perdere tutto il residuo animale e di realizzare la propria natura completamente ‘divina’, quella parte che sembra diversa da quella animale – mente, spirito, o controllo”71. French vede il sadomasochismo insito in questo impulso culturale di mutilare o uccidere l’animale/femminile in se stessi. Secondo French, la società patriarcale ha 67 Hanna Fenichel Pitkin, op. cit., p. 230. Evelyn Fox Keller, Gender and Science (1978), in Discovering Reality: Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, and the Philosophy of Science, edited by Sandra Harding and Merrill B. Hintikka, Reidel, Dordrecht 1983, pp. 187-205, in particolare p. 197. La caccia è, certamente, il rito quintessenziale di passaggio alla maturazione maschile. Come Barbara A. White nota in The Female Novel of Adolescence, Greenwood, Westport, Conn. 1985, pp. 126-127, “molte storie iniziatiche [riguardano] la caccia [in cui] il protagonista distrugge un ‘principio femminile’”. Molte teoriche femministe hanno collegato la caccia alla dominazione maschile. Si veda Charlotte Perkins Gilman, His Religion and Hers (1923), Hyperion, Westport, Conn. 1976, pp. 37-38. Uno studio più recente è quello di Peggy Reeves Sanday, Female Power and Male Dominance: On the Origins of Sexual Inequality, Cambridge University Press, Cambridge 1981, pp. 66-69, 128-130. 69 Rosemary Radford Ruether, New Woman/New Earth, p. 25. 70 Ivi, pp. 195-196. 71 Marilyn French, op. cit., p. 341. Coral Landsbury riconosce la connessione insita tra vivisezione e pornografia sadomasochistica e analizza un certo numero di lavori di pornografia di fine Ottocento che includono scene di vivisezione, op. cit., capitolo 7. 68 116 Josephine Donovan DEP n. 23 / 2013 raggiunto un’impasse spaventosa: “La nostra cultura, che venera sopra ogni cosa il potere di uccidere, vuole annichilire tutto quello che è ‘femminile’ nel nostro mondo”72. Le teoriche femministe contemporanee hanno identificato metodi epistemologici e ontologici alternativi che debbono, io credo, sostituire il modello di dominazione/controllo sadomasochistico tipico dell’epistemologia scientifica patriarcale. Ruether, ad esempio, suggerisce lo sviluppo di nuovi modi con cui relazionarsi con la natura e le forme di vita non-umane. “Il progetto di vita umana”, scrive, “non deve essere più visto come quello di ‘dominio sulla natura’ […]. Piuttosto, dobbiamo trovare un nuovo linguaggio di responsabilità ecologica, una reciprocità tra la consapevolezza e il sistema del mondo in cui viviamo e ci muoviamo ed esistiamo”73. In Sexism and God-Talk (1983), Ruether suggerisce che la coscienza umana non debba essere vista in modo diverso da quella delle altre forme di vita, ma come un continuum con lo spirito dalla duplice forma, insito in altri esseri viventi La nostra intelligenza è una forma speciale e intensa di […] energia radiale, ma non priva di continuità con altre forme di vita; è l’autoconsapevolezza o la “dimensione di pensiero” dell’energia radiale ad essere una questione importante. Noi dobbiamo rispondere all’“alterità” di tutti gli esseri viventi. Non si tratta di romanticismo, o di animismo antropomorfico che vede “una driade negli alberi”, sebbene la visione animista abbia una sua autentitcità […]. Rispondiamo non solo come “io ad esso”, ma anche “io a te”, allo spirito, all’energia della vita che giace in ogni essere vivente nella sua forma di esistenza. La “fratellanza dell’uomo” ha bisogno di essere ampliata per abbracciare non solo le donne, ma anche l’intera comunità della vita74. Ruether reclama una “nuova forma di intelligenza umana”, basata sulla modalità relazionale, affettiva, comunemente definita “artistica”, che va oltre la caratteristica lineare, dicotomica e alienata della consapevolezza “razionale” dell’epistemologia scientifica maschile. I modi lineari e razionali sono, aggiunge Ruether, “ecologicamente disfunzionali”75. Ciò di cui c’è bisogno è un modo relazionale più “disordinato” (il termine è mio – se ordine significa dominazione gerarchica) che non riconfiguri il contesto per adattarlo al paradigma del dominatore, ma veda, accetti e rispetti l’ambiente. In The Sacred Hoop: Recovering the Feminine in American Indian Traditions (1986), Paula Gunn Allen trova in queste tradizioni, atteggiamenti verso la natura in parte diversi dall’alienazione e dalla dominazione che caratterizzano l’epistemologia e la teologia occidentali. Dio e la dimensione spirituale non trascendono la vita, ma piuttosto sono immanenti in tutte le forme viventi. Tutte le creature sono viste come sacre e degne di rispetto fondamentale. Allen, appartenente al popolo Laguna Pueblo-Sioux, ricorda: “Quando ero piccola mia madre spesso mi raccontava che gli animali, gli insetti e le piante dovevano essere trattati con gentile rispetto, in accordo con l’educazione espressa dagli adulti di elevato status sociale”. Nella sua cultura, la natura è vista “non come cieca e meccanica, ma con72 Marilyn French, op. cit., p. 523. Marilyn French, op. cit., p. 523. 74 Rosemary Radford Ruether, Sexism and God-Talk, p. 87. 75 Ivi, pp. 89-90. Si veda inoltre Gina Covina, Rosy Rightbrain’s Exorcism/Invocation, in Gina Covina and Laurel Galana, op. cit., pp. 90-102. 73 117 Josephine Donovan DEP n. 23 / 2013 sapevole e organica”. C’è una “linea ininterrotta” tra “la vita umana e quella non umana”76. Piuttosto che modalità gerarchiche, lineari e meccanicistiche, Allen propone un ritorno alla sensibilità relazionale atemporale propria della sua gente. Riconoscendo che “c’è una sorta di connessione tra colonizzazione e tempo cronologico”, Allen osserva che “il tempo indiano si basa sulla percezione degli individui, come parte di un’intera forma in cui l’appropriatezza non è una questione di come i denti di un ingranaggio facciano presa gli uni sugli altri, ma piuttosto di come una persona si armonizzi con l’avvicendarsi delle stagioni, con la terra, e con la realtà mitica che dona significato a tutta la vita […]. Le mansioni tradizionali delle donne, le loro arti e manifatture, e le loro letterature e filosofie, sono molto spesso più accrescitive che lineari, più atemporali che cronologiche, in relazione armonica con tutti gli elementi percepiti, a differenza della cultura occidentale in generale […]. Le popolazioni tradizionali percepiscono il mondo come un insieme”77. Nel suo recente studio sull’arte contemporanea delle donne, Women as Mythmakers (1984), Estella Lauter ha identificato il profilo di un nuovo mito che coinvolge le donne e la natura. “Molte di queste artiste accettano l’affinità tra la donna e la natura come punto di partenza – creando perciò immagini ibride di donna/animale/terra fino ad annullare le vecchie distinzioni tra i livelli della Grande Catena dell’Esistenza”78. Riconoscendo il modello di Woman and Nature (1978) di 76 Paula Gunn Allen, op. cit., pp. 1, 80, 100; si veda inoltre p. 224. Ivi, p. 154, 243, 244. 78 Estella Lauter, Women as Mythmakers: Poetry and Visual Art by Twentieth-Century Women, Indiana University Press, Bloomington 1984, p. 18. Uno studio separato può essere condotto sugli animali nella narrativa delle donne. In un certo numero di opere le donne ricorrono agli animali per vendicarsi di ferite loro inferte; si veda Kerfol (1916) di Edith Warton, in The Collected Short Stories of Edith Wharton, edited by R. W. B. Lewis, Scribner’s, New York 1968, pp. 282-300; The Fiftyninth Bear (1959) di Sylvia Plath, in Jhonny Panic and the Bible Dreams, Harper & Row, New York 1979, pp. 105-114; In altri scritti l’identificazione tra donne/animali è esplicita. Si veda la volpe di Mary Webb, Goee to Earth (1917), Dalton, New York 1974; la volpe di Radclyffe Hall, The Well of Loneliness, Covice, Freed, New York 1929; le anatre di Ellen Glasgow, The sheltered Life, Doubleday Doran, Garden City, N.Y. 1932; il mulo di Zora Neale Hurston, Their Eyes Were Watching God, (1937), University of Illinois Press, Urbana 1978; il picchio di Willa Cather, A Lost Lady, Knopf, New York 1923; la volpe di Hariette Arnow, Hunter’s Horn, Macmillian, New York 1949. In molti romanzi di Gasgow la connessione donne/animali è un tema centrale. Si veda Josephine Donovan, The Demeter-Perephone Myth in Wharton, Cather, and Glasgow, State University Press, University Park: Pennsylvania 1989, in particolare il capitolo 5. In molte opere di donne, gli animali sono i loro amici più intimi e spesso vi è una sorta di comunicazione mentale tra di loro (specialmente quando le donne sono delle streghe). Si veda Annie Trumbull Slosson, Anna Malann, in Dumb Foxglove and Other Stories, Harper & Row, New York 1898, pp. 85-117; Mary E. Wilkins (Freeman), Christmas Jenny, in A New England Nun and Other Stories, Harper, New York 1891, pp. 160-177; Sarah Orne Jewett, A White Heron in The Country of the Pointed Firs (1925) edited by Willa Cather Doubleday Anchor, Garden City, N.Y. 1956, pp. 161-171; Virginia Woolf, The Widow and the Parrot: A True Story, in The Complete Shorter Fiction of Virginia Woolf, edited by Susan Dick, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego 1985, pp. 156-163; Rose Terry (Cooke), Dely’s Cow in How Celia Changed Her Mind and Selected Stories, edited by Elizabeth Ammons, Rutgers University Press, New Brunswick, N.J. 1986, pp. 182-195; Susan Glaspell, A Jury of Her Peers in American Voices: American Women, edited by Lee R. Edwards and Arlyn Diamond, Avon, New York 1973, pp. 359-381. The Beth Book (1987) di Sarah Grand, Dial, New York 1980, e diversi altri lavori di Elizabeth Stuart Phelps Ward, op. cit., sono esplicitamente antivivisezionisti. Si veda 77 118 Josephine Donovan DEP n. 23 / 2013 Susan Griffin, Lauter riconosce nella letteratura e nell’arte contemporanea delle donne “un’immagine di relazioni tra i diversi ordini dell’esistenza che è estremamente fluida, senza essere frammentaria”79. In queste opere i confini tra mondo umano e i regni vegetale ed animale sono sfumati. Appaiono forme ibride: le donne si trasformano in entità naturali, come piante o si fondono con la vita animale. Lauter trova “un numero sorprendente di” poetesse che hanno “un alto grado di identificazione con la natura, senza averne paura e senza smarrire la propria consapevolezza”. Molte di queste artiste hanno riconvalidato le antiche figure mitologiche che simboleggiano le relazioni delle donne con la natura: Demetra/Kore, Artemide/Diana, Dafne, Circe. La terra non è più vista come “materia inerte da razziare, ma materia ferita da cui fiorisce un rinnovamento. I due corpi, quello della donna e quello della terra, sono tra di loro solidali”80. Le artiste e le teoriche femministe qui citate puntano ad un nuovo tipo di relazione; diversa dal modello soggetto-oggetto tipico dell’epistemologia scientifica e della distanza razionalista praticata dai teorici maschili dei diritti degli animali, essa riconosce la varietà e le differenze tra le varie specie, ma non le quantifica né le struttura gerarchicamente nella Grande Catena dell’Esistenza. Rispetta la vitalità e lo spirito (il “tu”) delle altre creature, e comprende che esse e noi esistiamo nello stesso, unico continuum. Essa valorizza ciò che noi condividiamo – la vita – che è più importante delle nostre differenze. Tale relazione talvolta coinvolge gli affetti, talvolta il timore reverenziale, ma sempre il rispetto. In Maternal Thinking, Sara Ruddik sostiene che si possa individuare un’epistemologia materna, derivata dalla storica pratica delle cure materne – vale a dire, prendersi cura di un altro che ha bisogno di protezione e di crescere. La definisce un’attitudine “di mantenimento”, che “è governata dalla priorità del mantenere sull’acquisire, di conservare ciò che è fragile, di preservare ciò che è debole, di Lansbury per altri lavori in quest’ambito. Flannery O’Connor mostrò l’arroganza maschile coinvolta nella caccia; si veda The Turkeys in Complete Stories, Farrar Straus & Giroux, New York 1971, pp. 42-53. Si deve contare, tra le altre opere significative, Creatures Great and Small di Colette, translated by Enid McLeod, Secker & Warburg, London 1951; Flush A Biography di Virginia Woolf, Hogarth, London 1923; e The Fur Person (1957) di Mary Sarton, New American Library, New York 1970. Si veda anche Zahava, ed., op. cit.; Ellen Moers in Literary Women, Doubleday, Garden City, N.Y. 1977, nota che “un ricco campo di studi come quello degli animali nelle vite delle scrittrici prometterebbe molta fortuna nelle dissertazioni accademiche. George Sand aveva un cavallo […] chiamato Colette; Christina Rossetti aveva un vombato; Colette aveva tutti quei gatti; Virginia Woolf si appassionava per ogni tipo di animale. Ma sono i loro cani che rappresenterebbero al meglio l’obiettivo della ricerca – lo spaniel di nome Flush di Elizabeth Barrett; il ‘cane largo quanto me stessa’ di Emily Dickinson” (p. 260). Il più promettente approccio teorico all’argomento sulla connessione delle donne con gli animali è quello proposto da Margaret Homans in Bearing the Word: Language and Female Experience in Nineteenth-Century Women’s Writing, University of Chicago Press, Chicago 1986. Usando la teoria lacaniana, Homans suggerisce che le donne e la natura siano collegate come “il referente assente” nel discorso patriarcale. La sua discussione sul trattamento sadico di Heathcliff nei confronti degli uccelli in Wuthering Heights è particolarmente indicativa. L’autrice osserva che l’obiettivo di Cathy è di “proteggere la natura dall’uccisione simbolica e letterale da parte della mano della legge androcentrica” (p. 78). 79 Estella Lauter, op. cit., p. 19. 80 Ivi, pp. 174, 177. 119 Josephine Donovan DEP n. 23 / 2013 provvedere qualsiasi cosa sia a portata di mano e necessaria alla vita del bambino”. Ruddick risalta l’atteggiamento “di mantenimento” contro il “pensiero scientifico, tanto quanto […] il capitalismo strumentale e tecnocratico”. La pratica delle cure materne riconosce “il controllo esagerato come una responsabilità”, in profondo contrasto con il modello scientifico della manipolazione81. L’etica materna coinvolge un tipo di rispetto reverenziale per la vita e una realizzazione che va molto al di là del controllo dell’individuo. Citando Iris Murdoch e Simone Weil come predecessore filosofiche, Ruddick definisce questo un’etica dell’umiltà. È un atteggiamento che “non solo accetta i rischi del pericolo o della morte, ma anche le esistenze separate, indipendenti e incontrollabili, in via di sviluppo e in crescita, delle vite che lei si adopera per preservare”. Ruddick chiama tale atteggiamento “amore attento”, l’esercizio di domandare “Che cosa stai provando?”82 Se i vivisezionisti si fossero fatti tale domanda, la vivisezione non esisterebbe. In un recente articolo Evelyn Fox Keller propone simili distinzioni nelle sue osservazioni sulla pratica scientifica “femminile” del premio Nobel Barbara McClintock (che contrasta in modo molto marcato la manipolazione aggressiva della natura proposta da Bacone, vista nei suoi peggiori esperimenti da laboratorio sugli animali). McClintock crede nel “lasciare che la materia si rivolga a te”, permettendo di “indicarti quale prossimo passo fare”. Non crede che gli scienziati dovrebbero “imporre una domanda” alla materia, come richiesto dal paradigma matematico della tradizionale epistemologia scientifica; piuttosto, dovrebbero trovare risposta da sé e provare un rispetto empatico per essa83. È interessante che diverse scienziate e naturaliste, che hanno collaborato ed osservato la vita animale per anni – come Jane Goodal, Dain Fossey, Sally Carrighar, Francine Patterson, Janis Carter – esprimano quest’etica implicitamente: con un atteggiamento di cura, rispettosa, nei confronti dei loro “soggetti”84. Infine, In a Different Voice (1982) di Carol Gilligan sostiene che un’etica femminile sia radicata nel “modo di pensare, contestuale e narrativo piuttosto che for- 81 Sara Ruddick, Maternal Thinking, in “Feminist Studies”, VI, 2, Summer 1980, pp. 350-351. Si veda inoltre il suo Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace, Beacon, Boston 1989. 82 Ead., Maternal Thinking 1980, pp. 351, 359. 83 Evelyn Fox Keller, Feminism and Science, in “Signs”, VII, 3, Spring 1982, p. 599. 84 Si veda Jane Goodall, In the Shadow of Man, Houghton Mifflin, Boston 1971; Ead., The Chimpanzees of Gombe: Patterns of Behavior, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1986; Dian Fossey, Gorillas in the Mist, Houghton Mifflin, Boston 1983; Sally Carrighar, Home to the Wilderness, Houghton Mifflin, Boston 1973. Su Patterson e Carter si veda Eugene Linden, Silent Partners, Times Books, New York 1986; Janis Carter trascorse otto anni cercando di reintrodurre Lucy, uno scimpanzé che aveva imparato il linguaggio dei segni, nella foresta dell’Africa occidentale. Racconta la sua storia commovente in Surviving Training for Chimps, in “Smithsonian”, IX, 5, June 1988, pp. 36-49. Goodall ha recentemente pubblicato un’aspra condanna del trattamento degli scimpanzé nei laboratori americani. Si veda il suo A plea for the Chimps, in “New York Times Magazine”, May 17, 1987. Di particolare interesse è anche il testo Cynthia Moss, Elephant Memories: Thirteen Years in the Life of an Elephant Family, Morrow, New York 1988; e l’esperienza di Sue Hubbell con le sue api, in A Country Year: Living the Questions, Random House, New York 1986. 120 Josephine Donovan DEP n. 23 / 2013 male ed astratto”85. Ciò che lei chiama “etica della responsabilità” è in aperto contrasto con “l’etica del diritto”, osservata nella teoria sui diritti animali di Regan. Nel già visto modello femminile “l’etica e la conservazione della vita sono contingenti e al di sopra della connessione che sostiene [e] mantiene intatta la rete di relazion”. L’autrice pone in rilievo questo metodo, contro l’approccio dei “diritti” (visto nella sua analisi come più tipicamente maschile) che si affida alla “separazione, più che alla connessione” e basato su una “logica formale” di valutazioni quantitative strutturate gerarchicamente86. Gilligan, Ruddick, Lauter, Allen, Ruether e French propongono un’etica che richiede un rispetto basilare per le forme di vita non umane, un’etica che ascolti e accetti la diversità delle voci dell’ambiente e l’importanza delle loro realtà. È un’etica che resiste all’appropriazione forzata e alla manipolazione del contesto per sottometterlo alle categorie di qualcuno; è anti-imperialista e affermatrice di vita. Si potrebbe obiettare che questa etica è troppo vaga per essere praticabile nelle decisioni riguardanti gli animali. La mia proposta, ciononostante, non è di stilare un’etica specifica e pratica, ma, piuttosto, di indicare dei modi in cui il nostro pensare le relazioni tra umani/animali possa essere re-indirizzato. Alcuni potrebbero insistere: supponiamo che qualcuno debba scegliere tra un moscerino e un essere umano. Si tratta, infatti proprio del rifiuto di questo tipo di pensiero da parte dell’epistemologia femminista. Nella maggioranza dei casi, le scelte di tipo “autaut” nella vita reale possono essere trasformate in “entrambi e in ogni caso”. Nella maggioranza dei casi, le situazioni di vita o di morte, come nell’esempio dell’ipotetica scialuppa di salvataggio, possono essere evitate. Più nello specifico, comunque, è chiaro che l’etica qui abbozzata significherebbe che le femministe dovrebbero rifiutare la dieta carnea; l’uccisione di animali vivi per produrre vestiti; la caccia; la cattura di animali selvatici per le pellicce (un consumo di lusso quasi esclusivamente femminile); i rodei; il circo; e l’industria agroalimentare; devono favorire una drastica revisione degli zoo (semmai gli zoo dovessero continuare ad esistere) per permettere agli animali ampi spazi per poter vivere in habitat naturali; dovrebbero rifiutare l’uso di animali da laboratorio per testare i detergenti e i cosmetici (come il tristemente noto “LD-50” e i test di Draize) e per 85 Carol Gilligan, In a Different Voice: Psycological Theory and Women’s Development, Harvard University Press, Cambridge 1982, p. 19. Per un’ulteriore discussione sull’etica proposta dalla teoria femminista si veda Donovan, The New Feminist Moral Vision in Feminist Theory, pp. 171-186. 86 Carol Gilligan, op. cit., p. 19, 59, 73. Un altro importante studio che sviluppa l’etica femminista è l’opera di Nell Noddings, Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1984. Sfortunatamente, mentre Noddings crede che l’etica della cura da lei sostenuta sia valorizzata da un atteggiamento celebrativo verso il mondo domestico femminile, che include, nota l’autrice, “dar da mangiare al gatto”, tuttavia rifiuta specificatamente le principali istanze della teoria dei diritti degli animali, compreso l’astensione dal mangiar carne. È chiaro che la sua etica del “prendersi cura” comprende esclusivamente agli umani. L’arbitrarietà della sua posizione può essere attribuita solo a uno specismo che non è stato preso in debita considerazione. Il libro di Nodding, sebbene comunque ammirevole, presenta una tesi debole a causa di questo pregiudizio, dimostrando così come la teoria femminista debba considerare la teoria dei diritti animali se vogliamo evitare le ipocrisie e le inconsistenze delle signore del tè, condannate da Singer (come Noddings, che amano i propri animali domestici, ma approvano la dieta carnivora, p. 154). 121 Josephine Donovan DEP n. 23 / 2013 l’equipaggiamento militare; gli esperimenti psicologici, come ad esempio quello di Harlow sui primati presso l’Università del Wisconsin; dovrebbero contribuire agli sforzi per sostituire gli esperimenti medici con modelli computerizzati e colture di tessuti; dovrebbero condannare e attivarsi per prevenire ulteriori distruzioni di paludi, foreste, habitat naturali. Tutti questi cambiamenti dovrebbero essere parte di una ricostruzione femminista del mondo. I diritti naturali e l’utilitarismo presentano degli argomenti utili e notevoli per il trattamento etico degli animali. È possibile inoltre – e senza dubbio necessario – fondare quell’etica sul dialogo emotivo e spirituale con le forme di vita non-umane. Oltre ad una cultura relazionale femminile basata sulla cura e l’amore attento, inoltre, emerge il fondamento per un’etica femminista per il trattamento degli animali. Noi non dovremmo uccidere, mangiare, torturare e sfruttare gli animali perché essi non vogliono essere trattati così, e noi ne siamo consapevoli. Se li ascoltassimo, saremmo in grado di udirli. 122 Femminismo e questione animale: bibliografia orientativa e strumenti di ricerca nel web a cura di Annalisa Zabonati Sul pensiero ecovegfemminista, che accoglie le istanze dell’ecofemminismo animalista e vegano, c'è ormai una bibliografia vastissima. In questa breve rassegna ci limitiamo ad indicare le opere essenziali per accostarsi all’argomento. Per quanto riguarda la sitografia proponiamo una scelta dei siti web principali con una breve descrizione. Bibliografia Adams Carol J., The Oedible Complex: Feminism and Vegetarianism, in The Lesbian Reader, Covina Gina - Galana Laurel (eds.), Amazon Press, Los Angeles 1975, pp. 145-152. Adams Carol J., The Sexual Politics Of Meat, Continuum, New York 1991. Adams Carol J., The Feminist Traffic in Animals, in Ecofeminism: Women, Animals, Nature, Gaard Greta (ed.), Temple University Press, Philadelphia 1993, pp. 195-218. Adams Carol J., Neither Man nor Beast: Feminism and the defense of animals, Continuum, New York 1994. Adams Carol J., ‘Mad Cow’ Disease and the Animal Industrial Complex: An Ecofeminist Analysis, in “Organization and Environment”, 10, 1997, pp. 26-51. Adams Carol J., Ecofeminism and the Eating of Animals: feminism and the defence of animals, Black Powder Press, Sacramento 2000. Adams Carol J., Pornography of Meat, Continuum, New York 2004. Adams Carol J.-Donovan Josephine Animals and Women: Feminist Theoretical Explorations, Continuum, New York 1995. Adams Carol J.-Donovan Josephine, Beyond Animal Rights: A Feminist Caring Ethic for the Treatment of Animal, Continuum, New York 1996. Adams, Carol J.-Tyler Tom, An Animal Manifesto: Gender, Identity, and Vegan-Feminism in the Twenty-First Century, in “Parallax 38”, XII, 1, 2006, pp. 12028. © DEP ISSN 1824 - 4483 Annalisa Zabonati DEP n. 23 / 2013 Anderson Kay, A Walk on the Wild Side: A Critical Geography of Domestication, in “Progress in Human Geography”, XXI, 4, 1997, pp. 463-85. Bailey Cathryn, On the backs of animals: The Valorization of Reason in Contemporary Animal Ethics, in “Ethics & the Environment”, X, 1, 2005, pp. 1-17. Bailey Cathryn, We Are What We Eat: Feminist Vegetarianism and the Reproduction of Racial Identity, in “Hypatia”, XXII, 2, Spring 2007, pp. 39-59. Baricalla Vilma (a cura di), Animali ed ecologia in una rilettura del mondo al femminile, Oasi Alberto Perdisa, Ozzano dell’Emilia (BO) 2009. Battaglia Luisella, Femminismo e animalismo: una nuova alleanza?, in “Lares”, LXXIV, 1, gennaio-aprile 2008, s.p. Benney Norma, All of One Flesh: The Rights of Animals, in Reclaim the Earth: Women Speak out for Life on Earth, Caldecott Leonie-Leland Stephanie (eds.), Women’s Press, London 1983. Birke Lynda, Feminism, Animals and Science: The Naming Of the Shrew, OU, Buckingham 1994. Birke Lynda, Intimate Familiarities? Feminism and Human-Animal Studies, in “Society and Animals”, X, 4, 2002, pp. 429-436. Buettinger Craig, Women and Antivivisection in Late Nineteenth-century America, in “Journal of Social History”, XXX, Summer 1997, pp. 857-872. Bujok Melanie, Materialità corporea, ‘materiale-corpo’. Pensieri sull’appropriazione del corpo, di animali e donne, in “Liberazioni-Rivista di Critica Antispecista”, Antologia 1, 2005-2008, pp. 7-19. Castricano Jodey, The Question of the Animal: Why Now?, in “Topia. Canadian Journal of Cultural Studies”, 21, spring 2009, pp. 183-193. Clark Emily, “The Animal” and “The Feminist”, in “Hypatia”, XXVII, 3, August 2012, pp. 516-520. Clement Grace, The Ethic of Care and the Problem of Wild Animals, in “Between the Species”, 3, Aug. 2003, pp. 1-12. Cobbe Frances P., The Confession of a Lost Dog, Griffith & Farran, London 1867. Cobbe Frances P., The Antivivisection Question, Victoria Street Society for the Protection of Animals from Vivisection, United with the International Association for the Total Suppression of Vivisection, London 1884. Cobbe Frances P., The Future of the Lower Animals, Victoria Street Society for the Protection of Animals from Vivisection, London 1884. Cobbe Frances P., The Nine Circles; or, The Torture of the Innocent, Society for the Protection of Animals From Vivisection, London 1893. 124 Annalisa Zabonati DEP n. 23 / 2013 Collard Andrée - Contrucci Joyce, Rape of the World: Man’s Violence against Animals and the Earth, The Women’s Press, London 1988. Craighead Meinrad, The Feminist Connection, in “Vegetarian Times”, January 1991, pp. 59-80. Cudworth Erika, ‘Most farmers prefer Blondes’: The Dynamics of Anthroparchy in Animals’ Becoming Meat, in “Journal for Critical Animal Studies”, VI, 1, 2008, pp. 32-45. Dahles Heidi, Game killing and killing games: An Anthropologist Looking at Hunting in a Modern Society, in “Society and Animals”, I, 2, 1993, pp. 169-189. Davis Karen, Farm Animals and the Feminine Connection, in “The Animal's Agenda”, VIII, 1, 1988, pp. 38-39. Davis Karen, Prisoned Chickens, Poisoned Eggs: An Inside Look at the Modern Poultry Industry, Book Publishing Company, Summertown Tenn. 1996. Deckha Maneesha, The Salience of Species Difference for Feminist Theory, in “Hastings Women’s Law Journal”, XVII, 1, 2006, s.p. Deckha Maneesha, Disturbing Images PETA and the Feminist Ethics of Animal Advocacy, in “Ethics & the Environment”, XIII, 2, 2008, pp. 35-76. Deckha Maneesha, The Subhuman as a Cultural Agent of Violence, in “JCAS Journal for Critical Animal Studies”, VIII, 3, 2010, pp. 29-51. Deckha Maneesha, Toward a Postcolonial, Posthumanist Feminist Theory: Centralizing Race and Culture in Feminist Work on Nonhuman Animals, in “Hypatia”, XXVII, 3, Summer 2012, pp. 527-545 Dixon Beth A., The feminist connection between women and animals, in “Environmental Ethics”, XVIII, 2, 1996, pp. 181-194. Dixon Beth A., Animal Emotions, in “Ethics & the Environment”, VI, 2, Autumn 2001, pp. 22-30 Donovan Josephine, Animal rights and feminist theory, in “Signs”, XV, 2, 1990, pp. 350-375, trad. it. di Chiara Corazza, Diritti animali e teoria femminista, in “Dep”, 23, 2013. Donovan Josephine, Attention to Suffering: A Feminist Caring Ethic For The Treatment of Animals, in “Journal of Social Philosophy”, XXVII, 1, Spring 1996, pp. 81-102. Donovan Josephine, Feminism and the Treatment of Animals: From Care to Dialogue, in “Signs”, XXXI, 2, Winter 2006, pp. 305-329. Donovan Josephine-Adams Carol J. (eds), The Feminist Care Tradition in Animal Ethics, Columbia University Press, New York 2007. Dunayer Joan, In the Name of Science: The Language of Vivisection, in “Organization Environment”, 13, 2000, pp. 432-452. 125 Annalisa Zabonati DEP n. 23 / 2013 Dunayer Joan, Animal Equality-Language and Liberation, Ryce Pub., Derwood 2001. Dunayer Joan, Speciesism, Ryce Pub., Derwood 2004. Elston Mary Ann, Women and Antivivisection in Victorian England, 1870-1900, in Vivisection in Historical Perspective, Rupke Nicolas A. (ed.), Croom Helm, London 1987, pp. 259-294. Evans Rhonda-DeAnn K. Gauthier-Forsyth Craig J., Dogfighting: Symbolic Expression and Validation of Masculinity, in “Sex Roles”, 39, 1998, pp. 825–38. Ferguson Moira, Animal Advocacy and Englishwomen, 1780-1900: Patriots, Nation, and Empire, University of Michigan Press, Ann Arbor MI 1998. Finsen Susan, Making Ends Meet: Reconciling Ecoholism and Animal Rights Individualism, in “Between the Species”, IV, 1, 1988, pp. 11-20. Fitzgerald Amy J., The Emergence of the Figure of ‘Woman the Hunter’: Equality or Complicity in Oppression?, in “Wome’s Studies Quarterly”, XXXIII, 1/2, Spring-Summer, 2005, pp. 86-104. Fitzgerald Amy, Animal Abuse and Family Violence: Researching the Interrelationships of Abusive Power, Edwin Mellen Press, Lewinston N.Y. 2005. Gaard Greta (ed.), Women, Animals, Nature, Temple University Press, Philadelphia 1993. Gaard Greta, Women, Animals, and an Ecofeminist Critique, in “Environmental Ethics”, 18, 1997, pp. 440-443. Gaard Greta, Tools for a Cross-Cultural Feminist Ethics: Ethical Contexts and Contents in the Makah Whale Hunt, in “Hypatia”, XVI, 1, 2001, pp. 1-26. Gaard Greta, Ecofeminism on the Wing: Perspectives on Human-Animal Relations, in “Women & Environments”, 52/53, 2001, pp. 19-22. Gaard Greta, Vegetarian Ecofeminism: A Review Essay, in “Frontiers”, XXIII, 3, 2002, pp. 117-146. Gaard Greta, Ecofeminism revisited: Rejecting essentialism and re-placing species in a material feminist environmentalism, in “Feminist Formations”, XXIII, 2, 2011, pp. 26-53. Gaard Greta, Feminist Animal Studies in the U.S.: Bodies Matter, in DEP, 20, luglio 2012, pp. 14-21 (http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=138551). Gaard Greta, Speaking of Animal Bodies, in “Hypatia”, XXVII, 3, August 2012, pp. 520-526. Gaarder Emily, Women and the Animal Rights Movement, Rutgers University Press, Chapel Hill NC 2011. George Kathryn Paxton, Animal, Vegetable, or Woman? A Feminist Critique of Ethical Vegetarianism, SUNY Press, Albany 2000. 126 Annalisa Zabonati DEP n. 23 / 2013 Gheaus Anca, The Role of Love in Animal Ethics, in “Hypatia”, XXVII, 3, August 2012, pp. 583-600. Gillespie Kathryn, How Happy is Your Meat?: Confronting (Dis)connectedness in the ‘Alternative’ Meat Industry, in “The Brock Review”, XII, 1, 2011, pp. 100128. Gilman Perkins Charlotte, The Beast Prison, in “Forerunner”, 31, November 1912, pp. 128-30. Gilman Perkins Charlotte, Birds, Bugs and Women, in “Forerunner”, 4, May 1913, pp. 131-32. Glasser Carol L., Tied Oppressions: An Analysis of How Sexist Imagery Reinforces Speciesist Sentiment, in “The Brock Review”, XII, 1, 2011, pp. 51-68. Gruen Lori, Dismantling Oppression: An Analysis of the Connection Between Women and Animals, in Ecofeminism: Women, Animals, Nature, Gaard Greta (ed.), Temple University Press, Philadelphia 1993, pp. 60-90. Gruen Lori, On The Oppression of Women and Animals, in “Environmental Ethics”, 18, 1996, pp. 441-444. Gruen Lori, Ethics and Animals, Cambridge University Press, Cambridge 2011. Gruen Lori – Weil Kari (eds.), Animal Others, in “Hypatia”, XXVII, 3, August 2012, pp. III–IV, 477–700. Haraway Donna, Primate Visions: Gender, Race and Nature in the World of Modern Science, Routledge, New York 1989. Haraway Donna, The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness, Prickly Paradigm Press, Chicago 2003. Haraway Donna, When Species Meet, University of Minnesota Press, Minneapolis 2008. Harper Amie Breeze, Race as a ‘Feeble Matter’ in Veganism: Interrogating whiteness, geopolitical privilege, and consumption philosophy of ‘cruelty-free’ products, in “JCAS - Journal for Critical Animal Studies”, VIII, 3, 2010, pp. 5-28. Harper Amie Breeze (ed.), Sistah Vegan: Food, Identity, Health, and Society: black female vegans speak, Lantern Books, New York 2010. Hawkins Ronnie Zoe, Ecofeminism and Nonhumans: Continuity, Difference, Dualism, and Domination, in “Hypatia”, XIII, 1, 1998, pp. 158-197. Hoffman Merle, Do Feminists Need to Liberate Animals Too?, in “On The Issues Magazine”, Spring 1995, pp. 1-8. Houston Pam (ed.), Women on Hunting, Ecco Press, Hopewell, NJ 1995. Jones Pattrice, Violation & Liberation Grassroots Animal Rights Activists Take on Sexual Assault, in http://www.earthfirstjournal.org/article.php?id=247, s.d. 127 Annalisa Zabonati DEP n. 23 / 2013 Jones Pattrice, Their Bodies, Our Selves: Moving Beyond Sexism and Speciesism, in “Satya Magazine”, january 2005. Jones Pattrice, What's wrong with rigths?, in “Satya Magazine”, october 2005. Jones Pattrice, Fear of Feeling: Trauma and Recovery in the Animal Liberation Movement, in “Satya Magazine”, June-July 2005. Jones Pattrice, Of Brides and Bridges: Linking Feminist, Queer, and Animal Liberation Movements, in “Satya Magazine”, june-july 2005, trad. it. Unioni e ponti le connessioni tra i movimenti femministi, queer e di liberazione animale, in http://anguane.noblogs.org/?p=198, 2011. Jones Pattrice, Fighting cocks: ecofeminism versus sexualized violence, in Sister Species: Women, Animals and Social Justice, Kemmerer Lisa A (ed.), University of Illinois Press, Chicago 2011, pp. 45-56. Kalechofsky Roberta, Methaphors of Nature: Vivisection and Pornography – The Manichean Machine, in “Between the Species”, IV, 3, 1988, pp. 179-185. Kalof Linda-Fitzgerald Amy-Baralt Lori, Animals, Women, and Weapons: Blurred Sexual Boundaries in the Discourse of Sport Hunting, in “Society and Animals”, XII, 3, 2004, pp. 237-251. Kemmerer Lisa A., Hunting Tradition: Treaties, Law, and Subsistence Killing, in “Animal Liberation Philosophy and Policy Journal”, II, 2, 2004, pp. 1-2. Kemmerer Lisa A., Speaking Up for Animals: An Anthology of Women's Voices, Paradigm Publishers, Boulder, CO 2011. Kemmerer Lisa A. (ed.), Sister Species. Women, Animals and Social Justice, University of Illinois Press, Chicago 2011. Kheel Marti, The Liberation of Nature: A Circular Affair, in “Environmental Ethics”, 7, Summer 1985, pp. 135-149. Kheel Marti, Speaking the Unspeakable: Sexism in the Animal Rights Movement, in “Feminists for Animal Rights Newsletter”, 2, Summer/Fall 1985, pp. 1–7, trad. it., Dire l'indicibile: il sessismo nel movimento per i diritti animali, http://anguane.noblogs.org/?p=987. Kheel Marti, An/Aesthetics: The Re-Presentation of Women and Animals, in “Between the Species”, 1, Spring 1985, pp. 37-45. Kheel Marti, Animal Liberation Is a Feminist Issue, in “The New Catalyst Quarterly”, 10, Winter 1988, pp. 8-9. Kheel Marti, Liberazione animale ed etica ambientale: può l’ecofemminismo accorciare le distanze?, trad. it. di Cavalieri Paola, in “Etica & Animali”, II, 1, primavera 1989, pp. 46-52. Kheel Marti, The Killing Game: An Ecofeminist Critique of Hunting, in “Journal of the Philosophy of Sport”, XXIII, 1, 1996, pp. 30-44. 128 Annalisa Zabonati DEP n. 23 / 2013 Kheel Marti, Animal Husbandry: Time for Divorce, in “Feminists for Animal Rights Semiannual Publication”, 12, Autumn 2000/Winter 2001. Kheel Marti, Vegetarianism and Ecofeminism: Toppling Patriarchy with a Fork, in Food for Thought: The Debate over Eating Meat, Sapontzis Steve (ed.), Prometheus Books, Amherst, N.Y. 2004, pp. 327-341. Kheel Marti, Direct Action and the Heroic Ideal: An Ecofeminist Critique, in Igniting a Revolution: Voices in Defense of the Earth, Nocella Anthony J. - Best Steve (eds), AK Press, Oakland-CA 2006, pp. 306-318. Kheel Marti, Nature Ethics: An Ecofeminist Perspective, Rowman & Littlefield, Lanham 2008. Kingsford Anna B., The Perfect Way in Diet, Kegan, Trench & Co., London 1881. Kingsford Anna B., The Uselessness of Vivisection, in “Nineteenth Century”, February 1882, pp. 171-183. Kruse Corwin R., Gender, Views of Nature, and Support for Animal Rights, in “Society and Animals”, VII, 3, 1999. pp. 179-198. Lansbury Coral, The Old Brown Dog: Women, Workers, and Vivisection in Edwardian England, University of Wisconsin Press, Madison WI 1985. Leneman Leah, The Awakened Instinct: Vegetarianism and the Women's Suffrage Movement in Britain, in “Women’s History Review”, VI, 2, 1997, pp. 271287. Lind-af-Hageby-Emilie Augusta Louise “Lizzy”, The Shambles of Science; Extracts from the Diary of Two Students of Physiology, E. Bell, London 1903. Lind-af-Hageby-Emilie Augusta Louise “Lizzy” (ed.), The Animal’ Cause. A Selection of Papers Contributed to the International Anti-Vivisection and Animal Protection Congress-London, July 6th-10th, 1909, Animal Defence & AntiVivisection Society, London 1911. Lind-af-Hageby-Emilie Augusta Louise “Lizzy”, The New Morality: An inquiry into the Ethics of Anti-vivisection, Animal Defence and Anti-Vivisection Society, London 1911. Lind-af-Hageby-Emilie Augusta Louise “Lizzy”, On Immortality: A Letter to a Dog, Lind-af-Hageby, London 1916. Lind-af-Hageby-Emilie Augusta Louise “Lizzy”, Cruel Experiments on Dogs and Cats Performed in British Laboratories, Animal Defence and Anti-Vivisection Society, London 1927. Lind-af-Hageby-Emilie Augusta Louise “Lizzy”, Vivisection and Medical Students: A Public Scandal and a Disgrace, Animal Defence and Anti-Vivisection Society, London 1930. 129 Annalisa Zabonati DEP n. 23 / 2013 Lind-af-Hageby-Emilie Augusta Louise “Lizzy”, Bombed Animals-Rescued Animals-Animals Saved from Destruction. Typical Cases from the Records of the Animal Defence Society’s War Work and Some Comment, Animal Defence & AntiVivisection Society, London 1941. Lind-af-Hageby-Emilie Augusta Louise “Lizzy”, Introductory Commentary on Civilsation, “Charity” and Justice to Animals, etc., Animal Defence & AntiVivisection Society, London 1953. Liszt Amy, Animal Liberation as a Valid Response to Structural Violence, in “Between the Species”, Fall 1990, pp. 163-169. Lucas Sheri A., A Defense of the Feminist-Vegetarian Connection, in “Hypatia”, XX, 1, winter 2005, pp. 150-177. McKenna Erin, Feminism and Vegetarianism: A Critique of Peter Singer, in “Philosophy in the Contemporary World”, I, 3, 1994, pp. 28-35. MacKinnon Catharine A., Of Mice and Men: A Feminist Fragment on Animal Rights, in Animal rights: Current Debates and New Directions, Sunstein Cass R.Nussbaum Martha C. (eds.), Oxford University Press, New York 2004, pp. 263276. Mannucci Anna, La donna dei gatti: Dalla gattara anomica alla tutor della legge “281, in “La Ricerca Folklorica”, 48, 2003, pp. 99-117. Midgley Mary, Animals and Why They Matter, The University of Georgia Press, Athens GA 1993. Milliet Jacqueline, Ya-t-il une domestication feminine? Les exemples du porce et du chien, in ”Ecologie h umaine”, XII, 2, 1994, pp. 65-82. Milliet Jacqueline- Casciarri Barbara, Il mito scientifico dell’ammansimento degli animali da parte delle donne, in “La Ricerca Folklorica”, 40, 1999, pp. 6572. Munro Lyle, Caring about Blood, Flesh, and Pain:Women’s Standing in the Animal Protection Movement, in “Society & Animals”, IX, 1, 2001, pp. 43-61. Noske Barbara, Humans and Other Animals – Beyond the Boundaries of Anthropology, Pluto Press, London 1989. Nussbaum Martha C., Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership, Harvard University Press, Cambridge Mass 2006. Parsons Rhea (ed.), Women, Food and Consumption, in “MP: An Online Feminist Journal”, III, 3, Winter 2011, pp. 1-84. Peek Charles W.-Bell Nancy J.-Dunham Charlotte C., Gender, Gender Ideology, and Animal Rights Advocacy, in “Gender & Society”, X, 4, August 1996, pp. 464-478. Pink Sarah, Women and Bullfighting: Gender, Sex and the Consumption of Tradition, Berg, Oxford 1997. 130 Annalisa Zabonati DEP n. 23 / 2013 Luhar Evelyn, Beyond Prejudice: The Moral Significance of Nonhuman Animals, Duke University Press, Durham 1995. Plumwood Val, Integrating Ethical Frameworks for Animals, Humans and Nature: A Critical Feminist Eco-Socialist Analysis, in “Ethics & the Environment”, 5, 2000, pp. 285-322. Puleo Alicia H., Feminismo y tauromaquia, in “El viejo topo”, 195-196, 2004, pp. 72-77. Romain Dianne, Feminist Reflections on Humans and Other Domestic Animals, in “Between the Species”, Fall 1990, pp. 213-218. Rossini Manuela, To the Dogs: Companion Speciesism and the New Feminist Materialism, in “Kritikos”, III, September 2006, pp. 1-15. Ruether Rosemary R., Men, Women, and Beasts. Relations to Animals in Western Culture, in “Between the Species”, Summer 1992, pp. 136-141. Salamone Constantia, The Prevalence of the Natural Law: Women and Animal Rights, in Reweaving the Web of Life: Feminism and Nonviolence, McAllister Pam (ed.), New Society, Philadelphia 1982, pp. 364-375. Slicer Deborah, Your Daughter or Your Dog? A Feminist Assessment of the Animal Research Issue, in Ecological Feminist Philosophies, in “Hypatia”, VI, 1, 1991, pp. 108-124. Smith-Harris Tracey, Bringing Animals Into Feminist Critiques of Science, in “Canadian Woman Studies – Les Cahiers de la Femme”, XXIII, 1, 2003, pp. 85-89. Socha Kim, Women, Destruction, and the Avant-Garde: A Paradigm for Animal Liberation, Rodopi, Amsterdam & New York 2011. Spiegel Marjorie, The Dreaded Comparison: Human and Animal Slavery, Mirror Books, 1996. Yarbrough Anastasia-Thomas Susan (eds.), Women of Color in Critical Animal Studies, in “JCAS - Journal for Critical Animal Studies”, VIII, 3, 2010, pp. 1-69. Ward Stuart Phelps Elizabeth, Trixy, The Riverside Press, Boston & New York 1904. Warkentin Traci, Interspecies Etiquette. An Ethics of Paying Attention to Animals, in “Ethics & The Environment”, XV, 1, 2010, pp. 101-121. Weil Kari, A Report on the Animal Turn, in “Differences”, XXI, 2, 2010, pp. 123. Wellington Alex, Response: Feminist Positions on Vegetarianism: Arguments For and Against and Otherwise, in “Between the Species”, summer & fall 1995, pp. 98-104. Westra Laura, Animal Ethics, Biocentric Environmental Ethics and Feminism, in “Between the Species”, IV, 3, 1988, pp. 186-190. 131 Annalisa Zabonati DEP n. 23 / 2013 Zabonati Annalisa, Ecofemminismo e questione animale: una introduzione e una rassegna, in DEP, 20, 2012, pp. 171-188, http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=139007. Zahava Irene (ed.), Through Other Eyes: Animal Stories by Women, Crossing, Freedom CA 1988 Sitografia Siti personali Carol J. Adams – sito in cui descrive il percorso personale come attivista ecofemminista e studiosa indipendente, con un elenco delle sue pubblicazioni. http://www.caroljadams.com/ì Greta Gaard – sito in cui trovare informazioni e materiali sull’ecofemminismo animalista e vegano. http://gretagaard.efoliomn.com/ Breeze A. Harper – presentazione del progetto “Sistah Vegan”, che promuove l’ecofemminismo vegano nero. http://breezeharper.tripod.com/research/Home.html pattrice jones – sito che ospita oltre alla sua biografia, materiali e documenti da lei prodotti. http://www.pattricejones.info/about.html Marti Kheel – presenta la sua biografia, le pubblicazioni e le recensioni al suo ultimo lavoro Nature Ethics. http://martikheel.com/ Vegina - Sito femminista vegano che propone articoli sui temi della relazione tra i generi e tra gli umani e gli animali. http://vegina.net/ Siti specifici Challenge Oppression. Sito che propone riflessioni sulle oppressioni e le ingiustizie contro gli animali non umani, gli umani e la terra da un punto di vista ecofemminista vegano. http://challengeoppression.com/category/feminism-sexism/ 132 Annalisa Zabonati DEP n. 23 / 2013 Feminists for Animal Rights (FAR) – Sito del collettivo attivo dal 1981 al 2001, che ospita materiali e documenti del gruppo. http://www.farinc.org/ OneFight – Sito di divulgazione e promozione del pensiero e della pratica anarco-ecofemminista vegana. http://onefight.org/ Vine Sanctuary – Sito dell’omonimo rifugio in cui sono ospitati specialmente polli salvati da allevamenti e galli da combattimento recuperati. http://vine.bravebirds.org/ LGBT Compassion – Sito dedicato alla riflessione LGBT e le connessioni delle oppressioni tra genere, orientamento sessuale e altro-da-umani. http://www.lgbtcompassion.org/ Queering Animal Liberation – Progetto di antologia “in progress” che abbraccia i temi della liberazione animale con la liberazione umana, attraverso la lente della teoria queer. I fondatori e le fondatrici del progetto sono Kim Stallwood, Pattrice Jones, Olivia Lane. http://queeranimals.wordpress.com/about/ United Poultry Concern – Associazione fondata da Karen Davis, sito di riferimento per i rifugi per animali da “reddito” statunitensi con una ricca pagina di web links http://www.upc-online.org/ Siti in lingua italiana Anguane – Sito del collettivo omonimo che offre materiali e documenti originali e in traduzione da altre lingue sui temi dell’ecofemminismo animalista e vegano. https://anguane.noblogs.org/ Dumbles – Sito ecofemminista che presenta delle riflessioni sull’ecologia sociale, l’ecofemminismo, l’antispecismo e il rapporto con gli animali. http://dumbles.noblogs.org/?s=animal “Musi e Muse” – Rivista on line di riflessioni sulle relazioni tra umani e animali secondo un’ottica di genere. http://musiemuse.wordpress.com/ 133 “Hypatia. A Journal of Feminist Philosophy”, Special Issue: Animal Others, August 2012, XVII, 3, pp. iii-iv, 477-700, editors: Lori Gruen and Kari Weil. Hypatia, rivista di filosofia femminista in lingua inglese, dalla metà degli anni ‘80 è una fucina di idee e proposte di analisi su molti temi di carattere teorico che affronta in una prospettiva multidisciplinare. Come afferma Sally Scholz nella presentazione della rivista, Hypatia è un luogo di riflessione sui diversi aspetti del femminismo, sulle esperienze e le pratiche delle donne, sulle questioni di genere. Nel marzo 1991 la rivista ha dedicato un numero speciale all’ecofemminismo1, favorendone la diffusione di teorie e prassi. In quelle pagine erano già presenti i temi delle relazioni tra ecofemminismo, animali e animalismo e dell’etica della cura. Nell’agosto 2012 è apparso un numero speciale dal titolo Animal Others, che ha come tema il femminismo e la questione animale. Lori Gruen e Kari Weil, note per i loro studi nell’ambito dell’ecofemminismo e degli “Animal Studies”, ne sono le curatrici. Il fascicolo è dedicato a Marti Kheel, una tra le ecofemministe animaliste di maggior rilievo scomparsa nel 20112. In questa scheda ci proponiamo di illustrare la ricchezza dei temi affrontati nel modo più dettagliato possibile. Animal Others raccoglie i contributi del simposio Feminists encoutering Animals, tenutosi nel luglio 2012 e della conferenza dal titolo Sex/Gender/Species, del febbraio 2011. Le curatrici del volume hanno proposto alla riflessione i seguenti quesiti: - Gli Animal Studies hanno una prospettiva di genere? E se sì, con quali effetti? - La cosiddetta “teoria” animale è in disaccordo con le emozioni e/o l’impegno politico femminista? Negli “Animal Studies” c’è uno scarto tra il personale e il politico (o teoretico)? E se sì, come si presenta? - Gli “Animal Studies” hanno trascurato o non riconosciuto le intuizioni femministe ed ecofemministe? E, se è accaduto, cosa è andato perduto e cosa si può fare per recuperare queste intuizioni? (p. 492). Nonostante dal simposio siano emerse posizioni diverse, vi è stata un’ampia convergenza sulla necessità di mantenere l’impegno politico ed etico femminista negli “Animal Studies”. Il femminismo diviene pertanto un impegno reale e concreto nelle relazioni con gli altri animali, attraverso interpretazioni intersezionali3, che sono il punto nodale di quelli che Gruen e Weil considerano il “common concern”, ovvero la relazione tra la teoria e la pratica, questione cruciale per il femminismo fin dal suo nascere. 1 Hypatia – A Journal of Feminist Philosophy, Special Issue: Ecological Feminism, VI, 1, 1991. Su Marti Kheel e la sua critica al movimento ambientalista e di liberazione animale si veda la recensione della sua opera principale preceduta da un breve profilo biografico in questo numero di DEP. 3 L’intersezionalità è una teoria che esamina la natura delle identità sociali e delle relazioni di potere, il modo in cui queste si generano, si intrecciano e si influenzano e le gerarchie che creano. Essa offre la possibilità di comprendere in profondità i modi con i quali si esercita l’oppressione. 2 © DEP ISSN 1824 - 4483 Hypatia DEP n. 23 / 2013 Apre il numero il contributo di Kelly Oliver, Ambivalence Towards Animals and The Moral Community. L’autrice si interroga sulle ragioni dell’ambivalenza nella considerazione degli animali all’interno della comunità morale; se infatti da un lato essi appaiono come soggetti innocenti, dall’altro sono visti come mostri minacciosi da cui difendersi. Una ambivalenza che l’autrice fa risalire alla loro condizione di appendici, individui esterni alla società. L’intervento di Traci Wakentin, Must Every Animal Studies Scholar Be Vegan?, prende avvio dalla progressiva diffusione del veganismo o del vegetarismo tra attivisti/e e studiosi/e ambientalisti/e, ecologisti/e ed eco-femmiste, come espressione di un imperativo morale che riconosce alle scelte di vita una importanza politica (p. 500). Scelte che tuttavia sollevano dilemmi e controversie di non facile soluzione. Oggetto di controversia, ad esempio, specialmente negli Stati Uniti, è la questione legata alla produzione della soia, elemento essenziale della dieta vegana/vegetariana, appannaggio quasi esclusivo della Monsanto, nota multinazionale agroalimentare che adotta politiche economiche ed imprenditoriali neoliberiste che si fondano sugli OGM e impongono i loro semi sterili ai contadini di tutto il mondo, come da anni denuncia Vandana Shiva. D’altro canto, la produzione zootecnica industrializzata, che reifica e “meccanizza” gli animali, utilizza altresì manodopera sottopagata di immigrati clandestini. Pertanto, produzione alimentare e scelte che riguardano la dieta sono strettamente connesse all’oppressione delle donne, degli animali, della natura e di altri gruppi umani marginali. Pertanto Wakentin auspica che gli “Animal Studies” incontrino l’ecofemminismo, per troppo tempo escluso dagli ambienti accademici. Stephanie Jenkins, in Returning the Ethical and Political to Animal Studies, richiama l’attenzione sulle pratiche femministe e ne sottolinea l’importanza al fine di superare il dualismo ontologico nell’etica. E ciò per avvicinarsi ad una visione compassionevole degli animali, soggetti vulnerabili ed inestimabili. Anche Jenkins afferma la necessità del veganismo come etica femminista non violenta benché, avverte l’autrice, essa non sia sufficiente in una prospettiva di liberazione. Questa scelta, ovvero il rifiuto dell’idea che alcuni soggetti siano sopprimibili, proviene da un “imperativo corporeo” (p. 505) in risposta all’altrui sofferenza. Anche la critica radicale alla domesticazione come forma di violenza, aggiunge l'autrice, dovrebbe essere oggetto della riflessione femminista e degli “Animal Studies”. Sul tema del difficile incontro tra femminismo e “Animal Studies” è intervenuta anche Carrie Rohman in Disciplinary Becomings: Horizons of Knowledge in Animal Studies. Le studiose in questo settore di studi, infatti, talora deplorano il dominio maschile in ambito accademico, che lo ha reso un “circolo maschile” (p. 513). La critica femminista, conclude Rohman, potrebbe ampliarne gli orizzonti degli “Animal Studies” e dare nuovo impulso alla ricerca. Anche Emily Clark in “The Animal” and “The Feminist” avanza altre ragioni in favore dell’inclusione di una prospettiva femminista negli “Animal Studies”. Le femministe, infatti, scrive l’autrice, sanno di che cosa si sta parlando quando si tocca il tema del corpo e ne conoscono l’ importanza dal punto di vista teorico. Ma è altrettanto necessario che le femministe animaliste si rivolgano a quelle femministe che ancora non considerano rilevanti i temi legati agli animali e allo specismo e trascurano i collegamenti tra le differenze di specie e quelle di genere. Una rifles135 Hypatia DEP n. 23 / 2013 sione critica sull’umano e sull’umanismo, è più che mai urgente poiché, attraverso la sua attenzione solo per l’umano, e senza attenzione all’intreccio delle forme di dominio, il femminismo rischia di sostenere l’intero sistema gerarchico oppressivo, senza scalfirlo. Il tema del corpo è centrale anche nell’intervento di Greta Gaard4, Speaking of Animal Bodies. Dopo aver riaffermato la centralità del corpo nella riflessione femminista, ricorda che è a partire dal corpo che le donne riconoscono la propria posizione marginale e la loro oppressione sociale e politica. Ricorda inoltre che la consapevolezza del nesso liberazione delle donne e liberazione di tutti viventi è presente fin dagli albori del femminismo. Anche Gaard rileva il tentativo di “femminilizzare” il movimento animalista, screditando gli aspetti affettivi ed emozionali delle attiviste, già descritte da Peter Singer, come quelle “anziane signore emotive in scarpe da tennis”; anch’essa rileva la difficoltà di far entrare la questione animale nel mondo accademico, e il pervicace antropocentrismo delle femministe, oltre alla manifesta diffidenza verso la questione tra gli ambientalisti e gli ecologisti neri, almeno fino a tempi molto recenti. Corpi e soggetti nella loro pluralità devono quindi restare saldamente al centro della riflessione teorica e della prassi quotidiana. Gaard in conclusione auspica la trasmissione del sapere oramai ultradecennale delle ecofemministe animaliste vegane: l’ascolto attento ed empatico, la disantropocentrizzazione, l’assunzione di responsabilità personale e politica nei confronti degli animali. Il numero prosegue con la rubrica dedicata ai saggi. Il primo contributo è quello di Maneesha Deckha Toward a Postcolonial, Posthumanist Feminist Theory: Centralizing Race and Culture in Feminist Work on Nonhuman Animals, in cui l’autrice analizza la teoria femminista postumanista, un approccio utile per la lettura delle interconnessioni tra genere, specie e marginalità, ma che può apparire debole ed esposta all’essenzialismo, all’etnocentrismo e all’elitarismo. Infatti, centrando l’attenzione solo sul genere si escludono tutti gli aspetti inerenti la razza, la classe, la specie, che invece devono essere considerati elementi basilari delle oppressioni. Deckha sostiene che la razza e la cultura, non meno del genere, sono elementi importanti nella determinazione dell’oppressione specista. Il femminismo postumanista, conclude, potrebbe trarre vantaggio dall’utilizzo delle teorie intersezionali per affrontare la questione animale da un’ottica postcoloniale. Ruth Lipschitz, nel saggio Skin/ned Politics: Species Discourse and the Limits of “The Human” in Nandipha Mntambo’s Art, osserva la questione femminismo e animalismo dalla particolare prospettiva dell’arte. Il saggio analizza le opere dell’artista sudafricana Nandipha Mntambo e ne individua le modalità discorsive. Emergono i temi del carnofallologocentrismo (Jacques Derrida), della violenza colonialista (Achille Mbembe) e la teoria dell’abieazione (Julia Kristeva). Le opere di Mntambo presentano un’animalità trasgressiva che colloca l’umano originario nell’alveo della naturalità primeva, accentuando lo “scandalo” del mangiare l’altro. Queste opere rendono ambiguo il confine che separa l’umano dall’animale, il limite 4 Di Greta Gard, tra le ecofemministe animaliste vegane di maggior spicco, il numero 20 di DEP, dedicato all’ecofemminismo, ha ospitato il saggio Feminist Animal Studies in the U.S.: Bodies Matter, (http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=138551). 136 Hypatia DEP n. 23 / 2013 tra corpi edibili e inedibili e toccano la questione del comportamento alimentare nelle sue sfaccettature simboliche e reali. Il saggio di James Stanescu, Species Trouble: Judith Butler, Mourning, and the Precarious Lives of Animals, prende le mosse dalle opere di Judith Butler e si sofferma sugli “Animal Studies” queer e femministi che enfatizzano la comune finitezza corporea tra umani e nonumani. Il pensiero antropocentrico, infatti, può essere sovvertito anche riconoscendo il lutto verso gli animali come un atto politico. Il bancone del macellaio diviene il luogo fisico e simbolico della sovraesposizione di pezzi non ricondotti all’unità dei corpi, evitando la consapevolezza che si tratta di corpi vissuti e morti nella sofferenza, placando colpe e responsabilità. Rinunciando alla pratica del disconoscimento si può entrare nella “comunità delle precarietà condivise”, rifiutare la complicità nella devastazione e nella sofferenza, esprimere quel rispetto che si manifesta nei riti di riconoscimento dell’altro da sé, come il lutto, che accoglie e raccoglie memorie e storie. Anca Gheaus affronta il tema dei sentimenti verso gli animali con un suo saggio dal titolo The Role of Love in Animal Ethics. Gli aspetti relazionali e affettivi possono, a suo avviso, entrare a pieno titolo in un’etica in grado di rifondare le relazioni tra gli umani e tra gli umani e gli animali. Grande rilievo ha la posizione di Raimond Gaita che enfatizza l’importanza delle connessioni emotive tra creature che hanno bisogni relazionali e affettivi simili, all’interno dell’orizzonte dell’etica della cura. Gheaus propone un’ “etica del bisogno” guidata dai principi della solidarietà e della reciprocità, in cui l’amore unisce e crea le basi per una diversa considerazione dei nonumani e delle relazioni che intratteniamo con loro. Ne discende che definire gli animali come portatori di interessi morali ha forti ripercussioni sulla nostra visione dell’etica. Kathy Rudy, LGBTQ…Z?, affronta il tema della bestialità/zoofilia nella cornice della teoria femminista queer, per proporre una nuova forma di animalismo, che potrebbe essere definito amore per gli animali e che si fonda sulla consapevolezza della forza rivoluzionaria dell’amore. Le terribili condizioni di vita e di morte di milioni di animali in America hanno assunto un aspetto inquietante. Gli animali, non solo sono carne da macello, ma sono mezzi “meccanici” per raggiungere scopi utilitaristici ed equivoci, come la vivisezione, i circhi, etc.. È tempo di proporre un’analisi critica della modernità e delle sue aberrazioni in cui umani e animali sono prigionieri. Più che risposte scaturiscono domande su quale forma d’amore si possa esprimere nei confronti degli animali mettendo radicalmente in discussione il nostro consueto modo di pensare. Susan McHugh in Bitch, Bitch, Bitch: Personal Criticism, Feminist Theory, and Dog-writing, esplora la scrittura femminile, letteraria ed accademica, in cui compaiono gli animali. In molti casi si è imbattuta nella figura del cane, per lo più femmina, scelto come compagno di vita, una scelta che le è apparsa una sorta di reazione all’imperante androcentrismo. Autrici come Caroline Knapp, Deirdre McLoskey, Alice Kuzniar e Donna Haraway, descrivono le proprie esperienze, le proprie riflessioni sulla speciale relazione con le loro compagne animali. Nelle narrazioni della propria vita con i cani, specie se femmine, emergono modelli nuovi di intimità e condivisione, affiora la vicinanza, non la differenza, tra umani e animali in cui il corpo è sempre centrale. 137 Hypatia DEP n. 23 / 2013 Irina Aristarkhova in Thou Shall Not Harm All Living Beings: Feminism, Jainism, and Animals propone l’accoglimento del concetto jainista di non danneggiamento come concetto filosofico femminista al fine di introdurre modifiche sostanziali nei nostri rapporti con gli altri esseri viventi. L’etica della cura, al centro di molte riflessioni ecofemministe animaliste, può trasformarsi in quella che Aristarkhova definisce l’etica del rispetto e del non possesso, a partire dalla pratica del non cibarsi di animali. Nelle nostre società, com’è noto, il principio di non uccidere è applicato solo agli umani e, solo in particolari circostanze, agli animali. Le implicazioni etiche, giuridiche, sociali, politiche e financo filosofiche sono immense. Non sono più accettabili, conclude l’autrice, le disquisizioni sul grado di violenza consentito, si deve assumere un diverso orientamento che rifiuti la violenza verso tutte le creature. Inoltre, integrando l’etica femminista della cura con quella jainista del rispetto e della nonviolenza si apre la strada ad un profondo cambiamento, nei confronti degli animali e degli umani stessi tra di loro. Come si augura Aristarkhova, è un progetto femminista che dalla cura va verso la responsabilità. Il saggio Intimate Bureaucracies: Roadkill, Policy, and Fieldwork on the Shoulder di Alexandra Koelle chiude la sezione Articles. Koelle afferma che da oltre vent’anni, naturalisti ed esperti di logistica lavorano con i gruppi ambientalisti, le amministrazioni statali e i governi tribali per cercare di mitigare gli effetti dell’antropizzazione in vaste aree dove sono presenti molti animali selvatici. Un’ecologia di “strada”, come la chiama Koelle, che può e deve intrecciarsi con il pensiero e la pratica femministe. I naturalisti hanno il compito di contare, riconoscere e catalogare le tracce lasciate sul terreno dagli animali, producendo quelle che Koelle chiama le “burocrazie intime”. Una tale procedura ha diverse implicazioni sugli animali. Molto spesso i rapporti che ne scaturiscono provengono dall’osservazione delle collisioni tra i veicoli e gli animali e mirano all’adozione di contromisure per ridurre l’impatto di questi incidenti. Rimangono fuori da questi “rilevamenti” tutti i piccoli animali, quali piccoli mammiferi, tartarughe, uccelli, rane e sono addirittura inesistenti gli insetti e gli invertebrati. I metodi effettivamente utilizzati per ridurre la morte degli animali sulle strade sono spesso insignificanti. Gli inviti ai comportamenti attentivi possono essere utili per allungare le distanze tra l’ostacolo e il veicolo. Ma quegli ostacoli, che possono diventare corpi morti, devono riacquisire la sostanza dell’individualità e attivare procedure di attenzione e rispetto per ogni essere vivente. Rimane purtroppo il senso di violenza e al contempo di impotenza che l’invasione umana produce. Ciò che può essere realizzato è quanto meno il recupero degli animali incidentati o dei loro corpi straziati, testimonianza diretta di un principio cardine: il riconoscimento e la condivisione della sofferenza. Erika Battocchio-Annalisa Zabonati 138 Women of Color in Critical Animal Study, “Journal of Critical Animal Study”, VIII, 3, 2010. Il Journal for Critical Animal Studies (JCAS) ha dedicato un numero speciale al contributo delle donne di colore alla questione animale, prospettiva perlopiù assente nella maggior parte degli studi vegan e animalisti. Women of Color in Critical Animal Studies è stato coordinato da Anastasia Yarbrough, scrittrice, naturalista, attivista per i diritti animali, e da Susan Thomas, direttrice del Gender and Women’s Studies, docente presso la facoltà di Scienze Politiche e Studi di Genere della Hollins University. Women of Color raccoglie due saggi: Race as a “Feeble Matter” in Veganism: Interrogating witheness, geopolitical privilege, and consumption philosophy of cruelty-free products, di Amie Breeze Harper, e The Subhuman as a Cultural Agent of Violence di Maneesha Decka. Ad essi si aggiunge la testimonianza di Claudia Serrato, Ecological Indigenous foodways and the healing of all our relations, un’intervista alla femminista anarchica, attivista per i diritti animali Sarat Colling, a cura di Laura Shields, e la recensione del libro Sistah Vegan a cura di Anastasia Yarbrough. Breeze Harper, fondatrice del progetto Sistah Vegan, ha studiato l’influenza che razza, genere, classi sociali e geografia esercitano sulla relazione con il cibo, sulla sua percezione e sulle abitudini alimentari. In Race as a “Feeble Matter” Harper individua e mette in discussione il “privilegio bianco” nella filosofia e nelle comunità vegan, con l’obiettivo di rilevare l’importanza della questione razziale all’interno del discorso animalista e vegano. L’autrice mette in rilievo che i movimenti per i diritti animali, la filosofia e la pratica alimentare vegana siano per lo più diffusi tra i bianchi appartenenti alla classe media. La principale corrente vegan, infatti, dedica spazio quasi esclusivamente alla “whiteness”, che rende invisibile la questione della razza. Il razzismo non dovrebbe esistere in una società “post-razziale”, eppure negli attivismi più radicali permangono epistemologie sociali e spaziali “bianche”. Breeze Harper parla dunque di “ignoranza bianca” e “supremazia bianca” nei processi di produzione di prodotti vegan; processi che ricorrono a sistemi consumistici e di sfruttamento della forza-lavoro, frutto di una logica di dominio entro un sistema capitalistico globale. Infatti, sostiene Harper, il bracciante haitiano di colore che lavora nell’estrazione dello zucchero di canna, i bambini costretti a lavorare in Costa d’Avorio nella produzione del cacao e i minori sfruttati nelle industrie tessili in Uzbekistan sono difficilmente ascoltati dai “consumatori” vegani bianchi. La questione razziale non può pertanto essere “flebile” nel discorso vegano e animalista, in quanto il consumo di prodotti cruelty-free è contraddittorio, se privo della consapevolezza della fatica e del lavoro di molte persone, costrette in ad accettare condizioni miserrime se non addirittura di schiavismo. Si rende perciò necessario ripensare criticamente la percezione di razza, per riconoscere le implicazioni di ingiustizia sociale, che anche la pratica vegana e l’attivismo per i diritti animali possono presentare. Nel saggio The Subhuman as a Cultural Agent of Violence Maneesha Deckha, docente presso l’University of Victoria Faculty of Law in Canada, analizza la pra© DEP ISSN 1824 - 4483 Women of Color in Critical Animal Studies DEP n. 23 / 2013 tica della violenza di genere, razzista ed economica, a partire dal concetto di “subumano”, che rende inferiore “l’altro” e “il diverso”, e “giustifica” la violenza maschile-maschilista all’interno della logica binaria, così come è stato sottolineato nel pensiero femminista. Maneesha Deckha analizza tre casi studio: il lavoro forzato, i campi militarizzati e le leggi di guerra. In questo saggio l’autrice mette in discussione la centralità di alcuni valori antropocentrici, inclusi i diritti umani e la dignità umana, e afferma l’urgente necessità di trovare una discorsività alternativa alla disumanizzazione degli umani e all’inferiorizzazione dei nonumani. L’esistenza di luoghi di sofferenza e tortura per gli animali, come i macelli, in cui ogni giorno solo negli Stati Uniti sono uccisi 9,5 miliardi di animali, giustifica l’esercizio della violenza entro il limite della “sofferenza necessaria”, distinta dalla “sofferenza non necessaria”, identificata come crudeltà. Perciò, nonostante nella società contemporanea non siano più ammissibili, ad esempio, alcuni comportamenti cruenti contro gli animali, in modo occulto si promuove una violenza sistematica ed industrializzata, come quella che si consuma nei mattatoi. La violenza nei confronti degli animali favorisce la violenza nei confronti degli umani, attraverso il processo di “animalizzazione” (o “sub-umanizzazione”), come nel caso dei campi di concentramento, in cui l’uccisione sistematica era facilitata dall’identificazione dei prigionieri con gli “animali”. È quanto accade ancor oggi nelle prigioni di Guantanamo e di Abu Ghraib, luoghi in cui vige lo “stato d’eccezione” alle leggi di tutela dei diritti civili e della persona. Anche lì gli esseri umani sono considerati sub-umani, ovvero terroristi appartenenti ad una cultura ritenuta misogina e ad una religione e ad una razza “inferiori”. Le pratiche di schiavitù continuano a sussistere al giorno d’oggi, nelle forme della tratta degli umani e del lavoro forzato, vere imprese commerciali in cui bambini e adulti, specialmente le donne, sono letteralmente imprigionati, controllati, violati, privati di ogni volontà e libertà. La schiavitù è la negazione dell’umanità, e consente la percezione degli “altri” come oggetti da sfruttare. Povertà, sfruttamento capitalismo nelle sue forme estreme, corruzione statale e conflitti armati sono le condizioni che favoriscono il persistere di tale crimine. Così accade nelle cosiddette “leggi di guerra” che regolano la prassi di una violenza “legittima”, riscontrabile sia nei contesti bellici, in cui il nemico è connotato con sembianze e tratti animaleschi, ma anche nella quotidianità. Genocidi e assassinii sono così riconosciuti come atrocità e crimini solo in seguito, a fronte delle denunce dei sopravvissuti. Per gli animali, invece, le morti di massa sono una prassi consueta, all’insegna della “violenza legittima” e legittimata. La “subumanizzazione” rinforza anche in questo caso la legittimità dell’uccisione. I discorsi sui diritti umani non eliminano la contrapposizione tra umano e subumano, anzi, quest’ultima categoria “animalizza” e de-umanizza l’umano. Per l’autrice è necessario quindi rivedere l’opposizione tra umano e animale, cancellando il confine che divide le due realtà, in una discorsività non più antropocentrica e gerarchica. Abbattere l’idea di sub-umano è l’unico mezzo efficace per poter eliminare la violenza nei confronti degli animali umani e nonumani. Claudia Serrato, nutrizionista esperta in pratiche e tradizioni alimentari e cofondatrice del progetto per la salute e la sovranità alimentare Decolonial Food for 140 Women of Color in Critical Animal Studies DEP n. 23 / 2013 Thought, propone un’analisi delle pratiche alimentari indigene in Ecological Indigenous Foodways and the Healing of All Our Relations. In quanto Xicana, Claudia Serrato deliberatamente sceglie di impostare il proprio contributo secondo un’epistemologia e un paradigma di ricerca indigeni. Infatti, spiega l’autrice, le tradizioni indigene alimentari, e non solo, mettono in luce l’importanza delle relazioni tra gli animali, la terra e gli esseri umani. Il cibo tradizionale consisteva nei frutti della terra, in equilibrio con il principio femminino di Tonanztin, che regola la cooperazione per il nutrimento, per il “pane”: ma caldo, pozole1, tacos2 e atole3, cibi tradizionali nativi, sono stati stravolti dall’arrivo dello chef biancovestito (e di razza bianca) che ha introdotto l’alimentazione carnea, il pilastro fondamentale e imperativo della dieta (occidentale). Eppure, le donne indigene si oppongono ai cibi di “massa”, prodotti in catena di montaggio, ricchi di proteine animali e femminilizzate4, strappate dalla terra e dalle creature viventi con la violenza e lo sfruttamento; alimenti ottenuti snaturando i processi fisiologici e naturali della terra e del ciclo della vita con l’industria agroalimentare e zootecnica, in cui la prassi comune è l’appropriazione delle risorse d’acqua per coltivare mais geneticamente modificato o per allevare innaturalmente animali che si ammalano perché costretti in spazi angusti e alimentati forzatamente. I disordini alimentari provocano disturbi di ogni genere, malattie cardiovascolari, obesità, cancro e diabete, tutti derivati dall’innaturale alimentazione bianca. Si contrappone ad essa la creatività nativa, la cultura e la storia femminile (her-stories), in cui l’arte culinaria magicamente trasforma la materia prima, i frutti della terra, in delizioso cibo. Laura Shields propone la sua intervista a Sarat Colling, anarco-animalista e attivista femminista transnazionale di origini indiane, collaboratrice dell’Institute for Critical Animal Studies. L’intervista mette in luce le relazioni tra l’essere “donna di colore”, di origini transnazionali, nella piccola comunità a maggioranza bianca di Hornby Island, in Canada, e l’attivismo per i diritti animali come un intreccio di relazioni inscindibili nel pensiero e nella scrittura. Sarat Colling comprese precocemente la connessione tra i prodotti di origine animale e la sofferenza degli animali e si avvicinò alla filosofia della liberazione animale, arrivando al progetto di Love and Liberation5, storia romanzata dell’ALF – Animal Liberation Front. Il suo attivismo anarchico riconosce i principi della nonviolenza e dell’ahimsa, così come è espressa nello Yoga Sutras di Pantajali, e si occupa delle questioni di genere, razza, classe e specie. Nel suo pensiero l’anarchismo e il femminismo transnazionale sono sorretti dalla convinzione della necessità di superare le barriere della “colonizzazione discorsiva” per giungere a dare ascolto, attenzione e voce agli oppressi, umani e non umani. 1 Caldo e pozole sono delle tradizionali zuppe pre-colombiane. Tortillas di mais. 3 Bevanda calda tradizionale del centro America. 4 Le proteine animali femminilizzate sono le uova, il latte e i suoi derivati. 5 Sarat Colling, Anthony J. Nocella II, Love and Liberation. An Animal Liberation Front Story, Piraeus Books, Williamstown 2012. 2 141 Women of Color in Critical Animal Studies DEP n. 23 / 2013 Anastasia Yarbrough, recensisce il libro curato da Breeze Harper, Sistah Vegan6, in cui è illustrato il rituale magico e l’intreccio di pratiche spirituali, olistiche e culinarie, già affrontato nella testimonianza di Claudia Serrato, una delle molteplici forme di cultura e sapere vegan. Sistah Vegan, ha come obiettivo la ricostruzione della filosofia e della pratica vegan da una prospettiva femminista, di colore, anti-colonialista ed anti-razzista. È la testimonianza corale e multi sfaccettata di cosa significa “essere vegan” per le donne di colore. Da dieta a pratica spirituale, da pratica alimentare a sostenibilità alimentare, dai diritti animali alla giustizia sociale, dalla questione della razza alla sessualità, dall’idea di libertà alla costruzione dell’identità, quali parti del “sentire vegan”, anzi “black-vegan”. Il numero di JCAS si chiude così con uno sguardo che oltrepassa i consueti “limiti” della pratica e della filosofia vegan “bianca” e “occidentale”. I vari contributi dimostrano come la questione del colore e del genere non siano una materia “flebile” nella stessa questione animale, ma che anzi debbano essere considerate nella loro complessità, da punti di vista diversi, e dal basso. Decostruire l’opposizione tra tutto ciò che è umano e ciò che non lo è, smontare la categoria di “sub-umano”, e la presunta inferiorità degli animali come giustificazione della violenza, sono esigenze comuni e condivise che devono non solo collegare, ma innescare le innegabili connessioni tra le questioni di genere, colore, classe e specie. Chiara Corazza 6 Amie Breeze Harper (ed.), Sistah Vegan. Black female vegans speak on food, identity, health, and society, Lantern Books, New York 2010. 142 Marti Kheel, Nature Ethics: An ecofeminist perspective, Rowman & Littlefield, Lanham MD, 2008, pp. 354. Nell’introduzione a Nature Ethics, Rosemary Radford Ruether scriveva: “Questo libro rappresenta l’impegno di oltre 25 anni della filosofa ambientalista Marti Kheel, per unire i movimenti femminista, ambientalista e di liberazione animale, apparentemente distaccati (p. IX)”. Eminente studiosa ecofemminista, nonché attivista per i diritti animali e l’etica ambientale, Marti Kheel ha pubblicato molti contributi in antologie e riviste. Caposaldo della sua teoria e del suo attivismo è The Liberation of Nature: A Circular Affair, un saggio del 1984, apparso originariamente in “Enviromental Ethics” che rappresenta la prima critica femminista al dualismo tra la filosofia della liberazione animale e quella della liberazione della terra. Kheel, morta prematuramente nel 2011, nasce a New York nel 1945, e fin da bambina si occupa degli “altro-da-umani”. A 25 anni diventa vegetariana, in seguito ad alcune spiacevoli esperienze nei ristoranti dove lavorava che la portano ad avere uno sguardo diverso sugli animali e sul loro destino. Quattro anni più tardi si unisce ad un gruppo di attiviste/i per la liberazione animale a Montreal e compie la scelta vegana. Nel 1982 fonda in California, con altre ecofemministe, il collettivo Feminists for Animal Rights (F.A.R.), con l’intento di creare un collegamento tra i movimenti femministi e quelli per i diritti animali. Nel 1989, il suo articolo From Healing Herbs to Deadly Drugs: Western Medicine’s War Against the Natural World, ispira un’importante disputa legale contro il governo canadese accusato di discriminazione religiosa verso varie pratiche di medicina olistica. Per questo processo la femminista statunitense fu convocata come consulente. Marti Kheel ha promosso lo sviluppo di una filosofia ecofemminista olistica in grado di connettere i movimenti e le filosofie femministe con quelle per i diritti animali e di etica ambientale, un modo di accostarsi ai problemi sociali che sviluppa empatia, compassione e cura per tutti gli esseri senzienti. Nella sua ultima opera, Nature Ethics, l’autrice illustra l’astrattezza di alcune impostazioni che “si interessino delle ‘specie’, dell’‘ecosistema’ o della ‘comunità biotica’ più che degli individui” (p. 2) e che rimangono ancorate ad una visione maschile. Essa si sofferma su quattro esponenti dell’ecosofia – Theodor Roosevelt, Aldo Leopold, Holmes Rolston III e Warwick Fox – e ne analizza il rapporto morale con la natura e i criteri usati per delineare i parametri di ciò che è ritenuto degno di considerazione morale. Nel I capitolo, Finding a Niche for All Animals Kheel esprime la sua critica anche di quegli stessi teorici universalmente riconosciuti come i padri fondatori dell’animalismo contemporaneo, Peter Singer e Tom Regan, e afferma che entrambi, pur da posizioni filosofiche e teoretiche differenti, riducono la natura a uno sfondo per gli umani, escludendo ogni riconoscimento alle varie entità che la compongono e includendo nella considerazione etica e morale solo alcuni tra gli animali. Questi autori enfatizzano l’importanza dell’autonomia, della capacità cognitiva e di pensiero, della progettualità, elementi che molta parte del femminismo riconosce come ideali maschili della tradizione occidentale, caratterizzati dal paradigma © DEP ISSN 1824 - 4483 Marti Kheel DEP n. 23 / 2013 competitivo, da una visione dualistica e atomista. In tale scenario ci sono esseri che soccombono e altri che vincono, alcuni che si sacrificano e altri che godono i benefici, nella perpetuazione di una logica patriarcale di dominio e di possesso. Delusa dalle impostazioni degli ambienti ecologisti, eticisti, animalisti, Kheel si rivolge all’ecofemminismo, che a sua volta si rivela insoddisfacente per la scarsa considerazione degli animali, ad eccezione delle ecofemministe animaliste. Convinta che l’indifferenza nei confronti degli altro-da-umani sia stata e continui ad essere un nodo cruciale delle filosofie occidentali che si occupano della natura, decide di risalire alle radici del problema. In Nature Ethics Kheel esplora la formazione dell’identità maschile (Masculine Identity: Born Again ‘Man’) avvalendosi delle teorie femministe, delle teorie sociologiche, dei “men’s studies” e della teoria delle relazioni oggettuali. Ella muove dall’idea che il genere sia un concetto che organizza la vita sociale in modi specifici. È una definizione pratica delle differenze biologiche (Raewyn W. Connell, 1987), che organizza non solo gli aspetti sociali, ma crea il binarismo degli opposti, promuovendo l’idea dell’altro in contrapposizione a ciò che è maschile, un maschile che diviene la norma e l’identità di base. Kheel critica gli ecofilosofi prendendo le mosse dalla loro definizione di natura, ovvero ciò che è altro da sé, in alternativa all’uomo – uomo bianco occidentale – essere razionale, capace di dominare i propri istinti, in grado di distinguersi dagli animali. Questi s-oggetti sono quindi sia altro da sé, in quanto distanti dalla definizione di umano, ovvero incarnazione dell’uomo, sia parte integrante della natura, ben distaccata se non propriamente dissociata dalla cultura, di pertinenza prettamente maschile. Nel capitolo Origins of the Conservation Movement: Preserving Manhood Kheel ripercorre la storia del movimento per la conservazione ambientale e della pratica della caccia, tema quest’ultimo da lei già trattato anche in License to Kill: An Ecofeminist Critique of Hunter’s Discourse, saggio presente nel testo curato da Carol J. Adams e Josephine Donovan Animals and Women. Feminist Theorethical Explorations (Duke University Press, Dunham and London 1995, pp. 85-125) e The Killing Game: An Ecofeminist Critique of Hunting, pubblicato nel 1996 sulle pagine del “Journal of the Philosophy of Sport” (XIII, pp. 30-40). Il tema della caccia è indagato a partire dalla narrativa del cacciatore, cioè del processo di inseguimento, conquista e consumo dell’animale conquistato. La caccia, è stata indicata troppo spesso come l’unica modalità di procacciamento di cibo in alcuni periodi storici, nonostante numerosi studi antropologici e archeologici femministi abbiano rivelato che nelle economie di sussistenza avevano grande rilevanza le pratiche di raccolta e che le proteine animali provenivano in parte dal consumo di resti di animali morti non per mano umana1. 1 Rappresentativo è il testo di una delle precursore dell'antivivisezionismo femminista, Anna B. Kingsford che redasse la sua tesi di laurea, poi divenuta un libro nel 1881, dal titolo The Perfect Way in Diet. Tra gli studi più recenti, citiamo quelli di Michelle Zimbalist Rosaldo, The Use and Abuse of Anthropology: Reflections on Feminism and Cross-Cultural Understanding, in “Signs”, vol. 5, 3, 1980, pp. 389-417; Frances Dahlberg (ed.), Woman The Gatherer, Yale University Press, Yale 1981; Nancy Makepeace Tanner, Hunters, Gatherers, and Sex Roles in Space and Time, in “American Anthropologist”, New Series, vol. 85, 1983, 2, pp. 335-341; Linda Marie Fedigan, The Changing Role of 144 Marti Kheel DEP n. 23 / 2013 Prende quindi in considerazione il pensiero del cacciatore e tassidermista Theodor Roosevelt (Thinking Like a Mountain or Thinking Like a ‘Man’?), promotore del movimento per la conservazione della natura, che durante un safari in Africa uccise e imprigionò circa 11.400 animali, poi donati (quando non mangiati) a vari musei di storia naturale. Come scrive Kheel, “i cacciatori ai tempi di Roosevelt non avvertivano la contraddizione tra l’amore per la natura e il desiderio di distruggere delle vite individuali” (p. 88). Questi cacciatori di fine secolo si identificavano in una serie di contrapposizioni: natura/cultura; animale/umano; donna/uomo; selvaggio/civilizzato; gioco/sport; caccia di sussistenza/caccia sportiva. Aldo Leopold, considerato “padre” fondatore dell’etica ambientale e profeta di una trasformazione radicale dell'atteggiamento verso la natura, autore del famoso Almanacco di un mondo semplice, proponeva una visione ecocentrica in cui gli umani non erano più considerati i conquistatori del mondo naturale, ma cittadini di una comunità biotica che richiedeva amore e rispetto. Anche in questo caso, Kheel dimostra che non si tratta di una nuova visione che propone amore e rispetto reali per tutte le forme di vita, ma di un sentimento verso un insieme biotico, che poco si distingue da quello inteso dai tradizionali movimenti conservazionisti. Leopold è stato anche uno dei fondatori della scienza del controllo della fauna selvatica. Influenzato dalla sua esperienza nel servizio forestale, egli credeva fosse possibile applicare i principi della custodia delle foreste alla gestione degli animali selvatici, tanto da affermare che la caccia era “il prodotto principale della foresta” (pp. 404411). Spesso viene citato un episodio che ha segnato la conversione di Leopold ad una diversa visione della caccia, quando Leopold, insieme ad alcuni compagni, uccise un cucciolo di lupo e la madre. In realtà, svela Kheel, Leopold continuò a cacciare per tutta la vita, benché solo alcuni tipi di animali. Ciò che era cambiato nella sua visione non derivava da un sentimento di empatia verso la lupa uccisa, ma dalla preoccupazione oggettiva di una possibile estinzione dei lupi. Rimane, quindi, una visione astratta della natura, distaccata dai bisogni e dai diritti degli individui che ne fanno parte. L’enfasi di Leopold sull’importanza centrale della caccia sportiva riflette un orientamento maschilista che “sacrifica” gli esseri individuali a favore di una prospettiva “oggettiva” più allargata, simboleggiata dalla “terra” (p. 129). Emblematica è la citazione di Karl Popper tratta da Objective Knowledge che apre il quinto capitolo (The Ecophilosophy of Holmes Rolston III): “A mio parere – scrive Popper – il più grande scandalo della filosofia è che, mentre tutto attorno a noi il mondo della natura muore, e non solo il mondo della natura, i filosofi continuano a discutere, a volte in modo intelligente altre volte no, se questo mondo esista”. Rolston, filosofo e teologo, con una posizione minoritaria nell’ambiente degli eticisti, era convinto che la natura avesse un valore oggettivo. Sosteneva infatti che la natura avesse un valore indipendente dagli umani, e che questi ultimi non portassero valore alla natura (p. 140). Ma è proprio la sua idea di valore che lo accomuna agli altri filosofi. Rolston ha definito tre tipi di valori in natura: strumentale, intrinWomen in Models of Human Evolution, in “Annual Review of Anthropology”, vol. 15, 1986, pp. 2566; Marion Nestle, Paleolithic Diets: a Sceptical View, in “Nutrition Bulletin”, n. 25, 2000, pp. 43-47; Jared Diamond, Armi, Acciaio e Malattie, tr. it. di Luigi Civalleri, Einaudi, Torino 2006; Jim Mason, In un mondo sbagliato, tr. it. di Massimo Filippi, Casale Monferrato (Al) 2007; Carol J. Adams, The Sexual Politics of Meat, Continuum, New York-London 2010. 145 Marti Kheel DEP n. 23 / 2013 seco e sistemico, costruendo così una gerarchia per diverse categorie che, a turno, impongono degli obblighi (p. 141). In questa gerarchia, gli esseri umani sono superiori a tutti gli altri esseri viventi, non per una specifica utilità biologica, ma per le capacità creative e la loro soggettività. Anche Rolston, come altri eticisti, basa le sue riflessioni su dualismi oppositivi. Kheel afferma che Rolston, impegnato ad osannare le capacità umane, abbia perso di vista il reale comportamento degli umani verso la natura: gli unici esseri capaci di distruggere il proprio ambiente e di atti di violenza ineguagliabile verso la propria e tutte le altre specie (p. 144). Nel penultimo capitolo, The Transpersonal Ecology of Warwick Fox, Kheel esamina il pensiero di Warwick Fox e ne mette in discussione le radici patriarcali che svalutano i legami personali e affettivi ed escludono gli altro-da-umani. Fox sviluppa il suo pensiero a partire dall’ecologia profonda e in particolare dal pensiero di Arne Naess. Prendendo le mosse dal concetto di realizzazione del Sé, propone un nuovo termine che trae dalla psicologia transpersonale: “ecologia transpersonale”. Per Fox, il Sé ecologico transpersonale comprende un’ampia sfera di identificazioni con “famiglia e amici, altri animali, oggetti fisici, la regione in cui si vive e così via” (p. 171). L'impostazione di Fox, che vede la più alta realizzazione del Sé nell’identificazione trascendentale col cosmo, ripropone la tradizionale visione patriarcale che favorisce una sorta di consapevolezza globale a discapito di legami di disponibilità e cura verso i singoli individui. Nonostante proponga una visione allargata del Sé, insiste sul fatto che gli-altro-da-umani si realizzano esclusivamente su un piano materiale, mantenendo la visione dualistica e specista del dualismo umani/natura. Nel capitolo conclusivo, Ecofeminist Holist Philosophy, Kheel afferma che l’ecofemminismo è un orientamento pratico e filosofico di tipo olistico anziché una singola filosofia, un approccio critico verso le ideologie che sostengono le varie forme di dominio, comprese quelle basate su razza, classe, età, etnia ed orientamento sessuale. L’ecofemminismo è impegnato in una trasformazione sociale, il suo metodo si basa sulla premessa che non si può cambiare ciò che non si capisce. Comprendere il lavorio sotterraneo della società patriarcale è la premessa fondamentale per cambiare la nostra società che si basa ancora sullo sfruttamento delle donne e della natura. Come afferma Marti Kheel in un altro suo scritto2: “La natura non sarà ‘salvata’ dalla spada della teoria etica, ma piuttosto dalla trasformazione della coscienza verso tutte le forme di vita” (p. 242). L’etica non si basa sull’imposizione di diritti e doveri, ma su un’evoluzione della propria visione del mondo e delle relazioni. Per cambiare l’attuale logica distruttiva della natura sarebbe utile comprendere i modi in cui si combinano queste forme di dominio, poiché non è possibile modificare lo stato attuale delle credenze e dei comportamenti del mondo patriarcale senza capire il flagello che proviene dalla mentalità che le è propria. L’opera di Kheel è un punto di riferimento fondamentale in un panorama tuttora dominato dagli uomini sia nei movimenti ecologisti, per i diritti animali e per la liberazione animale, che affermano sovente un sessismo strisciante, raramente messo 2 Marti Kheel, From Heoric to Holistic Ethics: The Ecofeminist Challenge, in Greta Gaard (ed.), Ecofeminism: Women, Animals, Nature, Temple University Press, Philadelphia 1993, pp. 243-271. 146 Marti Kheel DEP n. 23 / 2013 in discussione. Kheel propone una critica profonda alle basi filosofiche di questi movimenti, che pretendono di liberare la terra e i suoi abitanti senza riconoscere i privilegi di chi formula le teorie e agisce le pratiche. L’ecofemminismo dà visibilità e importanza alle interconnessioni tra le varie forme di dominio, contribuendo a minare alla radice sistema di pensiero patriarcale, anche nelle sue forme più velate. L’etica della cura e l’empatia, principi cardine individuati come epicentro della cosiddetta “etica della cura” anche da altre autrici ecofemministe come Josephine Donovan e Carol J. Adams3, vengono messe in primo piano, come modalità di avvicinamento all’altro-da-sé (umano e non-umano), per una pratica che si cala nella quotidianità e tiene conto degli individui, della pluralità, non delle astrazioni (p. 226). In quest’ottica, Kheel sottolinea l’importanza di una pratica vegana come forma di cura specifica. Il veganismo è quindi il mezzo per ridurre le sofferenze degli altro-da-umani e contribuire al benessere del mondo naturale (p. 233). La speranza è che i contributi ecofemministi, di cui Marti Kheel è una significativa esponente, diventino parte integrante delle teorie ecologiste, per la liberazione animale e della terra al fine di mettere in discussione alle radici il pensiero del dominio, anche laddove non è così esplicito e scontato. A Marti Kheel piaceva immaginare un futuro in cui ad una sua nipote che con incredulità le avesse chiesto se realmente nel passato gli umani usavano cibarsi di animali avrebbe potuto rispondere: “Sì, ma ora tutto questo è storia. Come in un brutto sogno. Ora invece possiamo vivere in pace ed armonia con tutte le creature della terra. L’“Era del Tradimento” è definitivamente tramontata”4. Erika Battocchio-Annalisa Zabonati 3 Josephine Donovan - Carol J. Adams (eds.), The Feminist Care Tradition in Animal Ethics, Columbia University Press, New York 2007. 4 Marti Kheel, “From Heoric to Holistic Ethics: The Ecofeminist Challenge”, op.cit., p. 271. 147 Jimena Rodríguez Carreño (ed.), Animales no humanos entre animales humanos, Plaza y Valdés Editores, col. Dilemata. Ética, filosofía y asuntos públicos, Madrid-México, 2011, pp. 393. Fruto de un trabajo intenso y continuado por parte de cierto número de investigadoras e investigadores en las áreas de Ética Animal y de Derecho, este libro reúne importantes aportaciones sobre un tema de suma actualidad: nuestra relación con los animales no humanos. El título ya indica un posicionamiento de vanguardia: se abandona el antropocentrismo autocomplaciente y mistificador para dar paso a un reconocimiento humilde de la pertenencia común a la categoría “animal” de humanos y animales. Esta definición humana podría ser de carácter puramente epistemológico, simple asunción y desarrollo de las tesis darwinianas sin anhelo de transformación social. Pero la obra que nos ocupa va más allá, revelando una vocación ética indiscutible. A pesar de su diversidad, los diferentes trabajos que la componen coinciden, en última instancia, en reconocer la necesidad de una reformulación de nuestros derechos y deberes y de las leyes que afectan a los individuos de las demás especies. Para los autores de la introducción – Txetxu Ausín y Jimena Rodríguez Carreño – éste es el eje vertebrador de la selección de los artículos que presentan. En el primer estudio, Priscilla Cohn (The Ferrater Mora Oxford Centre for Animal Ethics) examina los argumentos que se suelen utilizar para justificar la práctica de la caza recreativa y los contrapone a las investigaciones actuales provenientes de la antropología. Afirma que la hipótesis paleo-antropológica de la hominización a través de la caza es errónea. El ancestro humano habría sido en realidad un carroñero, es decir, una criatura que se alimentaba ocasionalmente con presas cazadas por animales carnívoros a los que ahuyentaba. La caza no se basaría, pues, en un antiguo instinto irresistible. Es una institución cultural que puede ser elegida o rechazada. Pricilla Cohn critica, asimismo, otros argumentos de corte psicológico y sociológico entre los que se incluyen las famosas tesis del filósofo español Ortega y Gasset sobre la caza como embriaguez orgiástica y loable retorno a la simplicidad del Paleolítico. Culmina su artículo condenando la caza a partir de principios éticos fundamentales aplicables a todos los seres capaces de sufrir. Paula Casals (Institució Catalana de Reçerca i Estudis Avançats, Departament de Dret, Universitat Pompeu Fabra) aborda, por su parte, las prácticas de extrema crueldad para con los animales no humanos que se dan en los ritos de santería de origen africano en Estados Unidos. Expone los procesos judiciales que han tenido lugar y que han contrapuesto la defensa de los animales por un lado y el reconocimiento de la libertad religiosa o de la diversidad cultural por otro. Observa la condescendencia con que ciertos sectores progresistas ven la cuestión al disculpar tales prácticas por la situación de pobreza y marginalidad del colectivo que las realiza. Concluye señalando que estas razones deben llevar a políticas que mejoren su igualdad de derechos y acceso a los bienes y no que impulsen el abuso sobre los más vulnerables, sean éstos las mujeres, los niños y niñas o los animales. © DEP ISSN 1824 - 4483 Jimena Rodríguez Carreño DEP n.23 / 2013 La propia coordinadora del libro, Jimena Rodríguez Carreño (AIUDAAsociación Interuniversitaria para la Defensa de los Animales), contribuye como autora con un trabajo que busca rescatar del olvido la figura de Frances Power Cobbe. Esta sufragista combatió la desigualdad legal que sometía a las esposas en la pareja y las convertía en menores de edad ante la sociedad británica. Pero Cobbe, como algunas otras sufragistas, tuvo un gran papel en la lucha contra la vivisección. Recuerda la autora que el movimiento antiviviseccionista de la Inglaterra victoriana tenía en sus filas mayoría de mujeres y su causa era concebida como propia de la sensibilidad femenina, menos controlada por la razón. La vivisección practicada en los laboratorios fue vinculada por feministas como Cobbe a la histerectomía, operación realizada con una frecuencia abusiva, y con el control sanitario a las prostitutas para garantizar la salud de los felices usuarios. Frances Power Cobbe aparece en este retrato como una autora ética que se encontraría entre la tradición y la modernidad ya que, como cristiana, rechazó el darwinismo y el materialismo, pero condenó la tortura en nombre de la ciencia, se adelantó a los descubrimientos de la etología cognitiva en su apreciación de las capacidades de los animales no humanos y abogó por el vegetarianismo a partir de principios morales. Es justamente la dimensión ética de nuestra alimentación el tema del siguiente artículo, “La receta moral del vegetarianismo”, a cargo de Pablo de Lora (Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Madrid). De Lora realiza un rápido recorrido de la temática desde sus orígenes en la Antigüedad hasta el utilitarismo y la teoría de los derechos, comparando sus argumentaciones a favor y en contra del vegetarianismo. Pasa después a realizar una clasificación de los diferentes tipos de actitud sobre la forma de alimentarse desde patrones éticos. Esta clasificación se resume en un cuadro de tipos de alimentación (p.133) muy útil a la hora de clarificar conceptos que subyacen a las nuevas tendencias en debate en las sociedades modernas. Diferencia entre vegetarianismo (ovo-lacteo), veganismo, dieta omnívora irrestricta y dieta omnívora consciente. Esta última sería la de quienes no se abstienen de comer productos de origen animal, incluida la carne, pero lo hacen de forma reducida y exigen que provenga de la producción ecológica (organic) con ganadería tradicional y el menor sufrimiento posible para los animales. Para los omnívoros irrestrictos, los animales no humanos son simples recursos y la ganadería industrial no representa un problema. De Lora se decanta por el vegetarianismo. A su juicio, la dieta vegana es supererogatoria (esto significa en términos de la ética, que su práctica es admirable pero no moralmente obligatoria) ya que De Lora sostiene que ciertos productos como los huevos o la leche pueden ser obtenidos en condiciones bienestaristas sin sufrimiento animal. Su texto finaliza con un apartado sobre la responsabilidad humana en la alimentación de carnívoros privados de libertad en los zoológicos. Con el sugerente título de “¿Cómo integra la globalización a mi otro significativo?”, Asunción Herrera Guevara (Departamento de Filosofía, Universidad de Oviedo), parte de la expresión “my significant other” que sirve en USA y Gran Bretaña para designar a una persona afectivamente muy cercana sin especificar el vínculo que se tiene con ella. Asunción Herrera Guevara la redefine como “todo ser vivo capaz de significarme, es decir, de dar significado a mi 149 Jimena Rodríguez Carreño DEP n.23 / 2013 identidad” (p.142). Concibe a los derechos como productos de la convención y sigue a Kelsen en su teoría de que crear un derecho para alguien es establecer una obligación, prohibición o restricción para los demás. Desde esta concepción, señala, tanto los niños como los animales pueden ser sujetos con derechos aún sin ser capaces de asumir obligaciones. Observa que en este inicio de siglo podemos hablar de derechos para los animales no humanos ya que estos han pasado a formar parte de mi otro significativo. Conjugando la defensa de los derechos propia de la tradición liberal con el valor de la deliberación de la tradición republicana, llama “democracia requisitoria” a la surgida del avance de los derechos sociales, una democracia que en nuestro tiempo estaría llevando cada vez a mayor número de personas a pedir derechos para los animales. Concluye su trabajo afirmando que en este nuevo período de globalidad, la tesis de la continuidad humano-animal nos ha de conducir a una ciudadanía ecológica que se forjaría a través del reconocimiento de derechos y la deliberación sobre las formas de vida que los hacen posibles. Las ONG y los organismos internacionales como la ONU jugarían un papel importante en el avance hacia una Constitución de esta nueva ciudadanía. En la sexta aportación, “Sentados frente al espejo literario: el alma de los animales en Unamuno y Coetzee”, Montserrat Escartín Gual (Departament de Filologia i Comunicació, Universidad de Girona) comienza con un breve repaso filológico y filosófico de la noción de “alma” para pasar después a estudiar los puntos de contacto entre dos novelas en que la temática de la condición animal tiene un lugar muy importante: Niebla (1914), del español Miguel de Unamuno y Disgrace (1999) y Elisabeth Costello (2003) del sudafricano de origen boer Coetzee, Premio Nobel de Literatura 2003. La autora subraya la similar actitud crítica de ambos con respecto a los prejuicios culturales que devalúan a los animales no humanos en la tradición hegemónica: tratados como cosas, ignorados en sus padecimientos físicos y psicológicos en nombre de la razón, convertida en criterio excluyente por una utilización sesgada y antropocéntrica. También destaca la compasión que expresan por su trágico destino y el paralelo que establecen con los desdichados personajes humanos de sus relatos. Como no podía dejar de hacerse, Escartín observa asimismo una profunda diferencia que separa a Unamuno y Coetzee: la inmortalidad del alma humana y animal en el primero otorgaba un consuelo que la visión, aún más profundamente trágica del segundo, ya no está dispuesta a otorgar. Óscar Horta (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Rutgers University) se propone en el estudio siguiente dejar claras las diferencias y las incompatibilidades entre las éticas antiespecistas y las ecologistas. Con el significativo título de “Tomándonos en serio la consideración moral de los animales: más allá del especismo y el ecologismo”, Óscar Horta comienza señalando las razones que aducen los partidarios de posiciones especistas (los humanos poseemos mayores capacidades cognitivas, estamos en una situación de poder, etc.) y refutándolas una a una (el criterio de las capacidades cognitivas superiores podría justificar que se sacrificase a los humanos de inteligencia media si ello fuera en beneficio de los genios; o bien, si las relaciones de poder legitiman la explotación, también se estaría justificando la explotación de los humanos más débiles. Dado que los especistas no querrían apoyar tales consecuencias, concluye 150 Jimena Rodríguez Carreño DEP n.23 / 2013 que las posiciones especistas carecen de fundamento. Será especista para Óscar Horta toda posición que establezca una discriminación por razón de especie, incluyendo en esta categoría a aquellos pensadores que defienden a los animales pero en última instancia ponen los intereses humanos por encima de los que poseen aquellos. El criterio para ser merecedor de la consideración moral será poseer una conciencia que permita tener experiencias positivas y negativas. Los animales cumplen esta condición, no así las plantas. Sólo una visión mística, señala Horta, puede suponer que son capaces de ello sin un sistema nervioso centralizado. Rechaza así el biocentrismo que llevaría a consecuencias indeseables como la condena del suicidio o el respeto a las bacterias. Observa también que el holismo de las posiciones ecologistas ecocéntricas termina, por lo común, en un fuerte especismo antropocéntrico. De todo lo expuesto, finaliza enumerando las consecuencias prácticas de una actitud no especista coherente: veganismo y deberes no sólo negativos (abstenerse de hacer daño), sino también deberes positivos (actuar a favor de alguien). Esto último incluiría defender a los animales no humanos frente a las agresiones humanas y comenzar a plantearse las formas de lograr que disminuya su sufrimiento en la Naturaleza, la cual, señala, dista mucho de ser un paraíso. Por su parte, Walter Sánchez Suárez (Departamento de Lógica y Filosofía Moral, Universidad de Santiago de Compostela) se centra en “El valor de la vida en Singer, Nagel y Schweitzer”. Su estudio muestra que los dos primeros conceden valor sólo a la vida consciente. Los individuos capaces de experimentar sensaciones poseen gracias a esta capacidad, según ambos filósofos, un interés por prolongar su vida. El autor se detiene en las clasificaciones que Singer ha realizado para diferenciar tipos de seres vivos: autoconscientes (capaces de tener preferencias respecto a su vida futura y para los que reconoce el derecho a la vida); conscientes (capaces de sentir y, en consecuencia, de preferir el placer y evitar el dolor); y seres no conscientes (incapaces de experiencias positivas o negativas, por ejemplo, las plantas). Mientras que para los primeros, Singer reconoce el derecho a la vida, en el caso de los segundos admite que podría dárseles muerte si fuera totalmente indolora. Los últimos, los seres no conscientes, no entran en el círculo de la consideración moral. Walter Sánchez Suárez concluye su comparación de los tres filósofos afirmando que si bien la posición biocéntrica de Albert Schweitzer no parece muy rigurosa frente a las de Nagel y Singer, su principio del respeto a toda vida puede ser considerado un pertinente principio de precaución para el trato que damos a seres vivos como, por ejemplo, las abejas, seres sobre los que no tenemos un perfecto conocimiento del sistema nervioso y, por lo tanto, del nivel de conciencia que éste les permite alcanzar. En el trabajo titulado “Los fundamentos normativos de Liberación Animal de Peter Singer”, Renzo Llorente (Saint Louis University, Madrid Campus) sostiene, contrariamente a numerosos intérpretes de la obra del famoso bioético, que ésta no es en realidad un texto utilitarista. Su clave normativa sería en realidad el principio de minimizar el sufrimiento, como el propio Singer ha expresado en alguna ocasión. La confusión de los intérpretes se debería a tres causas diferentes: las múltiples autodefiniciones del filósofo como partidario del utilitarismo de las preferencias; la presencia en Liberación Animal de razonamientos que sopesan 151 Jimena Rodríguez Carreño DEP n.23 / 2013 placer y dolor, algo propio de la tradición utilitarista; y, por último, el escaso interés mostrado por Singer para corregir la confusión de sus intérpretes. A partir del esclarecimiento del núcleo ético de esta obra, Renzo Llorente defiende a Singer de algunas acusaciones de incoherencia que ha recibido por parte de algunos críticos. Así, muestra la disolución de las supuestas contradicciones en lo que respecta a la defensa del vegetarianismo, a su rechazo de los métodos violentos en el activismo animalista y a su opinión contraria a la intervención humana en la naturaleza para evitar el sufrimiento animal. En el siguiente trabajo, Antoni Defez (Departament de Filosofia, Universitat de Girona) propone algunas reflexiones en torno al fundamento de los derechos. Su aportación, con el título de “¿Qué decimos cuando decimos que los animales tienen derechos?”, diferencia entre posiciones filosóficas de realismo moral (racionalismo que parte de la posesión de una propiedad, por ejemplo, la capacidad de sentir, de la que se deriva el derecho) y un antirrealismo (un derecho es una propiedad relacional que deriva de la praxis humana que decide quién tiene derechos y cuáles) en el que se coloca el mismo autor. Observa que la primera posición incurriría en la falacia naturalista que deriva el deber ser del ser. La segunda posición constituiría, a su juicio, un antropocentrismo correcto, distinto del antropocentrismo metafísico y moral que parte de diferencias esencialistas. Desde un punto de vista estratégico, afirma, el realismo moral de los defensores de los animales podría ser compatible con el antirrealismo. Concluye que desde este último se puede asumir la necesidad de un cambio en el trato a partir del argumento de “que nos gusta más una forma de vida en que los animales sean tratados de otro modo: que nos sentimos más humanos si no los maltratamos” (p. 276). La renuncia a una fundamentación fuerte no implicaría, así, renunciar a los objetivos de los defensores de los animales. Lorenzo Peña (Instituto de Filosofía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC) concentra su atención en los animales domésticos y en cautiverio. Como se puede adivinar ya por el título “Deberes y derechos de nuestros hermanos inferiores”, su trabajo se separa tanto de las reivindicaciones animalistas como del planteamiento antropocéntrico fuerte que niega derechos y estatus de persona a los animales no humanos. Apoyándose en un enfoque naturalista que busca conocer lo que es para plantear lo que debe ser, afirma en primer lugar nuestro parentesco, mayor o menos según las especies, con el resto de los seres sintientes. Recuerda que nuestra sociedad, desde tiempos remotos, es interespecífica, al haber incluido al perro y a otros animales domésticos en su vida cotidiana como compañeros de labor. Dedica al caballo varias páginas mostrando sus aportaciones al desarrollo civilizatorio y las variaciones en la concepción de su psicología que muestran los consejos para su domesticación a lo largo de los siglos. Pero su propuesta moral y jurídica opta por la continuación del estatus de propiedad de los animales domesticados en virtud de que su inserción en la sociedad humana tiene lugar en condiciones de inferioridad y subordinación. Apelando al orden jurídico romano, sostiene que el esclavo puede ser también sujeto de derechos (a la vida, a no ser maltratado, a ser cuidado...) en la medida en que es sujeto de obligaciones (de obedecer a su amo, respetar las normas, etc.). Así, su artículo finaliza con una propuesta de un nuevo Estatuto del Animal No 152 Jimena Rodríguez Carreño DEP n.23 / 2013 Humano, norma que debería tener rango de ley, que estableciera derechos y deberes que los dueños tienen con respecto a sus animales no humanos y, correlativamente, los derechos y deberes que hay que reconocerles y puede imponerse a éstos. El libro se cierra con un panorama de la “Evolución del marco jurídico de la protección animal desde 1929 hasta 2010” en España a cargo de José María Pérez Monguió (Departamento de Derecho Público, Universidad de Cádiz). El autor muestra el progreso que, a pesar de ciertas apariencias desesperanzadoras, se ha dado tanto en la concepción como en el tratamiento jurídico del tema. Apunta que ya a finales del siglo XIX, algunos precursores, como el gobernador civil de Cádiz, habían instado a que las autoridades locales tomaran medidas para evitar espectáculos bochornosos de barbarie en público, pero que, a diferencia de la actualidad, el argumento principal era el efecto malsano que podía tener en la población la visión de la violencia. Observa que los mayores avances se dieron en el primer tercio del siglo XX y que no se debieron a demandas sociales, sino a la acción de algunas personalidades políticas. La sociedad no entendía que se pudiera multar o arrestar al maltratador. Poco a poco y por influencia de la Unión Europea y del movimiento internacional de defensa de los animales, desde finales de los años sesenta y la década de los setenta, se irá pasando de la simple idea de “protección” contra el daño físico, presente en los Patronatos de Animales y Plantas, a una concepción más exigente y moderna de “bienestar” que incluye los aspectos físicos y psicológicos. El estudio finaliza constatando los avances realizados en las normativas autonómicas, en particular la de Cataluña cuya ley de 2010 prohibió las corridas de toros en su territorio. Como puede constatarse a través del recorrido realizado por la totalidad de los trabajos compilados, a pesar de coincidir en la finalidad ya apuntada al comienzo de estas líneas, los autores de este libro mantienen posiciones diferentes, e incluso en algunos casos contrarias, tanto desde el punto de vista de la argumentación como de las propuestas, por lo que su lectura resulta altamente sugerente y enriquecedora. Alicia H. Puleo 153 Michela Pezzarini, “Il cane o tua figlia?” Riflessioni sull’ etica del care e la vivisezione. Nelle pagine che seguono pubblichiamo un anticipazione dell’intervento che Michela Pezzarini, attivista per gli animali, redattrice della rivista on-line “Musi e Muse” e traduttrice, terrà il 26 settembre 2013 presso la Biblioteca della Casa del Parco della Pineta Sacchetti a Roma. Il tipico approccio alla questione della sperimentazione su cavie animali – o vivisezione – da parte dei suoi sostenitori (la gran parte del mondo scientificoaccademico, le case farmaceutiche, tutta l’industria medico-sanitaria, ma non solo, poiché ogni sostanza che entri in contatto con l’umano deve essere prima testata su animali) è quello di presentare il tipico caso-limite, la situazione estrema in cui si è costretti a operare una decisione ardua e discriminante: chi salvi, tua figlia o il cane? Il bambino o la ratta nel laboratorio? È sempre una questione di vita o di morte e tertium non datur – per cui ci sarebbe innanzitutto da obiettare se si tratti o no di una vera e propria scelta, o non si tratti piuttosto di una domanda retorica, considerato che per il sentire comune non è veramente possibile sacrificare una vita umana al posto di una animale. Il termine sacrificio scelto dai vivisettori per descrivere la morte delle cavie alla fine di una vita di torture, (quando, decapitate o altro, sono gettate via come strumenti ormai inservibili) richiama una sfera religiosa che vorrebbe forse avvolgere la pratica dell’aura dorata delle cause superiori, per non dire superne, di cui gli umani diverrebbero meri esecutori in terra: esecutori dell’inevitabile o della necessità di cui si fa virtù. (E dovremmo seriamente prendere in considerazione il potere di una scienza che si pone come religione della nostra era). Con l’articolo Your Daughter or Your Dog del 1991, pubblicato in The Feminist Care Tradition in Animal Ethics (raccolta di saggi sull’etica del care in campo animale e l’ecofemminismo curato da Josephine Donovan e Carol J. Adams, edito dalla Columbia University Press nel 2007)1 l’approccio di Deborah Slicer alla questione è piuttosto originale nella sua posizione controcorrente, seppur non definitiva. Slicer infatti giunge a conclusioni che non pongono la parola fine alla discussione sulla ricerca biomedica effettuata su cavie animali, ma che piuttosto ne aprono gli orizzonti nell’auspicio che la presenza di altre voci ne riprenderanno le fila per tessere un più ampio e variegato discorso, includendo punti di vista e aspetti non ancora considerati. Perché, Deborah Slicer dice, la questione della ricerca biomedica è stata ed è ancora presentata da quella che Carol Gilligan ha definito “tradizione della giustizia” nella filosofia morale e politica – in cui Peter Singer e Tom Regan sono accomunati – un approccio che non rappresenta correttamente le relazioni morali che intrecciamo con gli animali. 1 Deborah Slicer, “Your Daughter or Your Dog”, in Josephine Donovan-Carol J. Adams (eds.), The Feminist Care Tradition in Animal Ethics. A Reader, Columbia University Press, New York 2007 pubblicato per la prima volta in “Hypatia”, VI, 1, 1991, pp. 108-124. © DEP ISSN 1824 - 4483 Michela Pezzarini DEP n. 23 / 2013 Slicer articola il suo saggio in paragrafi in cui analizza e critica sia l’approccio utilitaristico di Peter Singer che quello giusnaturalistico di Tom Regan: entrambi i teorici della liberazione animale, ad esempio, giustificano il sacrificio (ancora!) di chi non ha interessi per il bene in favore di chi ne ha. La critica che Slicer muove a quello che definisce essenzialismo morale di Singer e Regan è chiara e si articola in diverse motivazioni: innanzitutto l’essenzialismo rende inessenziali e irrilevanti certe relazioni come quelle familiari o amicali; in secondo luogo, l’essenzialismo spoglia l’individuo (animale o umano) della sua storia specifica, insieme alla sua unicità affettiva ed emotiva. Nello specifico, le teorie dei diritti animali riducono gli individui a quei cumuli atomizzati di interessi che la tradizione filosofica della giustizia riconosce come la base per poter essere considerati soggetti morali: gli animali quindi vi sono rappresentati secondo quel tipo di capacità che è tipica degli esseri umani, contemplata come il valore che permette di vivere una vita umana “piena”. In questo includere gli animali nella comunità morale in base ad un concetto di “sameness” (un’uguaglianza intesa come non-diversità), Slicer percepisce – come Marti Kheel e altre ecofemministe (e Irish Murdoch prima di loro) – quell’arroganza del voler assimilare a sé “l’altro”, in una sorta di fusione che cancella differenze e peculiarità individuali. L’arrogante essenzialismo ricrea le gerarchie morali e il pensiero dualistico in modalità che fondano inferiorità e subordinazione, mentre “non vi è ragione che dalle differenze, dall’indipendenza e dall’indifferenza degli animali non nascano scambi e relazioni basate su atteggiamenti eticamente significativi quali il rispetto, la gratitudine, la compassione, il senso di fratellanza o sorellanza e lo stupore” (p.110). Sappiamo ormai che tali relazioni sono non solo praticabili e moralmente consone, ma anche fruttuose dal punto di vista epistemologico, mentre le gerarchie di valori dualistiche (giustizia vs. emotività) categorizzano donne, animali e natura nonsenziente collocandoli su uno dei due lati opposti, funzionali alla loro oppressione: non solo Singer e Reagan mancano di approfondire l’uso che la nostra società fa di tali gerarchie dualistiche, ma le loro teorie della “liberazione” non farebbero altro che perpetuare tale approccio di pensiero. Il secondo aspetto dell’etica della giustizia che Slicer pone in discussione è la tendenza a generalizzare e a fornire caratterizzazioni astratte delle situazioni morali alle spese dei particolari del singolo contesto, di cui vanno perduti i dettagli storici, sociali, economici, familiari e altri, essenziali per la valutazione di una situazione, di una decisione presa o da prendere o anche di una persona. Questa tendenza è funzionale alla formulazione di principi generali e prescrittivi, poi applicati a situazioni descritte in modo superficiale: per la sperimentazione biomedica, come per il vegetarismo, Regan e Singer riconoscono agli animali (applicando la loro severa e imparziale considerazione) un interesse superiore a quello degli umani – cioè quello di mangiarli e di utilizzarli come cavie. A questa conclusione pervengono grazie ad un principio di giustizia stabilito in precedenza assieme al riconoscimento della forza del desiderio di non morire degli animali – riconoscimento e principio che dovrebbero essere evidenti a chiunque si affidi alla logica. A questo punto, Deborah Slicer ricorda che, almeno a partire da Carol Gilligan, compito centrale del pensiero femminista in campo morale è stato quello di valutare il ruolo, la collocazione e la natura dei principi nella vita morale, per giungere spesso alla conclusione 155 Michela Pezzarini DEP n. 23 / 2013 che una “moralità di principi” non lascia spazio alla virtù e all’affettività, fondamentali nella concezione stessa di moralità. Se la scuola e i libri spesso ci insegnano che utilitarismo e giusnaturalismo sono le uniche opzioni “ragionevoli”, dobbiamo metterle in discussione o in alcuni casi non potremo prestare ascolto a quello che ci suggeriscono l’immaginazione e il cuore – o a quello che molto semplicemente ci dicono i fatti – per far rientrare ogni diversa situazione entro il “principio” (con tutta la sua impalcatura teorica). Un approccio basato sul principio inoltre semplifica eccessivamente le nostre relazioni affettive e potenziali con gli animali, oltre che privarci dell’opportunità di relazionarci a loro e di operare scelte responsabili di pratiche che riguardano direttamente la loro vita – pensiamo alle nostre scelte alimentari, di prodotti per l’igiene personale e di medicinali. La fiducia assoluta che Singer e Regan attribuiscono alla ragione, in quanto universale, inoltre, se a molti critici e critiche può sembrare ingenua, si basa anche su una certa insensibilità nei confronti della psicologia morale, se non un vero e proprio disprezzo (tutto occidentale, e forse maschilista) per l’emotività, considerata come una “cosa da donne”. Il loro approccio rientra comunque nella tradizione che polarizza ragione ed emotività, preferendo la prima quando le due confliggono. Slicer a questo proposito dichiara che non esiste una formula prestabilita che ci permette di stabilire quanto peso debbano avere i nostri sentimenti nel risolvere dilemmi che riguardano relazioni pubbliche o private; senza dubbio esistono situazioni meglio risolvibili affidandosi ad un principio di massima che sia imparziale e spassionato, ma è anche vero che spesso si tratta di una “sensibilità unificata” in cui emozioni e pensiero si fondono. Sia per fare delle scelte responsabili che per articolare nuove visioni morali (estremamente necessarie), resta quindi di vitale importanza l’esperienza diretta di tutte le conseguenze che portano con sé le nostre decisioni morali. Nel caso della sperimentazione biomedica si consulteranno dunque studi ben documentati da cui si evincerà che spesso gli animali sono utilizzati in eccesso o male per ricerche irrilevanti o ripetitive fino all’inutilità; che non ci si avvale di alternative non-animali o che non se ne sviluppano; che spesso i ricercatori utilizzano specie con bisogni psico-sociali più elevati di quanto sia necessario all’esperimento; che le cavie possono essere modelli inattendibili come modelli umani; che nei laboratori le normative che dovrebbero proteggere gli animali non vengono rispettate o sono largamente inadeguate. Slicer fa risalire l’approccio alla sperimentazione biomedica alla strategia tipica di un sistema di controllo patriarcale in cui la materia (vivente) viene spezzata e artificialmente ricombinata per essere immessa sul mercato in forma tale da richiedere la nostra gratitudine (e così avviene anche per la vita degli animali). Naturalmente queste considerazioni sono note a Singer e Regan, che però ritengono di non doverle affrontare nel nome di una rivendicazione abolizionista in termini morali; il fatto è, però, che per molte persone la questione della sperimentazione sugli animali è una questione di quando e come debba essere fatta, come avviene per l’eutanasia o la “guerra giusta”, piuttosto che una questione morale tout court (Slicer precisa che la sperimentazione non è affatto paragonabile all’eutanasia o alla “guerra giusta”, ma che piuttosto le modalità con cui le persone si rapportano ad essa sono simili). Caratterizzare quindi la questione senza tenere conto delle ca156 Michela Pezzarini DEP n. 23 / 2013 ratteristiche, delle procedure e di altri elementi contestuali – incluso l’approccio del pubblico – la rende fuorviante, se non irrilevante, agli occhi di chi non abbia già optato per l’inaccettabilità morale della pratica. Se Regan differenzia tra sacrificio istituzionalizzato ed eccezionale – e ci lascia riflettere sull’accettabilità del secondo, che contemplerebbe la valutazione caso per caso per poter decidere se si tratti di un caso “estremo” o no (e ci sarà certo bisogno di criteri che permettano di identificare quando un caso non è di “routine”), Singer ricorre all’argomentazione basata sull’onere della prova. Ovvero, al ricercatore che sostenga la necessità di eseguire un certo esperimento su animali si deve chiedere se sarebbe disposto ad utilizzare un essere umano del medesimo livello intellettivo. Come non vedere però che anche la comunità che si appella ai diritti avrà l’onere di giustificare il non utilizzo degli animali, soprattutto alla luce di una perdita di vantaggi futuri? Slicer evidenzia che l’impasse utilitaristica, stranamente vista da Singer come una vittoria, è in realtà un vicolo cieco: sostenere infatti che non vi sono argomenti per difendere la posizione non fa assolutamente sparire il problema, ma è piuttosto un’indicazione di come l’utilitarismo, in sé e per sé, non sia in grado di offrire soluzioni a tale impasse. Al contrario, l’utilitarismo potrebbe rivelarsi come parte del problema stesso, ossia: una caratterizzazione super partes e fuorviante di una questione può farla apparire irrisolvibile. È interessante che Slicer offra una terza via che non è prevista né dalla letteratura per i diritti animali (che sostiene che i legami affettivi non contano nulla, come nell’ apertura di Liberazione animale di Singer), né dalla comunità scientifica (per cui contano in assoluto: tua figlia o il cane?): una possibilità che include l’esistenza di altri modi di porre il problema, trascendendo la contrapposizione di due letture antitetiche. Vi sono infatti degli aspetti alquanto significativi della questione che vengono regolarmente trascurati: innanzi tutto come giustifichiamo il sacrificio di esseri vulnerabili e innocenti per i nostri fini di individui che detengono il potere su di loro? Da cui anche la questione – sempre aperta, quando si parla di animali – della “legge del più forte”: pensiamo ad animali catturati in natura o geneticamente generati per essere usati per soddisfare i bisogni di altri. E ogni femminista conosce (e riconosce) bene questa forma di arroganza, che giustificare come atteggiamento (e nelle pratiche) significa perpetuare. Inoltre, si può considerare “civilizzata” una società che si appropria di esseri contro la loro volontà e discernimento per utilizzarli in ricerche dolorose e mortali? Secondo Slicer ciò si riallaccia al concetto di sadismo culturale, in cui gli atti violenti sono neutralizzati in virtù del fatto che sono molto comuni: la società che è apatica rispetto alle morti nei laboratori di centinaia di migliaia di animali all’anno, è la stessa che permette che decine di migliaia di donne siano ammazzate da mariti e compagni. Gli atti di violenza sulle donne e quelli sugli animali vengono neutralizzati in modo analogo. L’ultimo argomento, ma non certo il meno importante, è quello della schizofrenia affettiva di un paese (Slicer si riferisce agli Stati Uniti, ma la similitudine con qualunque altro paese occidentale è presto fatta) che spende enormi cifre per i propri “animali da compagnia” e allo stesso tempo investe pesantemente in ricerca effettuata sulla pelle (sul corpo) di gatti, cani, conigli e criceti e non solo. 157 Michela Pezzarini DEP n. 23 / 2013 La domanda inevitabile è, dunque: come e perché limitiamo la nostra immaginazione (individuale e collettiva) in tale modo? Rimuovere tutto ciò non equivale forse a rimuovere il sofisticato meccanismo emotivo che stimola questa situazione, assieme alla responsabilità morale (individuale e collettiva) che la accompagna? Josephine Donovan nel saggio Dal care al dialogo: il femminismo e il trattamento degli animali2 (che conclude The Feminist Care Tradition in Animal Ethics), articola molto chiaramente quanto il punto di vista degli animali e il nostro continuo e attento dialogo con essi vadano ad arricchire quella capacità che permette contemporaneamente di capire meglio loro e di nutrire la nostra facoltà empatica una funzione dell’animo umano, quest’ultima, che può essere appresa e quindi anche insegnata3. Ovviamente, approfondisce Slicer, per gli animali nei laboratori non si possono provare gli stessi sentimenti che si provano per il cane e il gatto che sono i compagni di una vita (proprio come avviene con i sentimenti che si provano per i bambini che non sono i propri figli), ma ribadisce comunque l’importanza dei legami, che sono appunto tali e che quindi non si devono relegare in qualche angolo al fine di garantire una cieca imparzialità. Se non possiamo provare gli stessi sentimenti per tutti, possiamo però estendere i nostri sentimenti, il nostro interesse, la nostra cura a chi ci è meno vicino; questo avviene attraverso l’empatia e l’immaginazione morale, che sono certamente in grado di oltrepassare i confini di specie. La conclusione a cui Slicer perviene è aperta: è ovvio che non tutte le persone che estendono il proprio interesse empatico a comprendere gli animali da laboratorio automaticamente condanneranno la sperimentazione su di essi, ma di certo smetteranno di giustificare con la superficialità nota tale pratica, di cui si verrà a riconoscere l’aspetto tragico: quello che ci obbliga ad operare delle scelte morali nonostante la quasi totale assenza di precedenti e senza quasi avere la possibilità di sapere se si è fatta la scelta giusta. La conclusione dell’articolo getta dei ponti verso le interpretazioni a seguire che riprenderanno le fila del discorso iniziato su un argomento tanto dibattuto ed estremizzato, la cui lettura alla luce dell’etica del care e della posizione ecofemminista inizia a scandagliare quella sensazione di ambivalenza che l’autrice prova riguardo la questione. L’auspicio che altre e altri la riprendano e approfondiscano per articolare l’analisi oltre le molteplici diramazioni di vaghe – e dogmatiche – semplificazioni suggerisce un percorso che, nel 2013, è già (anche se solo in parte) strada battuta. Michela Pezzarini 2 La traduzione italiana di Michela Pezzarini è pubblicata nel numero 2 di “Musi e Muse – rivista online di teorie e pratiche tra genere e specie”, www.musiemuse.org. 3 Susan Sontag, Davanti al dolore degli altri, trad. it. di Paolo Dilonardo, Mondadori, Milano 2003. 158 Femminismo, economia, beni comuni. Note a margine del II Convegno internazionale Economics and the Common(s), Heinrich Böll Foundation, Berlino, 22-24 maggio 2013. Il 24 maggio scorso si è concluso a Berlino il II Convegno internazionale organizzato dal Commons Strategies Group1 e dalla Heinrich Böll Foundation: Economics and the Common(s): from Seed Form to Core Paradigm. Nella convinzione che i beni comuni – ovvero la gestione condivisa di beni necessari alla vita su base di equità e sostenibilità –, la loro rivendicazione, difesa e creazione in ogni ambito della vita sociale possa rappresentare la sola alternativa al paradigma della crescita illimitata e all’economia di mercato, il convegno si proponeva di esplorare e aprire nuove prospettive per il mutamento sociale, politico e culturale. Uno dei più rilevanti impedimenti al mutamento sociale positivo – si legge nella presentazione del convegno – è il radicamento del potere del fondamentalismo del mercato come paradigma economico e politico. In base al dogma prevalente solo l’interesse individuale, i diritti espansivi dei diritti individuali di proprietà, lo scambio mercantile e il libero mercato globalizzato possono promuovere il benessere umano. Questa visione è stata progressivamente messa in discussione nel momento in cui le dinamiche dell’economia di mercato si sono rivelate predatorie, una minaccia per la biosfera2. All’evento hanno partecipato ben 240 persone – studiosi, attivisti, sostenitori – di 30 diversi paesi. Oltre all’approfondimento delle tematiche legate ai beni comuni, alla promozione iniziative e progetti, al confronto delle esperienze, lo scopo precipuo del convegno era rivolto al superamento delle divisioni – tra nord e sud, tra attivismo e riflessione teorica, e soprattutto tra diversi modi di intendere i beni comuni che molto spesso considerano solo quelli che appartengono alla sfera naturale, escludendo quelli che pertengono alla vita civile e sociale. Una esclusione criticata da più parti e in particolare dal pensiero femminista3. La prospettiva di genere è stata centrale nell’impostazione dei lavori. Lo ha affermato Barbara Unmüßig, presidente della fondazione Heinrich Böll, nella sua relazione introduttiva. L’attenzione rivolta negli ultimi anni dalla Fondazione all’economia femminista, all’ ecofemminismo, ai nuovi movimenti femminili e alle loro utopie, al rapporto tra degrado ambientale, mutamenti climatici e condizione delle donne, al lavoro della sussistenza, si è concretizzato in numerose pubblicazioni, in 1 Un gruppo di studiosi e attivisti da molti anni impegnati dal punto di vista teorico e pratico sul tema dei beni comuni. Tra essi ricordo David Bollier-Silke Helfrich, curatori del volume The Wealth of the Commons: a World Beyond Market and State, Heinrich Böll foundation, Berlin 2012. All’interno di una bibliografia ormai vastissima l’opera è un punto di riferimento fondamentale, sia per le esperienze che gli approcci teorici. Il primo convegno si era tenuto nel 2010. 2 Si veda la presentazione all’indirizzo:http://p2pfoundation.net/ECC2013#Goals_of_the_Conference. 3 Rimando in particolare alla definizione di commons formulata dalle autrici e dagli autori del volume curato da Terisa E. Turner (ed.), Gender, Feminism and the Civil Commons = Genre, féminisme et la commune civile, University of Ottawa & Canadian Association for the Study of International Development, Ottawa 2001: “The civil commons can be defined as any cooperative human construct that enables the access of all members of a community to life goods”. La citazione è tratta dal saggio introduttivo di John McMurtry, The Life-Ground, the Civil Commons and the Corporate male Gangs, http://www.uoguelph.ca/~terisatu/gc.htm. © DEP ISSN 1824 - 4483 Heinrich Böll Foundation DEP n. 23 / 2013 zioni, in particolare nella monografia di Christa Wichterich, The Future We Want. A Feminist Perspective (2012)4. Scrive Barbara Unmüßig nell’introduzione al volumetto: I modelli e le utopie economiche ed ecologiche femministe stanno riguadagnando terreno. Per la Fondazione Heinrich Böll è cruciale dare voce a queste idee e dare loro un maggiore rilievo all’interno del più ampio discorso su un mondo equo post-crescita. [...] A nostro parere il dibattito sull’ economia ecosostenibile, sulla crescita e sui nuovi modelli di prosperità è una grande opportunità per richiamare l’attenzione sull’ecologia femminista e sulla sostenibilità in una prospettiva di genere, e di riportare queste visioni nell’agenda politica (pp. 7-8). L’opuscolo di Christa Wichterich si soffermava sul concetto di caring economy, concetto centrale nella riflessione economica femminista, principio fondamentale di ogni attività economica, punto di partenza per la formulazione di alternative possibili all’economia di mercato per la soddisfazione dei bisogni fondamentali. La ridefinizione dell’attività umana nel suo complesso, oltre il mercato e la remunerazione, la valorizzazione del lavoro di cura volto alla riproduzione sociale e alla rigenerazione della natura, è dunque inscindibile dalla questione dei beni comuni5. Al convegno questa tematica è stata sviluppata nella sezione dedicata al lavoro: Working and Caring in a World of Commons che, nell’intento degli organizzatori, avrebbe dovuto essere un punto di riferimento fondamentale per tutte le altre sezioni dedicate rispettivamente alla terra e alla natura, alla moneta e al mercato, alla cultura e alla scienza, alle infrastrutture. Riconoscere il complesso del lavoro necessario alla sussistenza – si legge nella presentazione della sezione – è una precondizione per superare la separazione tra sfere economiche di produzione (economia basata sul debito) e di riproduzione (economia basata sul tempo) [...] e questo è un pensiero intrinsecamente femminista. Sbarazzarsi di una nozione limitata di lavoro, inteso come “occupazione”, separato dall’attività fondamentalmente umana di riproduzione della vita e subordinato alle regole del mercato è dunque il primo passo di un percorso trasformativo. In questa prospettiva la relazione introduttiva di Daniela Gottschlich, Doing Away with “Labour”: Working and Caring in a World of Commons, ha affrontato il rapporto tra caring e commoning. I due concetti – ha spiegato la studiosa dell’Università di Lüneburg – hanno importanti elementi in comune: entrambi criticano la cultura della competizione e il paradigma della crescita illimitata, pongono un’enfasi particolare su cooperazione, reciprocità e responsabilità. Tuttavia, mentre nel caso della gestione dei commons si tratta di cooperazione tra individui con uguali diritti e condizioni, che agiscono sulla base di una libera scelta, nel caso del lavoro di cura, ovvero di attività riproduttive, si tratta per lo più di lavoro indispensabile, molto spesso compiuto in condizioni di dipendenza, che ha a che fare con la fragilità. Come combinare caring and commoning, come fondere i due prin4 Le pubblicazioni della Fondazione sono in gran parte liberamente scaricabili dal sito: http://www.boell.de/publications/publications.html. 5 Sulla riflessione femminista sui beni comuni oltre a Terisa E. Turner (ed.), Gender, Feminism and the Civil Commons, cit., si veda la traduzione in italiano del saggio di Silvia Federici, Feminism and the Commons nel numero 20 di questa rivista e la recente intervista rilasciata dall’autrice il 7 marzo 2013 a marina Vishmidt Permanent Productive Crisis:An Interview with Silvia Federici, http://www.metamute.org/editorial/articles/permanent-reproductive-crisis-interview-silvia-federici#. 160 Heinrich Böll Foundation DEP n. 23 / 2013 cipi per trasformare il sistema economico? L’unico modo per realizzare un vero mutamento risiede, a parere dell’autrice, nel porre l’attività riproduttiva umana e la rigenerazione della natura al centro di ogni commoning, ovvero di ogni attività volta a creare commons, nel saper cogliere “la produttività della riproduzione”, naturale e sociale, connettendo giustizia sociale, ambientale e di genere. Il tema del ruolo delle donne, protagoniste indiscusse dei conflitti ambientali nei paesi del Sud del mondo per la difesa e la conservazione dei beni comuni, è stato più volte toccato nel corso del convegno. Mariastella Svampa, sociologa e filosofa, docente alla Universidad Nacional de la Plata, nella sua relazione introduttiva dedicata all’America Latina6 (Commons Beyond Development: The Strategic Value of the Commons as a Paradigm Shift) ha messo in rilievo la cultura del “cuidado” come aspetto etico fondamentale che ha guidato e guida le donne delle varie comunità nell’opposizione alla sottrazione della terra e dei beni comuni7. Ma è stata soprattutto la studiosa e attivista indiana Soma Parthasarathy Kishore ad affrontare, in uno dei numerosi incontri collaterali di approfondimento e discussione, il tema dei commons da una prospettiva femminista. Nel suo intervento: A Feminist Perspective on the Commons as Process, elaborato insieme a Richa Audichaya, Soma Parthasarathy Kishore ha ricostruito l’importanza dei beni comuni nell’economia di sussistenza in India. Una “tradizione vivente” nell’agire e nel sapere delle donne, fondata su “una reciprocità simbiotica di nutrimento e rigenerazione, su conoscenze e pratiche che si sono sviluppate nei secoli”. Una tradizione del dono, basata sul principio del ricevere e del creare abbondanza, un modo di vivere, un processo che raramente viene colto e preso in considerazione nella sua complessità e nel suo valore. Sul lavoro del curare e del nutrire necessario alla sussistenza delle comunità, infatti, prevale un’ignoranza diffusa, in particolare sulle sinergie, i processi, le conoscenze che esso richiede. “La semplicità dei bisogni è intessuta in una sottile trama di relazioni di dono e di reciprocità” che impedisce il sorgere di accumulazione e conflitti. Una analisi femminista dei commons rivelerebbe che l’essere radicati in cicli di dare e ricevere da un ambiente naturale di abbondanza e guidato dalla semplicità dei bisogni ha evitato la tentazione dell’accumulazione [...] Il “lavoro” da un punto di vista femminista sui commons deve incorporare l’agire e i processi messi in atto in un contesto di abbondanza naturale nonché i processi condivisi di produzione al fine del benessere nel senso più profondo8. La sottrazione dei commons, spazi vitali ed entità sociali, è una frattura profonda che conduce all’alienazione, all’emigrazione, alla violenza, come accade nella struttura socioeconomica patriarcale capitalistica caratterizzata dal dominio sulle donne e sulla natura. 6 Altre due relazioni introduttive ai lavori del convegno sono state tenute da Stefano Rodotà (Consituting the Commons in the Context of State, Law and Politics) e da Silke Helfrich e david Bollier (What Do We Mean by Economics and the Commons?). 7 Com’è noto, i conflitti in tutto il continente sono in aumento. I conflitti sulle risorse minerarie, ha ricordato Mariastella Svampa, sono passati da 120 nel 2010 con un coinvolgimento di 150 comunità a 161 nel 2012 con un coinvolgimento di 212 comunità a ben 184 nei soli primi quattro mesi del 2013 con un coinvolgimento di 253 comunità. 8 Cito dall’intervento dell’autrice che ringrazio per avermi consentito di leggere nella sua versione scritta. 161 Heinrich Böll Foundation DEP n. 23 / 2013 Impossibile rendere conto dei dibattiti, degli scambi avvenuti nel corso del convegno e che tuttora proseguono nei blog approntati nel sito della fondazione. La rilevanza dell’evento che ho inteso sottolineare e che ne fa un punto di riferimento fondamentale è la consapevolezza dell’imprescindibilità di una prospettiva di genere nell’analisi critica del capitalismo, nelle pratiche quotidiane, nelle strategie di mutamento sociale. Una consapevolezza ancora ben lontana dall’essersi affermata nel pensiero critico della crescita illimitata. 162 Federica Frediani-Ricciarda Ricorda-Luisa Rossi (a cura di) Spazi Segni Parole. Percorsi di viaggiatrici italiane, Prefazione di Luca Clerici, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 282. Sono numerose le voci che nel volume a cura di Federica Frediani, Ricciarda Ricorda e Luisa Rossi raccontano altrettante esperienze di viaggio tra il XIX e XX secolo. I pregi di un lavoro quale Spazi Segni Parole vedono innanzitutto, come sottolinea anche Luca Clerici nella Prefazione, la valorizzazione di esperienze femminili – peraltro di grande rilievo nel panorama culturale loro coevo – oggi a rischio di oblio. Coltivare la memoria di tali e tante figure contribuisce non solo a un progresso importante sul fronte degli studi odeoporici, in stretto rapporto con l’imagologia e con la rappresentazione dell’ “alterità” in differenti momenti e contesti, ma vede anche un ulteriore tassello nella tanto ampia quanto rimossa storia delle donne. Le figure femminili raccontate in questo volume hanno spesso guardato al viaggio come condizione strutturale, non eccezionale, delle loro esistenze, documentandolo in varie lingue e in differenti tipologie di scrittura. Un ulteriore pregio del volume consiste infatti nei criteri di selezione delle opere, che non hanno inteso la scrittura in italiano come unico paradigma, proprio perché avrebbe causato l’esclusione di biografie di grande pregnanza, condannandole a ulteriori silenzi. Le esperienze di una viaggiatrice come Carla Serena, nata ad Anversa negli anni Venti dell’Ottocento, moglie del patriota veneziano Leone Serena ed esploratrice di regioni ostili e poco conosciute quali quelle caucasiche, non sarebbero potuto rientrare in questo corpus se si fosse guardato al criterio stringente della composizione in lingua italiana; parimenti Dora d’Istria, intellettuale poliedrica e di grande rilievo nella seconda metà del XIX secolo, autrice in francese di testi dedicati alla storia delle donne con uno sguardo particolare al Sud-est europeo, non sarebbe stata contemplata se le curatrici si fossero attenute al criterio monolinguistico. Un terzo elemento di valore è rappresentato dall’eterogeneità delle opere considerate, che attraversano molteplici ambiti del sapere: citando alcune delle autrici indagate, la prospettiva letteraria spicca maggiormente nell’opera di Luigia Codemo raccontata da Alberto Zava e in quella di Annie Vivanti per la penna di Marco Sirtori; il racconto etnografico caratterizza le scelte narrative di Amalia Nizzoli e Carla Serena secondo la lettura di Anna Vanzan; diari di viaggio sono redatti dalla Baronessa di Villaurea, Giuseppina Croci e Carla Novellis raccontate da Luisa Reina, ma anche da Carla Serena nel saggio di Françoise Ardillier-Carras; il reportage giornalistico è la forma prescelta da Caterina Pigorini Beri e Cesira Pozzolini Siciliani nel saggio di Ricciarda Ricorda e da Matilde Serao in quello di Luca Bani; infine, Francesca Bonardi raccontata da Luisa Rossi trova particolarmente congeniale la documentazione fotografica, che peraltro arricchisce il volume stesso, permettendo a chi legge di avvicinarsi ulteriormente ad alcune di queste biografie (le immagini riguardano in particolare Virginia Oldoini, Eva Mameli Calvino e Francesca Bonardi). Le curatrici non hanno inoltre posto limiti nel considerare le mete delle viaggiatrici, che attraversano molteplici continenti – dall’Europa al Vicino ed © DEP ISSN 1824 - 4483 Frediani-Ricorda-Rossi DEP n. 23 / 2013 Estremo Oriente, dal Maghreb agli Stati Uniti – conferendo al volume un respiro pressoché planetario e rendendolo prezioso repertorio a cui attingere dal punto di vista imagologico. I confini – intra ed extra testo, intesi nella loro materialità e in un’accezione più astratta – sono continuamente attraversati e rimessi in discussione: l’impostazione teorica che struttura il volume e le esperienze che raccoglie contribuiscono a un ripensamento della nozione di confine, mostrandone la sua superabilità e relatività. Lo “scarto” (p. 34) rispetto alle rappresentazioni diffuse dell’ “altro/a”, in particolare orientale, rappresenta un’ulteriore peculiarità di alcune delle testimonianze indagate: l’esempio di Cristina di Belgiojoso è in tal senso indicativo, come Federica Frediani illustra nel saggio destinato alla intraprendente italiana che offre una visione del tutto antistereotipata delle donne orientali oggetto del suo sguardo. Parimenti anche le egiziane al centro delle descrizioni di Amalia Nizzoli raccontata da Anna Vanzan sono tratteggiate con un approccio libero da pregiudizi, del tutto anomalo se si considera che Le memorie sull’Egitto sono datate 1841. Da parte sua Annie Vivanti, per la penna di Marco Sirtori, esibisce un “atteggiamento di sincera apertura a un mondo altrimenti osservato, in prospettiva maschile, dall’altezza della superiorità di razza e di classe” (p. 205), a proposito dell’Egitto in cui soggiorna negli anni Venti del Novecento. Il medesimo approccio è condiviso da Mantea, nom de plume di Gina Sobrero, che diviene consapevole di alcune sue considerazioni un po’ affrettate nei confronti degli Stati Uniti che osserva negli anni Ottanta dell’Ottocento; meno consapevole appare invece l’altra viaggiatrice affiancata da Ambra Meda a Mantea, Adriana Dottorelli, che nel 1933 dà alle stampe Viaggio in America: in tal caso gli States rappresentano semplicemente una meta turistica e forse per questo vengono descritti con “il tono un po’ pedestre del baedeker” (p. 236). Proseguendo lungo il filo della rappresentazione dell’ “altro”, interessanti paiono gli sguardi rivolti alle colonie africane presentati nel saggio di Isabella Bonati: seppure spesso condizionati dalla retorica fascista imperante, offrono una visione mediata da uno sguardo femminile spesso più attento ai dettagli e alle sfumature di quanto i viaggiatori uomini offrissero dei medesimi territori. La curiositas di ampio respiro che caratterizza una donna come Elena d’Orléans duchessa d’Aosta, che ripetutamente si reca in Africa Orientale nel primo trentennio del Novecento, è comune a molte altre scrittrici e permette una conoscenza etnografica dettagliata grazie alle rigorose descrizioni di ciò che osserva, con particolare attenzione alla sfera femminile. Di tutt’altro tenore appaiono i resoconti di Gina Lombroso e Eva Mameli Calvino raccontate da Carlo Gemignani e Loretta Marchi. Nell’America Meridionale (Brasile, Uruguay, Argentina): Note e impressioni della prima si trovano precise osservazioni di natura sociologica, antropologica, ma anche naturalistica. Inoltre, l’attenzione alla questione femminile, comune a molte altre viaggiatrici, si sviluppa in un capitolo specifico dell’opera, che poi vedrà successivi sviluppi e pubblicazioni che porteranno Gina Lombroso “almeno ad aggirare l’assunto dell’inferiorità biologica della donna nei confronti dell’uomo, punto fermo delle teorie del padre” (136). Sarà invece Cuba a rappresentare un “punto di svolta” (240) nella vita di Eva Mameli Calvino, dove a partire dal 1920 dirige il dipartimento di botanica della Stazione agronomica di Santiago de las Vegas, nei 164 Frediani-Ricorda-Rossi DEP n. 23 / 2013 pressi dell’Avana: la sua esperienza di viaggio non si traduce in scritti odeporici, ma in elaborazioni scientifiche legate alla sua professione: “il suo attraversamento della realtà locale è sempre quello specialistico della studiosa” (p. 241). Da questa breve disamina emerge il mosaico composito che Spazi Segni Parole rappresenta: in esso troviamo mete diversificate, viaggiatrici spinte a partire da molteplici ragioni (per diletto, per dovere, in esilio), in solitudine o in compagnia, autrici di opere in lingue diverse e dai generi difficilmente definibili, spesso corredate da bozzetti e fotografie. Tale pluralità di temi, stili e vite non offre tuttavia una impressione di dispersività in chi legge, ma al contrario tratteggia una panoramica ampia dei tanti significati che il viaggio assume per le donne. Esso si può tradurre in esperienza di libertà e di conoscenza (dell’altro e di sé), di empowerment o, in altri termini, di passo verso “il pieno godimento della cittadinanza e dell’emancipazione personale” (p. 123). In conclusione, la varietà degli spunti offerti rende il volume non solo un importante punto di arrivo, ma anche luogo metaforico di (nuove) partenze per coloro che volessero approfondire un tema così ricco, centrale e poliedrico quale è quello della scrittura di viaggio. Silvia Camilotti 165 Silvia Camilotti, Ripensare la letteratura e l’identità. La narrativa italiana di Gabriella Ghermandi e Jarmila O!kayová, Bononia University Press, Bologna 2012, pp. 178. La “letteratura della migrazione” in lingua italiana è approdata, negli anni più recenti, a una fase nuova, avanzata, della propria crescita e, significativamente, in questo processo un ruolo di primo piano ha svolto la scrittura femminile: infatti, grazie a narrazioni dovute a voci di donne si è giunti al confronto vivo con la tradizione letteraria tradizionale e a un’inedita riflessione sull’identità italiana, sottratta alla logica della paura e della diffidenza e intesa al contrario come sfida epistemologica centrale nella contemporaneità. In questa direzione si colloca la ricerca di Silvia Camilotti, che ha il merito di proporre una nuova prospettiva di analisi, focalizzata sull’articolazione tematica e sull’alto livello formale delle narrazioni, a dimostrare la necessità di integrare l’attenzione per la dimensione socio-antropologica dei testi con la rilevazione del loro interesse sul piano letterario, linguistico ed estetico e a renderne così possibile l’inquadramento, a pieno titolo, nel panorama della letteratura italiana contemporanea. È questa l’ottica che porta l’autrice a usare le virgolette per la categoria di “letteratura della migrazione”, sulla cui legittimità da tempo avanza dubbi e perplessità (Camilotti 2008), ritenendola riduttiva, in sintonia con gli studi più recenti in materia, seppure non priva di una sua utilità, soprattutto nel passato. Anche in queste pagine ripercorre le numerose motivazioni che spingono a superare tale “etichetta”, dalla crescente presenza di scrittori di seconda generazione, che non hanno sperimentato in prima persona l’esperienza migratoria e sono stati scolarizzati in lingua italiana, all’articolato rapporto che può realizzarsi tra l’opera e l’esperienza biografica dell’autore, cui può essere fatta allusione anche in termini assai sfumati, al rischio di una collocazione di questa produzione in uno spazio parallelo a quello della letteratura italiana. A postulare il superamento di una simile categoria sono del resto anche i protagonisti, gli autori stessi, che prendono sempre più spesso esplicita posizione in merito: la voce di Igiaba Scego si unisce, proprio in questi giorni, alle testimonianze fornite da Camilotti, invitando dalle pagine del “Corriere della Sera” a salvare gli scrittori di origine migrante dall’etichetta “che costringe tutti loro a vivere in uno spazio letterario ristretto e immutabile”, in un paese sempre più multiculturale, e che rischia “di ridurre il soggetto in oggetto e di gettare disvalore sulle opere”. Se invece si riconoscerà “piena cittadinanza artistica a questa letteratura dalle mille etichette”, conclude la scrittrice, si potrà giungere a “una letteratura italiana finalmente senza confini che possa fregiarsi nel futuro di un Salman Rushdie o di una Zadie Smith tricolore” (Scego 2013). Non vi è dubbio che la via da percorrere per raggiungere una simile meta sia quella qui suggerita da Silvia Camilotti: considerare la letteratura come “il campo privilegiato per sviluppare una presa di coscienza di sé e della realtà circostante” (p. 69), sia per gli autori che per i lettori, attraverso l’analisi delle potenzialità critiche delle opere di questi scrittori «nei confronti di una rappresentazione rigida del concetto di identità, sia essa individuale o collettiva, nonché dei modi in cui tali © DEP ISSN 1824 - 4483 Camilotti DEP n. 23 / 2013 scritture possono ravvivare quel rapporto tra letteratura e società, tra narrazione e identità, che sembra andato perduto» (p. 50). Ecco allora l’indagine svilupparsi in tre capitoli, il primo dei quali è dedicato all’analisi di alcuni fondamentali presupposti teorici, che nei due successivi vengono poi messi alla prova dei testi, Occhio a Pinocchio di Jarmila O!kayová (2006) e Regina di fiori e di perle di Gabriella Ghermandi (2007), esaminati in rapporto ai rispettivi modelli di riferimento, il collodiano Pinocchio e Tempo di uccidere di Ennio Flaiano. Per quanto riguarda i presupposti di ordine teorico affrontati nel primo capitolo, a emergere con particolare evidenza è il nodo problematico dell’identità, cui si accennava sopra: Camilotti condivide l’idea di Francesco Remotti che si tratti di una parola potenzialmente “avvelenata”, nella misura in cui può celare sotto un’apparenza di innocenza una serie di tratti – compattezza, immodificabilità, ereditarietà – non troppo distanti dalle connotazioni del termine “razza”. Al contrario, come sottolineano intellettuali del calibro di un Bauman, un Maalouf o un Todorov, l’identità non può che essere composita, formarsi nell’apertura e nello scambio, tanto più inevitabili quanto più si accentua il carattere multiculturale della società: si arriva così al paradosso “che vede, nel contesto globalizzato e ad alta mobilità di oggi, da una parte l’impraticabilità di una visione statica di individui e società e dall’altra l’avanzare di logiche identitarie che rivendicano istanze di inflessibilità” (p. 24); ecco allora anche la lingua e la cultura nazionali divenire baluardi di un’“ossessione identitaria” destinata a crescere con l’accentuarsi dei fenomeni migratori. Non mancano risposte in controtendenza a tale situazione, come la nozione di “creolizzazione” sviluppata da Édouard Glissant, che intende evidenziare gli scambi e le trasformazioni delle varie culture del mondo, poste però tutte sul medesimo piano, senza gerarchie di valori; interessante risulta poi la rielaborazione del concetto di passing che, nell’accezione ampliata che ne ha fornito Anna Camaiti Hostert, viene a indicare il “tentativo di svincolo dalle catene di una rigida soggettività” (p. 31), nella ricerca di un modello trasversale e plurale. Il punto di arrivo di questa riflessione, da parte di Silvia Camilotti, appare opportunamente calibrato tra i due possibili estremi della “rivendicazione di matrice identitaria” da un lato, “la disidentificazione” dall’altro, a favore della creazione di relazioni paritarie, fondate sul “riconoscimento – non la tolleranza – di ciascuna soggettività nella sua complessità”: visione composita dell’individuo e della società, destinata a essere indubbiamente promossa dalla produzione di autori e autrici migranti. Il secondo nodo problematico affrontato nel capitolo “teorico” del volume riguarda un’ulteriore declinazione della questione dell’identità, ovvero lo stretto rapporto di reciprocità che intrattiene con la letteratura nazionale: è nota la funzione da sempre svolta dalla letteratura nel plasmare la rappresentazione di un paese, tanto in senso nobilitante, quando si è trattato di rafforzare l’identità nazionale, quanto inferiorizzante, con la creazione di stereotipi, laddove ci si è riferiti a rapporti di forza e di conquista. Ai testi letterari può competere pertanto sia il rafforzamento di immagini sedimentate sia la loro decostruzione: possono così influire sui rapporti tra il sé e l’altro, tra l’identità e l’alterità in senso oppositivo e statico, ma anche costruttivo e relazionale: in questo quadro, ancora la 167 Camilotti DEP n. 23 / 2013 scrittura migrante può occupare uno spazio privilegiato, disponibile com’è all’apertura, alla relazione; in particolare, riesce a favorire il decentramento narrativo, con il “rovesciamento della prospettiva eurocentrica, la valorizzazione della relatività dei punti di vista ed il superamento dell’autoreferenzialità” (p. 36). Camilotti approfondisce il discorso in questa direzione facendo riferimento all’imagologia, quel ramo della comparatistica che analizza le rappresentazioni dei popoli in letteratura, evidenziandone i cliché ma individuando anche le componenti storiche e politiche e le tracce del clima dell’epoca in cui le opere si sono formate e che portano con sé; in particolare, la studiosa indaga appunto il contributo che i testi letterari hanno fornito appunto al processo di formazione dell’identità nazionale. Interroga a questo proposito quanti si sono occupati di tale processo e, in particolare, del concetto di carattere nazionale, dall’ormai classico contributo di Giulio Bollati, L’italiano. Il carattere nazionale come storia e come invenzione (1983) alla recente analisi di Silvana Patriarca, Italianità. La costruzione del carattere nazionale (2010), per concludere che, se oggi la scrittura letteraria appare in difficoltà nel rappresentare quanto ora risulta assai confuso e sfuggente, non è stato così durante il processo di fondazione dello stato nazionale, quando due testi per ragazzi come Cuore e Le avventure di Pinocchio hanno svolto un’indubbia funzione nella messa a punto e nel rafforzamento di una certa idea di italiano e di italianità. Appare pertanto particolarmente interessante che una scrittrice di origine slovacca abbia scelto di misurarsi, nel 2006, proprio con uno di questi due libri, il celeberrimo testo di Collodi, dimostrando le potenzialità critiche della letteratura della migrazione nei confronti di un concetto rigido di identità e insieme ravvivando il rapporto tra letteratura e società; è, quest’ultima, un’idea forte che attraversa positivamente tutto il libro di Camilotti e ne chiarisce le intime motivazioni: un’idea di letteratura intesa come “agente, fattore attivo nella e per la società” (p. 63). In quest’ottica sono analizzati, nei due capitoli successivi, sia il testo di Jarmila O!kayová, Occhio a Pinocchio, che quello di Gabriella Ghermandi, Regina di fiori e di perle: a sottenderli entrambi, “il loro essere situati”, in quanto scritti da autrici appartenenti a una categoria generalmente considerata minoritaria e a rischio di subalternità come quella delle donne straniere, “la strategia di riscrittura che mettono in atto, la problematizzazione del rapporto tra identità e narrazione a cui rinviano” (p. 65). Per le due autrici collocarsi all’interno della tradizione letteraria italiana significa allora acquisire nuova consapevolezza di sé come “soggetti attivi”: sfida importante, commenta Camilotti, sia per loro che per i lettori italiani, che hanno modo di confrontarsi con originali riletture di opere canoniche. Si tratta per altro di esempi diversi, ma complementari: nel caso di O!kayová, la re-vision della storia del burattino si inquadra in una molteplicità di diverse interpretazioni toccate nel tempo al testo collodiano, ma acquisisce un significato particolare grazie all’originalità del punto di vista e dello sguardo dell’autrice, che, già prima di emigrare in Italia, nel 1974, aveva pubblicato racconti e poesie, attività che prosegue anche una volta arrivata nella penisola, dedicandosi dapprima alla traduzione di fiabe slovacche e arrivando poi al romanzo. Camilotti sottolinea come l’approdo a Occhio a Pinocchio sia preceduto da tre opere, Verrà la vita e 168 Camilotti DEP n. 23 / 2013 avrà i tuoi occhi (1995) – non sfuggirà l’allusione pavesiana del titolo –, L’essenziale è invisibile agli occhi (1997), Requiem per tre padri (1998), in cui sono già presenti alcuni degli elementi di fondo che confluiranno nel testo del 2006, come la presenza di riferimenti fiabeschi e di allusioni al mondo fantastico, l’attenzione alla natura, con descrizioni ricche di dettagli, la riflessione sul valore delle parole. La studiosa segnala poi, tra le maggiori novità introdotte da O!kayová, la scelta di dare la parola al burattino stesso, essere dall’identità plurale, di legno ma senza fili, e per questo prossimo alla condizione dello straniero, outsider come lui, destinato a scontrarsi con i pregiudizi e le fobie classificatorie di quanti lo circondano: la questione identitaria diviene così centrale e acquisisce maggior drammaticità. Il Pinocchio della scrittrice slovacca, infatti, ha tratti meno ambigui di quello collodiano, è soprattutto un ribelle ai canoni e a una visione predeterminata del mondo e del linguaggio; più che la trasformazione in uomo, ad attenderlo è la scoperta che la libertà dalle barriere reali e metaforiche può essere raggiunta solo se ci si nutre di speranza e di immaginazione. L’operazione letteraria di O!kayová, conclude Camilotti, “non solo rielabora un classico, ma offre un’immagine di identità articolata, che resiste alle categorizzazioni”, sicché “dietro la maschera della fantasia, la scrittrice descrive anche una fase della storia italiana dell’oggi, in cui tante voci marginalizzate chiedono ascolto, rispetto e riconoscimento” (p. 121). Pure il romanzo di Gabriella Ghermandi intrattiene uno stretto rapporto con la storia italiana dell’oggi, trattando del colonialismo italiano, il cui nesso con le migrazioni e le cui conseguenze anche attuali si tende tuttora a minimizzare o a trascurare del tutto. A differenza della scrittrice slovacca, Ghermandi non riprende tutta la vicenda di Tempo di uccidere, ma ne rovescia un’unica scena, quella fondamentale dell’omicidio della giovane Mariam da parte del tenente italiano, cui corrisponde l’uccisione del talian sollato operata dalla donna etiope; tuttavia, il riferimento al romanzo del 1947 è altrettanto centrale, nella misura in cui l’autrice adotta una prospettiva capovolta per raccontare un secolo di storia comune tra l’Italia e il suo paese di origine, l’Etiopia: storia su cui solo in tempi recenti, com’è noto, si è iniziato a focalizzare l’attenzione e a condurre ricerche scientificamente documentate, mentre sembra ancora difficile da scalfire “l’immaginario collettivo in materia di colonialismo, tuttora inteso alla stregua di un’occasione di miglioramento – se non di civilizzazione – delle condizioni di vita dei popoli africani” (p. 127). Tanto più importante diviene allora la presenza di voci che anche in campo letterario sollecitino la riflessione in merito ed è positivo che, negli anni più recenti, se ne annoverino numerose, come testimonia il volume di Daniele Comberiati dedicato alle scrittrici della Quarta sponda (Comberiati 2009). In questo quadro, l’operazione di Ghermandi, che si confronta con uno dei rarissimi romanzi “coloniali” prodotti dalla letteratura italiana, assume particolare rilievo; anche Ennio Flaiano getta sull’impresa italiana uno sguardo disincantato e ne offre una visione articolata: nessuna concessione, nelle sue pagine, alla retorica fascista, che, al contrario, è messa alla berlina, anche se la denuncia non è altrettanto esplicita quanto quella, durissima, affidata alle note di diario scritte durante l’esperienza bellica e pubblicate postume, con il titolo Aethiopia. Appunti per una canzonetta (1935-1936) (Flaiano 1990). In Regina di fiori e di perle 169 Camilotti DEP n. 23 / 2013 l’autrice, da parte sua, propone un’immagine a tutto tondo del popolo etiope e valorizza in particolare il protagonismo femminile, con un netto rovesciamento del discorso coloniale; è interessante però notare come nel racconto di Mahlet, la giovane “cantora” etiope cui è affidato il compito di raccogliere le storie di quanti hanno vissuto l’esperienza coloniale – storie che l’autrice ha fondato su un’attenta documentazione e sulle testimonianze di chi vi è passato attraverso – è forte il senso di condivisione delle vicende, pur vissute su sponde opposte, in vista dell’elaborazione di una memoria che segni finalmente il “tempo di sanare” quella ferita. Sottolinea a ragione Camilotti, a questo proposito, che “l’idea che la ricostruzione di una vicenda coloniale possa divenire occasione di presa di coscienza e di incontro sorregge e caratterizza il testo” (p. 149): lo sancisce in modo esplicito e definitivo la dichiarazione che conclude il romanzo stesso, “e loro, i tre venerabili anziani di casa, me lo dicevano sempre negli anni dell’infanzia, durante il caffè delle donne: ‘Da grande sarai la nostra cantora’. Poi un giorno il vecchio Yakob mi chiamò nella sua stanza, e gli feci una promessa. […]. Ed è per questo che oggi vi racconto la sua storia. Che poi è anche la mia. Ma pure la vostra” (Ghermandi 20112). Si chiude il bel libro di Camilotti, corredato anche di un imponente quadro di riferimenti bibliografici, con la corroborante conferma delle potenzialità che competono alla letteratura, che sembra poter ancora svolgere la funzione di «fattore di trasformazione capace di plasmare nuove forme e soluzioni sul piano culturale e sociale»: potenzialità alla cui realizzazione proprio la “letteratura della migrazione” appare in grado di offrire un contributo fondamentale. Riferimenti bibliografici Camilotti Silvia (a cura di), Introduzione, in Lingue e letterature in movimento. Scrittrici emergenti nel panorama letterario italiano contemporaneo, Bononia University Press, Bologna 2008, pp. 7-17. Comberiati Daniele, La quarta sponda. Scrittrici in viaggio dall’Africa coloniale all’Italia di oggi, nuova ed. riveduta e corretta, Caravan edizioni, Roma 2009. Flaiano Ennio, Tempo di uccidere e Aethiopia. Appunti per una canzonetta, in Flaiano Ennio, Opere. 1947-1972, a cura di Corti Maria e Longoni Anna, Bompiani, Milano 1990, pp. 5-282. Ghermandi Gabriella, Regina di fiori e di perle, Donzelli, Roma 20112. Scego Igiaba, Cittadinanza artistica o non ci sarà mai una Zadie Smith italiana, in “La Lettura”, supplemento del “Corriere della Sera”, 62, 20 gennaio 2013, p. 4. Ricciarda Ricorda 170
Scaricare