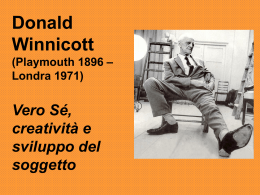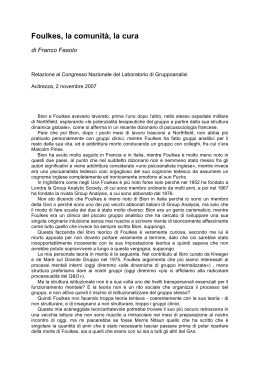RICORDI E RIFLESSIONI Dott. Giancarlo Grasso Convegno in memoria di Marcella Balconi 13 novembre 2009 Questa storia inizia nel 1953. MB dopo cinque anni sta concludendo la frequentazione di Losanna, prima con un tirocinio di un anno al Centro Medico Pedagogico, poi per seguire e concludere l’analisi. Nel 1953 Giovanni Bollea dà inizio alla pubblicazione della rivista italiana di NPI, denominata “Infanzia Anormale”, per segnare la continuità ideale con l’omonimo giornale di Sante De Sanctis di trenta quaranta anni prima. Nel primo numero compare anche un articolo di MB, intitolato “I bambini Difficili”, il testo di un intervento di pochi mesi prima ad un Convegno nazionale sulle condizioni dell’infanzia in Italia, a Pescara. Il convegno era stato organizzato nell’ambito della sinistra, con la partecipazione di pediatri, psicologi, psicoanalisti, oltre ad esponenti del mondo politico e sindacale. Tra l’altro, Ella scrive: “Credo ci si debba intendere innanzitutto sul valore da dare al termine “bambini difficili”. Sappiamo che sono considerati “difficili” quei bambini che turbano l’ambiente e presentano difficoltà per gli adulti: sono almeno questi i bambini che ci vengono portati con maggior frequenza ai Centri Medico-Pedagogici, se escludiamo tutta la gamma di pazienti che presentano disturbi della sfera intellettiva o forme neurologiche. Non dobbiamo invece considerare difficili quei bambini che hanno delle difficoltà ad adattarsi alla vita, ad accettarsi, a realizzarsi? Noi vedremo allora che si potrà parlare spesso, piuttosto che di bambini “difficili”, di genitori ed educatori “difficili”, che presentano cioè, senza volarlo, un inceppo ad un normale sviluppo dei ragazzi. Questo è necessariamente il punto di vista proprio a noi terapeuti, in quanto dobbiamo risolvere i conflitti dei nostri piccoli pazienti per aiutarli ad affrontare la vita: non possiamo, né dobbiamo, adattarci a modificare delle strutture normali pur di adeguarle ad ambienti anormali. Spesso bambini veramente malati dal punto di vista psicologico (e qui credo sia necessario fermare la nostra attenzione), non presentano alcun disturbo apparente quando i parenti si adattano ad essi ed accettano la loro malattia, e invece bambini normali che si rifiutano di accettare reazioni anormali di un ambiente malato possono diventare elemento perturbatore ed essere considerati difficili.” Le argomentazioni non sono originali, si rifanno ai modelli della psichiatria infantile praticati nella Svizzera Romanda, ripresi in Francia, sotto la guida di Lebovici e Diatkine. MB sottolinea in sostanza due ragioni per coinvolgere e mettere in causa i genitori, la prima nella loro veste di interpreti-testimoni non neutrali dei problemi del figlio, spesso -soprattutto all’epoca- non in grado di percepirne le difficoltà. Da qui l’esigenza di affiancare, all’intervento verso i bambini segnalati, indagini estese all’intera popolazione infantile. Qualcosa di simile veniva attuato in quel tempo a Losanna da Repond, uno dei maestri di MB, sulle popolazioni contadine del Vaud. L’altro motivo nasceva dall’importanza dei problemi dei genitori nella genesi della patologia infantile.Poco tempo dopo, in un altro scritto su Infanzia Anormale, citerà la “nevrosi reattiva”, quadro evocato da Beno, il suo analista, nel descrivere situazioni per la cui comprensione era necessario vedere insieme le dinamiche dei genitori e quelle del bambino. Successivamente MB ritornerà ancora sull’argomento, in un articolo sulla diagnosi di struttura, in collaborazione con M. E.Berrini.Osservano le Autrici che la situazione privilegiata in cui si lavora in psichiatria infantile consente di conoscere direttamente una serie di fattori che incidono sullo sviluppo del bambino: ambiente, personalità dei genitori, esperienze di vita, storia del sintomo. Importante però è centrare l’attenzione sul modo personale in cui il bambino vive ed elabora le proprie esperienze e, per il duplice condizionamento biologico e sociale, va strutturando quella che sarà la sua personalità adulta. E queste dinamiche vanno valutate in relazione alla storia del rapporto genitori-bambino, alla dinamica tra sintomi e comportamenti del bambino da un lato e sintomi, comportamenti e personalità dei genitori dall’altro. Un ruolo centrale nello sviluppo del bambino viene così assegnato al gioco delle parti tra genitori e figlio ed agli eventuali ostacoli che possono intervenire a intralciare il processo evolutivo. L’argomentazione delle Autrici è molto articolata, procede per così dire per approssimazioni successive, come è inevitabile trattando di vicende intrapsichiche, di cui sintomi e comportamenti non sono che la punta di un iceberg, la cui parte nascosta affonda nell’ineffabile. (Wittgenstein scriveva che l’indicibile può essere mostrato ma non detto…). L’enfasi con cui Balconi e Berrini insistono su questi temi appare d’altronde giustificata se si ha presente quanto allora questo indirizzo fosse del tutto nuovo nell’ambiente culturale italiano. All’epoca poco si sapeva delle dinamiche profonde in gioco nella relazione genitori-bambino e in generale del rapporto tra normalità e patologia. A questo proposito un importante contributo venne dalla scuola kleiniana al Congresso psicoanalitico internazionale del 1956 a Ginevra, in cui W. Bion e H. Segal descrissero un nuovo meccanismo di difesa dell’Io, definito della identificazione proiettiva. H. Segal riferì come nel corso dell’analisi di pazienti schizofrenici, questi venissero sempre più spesso sperimentando per brevi momenti delle ansie depressive. Ella scrive:” molto spesso si verificherà che la parte depressiva dell’Io del paziente è proiettata nell’analista, e, al fine di realizzare questa proiezione, il paziente può ricorrere ad accurate manipolazioni della situazione analitica in modo da suscitare sentimenti depressivi nell’analista”. Per Segal il dato centrale della situazione è l’intollerabilità da parte del paziente della sofferenza e dei sensi di colpa, che induce l’immediata proiezione nell’analista della parte depressa dell’Io. Il meccanismo dell’identificazione proiettiva verrà ad assumere un ruolo centrale nello studio dell’evoluzione del primo rapporto madre-bambino, quando più tardi Bion richiamerà l’attenzione sulla funzione materna nell’alleviare le sofferenze del neonato, attraverso la reverie, attività in cui la madre prende in sé il disagio del piccolo e glielo restituisce liberato della sua potenzialità distruttiva. L’identificazione proiettiva, così come era stata descritta dalla Segal, appare conseguentemente come l’esito del fallimento di quel processo, per cui il soggetto proietta il suo messaggio di paura e di sofferenza, senza attendersi di ricevere una risposta rassicurante. Viene così, in termini semplificati, a chiudersi il quadro a proposito della continuità tra evoluzione normale ed esiti patologici. Così pure viene a evidenziarsi il compito del terapeuta, in certo senso di funzione vicariante della figura materna, disposta ad accogliere le proiezioni del paziente per riavviare il processo primario descritto da Bion. La mia è una semplificazione, in contrasto con le elaborate argomentazioni dell’Autore: il doversi far carico delle ansie e delle sofferenze del paziente rimane comunque un passaggio ineludibile, quantomeno nella terapia dei disturbi primari; esigenza questa che richiede, oltre alla formazione specifica, particolari caratteristiche di personalità da parte del terapeuta. In proposito ricordo l’attenzione che MB dedicava nella scelta dei collaboratori e dalla loro capacità di sopportare le frustrazioni. Un cenno a questo viene fatto in un’intervista a Scotti pubblicata sui Quaderni di Psicoterapia Infantile, particolare di cui MB non fu molto soddisfatta, temendo di apparire come una negriera! D’altra parte, pensando alla scarsa considerazione in cui era tenuto all’epoca questo lavoro, la stessa scelta professionale era già per se stessa indice di una discreta disponibilità ad accettare esperienze frustranti! Oltre alla formazione personale, MB dava molta importanza all’elaborazione in collettivo, attraverso riunioni settimanali dell’equipe, in cui, oltre alle questioni organizzative, venivano discussi dei casi clinici. Scopo di queste riunioni non era solo quello di assicurare l’omogeneità di indirizzo del servizio, ma anche di approfondire e comprendere le dinamiche per potere così correttamente gestire l’impatto emotivo con il paziente. La tesi secondo cui la comprensione del significato delle ansie e delle sofferenze del paziente, permette al terapeuta i sopportale e di restituirgliele tollerabili, è la traduzione di ciò che Bion definisce la trasformazione di elementi beta in elementi alfa, secondo un processo analogo a quello che si verifica tra madre e neonato grazie alla reverie materna. Ma, per procedere, è necessario un altro richiamo a Bion, a quanto l’Autore descrive avvenire nei gruppi. Egli si sofferma su quelli che definisce “assunti di base” che si creano all’interno dei gruppi. Il termine è improprio per la nostra lingua, più corretto sarebbe “preconcetto” o “convincimento aprioristico”. Egli precisa: “perché si formi un gruppo deve esistere un assunto di base”. Dei tre assunti di base da lui descritti a noi può interessare quello di dipendenza, che si realizza quando il gruppo si riunisce allo scopo di essere sorretto da un capo, ritenuto onnisciente e onnipotente, da cui dipendere per ricevere protezione. I gruppi fondati su assunti di base sono organizzati al fine di difendersi dai cambiamenti, di garantirsi la sicurezza al riparo da novità, da sorprese; essi sono dominati, in ultima . analisi, dal rifiuto di apprendere dall’esperienza Ai gruppi di assunto di base di Bion contrappone il gruppo razionale, fondato sul riconoscimento della necessità di una evoluzione piuttosto che adagiarsi fidando nell’efficacia della magia. Sempre secondo l’Autore, il gruppo razionale, o gruppo di lavoro, è in equilibrio permanente con le istanze mosse dagli assunti di base: nel gruppo di lavoro le persone cooperano ciascuna secondo le proprie capacità, sono persone disposte ad apprendere dall’esperienza, che si riuniscono per svolgere un compito, diversamente da quanto avviene nei gruppi dominati da assunti di base, dove al singolo non è richiesta nessuna capacità di collaborazione. Questo in sintesi quanto di Bion può interessare al nostro discorso. Tornando a noi, è intuibile che nel servizio di Novara, specialmente all’inizio ma non solo, dovesse tendere a prevalere l’assunto di base di dipendenza. Nei primi anni, a fianco di MB, che andava perfezionando la propria formazione a Losanna, ed in stretta collaborazione con personaggi della statura di Lebovici e Diatkine, si erano riunite alcune giovani senza altra formazione che il diploma magistrale – non esistevano allora Facoltà di Psicologia. Era cioè inevitabile che ella fosse il centro di riferimento del gruppo, da cui dipendere in toto: suo compito fu perciò, oltre che di orientare le scelte per la formazione personale, di cercare di valorizzare le attitudini e le inclinazioni di ciascuna di ciascuna di loro. Abbiamo cioè l’equivalente in termini bioniani di un gruppo costantemente in tensione dialettica tra l’assunto di base di dipendenza, in cui adagiarsi sotto la protezione di un capo, ed una realtà in cui fosse chiesto a ciascuno un contributo al fine di apprendere dall’esperienza. Fu Meltzer a farci riflettere sulla funzione del gruppo di lavoro, come luogo in cui discutere i problemi clinici, alla ricerca del significato delle ansie, dei sensi di impotenza e di paura di cui ci investivano i pazienti per poter così procedere nella loro cura. Il gruppo veniva così ad acquisire l’immagine di un “contenitore” ed elaboratore delle emozioni suscitate dalla situazione transferale, una componente insostituibile del processo terapeutico. E qui si conclude il mio discorso sul metodo di lavoro di MB, riassumibile nell’attenzione ai movimenti transferali e controtransferali e nella complementare elaborazione nel gruppo. Su questi argomenti MB scrisse poco e solo nei primi anni, quando gli indirizzi psicodinamici erano pressoché assenti nella psichiatria infantile italiana. I suoi interessi erano concentrati su problemi clinici, in particolare, dai primi anni ’70, sull’evoluzione dei primi rapporti oggettuali e sulla loro distorsione, nell’autismo e nelle psicosi precoci. Di questi argomenti penso che solo MB può parlare, in prima persona, attraverso gli scritti che ha lasciato, soprattutto il volume sul disegno e la psicoanalisi infantile, in collaborazione con Del Carlo Giannini, pubblicato nel 1987 e ristampato nel 1991, purtroppo esaurito da tempo. L’Editore Cortina, da me interpellato, non è d’altronde disposto a provvedere ad una ristampa, dati i costi che ciò comporterebbe. Certamente un’ iniziativa in tale senso sarebbe il degno coronamento del ricordo di MB nel decennale della morte: occorrerebbe però che qualcuno si assumesse l’iniziativa di promuovere l’evento. Per non ridurre il mio intervento ad un amarcord, ritengo opportuno a questo punto un cenno a ciò che è accaduto dopo, alla storia dei nostri servizi negli ultimi 15-20 anni. Al modello che si era venuto costruendo nei decenni precedenti, incentrato sullo studio delle strutture intrapsichiche e delle dinamiche relazionali ed al loro trasformarsi nel corso dell’età evolutiva, sono venuti sostituendosi indirizzi basati su liste di sintomi validate statisticamente, che poco spazio lasciano alle peculiarità ed elle storie individuali. Parallelamente il personale dei servizi ha perso gran parte delle caratteristiche del gruppo di lavoro bioniano, assomigliando piuttosto a ciò che nel privato è lo studio associato, i cui componenti operano ciascuno per proprio conto, condividendo le strutture materiali. Questa scelta ha un fondamento scientifico, che vorrei descrivere ricorrendo alle parole di Max Planck, che oltre che ad un grande fisico fu un profondo epistemologo. Egli scriveva: “c’è un punto, un unico punto nell’immensità della natura e del mondo dello spirito, che non solo praticamente, ma anche logicamente, è e rimarrà incessabile ad ogni scienza e quindi ad ogni studio causale: questo punto è il nostro Io”. E ancora: “questa rinuncia a tutto ciò che è intuitivo e immediatamente a contatto con la vita è un grave sacrificio; ma questo sacrificio va compiuto, soprattutto in considerazione degli impareggiabili vantaggi che vengono alla ricerca scientifica con l’introduzione del determinismo”. Indubbiamente è a questi principi che si ispirano il DSM, l’ICD e la CD 0-3. A mio parere esistono però altre ragioni, più umane…, che possono spiegare la svolta. Tre anni fa psichiatri australiani e neozelandesi hanno richiamato l’attenzione su ciò che hanno definito “fatica da compassione”o tout-court ”patologia da compassione”, che minaccia la salute mentale del medico, quando si prende troppo a cuore le sofferenze dei pazienti, o addirittura vi si identifica, vivendoli in prima persona. Nel vecchio linguaggio diremmo quando accetta in sé le proiezioni del paziente, ossia, ciò che un tempo era ritenuto condizione per curare il paziente, ora viene visto come una minaccia per la salute mentale del terapeuta. Come spiegare questo mutamento? Sarei tentato di proporre un’ipotesi generazionale. La generazione di MB, che poi è anche la mia, usciva da una guerra che non aveva permesso di evitare l’esperienza del male e della sofferenza, da cui era impensabile uscire e trovare un’alternativa se non attraverso la comprensione del senso di ciò che era accaduto. Eravamo in un certo senso dei post-traumatici! La generazione successiva, l’attuale, è cresciuta in una realtà tutto sommato di pace e di benessere, di conseguenza più vulnerabile al contatto con la sofferenza, propensa piuttosto a proteggersi da essa: più a rischio, in caso diverso, di cadere vittima di “patologie da compassione”. Questo ovviamente in linea generale, a prescindere dalle storie individuali. Questa ipotesi ha qualche verosimiglianza, considerando che la svolta si verifica nel 1980, con il DSM III, che abbandona l’impostazione psicoanalitica, ancora presente nel DSM II, focalizzandosi sui comportamenti, a scapito dei fenomeni psichici e dei meccanismi psicopatologici sottostanti. La svolta viene di solito attribuita all’avvento della psicofarmacologia e dell’utilizzo crescente degli psicofarmaci in psichiatria. Sarà vero, anche se in realtà l’introduzione degli psicofarmaci era iniziata almeno trent’anni prima. Non sarà che è allora che il cambio generazionale ha raggiunto il punto di svolta? Qui mi fermo, anche se non possiamo ignorare che l’indirizzo attuale lascia un fianco scoperto, specie nei Paesi come il nostro, dove esiste un unico servizio sanitario, diversamente ad es. dagli USA, in cui esiste una psichiatria privata, per i ricchi, ad orientamento psicoanalitico, in cui il paziente è “soggetto”, ed una psichiatria pubblica, dei poveri, dove il paziente è “oggetto”.
Scaricare