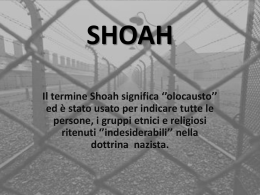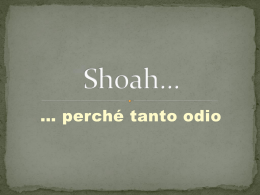Atti e contributi del Seminario di Imola del 5 e 6 dicembre 2005 Atti e contributi del Seminario di Imola del 5 e 6 dicembre 2005 I valori della Resistenza al nazismo e al fascismo e gli ideali di libertà ed unità nazionale, come si legge nel Preambolo del nuovo Statuto regionale, sono i principi su cui si fonda la Regione Emilia-Romagna. La Repubblica italiana, a sua volta, riconosce il 27 gennaio, anniversario dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti ed invita ad organizzare, in questo giorno, incontri e momenti comuni di riflessione e narrazione di quei tragici eventi. I n questa direzione si inserisce il seminario di formazione sul tema della Shoah, della Memoria e della pacifica convivenza fra i popoli tenutosi nella Città di Imola, che qui intendo ringraziare per la solerzia e la sollecitudine nell’ospitarci, il 5 e 6 dicembre 2005. N on c’è futuro senza memoria. L’Assemblea regionale ha ben chiaro quale sia il ruolo della memoria nel processo di costruzione dell’identità locale e nazionale e l’importanza ed il significato che questo concetto viene ad assumere nel contesto contemporaneo. La memoria è infatti il necessario prerequisito per aprirsi al nuovo, guardare al futuro, costruire l’Europa. E il processo di costruzione dell’Europa non può che partire dal riconoscimento e dalla affermazione del diritto alla Memoria, del diritto dei testimoni, ovvero di tutti coloro che “c’erano” e che hanno il bisogno ed il diritto di affermare un “mai più” ed il concomitante nostro dovere di ascoltare. I n questo quadro, fondamentale risulta l’apporto ed il ruolo della scuola, quale luogo deputato alla formazione umana, civile e culturale dei più giovani e di sensibilizzazione ai valori della democrazia e della solidarietà. E’ proprio dal mondo della scuola che ci è venuta la sollecitazione a promuovere questo momento di riflessione ed è al mondo della scuola, agli insegnanti ed agli educatori, in primis, che si rivolge questa iniziativa che abbiamo però voluto “aprire” anche al resto della cittadinanza perché la memoria è e resta un affare di tutti. P ersonalmente ringrazio l’ANED, l’Associazione Figli della Shoah, le comunità ebraiche, l’ANPI e tutti coloro che, in ogni luogo, ci aiutano e sostengono a realizzare - a livello locale - simili eventi. Un ringraziamento speciale va poi ai relatori intervenuti e ai “testimoni” che grazie alla loro preziosissima opera di “restituzione dell’esperienza” ci hanno aiutato a rivivere quei tragici momenti e a promuovere riflessioni ed analisi in una rete di relazioni che si è rivelata ben più efficace di qualsiasi iniziale aspettativa. È per questo motivo che, a distanza di un anno, l’Assemblea ha deciso di mettere a disposizione, di tutto il corpo docente, alcuni di questi contributi, perlopiù frutto degli interventi effettuati in occasione del seminario tenutosi ad Imola, il 5-6 dicembre 2005. L’ iniziativa ha infatti voluto costituire una tappa importante di valutazione, aggiornamento ed arricchimento del know-how complessivo. Non punto di arrivo, dunque, ma di partenza. Siamo infatti certi del fatto che solo attraverso la massima circolazione delle informazioni e la condivisione di strumenti e metodi, il modello di approccio alla tematica della memoria e della pacifica convivenza, sviluppato durante i nostri incontri, possa diventare, a tutti gli effetti, una esperienza condivisa. Una esperienza che trova oggi nella recente sentenza che chiude, a 62 anni di distanza, il processo per l’eccidio di Marzabotto, un fondamentale tassello. Monica Donini Presidente Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna L a Città di Imola ha accolto volentieri l’opportunità offerta dalla Regione Emilia Romagna, attraverso l’Assemblea Legislativa e l’Assessorato competente, di ospitare una riflessione rivolta agli insegnanti ed agli educatori sui temi della Shoah, della deportazione e dei genocidi. N on ci sfugge anzitutto il fatto che nella Legge n° 211 del 20 luglio 2000, istitutiva del Giorno della Memoria, il mondo della scuola sia chiamato al ruolo fondamentale “di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”. D opo alcuni anni di percorsi che le scuole del nostro territorio hanno svolto con puntualità e passione ci è sembrato assai opportuno offrire un seminario di approfondimento e confronto a tutti i professionisti chiamati allo straordinario compito dell’educazione dei giovani su questi temi ed al fine di conservare la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell’Europa, affinché simili eventi non possano mai più accadere. G razie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Figli della Shoah, dell’ANED Associazione Deportati, della Fondazione CDEC - Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, della Comunità Ebraica di Bologna, della Scuola di Pace di Monte Sole, del Cidra di Imola e di molte altre associazioni nonché grazie al supporto di tanti soggetti istituzionali, tra cui il Circondario Imolese, che hanno fattivamente operato alla realizzazione dell’evento, quelle giornate seminariali sono state arricchite da personalità e da interventi di grandissimo spessore. Voglio citare tra gli altri la graditissima presenza di Liliana Segre, per la prima volta nella nostra città, che ha portato la sua importante e toccante testimonianza di sopravvissuta. N on abbiamo inteso gli eventi proposti come un punto di arrivo, ma invece come un’occasione di riflessione per ricaricare le energie verso percorsi da riprendere e ripetere ogni anno con ritrovata originalità e vivacità. A bbiamo la ferma volontà di riproporre anche in futuro occasioni di confronto come questa, davvero qualificate e fruttuose. Fabrizio Castellari Vicesindaco e Assessore all’Istruzione e Formazione Comune di Imola So m m a r i o Programma del Seminario di Imola pag. 9 Introduzione al Progetto pag. 11 - Andrea Ferri “ 15 - Pia Jarach “ 19 - Liliana Segre “ 23 - Alessandra Chiappano “ 39 - Francesco Maria Feltri “ 45 - Nadia Baiesi “ 53 - Valter Baruzzi “ 57 Relazioni 5NCICLODISEMINARISULTEMADELLA3HOAHINDIRIZZATOAIDOCENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA REGIONE lNALIZZATO ALLIDENTIlCAZIONE DI MODALITÌ E STRUMENTI DI RImESSIONE ED ANALISINELLECLASSICHEABBIANOUNALOROCONTINUITÌPROGETTUALE EDOPERATIVA /BIETTIVO DEL PERCORSO Ò LIDENTIlCAZIONE DI UN MODELLO CONDIVISO DI APPROCCIO ALLA TEMATICA DELLA MEMORIA E DELLA PACIlCA CONVIVENZA FRA I POPOLI CHE CONSENTA AI DOCENTI DI SVILUPPAREMOMENTIDIRImESSIONEEDANALISINELLESCUOLE )LCICLODISEMINARICHEHAPRESOILVIADA"OLOGNAILE SETTEMBRE SI SVILUPPA ATTRAVERSO APPUNTAMENTI CHE TOCCHERANNOICAPOLUOGHIDIPROVINCIAEDALTREREALTÌLOCALIDELLA REGIONE%MILIA2OMAGNA ) SEMINARI VERRANNO SVILUPPATI SEGUENDO UN UNICO SCHEMA DI RIFERIMENTOCHEPREVEDEUNAPPROCCIOALTEMAELAPROPOSIZIONE DI CASI ESEMPLARI ED ESPERIENZE REALIZZATE CHE IN CIASCUN TERRITORIO SARÌ ESPRESSIONE DEL VISSUTO PROPRIO DEL TERRITORIO STESSO Assessorato scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità Città di Imola Assessorato all’istruzione e Formazione 3EMINARIODIFORMAZIONE PERGLIINSEGNANTIDIOGNIORDINEEGRADO APERTOALLACITTADINANZA LA3HOAHINCLASSE )L SEMINARIO Ò RICONOSCIUTO COME ATTIVITÌ DI FORMAZIONE IN SERVIZIO AGGIORNAMENTO GLI INSEGNANTI HANNO DIRITTO ALLA FRUIZIONE DI GIORNI NELLANNO SCOLASTICO PER LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE DI FORMAZIONE RICONOSCIUTE DALLAMMINISTRAZIONE CON ESONERO DAL SERVIZIO E CON SOSTITUZIONEAISENSIDELLANORMATIVASULLESUPPLENZEDEI DIVERSIGRADISCOLASTICIART#CNL $EPORTAZIONIEGENOCIDI TRAPASSATOEPRESENTE PERCORSIDIFORMAZIONE PERUNACITTADINANZA CONSAPEVOLEECONDIVISA )MOLADICEMBRE 3ALA#ONFERENZEDEL#IRCOLO3ERSANTI 0IAZZA-ATTEOTTI 3EGRETERIAORGANIZZATIVA !SSEMBLEA,EGISLATIVA2EGIONE%MILIA2OMAGNA2ELAZIONI%STERNE 2OSI-ANARITEL EMAILRMANARI REGIONEEMILIAROMAGNAIT )NCOLLABORAZIONECON !NED&ONDAZIONE#$%#&IGLIDELLA3HOAH TEL "ARBARA0ORCUFAX -IRYAM#OHENCELLEMAILMIRYAMCOHEN YAHOOIT Università di Bologna Facoltà Scienze della Formazione Provincia di Bologna 5FlCIOSCOLASTICOREGIONALEPERL@%MILIA2OMAGNA TEL Università degli studi di Roma 3 !DESIONIPERLESCUOLEADESAURIMENTOPOSTI #ENTRO)NTEGRATO3ERVIZI3CUOLA4ERRITORIO 3ERGIO3UZZITELFAX EMAILCONFERENZATERRITORIALE NTSPROVINCIABOLOGNAIT L A N L ABORATORIO N AZIONALE PER LA D D IDATTICA I S DEL LA S TORIA ANED Associazione Deportati Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC - Onlus ORE #OORDINA &ABRIZIO#ASTELLARI 6ICESINDACO E !SSESSORE )STRUZIONE E &ORMAZIONE DEL #OMUNEDI)MOLA 3ALUTIDELLE!UTORITÌ -ASSIMO-ARCHIGNOLI 3INDACODEL#OMUNEDI)MOLA !NDREA$E-ARIA 0RESIDENTE2ETE)STITUZIONI3COLASTICHEDEL4ERRITORIO)MOLESE 3ALUTIDELLE!UTORITÌ 3ERGIO3ANTI 0RESIDENTE&ONDAZIONE#ASSADI2ISPARMIODI)MOLA .ARA2EBECCHI 6ICE0RESIDENTEDELLA0ROVINCIADI"OLOGNA 5FlCIODI0RESIDENZADEL#IRCONDARIO)MOLESE $ANIELE-ANCA $ANIELA'UERRA #ONSIGLIERE DELL!SSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA 2EGIONE %MILIA2OMAGNA 6ITTORIANO:ACCHERINI DICEMBRE ORE #OORDINA -ARIO&AGGELLA !NED3EZIONEDI)MOLA #ONSIGLIERE DELL!SSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA 2EGIONE %MILIA2OMAGNA 0ERUNALETTURAPEDAGOGICADELLA3HOAH 6ALTER"ARUZZI 1UESTIONIDISTORIADELLA3HOAH ,ANTISEMITISMOFASCISTAELELEGGIANTIEBRAICHE -ICHELE3ARFATTI ,APPLICAZIONEDELLELEGGIANTIEBRAICHEA)MOLA !NDREA&ERRI )LPASSAGGIODELTESTIMONE $AVID-EGHNAGI 0IA*ARACH ,A3HOAHNEILIBRIDINARRATIVAPERRAGAZZI,ETTUREDI !LESSIA#ANDUCCI )LUOGHIDELLASTORIAELADIDATTICA !LESSANDRA#HIAPPANO &RANCESCO-ARIA&ELTRI 1UESTIONIDIATTUALITÌ ,A3HOAHELACITTADINANZACONDIVISA .ADIA"AIESI $IBATTITO ,ILIANA3EGRE %SPERIENZEDELLESCUOLEDELTERRITORIO IMOLESE ,ETAPPESUCCESSIVE )SABELLA&ILIPPI $IBATTITO 5FlCIO SCOLASTICO REGIONALE DELL%MILIA2OMAGNA $IRE ZIONEGENERALE #ONCLUSIONI -ONICA$ONINI #ONCLUSIONI ,UCIA,EGGERI 0RESIDENTEDELL!SSEMBLEALEGISLATIVADELLA2EGIONE %MILIA2OMAGNA $IRETTORE#ENTRO)NTEGRATO3ERVIZI3CUOLA4ERRITORIO ORE "UFFET ORE "UFFET DICEMBRE 5NRINGRAZIAMENTOALLADITTA#AMSTPERILBUFFETOFFERTO Il tema della Shoah, della Memoria e della pacifica convivenza fra i popoli sono al centro di un ciclo di seminari, organizzati dall’Assemblea Legislativa, in collaborazione con numerosi enti ed associazioni del territorio, che ha preso il via da Bologna il 27-28 settembre 2005 (Sala Zodiaco - Provincia di Bologna), per poi toccare altri capoluoghi di provincia e realtà locali, fra cui i comuni di Carpi (Auditorium San Rocco, 17 novembre 2005) ed Imola (Sala Conferenze del Circolo Sersanti, 5-6 dicembre 2005). In t r o d u z i o n e a l Pr o g e t t o Indirizzata ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione ed aperta alla cittadinanza, l’iniziativa si è data, come finalità, l’identificazione di modalità e strumenti di natura didattica e pedagogica e di un modello condiviso di approccio alla tematica della memoria e della pacifica convivenza fra i popoli, quali valori fondanti di un piu’ ampio e responsabile concetto di cittadinanza. I seminari sono stati sviluppati sulla base di uno schema comune che, partendo da un approccio teorico al tema, è giunto a toccare questioni di carattere più propriamente metodologico, che attengono il che cosa insegnare ed il come insegnare la Shoah in una società sempre più complessa e multiculturale. Partendo da queste riflessione e certi del fatto che, quale che sia la materia da insegnare, non esistono né un unico modo per farlo, né, tanto meno, una metodologia ideale, valida per tutti gli insegnanti e per tutti gli studenti, il progetto si è dato l’ambizioso obiettivo di identificare un modello condiviso. E lo si è fatto abbinando all’approccio teorico e a quello metodologico, la proposizione di casi esemplari, attraverso il testimone ed il luogo, e di esperienze, realizzate su ciascun territorio. I seminari sono stati infatti realizzati nel riconoscimento delle specificità locali e valorizzandone la peculiarità di apporto. La città di Carpi, ad esempio, si caratterizza per la presenza dell’ex campo di Concentramento di Fossoli, del Museo Monumento del Deportato e per molteplici iniziative che ruotano attorno al tema della Memoria. Sempre da Carpi, lo ricordiamo, il 25 gennaio scorso 2006, è partito il Treno per la Memoria che ha portato più di 600 studenti a visitare il campo di sterminio di Auschwitz. Rispondendo alle numerose sollecitazioni affinché venga data continuità operativa e progettuale al percorso intrapreso, l’Assemblea ha deciso, a oltre un anno di distanza, di mettere a disposizione di tutto il corpo docente, e non solo del personale intervenuto, alcuni degli atti e dei contributi, perlopiù parte frutto degli interventi effettuati in occasione del seminario tenutosi ad Imola, il 5-6 dicembre 2005. Si ringraziano i soggetti che con noi hanno collaborato alla realizzazione del progetto: - Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, - Assessorato regionale Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro, Pari opportunità - Province e comuni della Regione Emilia-Romagna - Università di Bologna - Facoltà di Scienze della Formazione - Scuola di Pace di Monte Sole - LANDIS - Laboratorio nazionale per la didattica della storia 11 - INSMIL - Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia - Fondazione per la memoria della deportazione - ANED - Associazione deportati - ANEI - Associazione nazionale ex internatI - CDEC - Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea - I Figli della Shoah e tute le associazioni, non citate nell’ elenco, che sul territorio operano sul tema della memoria e per la promozione di percorsi di formazione per una cittadinanza attiva e consapevole. In t r o d u z i o n e a l Pr o g e t t o 12 Le 13 R elazi oni (…) Grazie. Come ha anticipato il moderatore, ho il compito di illustrare brevemente l’applicazione delle leggi razziali a Imola. Consentitemi però prima di condividere con voi una suggestione. Noi siamo ospitati oggi dal circolo Sersanti per questo seminario di due giorni; in questo stesso circolo circa settant’anni fa è stato perpetrato uno degli atti applicativi delle leggi razziali a Imola, di minore entità rispetto ad altri, ma comunque rilevante. Cesare Fiorentino, uno dei più stimati commercianti della città, uno dei pochi ebrei presente stabilmente ad Imola in quegli anni, venne espulso dal circolo Sersanti del quale faceva parte da molti anni, in applicazione delle leggi razziali del 1938. Credo quindi che questa coincidenza abbia un suo significato, perché da conto di come l’applicazione delle leggi razziali permeava la vita delle persone nei suoi aspetti più minuti e quindi paradossalmente più sensibili a ogni forma di coartazione. An d r e a Fe r r i Vorrei ora offrirvi tre spunti di ricerca sul tema oggetto di questo seminario. Il primo riguarda la presenza ebraica locale in età contemporanea. Imola in età medievale e moderna aveva avuto una fiorente comunità ebraica con copisti, rabbini, studiosi della Thorah famosi in tutti Italia. Si registra poi una soluzione di continuità tra questa comunità, che di fatto cessa di esistere alla fine del secolo XVI, con il nucleo di tre famiglie, che si stanzia stabilmente ad Imola proveniente dalla Toscana. La famiglia Fiorentino era originaria di Monte San Savino, una piccola località in provincia di Arezzo. Nella seconda metà del secolo XIX si stanziano ad Imola Ferruccio Fiorentino e la moglie Emma Passigli, la cui attività principale è quella di commercio di stoffe. Ad essi si aggiungono Arturo Fiorentino, fratello di Ferruccio, con la moglie Emma Tedeschi. Come molti di voi sanno il negozio dei Fiorentino è ancora attivo ad Imola, gestito dai discendenti di Arturo. L’integrazione della famiglia Fiorentino nella comunità imolese fu rapida e profonda: un Fiorentino è tra gli iniziatori della Camera di commercio a Imola; i Fiorentino entrano come soci nella Cassa di Risparmio di Imola; i loro figli abitano in Imola e svolgono qui la loro attività. Molte tracce hanno lasciato nei giornali, negli atti amministrativi, nelle attività dei vari circoli ed associazioni di cui hanno fatto parte, circolo Sersanti compreso. Potete quindi immaginare con che apprensione e angoscia accolsero l’applicazione delle leggi razziali. Il loro contenuto comincia a trasparire prima ancora della promulgazione in una serie di articoli che compaiono su quotidiani nazionali e locali, primo fra tutti il Resto del Carlino, che allora era controllato dal partito fascista. Quando le leggi vengono promulgate, i Fiorentino si adeguano alle prescrizioni stabilite, si presentano all’ufficio anagrafe del comune, l’ufficio che è proprio qui davanti, sulla piazza, per farsi registrare utilizzando gli appositi i moduli; accettano di vedere i loro nomi cancellati dagli elenchi telefonici; accettano di non avere al loro servizio domestici ariani, quegli stessi domestici imolesi che avevano sempre avuto; accettano quindi di subire tutta una serie di umiliazioni. L’unica bambina in età scolare ebrea di Imola era una Fiorentino, figlia di Cesare, socio del circolo Sersanti. Grazia Fiorentino, una signora oggi abitante a Bologna, ricorda nitidamente come avvenne la sua espulsione dalle scuole; ricorda ancora più nitidamente come avvenne il suo esame da privatista che sostenne sempre nelle scuole Carducci dove in un’aula il suo banco venne addossato all’angolo opposto a quello di tutti gli altri studenti per evitare loro la contaminazione con una non ariana. Ma il peggio per gli ebrei imolesi, doveva ancora venire perché dopo il 1943, la caduta di Mussolini e la costituzione della Repubblica Sociale italiana, l’applicazione delle leggi razziali non fu più solo di taglio burocratico-amministrativo, ma mirava alla cattura e alla soppressione fisica di tutti gli ebrei presenti nel territorio della Repubblica Sociale, di cui anche Imola faceva parte. Questo spinse i Fiorentino dapprima a trasferirsi in piccoli centri del circondario imolese, (Fontanelice, Mor- 15 dano, Medicina, Dozza), ed in seguito pure a fuggire in Svizzera. E in questo furono aiutati da Amedeo Ruggi, che diventerà uno dei più importanti sindaci di Imola dopo la liberazione, che allora era un giovanissimo militare; tramite parentele Rosa Cardoni, domestica dei Fiorentino Ruggi era in contatto con la famiglia e accettò di scortare Cesare, Matilde e Grazia Fiorentino fino al confine svizzero, che poterono fortunosamente superare dopo una serie di peripezie, rimanendo in territorio elvetico alla fine della guerra. Dopo il loro ritorno Grazia Fiorentino e i genitori non si stabiliranno più a Imola, ma presero residenza a Bologna. La loro vicenda è stata dolorosa, una sorta di microcosmo in cui si ritrovano molte delle peripezie che gli ebrei italiani dovettero subire. Molte considerazioni, molti aneddoti, molti dettagli si potrebbero raccontare sulla vicenda ebraica imolese anche in età contemporanea. Io però vorrei concludere condividendo con voi una opinione che mi sono formato studiando queste carte: forse perché non si sono verificati per gli ebrei imolesi esiti tragici come deportazioni ed uccisioni, mi sono concentrato su altri aspetti, come la burocratica freddezza con la quale non solo senatori, deputati, ministri, ma 16 An d r e a Fe r r i Sintetizzando quindi si possono indicare tre percorsi di ricerca. In primo lugo punto la storia della presenza degli ebrei a Imola; secondariamente l’applicazione delle leggi razziali in tutti i suoi minuti particolari; infine è importante specificare che la modalità di ricerca è quella che passa attraverso i documenti, intesi non solo dal punto di vista archivistico ma anche iconografico, topografico, epigrafico. è importante ed anche suggestivo toccare con mano, vedere come concretamente le autorità amministrative della nostra città una manciata di decenni fa hanno applicato le leggi razziali; hanno mutato il nome del vicolo Giudei, perché non era ammissibile che in una città ariana ci fosse un vicolo intitolato agli ebrei, e lo hanno dedicato ad Alfeo Albertazzi, un caduto fascista nella guerra di Spagna; questa intitolazione è stata rimossa solo pochi anni dopo la fine della guerra. A questo proposito è significativo un modulo che io ho trovato pochissimi anni fa nell’archivio dell’ufficio anagrafe di Imola dove ancora si trovava; è intitolato “modulo per la spiegatura razziale di tutto il personale della pubblica amministrazione locale” cioè gli impiegati comunali; il modulo richiede inizialmente cognome, nome, paternità, maternità, data e luogo di nascita; chiede poi di precisare il ruolo e la qualifica del dipendente; si dilunga poi sulle origini razziali: “Il padre è di razza ebraica? La madre è di razza ebraica? Il padre è di nazionalità italiana o straniera? La madre è di nazionalità italiana o straniera? Il nome dei genitori o dei nonni è un nome che richiama origini ebraiche?”. Tra le circolari rinvenute nell’archivio delle scuole elementari Carducci ne ho rinvenuta una del 20 febbraio 1940, a firma del provveditore agli studi di Bologna e diretta a tutti i capi d’istituto, avente come oggetto “Mostra della razza”. Vi cito alcune righe: “il Duce ha disposto che il 21 aprile si è inaugurata a Roma la mostra della razza, il nostro Ministero” cioè quello della pubblica istruzione “intende partecipare con materiale atto a documentare la funzione della scuola nella politica razziale e per tanto richiede alle scuole dipendenti elementi che dimostrino per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole medie. Per le scuole materne…materne: lo sviluppo del Risorgimento, lo sviluppo dal Risorgimento al Fascismo, i metodi e gli aspetti della vita della scuola materna, della scuola elementare: sviluppo della tecnica didattica, dell’edilizia e dall’irradiamento scolastico, attrezzature, ambulatoriali, assistenza igienica, sanitaria, alimentare e sussidi didattici per la formazione della coscienza razzista; per la scuola media: iniziative per la formazione della coscienza razziale, aspetti del lavoro produttivo come contributo alla sanità della razza, aspetto dell’orientamento professionale. Vi prego di comunicare entro il 26 l’elenco del materiale necessario, confido nella vostra intelligente e pronta collaborazione per la riuscita dell’importante esposizione” firmato “il provveditore agli studi Sgroi”. An d r e a Fe r r i anche prefetti, questori, insegnanti, capi ufficio discettavano d’inferiorità razziale nelle loro circolari, di disposizione per l’applicazione delle leggi razziali; tutti eventi avvenuti qui, in questi locali, negli uffici del comune, nei vari ambiti della pubblica amministrazione. Passare il testimone storiografico alle giovani generazioni significa fare toccare loro con mano che queste episodi non avvenivano al di sopra della testa delle persone, ma nella quotidianità, nella normalità della vita amministrativa di una città di provincia come era Imola a quei tempi. Nel 1998 nella stessa via Giudei il cui nome era stato cambiato, è stata posta una targa che ricorda quelli eventi, con la collaborazione della comunità ebraica di Bologna. Ma la cosa importante è fare intendere agli studenti che lo studio della storia non è una mera suggestione erudita, ma una delle chiavi di comprensione del presente e di programmazione, per quello che è possibile, del futuro. (…) 17 Pi a Ja r a c h (…) Buongiorno, cerco di non stare troppo sul microfono, mi sentite tutti? Cercherò di essere breve perché vorrei lasciare maggiore spazio possibile a Liliana Segre. Mi ha fatto molto piacere constatare, fino ad ora, che nessuno dei relatori che mi hanno preceduto ha letto, rende più diretto ed immediato questo incontro. Quello che oggi vorrei comunicare io, sia agli insegnanti che ai ragazzi, è l’importanza di curare insieme all’aspetto storico, anche l’aspetto della comunicazione. Prima di fare questo lavoro come volontaria mi occupavo infatti di pubblicità, quindi di “comunicazione”. Secondo me è molto importante anche in quest’ambito, così particolare, ridare, prima di tutto, senso alle parole. Noi non ci accorgiamo di quanto spesso cose che diamo per scontate, in realtà, non lo siano affatto. Provate a chiedere per la strada a una persona qualsiasi se esiste differenza tra un ebreo e un israeliano: non la sapranno evidenziare. Più di una volta mi sono sentita dire cose che non stavano “insieme”, persino da persone da cui mi sarei aspettata qualcosa di ben diverso… Quindi cominciamo a ritrovare il senso delle parole, capire chi è un ebreo, chi è un israeliano; che differenza c’è, perché in altri casi si dice israelita … Forse, per chi non è ebreo, non esiste la percezione chiara di quanto sia difficile, a volte, pronunciare questa semplicissima parola senza sentirsi imbarazzati e credo che anche questo sia il retaggio di un’epoca passata. A tal proposito, è stato appena citato il cambiamento di nome di una strada … In realtà giudeo, ebreo, tutto ha un senso. Ridiamoglielo così come dobbiamo ridare senso alle proporzioni, ai numeri. E’ fondamentale far capire ai ragazzi di che realtà stiamo parlando, quanti erano gli ebrei in Italia durante quel periodo, quanti sono oggi, quanti erano e quanti sono attualmente nel mondo, sennò non si riuscirà mai a inserire nel giusto contesto questa storia. A proposito della storia del “prima” avete appunto sentito di una strada che si chiamava Vicolo dei giudei, nome che poi è stato cambiato. Chiediamoci perché si chiamava Vicolo dei giudei, andiamo indietro nel tempo, perché altrimenti la Shoah rischia di essere considerata come un episodio estemporaneo, un dramma terribile fine a se stesso, perpetrato da demoni, da folli, da pazzi … In realtà, come diceva il professor Sarfatti in modo particolare, la Shoah ha avuto luogo in Europa, per opera di uomini che erano come noi. Questo è un punto nodale nella corretta “comunicazione” della Shoah, si deve fare attenzione a non cadere nella tentazione di essere quasi romantici, di pensare che, essendo noi sicuramente tutti dalla parte del bene, non avremmo mai potuto avere il ruolo del “cattivo” tra virgolette … Troppo facile, non è su questa linea piatta che dobbiamo leggere la storia e, soprattutto, la storia della Shoah; non esistono solo il bene e il male, esiste anche una terza dimensione che è quella di chi stava a guardare. Riflettiamo su questa zona grigia, che non è né bene, né male, osserviamola attentamente, perché è quella dove si collocarono la maggior parte dei cittadini europei durante la Shoah e quella dove in ogni momento è sempre più facile collocarsi. Noi dove ci saremmo messi? È facile attribuire le colpe agli altri, è facile liberarsi la coscienza dando la colpa a un “cattivo” o a tanti “cattivi” e noi … noi che crediamo di non avere pregiudizi, di fronte al nostro compagno di classe espulso perché “ebreo” come avremmo reagito? Noi colleghi di un insegnante espulso perché “ebreo”, come avremmo reagito? Quanti furono gli insegnanti che si rifiutarono di prendere il posto dei loro colleghi espulsi? Ecco, anche questo è parlare di Shoah, è comunicare una storia tanto inaccettabile quanto costruita dal concatenarsi di processi, azioni e reazioni assolutamente “umani”. Comunicare per ricordare in modo attivo è per l’ebraismo una tradizione. “Memoria” non è solo una parola, ma una pratica costante che deve farci crescere umanamente, come si dice tutti gli anni per la Pasqua ebraica durante la lettura dell’Haggadah, (che è il racconto dell’uscita dall’Egitto): “in ogni generazione c’è qualcuno che deve sentirsi come se lui stesso fosse stato liberato 19 dall’Egitto”. Ogni anno deve essere lo stesso per la Shoah, che altrimenti diventa un rito vuoto, una ricorrenza come tante altre. Una signora prima mi ha chiesto se per essere membri dei Figli della Shoah bisogna proprio esserne figli. Le ho risposto che, come sono diventata figlia adottiva io, tutti possiamo esserlo. Proprio in questa chiave di lettura, cioè come “figli” possiamo forse riuscire a leggere le testimonianze per quello che sono davvero: un viaggio tragicamente reale nel tempo. Liliana Segre che oggi vedete qui dinnanzi a voi, una signora elegante, in realtà ci racconta la sua storia di bambina. Aveva appena 13 anni quando fu arrestata e deportata come una criminale alla fine del 1943 e da tredicenne affrontò quel viaggio all’inferno … Quando ascoltiamo una testimonianza dobbiamo veramente fare uno sforzo, cercare di trasportarci nel tempo e di immaginare, in questo caso Liliana, per come era allora. Poco tempo fa, mi è capitato di essere proprio con lei in una occasione di festa con ebrei che hanno tradizioni molto diverse da quelle dell’ebraismo italiano, ebrei aschenaziti, eredi del mondo di cui ci parlava il professor Sarfatti poco fa, del famoso mondo degli schtetl, molto più ortodosso, e assai lontano anche esteticamente dalle abitudini dell’ebraismo italiano. A un certo punto Liliana m’ha guardato e m’ha detto “ma tu t’immagini quando io sono arrivata ad Auschwitz e mi sono ritrovata in mezzo a persone che erano così diverse da me, con cui io non avevo niente in comune, che avevano tradizioni diverse e una lingua così diversa?!” Cerchiamo di immaginarci Liliana bambina, una bambina italiana simile a qualsiasi altra bambina, che di punto in bianco si vede 20 Pi a Ja r a c h Sempre a proposito di “comunicazione”, un altro lavoro che ritengo molto utile è quello di osservare ciò che viene detto in televisione, sulla stampa, su Internet: le vie di accesso alla conoscenza sono sempre di più, ma come vengono recepite e utilizzate? Quante inesattezze ci possono trovare? Affidarsi troppo a quello che si vede e a quello che si sente senza analizzarlo in maniera cosciente e senza avere basi e strumenti adeguati lascia spazio a tanta confusione. Non spendersi per questo significa lasciare che la Shoah sia una vicenda che riguarda un popolo antico, scomparso dalle pagine della Storia e poi ricomparso, in maniera più o meno marginale a seconda del testo adottato, durante la Seconda Guerra Mondiale. Vi invito quindi, prima di affrontare la Shoah a ricostruire la storia del popolo ebraico attraverso i secoli, per esempio cercando nelle proprie realtà locali i documenti che raccontano della presenza ebraica e delle vicende alterne di cui gli ebrei furono protagonisti. Come divulgatrice penso che l’altro elemento estremamente importante sia il cuore … il cuore e l’emozione. Certo, non deve essere l’unica cosa, per carità, ma è pur sempre ciò che ha portato una persona come me a impegnarsi in questo campo. Prima di tutto è stato il mio cuore ad ascoltare le testimonianze di Liliana Segre, di Goti Bauer, di Nedo Fiano e ad accoglierne il messaggio più profondo. Da allora in poi ho conosciuto altre persone straordinarie, sia al CDEC dove mi sono formata, che durante le interviste ai sopravvissuti, realizzate per la fondazione di Spielberg in Italia. Raccogliendo le loro testimonianze ho imparato ad amplificarle, perché secondo me è importante anche sapere trasmettere delle emozioni. Ripeto, non si deve puntare solo su questo e credo che per voi insegnanti sia comunque difficile riuscire a mantenere la tensione emotiva con gli studenti. I Figli della Shoah, il CDEC così come altri, organizzano mostre che poi rendono itineranti per offrire strumenti e supporti che raggiungano il maggior numero di studenti possibili e si rendono inoltre disponibili ad offrire operatori preparati e motivati per affiancare voi insegnanti. Ogni tanto può essere utile spezzare il rapporto diretto con gli studenti su argomenti tanto complessi e, ancora oggi, non privi di polemiche insidiose. Mi fermo qui perché credo che possiate rivolgervi direttamente all’associazione Figli della Shoah sia per richiedere la mostra che il materiale didattico ad essa correlato. E vorrei invece introdurre Liliana Segre. trasformare completamente la vita, trovandosi catapultata in una realtà che non è concepibile, nell’impossibilità di comunicare con il suo vicino, di condividere con chicchessia anche il più piccolo dei pensieri: sola. No, non è semplice immaginare, perché noi siamo troppo abituati a condividere. Ecco, senza volere, vi ho proposto un altro dei possibili spunti di riflessione sulla Shoah: come può esserci stanchezza nel parlarne ogni anno? Non lasciate che la Memoria diventi una cosa fine a se stessa e sterile, le strade sono davvero infinite. E la Memoria diventerà un dono di inestimabile valore. Per oggi vi chiedo di fare voi un dono a Liliana: fatele voi delle domande, non lasciate che sia lei a raccontarsi, a rivivere nuovamente da sola il suo viaggio. Rendetevi protagonisti, come dobbiamo cercare di essere sempre, grazie. Pi a Ja r a c h (…) 21 Mi presento: mi chiamo Liliana Segre, ho 70 anni, sono una nonna, una mamma, una moglie, una donna qualunque, come ne incontrate tante per la strada. Sono una persona qualsiasi, che nessuno noterebbe, che nessuno saprebbe chi sia, se, dopo quaran-tacinque anni di silenzio, un silenzio sofferto, un silenzio pesante dentro di me, non avessi, a un certo punto, sentito che non potevo più tacere, che avevo un dovere trascurato fino a quel momento, essendo una delle pochissime sopravvissute nel campo di sterminio di Auschwitz. Li l i a n a Se g r e Sono una delle pochissime persone che possono raccontare la Shoah, parola ebraica che significa catastrofe, rovina totale, perché sofferta direttamente sulla propria pelle, in tutti i sensi, perché ho anche un numero tatuato sul braccio sinistro. Ma, poi, negli anni, quando ho conosciuto storici, filosofi, critici, giornalisti, scrittori, psicologi, persone molto più colte e dotte di me, che ho incontrato nelle varie occasioni nelle quali sono stata invitata, ho sentito come la Shoah venisse rivoltata in tutti i sensi con mille diverse interpretazioni. Io ascoltavo, come ascolto sempre con grande interesse e con altrettanto interesse leggo tutto quello che si scrive in proposito, e mi rendo conto che il dovere della testimonianza è enorme. Mi dispiace molto di aver cominciato così tardi, a sessantenni, e di avere ormai sicuramente, per legge di natura, così poco tempo davanti a me, perché c’è così tanto da dire, prima che sia troppo tardi! Ora, quando noi pochi sparuti e vecchi sopravvissuti non ci saremo più, il mare dell’indifferenza, dell’ignoranza e dell’opportunismo, si chiuderà come se noi non fossimo mai esistiti. Io, come gli altri, uno dei tanti sommersi, come scrive Primo Levi in Sommersi e salvati, nell’indifferenza del mondo. E allora ecco che mi presento là dove sono invitata, e non solo da testimone, ma anche da madre, da nonna, da donna, sento il bisogno di incontrarmi con voi ragazzi, il mio pubblico eletto, i ragazzi con gli occhi puri, che il mondo non ha ancora contaminato con i suoi orrori e che possono diventare qualunque cosa. Voi avete la vita nelle vostre mani: potrete diventare donne e uomini straordinari, o quelli che buttano via la loro vita in discoteca, nella droga, o nel ridere stupidamente, anche quando, di ridere, non è proprio il momento, facendo quello ‘zapping’ della loro vita che si fa quando c’è qualcosa che da fastidio alla televisione. Zack, giri e in un attimo vedi una cantante, una partita di calcio, gli idoli del giorno d’oggi che non vi faranno crescere, diventare persone con la T maiuscola, non vi saranno d’aiuto, per divenire capaci di giudicare e di scegliere, sapendo dire motivati sì o motivati no. Soprattutto fondati no, quando sia il momento di dire no, perché risulta più facile dire sì. L’ho sperimentato personalmente com’era più facile dire sì. L’ho sperimentato a livelli di una gravita estrema che hanno voluto dire morte e disperazione, torture inflitte a persone colpevoli solo di essere nate, perché questa era la loro colpa. Inizio sempre così la mia testimonianza, raccontando di quando avevo otto anni. Quando anche voi diventerete vecchi e vi guarderete allo specchio, così come mi guardo io tutte le mattine, direte: “Ma pensa un po’ come sono diventato o diventata, mentre ognuno, dentro di sé, è rimasto sempre quello di allora: non cambia lo spirito, cambiano il fisico e l’aspetto, purtroppo!” Avevo otto anni ed ero una bambina come tante altre, nata a Milano, da genitori milanesi, da una famiglia, italiana da cinquecento anni, profondamente italiana: non sapevo neppure di essere ebrea. La mia era una famiglia ebraica agnostica, non particolarmente religiosa né inserita nel contesto della comunità ebraica di Milano e d’Italia, che contava comunque a quel tempo, e anche adesso - la gente non lo sa - trentacinquemila persone, una vera minoranza in un paese di cinquanta milioni di Italiani. Queste persone, con una legge fascista vergognosa, nel 1938 furono declassate a cittadini 23 di serie B: non importava se, tra questi, vi fossero professori di università, scienziati, umanisti, eccetera. Proprio ieri, leggevo sul Corriere della Sera, un elenco di Italiani, insigniti del premio Nobel; tra di loro Emilio Segre, Rita Levi Montalcini, A. R. Lurija, Renato Dulbecco. Tutta gente tornata in Italia dopo le persecuzioni, portando premi Nobel, ma allora, a causa di quella legge che declassava i cittadini italiani di religione ebraica a cittadini di serie B, tutti cacciati via, a partire dagli scolari di prima elementare fino agli studenti dell’università, ai professori, a coloro che ricoprivano cariche pubbliche nell’esercito e nella pubblica amministrazione. Non ci furono girotondi, manifestazioni sindacali, prese di posizione di alcun genere. Quelli che alzarono la voce per dire: “Mi vergogno di tutto questo”, furono talmente pochi da passare addirittura alla storia. Tutti dissero invece di sì, nell’indifferenza generale. Non fui più invitata alle loro festicciole. Vedevo che, anche nei giardini dove andavo a giocare, si manifestava una certa, non dico solo indifferenza, ma anche preferenza per le altre bambine. Nella nuova scuola, non parlavo mai di quello che succedeva a casa mia, conducevo una doppia vita, cosa che, poi, mi è successa spesso per sopravvivere. Ero una bambina qualunque: frequentai la terza, la quarta, la quinta, nella nuova scuola privata: non parlavo mai. Ero una bambina all’apparenza quasi come le altre; ma poi uscivo, sapevo che a casa mia veniva la polizia, continuamente, per controllare i documenti. Io seguivo tutto con i miei occhi infantili, già però fattisi maturi con l’esperienza di quei tempi, l’ansia e le espressioni del viso del mio papa (la mamma non l’avevo più) e dei miei nonni: tutta gente angosciata che, di colpo, aveva perso quella tranquilla serenità di “vite piccole piccole” di “borghesi piccoli piccoli” come eravamo noi. In quegli anni di persecuzione, mi ricordo di quando entrava la polizia in casa nostra. La nonna ed io andavamo ad aprire: si paravano davanti due o tre poliziotti i quali, nel mio ricordo infantile, mi sembravo “molto grandi” nel vano della porta. Entravano con aria truce, dovevano controllare i documenti dei “nemici della patria” e rimanevano spiazzati. Mia nonna, una signora dell’ottocento, dolcissima, li invitava in salotto, offriva loro dei biscottini fatti da lei e mi mandava di là a giocare. Io volevo stare ad ascoltare fuori dalla porta che cosa dicevano alla nonna, ma, nello stesso tempo, avevo paura e pensavo a qualcosa di inconsueto per i miei otto/nove anni di allora. Frattanto si susseguirono e si incrementarono le restrizioni per gli ebrei: permessi per ogni cosa e, soprattutto, solitudine. Ho detto solitudine, dal momento che tutti sono pronti a seguire il carro dei vincitori, ma molto pochi sono quelli disposti a seguire la strada di coloro che cadono in disgrazia. Allo scoppio della guerra, ai primi bombardamenti, sfollammo in un paesino della Brianza, dove non c’erano scuole private ed io, che avrei dovuto frequentare la seconda media, stavo 24 Li l i a n a Se g r e Io mi ricordo quando mio papa mi comunicò che non avrei più potuto frequentare la scuola: cercava di spiegarmi che non avevo fatto niente di male, non ero stata espulsa dalla scuola io, in quanto io; eravamo stati espulsi noi, solo in quanto ebrei, dalla società civile. Era civile quella società? Non lo so, noi ne eravamo stati e-spulsi. È vero, lo racconto spesso, che, obbligata a cambiare scuola, (andavo comunque in una scuola non lontana da quella pubblica), incontravo le mie compagne d’un tempo, le quali mi segnavano a dito, dicendo: “Quella lì è la Segre, non può più venire a scuola, perché è ebrea”. Erano bambine come me, ‘stupidine’, mica sapevano delle leggi razziali, sentivano a casa quello che veniva detto contro di noi. invece sempre a casa, a curare mio nonno, malato gravissimo, affetto dal morbo di Parkinson. Io stavo con lui, lo accudivo, cercando di trovare in me un’allegria e una spensieratezza che in realtà non possedevo; inventavo delle storie, gli facevo il teatro: ero molto fantasiosa a quel tempo. Intanto ero diventata una specialista della radio. Allora non c’era ancora la televisione, e io stavo sempre a sentire la radio dei vicini, perché, tra le tante cose proibite, c’era quella dell’uso della radio, soprattutto di girare la manopola della radio per cercare un’altra stazione. La manopola era stata, infatti, fissata dalla polizia sull’unica stazione italiana. Li l i a n a Se g r e Io, invece, andavo a sentire “Radio Londra” dai nostri vicini, ed ero diventata una specialista della guerra, seguivo i bollettini e, soprattutto, capivo, sia dalla radio sia dalla cupezza dell’umore dei miei, sempre più disperati, che cosa stesse accadendo: le armate tedesche stavano invadendo tutta l’Europa, gli eserciti antitedeschi cadevano come birilli, l’uno dopo l’altro, e l’avanzata tedesca pareva inarrestabile. Noi sapevamo benissimo che cosa sarebbe accaduto se avessero vinto i nazisti. Il mio papa, ufficiale dell’Esercito Italiano nella prima guerra mondiale, viveva anche un suo dramma personale: doveva infatti augurarsi, per la salvezza nostra, che l’Italia perdesse la guerra. Nell’estate del 1943, il 25 luglio, cadde il fascismo e, dopo l’8 settembre, i nazisti diventarono padroni di tutta l’Italia del nord e, alle leggi razziali fasciste, già per loro conto severe e umilianti, si sovrapposero le leggi razziali di Norimberga, che prevedevano programmaticamente la ‘soluzione finale’. Cominciò una vera e propria caccia all’uomo, una caccia a uomini, donne, bambini, compresi neonati, donne incinte, vecchi intrasportabili, colpevoli solo di esser nati ebrei. In questo i nazisti erano aiutati da questori e prefetti italiani, i quali, già da tempo avevano stilato elenchi molto precisi con tutti gli indirizzi, i nomi, i cognomi degli ebrei, cittadini italiani ebrei, residenti in Italia. Cominciò dunque una caccia spietata nella quale gruppi armati di tutto punto andavano casa per casa per stanare persone inermi che non sapevano bene che cosa stesse succedendo, persone che fino al giorno prima avrebbero giurato, per il fatto di essere talmente malate, vecchie o bambini, di non doversi preoccupare di fuggire. Era una “caccia all’uomo” talmente spietata e tragica, che alcuni ebrei andarono addirittura a consegnarsi, perché non potevano più reggere la fatica angosciosa della fuga. Una persecuzione, che implicava la ricerca di appoggio in una casa di non ebrei, i quali rischiavano la vita per ospitare gli ebrei, ragion per cui non se ne trovavano in tutti gli angoli, oppure uno poteva dormire una notte in una casa, ma gli ospiti gli dicevano: “Domani dovete andare via”. Erano situazioni che di colpo, da un giorno all’altro, procuravano dolori e disperazione infiniti. Il mio papa decise allora che io sarei andata via di casa, non potendo portar via i suoi vecchi genitori, il nonno, soprattutto, intrasportabile. In tale occasione il mio papa, oltre che un padre meraviglioso, si dimostrò un figlio fantastico. Io, fra pianti e disperazione, fui ospitata, prima in Valsassina, poi a Legnano, da amici eroici, che mi tennero presso di loro con grande affetto. Famiglie indimenticabili: si chiamavano l’una Pozzi, l’altra Civelli. Li nomino sempre, perché furono dei ‘Giusti’ che rischiarono la vita per me, una ragazzina di tredici anni, con documenti falsi. Avevo la carta d’identità falsa ed ero così stupida, così sciocca, che non riuscivo assolutamente ad imparare quelle false generalità; mi sembrava una cosa enorme non poter più dire il mio nome, cognome, indirizzo, data di nascita; erano diventate altre le mie generalità, e il mio papa mi diceva: “Imparale, imparale, perché non è solo la salvezza tua, ma anche di chi ti ospita.” Avendo carta d’identità falsa, ero un’ospite che metteva in pericolo di vita le persone che mi tenevano con loro. Poi, dopo mille suppliche, perché volevo andare in Svizzera e non rimanere più in una situazione così critica, senza notizie dei miei amatissimi cari, il mio papa riuscì ad ottenere un 25 permesso dalla questura di Corno per i suoi genitori. Era un permesso sul quale era scritto (lo vidi poi, dopo la guerra), che Olga e Giuseppe Segre, in considerazione del loro stato di salute, potevano vivere a Inverigo, sotto la custodia dei padroni di casa, perché impossibilitati a nuo cere al grande Reich Tedesco: lo credo che non potessero nuocere! Il nonno tremava in tutto il corpo e la nonna era andata via di testa, quasi completamente, per il terrore di quello che ci aspettava. Questo permesso doveva rivelarsi carta straccia, ma allora non lo sapevamo; dico questo perché i miei nonni, mesi dopo, quando io e il mio papa eravamo già stati arrestati e portati ad Auschwitz, i miei nonni ampissimi, dolcissimi, furono anche loro arrestati in quelle condizioni è deportati. Purtroppo giunti vivi ad Auschwitz, furono gasati e bruciati all’arrivo, per la sola colpa di essere nati; ma in quel momento noi eravamo felici di quel permesso a cui credemmo o volevamo credere. I nostri amici di Legnano allora organizzarono la fuga per me e per il mio papa. Correvamo sulla montagna, mi ricordo, la mano nella mano del mio papa, il quale portava una piccola valigia, mentre i nostri accompagnatori ci spronavano ad andare sempre più in fretta sulla cresta della montagna. A noi pareva un’impresa difficilissima, ma poi, finalmente, all’alba, riuscimmo a passare. Eravamo nella terra di nessuno: quella striscia che si interpone tra i due stati e poi un boschetto: era la Svizzera! Ah la felicità! Ci abbracciavamo, io e mio papa e i due vecchi cugini che si erano uniti a noi all’ultimo momento. Sembrava impossibile che proprio noi fossimo riusciti, dopo tanti pericoli, dopo tante paure, ad arrivare dall’altra parte. La sentinella che ci vide in quel boschetto, senza una parola, ci accompagnò ad Arzo, primo comune al di là del confine italiano, al Comando di Polizia. Entrammo e, dopo lunga attesa, finalmente l’ufficiale svizzero-tedesco ci ricevette e, immediatamente, ci disse che dovevamo tornare indietro: la Svizzera era piccola e non c’era posto per noi. Quando capii che, dopo tanta euforia e felicità per essere arrivati lì, l’ufficiale ci respingeva, io mi buttai per terra, gli tenevo le gambe, stringevo, lo supplicavo in ginocchio, piangendo, e lui mi respingeva, così come si fa con un cucciolo che ti disturba, che ti si attacca alle gambe: “Via, via”, non “c’era niente da fare, “Via, via”. Quell’ufficiale, dunque, ci rimandò indietro con le sentinelle armate, più o meno là dove eravamo scesi la mattina precedente. Fummo arrestati sul confine e la sera stessa eravamo in camera di sicurezza; il giorno dopo nelle carceri di Varese. A tredici anni, entrai da sola nel carcere femminile di Varese; me lo ricordo sempre come un momento di grande solitudine della mia vita, quando, per la sola colpa di essere nata, fui trattata come una delinquente comune: fotografia, impronte digitali, buttata in una cella da una donna senza pietà. Nella cella c’erano altre donne ebree, catturate sul confine, come me. 26 Li l i a n a Se g r e Ci trovammo sui monti dietro a Varese, dopo aver affrontato mille pericoli, con le carte d’identità false, ma avevamo tutti anche quelle vere, perché dovevamo entrare in Svizzera, dove, con documenti falsi, non saremmo stati accolti; avevamo quindi doppi documenti: una cosa pericolosissima! Arrivammo nella notte, il mio papa ed io, a Saltrio, sopra Viggiù, e lì trovammo dei contrabbandieri senza scrupoli. Ci sono stati dei ‘Giusti’, ma anche degli ‘Ingiusti’, i quali approfittarono in modo spaventoso delle disgrazie altrui. Tali contrabbandieri, per cifre da capogiro, in quei mesi, facevano passare o non passare, secondo la loro convenienza, antifascisti renitenti alla leva, gruppi di ebrei, disperati così come eravamo noi. Ci trovavamo sulle montagne, cittadini completamente inadatti, ‘borghesi piccoli piccoli’, senza neppure un’attrezzatura adatta per l’inverno: era dicembre. Con fatica fisica enorme, nel buio, con le sentinelle che stavano per passare, i contrabbandieri ci dicevano: “Svelti, svelti, camminate più in fretta!” Li l i a n a Se g r e Dopo una settimana trascorsa a Varese, fummo portate nel carcere di Corno: carceri vecchie, senza riscaldamento, senza nemmeno l’ora d’aria. Ci domandavamo che cosa sarebbe stato di noi. Io mi chiedevo: “Chissà che cosa pensa il mio papa nel carcere maschile, che cosa starà pensando di quello che succede a me?”. Poi, improvvisamente, per quegli oscuri disegni dei nazisti, troppo difficili da interpretare e da capire, eccoci di nuovo insieme nel carcere di S. Vittore a Milano. Era una vita incredibile quella nel carcere di S. Vittore, sulla quale io mi soffermo per dirvi che quella cella spoglia non era come quelle di adesso (per quanto orribili, hanno televisione, fornelletto, gabinettino); era quella una cella spoglia nella quale c’erano due brande di ferro, pareti nude, un secchio per i nostri bisogni. Fu l’ultima casa per il mio papa e per me, e, pur nella disperazione, in quella cella fui felice, salvo quando la Gestapo (polizia segreta di stato tedesca), chiamava gli uomini per gli interrogatori, e io rimanevo sola con i miei tredici, anni in quella cella. Aspettavo una, due, tre ore, che lui ritornasse; sapevo che picchiavano, sapevo che torturavano, e racconto sempre che erano isolo le scritte dei disgra ziati passati prima di noi da quella cella l’unica lettura di cui disponevo. Non avevo una spalla su cui piangere, mai l’ho avuta. Erano scritte sul muro, erano addii, firme, maledizioni, benedizioni. Lui poi tornava, ci abbracciavamo in silenzio, non mi raccontava nulla; io ero vecchia, vecchia, non avevo i miei tredici anni spensierati come avrei dovuto: ero sua madre, sua sorella, sua amica che lo stringeva al cuore. Alla fine di gennaio, entrò un tedesco nel raggio. Il carcere di Milano ha una pianta a stella, con tanti raggi, uno dei quali era riservato solo agli ebrei. Si era riempito: eravamo sei, settecento persone. Un pomeriggio - dicevo prima - entrò un tedesco e lesse un elenco di nomi, tra questi anche i nostri, di coloro che si dovevano preparare a partire il giorno dopo, per ignota destinazione. Rino Ravenna, un signore scapolo, uno dei due cugini che erano fuggiti con noi, arrivando in Svizzera, vecchi con le loro ultime forze, i loro ultimi soldi, sentendo il suo nome, salì all’ultimo piano di S. Vittore, che, allora, aveva ballatoi, simili a quelli che si vedono nelle prigioni americane, quindi aperto, e si buttò giù. Morì sul colpo. Aveva scelto lui come morire. Io non avevo mai visto un morto e mi ricordo come era scomposto lì, sull’impiantito, quando ci accorgemmo che era lui: il vecchio cugino saggio, un professore che non poteva più insegnare niente a nessuno. Ci preparammo a partire, ma eravamo più di 600 persone. In tutto, gli ebrei, deportati in Germania dall’Italia, in varie ondate, furono, su quei trentacinquemila che vi dissi all’inizio, ottomilaseicento: circa un quarto della popolazione ebraica (l’ho letto sul ‘Libro della Memoria”, perché io quei numeri non li conoscevo: siamo tornati in trecentotredici). Uscimmo dal carcere di S. Vittore, attraversammo la città su camion, una città deserta, nessuno alle finestre. Fummo portati alla stazione centrale e lì, dai sotterranei, caricati a calci e pugni sui vagoni-bestiame che erano pieni di un’umanità dolente. Man mano che i vagoni venivano riempiti da cinquanta o sessanta persone, venivano sprangati da fuori. Come ci si pone con il proprio padre, con la propria madre, con il proprio marito, sorella o fidanzato, come ci si pone dentro un vagone bestiame, al buio, un po’ di paglia per terra, un secchio per gli escrementi, non acqua, non luce? Come ci si guarda l’uno con l’altro? Come dire all’altro: “Ti voglio bene, sono qui per darti speranza!”. Una tragedia, incombente come quella, ti toglie la possibilità, la voglia, il desiderio, la forza fisica e psichica di pronunciare e accettare una parola. Il mondo é nemico intorno a te. Il treno si muove. Dove va quel treno per una settimana? Viaggi in quelle condizioni e vedi passare il confine e scendere i ferrovieri italiani: sapevano che non portavano vitelli (veramente portavano dei vitelli al mattatoio!). 27 Le nostre voci uscivano come lamenti da quei piccoli finestrini schermati nei quali entrava il freddo dell’inverno, quando il treno si fermava nelle stazioni: nessuno ci dava qualcosa o si degnava di ascoltarci. Scesero i ferrovieri italiani e salirono altri ferrovieri, austriaci prima, tedeschi poi. Passava la campagna innevata. Guardavamo i pa-esini, la chiesetta, il filo di fumo, le tendine alle finestre, e noi eravamo lì, per la sola colpa di essere nati, eravamo lì, eravamo lì! Ma perché? Ma perché? Ma perché? Questo me lo sono chiesta sempre, per tutta la vita. Perché? Perché? Perché? Non ho potuto trovare una risposta! Arrivammo ad Auschwitz.. Lo racconto sempre ai ragazzi, perché il viaggio della deportazione è un momento importantissimo. Cercherò di rendere con le mie povere parole un viaggio così allucinante, inventato da uomini per altri uomini, diviso in tre parti: - la prima era quella del pianto in cui tutti piangevano; - la seconda era quella degli eletti, dei ‘religiosi’. Io purtroppo non sono religiosa e ho guardato sempre chi ha la fede con invidia, brutto sentimento che non vorrei avere* ma che provo solo in questo caso. Erano gli ultimi giorni, nessuno parlava più, non c’era più niente da dire, ed ecco che a quel silenzio, così importante, si sostituì il clamore osceno degli assassini intorno a noi. Arrivati ad Auschwitz, stazione, binario morto, stazione di arrivo per tutti, di tantissimi trasporti di centinaia, di migliaia, centinaia di migliaia di persone che arrivarono dall’Europa occupata dai nazisti, per la colpa di essere nati, spalancarono quei portelli, con una forza e una violenza inaudite e ci tirarono giù da quei vagoni: gambe anchilo-sate, occhi non più abituati alla luce. Apparve davanti a noi una spianata, coperta di neve sporca, e tanta gente. C’eravamo noi, seicento e passa persone di quel trasporto e poi uomini, prigionieri vestiti a righe, che non avevamo mai visto, adibiti a tirarci giù dai vagoni, ad ammucchiare le valigie, e le SS con i loro cani, molto bene addestrati. Furono divisi gli uomini dalle donne e lasciai per sempre la mano del mio papa. Rimangono nel mio ricordo solo quei sorrisini che gli facevo da lontano, dei piccoli ‘ciao’, ma poi, ad un certo punto, non l’ho visto più. 28 Li l i a n a Se g r e In quella condizione gli uomini pii, gli uomini religiosi si riunivano nel centro del vagone e pregavano, lodando Dio, pregavano anche per noi che non sapevamo pregare. Li guardavamo: era una visione surreale. Oggi ci vorrebbe la capacità di un regista eccezionale, il quale non facesse una semplice operazione, commerciale come tante, ma potesse rendere l’idea ehe4entro al vagone-, nel buio di quel vagone, con pochissima luce, un gruppo di uomini, avvolti nello scialle di preghiera, si dondolavano, salmodiando e lodando Dio. Guardavamo. Era una scena struggente, ma straordinaria e indimenticabile. Poi l’ultima fase, importantissima per me, gli ultimi giorni che trascorsi con il mio papa. La fase del silenzio. Non per niente io ho in grande onore il silenzio, in questo mondo di suoni e di rumori assurdi e inutili. E invito sempre quei tre di voi, che spero diventeranno candele della memoria, a riflettere sul silenzio, a trovare, nella loro giornata, tre minuti per stare in silenzio e riflettere, a-scoltare la voce della propria coscienza: una voce così forte, così importante, così solenne, una voce che è la vita stessa, e che non sbaglia nei suoi consigli. Quando non si ascolta la voce della propria coscienza, si possono commettere azioni infamanti, o anche solo non far nulla, che è quasi peggio. Il silenzio delle ultime cose, di quando uno è solo e deve trovare soltanto in se stesso la forza per andare avanti. Ci hanno messo in fila davanti a quel piccolo tribunale di vita e di morte, rappresentato da tre SS eleganti, inguantati, con gli occhi gelidi e il labbro atteggiato a sorriso. “Calmi, - ci dissero - state calmi. Stasera sarete di nuovo tutti insieme”. Li l i a n a Se g r e Ci volevamo credere, ci volevamo credere. Era una realtà troppo incredibile, per noi che eravamo usciti da quel treno, sul quale ancora qualcuno ci diceva ‘tesoro’ e ‘amore’ nella nostra lingua. E lì, in una babele di lingue e linguaggi, non capivamo niente, ci parlavano in tedesco. I prigionieri potevano essere polacchi, cecoslovacchi, tedeschi, potevano essere qualunque cosa. Ci impartivano ordini che non capivamo. Ci misero in fila: le donne da una parte, gli uomini dall’altra. Le SS avevano una grande organizzazione e la lista di quelli che erano arrivati. Sapevano già, per un disegno oscuro del destino, che in quel giorno volevano in vita trentun donne, non so perché trentuno, e settanta, ottanta uomini, fra quelli giovani che potevano lavorare. Così furono scelti, con un sì o con un no, i più giovani che andarono per primi alla selezione, ed io con loro. Poi, giunti, al numero trentuno, non guardavano più le altre, che potevano essere anche ragazze giovanissime. Raggiunta la quota stabilita, gli altri furono caricati sui camion. Noi li vedevamo andar via e dicevamo: “Che fortunati, in questo freddo e con la neve, scesi dal treno dopo tanti giorni, loro vanno in camion e invece noi a piedi”. Non sapevamo che venivano portati direttamente nelle camere a gas. Non era possibile immaginare una tragedia di questo genere. Avviati a piedi, ci guardavamo, trentun ragazze sconosciute, che avevamo in comune solo la consapevolezza di essere italiane, un elemento quindi importantissimo! “Dove andiamo adesso?” ci domandavamo. Incolonnate, entrammo poco dopo nel grande lager femminile di Birkenau, sottocampo. Entrammo, ed era una realtà incredibile da accettare: a perdita d’occhio, baracche, baracche grigiastre e neve sporca. Donne prigioniere, la testa rasata, vestite a righe che portavano pesi, veniva no picchiate, spinte, obbligate a compiere fatiche inutili che, al momento, noi non capivamo neppure che cosa fossero, e il triplo filo spinato, con la sentinella sulla torretta, la mitragliatrice puntata verso le prigioniere. Ma dove siamo arrivate? - ci chiedevamo -Stiamo impazzendo, forse non abbiamo dormito in questi ultimi giorni, siamo in preda ad un incubo!?!”. Non era possibile credere ai propri occhi. Nella prima baracca, fummo denudate di tutti i nostri vestiti, privati di quel pochissimo che potevamo ancora avere con noi. Mentre i soldati passavano sprezzanti e irridenti, noi, e mi rivolgo soprattutto alle ragazze, fummo costrette ad esibire una nudità obbligata, una nudità umiliata, una nudità offesa, una nudità presentata così a quei soldati, ai quali non interessavamo per niente come donne. Anzi, in verità, per le leggi di Norimberga, era proibito ai puri ariani accoppiarsi con donne delle così dette razze inferiori: quindi tante violenze abbiamo subito, ma non quella. Ci guardavano invece come esseri spregevoli. Noi cercavamo di Scoprirci in qualche modo. Ci fu rasata la testa e, mentre i capelli cadevano per terra, non eravamo già più noi. Ci fu poi tatuato il numero sul braccio e, al momento, era una cosa che faceva anche male fisicamente. Ci guardavamo l’una con l’altra, rivestite di stracci, con la divisa del campo, senza badare alla misura di chi doveva indossarla. La divisa era fatta di cascame di cotone, con quel freddo, e gli zoccoli non erano del numero del nostro piede. Non eravamo già più quelle che erano scese dal treno due ore prima, eravamo già delle schiave: quel nulla che i nostri persecutori volevano che diventassimo. 29 In una cosa sono riusciti sicuramente: quel numero tatuato sul braccio ha veramente sostituito, in noi sopravvissuti, la nostra i-dentità precedente, perché noi, prima di tutto, siamo quel numero, inciso così profondamente nella carne, nel cuore e nell’anima: nessuno di noi sarebbe stato mai più quello di prima. Il mio numero è 75190, e i miei figli sanno che, se avrò una tomba, dovrà esservi scritto prima del mio nome. È un numero che ha condizionato pro fondamente tutta la mia vita e che, purtroppo, ha condizionato i miei figli, ed ora passa anche alla seconda generazione, perché ho due nipoti che mi chiedono: “Perché tu, nonna, hai tatuato quel numero? E quindi questa nonna marchiata, la mamma marchiata, ha voluto dire nella mia famiglia molto dolore per tutti: un dolore che non si è esaurito con la mia persona. Secondo studi condotti da qualificati psicologi, questa -sindrome del sopravvissuto passa attraverso la prima? la seconda e, spero, non la terza generazione. E allora mi guardavo il braccio con il numero-scritto: cominciò così la mia vita di prigioniera-schiava. Soltanto il fatto che fossi alta e dimostrassi più anni aveva fatto sì che le SS, per la selezione alla stazione, mi avessero scelto per la vita, perché bambini, ragazzini che non avessero dimostrato più della mia età, sarebbero stati mandati immediatamente al gas. Io, per mia fortuna, fui scelta, dopo pochi giorni, per diventare operaia alla fabbrica Union. 30 Li l i a n a Se g r e Come si fa a descrivere che cos’era la vita, in quelle città di morte, dove il comandante non faceva altro che ripetere tutti i giorni, che. eravamo lì solo per lavorare, e che nel momento in cui non avessimo più potuto lavorare, saremmo usciti solo “durch den Kamin”, solo attraverso il camino. Le prime prigioniere, le ragazze francesi che incontrai, spiegarono a noi ragazze italiane appena giunte, dove eravamo arrivate, ci spiegarono cos’era quell’odore dolciastro, che permeava tutto il campo: era l’odore della carne bruciata; ci spiegarono cos’era quella ciminiera in fondo al campo dalla quale uscivano o la fiamma o il fumo. “Bruciano le persone!” “Bruciano le persone?!” Noi guardavamo le ragazze francesi, che avevano quindici giorni di anzianità, e dicevamo: “Queste sono pazze, ecco dove siamo arrivate, in un manicomio, questo è il punto: non l’avevamo capito, perché non era possibile che fosse vero.” E aggiungevano: “Sì, non vedrete mai più quelli che avete lasciato alla stazione, perché, a quest’ora, sono già stati cremati, sono già passati per il camino”. Bruciano le persone? Ci spiegarono allora che cosa voleva dire Lager di sterminio. Ci dissero che dovevamo imparare il tedesco a gran velocità, perché molti erano stati uccisi, in quanto sordi o muti alla lingua degli aguzzini; occorreva quindi imparare il proprio numero immediatamente; numero che serviva per la zuppa, per il cambio dei vestiti una volta al mese, per obbedire ai comandi, per tutto. Ci raccomandavano di non guardare mai in faccia i nostri aguzzini perché era proibito, di non incrociare il loro sguardo, perché bastava una simile imprudenza per essere mandati a morte. Bisognava obbedire ciecamente, cercando di rendersi invisibili. Imparai quella lezione, la imparai subito. Ero sola, sola, sola. Ho cominciato a ripetermelo immediatamente, ma, soprattutto, ho scelto immediatamente la vita. Questo dono straordinario che abbiamo, un dono a cui siamo chiamati senza nostra colpa o senza nostro merito; questo dono così meraviglioso, di cui ci si rende conto solo quando ci si trova in pericolo di vita. Dono che non va sprecato, dono che va vissuto ogni minuto, dono che non va buttato via per una moda, per un brutto voto; vita che non va gettata per un amore deluso, perché è un dono straordinario, eccezionale: prendetelo nelle vostre mani e vivetelo fino in fondo. Io, la mia vita l’ho già vissuta, sono vecchia, ed è stata straordinaria: sono stata molto felice, sono una donna molto felice. Scelsi la vita, la vita anche in quell’orrore. Volevo vivere, non potevo pensare che la mia vita sarebbe finita a tredici o quattordici anni che compii da prigioniera ad Auschwitz. Ebbi molta fortuna. Fui scelta, senza mio merito, ero la più stupida del mondo, la più giovane del gruppo. La Union è una fabbrica che in tempo di pace, produce automobili, in tempo di guerra, armi. Alla mattina, dopo l’appello, dopo quella sveglia, quando era buio (noi non avevamo orologio, radio, calendario, giornale, niente!), si entrava nella irrealtà del campo, per non essere più persone e quindi, come tali, eravamo solo Stuecke (pezzi) come si dice in tedesco, pezzi, che eravamo lì per lavorare, quindi senza orario. Alla mattina venivamo svegliate in quei giacigli dove dormivamo in cinque o sei, vestite, perché le compagne avrebbero rubato i vestiti, con gli zoccoli sotto la testa, perché le compagne avrebbero rubato gli zoccoli, svegliate con una bastonata, e poi fuori sulla neve all’appello che poteva durare mezz’ora, un’ora, due ore, finché non tornavano i conti agli aguzzini. Ci veniva poi data una scodella che dovevamo dividere in cinque, di una bevanda che chiamavano tchai, che voleva dire tiglio in polacco: un infuso di erbe che costituiva la nostra colazione del mattino. Ce la dividevamo in sorsi. Io, che ero sempre la più stupida del gruppo, non avevo capito che dovevo berne, una gran sorsata, perché difficilmente sarebbe tornata la seconda volta, poi imparai. Dopo di che venivamo messi in fila per cinque, un gruppo di circa settecentocinquanta del turno di giorno, alla fabbrica Union. Li l i a n a Se g r e All’uscita del campo, c’era l’orchestrina delle donne prigioniere: violiniste, obbligate a suonare marce e motivetti allegri, mentre i gruppi uscivano per andare al lavoro o al gas. Erano violiniste di cui si è anche scritto, perché era uno degli elementi molto particolari dell’organizzazione nazista del lager: erano gruppi di ragazze che, mentre suonavano motivetti allegri, qualche volta piangevano. Uscivamo dal campo e facevamo una marcia obbligata sulla neve, ballonzolando sugli zoccoli, con le gambe sempre più molli, lo stomaco sempre più vuoto e una fiacca spaventosa; marciavamo fino alla città di Auschwitz, dove lavoravamo tutto il giorno in fabbrica. Ma quando incrociavamo i gruppi dei nostri coetanei della Hitler-Jugend, ragazzi della SS giovanile, giovani pasciuti, biondi, ariani, con delle belle biciclette (io avevo lasciato la mia bicicletta, molto desiderata allora, a Inverigo), ci guardavano con disprezzo e ci sputavano addosso. Ci apostrofavano con parole così spaventose, ingiurie che non capii al momento; me le feci spiegare in seguito da qualcuno che capiva il tedesco. Non potevo rendermi conto che, dopo averci portato via tutto, casa, famiglia, quasi la vita, l’odio fosse tale da indurii ad offenderci con parole di questo genere. Queste larve di donne, ragazze, squallide, rapate a zero, vestite di stracci, ormai ridotte a ectoplasmi di quello che erano state, venivano ancora trattate con parole spaventose. Beh, io li odiavo, li guardavo e li odiavo profondamente! E fu per me fantastico, devo dire fantastico, quando, in età adulta, mi resi conto che la mia maturità di donna mi aveva portato a nutrire una grande pena per loro; ho capito che nella vita è stato così importante essere vittima, nipote e figlia di vittime, piuttosto che figlia o sorella o nipote di uno di coloro che avevano compiuto tali cose inenarrabili. Quando sono divenuta donna adulta, ne ho avuto pena: una pena infinita. Avevano bevuto latte avvelenato, un’ideologia avvelenata, che li aveva portati ad essere così. Proseguivamo poi la strada e arrivavamo in fabbrica, lavoravamo tutto il giorno: non c’erano sindacati a difendere un orario, eravamo lavoratori-schiavi, nessuno si occupava di noi. La mano d’opera che arrivava da tutta Europa, occupata dai nazisti, era talmente numerosa che, non appena uno cadeva o non ce la faceva più, sbagliava o disobbediva, veniva sostituito e mandato al gas. Che importanza poteva avere uno di questi, un sottouomo, un Untermensh, come dicevano loro. Non era più nessuno. Era un numero. Vada a morte, se ne prenda un altro. Lavorai un anno come operaia schiava. 31 Era una fortuna lavorare, perché era una fortuna lavorare al coperto, mentre quelle disgraziate, adibite ad attività all’esterno, erano obbligate, sotto la neve, sotto la pioggia, senza riparo, vestite di stracci, a scavare buche con le pale e la terra ghiacciata, mentre un altro gruppo doveva chiudere la buca. Oppure un gruppo caricava sul camion dei sassi molto pesanti, un altro gruppo, dall’altra parte, li scaricava: erano lavori ossessivamente insensati, fatti apposta per uccidere. Non ce l’hanno fatta. Noi lavoravamo invece in una fabbrica di munizioni, cercando tutti di lavorare al peggio, perché sapevamo di lavorare per la guerra, ma eravamo al coperto. La sera, quando, dopo la marcia, rientravamo, la prima visione era il crematorio. Fumo o fuoco. Chi sarà arrivato oggi? Chi sarà andato al gas? Facevamo la doccia in trenta, quaranta per volta. Scendeva un filo d’acqua. Tenevamo i vestiti e gli zoccoli con una mano, perché nello spogliatoio qualcuno li avrebbe subito rubati. Quando non si ha niente, non puoi giudicare un ladro come lo si giudica normalmente: era una questione di sopravvivenza, quindi te li tenevi con una mano, e con l’altra cercavi con quel pezzetto di sapone, che non faceva schiuma, e che ci avevano detto essere fatto con il grasso dei nostri morti, di lavarti della sporcizia della giornata trascorsa in fabbrica. Scendeva un filo d’acqua, o ghiacciata o bollente e, bagnate come eravamo, ci rivestivamo con i nostri stracci, mentre le sentinelle che passavano di lì, guardavano irridendo i corpi, che si scheletrivano giorno per giorno, per quel niente che mangiavamo, e poi uscivamo nella neve e tornavamo nella baracca. Finiva in fretta quel pezzo di pane nero pesantissimo, e poi c’era la notte; la notte in cui, con le dita nelle orecchie, dormivamo assolutamente stroncate dalla stanchezza della giornata e non volevamo sentire gli urli, i fischi, i lamenti di quelli che, in certi periodi, andavano direttamente al gas, e si udivano i richiami delle mamme che, nella folla, avevano perso i bambini e viceversa, ma noi volevamo dormire. Qualcuno mi ha chiesto: “Facevate dei sogni?” Io non mi ricordo di aver sognato, so che volevo dormire, avevo bisogno di dormire, non volevo pensare e, soprattutto, non volevo essere lì. Spesso mi pongono questa domanda: “Come ha fatto, signora, a sopravvivere?” Non lo so, evidentemente non era il mio momento per morire, ma io decisi che non volevo essere lì, decisi di sdoppiarmi, non era il piccolo gioco di quando andai nella scuola privata, dove mi ero sdoppiata: una era la scolara, l’altra la ragazzina perseguitata. Ormai ero vecchia, ero centenaria. Sono molto più giovane adesso, dentro di me, di allora che avevo quattordici anni. Io non volevo essere lì, volevo essere quella di prima, quella che correva sui prati, che nuotava al mare d’estate, che aveva quei visi affettuosi e la sua famiglia intorno, la ragazzina che dovevo essere a quell’età, e volevo astrarmi, così, in tutto e per tutto, dalla realtà in cui ero obbligata a vivere, mi ero identificata con una stellina che, nelle sere terse, quando tornavamo dalla fabbrica, io guardavo sempre, perché avevo deciso che sarei stata viva finché quella stellina avesse brillato e viceversa. Era un gioco con me stessa per cui non volevo vedere quegli orrori, non mi voltavo a vedere le mie compagne in punizione. Ero vigliacca, spaventosamente vigliacca, volevo salvaguardare la mia integrità mentale e non lo potevo fare, se non astraendomi da quella realtà. Era solo il mio corpo che mi riportava a quella realtà, il mio corpo che aveva freddo, fame, che veniva picchiato, che era diventato magro, un orrore: le anche con le piaghe, con le ossa che uscivano. Ero orribile. 32 Li l i a n a Se g r e La giornata era finita. Alla sera ci aspettava il momento fantastico in cui ci veniva distribuita una razione di pane nero, accompagnata da un cucchiaino di margarina e da un cucchiaino di marmellata acida e, qualche sera, da una rotella di salsiccia, che ci avevano detto di non chiedere di che cosa fosse fatta. Noi mangiavano avidamente. Non avevo specchio, ma il mio specchio erano i visi delle mie compagne con gli occhi scavati. Non avevamo più mestruazioni, non eravamo più donne, eravamo esseri informi che volevano vivere, perché la scelta di vita l’hanno fatta tutti, quelli che si sono salvati. I non si sono salvati perché hanno compiuto questa scelta, ma, certamente, questa li ha aiutati come accade al malato gravissimo. Il medico dice: “No, vedrà che ce la farà se ce la mette tutta”. Magari muore, ma si impegna a prendere le medicine, a non abbattersi nell’aura di morte: ce la può fare di più del pessimista, che è già deciso ad arrendersi. Noi volevamo vivere, volevamo vivere, volevamo vivere e, per questo, non si poteva guardare quel panorama di mucchi di cadaveri scheletriti, nudi, fuori dal crematoio, pronti per essere bruciati. Io non li guardavo, non guardavo il triplo filo spinato, le sentinelle, non guardavo i miei capi in faccia. Li l i a n a Se g r e Non volevo essere lì, non ci volevo essere. Ero da un’altra parte, ricordavo un vecchio film, una canzone, un romanzetto, di quegli stupidi che avevo letto. Non ero lì, ma c’ero. Tre volte passai la selezione in quell’anno che trascorsi a Birkenau-Auschwitz. Non era la selezione della stazione, quando quelli scesi dal treno venivano ‘aggrediti’ da una realtà più grande di loro, di cui non sapevano nulla. Per loro il fatto di dover andare a destra o a sinistra non voleva dire niente in quel momento, ma noi dopo lo sapevamo: erano selezioni annunciate, di cui si sapeva già l’esito. Come ci si sente, quando, nuda, e qui mi rivolgo sempre alle ragazze che mi ascoltano, completamente nuda, nella tua ormai perduta femminilità e dignità, sei obbligata ad attraversare un percorso obbligato e là, dopo quella porta, dalla quale si esce, ci sono tre assassini in divisa: uno è medico. Ma pensate ai medici SS che hanno compiuto esperimenti, che hanno mandato a morte persone colpevoli solo di essere nate; medici che avevano prestato pure il giuramento di Ippocrate, che impegna, chi lo pronuncia, a scegliere una vita professionale finalizzata ad aiutare gli altri. Poi c’era, io non lo sapevo, anche quel dottor Mengele di cui poi si parlò. Noi passavamo una per una davanti a quel tribunale di vita e di morte. Più una era magra, orribile, più era terrorizzata per la sorte che l’aspettava. Come ci si pone quando si attraversa quello spazio e là c’è quel tribunale di vita o di morte? Il cuore esce dal petto scheletrito per il terrore, e io avevo paura, una paura tremenda e dicevo a me stessa: “Non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire!”. Avevo scelto da sola il modo di pormi davanti ai tre assassini: indifferenza. In quel momento avrei voluto buttarmi per terra per supplicarli: “Lasciatemi vivere, non ho fatto niente di male, ho quattordici anni, voglio vivere, voglio vivere, voglio vivere!”. Guai! Sarebbe stato il massimo della loro soddisfazione. Né avevo certo la forza di guardarli in faccia con sfida, perché loro erano assassini e io no. Indifferenza. Arrivavo lì così, come se avessi dovuto attraversare un semaforo. Era un semaforo rosso e, quando la prima volta passai alla selezione, mi ricordo, il medico mi fermò e mi mise un dito sulla pancia, là dove due anni prima avevo subito un intervento di appendicite. Il mio cuore si fermò e pensai: “Ecco, la cicatrice mi manda a morte”. Invece no, lui, tutto compiaciuto, la mostrava ai suoi colleghi assassini. Mi chiese anzi di dov’ero ed io risposi: “italiana”, con un fil di voce. Lui aggiunse: “Ma che strazio questo medico italiano, che brutta cicatrice ha fatto a una ragazza così giovane: le resterà per tutta la vita”. Io - disse - la faccio molto meglio, la faccio così sottile che poi, da donna adulta, quando è nuda non si vede più”. Poi mi fece cenno che potevo andare. Ah la felicità! Andai a rivestirmi, non mi importava niente di quello che avevo 33 appena visto, di quello che stava succedendo dietro le mie spalle, di quello che poteva essere già successo prima. Ero viva, viva, viva, lo racconto sempre e lo racconto anche oggi che fui vigliacca, fui orribile, fui spaventosa e ho avuto per tutta la vita il rimorso, ce l’ho sempre, ce l’avrò finché vivrò. Ero appena passata, infatti, quando fermarono, dietro di me, una ragazza francese con la quale lavoravo in fabbrica, sulla stessa macchina che le aveva tranciato due dita. Lei, poverina, aveva coperto la sua mano con uno straccio, ma era nuda e gli assassini lo videro subito. Io ero appena passata: sentii che la fermarono, ma non mi voltai, non le dissi: “Ti voglio bene, fatti coraggio!”, una frase qualunque. Non mi voltai. Ero viva. E lei andava a morte per la sola colpa di essere nata! E la voglio ricordare, anche oggi, così com’era, francese, ventidue, ventitré anni:; riccioli biondi che erano ricresciuti un centimetro o due, occhi celesti, sorridente, voce dolce, gentile: Janine, morta ad Auschwitz, per la sola colpa di esser nata. Ma io non mi sono voltata. Ero diventata prigioniera, dura come una lupa affamata, che voleva vivere e sopravvivere. Mentre ci allontanavamo da Auschwitz, vedevamo in lontananza fuochi, perché i nostri persecutori avevano deciso di non far trovare ai Russi in arrivo le vestigia dell’orrore spaventoso, che era stato il campo di sterminio, perché, ad Auschwitz, c’erano le strutture di morte che non si trovavano in tutti i campi. Fecero saltare gran parte di queste strutture, che, infatti, sono ridotte ormai già da tanti anni, a macerie. Non tutto, però, perché non fecero in tempo, in quanto i Russi arrivarono prima del previsto, come descrive molto bene Primo Levi ne La Tregua, che io spero abbiate letto o visto nella versione cinematografica di Rosi. Noi, invece, fummo avviate per la marcia della morte sulle strade della Germania, e descrivere la marcia della morte, di cui pochissimo si sa, proprio perché pochissimi sono i sopravvissuti, é difficile. Fu un viaggio incredibile in cui i prigionieri, scheletriti, non potevano cadere. È durata giorni, ma non saprei dire quanti. Ho visto poi, sulla carta geografica, dopo tanti anni, quale percorso in quelle condizioni, a piedi, d’inverno, avevamo fatto, ma non si poteva cadere, anche lì, io, non mi voltavo. Sapevo che chi cadeva veniva finito con un colpo di fucile alla nuca dalle guardie della scorta, e quello che mi ricordo di quella marcia sono i bordi della strada, la neve insanguinata e, ogni tanto, un morto senza tomba, rimasto lì per sempre, perché nessuno poteva cadere e fermarsi: non ci dovevano essere feriti o malati: solo morti su quella strada. Io mi ricordo di come il cervello comandava noi che stavamo ancora in piedi, comandava alle gambe di camminare: cammina, cammina, cammina. Nessuno poteva appoggiarsi a noi, e noi non ci potevamo appoggiare a nessuno, perché era così faticoso andare avanti. Mi ricordo inoltre i letamai, gli immondezzai, i grandi immondezzai, saranno stati normali immondezzai, ma io me li ricordo grandissimi, nelle cittadine, nei paesi che attraversavamo, soprattutto di notte, con le case 34 Li l i a n a Se g r e Dopo un anno che “ero in campo”, senza sapere nulla di quello che stava succedendo, ecco che di colpo cominciammo a sentire i rumori della guerra che si avvicinava. In realtà, era il fronte dell’Est, erano i Russi, che avevano rotto le linee tedesche e che arrivavano più in fretta, di quanto i nazisti non immaginassero ad Auschwitz. Ecco che allora, di colpo, un giorno che eravamo in fabbrica arrivò l’ordine di evacuazione. Uscimmo così in fila, avviate sulle strade della Germania, per compiere quella marcia, giustamente chiamata “marcia della morte”, perché pochissimi giunsero a destinazione. Li l i a n a Se g r e chiuse, le porte e le finestre sprangate. Non c’erano civili che ci offrissero un bicchiere d’acqua, un pezzo di pane e noi, come piranha, ci buttavamo sugli immondezzai, per mangiare qualunque schifezza: torsoli di cavoli marci, ossi già spolpati, bucce crude di patate sporche di terra. Ci guardavamo una con l’altra. Eravamo orribili, eravamo donne-scheletro, con le bocche sporche, disposte a tutto per arrivare prima di un’altra al torsolo di cavolo. Era un modo per tacitare lo stomaco, anche se, il giorno dopo, vomito e diarrea sarebbero stati assicurati. Ma lo stomaco si doveva riempire, perché il cervello potesse comandare alle gambe di camminare. Cammina, cammina, cammina. Ci furono altri campi, ci fu Ravensbruck, terribile campo femminile, con molte donne politiche italiane, morte lì, poi ci fu un sottocampo che si chiamava Jugend-Lager, il campo della gio ventù, in cui i giovani morivano per la sola colpa di essere nati, e poi l’ultimo campo nel nord della Germania: si chiamava Machow, dove io mi trovavo nella primavera del 1945. Era un piccolo campo di cui si vedevano i confini. Eravamo ormai ridotte veramente a dei fantasmi di quelle che eravamo state, ed ero con due ragazze: Luciana e Laura Sacerdote, due sorelle di Genova con le quali ero partita da Milano. Una è ancora viva, abita a Genova e, ogni tanto, ci incontriamo e andiamo insieme al ristorante. Non abbiamo bisogno di parlare del passato, parliamo solo dei nostri nipoti, dei nostri figli. Il passato siamo noi! Sua sorella Laura, invece, che aveva il n° 75191, quindi quello dopo il mio, è morta, subito dopo la Liberazione, di stenti. Eravamo con ragazze francesi e greche; ormai era un mondo, un universo femminile di tutte le nazionalità, ridotte a larve. Non lavoravamo più, perché lì non si lavorava, ma, in compenso, vedevamo com’era fuori dal campo: non era come ad Auschwitz e Birkenau che, finito un Lager, ne cominciava un altro e, a perdita d’occhio, c’erano baracche, fili spinati, sentinelle, torrette. No, al di là del filo spinato, c’erano i prati diventati verdi, c’erano gli alberi, quel miracolo della primavera a cui nessuno fa caso. Avevamo vissuto per un anno in un’atmosfera grigia, senza erba, ad Auschwitz: non ci poteva essere, perché tutti i piedi la schiacciavano e, se ci fosse stato un filo d’erba, l’avremmo mangiato. Al di là del campo, vedevamo questo miracolo ripetersi: l’aria era tiepida, si scorgevano foglie di un verde straordinario, e noi pensavamo: “Uhm, potessimo mangiare una di quelle foglie, sarà buona, avrà un sapore di clorofilla!”. Eravamo talmente scheletriche, che non sentivamo quasi più la fame, non sentivamo più le botte, non sentivamo quasi più niente, ma quelle pochissime, tra cui io, che potevano ancora stare in piedi, ebbero la fortuna straordinaria, nelle prime ore di un pomeriggio, di uscire dietro la baracca. Vedemmo passare in fondo al campo dei gruppi di giovani prigionieri che tornavano dal lavoro nei campi: erano dei ragazzi francesi prigionieri di guerra, i quali, lo racconto sempre, scorgendo le figure che eravamo noi, senza sesso e senza età, incuriositi, cominciarono a chiedere: Qui êtes vous?! (Chi siete?). E noi in coro, perché nessuna aveva più la voce così forte per farsi sentire almeno a venti metri di distanza: “Siamo ragazze ebree”. “Ragazze! Ragazze! Ma quanti anni avete?”. Rispondevamo: “Quindici, venti, venticinque”. Non ci potevano credere, perché sembravamo vecchie e malate, giallognole, senza età, vestite di stracci. Questi ebbero pietà di noi e fu un’impressione splendida sentire, dopo tanto odio, che c’era stato e c’era ancora intorno a noi, odio tale da ridurre milioni di persone in quelle condizioni, che altre persone avevano pietà. Era una rugiada celeste, un’impressione antica, dimenticata, un sentimento di cui non pensavamo più che qualcuno avesse la fortuna di esserne dotato. Loro ebbero pietà e ci dissero: “Poverine, poverine, coraggio, non morite, la guerra sta per finire, i nostri a-guzzini la stanno perdendo, stanno arrivando i Russi da una parte e gli Americani dall’altra”. Era troppo, era una gioia quasi insopportabile! A noi, abituate ad ogni genere di lutti, alla perdita di tutto, ad essere ridotte come eravamo ridotte, e ormai capaci di sopporta- 35 re tutto, mancava la morte che sarebbe giunta poco dopo, se la guerra non fosse finita. Alla gioia però non eravamo preparate. Avevamo veramente, io me lo ricordo, male al cuore, la sensazione di non farcela a sopportare, ma, nello stesso tempo, era fantastico rientrare nelle baracche e riferire le parole dei prigionieri incontrati a quelle che non si alzavano più: “Ci hanno detto di non morire, che la guerra sta per terminare”. Avevano ragione, era così. Tutti i giorni passavano e ci ragguagliavano sulla situazione: i Russi sono a venti km, gli Americani a trenta, poi a dieci, poi a cinque, e che cosa succederà di Jioi? Ci ammazzeranno tutti, i nostri aguzzini, faranno come ad Auschwitz, dove hanno ucciso tutti quelli che potevano. Non fecero in tempo e, con un nervosismo di cui improvvisamente ci rendevamo conto, terrorizzate, naturalmente, nel vederlo, i tedeschi incominciarono a portare via scrivanie, carte, dossier, tutto quello che volevano nascondere. In quegli ultimissimi giorni di a-prile comandarono di evacuare il campo e fu aperto quel cancello che avevamo sognato di vedere aperto, perché, quando uno non sa che cosa vuoi dire essere prigioniero, non può neppure immaginare che cosa significhi una porta che si apre ed essere libero di camminare su una strada. Li vedevamo fuggire, si mescolavano a noi, caricavano tutti i loro averi, la roba, il maiale, portavano via le valigie, lasciavano le case. Le nostre guardie, che avevano terrorizzato non solo noi donne-nulla, donne schiave, donne prigioniere, ma tutti gli eserciti d’Europa, si mettevano in borghese. Le nostre guardie vicino a noi, si mettevano in borghese: era una visione incredibile. Mandavano via i cani che, poveretti, non sapevano dove andare e tornavano, e loro rimandavano via ancora questi animali, sperduti nella campagna che nessuno voleva più: era il simbolo delle SS, il cane. Si spogliavano, si mettevano in mutande, avevano sacche, cartelle, buttavano via le divise, le armi, si vestivano in borghese, si mescolavano ai civili, si mescolavano a noi, e noi li guardavamo esterrefatti. Le guardie, le nostre guardie si mettono in mutande! Era una visione incredibile, inimmaginabile, che nessuno, in quelle notti del Lager, aveva mai sperato di vedere. Beh, io concludo sempre così la mia testimonianza. Passava vicino a me, mi sfiorava, mi toccava, non perché volesse volontariamente sfiorarmi o toccarmi, ma proprio perché ero un nulla vicino a lui, il comandante di quell’ultimo campo, di cui non ricordo neppure il nome. SS spietato con le donne inermi, elegante, nella sua divisa, vicino a me, era lì, e si metteva anche lui nudo o quasi, e si rivestiva di abiti civili. Io lo guardavo esterrefatta, perché era a due centimetri da me. Li avevo odiati, li avevo odiati con tutte le mie forze. Mi avevano portato via tutto, e li avevo odiati in un modo così forte che, in un certo senso, questo sentimento mi aveva quasi tenuto in vita. E lui si rivestiva, tornava a casa sua, dalla sua famiglia, tornava ad essere quello di prima, un bancario, un postino, un maestro di scuola, un contadino, non so chi. Quando buttò la sua pistola praticamente ai miei piedi, ebbi una tentazione foltissima, la tenta- 36 Li l i a n a Se g r e Noi non eravamo ancora libere, eravamo prigioniere, sorvegliate dalle guardie e dai cani, ma sentivamo che erano le ultime ore. E fu così, perché su quella strada tedesca, fummo testimoni del mondo che cambiava. La storia mutava corso davanti a noi. Vedevamo improvvisamente aprirsi le case dei tedeschi che uscivano, fuggivano, volevano recarsi nella zona americana. Ho capito dopo il motivo, naturalmente, perché lì stavano arrivando i Russi di cui avevano molta paura. zione più forte che abbia mai avvertito nella mia vita e pensai: “Adesso raccolgo quella pistola e gli sparo”, perché mi sembrava proprio il giusto finale di quando avevo lasciato per sempre la mano del mio papa, ero rimasta sola, ero diventata il numero 75190. Li l i a n a Se g r e Sarebbe stata la legittima conclusione della tragedia che avevo vissuto, credetemi, fino in quel momento, ma fu un attimo in cui capii, fino in fondo, che io non avrei mai potuto uccidere, per nessun motivo, nessuno, in nessun momento della mia vita, e che io avevo sempre scelto la vita, e la vita non va d’accordo con l’odio. Bisogna decidere: o odio, sinonimo di morte, o vita. Non ho raccolto quella pistola, perché ho scelto la vita, e, da quel momento, sono stata libera. 37 Il testimone e il luogo nella didattica della shoah Da numerosi anni gli istituti storici della resistenza si occupano della trasmissione della memoria, non soltanto o non più quella legata alla Resistenza, ma anche quella della shoah, questo è avvenuto soprattutto a causa delle numerose sollecitazioni che sono pervenute in occasione dell’istituzione della giornata della memoria, avvenuta nel 2001. Al e s s a n d r o Ch i a p p a n o Per quel che concerne la didattica della shoah, vorrei soffermarmi su uno dei temi che più mi stanno a cuore, riprendendo anche alcune delle suggestioni di chi mi ha preceduto, ossia l’uso del testimone e la visita ai luoghi della memoria. In via del tutto preliminare va ricordato che la storia della shoah, della deportazione va collocata all’interno del curriculum di storia contemporanea, che fa parte dei programmi della scuola superiore fin dal 1960. In realtà, le disposizioni ministeriali rimasero largamente disattese, come attesta un recente studio sull’insegnamento della storia contemporanea in Europa; nel capitolo dedicato all’Italia si nota come nel nostro paese si sia sempre registrata una difficoltà da parte degli insegnanti ad affrontare la contemporaneità: occorreva affrontare il nodo della “guerra civile”, della divisione dell’Italia e questo era estremamente difficile in classi dove coesistevano memorie così diverse e divise(1). Come afferma Marco Silvani: “Di fronte a queste difficoltà e all’imbarazzo creato dalla presenza di queste divisioni nella società, gli insegnanti hanno scelto la strategia del silenzio, o quella dell’ interpretazione del fascismo come di qualcosa di avulso dalla storia d’Italia”(2) . È stato soltanto con il decreto Berlinguer, del 1996, che i docenti di storia hanno dovuto confrontarsi con la storia contemporanea e procedere ad una riflessione di più ampio respiro sulla didattica della storia. Questo ha comportato l’acquisizione di una serie di strategie innovative: la didattica per progetti applicata anche alla storia e soprattutto il laboratorio di storia (3). È in questo preciso contesto che, a partire soprattutto dalla fine degli anni Novanta, inizia a concretizzarsi l’attenzione sulle leggi razziali, sui rapporti tra il fascismo e la deportazione, sulla storia dei campi di concentramento e di sterminio(4): le scuole, gli insegnanti, gli studenti diventano i principali attori di un processo di innovazione profondo, che porta allo sviluppo di una miriade di progetti che spesso nascono in concomitanza con la sistemazione degli archivi scolastici(5) e si concludono con i viaggi nei luoghi della memoria. 1) Si veda a questo proposito l’indagine curata da Alessandro Cavalli, Insegnare la storia contemporanea in Europa, il Mulino, Bologna 2005. 2) Cfr. Marco Silvani, L’insegnamento della storia contemporanea nelle scuole italiane: problemi e riflessioni, in Insegnare la storia contemporanea in Europa, a cura di Alessandro Cavalli, il Mulino, Bologna 2005, p. 187. 3) Cfr. Aurora Delmonaco, Dove si costruisce la memoria. Il laboratorio di storia, in Dalla memoria al progetto. Seminario di formazione per docenti, Quaderno n. 5 del M.P.I., Direzione classica, Latina, Liceo Scientifico “E. Majorana”-, 1994 ; Giuseppe Deiana, Io penso che la storia ti piace. Proposte per la didattica della storia nella scuola che si rinnova, Unicopli, Milano 1997; Aa. Vv, Insegnare il Novecento, Sezione de “I viaggi di Erodoto”, gennaio - aprile 1997, n. 31 (pp. 33-67); Aa. Vv., Per la storia contemporanea nella scuola. Curricolo di storia e riordino dei cicli. Inserto di «Italia contemporanea», giugno 2000, n. 219 (pp. 315-328). 4) Per un’ analisi dettagliata su questa esperienza si veda Insegnare Auschwitz a cura di Enzo Traverso, IRRSAE PiemonteBollati Boringhieri, Torino 1995 e in particolare il saggio di Federico Cereja e Brunello Mantelli, Le ricerche sulla deportazione e sulla Resistenza promosse dal Consiglio Regionale e dalle province piemontesi nell’ambito del concorso regionale “Visite di studio ai campi di sterminio”, pp. 139-141. 5) Cfr. in particolare I licei G. Berchet e G. Carducci durante il fascismo e la Resistenza a cura di Davide Bonetti, Giorgia De Maio, Mariagrazia Zanaboni, Milano 1996 e in particolare L’espulsione degli studenti ebrei dal Liceo Carducci, pp. 121-135; cfr. anche Una storia nella Storia. Il Virgilio 1934-1946. Ricerca di studenti e insegnanti su documenti inediti, Milano, Principato 2001; Maria Teresa Sega, La scuola fa la storia. Gli archivi scolastici per la ricerca e la didattica, Ediclo Editore, Portogruaro, 2002; Maria Luisa Perna, (a cura di), Tra vecchie carte… Esperienze didattiche negli archivi di scuole torinesi, Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea, Torino 2002. 39 Dalla fine degli anni Novanta e in misura ancora più rilevante a partire dal 2001, con l’entrata in vigore della legge istitutiva della Giornata della memoria, le attività legate al tema della shoah e della deportazione sono cresciute in maniera esponenziale e questo è sicuramente un bene, ma esiste, ed è sempre più concreto, il rischio che si parli di queste tematiche soltanto nell’ambito circoscritto di alcune specifiche giornate, come se si trattasse di una sorta di liturgia. (8) A mio avviso, per evitare che negli studenti si ingeneri una sorta di assuefazione, che inevitabilmente conduce alla banalizzazione, tali temi andrebbero affrontati all’interno di un percorso organico complessivo, in questo modo si eviterebbe di parlare degli ebrei soltanto come vittime, soltanto in connessione con la tragedia rappresentata dalla shoah, trascurando così l’importante contributo che hanno dato alla storia europea. Occorre poi tenere presente che, anche quando sia affronta la storia degli ebrei, in genere ci si sofferma sulle vicende degli ebrei occidentali e si finisce di ignorare del tutto la millenaria storia degli ebrei che vivevano nei paesi dell’Europa orientale, una storia di enorme ricchezza culturale, che traspare dai libri di Isaac B. Singer (9) : questo è forse l’aspetto più drammatico della shoah: la completa distruzione dell’ebraismo orientale, di cui oggi non resta praticamente nulla. Non sarebbe peregrino per affrontare la shoah in modo originale avvicinare gli studenti all’ebraismo orientale(10), tenendo conto anche del fatto che il numero più alto delle vittime riguarda proprio gli ebrei orientali. 6) Cfr. Aa. Vv., Storia vissuta, Consiglio Regionale del Piemonte-ANED-Franco Angeli, Milano 1988, in particolare Anna Maria Ariotti, Ricerche scolastiche e storia della deportazione: la preparazione delle ricerche, pp. 70-76. 7) Cfr. Insegnare Auschwitz, a cura di Enzo Traverso, IRRSAE Piemonte-Bollati Boringhieri, Torino 1995 e in particolare il saggio di Federico Cereja e Brunello Mantelli, Le ricerche sulla deportazione e la Resistenza promosse dal Consiglio Regionale e dalle province piemontesi nell’ambito del concorso regionale”Visite di studio ai campi di sterminio”, pp. 139-141. 8) Cfr. Anna Rossi-Doria, Invocazioni della memoria e ragione della storia: a proposito del “Giorno della memoria” in Aa. Vv, Roma 1944-1945: una stagione di speranze. L’Annale Irsifar, Franco Angeli, Milano 2005 e ancora Enzo Traverso, Le memorie di Auschwitz. Commemorazioni e uso pubblico della storia in Aa. Vv. Roma tra fascismo e liberazione. L’Annale Irsifar, Franco Angeli, Milano 2006, pp. 95-105. 9) Cfr. ad esempio Isaac B. Singer, La famiglia Moskat, TEA, Milano 1997. 10) Non mancano diari e testimonianze, scritte tra l’altro da adolescenti, pubblicate anche in italiano: cfr David Rubinowicz, Il Diario, Einaudi, Torino 1960, Mary Berg, Il ghetto di Varsavia, Einaudi, Torino 1991. Per una riflessione sulla storia della shoah nei territori orientali vedi Omer Bartov, L’Europa orientale come luogo del genocidio, in Aa. Vv, Storia della shoah, vol. II, La distruzione degli ebrei, UTET, Torino 2006, pp. 418-460 e ancora Christian Gerlach, L’Olocausto sul fronte orientale e il suo consenso, pp. 560-590. 40 Al e s s a n d r o Ch i a p p a n o Tuttavia, rispetto ai viaggi nei luoghi della memoria, vanno ricordate le esperienze che sono state fatte, a partire dagli anni Ottanta e per tutto il decennio successivo, grazie al coinvolgimento della Regione Piemonte, in collaborazione con l’ANED e il Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana.(6) Tali enti hanno promosso visite di studio nei campi di nazisti. L’iniziativa era diretta agli studenti delle scuole superiori: a studenti e insegnanti venivano proposte tracce su cui produrre elaborati o ricerche, i testi migliori erano premiati con un viaggio di studio, in genere la meta e a Mauthausen. Si è trattato di un’iniziativa che è stata estremamente lodevole e che ha visto il coinvolgimento di migliaia di studenti e di moltissimi docenti. Se si scorrono i dati quantitativi, raccolti nel volume curato da Enzo Traverso, Insegnare Auschwitz, che costituisce una pietra miliare nel quadro della riflessione didattica sulla deportazione e sulla shoah, si nota che il numero maggiore di studenti coinvolto proveniva dalle province e l’indirizzo di scuola più largamente presente era rappresentato dai licei, soprattutto scientifici, subito seguiti dagli istituti magistrali. Gli insegnanti coinvolti sono stati più di ottanta e i temi proposti si sono concentrati soprattutto sulle tematiche della deportazione in senso lato (quella politica e razziale, non mancarono però i riferimenti anche all’internamento militare) e a seguire della Resistenza. Nei primi anni la traccia era unica poi si passò a due e infine nel 1985 a quattro(7). Oggi quando si affronta la shoah si fa generalmente ricorso al testimone, soprattutto nei casi dove questo è possibile. Ma si tratta di un fenomeno che si è sviluppato nel corso del tempo: alla fine della guerra in realtà l’atteggiamento prevalente era il silenzio: infatti i sopravvissuti dei campi, fossero politici o ebrei, avevano da una parte il timore di non essere creduti (sogno ricorrente in campo anche di Primo Levi) dall’altra in generale la gente, come anche i familiari più stretti, non erano inclini ad ascoltare storie tanto tragiche: erano gli anni della ricostruzione e tutti volevano rincominciare vivere, lasciandosi alle spalle la guerra e le sue tragedie. Al e s s a n d r o Ch i a p p a n o Così negli anni Cinquanta assistiamo ad un vuoto di memoria.(11) I temi della deportazione, così come della shoah, dei campi, restano nell’ombra. Più forte è la memoria delle vicende partigiane. Il processo Eichmann, nel 1961, rompe il silenzio. Tale processo, celebrato a Gerusalemmme, e seguito dalla stampa internazionale(12), era stato ideato dal procuratore generale Gideon Hausner come una lezione di storia sulla shoah, capace di trasmettere valori forti alle nuove generazioni, non solo di Israele, ma del mondo intiero. Così il processo fu organizzato non tanto e non solo sui documenti probatori, come si fece a Norimberga, ma sui testimoni. Hausner decise di ascoltare quei testimoni che avevano già consegnato le loro memorie a Yad Vashem, l’istituto storico nato nel 1954. Sfilarono così nelle aule del tribunale 111 testimoni che raccontarono la shoah. Alcune delle loro testimonianze non erano strettamente collegate ad Eichmann e alla sua attività criminale, ma la loro deposizione contribuì a tracciare i confini della lezione di storia che il procuratore voleva impartire soprattutto alle generazioni che erano nate dopo la catastrofe. Come afferma Annette Wieviorka: “Il processo Eichmann ha liberato la parola ai testimoni, creando così una domanda sociale di testimonianze” e ancora: “Con il processo Eichmann, comunque, il sopravvissuto acquisisce un’identità sociale di sopravvissuto, che gli viene riconosciuta dalla società stessa. […] Al sopravvissuto viene attribuita una nuova funzione: il testimone è portatore di storia. In tal modo l’avvento del testimone trasforma profondamente le condizioni stesse della scrittura della storia del genocidio” (13). A partire dal 1961, sia il dibattito storiografico, sia quello civile sui temi della deportazione e della shoah conobbero un nuovo slancio: fu pubblicata la fondamentale opera di Raoul Hilberg La distruzione degli ebrei d’Europa(14), notevolmente accresciuta in una seconda edizione nel 1985 e alla fine degli anni Sessanta si celebrarono importanti processi in Germania contro i carnefici. Godettero anche di un notevole successo di pubblico le testimonianze letterarie sulla shoah: diventano dei classici, anche nelle scuole, i testi di Levi(15), di Amery(16), di Anne Frank. Durante gli anni della contestazione giovanile, soprattutto in Germania, è vivace i dibattito fra la generazione dei figli e quella dei padri, a cui si chiede conto delle atrocità del nazismo, nasce così un dibattito storiografico molto intenso; non altrettanto avverrà in Italia, dove continua a prevalere il mito del buon italiano. 11) Cfr. su questo il prezioso volume di, Anna Rossi-Doria, Memoria e storia: il caso della deportazione, Rubettino, Catanzaro 1998. 12) Cfr. il celebre saggio di Hannah Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano 1997. 13) Annette Wieviorka, L’era del testimone, Raffaello Cortina Editore, Milano 1999, p. 101 e 102. 14) Raoul Hilberg, La distruzione degli ebrei d’Europa, 2 voll. Einaudi, Torino 1985. 15) Specialmente Se questo è un uomo e La tregua, entrambi pubblicati da Einaudi anche in edizione scolastica. 16) Jean Améry, Intellettuale ad Auschwitz, Bollati Boringhieri, Torino 1987. 41 Alla fine degli anni Settanta, lo straordinario successo negli USA come in Europa, dello sceneggiato televisivo Holocaust segnò un intereresse crescente per la shoah anche se non mancò una dura presa di posizione dei testimoni che fecero dichiarazioni molto pesanti sulla banalizzazione e trivializazione della shoah presentata dallo sceneggiato(17), tratto da un libro di Gerald Green. A partire da questo momento cominciarono anche ad essere raccolte le testimonianze audiovisive, e il genocidio degli ebrei diventò un argomento al centro del dibattito storico e politico in molti paesi. Alla fine degli anni Novanta il film di Spielberg Schindler’s list registrò un enorme successo e ebbe inizio anche il grandioso progetto voluto dal regista di raccogliere le testimonianze di tutti i sopravvissuti della shoah. Non si trattava solo del desiderio di raccogliere tali testimonianze per creare un immenso archivio, ma anche perché si riconosceva alla testimonianza un importantissimo valore educativo e didattico. Infatti come ha scritto Geoffrey Hartman «l’immediatezza dei racconti in prima persona ha l’effetto del fuoco in quella gelida stanza che è la storia». Da questo momento in poi il ricorso alla testimonianza è diventato un elemento fondamentale nell’ambito della didattica della shoah e sicuramente l’incontro con il testimone è fondamentale(18), ma occorre tenere presente che esso rimane su un piano strettamente emotivo. Per questo credo che sia utilissimo, soltanto là dove esso si prefiguri come l’ elemento di un mosaico molto più ampio, il segmento di una lezione di più vaste proporzioni: se si ci affida soltanto al testimone o ad un film, o alla visita ad un luogo, si finisce per depauperare enormemente l’insegnamento della shoah, che significa, in primo luogo, cercare di comprendere i meccanismi che hanno reso possibile il nazismo, soffermandosi sulle tre tipologie umane individuate dallo storico Raoul Hilberg(19): vittime, carnefici, spettatori. Questo significa affrontare temi di grande complessità, che richiedono il ricorso ad una pluralità di strumenti e di discipline. Ogni testimone racconta la propria esperienza partendo dalla soggettività, e in questo senso ogni testimonianza è unica ed irripetibile, può essere paradigmatica, ma non può costituire l’unico elemento di cui si compone l’insegnamento di una vicenda così complessa come quella concentrazionaria. Quando parliamo di lager occorre tenere presente che alla fine della guerra avevano raggiunto il numero spaventoso di 1620, ma naturalmente si trattava di campi che afferivano a categorie differenti: c’erano elementi contigui, ma anche rilevanti diffe17) Cfr a questo proposito le dichiarazioni di Elie Wiesel, autore di La Notte sulla sua esperienza ad Auschwitz. 18) Cfr. Brunello Mantelli, Il testimone, lo studioso, l’insegnante, lo studente: per la trasformazione dei monologhi in un dialogo in Aa. Vv, Storia vissuta, Consiglio Regionale del Piemonte-ANED- Franco Angeli, Milano 1988, pp. 229-237. 19) Raoul Hilberg, Carnefici, vittime, spettatori. La persecuzione degli ebrei 1933-1945, Mondadori, Milano 1994. 42 Al e s s a n d r o Ch i a p p a n o Così anche in Italia, mentre fino a questa data era stato dato più spazio alla deportazione politica, si assiste ad un rovesciamento: quest’ultima viene lasciata sempre più nell’ombra, mentre l’attenzione si concentra su quella razziale. Questo aspetto è evidente anche rispetto agli studi scientifici: mentre sulle deportazioni razziali dall’Italia si è fatta piena luce, grazie agli studi di Liliana Picciotto, la storia completa della deportazione politica deve essere ancora scritta e un gruppo di lavoro dell’università di Torino, coordinato dai professori Mantelli e Tranfaglia, in parte finanziato dall’ANED, completerà le sue ricerche in merito solo alla fine dell’anno prossimo, dopo più di sessant’anni. renze: capire la deportazione, la shoah, i genocidi vuol dire anche saper distinguere, vuol dire comprendere che cos’era Auschwitz, che cos’era Mathausen. Affrontare la storia dei campi significa comprendere la società concentazionaria, le sue gerarchie, le sue stratificazioni, le sue leggi non scritte. Certo, l’incontro con un testimone crea un’empatia enorme, è come se gli studenti potessero toccare la storia, ma da qui bisogna partire per intraprendere un cammino di conoscenza capace di incidere nella vita degli studenti, altrimenti l’emozione passa e non resta nulla: soprattutto oggi, in un mondo in cui siamo continuamente sottoposti a sollecitazioni, a emozioni anche forti, ma effimere. Al e s s a n d r o Ch i a p p a n o In qualche modo il ragionamento sui luoghi è analogo: Thomas Lutz, il direttore della Fondazione La topografia del terrore afferma che i luoghi sono testimoni di pietra che possono parlare, ma occorre saperli interrogare con intelligenza: anche la visita ai luoghi di memoria va dunque preparata con cura, soprattutto va inserita in un percorso organico che non si esaurisca nella visita stessa. Educare ad un luogo di memoria significa, soprattutto, insegnare a leggere il luogo e comprendere anche le sovrapposizioni che la storia, con il suo passare, vi ha impresso. Significa capire i meccanismi che regolano l’uso pubblico che si fa della memoria di un luogo. Occorre che gli studenti sappiano che oggi Dachau, Buchenwald, Auschwitz non sono quello che erano ai tempi dei signori della guerra, che anche i monumenti commemorativi o i musei, hanno finito per snaturare i lager rispetto a quello che erano. È necessario essere avvertiti che per entrare in sintonia con i luoghi della memoria bisogna tenere presenti questi aspetti e cercare di ricostruire quel luogo nella propria mente, come era allora. La chiave di lettura potrebbe essere sentire il luogo, immergersi in esso ed accoglierlo in sè(20) e se questo può essere un percorso individuale (che insegnante e studente compiono per loro conto), occorrerà poi trasformarlo in una esperienza collettiva e condivisa, affinché assuma una rilevanza didattica e formativa. Educare ai luoghi di memoria significa, in ultima analisi, avere la consapevolezza, - contro ogni tentativo di cancellazione della memoria, come dei suoi luoghi - dell’importanza che certe località hanno per tutti gli uomini, a patto che si riconoscano in certi valori fondamentali. Sulla moltiplicazione dei viaggi della memoria, ha scritto pagine estremamente incisive Annette Wieviorka, in suo recentissimo libro Auschwitz, 60 ans aprè(21) in cui si interroga sulla ricaduta didattica che i viaggi della memoria possano avere su studenti così lontani da quel passato. Infatti se si pensa ad Auschwitz si deve sapere che allora era una immensa struttura concentrazionaria e che ora il campo è del tutto diverso, perché Auschwitz I è un museo, e i blocchi in cui erano alloggiati i prigionieri oggi ospitano una mostra commemorativa, mentre Birkenau, oggi appare ai nostri occhi come una landa desolata, un immenso spazio quasi vuoto e non è facile immaginarsi come poteva essere, con le sue trecento baracche e le strutture di messa a morte, ora quasi del tutto distrutte, ed è soltanto grazie ad una visita che necessita di tempi non affannosi che si può penetrare ed immergersi nel luogo, capire la struttura dello sterminio anche se oggi non restano che rovine. 20) Un percorso della memoria , a cura di Tristano Matta, Electa, Milano 1996, p. 150. 21) Cfr. Annette Wieviorka, Auschwitz, 60 ans après, Robert Laffont, Paris 2005. 43 Va dunque evitata, a mio avviso, l’estrema semplificazione a cui ricorrono tanti Consigli regionali in Francia che imbarcano intere classi sull’aereo per Cracovia, visita ad Auschwitz e ritorno alla sera stessa, in questo modo si pensa erroneamente di combattere l’antisemitismo strisciante in classi in cui la presenza di studenti di origine araba rende difficile insegnare la shoah. Non può essere questo il sistema: la visita ad Auschwitz non può diventare come un film tragico che scorre di fronte ai nostri occhi, va collocata all’interno di un percorso di lunga durata, altrimenti quello che è poi lo scopo del nostro essere educatori si smarrisce completamente finendo per creare un vuoto di memoria. Ma la sfida è oggi enorme: se vogliamo costruire una cittadinanza europea dobbiamo fare in modo che i giovani diventino consapevoli che una identità non è necessariamente migliore di un’altra e che quella francese può coabitare con quella magrebina a patto che non si pensi che una sia necessariamente migliore dell’altra. 44 Al e s s a n d r o Ch i a p p a n o La riflessione sulla shoah, su Auschwitz, sulla negazione dei diritti può essere un punto di partenza proprio per insegnare ai giovani che è possibile acquisire una cittadinanza europea, che accanto alle differenze, tenga conto delle affinità. Innanzi tutto, la Shoah deve essere contestualizzata all’interno di un più ampio quadro della storia del ‘900. Secondo me, l’obiettivo didattico principale deve essere quello di far capire ai nostri studenti qual è la specificità della Shoah: pertanto, dobbiamo avventurarci su quel versante molto problematico che è la storia comparativa. Operazione numero 1: quando e dove, come e perché nascono i campi di concentramento? I lager nascono nelle colonie, alla fine del XIX secolo. Nascono a Cuba, nelle Filippine, in SudAfrica ... tutte le volte i cui gli eserciti coloniali, malgrado la loro formidabile potenza (a quell’epoca, quelli europei e quello statunitense sono gli eserciti più forti del mondo), non riescono a controllare il territorio. Il nemico è imprendibile e invisibile, perché fa uso della guerriglia e gode del sostegno della popolazione civile. Fr a n c e s c o Ma r i a Fe l t r i Allora, l’esercito incaricato di riportare l’ordine fa ricorso a queste gigantesche, per l’epoca, nuovissime, strutture di repressione. I campi infatti sono strutture che consentono di internare intere popolazioni: tutti i civili sospettati o accusati di sostenere i ribelli guerriglieri. Il secondo passaggio del nostro discorso ci porta in Russia. Nel 1918, nella zona di Tambov, scoppia una rivolta di contadini. L’Armata Rossa si ricorda di quello che gli inglesi hanno fatto nei confronti dei boeri in Sudafrica: questo episodio, infatti, di quelli che ho citato prima era all’epoca il più noto e il più importante. In pratica, a Tambov si ripete, pari pari, un’esperienza di tipo militare che era nata come crimine di guerra in contesto coloniale. Per la prima volta, però, il lager viene trasportato in Europa. Il contesto è ancora militare. Ma, attenzione, il campo è usato ora in contesto di guerra civile, il che vuol dire che la persona imprigionata nel lager, adesso, è un cittadino dello stesso governo che ha istituito il campo. Non è più un boero (Sud Africa), non è più un Herero della Namibia, che i tedeschi mettono in lager negli anni 19041905 (ricordo, tra l’altro, che il termine lager si impone proprio a seguito dell’esperimento tedesco in Namibia). Al contrario, siamo di fronte a una evoluzione graduale, per cui il soggetto che il governo mette in lager è cittadino dello stesso stato: dell’autorità che ha istituito e gestisce il sistema. Oltre tutto, mentre la stampa inglese (cito solo questa, per comodità) poteva criticare sul “Times” i campi di concentramento contro i boeri, gridando che era una barbarie, nella Russia del 1918 la stampa è imbavagliata. Siamo di fronte a un regime totalitario. Per cui, ultimo stadio, il lager può tranquillamente passare da crimine di guerra a struttura di repressione politica: a campo di concentramento per oppositori politici. Il primo lager sovietico con finalità politiche nasce nel 1923, nelle isole Solovki. Siamo nell’estremo nord della Russia: è il primo campo a destinazione speciale. E’ un antico monastero, costruito nel XVI secolo: il più importante e prestigioso monastero di tutta la Russia. Esaminando il campo delle Solovki, nel Mar Bianco, ci accorgiamo che ci sono già tutte le strutture a cui siamo abituati: il comando del campo, la prigione del campo (per capirci, l’equivalente del Blocco 11 di Auschwitz) e la quarantena. Il lager è già nato, è già perfetto, è già maturo. Dobbiamo renderci conto che il parallelo tra sistema sovietico e sistema tedesco in un primo tempo funziona, è doveroso, è legittimo. A un certo punto, la biforcazione diventerà tale che non ci soddisfa più sotto il profilo storico e storiografico. Ma il giudizio morale è uguale, il giudizio politico identico. Il problema della distinzione è storiografico (e in questo senso anche pedagogico: perché il primo compito dell’educazione deve riguardare la capacità di critica, 45 la capacità d’individuare che non siamo di fronte a una notte in cui tutto è grigio e scuro. Al contrario, siamo di fronte a una serie di fenomeni storici diversi). Allora, come docenti, l’operazione che vi chiedo è quella, innanzi tutto, di avere informazioni precise e di assumere atteggiamenti di rigore, sotto il profilo terminologico e sotto il profilo concettuale. Rigore terminologico: su questo non insisterò mai abbastanza. I gulag, ad esempio … i gulag non esistono. Esistono i lager sovietici ed esiste il GULag: sigla che vuol dire direzione centrale dei lager. GULag è una sigla: se la usiamo al plurale, commettiamo una grave imprecisione. Cominciamo da queste cose elementari, impariamo i termini corretti ... e smettiamo di dire che gli ebrei sono ammazzati nei campi di concentramento. Non è vero. Dachau è l’inizio di tutta la storia, per quello che riguarda la vicenda dei lager tedeschi. All’inizio Dachau e gli altri campi del ‘33-’34 sono per prigionieri politici. Sul piano comparativo, non c’è nessuna differenza rispetto alle Solovki. La svolta l’abbiamo nel 1938, ed è una svolta che c’è stata anche in Unione Sovietica. Il campo diventa una struttura con finalità produttive: non serve solo a rinchiudere l’oppositore politico, ma c’è un salto di qualità in direzione della produttività. Perché viene deciso di costruire il lager di Mauthausen proprio in quel luogo? Perché lì c’è una cava di granito: esattamente come i sovietici costruiscono i campi della Kolyma a casa del diavolo, nell’estremo nord-est della Siberia, perché lì c’è l’oro, e perché lì c’è l’uranio. Per lo stesso motivo, costruiscono i lager di Vorkuta nell’estremo nord della Siberia centrale, perché lì c’è il carbone. Quindi, il principio di base è che il lavoro dei detenuti serve: nel caso sovietico, è parte integrante del progetto d’industrializzazione pensato da Stalin; nel caso nazista, serve per estrarre granito o comunque trarre un beneficio economico, che andrà nelle casse delle SS di Himmler o delle industrie di Göring. Ma le cose cambiano radicalmente quando, dal discorso dei campi di concentramento, ci spostiamo alla Shoah propriamente detta. La Shoah inizia in modo oscuro e poco lineare, su cui gli storici discutono. Tuttavia, i primi massacri organizzati avvengono già nel giugno del 1941, con l’invasione dell’Unione Sovietica. La Shoah incomincia con le Einsatzgruppen, con questi reparti speciali di SS o di poliziotti, che uccidono con il colpo alla nuca. Sono numeri da capogiro, che spesso sui libri di testo vengono completamente tralasciati. Stiamo parlando (come minimo) di 2 milioni di ebrei sovietici. La maggioranza degli ebrei sovietici, per non dire la totalità, vengono uccisi con un colpo di arma da fuoco, a 2 passi da casa loro: non vedono neanche un lager, non sanno neanche cosa sia un lager. 46 Fr a n c e s c o Ma r i a Fe l t r i Sono ammazzati dalle Einsatzgruppen (2 milioni), sono ammazzati nei centri di sterminio (2 milioni e mezzo) oppure nelle camere a gas di Auschwitz-Birkenau (800 000). Questi sono numeri approssimativi, sono puri ordini di grandezza. Resta che nei campi di concentramento (nel senso più stretto del termine) ne muoiono poche centinaia di migliaia: su un totale di 6 milioni di individui assassinati, è un’infima minoranza. I campi di concentramento sono per i politici, sono per gli omosessuali, per gli asociali: non per gli ebrei. Fino al ’39, non ce ne sono di ebrei nei campi di concentramento. Gli studiosi insistono da vent’anni su questa distinzione. Eppure, i libri di testo continuano a mescolare tutto: la soluzione finale – scrivono – avviene nei campi di Mauthausen, Dachau, Treblinka, Auschwitz ... come se fossero nati tutti nel ’33 (o tutti nel ’40), e come se tutti fossero in egual misura strutture di sterminio. Allora, andiamo con ordine, e partiamo da Dachau. Lo stesso discorso vale per i centri di sterminio. Mescolare Dachau con Treblinka è esattamente uguale a dire che Napoleone ha vinto la battaglia di Waterloo: è una stupidaggine uguale ... perché i centri di sterminio sono 4 e solo 4: Chelmno, Belzec, Sobibor e Treblinka. Questi luoghi, da soli, ammazzano 2 milioni, forse 2 milioni e mezzo di persone. Se non distinguiamo i lager dai centri di sterminio, della Shoah non capiremo mai la specificità. La deportazione di milioni di kulak fu un dramma, un disastro. La carestia in Ucraina fu terrificante: si parla di 6 milioni di persone che muoiono di fame in Ucraina, nel 1932-1933. Fr a n c e s c o Ma r i a Fe l t r i Che differenza c’è tra l’operazione nazista, una volta che si è messa in moto (nel 1942) e il genocidio degli armeni, la deportazione dei kulak, la carestia in Ucraina e tante altre tragedie? La differenza consiste in ciò: i kulak sono un nemico, un avversario, un soggetto politico. Anche gli armeni, per i turchi, sono un nemico politico. Ma Hitler ragiona in termini razzisti, razziali. Pertanto, se sopravvivono mille, o diecimila kulak, deportati in Siberia, ormai non sono più un pericolo politico per Stalin. Anche se quelli sopravvivono, non ci sono problemi. Se le donne o i bambini armeni, convertendosi all’islam, sopravvivono, questo non fa problema per i turchi, perché ormai il nemico politico è stato spezzato. Nel caso nazista, al contrario, siamo di fronte ad un genocidio che cerca l’ultimo bambino ebreo nella soffitta o nella cantina … Vedete come la storia comparativa diventa a questo punto una gabbia: il concetto stesso di totalitarismo diventa una gabbia, perché gli elementi di somiglianza (che pure sono importantissimi e da mettere a fuoco) ci lasciano perplessi, quando andiamo a mettere a fuoco (istanza della distinzione) quelle che sono le specificità ideologiche dei vari regimi e le specificità tecniche dei vari processi di genocidio e dei diversi crimini di massa. Rapidamente andiamo ad esaminare il più celebre di questi luoghi: Treblinka. Portare i ragazzi a Treblinka sarebbe una delle esperienze più interessanti. Auschwitz è più vicina, è più comoda, costa meno, ma portarli a Treblinka è davvero portarli nel cuore della Shoah. Treblinka ci aiuta a capire la vera dinamica, il vero epicentro: lì siamo nel cuore della Shoah. I nazisti hanno fatto il delitto perfetto: quando i Russi arrivano c’è una fattoria, non c’è altro. Tutto il resto intorno è un bel bosco. I nazisti hanno cercato di cancellare tutto. Ma la cosa più sorprendente (che stupisce me, stupisce lo storico, stupisce l’insegnante, stupisce il ragazzo) è che Treblinka è un luogo piccolissimo. E questo perché non è un lager, non è un campo di concentramento: è un campo di sterminio. Il treno arriva da Varsavia, gli ebrei scendono, si spogliano in due baracche, prendono una stradina (o meglio, un percorso obbligato), entrano in camera a gas e poi vengono gettati nelle fosse comuni. In due ore un intero treno viene liquidato: si scende e si muore, si scende e si muore. E’ una fabbrica di morte: primitiva, elementare... ma funziona alla perfezione. E’ il terzo centro, infatti, che viene messo in moto, all’interno della “Aktion Reinhardt”. Prima di Treblinka funzionavano già Belzec e Sobibor. Anzi, dal dicembre del 1941 era già attivo anche il centro di Chelmno (che però faceva uso dei Gaswagen, cioè di camere a gas mobili). Conseguentemente, quando Treblinka funziona, riesce a eliminare i 500 mila ebrei di Varsavia. In totale, uccide dai 700 ai 900 mila individui, a seconda delle stime degli storici. Oggi, un primo monumento sorge sulla zona della ferrovia, nel punto in cui si fermavano i treni. Dove sorgevano le camere a gas, vi è un grande monumento in pietra che evoca Varsavia, con le sue 500 mila vittime. Pietre più piccole evocano gli altri luoghi da cui sono stati deportati gli ebrei a Treblinka. 47 Sul piano tecnico, siamo di fronte ad un progetto più generale, che parte nel 1940 con l’eliminazione dei malati di mente e gli handicappati. Le esecuzioni avvengono ad Hartheim, in Austria, a circa 50 chilometri da Mauthasen, e in altri centri deputati all’eutanasia. Anche la struttura di Hartheim è piccolissima, perché i malati di mente arrivano a questo castello, scendono, si spogliano, entrano in gas. Il personale è lo stesso che lavorerà nei centri di sterminio del 1942. Christian Wirth e Franz Stangl fanno servizio prima ad Hartheim, e poi sono spostati a Sobibor e Treblinka, visto che ormai sono già esperti in gasazioni di massa. Sono portati all’est, per uccidere gli ebrei polacchi nei centri di sterminio. Levi, non dimentichiamolo, era ad Auschwitz III, dove non c’erano camere a gas. Queste erano solo ad Auschwitz II – Birkenau. Il vero campo di sterminio di Auschwitz non è quello di Levi, e neppure quello denominato Auschwitz I. Qui troviamo il celebre cancello con la scritta: “Il lavoro rende liberi”. Ma questo è un campo di concentramento per prigionieri politici, soprattutto polacchi: non è un campo di sterminio. Insomma, i campi di Auschwitz sono tre: il campo I (per prigionieri politici), il campo II (ai cui margini si trovavano le camere a gas) e il campo III (quello di Levi, vicino alla grande industria chimica della IG Farben). Del campo III possediamo solo alcune foto aeree scattate dagli anglo-americani nel 1944. Purtroppo, il campo oggi non esiste più e non ci sono (o non si sono conservate) foto scattate all’interno. Per quanto riguarda la Shoah, il luogo più importante è Birkenau (Auschwitz III). Sulla banchina ferroviaria di Birkenau avveniva la selezione, che è tipica di Auschwitz. Avveniva solo ad Auschwitz. Infatti, chi arrivava a Dachau era stato mandato lì per lavorare (e quindi non veniva selezionato): arrivava, veniva assegnato a una squadra e il giorno dopo cominciava a lavorare. Chi era mandato a Treblinka scendeva dal treno e moriva subito dopo. Ad Auschwitz, invece, si ha la divisione tra abili al lavoro e inabili al lavoro, tra l’altro documentata da una serie di foto molto importanti, scattate dalle SS e oggi raccolte nel così detto Album di Auschwitz, curata dal museo di Auschwitz e dal museo Yad Vashen di Gerusalemme. Si tratta di foto altamente drammatiche, perché presentano persone ancora in vita, che di sicuro non passeranno la selezione. Si tratta di vecchi, di bambini, oppure di donne giovani e sane che potrebbero essere considerate abili al lavoro, ma hanno un bambino in braccio e un altro per mano. I nazisti sanno bene che questi bambini, se strappati alle loro mamme, comincerebbero a urlare. Se scoppiasse il panico sulla rampa ferroviaria, il meccanismo potrebbe bloccarsi: allora, queste mamme giovani sono tutte spedite in gas, subito. 48 Fr a n c e s c o Ma r i a Fe l t r i Questi, lo ribadisco, sono 4 e solo 4: Chelmno, Belzec, Sobibor e Treblinka. Auschwitz, invece, era sia campo di concentramento sia centro di sterminio. Era l’uno e l’altro. Ma praticamente è l’unico che svolge questa doppia funzione. Noi diciamo sempre: “gli ebrei morti nei campi di concentramento ...”, perché il nostro parametro è Primo Levi. Ma Primo Levi (pur essendo il più grande e insuperato testimone italiano, sul piano umano e sul piano letterario) non è assolutamente rappresentativo della Shoah nel suo complesso. Tra l’altro, lo dice lui mille volte: “Io parlo solo della mia piccola esperienza, solo di ciò che ho visto”. Entra qui in gioco una delle questioni più interessanti, importanti e centrali della Shoah, la dimensione dello spreco. Avendo alle spalle una motivazione razzista, la soluzione finale elimina milioni di operai a costo zero. Pensate soprattutto agli ebrei polacchi: invece di essere usati per lo sforza bellico, vengono portati a Treblinka. Le esigenze ideologiche hanno la preminenza assoluta sulle esigenze di ordine economico. I due crematori maggiori di Auschwitz Birkenau erano chiamati con i numeri 2 e 3. Fr a n c e s c o Ma r i a Fe l t r i È un meccanismo industriale. Le persone destinate alla morte scendevano una piccola scala con gradini di cemento ed entravano in una grande sala di spogliazione. La camera a gas ospitava 1500 persone alla volta; i forni per distruggere i cadaveri erano 15, per ognuno dei due crematori. In totale, ad Auschwitz-Birkenau funzionavano 46 fornaci. Per capire e ricostruire tutto questo, i disegni del pittore ebreo francese David Olere sono una fonte di straordinario valore. Olere è sopravvissuto, pur essendo un Sonderkommando. Questo gruppo di detenuti aveva il compito di liberare le camere a gas e distruggere i corpi dei morti. I nazisti, nel gennaio del 1945, al momento dell’evacuazione dei campi, cercarono di eliminarli. Olere, tuttavia, riuscì a nascondersi e a sopravvivere. A differenza di Primo Levi (che aveva solo la penna e la voce, per testimoniare), Olere, essendo un grande pittore, aveva anche la matita. Pertanto, disegnò i crematori, le donne giovani che andavano in gas insieme ai bambini, la camera a gas e la procedura per la distruzione dei corpi (compresa la rasatura dei capelli e l’estrazione dei denti d’oro). Il gas Ziclon B veniva immesso da apposite botole, collocate sul tetto della camera. Vi ricordate le Einsatzgruppen? Queste persone ammazzavano centinaia di ebrei al giorno, sparando alla nuca. Alla fine di una giornata, erano uomini distrutti. Erano spesso nazisti convinti; erano SS. Ma arrivati a fine giornata, hanno ammazzato senza sosta, dall’alba al tramonto: 33 000 persone uccise, in 2 giorni, a Babi Yar, vicino a Kiev. Tutti, il giorno dopo, sono ubriachi: la seconda azione è fatta in stato di ubriachezza; molti sono impazziti. Himmler, quando riceve questi rapporti, si rende conto del fatto che così non si può andare avanti. Ecco allora l’escalation in direzione dei centri di sterminio. Ma quando arriviamo ad Auschwitz, nei crematori completati nel ’43, il procedimento ha raggiunto la perfezione tecnica. Il nazista sale sul tetto, apre un tombino, versa il Ziclon B, chiude la botola e se ne va: non vede più le vittime. È riuscito a mettere un diaframma, una barriera, un velo impenetrabile, tra sé e le vittime. Il coinvolgimento emotivo, che ancora bloccava tantissimi poliziotti o SS, è stato cancellato. Ad Auschwitz, il processo raggiunge poi la perfezione tecnica anche perché il lavoro sporco di pulizia delle camere, e di distruzione dei cadaveri, è lasciato fare ai Sonderkommando ebrei. Concludendo, due o tre istanze didattiche che mi paiono forti: 1. Contestualizzazione. Vuol dire che, in un curriculum di storia contemporanea (penso soprattutto alle scuole superiori, ma non solo) la Shoah va inserita nel più vasto ambito del Novecento. Solo alla fine dell’itinerario potrà emergere la specificità di questo evento. 2. Rigore terminologico e concettuale, con particolare riferimento ai termini lager e campi di sterminio. 49 3. Rigore cronologico, perché i lager e i campi di sterminio non nascono insieme. Esiste una successione precisa, che va rispettata. I ragazzi non vogliono prediche, ma una precisa ricostruzione di una dinamica storica. Tanto più essa sarà rigorosa, tanto più (forse) potrà essere anche utile per la crescita dei giovani cittadini del futuro. Grazie. (…) Feltri: Per molto tempo, in Israele ma non solo, la rivolta del ghetto di Varsavia è stato l’unico argomento della Shoah di cui si parlava. Per tutto il resto si era imbarazzati, preoccupati. C’era quasi un senso di vergogna, di colpa: “Ma come, milioni di persone che si sono lasciate ammazzare così?” Ma poi c’è un altro argomento più spinoso. Se parliamo delle città parliamo dei consigli ebraici: e se apriamo la questione dei consigli ebraici, gli storici si accapigliano, perché le valutazioni sull’operato dei consigli sono davvero molto diversificate. Ci sono comunque, sul tema dei ghetti, degli ottimi lavori, che studiano una serie di aspetti particolari. Ad esempio, riguardano le città della Lituania (come Kaunas/Kovno o Vilnius). Il problema a questo punto qual è? È che, studiando questi episodi specifici, tutta una serie di paradigmi semplificati di spiegazione della Shoah saltano. Tu credi che la decisione di attuare lo sterminio sia già stata presa il giorno X, e ti accorgi invece che un anno dopo c’è ancora il ghetto di Kovno. E allora dici: “Ma la decisione l’avevano presa o no? Chi dava gli ordini? Da dove partivano gli ordini? Che ruolo avevano, a livello locale, il singolo governatore, o il singolo nazista dotato di un alto grado, o il singolo ufficiale delle SS? Che margine di autonomia avevano?”. Si spalanca uno scenario di complessità veramente notevole: anzi, per certi versi, addirittura deprimente e inquietante. (…) Feltri: Adolf Eichmann, a torto o ragione, è stato considerato il prototipo di un certo modello di specialista parcellizzato: “Io facevo degli orari ferroviari: perché dite che sono un criminale?” Questo modello non vale per le Einsatzgruppen. Se tu sei in Ucraina e spari a bruciapelo, non funziona più il modello della “banalità del male“ di Hanna Arent. Anzi, scatta una serie di altri interrogativi e di domande che dobbiamo porci: in che misura funziona la pressione del gruppo, la paura di restare isolati, di sentirsi rinfacciare dagli altri: “ecco, il lavoro sporco lo fai sempre fare agli altri...” ? In gioco, può senza dubbio esserci una dimensione non ideologica. L’impianto del lavoro di Christopher Browning sui poliziotti che agirono in Polonia è questo: sostanzialmente è una serie di pressioni psicologiche di gruppo che spingono questo individuo a fare quello che ha fatto. Altro esempio, altro caso possibilissimo: il carrierista. Anche lui non è mosso da motivazioni 50 Fr a n c e s c o Ma r i a Fe l t r i In qualche modo, se la memoria del ghetto di Varsavia veniva conservata e presentata, tantissimi altri aspetti della Shoah sono stati trascurati, compresi tantissimi altri episodi di resistenza. C’è un motivo per cui dei ghetti e delle città oggi si parla poco: forse, all’inizio se ne è parlato di più che di altri argomenti. ideologiche forti. Tutto sommato, Franz Stangl (comandante di Treblinka) non è un gran nazista. Però sa e ha capito che, se fa queste cose, ci guadagna. E allora le fa, punto. In altri casi invece abbiamo, sia nel caso dei funzionari sia nel caso degli assassini diretti, dei nazisti convinti. È “l’antisemitismo demonologico” di Goldhagen. Spesso, tutte queste impostazioni vengono rigidamente contrapposte le une alle altre. In realtà, dovrebbero interagire tra loro. Fr a n c e s c o Ma r i a Fe l t r i È importante avere chiaro questo fenomeno della complessità interpretativa della Shoah. Guai a noi se ci fermiamo ad un paradigma semplice, semplificato. Ogni volta che formuliamo un’affermazione dobbiamo essere pronti e avvertiti: avere le antenne dritte. Perché altri aspetti della Shoah che studieremo domani, romperanno la lettura che abbiamo elaborato ieri. Fenomeno modernissimo la Shoah. Vero! Ma tutta una serie di altri elementi sono arcaici. L’uccisione a tu per tu, i pogrom in Polonia, i pogrom in Lituania: è la gente comune che ammazza gli ebrei, sulla base di pregiudizi antichissimi. Quindi la Shoah non è solo modernità, è anche antichità. Non è solo burocrazia: è anche esecuzioni; e non è solo qualcosa che viene mosso dal centro. Non ci sono solo Hitler e Himmler come grandi burattinai: ampio spazio ebbero pure le iniziative locali. Quindi, dobbiamo stare attenti ad avere questa elasticità mentale, per elaborare dei paradigmi storiografici il più possibile aperti. Non necessariamente questi paradigmi complessi riescono a trasformarsi in proposte didattiche. Possiamo anche assumere lucidamente la decisione che, in sede didattica, semplifichiamo e snelliamo. L’importante è che ci assumiamo la responsabilità di quel che facciamo: perché un conto è dire una cosa semplificandola, banalizzandola, perché noi sappiamo solo quello; e un conto è dire: “io mi rendo conto che il fenomeno è complesso, ma per esigenze didattiche, ai miei studenti di quinta elementare, di terza media, perfino di quinta liceo, presento solo questo”. Capite che è un’operazione molto diversa. 51 Na d i a Ba i e s i Moltissime cose sono già state dette e tutti, fin dal primo intervento della rappresentante della Regione Emilia Romagna, hanno parlato di “attualizzazione” e comunque della necessità di rivolgere lo sguardo, a partire dalla Shoah, anche al nostro presente. A questo proposito vorrei mettere a fuoco due o tre punti che mi sembrano abbastanza importanti e porvi qualche problema, in modo tale che abbiamo il tempo, spero, di scambiarci un po’ di idee, perché altrimenti il pomeriggio finisce nel silenzio e questo non va bene, soprattutto quando parliamo di giovani e di didattica. Parto da un dato in un certo senso autobiografico. Quando, molti anni fa, ho cominciato a riflettere su questi problemi, l’ho fatto a partire da alcune testimonianze, ed in particolare da quella di Primo Levi. E sono proprio i testimoni coloro che per primi rivolgono lo sguardo verso il futuro, per stimolare nei giovani la scelta per una cittadinanza responsabile e consapevole. Nel momento stesso in cui scelgono di ripensare il dolore e la sofferenza per raccontarla, essi calano il loro passato nel presente e guardano al futuro, che sono le ragazze e i ragazzi che hanno di fronte. Quando si preoccupano perché quello che è successo non accada mai più, si tratta già di una scelta che guarda lontano e che mi sembra contenga due aspetti: da una parte un’assunzione dolorosa di responsabilità nei confronti del passato, cioè di coloro che sono morti e che non possono raccontare; dall’altra un impegno verso le nuove generazioni. E questo perché si costruisca in loro la capacità di superare l’indifferenza di fronte a vicende simili a quelle che i testimoni hanno vissuto in prima persona (e che si ripropongono anche nel presente) e la forza di dire “io non ci sto”, di opporsi, di resistere. Tutto ciò mi pare ci chiami fortemente in causa come insegnanti, perché anche noi ci assumiamo il compito di trasmettere il messaggio ai nostri studenti. Un altro aspetto che è stato sottolineato fortemente da tutti gli interventi riguarda il fatto che un tema come quello della Shoah implica il coinvolgimento del piano dell’etica ed inevitabilmente ci spinge ad interrogarci su noi stessi e sul nostro ruolo di educatori. Credo che non si debba sfuggire a questo “mettersi in gioco completamente”, anche se concordo sulla necessità di un rigore scientifico, che riguarda il piano di una conoscenza attenta e puntuale dei problemi, capace di restituire il quadro storico del contesto in cui si cala la tragedia della Shoah che va affrontata anche in una prospettiva di lungo periodo, collegandola alla questione dell’antisemitismo. Un altro problema, al quale ci introduceva Alessandra Chiappano nelle ultime battute del suo intervento, riguarda il fatto che oggi noi insegnanti lavoriamo con giovani che vengono da altre culture. Anche questo è un fatto che ci interroga fortemente: insegnare la Shoah a dei bambini cinesi, accompagnare alle celebrazioni della giornata della memoria giovani sudamericani, pakistani, africani ecc. è una questione che non può essere passata sotto silenzio. Non c’è dubbio che per l’Occidente la Shoah rappresenta una ferita così profonda, una violenza estrema che mette in crisi la nostra cultura e inevitabilmente ci coinvolge. Non c’è dubbio che il campo di sterminio dove sono stati trucidati gli ebrei è una colpa dell’Occidente, è profondamente “dentro” questo nostro mondo. Come possiamo accostare giovani non europei a questo tema? Noi crediamo, in quanto insegnanti, che Auschwitz rappresenti il paradigma della violenza estrema, e che, come tale, debba essere affrontato a scuola, ma come, in un contesto multiculturale? Rispetto ad una nuova composizione delle nostre classi, noi tutti sappiamo che esiste un problema generale che riguarda tutti gli insegnamenti, esiste poi un problema più circoscritto che 53 riguarda la storia (quale storia per una società multietnica?) e, in questo ambito, il problema di come affrontare la seconda guerra mondiale ed in particolare Auschwitz. Come fare a non imporre una sorta di “colonizzazione” da parte della nostra cultura e a rispettare le differenze? Sappiamo bene che affrontare questo nodo vuol dire mettere in discussione molte questioni ed in particolare il tema dell’universalità della Shoah, tema che è stato già abbondantemente toccato negli interventi precedenti. Vorrei ora fare qualche riferimento alla mia esperienza. Attualmente lavoro alla Scuola di Pace di Monte Sole (il luogo della strage nota con il nome di Marzabotto). Evidentemente qui facciamo riferimento non alla Shoah, ma ad una strage di civili, anche se l’esperienza sviluppata come insegnanti intorno alla didattica della Shoah ci ha offerto molti strumenti per lavorare con i ragazzi anche in questo luogo. A Monte Sole, che è un luogo della memoria, di un’altra memoria, accogliamo molti giovani che vengono da paesi lontani, da situazioni di guerra e di violenza. E sono per esempio ragazzi kosovari, serbi e albanesi, ragazzi europei di diversi paesi, ragazzi israeliani e palestinesi, ragazzi bosniaci ed anche adulti di molte provenienze e “di molte sofferenze”. Qual è il meccanismo immediato che scatta nel momento in cui facciamo una visita guidata al luogo, con tutte quelle cautele che sono le stesse che abbiamo ascoltato negli interventi precedenti: il rigore storico, l’attenzione, il racconto dei dettagli? Le prime parole che ci dicono sono: “anche noi abbiamo vissuto questo orrore” e si verifica una sorta di “rispecchiamento” di sé, e si fa strada il desiderio di raccontarsi. La vicenda che raccontiamo mentre visitiamo i luoghi apre un varco, dà spazio alle loro memorie, alle esperienze che portano con sé. E noi arretriamo per un momento, per metterci in una posizione di ascolto e lasciare che siano loro a diventare protagonisti con quanto portano con sé, con quanto emerge dopo lo stimolo forte che il luogo, con i segni profondi del suo doloroso passato, è capace di suscitare . Forse questa modalità di approccio può farci riflettere. Non c’è dubbio che l’enormità dello sterminio ebraico è qualcosa di incommensurabile, e che resta centrale la conoscenza di quanto è accaduto durante la seconda guerra mondiale, dei crimini del nazismo, delle colpe di questo occidente. Ma è anche importante che, rispetto a presenze che vengono da altre culture, da altri mondi, sia data la possibilità di una “reciprocità”, di esprimere quello che sentono senza scandalizzarci se ci raccontano che anche loro hanno vissuto tragedie simili, e magari vengono da tragedie recenti. 54 Na d i a Ba i e s i Nel tentativo di proporre ai nostri studenti extraeuropei una chiave di lettura che possa essere efficace da un punto di vista educativo, potremmo forse porre l’accento sui meccanismi della violenza che si è scatenata all’interno del lager. E questo al fine di insegnare a cogliere gli elementi portanti di questi meccanismi, in modo da saperli riconoscere se e quando si ripresentano (o si sono già ripresentati) in altre realtà, in altri mondi e in altre culture. Dovremmo forse cercare di svelare il meccanismo dello sterminio, della cancellazione del “diverso” da parte del nazismo e del fascismo, magari ricostruendo il contesto nel quale si sono manifestati, per scoprire che percorsi analoghi sono riconoscibili anche in altri tempi. E qui è la storia che diviene la disciplina di riferimento. Possiamo, e forse dobbiamo, scegliere la strada del comparativismo, della storia comparativa, che sembra essere un elemento chiave in questo discorso. E questo non per mostrare che tutto è uguale, che nulla è mutato o muta nel tempo, ma al contrario per imparare a cogliere, attraverso la comparazione, i dettagli, i particolari, le sfumature, che rendono la specificità di un contesto, che mostrano l’ universo affascinante della complessità, che sollecitano domande, questioni, che aiutano l’apprendimento ad uscire dalla dimensione della passività. Forse possiamo provare a lavorare su questo livello. Si tratta di problemi difficili, per i quali non ci sono ricette precostituite, ma per i quali è necessario trovare soluzioni a seconda del contesto, del momento, della classe, delle soggettività e delle sensibilità degli studenti. A questo proposito faccio riferimento al volume di Milena Canterini, che affronta questi problemi. Forse potremmo ricordare anche George Steiner: Ecco, tenere conto, come ci insegna, che essere ebrei dopo la Shoah significa aprirsi al dolore degli altri, “essere un po’ più uomini” . Tutto questo ci lascia molto a cui pensare e forse potremmo provare ad aprire il dibattito. Dovevo una risposta su Monte Sole. E’ necessario ricordare che manca ancora, da un punto di vista storiografico, un contributo che possa essere considerato di ampio respiro. Abbiamo numerosi scritti, ma parziali, che non ricostruiscono il contesto in tutta la sua complessità Accompagnare in visita a Monte Sole significa anche fare presenti questi limiti. Na d i a Ba i e s i Credo che sia importante ribadire che il discorso su Monte Sole e sulle stragi non ha a che fare con il tema della Shoah se non in modo indiretto. Intendo dire che può essere interessante ricordare che la cornice di riferimento è la stessa: il nazismo e il nazismo, la loro ideologia, la loro propaganda fanno da sfondo ad entrambe le vicende. Da un punto di vista educativo potremmo forse tenerne conto. 55 Appunti per la relazione al Convegno “La Shoah in classe” (Le pagine seguenti sono gli appunti preparatori dell’intervento realizzato poi in collaborazione con l’attrice Alessia Canducci) Premessa Non sono uno storico, sono un pedagogista, mi occupo di educazione, ma farò riferimenti storici per sviluppare la mia riflessione… Va l t e r Ba r u z z i Non sono nemmeno uno studioso di Shoah – a dire il vero - ma la Shoah è una questione tragica, complessa e ineludibile che ci interpella tutti e, sul piano personale, fa parte delle narrazioni familiari che fanno da sfondo alla mia vita. Quando da ragazzo scoprii Se questo è un uomo di Primo Levi, dopo averlo letto ne comperai una copia e la regalai a mio padre, in segno di riconoscenza per la pazienza e la passione con cui mi aveva raccontato le storie della sua vita e, fra queste, l’esperienza di giovane militare in fuga dalla Jugoslavia verso l’Italia, dopo l’8 settembre 1943, catturato in Istria dai tedeschi e deportato in Polonia, dopo il suo rifiuto a rientrare in Italia con la divisa dell’esercito tedesco: storie che parlavano di umiliazioni e paura, il lungo viaggio su un treno merci, il freddo e la fame, la fortuna di capitare in un campo di lavoro (e non di sterminio) vicino al cantiere navale di Danzica, dove la mano d’opera era preziosa. Mi sarei reso conto solo più tardi, crescendo, di quanto recente, calda e bruciante fosse quella ferita e di come fosse importante per mio padre la narrazione e la rielaborazione di quella drammatica vicenda personale, era passato così poco tempo! E di come fosse importante il mio sguardo attento e curioso di bambino… e le mie domande che non si accontentavano di risposte generiche. Fu lui a parlarmi per primo dei campi di sterminio e della sorte degli ebrei. E’ da allora che mantengo vivo l’interesse per la Shoah, ma è stato più tardi che ho intrapreso un percorso di ricerca dove, accanto ad alcune risposte, ci sono ancora domande aperte. Non vi propongo, quindi, di ascoltare una lezione, ma di condividere le tracce di una riflessione in corso d’opera… La letteratura per ragazzi Ho chiesto di aiutarmi ad Alessia Canducci, attrice brava e sensibile che stimo e apprezzo, che accompagnerà i miei appunti di lavoro con la lettura di brani tratti da libri di narrativa per ragazzi che abbiamo scelto insieme, perché – vi anticipo una delle conclusioni – noi siamo convinti che accanto ai documenti e all’approfondimento storico, all’ascolto dei testimoni, alla visita ai luoghi significativi, al cinema… la letteratura per ragazzi sia una risorsa molto importante, per preparare e favorire un corretto incontro di bambini e ragazzi con la Shoah. Due interventi che si intrecciano. Vi proporremo brani senza commenti, in una sequenza che va dai testi più semplici e delicati a quelli più complessi, crudi e difficili. E nemmeno faremo riferimento alle età. Oggi ci interessa solo mostrare (e riascoltare insieme a chi già li conosce) alcuni tesori che si celano nella letteratura per ragazzi. 57 ALESSIA – 1 Uri Orlev, La nonna sul filo (versione poetica di Roberto Piumini), Feltrinelli kids, Milano, 1999 Haren Levine, La valigia di Hana: una storia vera, Fabbri, Milano 2003 (p. 43) I bambini, i ragazzi e il nostro rapporto con la Shoah Riferendosi a un viaggio ad Aushwitz insieme a un gruppo di studenti e insegnanti, il pedagogista Raffaele Mantegazza racconta questo episodio: Raffaele Mantegazza, L’odore del fumo. Auschwitz e la pedagogia dell’annientamento, Città Aperta edizioni, Troina, 2001 (pag 9, leggere prime 18 righe) Domanda: è sufficiente l’informazione storica, il “contatto” con i luoghi, l’incontro col dramma della Shoah per maturare sensibilità e consapevolezza? E che cosa ci importa davvero? Che i ragazzi siano informati e sappiano esporre correttamente e con competenza gli argomenti proposti, che provino orrore per ciò che è accaduto e maturino sentimenti di solidarietà e fratellanza universale, che sappiano comportarsi correttamente quando se ne parla o si visitano i luoghi della storia… E a che età è bene cominciare a parlare? Non si corre il rischio di traumi provocati dall’incontro con l’orrore della Shoah? Come gestire la relazione fra aspetti informativi e dimensione emotivo/affettiva? Fino a che punto raccontare, che immagini proporre? Come attualizzare senza cadere nella banalizzazione? Non è facile trovare le risposte. Certo siamo tutti d’accordo, credo, con quanto scrisse quasi 40 anni fa Adorno: “L’esigenza che Auschwitz non si ripeta più un’altra volta si situa prima di ogni altra in campo educativo (…) Non riesco a capire come finora si sia potuto occuparsene così poco.” [L’educazione dopo Auschwitz, 1966] Affermata questa esigenza, tuttavia, non possiamo fare a meno di osservare i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che conosciamo, così presi come sono da bambole alla moda, dal merchandising, dalla tecnologia applicata ai telefoni cellulari, dal vortice effervescente dei consumi, dalla frenetica organizzazione della vita quotidiana… Fra la loro vita e i nostri propositi educativi pare che ci sia un abisso, eppure è da lì che dobbiamo partire. Questa è la nostra realtà e non possiamo piegarla o immaginarla secondo i nostri desideri. Ci troviamo di fronte a un ostacolo difficile da superare, a meno che… 58 Va l t e r Ba r u z z i Evidentemente no, ma come deve essere invece questo incontro, perché approdi a risultati educativi? A meno che non prendiamo atto che il primo problema che abbiamo non è il rapporto fra noi e gli studenti, ma è il rapporto che abbiamo con noi stessi. Questa difficoltà di dialogo con giovani e giovanissimi richiede che noi in primo luogo avviamo una riflessione personale sul significato che ha per noi la Shoah, quali siano i nessi che la pongono in correlazione significativa con la contemporaneità e con la nostra vita. In un secondo momento rifletteremo sui possibili obiettivi educativi da porci. ALESSIA - 2 Tomi Ungerer, Otto, autobiografia di un orsacchiotto, Mondadori, Milano, 2003 La Shoah dentro al storia Ci sono interpretazione della Shoah incompatibili con qualsiasi intenzione educativa. Valutazioni che non ammettono l’esistenza di ipotesi pedagogiche. Va l t e r Ba r u z z i Alcuni esempi. - Ritenere che il genocidio ebraico sia un evento che ci lascia muti e attoniti, che resiste a qualsiasi tentativo di comprensione razionale! - Pensare al nazismo come se rappresentasse l’irruzione di forze irrazionali nella società tedesca, che hanno interrotto il fluire della civiltà europea, e quindi – in un certo senso – una parentesi da dimenticare. - Vedere nell’olocausto il compimento tremendo di una profezia, che attiene alla sfera del mitico e del metafisico, trascendendo la storia. Tutte le interpretazioni che pongono l’accento sull’eccezionalità, demonizzano il nazismo o sacralizzano la Shoah, ponendoli di fatto fuori dalla storia, rendono impossibile qualsiasi tentativo di ricerca e di comprensione. Ma questo vale anche per i rituali laici che dopo aver istituito la giornata della memoria si accontentano di commemorazioni che rischiano di essere banali e retoriche. Non dimentichiamo che viviamo in un Paese che mentre si istituisce la Giornata della memoria con plauso unanime (o quasi), presenta nel suo Parlamento forze politiche che propongono di equiparare di fronte alla Patria uomini e donne che hanno fatto la scelta di resistere al nazifascismo, con chi, nella Repubblica di Salò forniva le informazioni per i rastrellamenti o direttamente vi partecipava, spingendo sui carri bestiame donne uomini, vecchi e bambini destinati ad essere deportati nei lager nazisti, verso lo sterminio. Non è una novità, questa posizione – accanto al negazionismo che non voglio qui prendere in considerazione – si è mantenuta viva come un fiume sotterraneo che riaffiora quando la vigilanza sociale e culturale si indebolisce e le condizioni politiche sono favorevoli Non dimentichiamo che nell’autunno del 1988, nel ricordare la famigerata Notte dei cristalli, l’allora presidente del parlamento della Repubblica federale tedesca Philipp Jenninger, spiegò agli ebrei le “ragioni” che resero inevitabile il loro massacro, l’irresistibile fascinazione dei tedeschi per i trionfi di Hitler e la “necessità” storica di “rimettere gli ebrei al loro posto”. Si dimise poi dichiarando “Me ne vado: in Germania non si può dire la verità”. 59 Il bisogno psicologico di autoassoluzione, di rassicurazione e di pacificazione sono comprensibili, ma non possono falsificare la storia. E ci colpiscono nel profondo le parole di Walter Benjamin, quando scrive “Neppure i morti saranno al sicuro dal nemico se egli vince. E questo nemico non ha smesso di vincere.” Occorre leggere il nazismo e la Shoah come esperienze estreme, certo, ma dentro la storia e per ciò profondamente umane, di cui è necessario cogliere gli elementi di continuità con il passato e il presente. Il rispetto della memoria e della verità storica, sono i pilastri su cui si può aprire il capitolo del perdono, dove c’è chi il perdono deve chiederlo e ha già cominciato a farlo e chi può concederlo. La possibilità di un progetto pedagogico di conoscenza e riflessione sulla Shoah muove da questi presupposti. ALESSIA - 3 Ruth Vander Zee, Roberto Innocenti, La storia di Erika, C’era una volta, Pordenone, 2003 Quali sono le piste di ricerca che aprono la possibilità di una lettura pedagogica del nazismo e della Shoah.? - In primo luogo è necessario capire come una nazione e un popolo di grande cultura e civiltà nel cuore dell’Europa abbia potuto perpetrare un simile crimine nell’arco di dodici anni: Hitler sale al potere nel 1933 e la guerra finisce nel 1945. Attraverso quale processo le persone, le comunità hanno deciso di stare a guardare, di lasciar correre o sono state convinte ad abbandonare i loro valori le loro tradizioni politiche e culturali per appoggiare apertamente il potere nazista e i suoi crimini? I termini spiegare, capire e comprendere non significano scusare e giustificare, ma rispondono alla necessità di sapere di quali sentimenti, atteggiamenti, comportamenti stiamo parlando, per dare loro un nome e trovare le parole per definirli e poterne parlare senza equivoci. Ma anche riconoscerli, se del caso, nella nostra contemporaneità. Ci sono ricerche attente e ben documentati che raccontano come pacifiche persone comuni siano divenute sostenitrici di criminali assassini e esse stesse carnefici in prima persona. Ne cito due. William Sheridan Allen, Come si diventa nazisti. Storia di una piccola città 1930-1935. Einaudi, Torino, 1968 (1965) L’autore, sulla base di una vasta documentazione, ricostruisce giorno per giorno l’attività del partito nazista a Thalburg (Nordheim), una città di 10.000 abitanti situata al centro della Germania, con l’intento di capire quello che definisce “uno dei maggiori problemi politici e morali del XX secolo: come una democrazia civile sia potuta precipitare e affondare in una dittatura nichilista”. Il libro mette in evidenza la strategia di sopraffazione dei nazisti e le tappe della violenza, ma 60 Va l t e r Ba r u z z i Quali premesse per una lettura pedagogica della Shoah anche le divisioni dei suoi oppositori socialisti e gli atteggiamenti classisti e nazionalisti della borghesia, che accoglie il nazismo e lo appoggia accettando le illegalità pur di veder sconfitti i socialisti, senza capire che la violenza si sarebbe rivolta contro chiunque non fosse divenuto nazista. Ma Allen mostra come né i socialdemocratici, né i luterani e nemmeno gli ebrei di Nordheim riuscirono a intuire e a comprendere la natura del messaggio nazista, in tutta la sua drammaticità. Anche molte delle persone che pure vi aderirono, compresero che cosa significasse davvero il nazismo solo più tardi, quando la macchina del controllo e della repressione divenne spietata. Come mai questa difficoltà di percezione, si chiede Allen? Da questo punto di vista le difficoltà e il destino di Nordheim, conclude Allen con un monito per il futuro, saranno condivisi probabilmente da altri uomini, da altre città, in circostanze simili. E il rimedio non verrà trovato facilmente. Va l t e r Ba r u z z i Christopher R. Browning, Uomini comuni. Polizia tedesca e “soluzione finale” in Polonia. Einaudi, Torino 1995 e 1999 (1992) All’alba del 13 luglio 1942 gli uomini del battaglione 101 della Riserva di Polizia tedesca entrarono in un villaggio polacco (Jósefów). Al tramonto avevano rastrellato 1800 ebrei: ne selezionarono poche centinaia come “lavoratori” da deportare; gli altri, compresi donne, vecchi e bambini, li uccisero. Dove sta la novità? Ordinaria crudeltà nazista! Attenzione: gli uomini del Battaglione 101 erano operai, impiegati, commercianti, artigiani arruolati da poco. Uomini comuni reclutati per estrema necessità, che non erano nazisti militanti né fanatici antisemiti e che - nonostante ciò - sterminarono 1500 esseri umani in un solo giorno, dopodiché continuarono con efficacia il compito loro affidato, uccidendo altre 38.000 persone e collaborando alla deportazione di altre 45.000 che furono deportate e sterminate a Treblinka. Alla fine della guerra furono raccolte le testimonianze di 210 membri del Battaglione 101: cosa pensavano, mentre partecipavano alla “soluzione finale”? Come fu che diventarono assassini? Che cosa accadde dopo il primo massacro? Come giustificavano il proprio comportamento? Perché furono così spietatamente efficienti nell’eseguire gli ordini? Per fede nell’autorità, per paura della punizione? Ma quella scelta non era ineluttabile: le testimonianze raccolte da Browning raccontano che alcuni uomini del battaglione 101, appena intuirono che cosa li attendeva, chiesero di essere assegnati ad altri incarichi, cosa che ottennero senza subire conseguenze. ALESSIA - 4 Jerry Spinelli, Misha corre, Mondadori, Milano, 2004 ( pagg. 10 –12) Manipolazione e comunicazione di massa “Abbiamo intrapreso ad educare questo popolo in modo nuovo, a dargli un’educazione che inizi con la giovinezza per non finire mai. In avvenire, il giovane uomo passerà da una scuola all’altra. Ciò comincerà col bambino per finire col vecchio combattente. Nessuno deve poter dire che ci sarà per lui un momento in cui sarà lasciato solo”. 61 Queste parole fanno parte del programma del Partito nazionalsocialista tedesco: si ispirava all’esperienza di Mussolini che in Italia aveva inquadrato e messo in divisa anche i piccoli della scuola materna (i figli della lupa), e ci fanno capire quale dispositivo sia stato messo in atto per orientare atteggiamento e comportamenti del popolo tedesco. Hitler nel Mein kempf (1925) aveva scritto: “Il complessivo lavoro d’istruzione e d’educazione dello Stato etnico deve trovare il suo coronamento nell’infondere nel cuore e nel cervello della gioventù a lui affidata, lo spirito e il sentimento di razza. Nessun ragazzo, nessuna ragazza deve lasciare la scuola senza essere giunto a conoscere alla perfezione l’essenza e la purezza della razza” Ma altrettanta minuziosa cura venne posta nel controllo e nel dispiegamento di un apparato di manipolazione mediatico che utilizzava tecnologie e conoscenze innovative. Alcuni esempi: - Uso della radio (1933: diffusione in Germania di radio a poco costo che ricevevano solo trasmissione tedesche, ma non dall’estero; in Italia discorsi di Mussolini trasmessi dalla radio nelle piazze; in Ruanda…). - Grande attenzione alle tecniche comunicative (la retorica per neutralizzare gli argomenti degli avversari, comizi di giorno e di notte ponendo grande attenzione alle scenografie). - Interesse per le tecniche della pubblicità: la Coca cola nel 1930 usa Babbo Natale come testimonial e lo veste di rosso (i colori del suo logo), per una campagna destinata promuovere la vendita della sua bibita anche d’inverno. Hitler manda Goebbels negli USA a studiare la pubblicità. Nel 1933 Hitler dà vita al Ministero della chiarezza pubblica e della propaganda e ci mette a capo proprio Goebbels. Siamo in presenza di una grave crisi economica che colpisce un paese caratterizzato da un’economia industriale, nella quale il nazismo si inserisce utilizzando gli strumenti della modernità, forme di comunicazione di massa. Questo dispositivo venne impiegato per proporre piani, programmi e un immaginario che tenevano conto del senso comune dell’epoca, assecondavano orientamenti e mode già presenti nella società e nella cultura tedesche, si presentavano perciò al contempo con una patina di freschezza e di familiarità, si inserivano in un fertile terreno preesistente, in cui il nazismo si innestò coi suoi proclami. Alcuni esempi: - la reazione ottocentesca al positivismo e al razionalismo in Germania aveva assunto connotazioni mistico-esoteriche e di recupero delle origini germaniche arcaiche (celebrazione delle vittorie dei germani sui romani, ricerca sulle prime lingue e sui simboli runici): i simboli nazisti, ad esempio la forme delle 2 esse di SS, furono pescati da questo mare; - l’attenzione alla cultura esoterica indiana - la svastica è importata da lì - la filosofia ariana, la mistica della purezza sangue; - il recupero del rapporto con la naturale (festa dei solstizi); 62 Va l t e r Ba r u z z i - L’uso del cinema: film contro gli ebrei (1940, Suss l’ebreo). - anche le teorie razziste non sono una novità: il saggio di Gobineau sull’ineguaglianza delle razze è del 1852 e i “protocolli di Sion” (un falso documento della polizia segreta zarista che provava il complotto massonico e sionista mondiale) sono dei primi del 900 e nel 21 venne dimostrato che erano un falso. Fanno parte di quella cultura anche: - un certo culto della tradizione; - un sentimento diffuso di rispetto e obbedienza verso l’autorità costituita. Con la presa del potere (1933) il disegno diventa più esplicito. Viene abolita la libertà di stampa, - Il 10.10.1928 Mussolini aveva radunato tutti i direttori di giornale e aveva dato precise inequivocabili direttive. - In Germania Goebbels Ministro della propaganda dice: “Abbiamo invitato i giornalisti alla disciplina. Non sarà necessario impartire ordini.” Va l t e r Ba r u z z i C’è un crescendo di violenza e via via accadono le cose che sappiamo. Siamo di fronte alla progettazione curata e minuziosa di un gigantesco e drammaticamente moderno apparato di controllo e manipolazione, utilizzato per prendere il potere, cui diventa col passare degli anni sempre più difficile resistere e sfuggire… Eppure c’è chi resiste, con quali energie e coraggio, sulla base di quali valori, con quali strumenti culturali? ALESSIA - 5 Uri Orlev, Gioco di sabbia, Salani, Milano, 2001 Di quali valori si nutre la Resistenza al nazismo? Eppure c’è chi resiste. E’ di vitale importanza, per il nostro progetto, conoscere e capire quale sia stata la storia e la formazione di quei tedeschi che hanno deciso invece di resistere, sono stati per questo imprigionati e uccisi, dimostrando che c’era una differenza fra potere nazista e popolo tedesco. Quali valori hanno coltivato in sé, quali maestri hanno avuto, come hanno trovato il coraggio di resistere? Ci interessa capire, perché siamo convinti che in queste esperienze possiamo trovare gli elementi fondanti di una pedagogia della resistenza nei confronti della disumanità, della sopraffazione, della manipolazione e del terrore, in qualsiasi forma essi si manifestino. Una pedagogia della resistenza contro l’omologazione e l’indifferenza. Un solo esempio: i ragazzi della Rosa Bianca. La storia è semplice. Hans Sholl (1918) ha 15 anni quando Hitler diventa cancelliere del Reich e sua sorella Sophie (1921) ne ha 12. 63 I loro genitori sono contro il regime, ma lasciano i figli liberi di commettere errori, scommettendo sulla loro capacità di scelta. Hans e Sophie, aderiscono alla gioventù hitleriana con entusiasmo, ma ben presto capiscono e si allontanano da quell’esperienza disgustati. Alexander Schmorell (1917) è figlio di padre tedesco e madre russa, bilingue, innamorato della cultura e della letteratura russa Cristoph Probst (1919) figlio di un libero studioso senza docenza Willi Graf (1918) figlio di un commerciante grossista di vini, è attivo nei gruppi giovanili cattolici anche dopo la loro messa al bando Kurt Huber (1983) prof dell’università di Monaco, iscritto al partito nazionalsocialista è noto per le sue idee dissidenti, è scelto da Hans come guida spirituale I giovani sono studenti di medicina fuorchè Sophie che studia biologia e filosofia. Alcuni si conoscono da tempo, tutti insieme sii incontrano all’Università di Monaco. Nel giugno luglio 1942 inizia l’attività della Rosa Bianca: scritte sui muri contro Hitler e il regime nazista e 4 volantini, nel novembre/dicembre del 1942 la Rosa Bianca inizia a cercare contatti con altri gruppi di resistenza. Fra gennaio e febbraio 1943 i ragazzi redigono e distribuiscono il 5° e il 6° volantino. Vengono scoperti, arrestati, processati e ghigliottinati. La ricerca storica mostra un gruppo di giovani con le ansie, i sogni, le paure dei loro coetanei… che sentono però un forte richiamo verso l’etica della responsabilità. Come mai la propaganda nazista non ha inciso su di loro?. Quali sono stati gli anticorpi? A leggere le storie della loro vite si comprende che l’ambiente familiare è stato fondamentale per tutti, ma almeno per i fratelli Sholl si può dire che siano cresciuti in una famiglia che ha testimoniato valori, senza imporre scelte precoci. Comune a questi ragazzi è un percorso intellettuale che si fonda su una solida formazione letteraria (i loro autori preferiti sono bruciati da Goebbels), alcuni amano gli artisti d’avanguardia (distrutti i loro quadri), sono attratti dalle culture diverse (tzigana, russa…). I ragazzi della Rosa Bianca appartengono a famiglie di diverse religioni (cattolica e protestante), ma insieme avvertono con forza l’incompatibilità fra valori cristiani e nazismo, Graf in particolare è impegnato nel movimento di rinnovamento della chiesa, per il quale ogni cristiano ha il dovere di agire politicamente e socialmente. Che cosa scrivono i ragazzi della Rosa Bianca? (Leggere brani tratti dai volantini) 64 Va l t e r Ba r u z z i Alternano allo studio periodi di lavoro obbligatorio e il servizio militare, alcuni in Polonia altri in Russia dove si rendono conto dell’orrenda deliberata strage compiuta dall’esercito tedesco, contro gli ebrei e le popolazioni civili. Che cosa ci insegnano i ragazzi della Rosa Bianca? Che prima di essere la battaglia delle armi c’è un scontro di valori: - la democrazia contro la dittatura; - la libertà contro l’obbedienza cieca e la schiavitù; - l’originalità della persona contro l’omologazione nella massa; - la curiosità e la gioia di vivere contro l’arroganza del potere; - la responsabilità contro l’indifferenza; - la coscienza contro il fanatismo; - la difesa della pace e del dialogo, contro la violenza; - la convivenza contro l’idea di un popolo superiore che può distruggere gli altri… Una conclusione aperta Va l t e r Ba r u z z i Io credo che possiamo pensare lo studio del nazismo e della Shoah come a una tappa lungo il percorso di educazione ai valori e alla pratica della cittadinanza attiva e della democrazia, che rappresentano il vero antido contro gli orrori della dittatura e del terrore. Ma una tappa viene ad un certo punto di un percorso, dopo aver vissuto altre esperienze… Quali? Alcuni spunti. - È importante che i ragazzi abbiano vissuto le opportune esperienze sul piano della maturazione dell’intelligenza emotiva… E’ un tema questo che richiama il clima sociale che c’è nelle nostre classi, il dialogo fra adulti e ragazzi, ma anche il rapporto con la letteratura (che rappresenta un vero e proprio “libro di testo” per una educazione dell’intelligenza emotiva) ma anche con la musica e le altre forme d’arte… - È bene che abbiano riflettuto sulla questione dei valori, per capire che cosa significa la sopraffazione e sappiano dove porta e - a questo proposito – debbono disporre di una bussola (anche rudimentale) per cominciare a orientarsi. Che cos’è la democrazia, la si incontra quotidianamente? Come si prendono le decisioni insieme, come si affrontano i conflitti? - Debbono aver incontrato il tema dei diritti umani, conoscere la convenzione dei diritti dell’infanzia e percepirne la valenza universale (valgono per noi e per gli altri, oggi e in futuro, e sono una possibile chiave di lettura del passato), saperlo porre in relazione con la contemporaneità, con la loro vita. - Debbono essere stati posti in condizione di prendere le distanze dagli stereotipi del pregiudizio razzista; - È opportuno che sappiano per esperienza che cosa significa cittadinanza e quali siano i diritti di cittadinanza (Edgar Morin); - Quando i ragazzi incontrano, infine, gli orrori della Shoah nei documenti, visitando i luoghi, ascoltando testimoni… dovranno possedere gli strumenti culturali per contestualizzare e per compiere un’analisi critica del periodo storico e degli eventi Si tratta di chiavi di lettura, di strumenti di conoscenza… 65 Non dimentichiamo che la dimensione cognitiva implica la capacità di coniugare razionalità e aspetti emotivo/affettivi. Non c’é un ordine di priorità in questo elenco, né riferimenti espliciti alle età, per quanto mi riguarda il lavoro è in corso… L’approccio alla Shoah richiede che noi adulti lavoriamo insieme, serve un approccio multidisciplinare e un confronto che ci aiuti trovare insieme… “la misura”. L’incontro con la Shoah, allora, può diventare un’occasione di crescita importante, in primo luogo, proprio per noi adulti. E per i ragazzi un’esperienza di promozione del pensiero, muovendo dall’ascolto e dall’esplorazione delle proprie emozioni: una vera e propria iniziazione alla conoscenza di sé e del mondo. ALESSIA - 6 Jerry Spinelli, Misha corre, Mondadori, Milano, 2004 (p. 69-70) Va l t e r Ba r u z z i 66 © Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna Servizio Comunicazione, Relazioni esterne e Cerimoniale Grafica e impaginazione Centro grafico dell’Assemblea Legislativa Stampa Centro stampa dell’Assemblea Legislativa finito di stampare nel mese di marzo 2007
Scarica