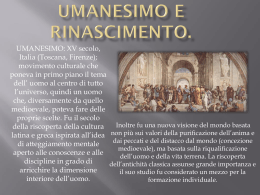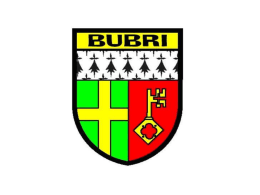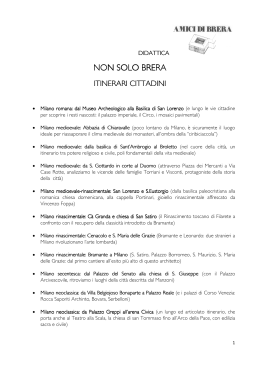Alla scoperta del bestiario medievale 30.09.2014 Dott.ssa Ulrike Kindl Siamo giunti, ormai, al mondo medioevale, un periodo di cruciale importanza in Europa: il Medioevo è davvero l’”età di mezzo”, la giuntura tra l’immensa eredità classica greco-romana e il Rinascimento che getta le basi dell’Europa moderna. Il Medioevo raccoglie ed elabora gli impulsi provenienti sia dal mondo mediterraneo sia da quello nordico celto-germanico, crea una nuova civiltà raffinatissima basata sia su evolute tecniche culturali, avute in dono dalle civiltà antiche, sia su sistemi di pensiero di altissima spiritualità, ereditati dai filosofi greci e dai padri del primo cristianesimo bizantino. Il Medioevo, lungi da essere stato un periodo “buio”, era, tutt’al contrario, il primo sogno di un’Europa unica, unita e universale, uno spazio culturale multiforme e in contempo omogeneo, espressione di un occidente colto, curioso e creativo, profondamente inserito nell’ideologia cristiana, ma aperto all’”altro”, che sia “meraviglioso”, “estraneo” (nella doppia accezione di strano e straniero), oppure anche “demoniaco”: il Medioevo era fermamente convinto che esistesse il diavolo e ne aveva una paura ancestrale, ma non fu del Medioevo l’aberrante persecuzione di fenomeni ritenuti “diabolici”. La spiritualità medioevale era radicata profondamente nella fede e nella fiducia in Dio, venerato come il Sommo Bene, il “Redentore” che non avrebbe mai permesso al Maligno di prendersi una vittoria definitiva sull’umanità, né di sguinzagliare un esercito di spiriti impuri per sovvertire l’ordine sacro della natura. Il credente si sapeva protetto dalla grazia divina, confidava nella potenza invincibile della croce, il cui segno metteva infallibilmente in fuga ogni presenza del male. La tragica “caccia alle streghe” era, invece, il primo segno di crisi della spiritualità medioevale: le streghe, per la religiosità popolare, sono sempre esistite, ma l’uomo medioevale aveva i suoi sistemi di protezione – non si sarebbe mai sognato di poter togliere “il male” dalla faccia della terra, e men che meno tramite processi e roghi affidati ad una dubbia giustizia umana. L’imago mundi medioevale vedeva l’uomo impegnato con tutte le sue misere forze a camminare sulle vie del Signore; a combattere il demonio ci pensi il Cristo, solo a Lui è dato il potere di superare il Maligno. Veri e propri “secoli bui” furono invece, sotto l’aspetto di superstizioni para-religiose e di fenomeni settari, il Cinquecento e il Seicento, quando il grandioso sistema medioevale, incentrato sul pensiero simbolico, cedette il passo al nascente pensiero moderno, affidato alla logica della scoperta scientifica e del calcolo matematico. In quel passaggio di tempo, quando il vecchio credo incondizionato nella verità biblica non riuscì più a tacitare le irrequietudini della mente critica, e il nuovo credo nella razionalità sperimentale non aveva ancora preso in toto in mano la nuova imago mundi basata sulla completa “leggibilità” della realtà, quello fu il momento davvero “buio” di un’Europa non più medioevale, ma non ancora illuminista. Da sempre è il “sonno della ragione che crea mostri”, e il Medioevo non fu per nulla “anti”-razionale, e men che meno “irrazionale”: seguiva una ragione ferrea, quella della dottrina cristiana, che conosceva certamente il diavolo, il “mostro” per eccellenza, ma non ne era succube. Il pensiero dei Lumi non puntò mai sulla sconfessione della dottrina cristiana, né si scagliò contro la ragione della religione – disegnò solo confini molto nitidi tra le competenze della “ragion pura”, ossia la capacità della mente umana di accedere alla conoscenza, e la fede, ossia la convinzione intima che le ultime verità non siano accessibili alla mente, bensì solo all’anima. Per noi contemporanei, figli dell’epocale cambiamento dei parametri che ha consegnato il primato dell’interpretatio mundi al pensiero razionale delle scienze esatte, oggi è molto difficile “leggere” correttamente il linguaggio simbolico del Medioevo, non “anti-logico”, come già detto, bensì “analogico”: il problema di fondo è che il pensiero simbolico non si basa esclusivamente sul “logos” (= , in greco letteralmente il “verbo”, la parola; più in generale la capacità di esprimersi in un discorso sintatticamente corretto, il “pensiero”). Il simbolo affonda le sue radici più profonde nella potentissima antagonista della parola ovvero l’immagine (= in greco , “forma”, figura, immagine immateriale nel senso di “idea”; oppure , “quadro”, pittura, da cui la nostra “icona”, la rappresentazione materiale). La tradizione occidentale ha certamente elaborato un’impressionante capacità di analisi logica. È però pressoché analfabeta se guardiamo la capacità di comprensione iconica e men che meno quella eidetica: non conosciamo, in altre parole, la sintassi delle immagini. Ci siamo abituati ad avvicinarci alla straordinaria visualità dell’arte medioevale in chiave esclusivamente artistica, ossia in una chiave di lettura “moderna”, sotto l’aspetto della qualità pittorica e/o tecnica, senza prendere in debita considerazione che l’arte medioevale non era semplicemente un’espressione della creatività artistica, bensì un sistema di culto: l’arte medioevale è sacra, sempre, anche quando rappresenta oggetti profani. Il binomio di “sacro” e “profano” rappresenta, per un sistema altamente simbolico come lo fu il pensiero medioevale, solo un’alternanza ritmica, una cadenza, comunque sempre circolare, dell’intero sistema cosmico, in armonioso equilibrio tra i poli estremi declinati secondo la visione dell’analogia “sicut in cælo, et in terra”1. Mostruose creature e figure grottesche sono giunte sino a noi, per esempio grazie agli affreschi romanici della chiesetta di Castellaz a Termeno, oppure ai maestosi portali in marmo di Castel Tirolo. Oltre a rappresentare una galleria d’arte di eccezionale valore storico, quale “messaggio” ci invia il concreto contatto visivo con quel linguaggio cifrato? Una cosa è certa: non si tratta di vedute di una qualsivoglia “realtà”, bensì di visioni di una verità dietro le sembianze. Il duopolio tra logos e eidos domina il pensiero occidentale fin dall’antichità più arcaica e non fu solo il possente divieto del Dio giudaico-cristiano che ordinò nei primi comandamenti del Decalogo di “non farsi idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra ...” (Esodo 20, 4-5). Anche il pensiero filosofico greco, sebbene la civiltà classica mediterranea fosse in sé assai incline alla figuratività, spostò con Platone il concetto di eidos sulla natura “essenziale”, ossia invisibile delle cose. Le idee (“eide”) di Platone non sono affatto delle “immagini”, tutt’al contrario, sono modelli astratti eterni, la causa del mondo percettibile che ne è solo la pallida copia, l’”ombra” di ciò che esiste separatamente dal mondo visibile su cui ragionare, mentre sono le idee le vere categorie del pensiero, unico strumento capace di indagine logica. Platone comunque non condannò con la stessa furia iconoclasta, con cui tolse alla percezione visiva ogni valore conoscitivo, il concetto di mythos, salvando così almeno la veridicità dell’immagine narrata, il racconto delle tradizioni. L’Europa medioevale ereditò la diffidenza verso l’immagine sia dalla sua origine cristiana, sia da un certo filone della tradizione classica e di seguito ebbe per oltre duemila anni un atteggiamento assai incerto nei confronti del fenomeno figurativo. Che il Dio dell’Antico Testamento avesse ben donde per temere l’idolatria, ossia la “venerazione di immagini”, si comprende dal fatto che la rivoluzione monoteista faticò non poco ad imporsi su culti politeistici e multiformi, dediti quindi al culto di idoli, simulacri ed immagini sacre. Se non ci fosse stata la saggia presa di posizione di papa Gregorio Magno che sottolineò la funzione didattica della rappresentazione figurativa, il “racconto per immagini”, ed autorizzò quindi di conseguenza almeno l’illustrazione della storia sacra in quanto litteratura illiterato, probabilmente la gloriosa storia dell’arte medioevale e più tardi del Rinascimento sarebbe stata soffocata ancora prima di poter muovere i primi passi. Più tardi la dottrina della Chiesa elaborò teorie sofisticate sulla natura dell’immagine, distinguendo a dovere tra il signum e il signatum, ossia tra il disegno reale, concreto e materiale, l’imago potenzialmente sacrilega e il concetto vero ed invisibile a cui la figura, l’immaginazione divenuta opera pittorica, si riferisce e a cui allude, senza però mai essere in grado di rappresentarlo per davvero. La venerazione cultuale non è diretta quindi alla pictura, bensì alla somma verità invisibile dietro l’immagine e che cosa è l’intero mondo visibile se non visione dell’invisibile? Per il pensiero medioevale tutto era simbolo e metafora dell’unica verità percepibile solo in ispirito: di conseguenza la sensibilità di leggere la realtà in chiave analogica creò una vera e propria estetica dell’invisibile, in perenne oscillazione tra imago e figura. “La verità è immagine”, si può riassumere il contenzioso, “ma non esiste un’immagine della verità”. Più subdola era l’insinuazione, ereditata dalla filosofia idealistica, che l’immagine in quanto tale non fosse in grado di contribuire all’indagine conoscitiva razionale, essendo l’opposto e l’antagonista del logos. L’immagine, secondo tale convinzione, potrebbe al massimo visualizzare contenuti astratti complessi, servire dunque a mo’ di exemplum, di illustrazione descrittiva ed esplicativa, oppure di integumentum, di rivestimento figurativo tramite la capacità di rappresentazione del reale per trasfigurarlo in allusione analogica del vero. Nemmeno l’empirismo illuministico riuscì a debellare l’ormai granitico pregiudizio in confronto all’intelligenza percettiva, in parte forse dovuto all’incredibile complessità della percezione visiva stessa. Infatti, nessuno vede le cose come sono, perché non è l’occhio lo strumento che elabora l’immagine riflessa, bensì la mente, che ricostruisce l’immagine percepita secondo i paradigmi dell’archivio visivo stratificati dall’impronta culturale2. È l’atlante delle immagini che ci dice come dovrebbe apparire la realtà e che condiziona con i suoi precetti la nostra capacità di “farci un’immagine” del mondo - ed esiste sempre un’altra possibilità di vedere l’ordine delle cose. Dare forma a fatti al di là di ogni possibilità di immaginazione è comunque un bisogno antropologico, a Cfr. Hans Belting, Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, C.H.Beck, München 1990. Trad. it. Il culto delle immagini. Storia dell'icona dall'età imperiale al tardo Medioevo, Carocci, Roma 2001 Mircea Eliade, Le Sacré et le profane [1956], trad. it.: Il sacro e il profano, Bollati Boringhieri, Torino 1973. 2 Cfr. Ernst H. Gombrich, Art and Illusion [1959], trad. it. Arte e e illusione. Studi sulla psicologia della rappresentazione pittorica Einaudi, Torino, 1965 1 2 cui risponde - sempre nell’ambito dell’atlante delle immagini elaborato dalla mnemosyne, dalla memoria culturale collettiva di una civiltà - l’unica potenza mentale capace di “con-fondere” logos ed eidos, parola e forma, il verbo e l’idea: il mito. L’immagine narrata, ovvero la narrazione immaginifica del mito crea l’orizzonte visionario su cui proiettare le nostre congetture relative ad avvenimenti nel vero senso della parola “in-immaginabili”. Non sappiamo darci né un inizio né una fine, se non tramite le immagini narrate del mito, non disponiamo di altri strumenti per intuire i destini del mondo, alla luce delle quali ognuno di noi misura il fato e la propria fortuna. Il mito, in altre parole, è alla base della convivenza tra il sacro e il profano, è l’immagine del tempo prima del tempo. Il mito è una categoria antropologica universale, non esiste un popolo su questa terra che non abbia un suo patrimonio peculiare di racconti mitici: miti che narrano le origini dell’universo, degli dei, dell’ordine sociale; miti che offrono delle immagini che diano forma all’horror vacui, alle paure ancestrali, alla percezione della finitezza dell’uomo davanti al mistero dell’eternità. La nostra cultura occidentale dispone in linea di massima di tre grandi bacini della memoria da dove attingere alle immagini di volta in volta più appropriate per districarsi nei meandri della mente, e cioè dell’eredità classica grecoromana, della tradizione giudaico-cristiana e del mondo celto-germanico, la cui remota irrequietezza ai margini dell'antico impero era fin dal momento della sua irruenza sulla scena della storia europea carica di un sottile fascino ambiguo. Il codice d’accesso a questo enorme tesoro di saperi stratificati segue però un percorso non per parole, bensì per immagini, perché il primo linguaggio del pensiero non “parla” attraverso segni di lingua, ma “vede” il valore iconico dei simboli. Dalla memoria più profonda non affiorano discorsi, bensì solo “visioni” di immediata verità, ma non decifrabili con la logica della lingua. Solo la percezione iconica, capace della stessa immediata sensibilità dovuta alla nostra filogenesi culturale, offre una possibile chiave di lettura3. Sarà poi il gesto narrativo la potenza creatrice che piega la carica iconica polisemantica alla necessità di s-piegare il simbolo e di trasformare il mistero in un’immagine narrata, in una storia di segni che sappia creare quella distanza tra l’animo umano e il mondo esterno che garantisce l’insorgere di sistemi fondanti di orientamento. Non importa se agli inizi vi fu il nulla, solo “abisso e tenebre” (Genesi 1, 1-2), oppure il caos indistinto e l’amplesso sempiterno tra Gaia e Urano (Teogonia di Esiodo), oppure le gocce del ghiaccio primordiale sciolte dalla vampa di Muspelheim, l’ambiguo luogo del fuoco primigenio (Miti nordici), per citare solo qualche esempio tra i miti cosmogonici più noti e diffusi; si tratta sempre di immagini potentissime dell’inizio che narrano il mistero dell’avvio della creazione, la nascita dell’ordine spazio-temporale, di cui la nostra attuale teoria del Big bang è nient’altro che l’ultima versione. L’immagine di per sé però non narra, non descrive né dimostra alcunché; l’immagine, semplicemente, è. Esiste come puro atto fenomenico e solo dopo essere passata per i filtri della percezione umana, inizia la sua vita di segno iconico caricato di significati. Ci vuole il demiurgo che metta ordine nel flusso caotico ed ininterrotto della palingenesi visiva, che fermi il vortice tramite la potenza del verbo strutturante, il logos. Senza le coordinate di un sistema mentale che divide e discerne tra due opposizioni non può formarsi, né affermarsi il pensiero logico; non bisogna mai dimenticare che quell’atto fondamentale della cultura conoscitiva umana affonda le sue radici più profonde in un mare magnum di immagini al di là di ogni governabilità tramite il logos. Il Dio Creatore, che riuscì ad incanalare l’ancestrale caos eterno in materia ordinata e comprensibile tramite la pronuncia delle giuste parole sacre, ossia, tramite l’invenzione del mito, conosce benissimo il potere temibile dell’immagine evocata affinché dal caos nasca una storia. Il mito, secondo la definizione di Elémire Zolla, è immagine narrata caricata di significati remoti, palinsesto di simboli, nesso “tra il creatore e il creato, punto di incontro fra eternità e tempo: esso cela e rivela nello stesso, identico istante”. Aveva le sue sacrosante ragioni, quindi, il nostro Padre Eterno, quando vietò all’uomo creato a Sua immagine e somiglianza in modo severo e perentorio di farsi immagine alcuna. Ma è sempre il mito che rende possibile tramite le sue grandi immagini il culto della memoria, il ricordo di quell’attimo traumatico quando avvenne lo strappo tra l’eterna sfera numinosa e il mondo sottoposto ai ritmi della misura limitata concessa al genere umano, e sono sempre immagini che affiorano alla mente, per dare forma a qualcosa che forma non ha. A questo punto le immagini narrate dai nostri grandiosi miti – di cui la Genesi è il paradigma fondante durante l’intero periodo medioevale – cede il passo al simbolo, immagine muta, ma gravida di significati, il cui messaggio è affidato all’enigma iconico, alla peculiarità dell’immagine di essere evidente e in contempo indecifrabile. Il simbolo, diverso dall’allegoria, non spiega nulla, nemmeno a chi crede di possedere i termini colti di confronto, né allude a qualche senso recondito racchiuso in un involucro metaforico. Il simbolo evidenzia un contesto ignoto: non segue quindi la logica dell’esempio, 3 Cfr. l’opera di Aby Warburg, Der Bilderatlas Mnemosyne [1929, rimasto incompiuto]; trad. it.: Mnemosyne. L’atlante delle immagini, a cura di Martin Warnke e Claudia Brink. Premessa all’edizione italiana di Nicholas Mann, Aragno, Torino, 2002 3 bensì quella dell’equazione. In origine, un simbolo (dal greco , “segno di riconoscimento”) era un oggetto concreto e tangibile, importante per la prassi giuridica antica: a conclusione di un accordo o di un’alleanza un tempo le due parti spezzavano il symbolon, di norma un anello, e ognuna delle due parti ne conservava una parte. In caso di contenzioso, il perfetto combaciare dei due pezzi di nuovo congiunti provava l’esistenza dell’accordo. La funzione del symbolon, diviso e disperso, era quindi quella di rendere visibile un complesso atto sociale, di provare l’esistenza di un patto. La moderna accezione di simbolo ha ereditato dall’antica radice il concetto del “mettere insieme” due parti, che però non sembrano ricomporsi perfettamente in un’unica idea, tutt’al contrario. Un simbolo dovrebbe essere la fusione funzionale tra un segno figurativo e il contenuto cifrato nella figurazione, ossia tra significato e significante, cosa che nell’ambito della comunicazione linguistica funziona a meraviglia. Cercando di venire a capo del groviglio simbolico, il meccanismo però si inceppa, visto che il significato del simbolo segue la logica del pensiero, il “senso”, mentre il ruolo del significante è affidato all’immagine, la cui grammatica è iconica e non discorsiva – e la grammatica delle immagini, come già visto, è ignota. Il simbolo unisce quindi proprio i due grandi contendenti di sempre, logos ed eidos, il verbo e l’immagine, esattamente come il mito, ma in forma ancora più stringente, perché l’intera intenzione comunicativa del simbolo è affidata, senza filtri, all’immediatezza dell’immagine. Nessun’altra figura se non il simbolo evidenzia con tale potenza la capacità dell’immagine di funzionare come strumento conoscitivo, certamente non logico, bensì analogico, affidato all’immediata illuminazione percettiva quando il fulmine della visione colpisce nel segno. Non conosciamo la logica non-predicativa della sintassi iconica, ma è assai probabile che il “filo di Arianna” per comprendere il complesso disegno dei labirinti mentali lo fornisca il già citato Atlante delle immagini: il simbolo, o meglio la imago simbolica, segue la stratificazione del palinsesto, ossia del piano originale continuamente riformulabile in un contesto di estrema mobilità all’interno di un contenitore fermo. Il supporto iconico, l’immagine in senso concreto di impressione visiva codificata in un quadro, una pictura, è nient’altro che una specie di pergamena, per restare all’interno delle analogie evocate dall’accezione di “palinsesto” (in senso stretto un antico codice la cui prima scrittura viene raschiata per porvi una seconda, o terza, riscrittura). Per quanto attento fosse eseguito il lavoro di cancellazione, sul foglio rimane un’inevitabilmente ombra del testo ivi presente prima, talvolta ricostruibile, il più delle volte però sepolto sotto i nuovi segni impressi, e al filologo resta da fare solo la constatazione che, comunque, quel codice è stato riutilizzato, formulando qualche ipotesi sul come, quando e perché. Affrontiamo ora, alla luce di quanto detto sopra, lo straordinario programma iconico della chiesetta di San Giacomo a Castellaz, sopra Termeno. Il piccolo tempio in purissimo stile romanico, in posizione panoramica sopra la Val d’Adige, è documentato esplicitamente a partire dal 1214; secondo leggende non confermate sarebbe sorto sulle tracce di un primo santuario cristiano, eretto a sua volta sulle fondamenta di un antico tempio dedicato alla dea Iside. La congettura potrebbe essere anche verosimile, ma non deve interessarci più del dovuto. Il patrocinio, dedicato all’apostolo Jacobus (Giacomo o Jacopo, detto il “Maggiore”) rivela che la chiesetta vegliava sulle rotte dei pellegrini in viaggio verso Santiago di Compostela, una delle mete predilette dei pellegrinaggi medioevali. Ad ulteriore conferma di questo dato troviamo nel complesso di ampliamento tardo-gotico notevoli affreschi del 1441, che rappresentano il cosiddetto “Hühnerwunder”, il “miracolo dei polli”, riferito ad una nota leggenda diffusa tra i pellegrini sul sentiero di Santiago. La leggenda narra che una pia famigliola in pellegrinaggio verso Santiago pernottò in un albergo a Santo Domingo de la Calzada (tappa obbligata sulla rotta, nella Spagna settentrionale). La figlia dell’oste si innamorò del bellissimo figlio della coppia, che rifiutò però – fedele al voto di castità durante il pellegrinaggio – le offerte amorose. La ragazza, offesa, giurò di vendicarsi e nascose un prezioso bicchiere d’argento nella saccoccia del giovane. Partita la famiglia di pellegrini, la figlia dell’oste gridò al ladro, fece catturare il giovane e lo accusò di furto. Il giudice di Santo Domingo, convinto della colpa del giovane, lo fece impiccare, nonostante i disperati appelli dei genitori, convinti invece dell’innocenza del figlio. Tristi e abbattuti, i due vecchi completarono il pellegrinaggio e implorarono l’aiuto di San Giacomo. Ritornati a Santo Domingo trovarono il figlio ancora vivo sulla forca, perché il Santo reggeva i piedi del condannato, tenendolo in vita. I genitori si precipitarono dal giudice, che si stava mettendo a tavola, e raccontarono il miracolo, chiedendo grazia per il giovane. Il giudice, incredulo, indicò due polli in padella davanti a sé e scosse il capo. “Vostro figlio è morto come questi polli arrostiti”, disse ai due pellegrini, ma non ebbe ancora finito di pronunciare la frase, che i polli si alzarono dalla padella, cantarono allegramente e si alzarono in volo. Basiti, tutti quanti si recarono alla forca, dove, in effetti, il giovane impiccato era vivo e vegeto, impegnato a recitare ad alta voce la lode di San Giacomo. 4 Meno “leggibile” è il grandioso ciclo pittorico dell’abside, ascrivibile al periodo attorno al 1220, eseguito da maestranze di alta qualità e di notevoli capacità artistiche. Il programma iconografico degli affreschi, certamente ideato da un chierico coltissimo, raccoglie il testimone da antiche tradizioni ermetiche, tutte improntate sul principio della Cosmogonia, rivista alla luce dell’interpretazione del tempo escatologico cristiano: il tempo della Salvezza. Fedele al precetto medioevale, che “il visibile non è altro che il riflesso dell’invisibile”, l’abside “rispecchia” l’imago mundi del Duecento, la visione simbolica di un’unità terrena e in contempo numinosa, immersa in un tempo sospeso tra la verità eterna e la realtà sofferta di una creazione già redenta, ma ancora impura. Si nota, a prima vista, la chiara tripartizione del “racconto” iconico, sottolineata da appositi nastri decorativi e ulteriormente rafforzata da un sapiente impiego di colori-guida. Nella volta in alto, sublime, la Maiestas domini, indica ai fedeli l’assoluta certezza della Somma Verità rivelata, garantita dai simboli dei quattro evangelisti e dalla Gloria del Signore, seduto in trono e circondato dalla mandorla, il simbolo dell’universo creato da Dio. Preziosi bordi ornano il regno dei cieli e in contempo separano l’eternità dalla sfera delle storie umane. I due dipinti negli spigoli ai lati, a destra e a sinistra della volta, non sono più leggibili; studi di paragone con programmi iconografici simili suggeriscono la presenza di una scena-chiave della Genesi, ossia l’offerta di Abele, gradita a Dio, e l’analoga, non accolta offerta di Caino: il fatto generò il fratricidio per mano di Caino, secondo la tradizione ermetica il vero peccato originale della Storia Sacra. È da quel primo omicidio che il paradiso perduto si trasformò definitivamente in un inferno, bisognoso di redenzione e di grazia divina per il riscatto. La sottile fessura della finestra al centro della seconda fascia ricorda la solenne promessa di Dio che non avrebbe lasciato il mondo nella disperazione del peccato: da questa finestra, orientata esattamente al sorgere del sole per l’equinozio primaverile – l’Annunciazione di Maria, 25 marzo – un raggio di luce illumina l’intero abside, a ricordare il patto tra Dio e il suo popolo. Il Redentore è annunciato, il tempo della Salvezza può prendere l’avvio: gli apostoli, accoppiati in animata discussione, fanno da cornice alla luce celeste. Ai lati però, due strane figure ammoniscono i fedeli che sì, la Redenzione è già avvenuta, il mondo è salvo – ma lo sfondo di un ferale colore bianco pare salire dal terzo girone in basso, dove si aggirano ancora gli spettri dell’inferno, creature fantastiche, ibride come uomini-pesce e uominiuccello, un centauro, un cinocefalo. Chi sono questi due “guardiani” sulle soglie del mondo degli uomini, sospeso tra il regno dei cieli in alto e gli abissi dell’inferno in basso? La chiave di lettura la fornisce una delle due figure mitologiche, riconoscibile come rappresentazione del segno zodiacale del Capricorno. Durante il periodo governato dal Capricorno, il “pesce-capra”, il sole raggiunge il punto più basso dell’apparente eclittica, sosta un istante sul tropico invernale, per “rinascere” nel buio della notte, riprendendo la salita verso il tropico estivo, il massimo splendore della luce. Di conseguenza, l’analoga figura al lato opposto, di lettura più enigmatica, deve essere una rappresentazione del segno zodiacale in cui cade il solstizio estivo: La sirena-uccello, “specchio” del Capricorno. La simbologia di questa bellissima figura femminile veicola un vero e proprio groviglio di allusioni classiche, teologiche ed ermetiche – la coda serpentiforme esorcizzata dal nodo apotropaico, la testa di corvo con il becco invece del sacro ibis, mentre coglie il frutto proibito della vita e della morte ecc. – tutte incentrate però al mistero del tempo ciclico a cui soggiace il mondo. Quanti viaggi tra i due tropici del Capricorno e del Cancro dovrà percorrere ancora il sole lungo il percorso dello zodiaco, prima che il raggio salvifico al centro dell’abside, certezza dell’avvenuta redenzione e promessa dell’apocalisse purificatrice, possa annunciare finalmente la desiderata parusia, la “seconda venuta del Redentore”, il giorno del Giudizio e della vita eterna nella gioia del Paradiso rinato? 5 Il “tempo” grava con peso insopportabile sulle spalle delle due figure in basso, interpretate, in una chiava di lettura per nulla peregrina, come la rappresentazione della coppia dei progenitori, Adamo ed Eva. Il codice iconico, polisemantico e multistrato, invia però a ben altri “archivi di immagini”, riconoscendo nella figura maschile il titano Atlante, punito da Zeus per essersi alleato con Kronos, durante la ribellione di Zeus contro il padre. Per i romani, Kronos-Saturno, il Signore dell’età d’oro, si ritirò dopo la sconfitta nel regno di Giano, la divinità bifronte del tempo, dove risiede tuttora governando, d’accordo con Giano, il “momento propizio”. Atlante, intanto, regge la volta del cielo, aspettando il momento della liberazione dal pesante fardello, ossia la fine del Tempo (= Chronos). Innumerevoli cicli dovranno susseguirsi sulla terra, prima che la coppia di titani possa togliere il sostegno e il cielo inizi a precipitare sulla terra, secondo i segni che annunciano l’inizio dell’Apocalisse. Intanto “madre Terra”, Eva, la controfigura di Adamo, nutre il secolo, aiutata dalle Pleiadi, figlie di Atlante e portatrici di pioggia feconda, e custodisce il mistero delle Esperidi, sempre figlie di Atlante, chiamate a vegliare i pomi d’oro nel giardino fatato di Era, il paradiso perduto della mitologia greca. Di più complessa lettura è la fascia più bassa, dedicata alla rappresentazione di un mondo infernale: non si vedono, però, diavoli o dèmoni della consueta iconografia medioevale, bensì uno “specchio” assai originale di un mondo fantastico, le cui fonti ed origini non sono del tutto chiare. Chiunque abbia ideato la scena della lotta tra creature ibride qui raffigurata, deve essere stato un uomo di vaste letture, nonché di sicura esperienza iconografica. Per creare visioni immaginifiche di tale livello, l’ignoto autore ha certamente considerato vari codici del Physiologus, in origine una specie di “Bestiario”, ossia una descrizione simbolica di animali, piante e pietre, i cui significati metafisici rimandano a citazioni delle Sacre Scritture oppure a convinzioni dell’imago mundi antica. Il Fisiologo greco (attorno al IV sec. d.C., di autore ignoto), tradotto attorno al primo millennio in latino, ha avuto molta fortuna, e di conseguenza moltissime imitazioni, tra cui tanti codici miniati, spesso di fattura assai pregevole 4 . Alla zoologia fantastica è senz’altro ascrivibile la scena di lotta tra una sirena (a forma di uccello con coda pisciforme) e un centauro, ambedue – secondo il Fisiologo – creature ibride e quindi infide, simboli di dottrine eretiche e di assiomi fasulli. La sirena, forte di un serpente malefico, si accapiglia con un centauro, aiutato a sua volta da un uomo-pesce che tende l’arco contro la megera, caratterizzata da un cosiddetto “copricapo frigio”, segno di un’indole spergiura e menzognera. Un mostriciattolo dalle orecchie di volpe (allusione alle mille astuzie ingannevoli di cui è padrona la volpe) si avvicina di soppiatto, evidentemente pronto ad aizzare i contendenti. Seguendo la traccia del Fisiologo, il messaggio potrebbe essere dunque un ammonimento a non cadere nei “vizi dello spirito”, soprattutto di non cedere ai richiami pericolosi delle sirene che – in allusione al celebre incontro tra Ulisse e quelle figure dal canto tanto soave quanto mortale – cercano di confondere i fedeli con dottrine eretiche e fuorvianti. Dovrebbe, quindi, rispondere dalla parte del semicerchio destro, un’allegoria dei “vizi del corpo”. Infatti, l’intera galleria delle creature fantastiche di questo gruppo è immersa nel “mare delle passioni”, soprattutto l’osceno cavaliere sul delfino, lascivo simbolo di Afrodite, attaccato da un mostro marino bicaudato, incitato da un altro essere spurio a pratiche certamente non consone all’insegnamento della Chiesa. Non manca, nel bel mezzo dell’orgia sfrenata, una sirenetta bifida, il cui sguardo severo sembra ammonire i fedeli di non perdersi nei pericoli della concupiscenza carnale, ma di serbare la potenza genitrice con decoro e pudore: infatti, il grembo della sirena è chiuso. Figure ai lati come il mostro cinocefalo (in lotta con un mostruoso 4 Cfr. Il Fisiologo, a cura di Francesco Zambon, Adelphi, Milano 1975 6 serpente) oppure lo sciapode rimandano, oltre che alla fauna allegorica del già citato Fisiologo, a testi classici, p.e. alle descrizioni etnografiche di Erodoto oppure alla Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, che favoleggiano di creature simili nei regni al limite dell’orbis terrarum, nelle Indie oppure nei deserti orientali. Lo straordinario programma iconografico di Castellaz offre quindi una specie di “palinsesto” della mnemosyne medioevale: citazioni delle Sacre Scritture, ricordi dell’eredità classica, nonché l’erudizione della tradizione scolastica si fonde in un unico affresco di immediata presenza e forte suggestione. Certamente l’umile fedele di allora non “leggeva” tutti i significati incrociati contenuti nell’abside, e non era nemmeno necessario. La percezione del mondo medioevale era allenata a “vedere” simboli: ogni chiesa era una preghiera fattasi pietra, e ogni figura presente in essa non poteva essere altro che un segno visibile della verità invisibile5. Assai diverso, e più complesso ancora, si presenta il problema della sintassi iconica in caso di opere composite, ossia quando non possiamo riferirci alla certezza che alla “sponda” della realizzazione iconica (= il significante) corrisponda un’idea mitopoietica (= il significato) ben radicata nel sistema vigente di allora. Il programma iconico dell’abside di Castellaz ci mostra un caso esemplare di coerenza e di volontà illustrativa dell’imago mundi duecentesca, dovuta ovviamente al fatto che l’intero disegno degli affreschi deve essersi basato su un progetto studiato nei minimi dettagli, compresa l’attenzione agli spazi disponibili, all’orientamento del sacro vano e alla simbologia dei colori impiegati. Questo caso non è dato per altre opere d’arte figurativa medioevale, realizzate p.e. in altre tecniche (soprattutto scultura) oppure la cui conclusione si è protratta per tempi diversi e spesso assai lunghi. Non vi può essere dubbio che pure in tal caso la carica simbolica dell’artefatto era “evidente” al pubblico di allora; ma per noi posteri, la cui chiave di lettura del mondo affonda le sue radici ormai da secoli nella razionalità illuminista, il senso di queste figure isolate (spesso creature fantastiche e/o mostri) resta spesso enigmatico, come se fossero “glifi” di un alfabeto, il cui valore equivalente è andato perso. Un esempio emblematico sono p.e. i due portali marmorei all’interno di Castel Tirolo (datati attorno al 1140), tra i capolavori massimi della scultura romanica in tutta la zona alpina, il cui programma iconografico originario è però quasi illeggibile. La tesi prevalente fino a poco tempo fa postulava maestranze probabilmente provenienti dalla pianura padana (in primo luogo da Pavia), e con ogni probabilità, i due portali sono stati assemblati in epoche diverse, utilizzando singoli pezzi di reimpiego (= spolia) di provenienza diversa: questo procedimento è possibile ovviamente solo con manufatti di pietra scolpita, sarebbe impensabile per la realizzazione di decorazioni pittoriche. Al di là della spiegazione dovuta a tecniche e materiali, la “composizione” di elementi architettonici così importanti come lo sono i portali d’ingresso in luoghi di culto, non era però certamente lasciata alla sola esigenza di riutilizzare dei materiali preesistenti. Chi si assumeva il compito di realizzare il restauro, era perfettamente consapevole della responsabilità non tanto verso il committente, quanto verso il Signore, alla cui gloria ogni azione ed ogni pensiero dell’universo medioevale era indirizzato. Lo documenta, per esempio, il caso del portale principale del duomo di Sovana (Toscana meridionale), la cui decorazione marmorea fu ricomposta a partire dal primo Duecento, riutilizzando materiali provenienti dall’antica chiesa preesistente, una delle arcidiocesi di epoca paleocristiana. Al centro del timpano, in posizione austera e predominante, è incastonata una lastra con l’iscrizione che descrive con tutti i dettagli il fatto della ricomposizione, menzionando pure il committente (e con ogni probabilità l’autore del rinnovato programma iconografico), il presul Petrus, probabilmente Pietro Blandebelli che fu vescovo di Sovana dal 1380 al 1386. Timpano del portale d’ingresso al duomo di Sovana. Al centro la lastra con l’iscrizione dell’avvenuta ricostruzione per opera del vescovo Petrus: NATUS IN URBE SENA/S ET PRESUL FACTUS IN ISTA/PETRUS UT HE JANUE/SIC FIERENT STUDUIT. 5 Cfr. Verena Friedrich, Tramin: St. Jakob in Kastelaz, Peda-Kunstführer 781, Kunstverlag Peda-Passau 2010; Ursula Düriegl: Die Fabelwesen von St. Jakob in Kastelaz bei Tramin. Romanische Bilderwelt antiken und vorantiken Ursprungs, Böhlau Verlag, Wien 2003. 7 Non sappiamo chi abbia creato i due portali di Castel Tirolo così come si presentano al visitatore odierno, né secondo quale “studio” specifico il maestro ignoto si sia mosso. Comunque, possiamo confidare nel fatto che le maestranze medioevali abbiano lavorato all’interno di un collaudato sistema di allusioni e richiami simbolici, per cui il messaggio principale risulterà senz’altro comprensibile, anche se ci sfugge inevitabilmente il significato di singoli particolari. Castel Tirolo sorge su un costone roccioso abitato fin dalla preistoria. Il primo insediamento fortificato risale al secolo XI: tracce di questa prima fase si trovano nei sotterranei del palazzo signorile e della cappella. La seconda fase di costruzione è datata 1139-1140; vi è rimasto il mastio con le mura spesse fino a 5 metri. Durante questa fase si colloca, con ogni probabilità, la ricomposizione dei due portali, utilizzando in parte spolia, in parte creando singole lastre “nuove” (ossia coeve) di eccelsa fattura. La terza grande fase di costruzione avviene sotto il conte Mainardo II, metà Duecento. Il castello rimase la residenza principale dei Signori di Tirolo fino al 1420, quando Friedl mit der leeren Tasche (il “Tascavuota”) trasferì la propria sede ad Innsbruck. L'attuale edificio e il camminamento risalgono ad epoca recente. Allo stesso periodo si fa risalire la sopraelevazione della cappella: la parte inferiore è consacrata a S. Pancrazio, quella superiore, riservata alla nobiltà, a S. Elisabetta d’Ungheria. Nel 1993, durante ampi scavi archeologici, gli esperti hanno scoperto una chiesa paleocristiana, o meglio: si scoprì poi che si trattava di tre chiese, costruite l'una sui resti dell'altra, la più antica delle quali risale alla tarda epoca romana. La seconda è invece del VI secolo, la costruzione più recente, a tre absidi, risale all’ottavo-novo secolo6. Notevoli sono i portali romanici del Palas e della cappella. Tra gli storici non c'è accordo sulla data e sull'origine di questi portali: per alcuni sarebbero addirittura – almeno parzialmente – da far risalire alla chiesa a tre absidi i cui resti sono stati trovati poco distanti, per altri commissionati dal conte Albert III (1189-1253)7. A parte le incertezze circa la provenienza dei marmi – in parte certamente materiali ricavati in loco (a Lasa), – non è stata finora possibile l’assegnazione dei singoli manufatti a scuole (ed epoche) precise. Di conseguenza, rimane irrisolto il problema del programma iconografico: il primo portale (ingresso nel Palas) è stato assemblato, forse, sotto il Leitmotiv del Paradiso (perduto?), il secondo (ingresso nella cappella), certamente secondo il tema della Redenzione tramite la Passione di Cristo. Osservando i portali è importante considerare la doppia valenza, divina e pagana, del linguaggio simbolico medievale. Alcune figure, animali o vegetali, possono rappresentare contemporaneamente entrambi i messaggi. Il tema del portale è governato dalla figura dell’Angelo, quasi certamente Michele (= “Chi è come Dio?”), i cui piedi poggiano su un accenno di trono. Austero, l’Angelo alza la mano destra in segno di benedizione (gesto di norma riservato al Redentore), indicando in contempo il Sommo Dio, Uno e Trino. Nella mano sinistra regge un bastone, sempre all’insegna della Trinità, pronto ad affrontare le schiere degli angeli caduti che alla fine dei tempi si muoveranno contro il regno dei cieli. Il programma iconografico attorno al portale pare essere incentrato sul tema della cacciata dal Paradiso (vedi in basso la presenza della coppia dei progenitori): costretti ad abbandonare la vita in stato di grazia, in assoluta armonia con Dio e l’intera Creazione, Adamo ed Eva perdono l’eterna beatitudine, senza preoccupazione e fuori dal tempo, e devono imparare a fare i conti con l’esperienza della fatica, della vecchiaia, della morte. La coppia, vestita già di tutto punto, lascia il Paradiso ed affronta, quindi, la cosiddetta “caduta nel tempo”. Da ora in poi, avrà inizio la Storia del mondo. L’ipotesi è rafforzata dalla cornice esterna composta di animali fantastici, la maggior parte dei quali sono riconoscibili come segni zodiacali (Toro, Ariete e Leone): si racconta, quindi, la Storia universale dell’uomo, inserito nella ciclicità del tempo profano, progettato però verso il destino finale, ossia il ritorno all’eternità del tempo sacro, dopo che l’arcangelo Michele avrà sconfitto il Drago. 6 Cfr. Martin Bitschnau, Walter Hauser, Baugeschichte der Burg Tirol im Hochmittelalter (1077/1100-1300). Vorbericht über die bauhistorischen Untersuchungen 1986-1994, in «Tiroler Heimat», 59 (1995), pp. 5–18. 7 Cfr. Gerhard Seebach, Die romanischen Portale auf Burg Tirol. Eine bauhistorische Untersuchung, in Eines Fürsten Traum. Meinhard II – Das Werden Tirols. Tiroler Landesausstellung 1995, pp. 79–93. 8 Meno enigmatico si presenta il programma iconografico del portale d’ingresso alla cappella, dominato dall’idea della Redenzione per opera della Passione. La scena-chiave della cornice in questo contesto è ovviamente il peccato originale (lastra con rilievo, in posizione centrale al lato destro), che segnò la frattura tra Dio-Creatore e uomo-creatura, e la perdita dello stato di grazia in cui si trovavano i progenitori. L’umanità, ormai, sarebbe irrimediabilmente condannata alla disperazione, se l’amore divino non avesse deciso di soccorrere i figli di Adamo ed Eva. In segno di somma pietà, la mano benedicente del Padre Eterno - (gesto identico presente nella figura dell’Angelo) - protegge l’insondabile mistero della Passione, per opera della quale le forze delle tenebre non avranno la vittoria. Figure fantastiche come il centauro – in contempo segno zodiacale del Sagittario e simbolo del pericolo di smarrimento eretico, – oppure configurazioni allegoriche come la visualizzazione della “forza d’animo” (la figura umana che spalanca le fauci del leone per strappare una vittima sacrificale alla belva), in contempo l’undicesimo Arcano dei Tarocchi, disegnano evidentemente una traccia a doppia lettura, sacra e profana, cristiana e pagana, fedele alle citazioni di esegesi biblica e in contempo allusiva a testi ermetici. L’ipotesi sembra confermata dalle tre figure al lato sinistro, che rappresentano, assai probabilmente, una lettura “a specchio” delle figure al lato destro. Al centauro, simbolo di dottrine eretiche e menzognere, corrisponde in basso a sinistra il Drago, il padre di ogni menzogna, che ha indotto i progenitori alla disubbidienza fatale (“… il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana” Apocalisse 12,9). Al centro, direttamente in relazione con il peccato originale, si vede la Bestia dell’Apocalisse, la maschera terrificante della ribellione a Dio, il segnale d’inizio dell’ultima battaglia (“Vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo.” - Apocalisse, 13,1). Alla “forza d’animo”, invece, non può che corrispondere il Leone del Cristo, Figlio di Dio, che con animo fermo ed infinita nobiltà di spirito ha affrontato la via della Passione per liberare il mondo dalla morsa del peccato. L’intero portale è armoniosamente strutturato tramite tre ordini di colonnine, decorate con stupendi motivi floreali – elementi decorativi e in contempo allusioni alle forze rigenerative della natura, oppure con antiche geometrie incrociate, sapienti reimpieghi di marmi in stile longobardo, in modo da “sigillare” i messaggi inviati al pio pellegrino, che potrà ora, affrancato dalla promessa di Redenzione, varcare la sacra soglia. Siamo quindi di fronte all’ennesima configurazione di profondi saperi, anche se non tutti i particolari del portale svelano la loro carica simbolica, veicolati da “visualizzazioni” del pensiero. Non è possibile “farsi un’immagine” della categoria del tempo, poiché sia quello sacro sia quello profano è un principio d’ordine, non una “realtà” come p.e. lo spazio. Il sistema simbolico medioevale reagì alla sfida di trovare un’immagine per raffigurare concetti che immagini non hanno, ricorrendo ad un’infinita varietà di evoluzioni, in un continuo processo iconico che usa il visibile per indirizzare la mente alla contemplazione dell’invisibile. Il patrimonio di questo incommensurabile “archivio delle immagini”, creato dall’arte figurativa medioevale, è fino al giorno d’oggi una delle più preziose eredità della cultura occidentale. 9
Scaricare