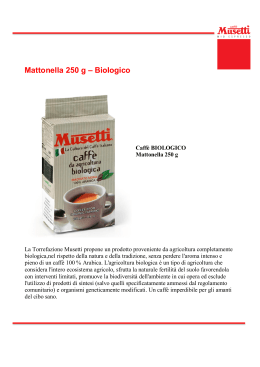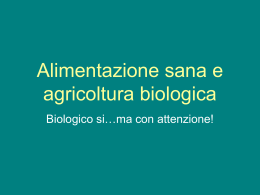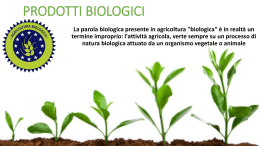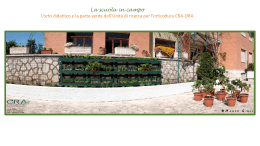Review n. 2 – Italus Hortus 12 (4), 2005: 31 - 44 L’orticoltura biologica: evoluzione, principi ispiratori e qualità dei prodotti Ferdinando Pimpini*, Giorgio Gianquinto e Paolo Sambo Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali, Università di Padova, Viale dell’Università 16, 35020 Legnaro (PD) Ricevuto: 4 luglio 2005; accettato: 22 luglio 2005 Organic vegetable production: evolution, base principles and quality of products Abstract. This paper is aimed to discuss the organic vegetable production and at the same time to highlight the critical points of this agricultural system in Italy. The organic surface has been increasing in Italy in the past decades but reached a plateau around the year 2000. In the past two years, the land destined to organic cultivation has stabilized around 1.0 million hectares and only 1% of this land is used to produce vegetable crops. Although Italy is still the first European producer of organic vegetables, in the last two years the cultivated area showed a reduction by 20%. There are several directing principles that characterize organic farming. They include biodiversity, integration, sustainability, natural plant nutrition, natural pest management and integrity. Each of those principles needs to be understood, respected and well applied in order to perform a real organic farming and not only a “substitution agriculture” based merely on the replacement of agrochemicals by organic compounds. One of the most important reasons encouraging consumers to buy organic products is the perception that organic food has better nutritional and quality traits. The analysis of the scientific literature available showed that only few researches were carried out following rigorous experimental criteria. In most of the experiments, only the nitrate content resulted clearly reduced by using organic procedures. Vague and sometimes contradictory results has been reported on nutrients and vitamins content. Several authors suggest that more researches are needed to asses the real effects of organic techniques in terms of quality of the product, in order to get more scientific data on this topic which at moment seems to be more discussed than effectively studied. Key words: cropping systems, sustainability, food quality. Introduzione A partire dalla metà degli anni ‘80, le preoccupazioni dovute alla presenza di residui tossici nei prodotti alimentari e all’impiego di tecniche ad elevato impatto, che possono incidere negativamente sull’ambiente, hanno visto l’affermarsi anche nel nostro Paese del concetto di agricoltura sostenibile. La maggiore sensibilità ambientale e di sicurezza alimentare è stata gradualmente assimilata in Italia, in seguito al nascere e allo svilupparsi di forti movimenti ambientalisti che hanno incominciato ad operare principalmente nei Paesi nord-europei a partire dalla fine degli anni ’60 - primi anni ’70. La presa di coscienza per questi temi da parte di una crescente fascia di consumatori e di produttori ha di fatto determinato un controllo più accurato del processo produttivo ed una maggiore oculatezza nell’uso di prodotti di sintesi. La diffusione di tecniche a minor impatto ambientale ha determinato la contrazione dei consumi di fertilizzanti, antiparassitari e diserbanti (fig. 1). Ciò è stato possibile grazie ad una maggiore attenzione nell’impiego di prodotti di sintesi nei momenti di effettiva necessità, all’applicazione di mezzi di lotta biologica e al ritorno a tecniche agronomiche più sostenibili. La maggiore attenzione e cautela nell’uso di fitofarmaci è testimoniata anche dai risultati dei controlli ufficiali sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale svolti dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Il riepilogo nazionale dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori pubblici nel corso dell’anno 2003, ultimi dati disponibili (Ministero della Salute, 2004), mette in luce che nel complesso i campioni di prodotti ortofrutticoli risultati non regolamentari sono stati pari all’1,8% del totale di quelli analizzati. Per quanto riguarda gli ortaggi, le irregolarità sono state l’1,7%; della quota restante (98,3%), l’82,3% è risultata priva di residui e il 16,0% è rientrata nei limiti previsti dalla legge, con maggiore presenza di campioni monoresiduo (13,1%), rispetto ai multiresiduo (4,6%). *[email protected] 31 Pimpini et al. Fig. 1 - Evoluzione dei consumi per ettaro di fertilizzanti e fitofarmaci in Italia nel periodo 1961-2004 e 1990-2001, rispettivamente (rielaborati da FAOSTAT, 2005). (*) compresi i battericidi. Fig. 1 - Evolution of fertilizers and pesticides consumption per hectare in Italy across the period 1961-2004 and 1961-200,1 respectively (re-arranged from FAOSTAT, 2005). (*) bactericides included. Confrontando i risultati dei programmi nazionali di controllo ufficiale sui residui nei prodotti ortofrutticoli a partire dal 1993, primo anno di attuazione del programma, risulta evidente come la percentuale di irregolarità negli ortofrutticoli abbia subito un progressivo decremento nel corso degli anni passando dal 5,6% del 1993 al 1,8% del 2003, con un lieve picco solo nel 2000 (fig. 2). Secondo il rapporto del Ministero tale risultato positivo è attribuibile: a) alle attività delle strutture centrali, e territoriali, ormai permanentemente impegnate nel controllo ufficiale in materia di antiparassitari in Italia, b) alla costante revisione in senso restrittivo operata dal Ministero della Salute su alcuni impieghi ammessi, c) ad una sempre maggiore consapevolezza degli operatori agricoli nell’impiego dei prodotti fitosanitari. Lo stesso Ministero sottolinea come il limite di legge sia determinato in maniera molto restrittiva e che quindi un suo lieve superamento occasionale non comporterebbe un pericolo per la salute. La stima dell’assunzione media di residui da parte del consumatore indica che questa rappresenta una percentuale molto modesta rispetto alle relative dosi giornaliere accettabili, di molto inferiori ai livelli di guardia indicati dal Ministero della salute (Ministero della Salute, 2004). Dall’orticoltura convenzionale all’orticoltura integrata e biologica Fig. 2 - Evoluzione delle percentuali di campioni irregolari risultati dal programma di monitoraggio nazionale per i residui di fitofarmaci in prodotti orto-frutticoli nel periodo 1993-2003 (fonte: Ministero della Salute). Fig. 2 - Evolution over time (1993-2003) of percentage of fruit and vegetable samples presenting pesticide residues above law threshold. Results from National monitoring program (source: Ministero della Salute). 32 La ricerca di una produzione sostenibile avviene attraverso l’adozione di pratiche agricole che fanno riferimento all’agricoltura integrata e all’agricoltura biologica. I sistemi di produzione integrata in orticoltura lasciano prevedere un possibile sviluppo e consolidamento nel loro impiego. Tale evoluzione consentirebbe di risolvere le problematiche legate al rifornimento di prodotti in quantità tali da soddisfare le richieste dei consumatori che, con sempre maggiore insistenza, si rivolgono verso la qualità, l’igienicità e la salubrità dei prodotti, nel rispetto dell’ambiente. Il settore, inol- L’orticoltura biologica tre, presenta aspetti peculiari che si contraddistinguono per elevata concentrazione territoriale e strutturale e consistente incidenza sull’economia agraria dei territori in cui sono realizzate. L’“integrato” può rappresentare un approccio razionale verso una produzione orticola in grado di soddisfare le esigenze di ogni classe sociale di consumatori garantendo, nello stesso tempo, buona redditività al produttore. Una volta raggiunto tale obiettivo, sarà necessario informare correttamente il consumatore attraverso la formulazione di disciplinari di produzione in grado di garantire la tracciabilità del prodotto. La definizione di tracciabilità viene data dal Regolamento CE 178/2002, con il quale vengono stabiliti i principi e i requisiti generali per garantire un alto livello di protezione della salute del consumatore ed un efficace funzionamento del mercato. Nel regolamento si definisce la tracciabilità come la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Se in un qualsiasi punto della filiera si riscontra una non-conformità dell’alimento, la tracciabilità deve consentire, a monte, di richiamare il prodotto già uscito dalla disponibilità dell’operatore e, a valle, il percorso a ritroso verso l’origine, per individuare le cause della non conformità e adottare le opportune misure correttive. Tale regolamento, tuttavia non è stato ancora completamente recepito o attuato a livello delle amministrazioni locali o delle organizzazioni di produttori, il che comporta, al momento attuale, l’assenza di un quadro normativo univoco e dettagliato. La garanzia di qualità può seguire diversi percorsi legati alla certificazione di prodotto e di processo (fig. 3). Una prima distinzione va fatta fra i “prodotti tipici certificati” e i “prodotti certificati”. Tra gli esempi più importanti di “prodotti tipici certificati” si ritrovano le DOP e IGP, afferenti ai Regolamenti Comunitari 2081/92 e 2082/92. Si tratta di marchi a difesa e valorizzazione di prodotti la cui qualità è storicamente legata al territorio. Anche se risulta spontaneo associare il concetto di tipicità a quello di biologico, nella realtà si tratta di due aspetti nettamente distinti; non sempre, infatti, i metodi di produzione definiti nei disciplinari DOP e IGP assumono a riferimento i vincoli legislativi della produzione biologica. Più frequentemente, anzi, tali disciplinari fanno riferimento a metodi produttivi vicini all’orticoltura integrata o addirittura convenzionale non indicando, in quest’ultimo caso, specifici protocolli di difesa e nutrizione. Quanto appena esposto, oltre che a fare chiarezza nella distinzione tra Marchio di Origine Geografica (prodotto tipico certificato) e Marchio di Produzione Biologica vuole anche focalizzare l’esigenza di una maggiore attenzione agli aspetti colturali dei prodotti tipici i quali se non al biologico dovrebbero, quanto meno, fare riferimento a metodi di produzione integrata in considerazione della naturale tendenza che spesso si osserva nel consumatore ad associare il concetto di tipicità con quello di salubrità. Nell’ambito dei “prodotti certificati”, un primo marchio di qualità è quello che contraddistingue il biologico con un chiaro riferimento normativo nel regolamento comunitario 2092/91. I prodotti derivati da agricoltura integrata trovano, invece, identificazione nei marchi afferenti alle certificazioni di processo e di prodotto. La certificazione di processo afferente alle normative comunitarie ISO o VISION, attraverso il controllo di organismi terzi, si propone di garantire la corretta esecuzione delle varie fasi relative al processo di produzione, garantendo che qualsiasi intervento venga eseguito nel migliore dei modi. Tale cer- Fig. 3 - Esempio di percorsi legati alla certificazione di prodotto e di processo. Fig. 3 - Example of different ways to certify products and processes. 33 Pimpini et al. tificazione accerta che tutti i punti critici della produzione siano affrontati in modo appropriato, ma spesso non entra nella valutazione della qualità del prodotto ottenuto. Per tale motivo appare di crescente interesse la certificazione di prodotto che si propone, invece, di certificare specifici aspetti qualitativi degli alimenti esitati sul mercato. In tale ambito possiamo inserire, oltre alla grande numerosità di marchi aziendali anche marchi collettivi che possono essere privati (es. associazioni di produttori, cooperative, consorzi) o pubblici (es. marchi regionali come “qualità controllata” dell’Emilia Romagna, marchi di “qualità certificata” della Regione Veneto) oltre alle produzioni afferenti al Regolamento comunitario 2078/92 e successivo 1257/99 adottato dalla quasi totalità delle Regioni, anche se con diversa adesione da parte del mondo operativo. Tale ampia variabilità di marchi, che pur afferisce nella stragrande maggioranza dei casi a tecniche integrate ecocompatibili, definite in specifici disciplinari, non aiuta a creare una immagine univoca di agricoltura integrata. In alcuni casi, infatti, si è tentato di sostituire i trattamenti con prodotti chimici a calendario con interventi conseguenti al superamento delle soglie di rischio (lotta guidata) o con una combinazione di tali trattamenti e l’uso di nemici naturali degli organismi dannosi (lotta integrata). In altri ambienti, oltre a tali interventi, si è fatto ricorso anche a tecniche preventive quali la scelta delle varietà e delle tecniche colturali più idonee a minimizzare l’impiego di fitofarmaci, intervenendo su tutte le fasi del processo, integrando tra loro le diverse tecniche colturali. Di conseguenza anche le normative indicate alle aziende sono state diverse; infatti, nel primo caso, sono state concentrate nel momento dei trattamenti antiparassitari, mentre nel secondo si sono estese a tutto il processo produttivo. Per quanto riguarda i settori merceologici, in alcuni ambienti, hanno interessato soltanto la frutticoltura, in altri alla frutticoltura si è aggiunto il settore zootecnico, in altri ancora alla frutta si sono affiancati vino, ortaggi, miele, itticoltura e zootecnia da carne. In ogni caso è da tener presente che, l’attenzione verso questo settore, è stata evidenziata da indagini condotte sugli orientamenti della GDO in relazione alle scelte di prodotto. Si è infatti accertato che, per tale importante canale di commercializzazione, la produzione integrata gioca un ruolo sempre determinante, sia per gli operatori italiani (60%) che per quelli europei (75%) ed è previsto un consistente sviluppo a condizione che il prodotto associ alle garanzie di sanità anche quelle di qualità organolettica e merceologica. A questo propo34 sito, molte catene della GDO già impongono degli standard ai fini della commercializzazione del prodotto. Tuttavia, mentre a livello nazionale tali standard vengono definiti dalle singole GDO, a livello europeo o internazionale è sempre più frequentemente richiesta l’osservanza degli standard imposti da consorzi di commercianti riconosciuti a livello istituzionale. Sono un esempio il British Retail Consortium (BRC) e l’Euro-Retailer Produce Working Group (EUREP), il cui obbiettivo è quello di sviluppare standard e protocolli per la certificazione dei prodotti ottenuti attraverso sistemi di buona pratica agricola. I numeri delle produzioni vegetali biologiche Il settore nel quale, con maggiore intensità dell’integrato, si identifica la orticoltura sostenibile, è rappresentato dal biologico. L’agricoltura biologica, pur avendo un peso relativamente limitato nel contesto dell’agricoltura italiana ed europea, è stata caratterizzata da un elevato tasso annuo di crescita. Negli anni ‘80 l’agricoltura biologica europea aveva una dimensione del tutto trascurabile finché gli Organismi comunitari, con il regolamento n. 2092/91 del Consiglio Europeo, hanno definito e quindi riconosciuto ufficialmente il metodo biologico delle produzioni vegetali, attivando anche un sistema di garanzie aggiuntive basato su controlli svolti da terzi. In seguito a questi provvedimenti si è verificata una crescita notevole, tanto che, al momento attuale, in Europa sono coltivati circa 5 milioni di ettari a biologico che coinvolgono circa 150 mila aziende. I regolamenti comunitari sulla materia hanno trainato il settore del biologico e, nel marzo del 2000, si è arrivati alla definizione del logo comunitario specifico, iniziativa che ha consentito di rafforzare l’immagine del biologico agli occhi del consumatore e di incidere maggiormente sulla valorizzazione di questi prodotti. L’agricoltura biologica costituisce un metodo di produzione basato prevalentemente sulla gestione delle risorse interne all’impresa agricola, privilegiando tecniche colturali “naturali”, rispetto a quelle basate sulla chimica di sintesi e sull’impiego massiccio di mezzi tecnici. Nel nostro Paese, tale settore, si caratterizza in tre elementi fondamentali: • superficie totale nazionale coltivata piuttosto modesta; • dispersione territoriale e settoriale; • articolata struttura associativa. Negli ultimi quindici anni, l’agricoltura biologica in Italia ha conosciuto uno sviluppo particolarmente L’orticoltura biologica Tab. 1 - Evoluzione delle superfici delle colture biologiche nel periodo 2000-2003 (MiPAF, 2005). Tab. 1 - Evolution over time (2000-2003) of the land under cultivation of organic crops in Italy (MiPAF, 2005). Superficie (ha) Anno 2000 2001 2002 2003 in conversione in regime biologico Totale 538.078 513.382 421.701 300.141 502.078 724.258 746.511 751.860 1.040.377 1.237.640 1.168.212 1.052.002 intenso, raggiungendo la massima espansione nel 2001 (tab. 1), anno in cui l’Italia è risultata essere il 3° paese al mondo ed il 1° in Europa per capacità produttiva. Negli anni successivi però si è assistito ad un ridimensionamento del fenomeno, con un calo delle superfici totali del 15%, registrato nel 2003, ultimi dati disponibili (MiPAF, 2005). La distribuzione del biologico si estende su tutto il territorio nazionale. La numerosità delle aziende supera di poco le 60.000 unità, pari a poco più del 2% del totale, con la massima numerosità (60%) ubicata nel Nord Italia, il 28% nel Centro e il restante 12% al Sud (ISMEA, 2003). Nell’ambito di tale drastica dispersione sul territorio nazionale dell’agricoltura biologica, che nel contesto generale del mondo rurale consolidato, presenta anche scarso peso numerico di aziende e di superficie totale coltivata, è parsa evidente la necessità di realizzare strutture associative di varia forma, con funzioni di promozione commerciale, di controllo delle azien- de, di rappresentanza nel contesto politico e, in alcuni casi, anche di dettare specifiche normative e gestire, sia dal punto di vista organizzativo che promozionale, il marchio biologico. Al momento attuale non sussiste ancora omogeneità di comportamento a livello nazionale, anche se è operativo un numero molto elevato di cooperative agricole oltre ad associazioni, coordinamenti e consorzi nazionali, provinciali e regionali, assistiti da associazioni e cooperative di tecnici. I dati MiPAF della SAU ripartita tra le diverse colture (tab. 2) confermano la tendenza emersa negli anni passati di una ripartizione della SAU ad agricoltura biologica fortemente sbilanciata a favore delle colture foraggere (53% della SAU), a cui seguono i cereali (20%). Tra le altre colture, una discreta diffusione si riscontra per l’olivo (8%), i fruttiferi (5%) e la vite (3%), mentre più limitato è il contributo delle colture orticole. La filiera delle produzioni orticole biologiche L’orticoltura rappresenta appena l’1,1 % della SAU complessiva biologica. Inoltre, tra il 2000 e il 2003 si è assistito ad una riduzione di circa il 30% delle superfici destinate a specie orticole (fig. 4). Tale fenomeno è dovuto, a differenza delle foraggere e degli altri seminativi, all’inadeguatezza dell’incentivo, proposto inizialmente dal Regolamento 2078/92 e successivamente recepito dai Piani di Sviluppo Rurale Regionali, rispetto alle perdite di reddito che si osservano in molti casi passando al sistema biologico. Al Tab. 2 - Superfici ed orientamenti produttivi delle colture biologiche (MiPAF, 2005). Tab. 2 - Land use for different organic crops (MiPAF, 2005). Superficie (ha) Orientamento produttivo Cereali Leguminose da granella Patate Barbabietola da zucchero Bietola da foraggio Colture industriali Orticoltura Fiori e piante ornamentali Foraggi Altri seminativi Fruttiferi Agrumi Olivo Vite Prati e pascoli Altro TOTALE in conversione in regime biologico Totale 56.195 4.317 158 102 102 7.696 2.585 26 74.738 3.319 15.766 5.834 24.792 11.439 83.837 9.236 153.181 7.345 730 3.887 215 24.617 8.769 75 222.259 5.838 36.448 10.915 61.410 20.271 179.165 16.734 209.376 11.662 888 3.990 317 32.313 11.354 102 296.997 9.157 52.214 16.749 86.201 31.709 263.003 25.970 300.141 751.860 1.052.002 35 Pimpini et al. Fig. 4 - Evoluzione delle superfici a colture orticole biologiche (ortaggi e patate) nel periodo 2000-2003 (MiPAF, 2005). Fig. 4 - Evolution over time (2000-2003) of land under cultivation of organic vegetables in Italy (MiPAF, 2005). momento attuale poi le Associazioni di categoria lamentano come la riforma della PAC in Italia abbia ignorato il settore dell’agricoltura biologica. L’orticoltura biologica è principalmente presente in Sicilia, Puglia ed Emilia Romagna, che nel complesso rappresentano circa il 60% della SAU orticola biologica nazionale. A livello nazionale gli ortaggi le cui superfici hanno un maggiore peso percentuale sono nell’ordine: pomodoro (545 ha di pomodoro da industria, 861 ha di pomodoro da mensa), pisello (1.173 ha) e patata (682 ha); a queste seguono asparago, carote, meloni, zucchine e carciofi (ISMEA, 2003). Per quanto riguarda il pomodoro, le varietà da industria sono maggiormente diffuse in Campania (126 ha), Lazio (115 ha) ed Emilia Romagna (108 ha) e le produzioni unitarie medie nazionali si attestano sulle 50 t ha-1; le varietà da mensa in Puglia (470 ha) ed Emilia Romagna (236 ha). Il pisello è maggiormente presente in Lombardia (373 ha), Emilia Romagna (276 ha), Marche (244 ha) e Toscana (161 ha) con una produzione unitaria media nazionale pari a 6,2 t ha-1. La terza coltura in ordine di importanza è la patata, concentrata per lo più in Sicilia (422 ha) che assorbe circa il 60% della SAU a patata biologica (produzione media nazionale di 28,2 t ha-1). Come si può dedurre da questa sintetica analisi, il settore biologico e l’orticoltura biologica in primis insiste su una superficie coltivata piuttosto modesta. La piccola dimensione rappresenta in verità la forza 36 Fig. 5 - Evoluzione dei prezzi all’ingrosso di alcuni prodotti orticoli nel periodo 9 marzo-17 giugno 2005. I prezzi dei prodotti orticoli biologici sono ricavati dalla “Borsa Ortofrutticola Biologica della CCIAA di Bologna” (CCIAA, 2005), quelli dei prodotti convenzionali dall’ “Osservatorio Prezzi Ortofrutta dell’ISMEA”(ISMEA, 2005). Fig. 5 - Wholesale prices of some vegetables during the period march 9th-June 17th 2005. Prices for organic produces has been recorded from “Borsa Ortofrutticola Biologica della CCIAA di Bologna” (CCIAA, 2005), while those for conventional produce from “Osservatorio Prezzi Ortofrutta dell’ISMEA” (ISMEA, 2005). L’orticoltura biologica del sistema, in quanto permette di spuntare sul mercato prezzi più elevati nei confronti del prodotto tradizionale (fig. 5). La crescita incontrollata del settore potrebbe portare al collasso per eccesso d’offerta. Piuttosto ampia ed articolata è la distribuzione merceologica degli ortaggi “bio”: i punti vendita del biologico offrono, a fianco ad ortaggi e frutta fresca, prodotti secchi (farine e legumi), prodotti da forno (paste alimentari, biscotto, crackers, altro), prodotti trasformati di origine sia vegetale (succhi di frutta, conserve, passate, succhi di pomodoro, olio di oliva, vino, aceto) che animale (formaggi e yogurt), prodotti conservati sott’olio (carciofini, aglio, fagiolini) e, infine, anche prodotti dietetici (crusche, pappe reali, miele). Tali realtà sono in grado di ottenere elevate quote di valore aggiunto esitando i quantitativi aziendali piuttosto modesti con modalità e canali diversificati come ad esempio agriturismo, spacci aziendali, vendita al dettaglio e, a volte, anche a domicilio. Tra i canali distributivi, sta emergendo con forza la grande distribuzione organizzata (ISMEA, 2003) che ha superato la quota del dettaglio specializzato con tutte le principali catene dotate di “label” privati per i prodotti biologici (es.: Esselunga Bio, Coop da Agricoltura Biologica, Agricoltura Biologica Pam, Sì naturalmente per Billa/Standa, ecc.). I concetti ispiratori dell’agricoltura biologica A questo punto risulta interessante tratteggiare brevemente i più importanti aspetti tecnici che caratterizzano l’agricoltura biologica. Diverse sono state le definizioni miranti ad identificare questo tipo di agricoltura ma quella che sembra la più appropriata per illustrarne al meglio sia la pratica che la filosofia di base è quella data dal National Organic Standard Board (NOSB, 1995) nel 1995. Secondo questa definizione l’agricoltura biologica è caratterizzata da “un sistema di gestione della produzione ecologico che promuove e sviluppa la biodiversità, i cicli biologici e l’attività biologica del suolo. Fa ricorso ad un utilizzo minimo di prodotti derivanti da attività extra-azienda li e a pratiche di gestione che ripristinano, mantengo no e stimolano l’armonia ecologica”. Su questa base non sorprende il fatto che l’agricoltura biologica ricada all’interno del grande ombrello dell’agricoltura sostenibile e che permetta quindi di conseguire notevoli vantaggi dal punto di vista ambientale, in termini di riduzione dell’erosione e della lisciviazione dei nitrati, e del risparmio energetico (Lockertz et al.; 1981, Drinkwater et al., 1998, Xie et al., 2003). Senza entrare troppo nei dettagli si può dire che tutta l’agricoltura biologica si basa su di una serie di principi/attività che devono sempre essere tenuti presenti. Tali principi possono essere identificati in: Biodiversità, Diversificazione e Integrazione, Sostenibilità, Nutrizione naturale delle piante, Controllo naturale delle avversità e Integrità. Biodiversità Come regola generale si può affermare che in natura ecosistemi molto vari presentano maggiore stabilità rispetto ad ecosistemi caratterizzati da poche specie. La stessa affermazione può considerarsi valida anche per gli agroecosistemi che risulteranno più stabili ed equilibrati quando saranno presenti molte colture diverse rispetto a quelli caratterizzati da monocoltura. Un agroecosistema equilibrato, come quello caratterizzante le aziende biologiche, ha maggiori possibilità di sostenere organismi utili in grado di favorire, per esempio, l’impollinazione e il controllo dei patogeni (Van Elsen, 2000; Bengtsson et al., 2005). Il concetto di biodiversità va poi molto spesso di pari passo con il concetto di diversificazione produttiva (molteplici prodotti esitati sul mercato) e la sostenibilità economica conseguente. Diversificazione e integrazione Molto difficilmente l’azienda biologica è un’azienda altamente specializzata. La presenza di numerose specie in coltura, dalle orticole alle foraggere, la produzione di cereali e l’allevamento di bovini garantiscono la disponibilità continua di prodotti per il mercato ed il conseguente costante introito per l’agricoltore riducendo anche i rischi di impresa. Altro aspetto positivo della biodiversità è quello di favorire un migliore ciclo dei nutrienti e vitalità del suolo (Carpenter-Bogs et al., 2000). Il ciclo dei nutrienti all’interno dell’azienda viene ottimizzato e il ricorso a input esterni viene ridotto al minimo. Sostenibilità In aggiunta alla maggiore sostenibilità economica legata alla diversificazione produttiva e alla flessibilità aziendale, i produttori biologici beneficiano anche delle sovvenzioni Comunitarie legate alla certificazione biologica. Non sempre tutto questo porta però a profitti maggiori per l’imprenditore biologico rispetto a quello convenzionale, essenzialmente perchè in zone non eccezionalmente vocate, le produzioni unitarie delle aziende biologiche sono basse. Dal punto di vista ambientale, la sostenibilità delle aziende biologiche è particolarmente elevata, come hanno dimo- 37 Pimpini et al. strato diversi indicatori quali il consumo di energia e la protezione dell’ambiente (Pacini et al., 2003; Elmaz et al., 2004). Quest’ultimo parametro è però molto spesso trascurato nella valutazione economica della sostenibilità che normalmente si basa sull’analisi costi-benefici (Flores e Sarandon, 2004). Nutrizione naturale delle piante In passato tra la maggior parte degli agricoltori biologici era diffusa l’idea che le piante assorbissero nutrienti sotto forma di molecole organiche (Hainsworth, 1976). La cosa si è rivelata assolutamente priva di fondamento e ha impedito per lungo tempo un dibattito serio sulla nutrizione in agricoltura biologica. Le principali differenze di opinione in tema di nutrizione delle piante tra gli agronomi “convenzionali” e quelli “biologici” non riguarda che cosa la pianta assorbe ma l’ambiente da cui le radici traggono il nutriente. Secondo Kuepper e Gegner (2004) il terreno dovrebbe essere immaginato come uno “stomaco” dove le sostanze vengono digerite prima di essere assorbite dalla pianta; la “filosofia” biologica sostiene che il primo passo per una corretta e naturale nutrizione delle piante debba essere il mantenimento in buone condizioni degli organismi che presiedono al processo “digestivo” nel suolo. Diretta conseguenza di questo modo di pensare è che tale processo viene ottimizzato evitando la distribuzione di sostanze “tossiche” e di tutte quelle pratiche che possono danneggiare i microrganismi del terreno. Secondo questo punto di vista, la gestione della nutrizione delle piante in modo convenzionale presenta alcune problematiche; infatti la distribuzione di massicce quantità di nutrienti in uno o due momenti specifici causa sbilanci nutrizionali che inducono infestazioni di insetti, maggiore suscettibilità delle piante alle malattie e ridotta qualità dei prodotti. Altra conseguenza del massiccio utilizzo dei concimi di sintesi può essere individuata nella ridotta “naturalità” dei terreni che finiranno per dipendere sempre più dagli apporti chimici, divenendo incapaci di fornire alle piante il nutrimento. La concimazione minerale convenzionale, nella maggiore parte dei casi, apporta solo alcuni dei molteplici elementi necessari per il sostentamento delle piante (N, P, K, Mg, Ca), e favorisce l’insorgere di problemi legati alla diffusione delle malerbe e alla lisciviazione dei composti più solubili (nitrato). Controllo naturale delle avversità Il controllo delle avversità rappresenta il problema più spinoso per ogni tipo di attività agricola e, nel caso delle pratiche biologiche, risulta probabilmente 38 l’aspetto più problematico in quanto ancora molto influenzato da motivazioni non sempre basate su evidenze scientifiche. Ciò appare, per esempio, dalla convinzione dei sostenitori del biologico che gli insetti attacchino essenzialmente piante indebolite dagli sbilanci nutrizionali (Kuepper e Gegner, 2004) e che siano respinti da piante in condizioni nutrizionali ottimali. Queste affermazioni sono basate essenzialmente sul fatto che in natura massicci attacchi di parassiti delle piante non si verificano molto spesso e, quando questo accade, il fenomeno ha breve durata in quanto l’ecosistema tende a ritrovare il suo equilibrio favorendo lo sviluppo di predatori e parassiti naturali degli insetti dannosi. Anche in questo caso viene evidenziato dai sostenitori del biologico come l’uso massiccio e costante di pesticidi renda l’ecosistema incapace di difendersi da solo e di conseguenza sempre più dipendente da ulteriori apporti di prodotti di sintesi. Integrità Rappresenta l’ultimo dei pilastri dell’attività biologica e presenta sfaccettature sia pratiche che filosofiche strettamente interconnesse tra loro. In termini generali si può affermare che il produttore deve rendersi garante nei confronti del consumatore finale della qualità dei prodotti conferiti al mercato. Tale garanzia non fa riferimento esclusivamente alle tecniche colturali adottate, ma anche alla messa in atto di tutti quegli accorgimenti necessari a proteggere i prodotti ottenuti da possibili “inquinamenti” derivanti dall’esterno. A conclusione di questo sintetico e s c u r s u s s u i principi ispiratori dell’agricoltura biologica, sembra utile riassumere nelle tabelle 3, 4, 5 e 6 quali sono le tecniche adottabili nell’agricoltura convenzionale, integrata e biologica. Al fine di rendere più chiara la comprensione delle tecniche utilizzate/ammesse nei tre tipi di agricoltura ogni tabella farà riferimento all’obiettivo principale per cui le operazioni sono adottate. La qualità dei prodotti biologici Una delle principali ragioni per cui i consumatori acquistano ortaggi “biologici” è la percezione che tali prodotti siano più “nutrienti” rispetto a quelli convenzionali. A tale riguardo esistono in bibliografia solo pochi studi che siano stati condotti in condizioni “ben controllate” e in grado di ottenere quindi una corretta e significativa comparazione tra i due tipi di prodotto. Molto spesso per gli esperimenti miranti a queste L’orticoltura biologica Tab. 3 - Comparazione tra le tecniche adottabili dall’agricoltura “convenzionale”, “sostenibile” e “biologica” per ridurre l’impatto ambientale. Tab. 3 - Comparison among techniques adopted by “conventional”, “sustainable” and “organic” farmers to reduce the environmental impact. Convenzionale Integrato Biologico Conservazione dello strato attivo del terreno attraverso: a) adeguate sistemazioni b) mantenimento della copertura vegetale c) limitazione della profondità di aratura SI SI SI NO Possibile SI NO SI SI Favorire la diversità e la complessità ambientale con: NO NO NO Possibile Possibile Possibile SI SI SI Coltivazione in zone vocate NO Consigliata Consigliata NO NO NO SI a) presenza di siepi b) macchie spontanee c) specchi d’acqua Tab. 4 - Comparazione tra le tecniche adottabili dall’agricoltura “convenzionale”, “sostenibile” e “biologica” per aumentare la sostenibilità e ridurre l’impatto ambientale. Tab. 4 - Comparison among techniques adopted by “conventional”, “sustainable” and “organic” farmers to improve sustainability and to reduce the environmental impact. Convenzionale Integrato Biologico NO Possibile SI NO Possibile SI NO SI NO Scelta varietale: NO NO NO Consigliata NO* Consigliata NO NO Materiale di propagazione: Consigliata NO Consigliata Consigliata SI SI SI - fino al 31.12.2003, se non disponibile materiale biologico SI SI NO NO NO SI SI NO NO (alcuni disciplinari non le vietano) Introdurre nell’avvicendamento: a) sovescio b) leguminose pratensi poliennali o leguminose pratensi o da granella annuali c) cereale d) monosuccessione Consociazione a) resistenza a fitopatie b) ecotipi locali o varietà “tipiche” a) sementi e materiale di propagazione vegetativa, proveniente da coltivazioni non biologiche b) piantine provenienti da coltivazioni non biologiche c) OGM Colture fuori suolo Materiale di propagazione: a) riscaldamento b) copertura in PE o EVA c) copertura in PVC d) copertura in doppio strato e) riciclaggio materiali plastici SI SI SI SI SI/NO a) residui vegetali b) materiali naturali biodegradabili c) PE o EVA d) PVC e) Riciclaggio materiali plastici NO NO SI SI SI/NO SI SI NO SI SI Solo per produzione piantine SI NO Solo per produzione piantine SI NO Consigliata SI NO SI Consigliata Consigliata SI NO SI Pacciamatura: 39 Pimpini et al. Tab. 5 - Comparazione tra le tecniche adottabili dall’agricoltura “convenzionale”, “sostenibile” e “biologica” per la nutrizione delle piante. Tab. 5 - Comparison among techniques adopted by “conventional”, “sustainable” and “organic” farmers for the plant nutrition. Convenzionale Integrato Biologico NO NO SI/NO SI/NO SI/NO NO SI Possibile Possibile SI/NO SI/NO SI con limitazione NO SI con limitazioni SI SI SI SI se “biologico” e compostato SI con limitazioni SI NO SI SI SI SI Solo riciclabile (NO PVC) NO SI con limitazioni Solo riciclabile (NO PVC) NO Fertilizzazione: a) coltivazione di leguminose b) lsovescio e/o residui colturali c) letame d) altri ammendanti organici e) reflui zootecnici f) fertilizzanti di origine naturale g) fertilizzanti chimici h) concimazione fogliare e fertirrigazione Irrigazione: a) salinità dell’acqua b) tubazioni in plastica Impiego di fitoregolatori SI SI SI Tab. 6 - Comparazione tra le tecniche adottabili dall’agricoltura “convenzionale”, “sostenibile” e “biologica” per la difesa delle colture. Tab. 6 - Comparison among techniques adopted by “conventional”, “sustainable” and “organic” farmers for disease and weed control. Convenzionale Integrato Biologico Fertilizzazione: a) mezzi agronomici b) scelta di varietà resistenti o tolleranti NO NO Consigliata Consigliata SI SI a) disinfezioni e disinfestazioni del terreno SI Con metodi fisici b) antiparassitari di sintesi c) antiparassitari di origine naturale SI NO SI con limitazioni SI Solo con solarizzazione (in caso di forte infestazione)* NO SI NO SI SI NO NO SI Consigliata SI (NO PVC) SI NO SI NO SI SI (NO PVC) SI SI SI (alcuni disciplinari) NO SI NO NO Controllo delle malerbe: a) falsa semina b) pacciamatura c) lavorazioni meccaniche d) pirodiserbo e termodiserbo e) solarizzazione b) diserbo chimico Difesa in post-raccolta comparazioni i ricercatori si sono rivolti per l’approvvigionamento dei prodotti al mercato al dettaglio (Bourn e Prescott, 2002) giustificando tale modalità operativa con la necessità di ottenere una randomizzazione dei campioni che risulti rappresentativa della generalità dei prodotti stessi. Tale giustificazione potrebbe essere accettabile se non inducesse i ricercatori a trascurare quelle che sono state le diverse modalità operative dei produttori (tecniche colturali, scelte varietali, ecc.) e il fatto che normalmente i prodotti biologici, in genere venduti localmente, giungono al mercato molto prima di quelli convenzionali che una volta raccolti devono essere spediti anche molto lontano (Harker, 2004). Ricerche bibliografiche condotte da Woese et al. 40 (1997) e da Bourn e Prescott (2002) hanno evidenziato che la comparazione tra ortaggi biologici e convenzionali secondo i 3 aspetti chiave legati al valore nutrizionale, alla qualità sensoriale ed alla salubrità presenta risultati molto variegati e talvolta confusi. Anche questi Autori hanno evidenziato la presenza di pochi studi ben strutturati e chiari. Per molti degli altri aspetti presi in considerazione, le differenze tra prodotti biologici e convenzionali non sono sempre attribuibili esclusivamente alla tecnica di coltivazione. Nessuna chiara evidenza è apparsa nei confronti della supposta maggiore suscettibilità dei prodotti biologici alla contaminazione microbiologica, così come dimostrato anche dagli studi di Sagoo et al. (2001). I principali aspetti che sono normalmente presi in conside- L’orticoltura biologica razione negli studi dell’effetto delle tecniche colturali sulla qualità dei prodotti orticoli sono essenzialmente il contenuto di azoto e di nitrati, il contenuto di vitamine e minerali e gli aspetti sensoriali. Per quanto riguarda il contenuto di azoto e gli effetti della fertilizzazione sulla produzione di proteine e sulla loro qualità i risultati appaiono ancora oggi contraddittori. Se molti Autori concordano sul fatto che elevati apporti azotati aumentano la concentrazione di proteine nella pianta, diverse sono le opinioni sull’azione della concimazione sul valore nutrizionale delle proteine prodotte. Benché le proteine sintetizzate da una pianta siano determinate dal suo patrimonio genetico, i rapporti in cui le diverse proteine sono sintetizzate vengono fortemente influenzati dalla quantità di fertilizzante azotato distribuito (Schuphan, 1961). In situazioni caratterizzate da apporti elevati, le proteine accumulate hanno un minor contenuto di aminoacidi essenziali. Per esempio, la lisina e la metionina rispettivamente aminoacidi essenziali maggiormente presenti in frumento e spinacio, diminuiscono proporzionalmente a livelli crescenti di azoto (Schuphan, 1961). Eppendorfer et al. (1979) hanno attribuito il duplice effetto di aumento del contenuto azotato e della diminuzione del valore nutrizionale della proteina grezza, all’effetto dei fertilizzanti sulla concentrazione degli amminoacidi liberi e delle ammidi. Essi hanno dimostrato inoltre che crescenti apporti di N (organico o minerale) sulla patata hanno provocato l’aumento della concentrazione dell’azoto ma anche la concomitante diminuzione della qualità delle proteine. A simili risultati sono giunti anche Syltie et al. (1982) su frumento. Al contrario, Millard (1986) ha trovato che applicazioni crescenti di azoto comprese tra 0 e 250 kg ha-1 non solo hanno aumentato la concentrazione di nitrati, ma hanno aumentato anche il contenuto di amminoacidi essenziali. Uno studio triennale svedese (Pettersson, 1977) ha evidenziato concentrazioni di proteina grezza significativamente più elevate in patata, frumento e orzo convenzionale, corrispondenti però a minori quantità di amminoacidi essenziali, solo in patata e in frumento. Sulla media di tutte le coltivazioni fatte in un periodo di 12 anni, Schuphan (1974) ha riscontrato però contenuti di proteina superiori del 18% e una media del 23% in più di metionina in patata e spinacio biologici. Apporti di pollina su spinacio e bietola rossa hanno generalmente dato livelli inferiori di N-totale nella sostanza secca rispetto ai quattro fertilizzanti minerali utilizzati (Goh e Vityakon, 1986), a causa della minore disponibilità dell’azoto apportato con il concime organico. Lairon et al. (1986) non hanno invece riscontrato differenze nella concentrazione di proteine o amminoacidi essenziali in lattuga coltivata utilizzando i due diversi metodi. Un recente studio condotto da Magkos et al. (2003) ha evidenziato ancora una volta che cereali e ortaggi coltivati con tecniche biologiche presentano minore contenuto di proteina grezza ma ad elevato valore nutrizionale. Il contenuto di nitrati nei vegetali è determinato da diversi fattori quali specie, varietà, luminosità, temperatura, tipo di terreno e apporti di N. In particolare la disponibilità di azoto durante la crescita della coltura è considerata la principale fonte di variabilità della concentrazione di nitrati, in relazione alla quantità e al periodo di applicazione. Nei fertilizzanti organici, la frazione di azoto organico è insolubile e deve quindi essere mineralizzata prima di poter essere assorbita contrariamente a quanto avviene con l’azoto minerale più prontamente assimilabile. Appare ovvio quindi che l’adozione di tecniche biologiche tende a ridurre il contenuto di nitrati nelle piante come conseguenza diretta della graduale disponibilità dell’azoto lungo il ciclo colturale. Risultati concordi in tal senso sono stati evidenziati su spinacio, lattuga, sedano, bietola, cavolo, porro e patata (Barker, 1975; Nilsson, 1979; Harwood, 1982; Vogtmann e Biedermann, 1985; Goh e Vityakon, 1986; Fischer e Richter, 1986). Il contenuto di nitrato nei prodotti biologici si è sempre mantenuto a livelli inferiori rispetto a quelli riscontrati nei prodotti convenzionali, anche se tali differenze sono variate molto in funzione dei fertilizzanti utilizzati (letame, pollina, sangue di bue, ecc.) e del periodo di coltivazione. In esperimenti di coltivazione di porro, carota, rapa e cavolo verde allevati in contenitore, apporti di compost (molto studiato per l’applicazione in agricoltura biologica) hanno dato basso contenuto di nitrati rispetto ad equivalenti applicazioni di N, P e K sotto forma minerale (Lairon et al., 1986). In contrasto con quanto affermato precedentemente sono apparsi i risultati ottenuti da Stopes et al. (1988) che non hanno riscontrato differenti concentrazioni di nitrati in ortaggi prelevati dalla catena di distribuzione biologica e da quella convenzionale durante due cicli invernali condotti in Inghilterra. Più interessante, anche se non sempre chiaro, appare l’aspetto legato al contenuto di minerali, vitamine e prodotti del metabolismo secondario. Molti studi hanno messo in evidenza come l’impiego di fertilizzanti, sia organici che minerali, non modifichi in maniera determinante la composizione delle piante e in particolare modo, il contenuto di vitamine; la loro 41 Pimpini et al. sintesi è influenzata maggiormente dal patrimonio genetico, dallo stato di maturazione alla raccolta e dalle condizioni climatiche (Stare et al., 1 9 7 2 ; Leverton, 1973; A.D.A., 1974; Anon, 1974; Jukes, 1977; Linder, 1985). In numero limitato e piuttosto datati appaiono comunque gli studi a questo proposito. Alcuni prodotti del metabolismo secondario delle piante, quali i composti fenolici, suscitano sempre maggiore interesse in quanto giocano un ruolo molto importante nella salute umana ed agiscono come composti antitumorali come riportato da Block et al. (1992), Steinmetz e Potter (1991) e da Hertog et al. (1993a e 1993b). Esistono comunque pochi studi relativi all’effetto della tecnica colturale sulla produzione di metaboliti secondari (Brandt e Molgaard, 2001). Anche se nessuna sostanziale differenza viene trovata tra alimenti biologici e convenzionali, Brandt e Molgaard affermano che i primi tendono a produrre un maggiore numero di tali composti che sono in grado di esplicare effetti benefici sulla salute dei consumatori. Studi condotti da Asami et al. (2003) hanno nettamente evidenziato la migliore qualità di fragole e mais dolce coltivati con tecniche “biologiche” e “sostenibili” rispetto a quelle ottenute in “convenzionale”. Tale superiorità si è manifestata con un contenuto più elevato di acido ascorbico e fenoli totali. Risultati contrastanti sono stati riportati da Hakkinen e Torronen (2000). In uno studio mirante a comparare l’effetto delle tecniche di coltivazione sul contenuto dei principali flavonoidi (composti ad azione antiossidante) negli alimenti e sulla loro biodisponibilità, è apparso che il consumo di ortaggi biologici tende a stimolare l’attività antiossidasica plasmatica e ad incrementare l’ossidazione proteica nell’organismo umano (GrinderPedersen et al., 2003), mentre Ren et al. (2001) hanno evidenziato che l’attività antimutagena del succo di cavolo cinese, carota, cipolla e spinacio prodotti con metodo biologico, è risulta di molto superiore a quella rilevata nel succo degli stessi ortaggi allevati convenzionalmente. confronti dell’ambiente e della salubrità degli alimenti. Tutto questo si è concretizzato in nuovi scenari produttivi caratterizzati da livelli crescenti di attenzione per l’ambiente e la salute dei consumatori. Le tecniche di produzione basate essenzialmente sul concetto del “più è meglio” si sono via via affinate cercando, in vario modo, di porre l’attenzione non più sulla quantità ma sulla qualità dei prodotti e del processo produttivo. Sono stati quindi messi a punto disciplinari di produzione di buona pratica agricola,che hanno previsto il passaggio dai “trattamenti a calendario” alla lotta guidata prima e integrata poi. Per alcuni agricoltori questo processo evolutivo ha poi portato alla riscoperta di tradizionali metodi produttivi che si sono evoluti a loro volta negli attuali disciplinari biologici. L’orticoltura biologica rappresenta oggi in Italia solo una piccola parte del totale anche se, dal punto di vista economico, gli interessi sono elevati. Dopo oltre 10 anni di sviluppo continuo, nei primi anni del 2000 il “biologico” in Italia ha subito una battuta d’arresto, almeno dal punto di vista della superficie coltivata che si è stabilizzata attorno a un milione di ettari. Ciò sembra più legato ad una necessità di riorganizzazione del settore (produzione e commercializzazione) che ad una riduzione della domanda che, anzi, appare consolidata se non in crescita. Da un’analisi dei dati a disposizione appare che, se dal punto di vista tecnico/agronomico, la ricerca abbia supportato questo particolare settore (in maniera più o meno accettabile almeno per quanto riguarda gli aspetti di nutrizione delle piante e della lotta alle malerbe), carenti risultano ancora le soluzioni disponibili per la difesa dai parassiti e dai patogeni. Discorso a parte merita la supposta superiorità nutrizionale e salutistica dei prodotti biologici che però, ad esclusione del ridotto contenuto di nitrato, non hanno evidenziato nessun’altra caratteristica specifica in grado di qualificarli come tali. Ancora molteplici sono i dubbi e le incertezze presenti, sotto il profilo scientifico, nell’ambito dell’orticoltura biologica, tali incertezze e dubbi dovrebbero essere chiariti affinché ulteriori reali sviluppi possano verificarsi in questo comparto molto discusso ma poco studiato. Conclusioni Riassunto L’orticoltura in Italia ha subito notevoli cambiamenti negli ultimi anni. Tali modificazioni sono state motivate, essenzialmente, dalle mutate condizioni economiche che hanno interessato la nazione dal secondo dopoguerra ad oggi. Parallelamente alle maggiori possibilità finanziarie della gran parte dei cittadini si è sviluppata anche una grande attenzione nei 42 Il lavoro affronta l’argomento dell’orticoltura biologica cercando di fare una disamina spassionata ed oggettiva di quella che è la situazione attuale in Italia e degli aspetti critici di questo comparto. A fronte di un mercato che ha avuto una rapida crescita negli anni ’90, inducendo di conseguenza un consistente aumento delle superfici investite, si riscontra una scarsità di L’orticoltura biologica informazioni scientifiche disponibili. La superiorità nutrizionale e qualitativa dei prodotti biologici, se da un lato risulta essere la principale motivazione nell’acquisto di tali prodotti, dall’altro non trova molti riscontri oggettivi in letteratura. Nel prossimo futuro si presuppone che non vi siano ulteriori grandi sviluppi in termini di superficie investita, ma solo un assestamento di quanto già esiste. Ulteriori ricerche, rigorose dal punto di vista dell’impostazione scientifica, sono necessarie al fine di fare chiarezza su di un argomento tanto importante quanto poco conosciuto. Parole chiave: sistemi colturali, sostenibilità, qualità degli alimenti. Bibliografia A.D.A., 1975. Position paper on food and nutrition misinforma tion on selected topics. J. Am. Diet. Assoc. 66: 277-280. ANON A., 1974. Organic foods. Food Technol. 28: 71-74. ASAMI D.K., H ONG Y.J., B ARRET D.M., M ITCHELL A.E., 2003. Comparison of the total phenolic and ascorbic acid content of freeze-dried and air-dried Marionberry, strawberry and Corn grown using conventional, organic and sustainable agricultu ral practices. J. Agric. Food Chem. 51: 1237-1241. BARKER A.V., 1975. Organic vs. inorganic nutrition and horticul tural crop quality. HortScience 10 (1): 50-53. BENGTSSON J., A HNSTROM J., W EIBULL A.C., 2005. The effects of organic agriculture on biodiversity and abundance: a metaanalysis. J. Appl. Ecol. 42 (2): 261-269. BLOCK G., PATTERSON B., SUBAR A., 1992. Fruit and vegetables and cancer prevention: a review of the epidemiological evi dence. Nutr. Cancer 18: 1-29. BOURN D., P RESCOTT J., 2002. A comparison of the nutritional value, sensory qualities, and food safety of organically and conventionally produced foods. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 42 (1): 1-34. BRANDT K., MOLGAARD J.P., 2001. Organic agriculture: does it enhance or reduce the nutritional value of plant foods?. J. Sci. Food Agric. 81: 924-931. CA R P E N T E R- B O G G S L., K E N N E D Y A.C., R E G A N O L D J . P . , 2 0 0 0 . Organic and biodynamic management: Effects on soil biology. Soil Sci. Soc. Am. J. 64 (5): 1651-1659. CCIAA DI BOLOGNA , 2005. Borsa Ortofrutticola Biologica. 15 giugno 2005. <http://www.bo.camcom.it/intranet/ REGISTRO-I/NOTIZIE-EC/Borsa-orto1/index.htm>. DRINKWATER L.E., W AGONER P., S ARANTONIO M., 1998. Legumebased cropping systems have reduced carbon and nitrogen losses. Nature 396 (19): 262-264. ELMAZ O., CERIT H., O ZCELIK M., ULAS S., 2004. Impact of orga nic agriculture on the environment. Fresenius Environ. Bull. (11A): 1072-1078. EPPENDORFER W.H., E GGUM B.O., B ILLE S.W., 1979. Nutritive value of potato crude protein as influenced by manuring and amino acid composition. J. Sci. Food Agric. 30: 361-368. FAOSTAT, 2005. 15 giugno 2005. <http://faostat.fao.org/faostat/collections?subset = agriculture>. FISCHER A., RICHTER C., 1986. Influence of organic and mineral fertilizers on yield and quality of potatoes. Proc. of the 5th IFOAM Int. Scientific Conference. Kassel (Germany), 27-30 Agosto, 1984: 236-248. FLORES C.C., SARANDON S.J., 2004. Limitations of neoclassical economics for evaluating sustainability of agricultural systems: Comparing organic and conventional systems. J. Sust. Agric. 24 (2): 77-91. GOH K.M., V ITYAKON P., 1986. Effects of ferti1izers on vegetable production. II Effects of nitrogen fertilizers on nitrogen con tent and nitrate accumulation of spinach and beetroot. N. Z. J. Agric. Res. 29: 485-494. GRINDER-PEDERSEN L., R ASMUSSEN S.E., B UGEL S., J ORGENSEN L.V, DRAGSTED L.O., GUNDERSEN V., SANDSTROM B., 2003. Effect of diets based on foods from conventional versus orga nic production on intake and excretion of flavonoids and markers of antioxidative defense in humans. J. Agric. Food Chem. 51 (19): 5671-5676. HAINSWORTH P. H., 1976. Agricolture: the only right approach. Bargyla & Gyler Rateaver, (Pauma Valley, CA). HAKKINEN S.H., T ORRONEN A.R., 2000. Content of flavonols and selected phenolic acids in strawberries and Vaccinium spe cies: influence of cultivar, cultivation site and technique. Food Res. Int. 33 (6): 517-524. HARKER F.R., 2004. Organic food claims cannot be substantiated through testing of samples intercepted in the marketplace: a horticulturalist’s opinion. Food Qual. Preference 15 (2): 9195. HARWOOD R.R., 1982. Organic farming research at the Rodale Research Center. Abstract. Rodale Press,: 21-31. HERTOG M., F ESKENS E.J.M., H OLLMAN P.C.H., K ATAN M.B., KROMHOUT D., 1993. Dietary antioxidant flavonoids and risk of coronary heart disease: the Zutphen elderly study. Lancet 342: 1007-1011. HE R T O G M., H O L L M A N P.C.H., K A T A N M.B., K R O M H O U T D . , 1993. Intake of potentially anticarcinogenic flavonoids and their determinants in adults in the Netherlands . Nutr. Cancer. 20: 21-29. ISMEA, 2003. Filiera Ortofrutta 2003. ISMEA, 2005. Osservatorio Prezzi Ortofrutta. 14 giugno 2005. <http://www.ismea.it/ homeOPO.asp?Filiera=50>. JUKES T.H., 1977. Organic food . CRC Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 9: 395-418. KUEPPER G., G EGNER L., 2005. Organic crop production. NCAT publication. 14 giugno 2005. <http://www.attra.ncat.org/attrapub/organiccrop.html>. LAIRON D., T ERMINE E., G AUTIER S., T ROUILLOUD M., L AFONT H., H AUTON J.C., 1986. Effects of organic and mineral ferti lization on the contents of vegetables in minerals, vitamin C and nitrates . Proc. of the 5th IFOAM Int. Scientific Conference. Kassel (Germany), 27-30 Agosto, 1984: 249260. LEVERTON R.M., 1973. Nutritive value of “organically grown” foods. J. Amer. Diet. Assoc. 62(5): 501. LINDER M.C., 1985. Food quality and its determinants, from field to table: Growing food, its storage, and preparation. In: Nutritional Biochemistry and Metabolism with Clinical Applications. Elsevier (New York): 239-254. LOCKERETZ W., S HEARER G., K HOL D., 1981. Organic farming in the corn belt. Science 211 (6): 540-547. MAGKOS F., A RVANITI F., Z AMPELAS A., 2003. Organic food: nutritious food or food for thought? A review of the evidence. Int. J. Food Sci. Nutr. 54 (5): 357-371. MI L L A R D P., 1986. The nitrogen content of potato ( S o l a n u m tuberosum L.) tubers in relation to nitrogen application the effect on amino acid composition and yields. J. Sci. Food Agric. 37: 107-114. MINISTERO DELLA SALUTE, 2004. Controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale Risultati in Italia per l’anno 2003. 14 giugno 2005. <http:// www.ministerosalute.it/alimenti/sicurezza/sicApprofondime nto.jsp?lang=italiano&label=con&id=296>. 43 Pimpini et al. MiPAF, 2005. L’agricoltura biologica in Italia - dati relativi agli anni 2000- 2003. 14 giugno 2005. <http://www.politicheagricole.it/ PRODUZIONE/ AGRIBIO/HOME.ASP>. NILSSON T., 1979. Yield, storage ability, quality and chemical composition of carrot, cabbage and leek at conventional and organic fertilizing. Acta Hort. 93: 209-223. NOSB, 1995. Annual meeting. Organic Trade Association . Orlando Fl. 13 aprile 2005. <http://www.northcoast.com/startrak/ota/legislat.htm>. P A C I N I C., W O S S I N K A., G I E S E N G., B A Z Z A N A C., H U I R N E R . , 2003. Evaluation of sustainability of organic, integrated and conventional farming systems: a farm and field-scale analy sis. Ag. Ecosyst. Environ. 95 (1): 273-288. P ETTERSSON B.D., 1977. A comparison between conventional and bio-dynamic farming systems as indicated by yields and quality. Bio-Dynamics 124: 19-27. REN H.F., ENDO H., H AYASHI T., 2001. The superiority of orga nically cultivated vegetables to general ones regarding anti mutagenic activities. Mutat. Res. 496 (1-2): 83-88. SAGOO S.K., L ITTLE C.L., M ITCHELL R.T., 2001. The microbiolo gical examination of ready-to-eat organic vegetables from retail establishments in the United Kingdom. Lett. Appl. Microbiol. 33 (6): 434-439. SCHUPHAN W., 1961. Nutritional Values in Crops and Plants. Problems for Producers and Consumers. Faber and Faber Limited (London). 44 SCHUPHAN W., 1974. Nutritional value of crops as influenced byorganic and inorganic fertilizer treatments. Results of 12 years’ experiments with vegetables (1960-1972). Qual. Plant. Pl. Fds. Hum. Nutr. 23(4): 333-358. STARE F.J., H EGSTED D.M., M AYER J., G EYER R.P., G ERSHOFF S.N., H E R R A R A M.G., M C G A N D Y R.B., K E R R G . R . , A N T O N I A D E S H . N . , 1972. Health foods: Definitions and nutrient values. J. Nutr. Educ. 47(3): 94-97. STEINMETZ K., P OTTER J., 1991. Vegetables fruits and cancer. I. Epidemiology. Cancer Causes Control, 2: 325-357. STOPES C., WOODWARD L., FORDE G., VOGTMANN H., 1988. The nitrate content of vegetable and salad crops offered to the consumer as from “organic” or “conventional” production systems. Biol. Agric. Hort. 5: 215-221. SYLTIE P.W., D AHNKE W.C., H ARROLD R.L., 1982. Nutritional value of hard red spring wheat grain protein as influenced by fertilization and cultivar. Agron. J. 74: 366-371. VAN ELSEN T., 2000. Species diversity as a task for organic agri culture in Europe. Agric. Ecosyst. Environ. 77 (1-2): 101-109. VOGTMANN H., BIEDENNANN R., 1985. The nitrate story -no end in sight. Nutr. Health 3: 217-239. WOESE K., L ANGE D., B OESS C., B OGL K.W., 1997. A comparison of organically and conventionally grown foods - Results of a review of the relevant literature. J. Sci. Food Agric. 74 (3): 281-293. XIE B., WANG X.R., DING Z.H., YANG Y.P., 2003. Critical impact assessment of organic agriculture. J. Agric. Environ. Ethics 16 (3): 297-311.
Scarica