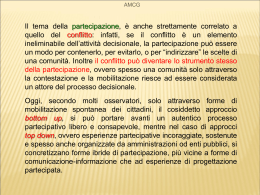del DIRITTO dell’AVVOCATURA della GIURISDIZIONE CEDA RIVISTA TRIMESTRALE N. 3-4 LUGLIO-DICEMBRE 2007 Hanno collaborato a questo numero: Gianni Barillari, avvocato del foro di Padova Sandro Grandese, avvocato del foro di Venezia Teresa Lo Torto, avvocato del foro di Venenzia Enrica Piovesan, dottoranda di ricerca dell’Università degli Studi di Padova Roberto Senigaglia, ricercatore, professore aggregato di Istituzioni di diritto privato, Università Ca’ Foscari di Venezia Giuliano Zanchi, avvocato del foro di Venezia, dottore di ricerca in Diritto Europeo dei Contratti RIVISTA TRIMESTRALE N. 3-4 LUGLIO-DICEMBRE 2007 INDICE Parte I GIURISPRUDENZA Diritto civile Le discriminazioni nel rapporto di lavoro. Le conseguenze risarcitorie della discriminazione: profili sostanziali e processuali di Gianni Barillari e Sandro Grandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 107 La prova della simulazione da parte del legittimario (nota a Tribunale di Napoli IX sezione 17 aprile 2007 – Giudice dott. Eduardo Campese) di Roberto Senigaglia e Teresa Lo Torto . . . . . . . . . . . . . . . . . » 125 Diritto penale Orientamenti giurisprudenziali della Corte Cassazione in materia di infedeltà patrimoniale. Problemi e soluzioni prospettate sul tema della specialità reciproca con l’appropriazione indebita (nota a Cassazione, Sez. II, 26 ottobre 2005 – dep. 10 novembre 2005 – n. 10175) di Enrica Piovesan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 137 Diritto amministrativo Legge e Autorità Indipendenti: le diverse tecniche di intervento nel diritto dei contratti di Giuliano Zanchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 169 LE DISCRIMINAZIONI NEL RAPPORTO DI LAVORO. LE CONSEGUENZE RISARCITORIE DELLA DISCRIMINAZIONE: PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI In data 10 maggio 2007, l’Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO) ha pubblicato il rapporto «Uguaglianza nel lavoro: affrontare le sfide». Il rapporto dell’ILO è lo studio più completo mai realizzato ad oggi sul tema della discriminazione, fornisce una fotografia a livello mondiale della discriminazione sul lavoro, menzionando sia i progressi che i fallimenti nella battaglia contro forme discriminatorie come quelle basate sul sesso, la razza o la religione, ma anche contro le nuove forme fondate sull’età, l’orientamento sessuale, la sieropositività o lo stato di salute delle persone, ribadisce che «di fronte ad un mondo che appare sempre più ingiusto, incerto e insicuro, combattere la discriminazione è oggi più urgente rispetto a quattro anni fa», ribadendo che «il persistere delle disuguaglianze nel reddito, nelle risorse e nelle opportunità riducono l’efficacia di qualsiasi azione volta a combattere la discriminazione». Nel presente articolo si vuole trattare il tema delle discriminazioni nell’ambito del diritto del lavoro e dei rimedi che i nostro ordinamento ha apprestato a tutela del discriminato. Il tema come abbiamo visto è di grande attualità ed è stato oggetto recentemente di un convegno internazionale in Venezia organizzato dall’associazione nazionale avvocati giuslavoristi. 1. In cui si discute degli atti discriminatori Il divieto di atti discriminatori per motivi politici, religiosi e sindacali, è stato introdotto dalla l. 15 luglio 1966, n. 604 (art. 4), poi confermato dallo Statuto dei lavoratori (art. 15). Successivamente, il diritto antidiscriminatorio si è notevolmente affinato, attraverso la ridefinizione delle forme di discriminazione e l’introduzione di un corpus 108 GIURISPRUDENZA di tecniche di tutela fortemente orientato a garantire l’effettiva protezione di alcuni gruppi svantaggiati. Le prime fasi di questo potenziamento hanno avuto come protagoniste le discriminazioni sessuali, destinatarie di un complesso nucleo di norme di carattere sostanziale e processuale, oggi raccolte nel d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna). La disciplina volta a combattere le discriminazioni etniche e razziali è contenuta nel d.lgs. 15 luglio 1998, n. 286 (testo unico in materia di immigrazione) e nel d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, attuativo della direttiva comunitaria n. 43 del 2000. Le discriminazioni fondate su convinzioni personali, credo religioso, handicap, età e orientamento sessuale sono disciplinate nel d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della direttiva comunitaria n. 78 del 2000. La tutela giurisdizionale prevede, sia per le discriminazioni sessuali che per i fattori di discriminazione da ultimo citati, un doppio binario di tutela, fondato, il primo, su un’azione inibitoria, che può assumere una dimensione individuale o collettiva, e, il secondo, su una tutela risarcitoria. Le ipotesi di tutela inibitoria previste dall’ordinamento in caso di discriminazioni sono regolate – agli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 198/2006 per le discriminazioni di sesso; – agli artt. 44 del d.lgs. n. 286/1998 e 4 del d.lgs. n. 215/2003 per le discriminazioni legate alla razza e all’origine etnica; – all’art. 4 del d.lgs. n. 216/2003 per le discriminazioni fondate sulla religione, convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale; – all’art. 3 della l. n. 67/2006 per le discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità. In tutte queste disposizioni normative il provvedimento del giudice che conclude il procedimento ha ad oggetto la cessazione del comportamento discriminatorio e la rimozione dei suoi effetti. L’ordine del giudice di cessare il comportamento discriminatorio si traduce, però, in un non facere infungibile, che non è suscettibile di esecuzione in forma specifica. Nell’ipotesi di discriminazioni fondate sul sesso, in caso di inottemperanza dell’ordine inibitorio del giudice, oltre ad un accessoria sanzione penale (artt. 37, comma 5, e 38, comma 4, d.lgs. 198/2006) è previsto un meccanismo di revoca dai benefici pubblici e di esclusione dai pubblici appalti. Ma più efficace è il congegno basato sul pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nell’ottemperanza a favore di un apposito fondo, destinato alle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (art. 37, comma 5, d.lgs. n. 198/2006). Di stampo in parte diverso sono, invece, i meccanismi volti a garantire la coercibilità del provvedimento inibitorio nelle ipotesi di discriminazione in ragione LE DISCRIMINAZIONI NEL RAPPORTO DI LAVORO 109 della razza o dell’origine etnica, della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale. Di fronte alle predette discriminazioni, il deterrente alla ripetizione dei comportamenti vessatori è costituito, oltre che dalla consueta previsione di una sanzione penale (art. 44, comma 8, d.lgs. n. 286/1998) e dalla revoca da benefici pubblici (art. 44, comma 11, d.lgs. n. 286/1998), dall’ordine di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate finalizzato ad impedire la ripetizione del comportamento. Tale piano di rimozione non è assistito, tuttavia, da alcuna sanzione quanto al suo effettivo adempimento. Maggiori effetti dissuasivi potrà produrre, allora, la pubblicazione del provvedimento del giudice su un quotidiano a tiratura nazionale prevista agli artt. 4, comma 6, d.lgs. n. 215/2003, 4, comma 7, d.lgs. n. 216/2003 e 3, comma 4, l. n. 67/2006. Sotto il profilo della tutela risarcitoria, il legislatore, prevedendo la risarcibilità dei danni patrimoniali e non patrimoniali per tutte le ipotesi di discriminazioni analizzate, ha recepito gli ultimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla risarcibilità di ogni pregiudizio o compromissione della sfera esistenziale della persona, del «valore uomo», inteso nella sua complessità e interezza di manifestazioni e relazioni. Il danno non patrimoniale, dunque, è stato inteso nella sua versione esistenziale e, pertanto, ricompreso nella lata definizione di danno derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, distinti da quelli alla salute e al benessere psichico già tutelati dal danno biologico e morale. Naturalmente, perché il giudice possa liquidare al lavoratore discriminato il risarcimento del danno non patrimoniale (oltre che patrimoniale), diventa imprescindibile provare non solo l’esistenza del fatto, la sua valenza antigiuridica e antidiscriminatoria, le conseguenze pregiudizievoli prodottesi sul piano esistenziale, morale, biologico, ma anche il nesso di causalità che lega gli effetti dannosi al comportamento discriminatorio; in sostanza, è indispensabile provare che quel pregiudizio non si sarebbe determinato in assenza di quella causa scatenante. Quindi, niente sconti formali sul piano probatorio in merito alla dimostrazione dei danni patiti dai soggetti discriminati: l’attenuazione del principio dell’onere probatorio a carico del ricorrente – che può avvalersi della prova presuntiva con l’ausilio aggiuntivo dei dati statistici – è prevista solo in relazione alla prova della sussistenza della fattispecie discriminatoria. 2. In cui si discute specificatamente del licenziamento discriminatorio I riferimenti normativi, come è noto, sono l’art. 4 l. 15 luglio 1966 n. 604, l’art. 15 l. 20 maggio 1970 n. 300 – come modificato dalla l. 9 dicembre 1977, n. 903 e 110 GIURISPRUDENZA dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216 – e l’art. 3 l. 11 maggio 1990 n. 108. Come è noto, l’attuale formulazione dell’articolo 15 è la seguente: È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali. In ragione del dato normativo, il percorso – soprattutto per quanto riguarda il licenziamento discriminatorio – sembrerebbe essere semplice e lineare, anche in considerazione del fatto che l’art. 3 l. n. 108/1990 sancisce la nullità del licenziamento discriminatorio, con conseguente applicabilità della tutela prevista dall’art. 18 l. n. 300/1970, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati dal datore di lavoro. In realtà, allo stato, il problema che si pone è determinare esattamente il regime della prova. Infatti, uno dei più grandi ostacoli per l’effettiva repressione degli atti discriminatori consiste proprio nella difficoltà di provare l’esistenza della discriminazione. Come ha scritto Vallebona in L’onere della prova degli atti discriminatori (in Lav. dir., 1989, 333), molte delle circostanze utili per la valutazione della natura discriminatoria di un provvedimento del datore di lavoro sono gelosamente custodite nella sfera datoriale, sicché risulta assai arduo per il lavoratore onerato conoscerle ed addurre le prove necessarie (per la citazione, cfr. Giur. Lav., 2004, n. 2, 154). La difficoltà di prova ha portato a interrogarsi sulla ripartizione degli oneri probatori in tema di atti discriminatori. È stato, infatti, osservato che la possibilità di deroghe al regime ordinario della prova va valutata tenendo conto della posizione reciproca delle parti nella dinamica del processo. Pertanto, esigenze di equità e giustizia dovrebbero far ritenere che la ripartizione degli oneri probatori debba avvenire in ragione della vicinanza alla prova di ciascuna parte e delle probabilità differenziate che i litiganti hanno di offrire la dimostrazione in giudizio delle proprie pretese (per le citazioni, cfr. Giur. Lav., 2004, n. 2, 154). I decreti legislativi nn. 215 e 216 del 2003 hanno tentato di dare una risposta al problema della ripartizione dell’onere della prova. LE DISCRIMINAZIONI NEL RAPPORTO DI LAVORO 111 Ma la strutturazione dell’onere della prova ha continuato a frustrare le aspettative dei ricorrenti (App. L’Aquila 15 agosto 2003, in Giur. Lav., 2004, n. 4, 401; Trib. Grosseto 10 giugno 2004, ibidem, 2004, n. 9, 907: La sussistenza del motivo ritorsivo (sindacale) del licenziamento deve essere provata anche per presunzioni e, in particolare, deve essere provato che i licenziamento è stato determinato in via esclusiva da motivo ritorsivo; Trib. Alba 2 novembre 2005, ibidem, 2006, n. 5, 509). Per poter affermare il carattere discriminatorio di un licenziamento a motivo dell’attività sindacale del lavoratore, o più semplicemente ritorsivo a seguito di iniziative legittimamente adottate nei riguardi del datore, e, dunque, la nullità del recesso siccome fondato su motivo illecito (artt. 1345 c.c. e 4 l. n. 604/1966) occorre che l’intento discriminatorio o di rappresaglia venga dimostrato con sufficiente certezza, sia pure solo per via di indizi, tali, però, da far giungere a conclusione sicura sul punto, e che l’intento illecito abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà dell’imprenditore, anche rispetto ad altri fatti rilevanti come giusta causa o come giustificato motivo. Il problema nasce da una non corretta applicazione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, per la cui attuazione sono stati promulgati i d.lgs. nn. 215 e 216/ 2003. Ci spieghiamo. La direttive citate, rispettivamente agli artt. 8, comma 1, e 10, comma 1, prevedono che Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un’altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento. Inoltre, gli artt. 3, lett. c), delle direttive in parola prevedono che la disciplina ivi contenuta si applichi anche ai licenziamenti (Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene: omissis c) all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione). Gli artt. 4 dei d.lgs. nn. 215 e 216/2003, rispettivamente ai commi 3 e 4, prevedono, poi, che Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, ele- 112 GIURISPRUDENZA menti di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell’art. 2729, primo comma, del codice civile. Nella relazione governativa al d.lgs. n. 216/2003 si legge: ... Circa il regime delle prove, è stata parzialmente recepita l’osservazione della commissione giustizia del Senato della Repubblica; tuttavia, la previsione di una radicale inversione dell’onere della prova è apparsa non strettamente conforme ai principi del nostro ordinamento giuridico... A seguito di tale formulazione è stata aperta una procedura di infrazione (n. 2006/2441) ex art. 226 del Trattato CE. Con detta procedura di infrazione la Commissione Europea ha contestato all’Italia la non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE. Secondo la Commissione Europea (e citiamo la relazione generale del 16 maggio 2007 ai lavori finali della Commissione Foglia per lo studio e la revisione della normativa processuale del lavoro) ... la legislazione italiana, chiedendo al ricorrente di dimostrare fatti gravi precisi e concordanti onde stabilire la presunzione di discriminazione, renderebbe troppo difficile all’attore adire la giurisdizione, mentre l’obbiettivo dell’articolo 10 paragrafo 1, della direttiva consiste nell’esatto contrario, cioè nell’alleviare l’onere della prova a carico della vittima di comportamenti discriminatori... A maggior ragione tale determinazione è errata visto che, come ribadito dalla relazione, esistono altre normative che trasferiscono l’onere della prova, come il d.lgs. n. 198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) il quale, all’art. 40, stabilisce: Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all’assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l’onere della prova sull’insussistenza della discriminazione. Allo stato, quindi, sul piano sull’assolvimento dell’onere probatorio è possibile proporre ipotesi alternative a quanto previsto dalla vigente normativa, eccependo, nei modi previsti, l’incompleto recepimento della direttiva europea sul punto. Problema, quello dell’onere della prova, che è stato fatto proprio e risolto dalla Commissione Foglia (la commissione Foglia dal nome del suo presidente Raffaele Foglia è una commissione per lo studio e la revisione della normativa processuale del lavoro) che, nell’articolato definitivo dei lavori depositato l’8 maggio 2007, ha previsto l’inserimento, dopo l’art. 15 l. n. 300/1970, dell’art. 15-bis (onere della prova) del seguente tenore: Nell’ambito delle azioni, individuali o collettive, per il riconoscimento della sus- LE DISCRIMINAZIONI NEL RAPPORTO DI LAVORO 113 sistenza di atti discriminatori di cui all’articolo 15 quando il ricorrente fornisce elementi di fatto dai quali può si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, spetta al convenuto provare che non vi è stata violazione del principio di parità di trattamento. La predetta Commissione ha proposto la conseguente sostituzione degli artt. 4 dei d.lgs. nn. 215 e 216/2003, prevedendo che nei giudizi per il riconoscimento di una delle discriminazioni di cui ai decreti legislativi in parola debba applicarsi l’art. 15-bis della l. 20 maggio 1970, n. 300. La Commissione ha proposto ancora la modifica dell’art. 3 l. n. 108/1990. Il nuovo art. 3 dovrebbe essere il seguente: Art. 3 – Licenziamento discriminatorio. 1. Si considera discriminatorio il licenziamento determinato dalle ragioni di cui alle seguenti disposizioni: a) articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604; b) articolo 15 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni; c) articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, e successive modificazioni. 2. Il licenziamento discriminatorio è nullo indipendentemente dalla motivazione adotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai dirigenti. Sempre la Commissione suggerisce che nella nuova formulazione dell’art. 3 si faccia esplicito riferimento all’art. 15-bis l. n. 300/1970 introdotto dalla Commissione medesima. La nuova disposizione, con l’inserimento dell’art. 54 del testo unico di cui al d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e successive modificazioni, estende un’ulteriore maggior tutela per le lavoratrici madri licenziate (dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino), visto che l’attuale giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cass. 19 luglio 2006, n. 16540) ritiene che... il licenziamento intimato alla lavoratrice madre in violazione della l. 30 dicembre 1971, n. 1204 sia affetto da nullità e perciò improduttivo di effetti, con la conseguenza che il rapporto di lavoro deve ritenersi mai interrotto e la lavoratrice ha diritto al risarcimento dei danni senza che possa trovare applicazione la disposizione prevista dalla l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18. Lo strumento processuale che il discriminato può attivare avverso gli atti e i comportamenti sanzionati si svolge nelle forme previste dall’art. 44 d.lgs. n. 286/ 1998. Anche qui è possibile che vi possano essere dei problemi di coordinamento 114 GIURISPRUDENZA con le conclusioni della Commissione Foglia che prevede per i rapporti di lavoro soggetti alla disciplina ex art. 18 l. n. 300/1970 una procedura accelerata per l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento, individuale e collettivo. Per quanto riguarda le conseguenze risarcitorie dell’atto discriminatorio, la formulazione dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 216/2003 prevede anche il risarcimento del danno non patrimoniale. Da tempo la Suprema Corte (13 luglio 2002, n. 10203, in motivazione) aveva statuito che ... l’«indennità» spettante ex art. 18, 4o comma, statuto dei lavoratori al dipendente illegittimamente licenziato è destinata a coprire quel danno intrinsecamente connesso all’impossibilità materiale per il lavoratore non reintegrato di eseguire la propria prestazione lavorativa. Ed invero, con la disposizione in esame si è inteso riconoscere il diritto del lavoratore al risarcimento di tutti quei pregiudizi economici che si configurano come immancabili e ineliminabili conseguenze dell’inattività lavorativa da licenziamento illegittimo. Ad avviso di questa corte, un’interpretazione letterale e logico sistematica dell’art. 18, 4o comma, induce, però, ad affermare che il diritto del lavoratore al rispetto della propria «professionalità» ed alla propria «immagine» possa ugualmente trovare un adeguato riconoscimento in sede giudiziaria. In altri termini, il legislatore ha voluto... unicamente significare che ogni pregiudizio derivante da inattività lavorativa abbisogna della necessaria prova, non potendo il danno alla professionalità reputarsi (in termini economicamente apprezzabili) come un effetto intrinseco e, pertanto, necessariamente riscontrabile in ogni genere di interruzione lavorativa anche perché il suddetto danno si atteggia, di volta in volta, con modalità ed in termini del tutto differenziati in ragione di ogni singola posizione lavorativa. Ciò premesso, deve ora evidenziarsi come il diritto in oggetto riceva adeguate forme di tutela nel sistema delle garanzie individuate dalla giurisprudenza in tema di risarcimento del danno da illegittimo licenziamento. Questa corte ha statuito che vanno detratti dal danno subìto dal lavoratore, in base alla regola del c.d. aliud perceptum, tutti quegli emolumenti che allo stesso sono stati corrisposti nel corso della sospensione del rapporto lavorativo (ad esempio: per l’attività spiegata presso altro datore di lavoro) e che il lavoratore non avrebbe percepito se non fosse stato licenziato. Nello stesso tempo i giudici di legittimità hanno anche riconosciuto al lavoratore il diritto ad ottenere il ristoro dei danni distinti ed «ulteriori» rispetto a quelli contemplati dalla disposizione del 4o comma dell’art. 18 statuto dei lavoratori. Mentre però la prova dell’aliud perceptum deve essere fornita dal datore di lavoro ex art. 2967 c.c., ai sensi di quest’ultima norma e dei principi in LE DISCRIMINAZIONI NEL RAPPORTO DI LAVORO 115 essa fissati, la prova dell’«ulteriore» danno incombe, invece, sul lavoratore (cfr. al riguardo, tra le altre, Cass. 5 giugno 1996, n. 5228; Cass. 29 marzo 1996, n. 2906; cui adde Cass. S.U. 3 febbraio 1998, n. 1099). La tutela risarcitoria contemplata dall’art. 18 garantisce al lavoratore soltanto le perdite patrimoniali, mentre non pone rimedio ai danni di natura non patrimoniale. La giurisprudenza prima e la norma ora pongono rimedio, riconoscendo la risarcibilità del danno non patrimoniale anche al di fuori dell’illecito penale. Il lamentato danno andrà risarcito in linea con le statuizioni della Suprema Corte, segnatamente in ragione di quanto statuito con la sentenza delle Sezioni Unite 24 marzo 2006, n. 6572: In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. 3. In cui si discute di un’ipotesi dalle conseguenza dirompenti:i licenziamento per malattia come possibile licenziamento discriminatorio All’art. 1 della direttiva 2000/78/CE, si legge. 116 GIURISPRUDENZA La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. Considerato che nella direttiva non è definita la nozione di handicap, il giudice spagnolo, investito dell’accertamento della legittimità di un licenziamento comminato in costanza di malattia, rimetteva alla Corte di Giustizia la controversia per sapere se il concetto di malattia possa rientrare nel concetto di handicap, con conseguente qualificazione del licenziamento per malattia come licenziamento discriminatorio. L’obiettivo del giudice spagnolo era capire se è giustificato trattare diversamente il licenziamento motivato dall’handicap rispetto al licenziamento determinato dallo stato di malattia, dal momento che entrambi vanno ad incidere sullo stesso diritto fondamentale, costituzionalmente protetto, ossia sul diritto alla salute del lavoratore. La Corte di Giustizia, con sentenza 11 luglio 2006,in causa C. 13/05 ha statuito che la malattia in quanto tale non può essere considerata un motivo che si aggiunge a quelli in base ai quali la direttiva 2000/78 vieta qualsiasi discriminazione. Tale conclusione è stata criticata da Fabris in Il licenziamento per malattia è valido o discriminatorio (in Giur. Lav., 2007, n. 6, 551), dove si legge: Non si può negare infatti che l’impedimento provocato dalla malattia abbia la stessa natura di quello provocato dalle cause indicate nominativamente dall’art. 1 della direttiva – età, religione, convinzioni personali, tendenze sessuali; correlativamente, la malattia presenta, nel mondo del lavoro, le medesime potenzialità di indurre ad un trattamento discriminatorio come definito dall’art. 2 della direttiva. La lettura resa dal commentatore potrebbe dare spazio ad una rivisitazione,in maniera rilevante, delle conseguenze del licenziamento per malattia. 4. In cui si discute della tutela giurisdizionale prevista nei decreti legislativi del 2003 La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti discriminatori per ragioni legate alla razza, all’origine etnica, alla religione, alle convinzioni personali, agli handicap, all’età e all’orientamento sessuale – secondo la previsione degli articoli 4, comma 1, e 4, comma 2, rispettivamente dei d.lgs. n. 215/2003 e n. 216/ 2003 – si svolge nelle forme previste dall’art. 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, approvato con d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286. LE DISCRIMINAZIONI NEL RAPPORTO DI LAVORO 117 Gli articoli in commento fanno esplicito riferimento agli atti e ai comportamenti di cui agli artt. 2 dei decreti: in realtà, il riferimento deve considerarsi di carattere esemplificativo e, pertanto, comprende anche le disposizioni, i criteri, le prassi e i patti di cui vi è menzione, in maniera analitica, al punto b) dei predetti articoli. Con riferimento all’art. 44 è stato evidenziato che si tratta di un procedimento atipico, che ricalca nella struttura il rito cautelare disciplinato dagli artt. 669-bis ss. del codice di procedura civile. Tale interpretazione (che individua come necessarie due fasi di cognizione, una sommaria e una piena) prende le mosse soprattutto dalla circostanza che il comma 7 dell’articolo in questione prevede che con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale... (e, quindi, prevede una decisione che definisce il giudizio, diversa dall’ordinanza di accoglimento o di rigetto della domanda prevista dal comma 4). Gli artt. 4 dei decreti nn. 215 e 216 del 2003 non prevedono, tuttavia, un richiamo al comma 7 dell’art. 44, ma, anzi, introducono una nuova disposizione (rispettivamente il comma 4 dell’art. 4 del d.lgs. n. 215/2003 e il comma 5 dell’art. 4 del d.lgs. n. 216/2003), secondo la quale con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti... Non esiste più, pertanto, una decisione che definisce il giudizio e con cui il giudice può procedere alla condanna del convenuto al risarcimento del danno, ma il Giudice, con lo stesso provvedimento con cui accoglie il ricorso (volto ad ottenere la cessazione del comportamento pregiudizievole e la cessazione degli effetti della discriminazione), può procedere alla condanna al risarcimento dei danni. Questa peculiarità induce a dubitare che l’attuale procedimento previsto dagli articoli 4 dei due decreti in commento sia calibrato su due fasi necessarie di giudizio, una cautelare e l’altra di merito, e porta a ritenere che lo stesso sia un procedimento speciale che si chiude con un’ordinanza, reclamabile dinnanzi alla Corte d’Appello. La normativa indicata garantisce la possibilità di adire il giudice, mediante un ricorso di parte, nell’ipotesi in cui sia attuata una discriminazione basata su uno dei fattori indicati dai decreti legislativi del 2003, al fine di ottenere un ordine di cessazione del comportamento pregiudizievole e l’adozione di ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere le conseguenze della discriminazione. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla 118 GIURISPRUDENZA parte, nella cancelleria del tribunale del luogo di domicilio dell’istante: si tratta di un foro esclusivo, stabilito per favorire la posizione del lavoratore e soprattutto per tutelare il lavoratore straniero, permettendo allo stesso di incardinare il procedimento nel luogo in cui ha la sede principale dei suoi affari e interessi. È necessaria una precisazione: il fatto che sia data la possibilità all’istante di depositare anche personalmente il ricorso comporta il riconoscimento della facoltà, per il ricorrente, di promuovere l’azione e di stare in giudizio anche senza l’assistenza di un difensore. Il tribunale in composizione monocratica, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. Per quanto riguarda l’audizione delle parti, questa riguarda non solo i diretti interessati, ma anche, trattandosi di litisconsorzio necessario, il prestatore di lavoro che dovesse essere stato favorito dal comportamento discriminatorio. In tale fase, il giudice potrà assumere tutti i mezzi di prova previsti per il giudizio di cognizione, in quanto indispensabili, ovvero assolutamente indispensabili in riferimento ai presupposti e alle finalità del provvedimento richiesto; a differenza di quanto previsto per il processo del lavoro dall’art. 421 c.p.c., la norma non contiene un esplicito riferimento ai poteri ufficiosi del giudice, il quale, nel rispetto del principio dell’onere di allegazione dei fatti, che spetta ex art. 112 c.p.c. alle parti, può disporre d’ufficio solo i mezzi di prova indispensabili. Terminata l’istruttoria, il giudice provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda: se accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi e tale esecutività non viene meno con la proposizione del reclamo. Nei casi d’urgenza, ovvero quando sia grave il pregiudizio che il soggetto discriminato potrebbe subire da un procedimento non rapido e audita altera parte, il giudice provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni; in tal caso, fissa con lo stesso decreto l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all’istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. Contro i provvedimenti emessi dal giudice è ammesso reclamo alla Corte d’Appello nei termini indicati all’art. 739, comma 2, c.p.c.; si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737, 738 e 739 c.p.c. In sede di reclamo, il procedimento si svolge in camera di consiglio. Nell’ipotesi in cui venga elusa l’esecuzione di un provvedimento emesso dal giudice in sede di reclamo, trova applicazione l’art. 388, comma 1, c.p., che preve- LE DISCRIMINAZIONI NEL RAPPORTO DI LAVORO 119 de la sanzione penale della reclusione o della multa: tale previsione induce a sottolineare che tali misure non risolvono il consueto problema di come provvedere in concreto alla rimozione delle discriminazioni realizzate con comportamenti omissivi o alla rimozione del pregiudizio arrecato da un atto datoriale che abbia beneficiato un lavoratore e svantaggiato illegittimamente il soggetto istante. Si introducono, inoltre, due sanzioni accessorie. In primo luogo, l’accertamento di atti o comportamenti discriminatori posti in essere da imprese – alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni ovvero che abbiano stipulato contratti d’appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture – è immediatamente comunicato dal giudice, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o agli enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie o dell’appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l’esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie e creditizie ovvero da qualsiasi appalto. La seconda sanzione accessoria consiste nella possibilità riconosciuta al giudice di ordinare la pubblicazione del provvedimento conclusivo del procedimento giudiziario, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale. L’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 215/2003 e l’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 216/2003, tuttavia, prevedono che Chi intende agire in giudizio per la sussistenza di una delle discriminazioni di cui all’art. 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 c.p.c. o, nell’ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all’articolo 5. Una volta depositato il ricorso, il procedimento si può chiudere in sede di conciliazione con le procedure previste dalla contrattazione collettiva o dalla legge o può proseguire, nel caso in cui il tentativo fallisca, in sede giudiziale. I decreti legislativi del 2003 riconoscono la possibilità al ricorrente di dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto in termini gravi, precisi e concordanti al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, che il giudice deve valutare ai sensi dell’art. 2729, comma 1, c.c. Ciò comporta che l’onere della prova rimane in capo all’attore, il quale è, però, facilitato nel dare la propria dimostrazione attraverso presunzioni semplici, potendo utilizzare dati statistici come indizi gravi e precisi della sussistenza della discriminazione. 120 GIURISPRUDENZA In pratica, dovendo nella prova per presunzioni sussistere un rapporto di causalità tra la premessa e la conseguenza che se ne deve trarre secondo l’id quod plerumque accidit, e cioè secondo un criterio di normalità, il dato statistico, nell’ipotesi normativa in commento, costituisce il criterio di normalità cui rapportare la congettura della presunzione. La prova statistica viene utilizzata soprattutto nei casi di discriminazione indiretta in cui il datore di lavoro pone a fondamento delle proprie scelte e dei propri comportamenti criteri solo in apparenza neutri, ma che, in realtà, mirano a svantaggiare e a produrre effetti negativi nei confronti di soggetti accomunati da un fattore di discriminazione. In tal caso possono essere allegati dati statistici relativi ai vari aspetti del rapporto di lavoro, dalle assunzioni alle progressioni di carriera, ai licenziamenti. La prova liberatoria, che grava in capo al datore di lavoro, consisterà, in caso di discriminazione diretta, nel provare la sussistenza di ragioni oggettive e soggettive, non riconducibili al motivo di differenziazione, tali da giustificare la disparità di trattamento; nell’ipotesi di discriminazione indiretta, nella contestazione dell’esistenza di un effetto proporzionalmente più svantaggioso per il lavoratore discriminato o nella dimostrazione dell’essenzialità del requisito oggetto di differenziazione per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Conseguentemente, il giudice, chiamato alla valutazione degli atti posti a base della discriminazione, deve, in presenza di un principio di prova che fondi la presunzione dell’esistenza della discriminazione, valutare l’oggettività della ragione addotta, la legittimità del fine perseguito, la necessità e la proporzionalità dei mezzi utilizzati dal datore di lavoro. Entrambi i decreti del 2003 stabiliscono che il giudice, con il provvedimento che accoglie il ricorso, dunque, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti della discriminazione compiuta. E, al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Ma, oltre a questo tipo di tutela, si prevede anche una tutela risarcitoria, che espressamente comprende il danno non patrimoniale, cioè il danno che deriva da ogni ingiusta lesione di un valore inerente la persona, costituzionalmente garantito, consistente in un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dall’art. 185 c.p. Questo comporta che in ipotesi di atto o condotta discriminatoria il soggetto leso potrà vedere ristorati, ad esempio, anche i patemi d’animo, le angosce, i mutamenti di abitudine, di ritmi di vita a cui è stato costretto a seguito dell’illecita violazione del principio di parità di trattamento. LE DISCRIMINAZIONI NEL RAPPORTO DI LAVORO 121 La valutazione del danno deve essere fatta dal giudice in via equitativa e in tale valutazione si dovrà tener conto di quanto espressamente indicato nei decreti, ovvero se l’atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale o un’ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento. Dunque, il giudice, al fine di determinare l’importo risarcitorio, destinato a subire, nella sussistenza dei menzionati presupposti di legge, un incremento rispetto a quello liquidabile in presenza di atto discriminatorio non ritorsivo, deve verificare, secondo la prima indicazione data dal decreto, anche d’ufficio, sulla base di quanto risulta dagli atti, se il dipendente aveva già in precedenza azionato il rimedio giudiziale volto ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento. Oltre a questo, ai fini della completezza della valutazione, il giudice deve considerare se la condotta discriminante sia stata intenzionale o meno, ovvero l’elemento psicologico che ha sorretto l’agente, essendo ovviamente la colpa meno grave del dolo. Infatti, mentre per aversi condotta discriminatoria passibile di tutela inibitoria volta alla rimozione degli effetti dell’atto o della condotta illegittimi non occorre che il soggetto discriminante abbia agito con dolo o colpa, rilevando la condotta oggettivamente intesa, qualora il soggetto leso voglia ottenere il risarcimento del danno necessariamente verranno in rilievo gli elementi costitutivi della responsabilità civile, la quale richiede l’imputabilità dell’evento dannoso, almeno a titolo di colpa. In entrambi i decreti legislativi si considerano e si disciplinano l’azione individuale e collettiva: questo costituisce un passo probabilmente obbligatorio, atteso che già l’art. 44 del d.lgs. n. 286/1998 riconosceva la legittimazione a ricorrere contro le discriminazioni di carattere collettivo fondate sulla razza, l’etnia e la religione in capo alle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Peraltro, vi è da sottolineare che il legislatore, nell’affermare l’esperibilità di ricorsi di carattere collettivo in relazione a tutte le fattispecie discriminatorie contemplate nei decreti del 2003, non si è preoccupato di coordinare la disciplina della legittimazione attiva ivi contenuta con la disposizione stabilita dal citato art. 44. Di conseguenza, ad agire in giudizio contro inique disparità dovute alla razza o all’origine etnica dei soggetti colpiti, possono oggi essere sia gli organismi sindacali locali indicati dal d.lgs. n. 286/1998 sia le associazioni individuate con il decreto interministeriale previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 215/2003. Un’ulteriore carenza deve essere individuata nel fatto che i decreti legislativi del 2003 non operano alcuna distinzione tra i rimedi conseguibili dalla vittima della discriminazione che abbia esperito un ricorso individuale (in proprio o tramite 122 GIURISPRUDENZA delega), da un lato, e dagli enti legittimati a promuovere giudizi di carattere collettivo, dall’altro. Il d.lgs. n. 215/2003 individua con precisione i titolari della legittimazione attiva (v. artt. 5 e 6 del predetto decreto); il legislatore, però, non ha usato la stessa precisione nell’ambito del d.lgs. n. 216/2003, nel quale si fa riferimento alle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tale diversificazione suscita delle perplessità: da un lato, si pensi ai diritti di quei soggetti che per le loro caratteristiche (v. tendenze sessuali o appartenenza religiosa) possono essere tutelati in maniera più efficace da un’associazione o un ente che della lotta a quelle peculiari discriminazioni fa la propria ragion d’essere, piuttosto che da un’organizzazione sindacale; dall’altro, non sembra in alcun modo argomentabile una tale differenziazione di disciplina. 5. In cui si discute della Legge 1o marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione) In vigore dal 21 marzo 2006, la nuova legge sulla tutela giudiziaria delle persone con disabilità, pone una serie di interrogativi determinanti ai fini della sua piena applicazione. Con l’ambizioso richiamo all’art. 3 della Costituzione, l’art. 1 della legge in questione si fa carico della «piena attuazione» della legge 104/1992 (art. 3: È disabile colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), inserendo, però, immediatamente, un limite di applicabilità, giacché esclude che la normativa possa fare riferimento alla disparità di trattamento nel campo del diritto del lavoro, perché in quest’ultimo caso sarà applicabile il d.lgs. n. 216/2003, che a sua volta ha recepito la Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 6. In cui si discute del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) e della direttiva n. 54/2006 Il Codice, entrato in vigore il 15 giugno 2006, raccoglie in un unico testo ben 11 leggi sulle pari opportunità e si compone di 59 articoli con l’obiettivo di razionalizzare l’attuale panorama legislativo al fine di divulgare sempre più e in modo migliore le regole e le prescrizioni sulle pari opportunità. LE DISCRIMINAZIONI NEL RAPPORTO DI LAVORO 123 In tale disciplina vengono ricompresi diritti e tutele che prima erano dispersi in vari testi normativi e presentavano sensibili disomogeneità. Si tratta di un riordino tecnico-giuridico che ha cercato di razionalizzare l’esistente. Il provvedimento si suddivide in 4 libri: – Libro I: Disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna; – Libro II: Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti etico-sociali; – Libro III: Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici; – Libro IV: Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti civili e politici. Dopo un lungo iter legislativo, con questo provvedimento trova formale riconoscimento il paritario contributo della donna allo sviluppo sociale e politico dello Stato e vengono definiti i concetti di discriminazione diretta e indiretta, discriminazione retributiva, molestie sessuali, accesso al lavoro all’interno del settore lavorativo e imprenditoriale. Una novità è costituita dall’abrogazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215 concernente «Azioni positive per l’imprenditoria femminile», lasciando, peraltro, piena autonomia alle Regioni di predisporre piani e progetti di sostegno adeguati. Il decreto legislativo – che ha fatto opera di semplificazione e di definizione dei concetti di discriminazione basate sul sesso sembra, però, già suscettibile di modifiche in ragione della direttiva n. 54/2006. Detta direttiva, che è entrata in vigore il 15 agosto 2006 e dovrà essere recepita dal nostro ordinamento entro il 15 agosto 2008, definisce nuovi ambiti processuali e sostanziali per le pretese risarcitorie del discriminato. Al riguardo, tra l’altro, si evidenzia: a) L’art. 40 del d.lgs. n. 198/2006 stabilisce: Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all’assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l’onere della prova sull’insussistenza della discriminazione. Con tale formulazione il legislatore ha ritenuto di dover modificare, seppure parzialmente, il principio dell’onere della prova (il che dimostra, ancora una volta, la necessità di adeguare in tal senso i d.lgs. nn. 215 e 216 del 2003, come già auspicato in precedenza); la prova, infatti, incombe al convenuto, ma solo e in quanto il ricorrente fornisca elementi di fatto idonei a fondare in termini precisi e concordanti la presunzione di atti discriminatori. La direttiva, però, all’art. 19, stabilisce che gli stati membri devono porre a ca- 124 GIURISPRUDENZA rico di parte convenuta l’onere di provare l’insussistenza del principio di parità a fronte della produzione da parte del ricorrente di soli elementi di fatto in base ai quali si possa presumere la discriminazione, eliminando, quindi, il riferimento ad elementi precisi e concordanti. b) L’art. 38 del d.lgs. n. 198/2006 prevede che il ricorso sia presentato dal lavoratore o dalle organizzazioni sindacali o dalla consigliera ovvero consigliere di parità. La direttiva, invero, all’art. 17, estende questo principio, riconoscendo questa facoltà ad associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche che abbiano un legittimo interesse al rispetto delle disposizioni della direttiva stessa. c) Lo stesso art. 38 d.lgs. n. 198/2006 stabilisce, poi, che il giudice, se richiesto, provvede a liquidare il risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordinando all’autore del comportamento denunciato, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. La direttiva, all’art. 25, affrontando in maniera più incisiva il problema, sancisce che le sanzioni che possono prevedere un risarcimento dei danni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Va da sé che la tutela approntata dalla nuova direttiva è sicuramente maggiore di quella prevista dal nostro ordinamento considerato che le sanzioni determinate dalla norma debbono essere in primo luogo dissuasive. Ci auguriamo di aver compiutamente rappresentato le norme «antidiscriminatorie» esistenti nel nostro ordinamento e che questo modesto contributo possa essere utile base per i necessari approfondimenti. Ringraziamo la rivista che ci ha dato l’opportunità di esporre le nostre riflessioni. Gianni Barillari Sandro Grandese Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, 17 aprile 2007 – Giudice dott. Eduardo Campese Motivi della decisione M.P., qualificandosi erede legittimo, in quanto unico figlio, di F.P., deceduto il ***, ha chiesto, in primo luogo, la declaratoria di simulazione relativa per l’allegato atto di compravendita stipulato dal notaio G.I., in data ***, tra C.Z., vedova P., ed il marito, F.P., avente ad oggetto diritti pari alla metà della piena proprietà dell’immobile sito in ***, perché dissimulante una donazione tra le medesime parti da ritenersi, altresì, nulla perché rogata, in violazione dell’alt. 48 della legge notarile, previa rinuncia all’assistenza dei testimoni. Ha sostenuto, in particolare, che malgrado nel menzionato rogito fosse stato indicato in £. 110.000.000 il prezzo pattuito, dandosi poi atto che lo stesso era stato corrisposto mediante n. 7 assegni circolari – di cui si erano indicati gli estremi – emessi all’ordine del venditore che, ricevendoli, ne aveva rilasciato quietanza, in realtà detto pagamento non aveva avuto luogo atteso che le somme costituenti la provvista di tali assegni erano risultate non provenienti dal conto corrente della compratrice, per essere poi attribuite al venditore, bensì da un conto corrente, esistente presso l’agenzia ***, intestato a *** che, nella loro interezza, le aveva versate ed incassate tramite girata per conoscenza e garanzia presso lo stesso istituto bancario e medesima agenzia. In buona sostanza, quindi, secondo la prospettazione attorea, i patrimoni personali, sia del venditore che della compratrice, erano rimasti del tutto immutati in rapporto al versamento di tale prezzo atteso che i predetti titoli, opportunamente emessi all’ordine di F.P. ma da lui mai incassati, erano del tutto fittizi e finalizzati ad occultare l’effettiva causa donativa sottesa al rogito in esame. C.Z., vedova P., invece, ha contestato la legittimazione ad agire dell’attore, ex art. 1415, secondo comma, C.c., quale terzo legittimato a richiedere la dissimulazione del negozio, ed ha comunque concluso per il rigetto dell’avversa istanza assumendo che il citato rogito *** era una regolare compravendita in cui l’assenza dei testimoni costituiti in atto era giustificata proprio dal fatto che, diversamente da quanto sostenuto da controparte, non si trattava di donazione, né reale, né fittizia. Tanto premesso, rileva il Tribunale che alcun dubbio può sussistere circa il fatto che M.P. debba considerarsi erede del defunto genitore, F.P. Precisato, infatti, che erede è colui che subentra nella generalità (heres ex asse) delle posizioni attive e passive del defunto od in una quota ideale di essa (heres ex parte), eccettuati i diritti specificamente attribuiti al successore a titolo particolare, va subito evidenziato che, nella specie, l’odierno attore è stato formalmente istituto erede di F.P. nel testamento olografo di quest’ultimo datato 7.11.2001, pubblicato in data 11.3.2004. Come è noto, però, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 485 c.c. (cfr. Cass. 6.5.2002, n. 6479). Orbene, nella fattispecie de qua, pur in assenza di un formale atto di accettazione dal parte dell’attore, appare indubbio che quest’ultimo abbia accettato, almeno tacitamente (cfr. art. 476 c.c.), l’eredità paterna. Invero, premettendosi che l’accettazione tacita dell’eredità può desumersi, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, soltanto dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede, trattandosi di un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l’eredità, e considerandosi altresì che l’indagine relativa all’accettazione tacita deve essere effettuata dal giudice di merito caso per caso, – valutandosi la peculiarità di ogni singola fattispecie, tenendosi 126 GIURISPRUDENZA conto di molteplici fattori, tra i quali quelli della natura e dell’importanza, nonché della finalità degli atti di gestione, che siano stati compiuti dal chiamato – non sembra allora potersi seriamente dubitare del fatto che M.P. tramite l’esercizio, nell’affermata veste di «... erede legittimo quale unico figlio di F.P....» dell’odierna azione – o comunque tramite quella di impugnazione del suddetto testamento intrapresa in danno della medesima convenuta con citazione notificatale il 24.1.2005 – abbia posto in essere un atto presupponente necessariamente la volontà di accettare la suddetta eredità (quanto alla possibilità di attribuire il valore di un’accettazione tacita dell’eredità all’impugnativa del testamento, cfr. Cass. 28.6.1993, n. 7125), producendosi peraltro tale effetto, ex art. 459 c.c., fin dal giorno dell’apertura della successione. Va sottolineato, poi, che, in quanto figlio legittimo del testatore F.P., e per effetto della già avvenuta accettazione, sia pure tacita, dell’eredità paterna, l’istante deve altrettanto indubbiamente considerarsi [erede] legittimario (cfr. art. 536 c.c.), e ciò indipendentemente dal fatto che la quota ereditaria riservatagli dal padre nel già citato testamento olografo datato 7.11.2001 corrisponda, o meno, a quella prevista dall’art. 542, primo comma, c.c. (nella specie, infatti, non si è certamente in presenza di un legittimario pretermesso). Ciò chiarito, rileva lo scrivente che la domanda in esame ripropone una tematica più volte affrontata dalla Suprema Corte nei casi, non infrequenti, in cui l’esito positivo dell’azione dichiarativa della simulazione, proposta dall’erede legittimario, riveli un sottostante atto dispositivo compiuto dal de cuius affetto da nullità, la cui declaratoria comporta il rientro del bene nel patrimonio ereditario. In proposito, costituisce opinione del tutto prevalente nella giurisprudenza di legittimità in materia che, ai fini della prova della simulazione d’una vendita posta in essere dal de cuius onde dissimulare una donazione, l’erede possa essere considerato terzo ed, in quanto tale, beneficiare delle agevolazioni probatorie previste dall’art. 1417 c.c. solo quando, contestualmente all’azione intesa alla dichiarazione della simulazione, proponga, facendo valere anche la sua qualità di legittimario e sulla specifica premessa che l’atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale all’integrità della quota di riserva spettategli, un’espressa e concreta domanda di riduzione (o nullità od inefficacia) della donazione dissimulata diretta a far dichiarare, in aggiunta all’appartenenza del bene all’asse ereditario, che la quota di riserva di sua pertinenza deve essere calcolata tenendo conto del bene stesso, non anche quando si sia limitato a chiedere l’accertamento della simulazione nell’ambito d’una petitio hereditatis ma senza alcuna connessa ed esplicita domanda di reintegrazione della legittima. Ciò in quanto l’erede legittimo, il quale miri semplicemente a far rientrare nella massa ereditaria un bene che assume solo apparentemente uscito dal patrimonio del de cuius, non lamenta lesione alcuna dei diritti successori a lui personalmente riconosciuti dall’ordinamento nella sua qualità anche di legittimario ma fa valere, nella sua sola qualità di successore universale subentrato mortis causa in tutti i rapporti già facenti capo al de cuius, un diritto ricompreso nel patrimonio di quest’ultimo, onde, venendosi a trovare nella medesima posizione del de cuius medesimo, rispetto al rapporto controverso incontra, non diversamente che per tutti gli altri rapporti già facenti capo allo stesso, tutte le limitazioni probatorie alle quali anche quegli sarebbe stato soggetto (cfr., sostanzialmente in tal senso, ex multis, Cass. 24.3.2006, n. 6632; Cass. 6.10.2005, n. 19468; Cass. 28.10.2004, n. 20868; Cass. 30.7.2004, n. 14562; Cass. 18.4.2003, n. 6315; Cass. 30.7.2002, n. 11286; Cass. 24.2.00, n. 2093; Cass. 21.4.98, n. 4024; Cass. 29.5.95, n. 6031; Cass. 29.10.94, n. 8942; Cass. 4.4.92, n. 4140; Cass. 6.8.90, n. 7909; Cass. 21.12.87, n. 9507). È da notare, al riguardo, che – a prescindere dal testo delle massime, non sempre esattamente rispondente alle argomentazioni sviluppate nelle sentenze ed ai principi dalle stesse desumibili – ove si ponga attenzione alle motivazioni risulta agevole rilevare come l’esonero dalle limitazioni probatorie della simulazione sia stato riconosciuto all’erede legittimo, e negato in caso contrario, sempre solo ed in quanto questi avesse contestualmente allegato che il suo diritto alla quota di riserva non poteva trovare soddisfazione sui beni relitti o, comunque, che la quota di riserva stessa doveva essere calcolata tenendo conto anche del bene la cui simulata alienazione era stata dedotta in giudizio; LA PROVA DELLA SIMULAZIONE DA PARTE DEL LEGITTIMARIO 127 presupposto sul quale si basano anche le decisioni con le quali è stata ritenuta possibile l’estensione degli effetti del detto esonero nel caso in cui, propostasi dal legittimario impugnazione dell’atto per simulazione, il relativo accoglimento, sulla base di prove consentitegli in quanto terzo, si riflettesse poi anche sull’azione dallo stesso contestualmente proposta quale erede per la riacquisizione del bene al patrimonio ereditario (cfr. Cass. 30.7.2004, n. 14562; Cass. 2.2.99, n. 848; Cass. 25.2.87, n. 1999). Non è, poi, da ritenere condivisibile, e non solo perché isolata, l’opinione espressa da Cass. 1.4.97, n. 2836 massimata nel senso che «Il legittimario che per far valere il suo diritto alla quota di riserva chiede l’accertamento della simulazione e la nullità, per difetto dei requisiti di forma, di un atto dissimulato, stipulato dal de cuius – nella specie donazione dissimulata da una vendita per scrittura privata – non ha bisogno di esperire contestualmente la domanda di riduzione – necessaria invece nel caso in cui l’atto dissimulato è valido – per non soggiacere ai limiti di prova previsti dall’art. 1417 c.c., perché l’accoglimento di detta domanda di nullità comporta la declaratoria di appartenenza det relativo bene all’asse ereditario, con conseguente calcolo di esso nella determinazione della quota spettante al suddetto legittimario». In realtà, nella fattispecie processuale ad essa relativa, la domanda di riduzione era stata formalmente proposta, sia pure in via subordinata rispetto alla principale di simulazione e nullità, e la Corte, in assoluta conformità al già richiamato indirizzo, ha ritenuto inapplicabili i limiti alla prova della simulazione proprio sulla considerazione che la principale fosse stata proposta «allo specifico fine del recupero della sua quota di riserva»; quella che non appare condivisibile, invece, è l’ulteriore considerazione per cui «l’applicazione dei limiti probatori della simulazione era già esclusa dalla formulazione congiunta delle istanze di simulazione e di nullità volte, nel loro complesso, a fare riapparire nel patrimonio del de cuius il bene oggetto della liberalità». Invero, la circostanza che la pronuncia di simulazione resa nel giudizio di petizione ereditaria promosso dal soggetto il quale abbia agito nella sola sua qualità d’erede legittimo possa giovare, indirettamente e di fatto, al soggetto medesimo anche nella sua diversa e distinta qualità di legittimario, non fatta valere in quel giudizio con azione intesa alla tutela dei relativi diritti, ai fini della determinazione in altra sede della quota di riserva e dell’esperimento d’una possibile azione di riduzione, è del tutto irrilevante nel detto giudizio di petizione ereditaria, laddove la legitimatio ad causam, la causa petendi ed il petitum dedotti, attenendo unicamente alla situazione giuridica della parte stessa che ha posto in essere il negozio simulato, in quanto assunta dal successore in universum ius dell’originario contraente, ostano, ex art. 1417 c.c., alla prova della simulazione con ogni mezzo, questa essendo consentita ai soli terzi estranei al negozio e non alle parti di esso. Né la simultanea proposizione delle azioni di simulazione e nullità, in quanto volte «nel loro complesso» a far riapparire nel patrimonio del de cuius il bene oggetto della liberalità, può di per sé sola portare ad escludere l’applicabilità dei limiti probatori della simulazione nel giudizio svolgentesi tra le parti del negozio assunto come simulato: anzitutto, in quanto nel detto giudizio l’unico vizio deducibile onde beneficiare dell’esonero dai detti limiti è l’illiceità e non la nullità del negozio dissimulato, onde la parte che di quest’ultimo deduca la nullità in una alla simulazione di quello impugnato non per questo è ammessa a fornire con ogni mezzo la prova della simulazione; in secondo luogo, perché alla disamina della questione di nullità del negozio dissimulato per un vizio ad esso proprio si può procedere, per l’inderogabile ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni che impone l’esame di quella presupposta prima di quella presupponente, solo ove sia già intervenuto l’accertamento della simulazione del negozio apparente e della consequenziale sussistenza di quello dissimulato, onde le domande di simulazione e di nullità non possono essere considerate «nel loro complesso» e la decisione sulla simulazione non può essere influenzata, neppure in relazione all’ammissibilità o meno di determinati mezzi istruttori, dalla considerazione che il negozio dissimulato possa poi, con successivo ed autonomo capo di decisione, essere riconosciuto invalido, così determinandosi la riacquisizione del bene al patrimonio ereditario ed indirettamente giovando al legittimario eventualmente leso nella quota di riserva (risultato, comunque, irrilevante, come già evidenziato). 128 GIURISPRUDENZA Tali essendo, allora, i principi da utilizzarsi per la decisione della presente domanda dell’attore, va osservato che dal complessivo tenore dei suoi scritti difensivi, oltre che dei verbali di causa, emerge, con tranquillante certezza, che lo stesso, pur allegando la propria qualità di erede (anche legittimario) del defunto genitore, non ha però in alcun modo prospettato che l’atto impugnato aveva anche concretato una violazione dei propri diritti ereditari. Egli, infatti, oltre alle domande, proposte in via principale, dirette ad ottenere l’accertamento della simulazione (relativa) della compravendita di cui al rogito *** del 26.10.2001 e la successiva declaratoria di nullità per vizio di forma della donazione da quest’ultimo dissimulata, non ha formulato, nemmeno in via gradata, all’uopo facendo specificamente valere anche la sua qualità di legittimario ed ipotizzando una lesione del suo diritto personale all’integrità della quota di riserva spettantegli, alcuna istanza diretta a far dichiarare, in aggiunta all’appartenenza del bene all’asse ereditario (conseguente alla invocata nullità della donazione dissimulata dal citato rogito *** del 26.10.2001), che la quota di riserva di sua pertinenza doveva essere calcolata tenendo conto del bene stesso. Può quindi ragionevolmente affermarsi che, così agendo, M.P. abbia mirato semplicemente a far rientrare nella massa ereditaria un bene a suo giudizio solo apparentemente uscito dal patrimonio del de cuius, non lamentando, contestualmente, alcuna lesione dei diritti successori a lui personalmente riconosciuti dall’ordinamento nella sua qualità anche di legittimario: egli, cioè, nella sua sola qualità di successore universale subentrato mortis causa, e nei limiti della quota riconosciutagli dal testamento olografo del proprio genitore datato 7.11.2001, nei rapporti già facenti capo al de cuius, ha inteso far valere un diritto ricompreso nel patrimonio di quest’ultimo, onde, venendosi a trovare nella medesima posizione del de cuius medesimo, rispetto al rapporto controverso incontra, non diversamente che per tutti gli altri rapporti già facenti capo allo stesso, tutte le limitazioni probatorie alle quali anche quegli sarebbe stato soggetto. In definitiva, quindi, la circostanza che l’attore abbia svolto la propria domanda esclusivamente quale erede, e non anche quale legittimario intenzionato a far valere altresì la lesione del proprio diritto alla integrità della quota di riserva spettategli, comporta che lo stesso non possa qualificarsi terzo ai fini della prova, ex art. 1417 c.c., della simulazione degli atti posti in essere dal de cuius, per cui, per dimostrare l’asserita simulazione della compravendita intervenuta, il 26.10.2001, tra il proprio defunto genitore e l’odierna convenuta, giusta l’atto per notar *** n. *** rep. e *** racc., lungi dell’avvalersi della prova testimoniale o per presunzioni, avrebbe dovuto produrre, ai sensi dell’art. 2725 c.c., – vertendosi in tema di simulazione relativa riguardante un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam – un atto scritto, cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti, e comunque dalla parte contro la quale essa doveva farsi valere in giudizio, con salvezza della prova testimoniale nella sola ipotesi, prevista dall’art. 2724 n. 3 cod. civ., di perdita incolpevole del documento. Pertanto, non essendo stata fornita nei modi suddetti tale dimostrazione, né essendo stata minimamente allegata una perdita incolpevole della necessaria prova documentale, la sua domanda di declaratoria di simulazione (relativa) dell’indicato rogito *** del 26.10.2001 va respinta, assorbendo peraltro tale pronuncia ogni altra statuizione sulla ulteriore sua richiesta di declaratoria di nullità della donazione asseritamente dissimulata da quest’ultimo. (omissis)» LA PROVA DELLA SIMULAZIONE DA PARTE DEL LEGITTIMARIO La sentenza che qui si annota ripropone una tematica più volte affrontata in sede interpretativa, sin dal Codice previgente, in relazione all’ipotesi in cui l’accoglimento della domanda tendente all’accertamento della simulazione, proposta dall’erede, porti alla luce un sottostante atto dispositivo – posto in essere dal de cuius LA PROVA DELLA SIMULAZIONE DA PARTE DEL LEGITTIMARIO 129 – affetto da nullità, la cui declaratoria abbia come conseguenza il rientro del bene nell’asse ereditario. Più in specifico, il Tribunale si è trovato ad affrontare una vecchia questione che porta con sé un’altrettanto remota soluzione giurisprudenziale: quella, cioè, se l’attore che ha svolto la propria domanda esclusivamente quale erede con la hereditatis petitio – e non anche quale legittimario che intenda altresì far valere la lesione del proprio diritto all’integrità della quota di riserva– possa considerarsi «terzo» ai fini della prova ex art. 1417 c.c. In concreto M.P., assumendo di essere, nella qualità di unico figlio, erede legittimo di F.P. citava in giudizio C.Z., moglie del de cuius, chiedendo l’accertamento della simulazione relativa dell’atto di compravendita intervenuto tra la convenuta ed il marito perché dissimulante una donazione tra le stesse parti, da ritenersi altresì nulla, in quanto stipulata, in violazione dell’art. 48 della legge notarile, senza assistenza dei testimoni. La decisione del Giudice partenopeo, nel rigettare la domanda proposta da M.P., ribadisce l’orientamento giurisprudenziale prevalente (1) secondo il quale, in materia di prova della simulazione di una vendita posta in essere dal de cuius, solo il legittimario può essere considerato terzo – e, come tale, beneficiare dell’illimitato regime probatorio disposto dall’art. 1417 c.c. – a condizione che l’accertamento della simulazione sia dal medesimo invocato quale mezzo per conseguire, nello stesso giudizio e attraverso l’articolazione di un’apposita domanda, la tutela delle proprie ragioni, con l’inclusione del bene nella quota di sua spettanza. In sostanza, secondo l’orientamento anzidetto, accolto dalla pronuncia in esame, ai fini della prova della simulazione, l’erede che subentra nella posizione giuridica del defunto in seguito alla successione fa valere lo stesso diritto già spettante a quest’ultimo, sicché sul piano probatorio resta vincolato agli stessi limiti che facevano capo al de cuius, nei cui rapporti, per l’appunto, succede. Mutuando le parole del giudicante, «l’erede legittimo, il quale miri semplicemente a far rientrare nella massa ereditaria un bene che assume solo apparentemente uscito dal patrimonio del de cuius, non lamenta lesione alcuna ai diritti successori a lui personalmente riconosciuti dall’ordinamento nella sua qualità anche di legittimario ma fa valere, nella sua sola qualità di successore universale subentrato mortis causa in ( 1 ) Cfr., ex multis, Cass. 21 luglio 1984, n. 4274, in Mass. Giur. It, 1984; Id., 27 ottobre 1984, n. 5515, in Mass. Giur. It., 1984; Id., 21 febbraio 1986, n. 1049, in Mass. Giur. It., 1986; Id., 11 ottobre 1986, n. 5947, in Foro It., 1987, I, 1175; Id., 30 gennaio 1987, n. 893, in Mass. Giur. It., 1987; Id., 21 dicembre 1987, n. 9507, in Mass. Giur. It., 1987; Id., 6 agosto 1990, n. 7909, in Mass. Giur. It., 1990; Id., 4 aprile 1992, n. 4140, in Mass. Giur. It., 1992. 130 GIURISPRUDENZA tutti i rapporti facenti capo al de cuius, un diritto ricompreso nel patrimonio di quest’ultimo, onde, venendosi a trovare nella medesima posizione del de cuius medesimo, rispetto al rapporto controverso incontra, non diversamente che per tutti gli altri rapporti già facenti capo allo stesso, tutte le limitazioni probatorie alle quali anche quegli sarebbe stato soggetto». Il legittimario leso, invece, si ritiene «terzo», non tanto perché estraneo all’atto simulato, ma in quanto fa valere un diritto proprio, attribuitogli dall’art. 563 c.c., potendo così addivenire alla prova della simulazione senza limiti, a norma dell’art. 1417 c.c. (2). Alcune tecniche selettive, volte a determinare l’ambito applicativo della disposizione da ultimo citata, sono state fissate nel tempo dai discorsi della giurisprudenza i quali, anzitutto, ritengono che i soggetti destinatari del più ampio regime probatorio disposto in ordine al contratto simulato debbono essere individuati, non solo in relazione alla posizione assunta rispetto al contratto della cui simulazione si tratta, ma anche, e soprattutto, all’azione in concreto esercitata. Occorre, in altri termini, far dialogare l’astrattezza della norma con la concretezza della specifica fattispecie in un’ottica funzionale per vagliare, proprio in ordine alle specificità della domanda, l’estraneità, non solo formale, dell’agente all’atto in contestazione. In quest’ottica, nella nozione di «parti» debbono ricomprendersi anche gli eredi i quali, succedendo in universum jus, subentrano anche nelle azioni spettanti al de cuius incontrando, laddove intendano esercitarle, le stesse limitazioni probatorie di quest’ultimo. Combinando le disposizioni di cui all’art. 1417 c.c. e all’ultimo comma dell’art. 1415 c.c. è stato affermato che il criterio generale che consente di operare la qualificazione di un soggetto quale «terzo» consiste nel ravvisare nella domanda dal medesimo prospettata un’azione concretamente e direttamente volta ad eliminare il pregiudizio derivato ad «un diritto proprio» dall’assetto di interessi apparentemente regolato. Considerate queste premesse generali, nello scenario giurisprudenziale, con riferimento all’azione di simulazione esercitata dal legittimario, è dato distinguere diverse declinazioni delle stesse. In particolare, il punto rispetto al quale le motivazioni delle sentenze si discostano riguarda i presupposti in presenza dei quali il legittimario può essere qualificato «terzo» rispetto al rapporto contrattuale che vedeva come parte il de cuius. ( 2 ) A tale proposito v. Cass., 29 maggio 1995, n. 6031, in Corr. Giur., 1996, 1139, con nota di M.R. Morelli, Problemi vecchi e nuovi in tema di pretermissione del legittimario; Id., 29 ottobre 1994, n. 8942, in Mass. Giur. It., 1994; Id., 6 agosto 1990, n. 7909, in Mass. Giur. It., 1990. LA PROVA DELLA SIMULAZIONE DA PARTE DEL LEGITTIMARIO 131 A questo proposito si è ritenuto che tale qualificazione operi in tutti i casi in cui il legittimario, rispetto agli atti di disposizione posti in essere dal de cuius, eserciti unitamente all’azione di simulazione quella di riduzione (3). In sostanza, pur essendo in molti casi evidente che l’azione di simulazione esercitata dal legittimario è strumentale alla reintegrazione della legittima, si richiede, ai fini della qualificazione dell’attore-legittimario quale «terzo» la proposizione esplicita e contestuale anche dell’azione di riduzione. È quanto emerge a chiare lettere dalla motivazione della sentenza in commento laddove il Giudice indica come orientamento prevalente quello che, ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal de cuius onde dissimulare una donazione, considera terzo l’erede «solo quando, contestualmente all’azione intesa alla dichiarazione della simulazione, proponga, facendo valere anche la sua qualità di legittimario e sulla specifica premessa che l’atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale all’integrità della quota di riserva spettantegli, un’espressa e concreta domanda di riduzione (o nullità od inefficacia) della donazione dissimulata diretta a far dichiarare, in aggiunta all’appartenenza del bene all’asse ereditario, che la quota di riserva di sua pertinenza deve essere calcolata tenendo conto del bene stesso, non anche quando si sia limitato a chiedere l’accertamento della simulazione nell’ambito di una petitio hereditatis ma senza alcuna connessa ed esplicita domanda di reintegrazione della legittima». Il «naturale» connotato strumentale dell’azione di simulazione volta a svelare donazioni dissimulate (valide) rispetto alla riduzione, ha talvolta condotto i giudici a dichiarare l’inammissibilità della prima nel caso di intervenuta prescrizione della seconda; in tal modo il legittimario che agisce in simulazione senza poter ottenere il ripristino della legittima per intervenuta prescrizione della relativa azione dovrebbe essere ritenuto privo dell’interesse ad agire (4). È evidente la debolezza di tale argomento giacché l’azione di simulazione, pur essendo necessaria per ottenere la successiva riduzione delle donazioni implicate, non può ritenersi sempre e solo strumentale a tali fini. Senz’altro isolata, ma non per questo priva di rilievo, è quella pronuncia della Corte di legittimità, altresì presa in esame ma disapplicata dal Tribunale napoletano, secondo la quale «il legittimario che per far valere il suo diritto alla quota di riserva chiede l’accertamento della simulazione e la nullità, per difetto dei requisiti ( 3 ) Cfr., Cass., 11 ottobre 1986, n. 5957, in Mass. Giur. It., 1986; Id., 30 gennaio 1987, n. 893, in Mass. Giur. It., 1987. Risultano orientate, in tal senso, anche alcune pronunce di merito quali, App. Milano, 19 luglio 1976; Trib. Roma, 3 ottobre 1992, in Giur. merito, 1993, 333. ( 4 ) In tal senso v. App. Milano, 19 settembre 1968, in Foro Pad., 1970, IV, 99. In dottrina cfr. G. Stolfi, In tema di prescrizione dell’azione di riduzione, in Riv. dir. proc., 1969, 146. 132 GIURISPRUDENZA di forma, di un atto dissimulato, stipulato dal de cuius – nella specie donazione dissimulata da una vendita per scrittura privata – non ha bisogno di esperire contestualmente la domanda di riduzione – necessaria invece nel caso in cui l’atto dissimulato è valido – per non soggiacere ai limiti di prova previsti dall’art. 1417 c.c., perché l’accoglimento di detta domanda di nullità comporta la declatoria di appartenenza del relativo bene all’asse ereditario, con conseguente calcolo di esso nella determinazione della quota spettante al suddetto legittimario». In tale pronuncia, dunque, se da una parte si conferma il principio che il legittimario non è soggetto ai limiti probatori previsti dall’art. 1417 c.c. poiché assume la qualità di terzo nel momento in cui agisce per far valere il proprio personale diritto alla quota di riserva, dall’altra si afferma che il legittimario non sempre, a tali fini, è tenuto a promuovere l’azione di simulazione congiuntamente a quella di riduzione, ritenendosi quindi – e qui sta la novità rispetto all’orientamento consolidato – che la proposizione di ambedue le domande sia necessaria solo nel caso in cui non sia posta in dubbio la validità del negozio dissimulato. La qualifica di «terzo» è stata da alcune sentenze esclusa in capo al legittimario che agisce per ottenere sia la reintegrazione della quota di riserva che di quella disponibile (5); in altre occasioni, viceversa, si è ritenuto che l’esonero del legittimario dai limiti probatori di cui all’art. 1417 c.c. non ha ragione di conoscere un trattamento differenziato laddove l’azione sia volta non solo ad incidere sulla determinazione della quota indisponibile ma pure a far riacquisire il bene al patrimonio ereditario (6). Più precisamente si è statuito che «in tema di accertamento della simulazione di atti compiuti dal de cuius, l’esonero dalle limitazioni probatorie a favore del legittimario, che agisca per il recupero e la reintegrazione della legittima, non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso in parte, nel caso in cui l’impugnazione dell’atto sia destinata a riflettersi non soltanto sulla determinazione della quota di riserva, ma anche sulla riacquisizione al patrimonio ereditario del bene formante oggetto del negozio simulato, in modo che il legittimario venga ad avvantaggiarsene sia in tale sua qualità, sia in quella di successore a titolo universale. Ne consegue che, in tal caso, il legittimario in quanto terzo rispetto all’atto simulato, è esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non potendosi applicare, rispetto ad un unico atto che si assume simulato, per una parte una regola probatoria e per un’altra una regola diversa» (7). ( 5 ) In questo senso v. Cass., 24 giugno 1961, n. 1514, in Foro It., 1961, I, 1466; Id., 22 giugno 1962, n. 1627, in Mass. Giur. It., 1962; Id., 21 febbraio 1966, n. 522, in Giust. Civ., 1966, I, 854; Id., 1 aprile 1974, n. 913, in Giur. It., 1975, I, 1, 953; Id., 6 agosto 1990, n. 7908, in Mass. giur. it., 1990. ( 6 ) Cfr. Cass., 2 aprile 1977, n. 1244, in Foro It., 1977, I, 1701; Id., 5 gennaio 1980, n. 66, in Giur. It., 1980, I, 1, 802; Id., 9 febbraio 1987, n. 1338, in Mass. Giur. It., 1987. ( 7 ) Cass., 6 ottobre 2005, n. 19468 in Giust. civ., 2006, I, 1505. Vedi anche Cass., 30 luglio 2004, n. LA PROVA DELLA SIMULAZIONE DA PARTE DEL LEGITTIMARIO 133 Alla rassegna anzidetta si aggiungono pronunce giurisprudenziali che operano la qualificazione del legittimario alla stregua di «terzo» prescindendo dalla circostanza che l’atto simulato sia stato preordinato dal de cuius a ridurre in tutto o in parte la quota riservata al legittimario o ad altri fini pregiudizievoli (8). I diversi orientamenti della giurisprudenza concernenti il regime probatorio applicabile all’azione di simulazione esercitata dai legittimari si annidano attorno all’individuazione del criterio che consente la qualificazione del legittimario come «terzo». Peraltro, come è stato giustamente osservato, in questi casi ci si riferisce in particolare al legittimario che agisce per la riduzione (9). È in ragione di ciò che, come abbiamo osservato, le difficoltà sorgono laddove il legittimario esperisce l’azione di simulazione non solo per ripristinare la quota di riserva ma anche per ottenere l’intera quota ereditaria. In sostanza si tratta di capire se la simulazione provata solamente a seguito dell’esonero dall’osservanza degli artt. 2722 e 2704 c.c., consente di accogliere la domanda soltanto fino a concorrenza della riserva. La giurisprudenza è oggi orientata per la soluzione più larga (10). Si comprende come la diversità dei criteri che consentono la qualificazione del legittimario ai fini dell’esonero dai limiti probatori di cui all’art. 1417 c.c. sia ricca di implicazioni, non solo sul piano pratico. Invero, alcune ricostruzioni conducono, tra l’altro, ad un trattamento differenziato ingiustificato del soggetto che agisce come legittimario, sia sul piano sostanziale che su quello processuale. Per chiarire meglio le nostre considerazioni è necessario volgere l’analisi alle speculazione della dottrina in materia (11). Alcuni Autori dissentono dalla possibilità di ravvisare nel legittimario un soggetto «terzo», a norma dell’art. 1417 c.c., ogni qualvolta costui agisce in simulazione contro gli atti dispositivi posti in essere dal de cuius (12). La premessa argomentativa di tale ricostruzione è che nella materia successoria quando si guarda al legittimario che agisce come «terzo» e non come «successore universale» ci si riferisce ad un suo «agir contro» la volontà del de 14562 in, Mass. Giur. It., 2005; Id., 18 aprile 2003, n. 6315, in Mass. Giur. It., 2003; Id., 2 febbraio 1999, n. 848 in, Mass. Giur. It., 1999. ( 8 ) Cass., 28 aprile 1980, n. 4719, in Rass. dir. civ., 1981, 1136; Id., 18 luglio 1980, n. 4719, in Mass. giur. it., 1980. In dottrina v. A. Trabucchi, Giur. It., 1952, I, 1, 113. ( 9 ) R. Sacco, voce Simulazione, in Enc. giur., XXVIII, Roma, 1992, 6. ( 10 ) A tale riguardo v., ex multis, Cass., 2 aprile 1977, in Riv. dir. civ., 1978, II, 20. ( 11 ) Sono noti i contributi di Giuseppe Azzariti in materia; ricordiamo, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982; Se il legittimario erede che agisca in simulazione sia da ritenersi parte o terzo ai fini della prova, in Giust. civ., 1970, IV, 109; Testamento che contenga attribuzione di un cespite di proprietà aliena, simulazione, collazione, in Giur. It., 1975, I, 1, 952; Atto simulato, lesione di legittima, ed efficacia dell’azione del legittimario, in Riv. dir. civ., 1978, II, 20. ( 12 ) Cfr. A. Trabucchi, in Giur. It., 1952, I, 1, 113 ss.; D. Barbero, Impugnazione e prova della simulazione da parte del legittimario, in Foro pad., 1953, 727. 134 GIURISPRUDENZA cuius. In sostanza, è l’«agir contro» che funge da criterio per operare la qualificazione del legittimario e, dunque, in materia di azione di simulazione, per includerlo o escluderlo dai limiti probatori di cui all’art. 1417 c.c. La dottrina alla quale ci stiamo riferendo precisa che il legittimario agisce per la tutela di un diritto proprio, ponendosi in tal modo contro la volontà del suo dante causa, solo nel momento in cui esperisce l’azione (petitoria) di reintegrazione della quota di legittima (13). Questa azione, con riguardo all’ipotesi del negozio simulato, potrà essere esercitata soltanto dopo aver ottenuto l’accertamento della reale natura dell’atto dispositivo (gratuita anziché onerosa) mediante l’azione (dichiarativa) di simulazione. Solamente quando il legittimario agirà per ottenere la reintegrazione della quota di legittima, dopo aver ottenuto l’accertamento della situazione dissimulata, egli acquisirà la qualifica di «terzo». In definitiva «la scoperta, sotto l’alienazione onerosa di una valida donazione lesiva della legittima, è condizione della legittimazione del legittimario a indossar la veste di «terzo» contro l’atto del suo autore per difendere il proprio diritto mediante l’azione di riduzione» (14). Secondo tale prospettiva, dunque, il legittimario che agisce per far accertare la natura simulata dell’atto dispositivo posto in essere dal de cuius non può, per ciò solo, essere qualificato come «terzo» giacché viene a mancare quell’«agir contro» che funge da criterio di qualificazione; egli piuttosto si trova ad agire diversamente da come ha operato il suo dante causa il quale, comunque, avrebbe potuto far accertare la simulazione. E ciò, tenuto conto che il legittimario agisce contro la volontà del defunto – assumendo dunque le vesti di «terzo» – ogni qualvolta «non era in potere del de cuius compiere contro il suo atto l’azione compiuta dal legittimario»; agisce invece diversamente dal suo dante causa – assumendo dunque le vesti di «parte» – quando «compie contro la volontà del de cuius un’azione che sarebbe stata anche nel potere di questo» (15). Altri autori ritengono di non condividere la distinzione così operata osservando che «la qualità di «terzo» appartiene al legittimario in quanto tale, e si manifesta, prima e indipendentemente dalla questione di riduzione, quando domanda ( 13 ) Cfr. D. Barbero, Impugnazione e prova della simulazione da parte del legittimario, cit., 727. ( 14 ) D. Barbero, Op. ult. cit., 728. L’Autore osserva che «una cosa è l’agire contro il de cuius, contro la sua disposizione, contro la sua volontà; un’altra cosa è agire diversamente da lui. Nell’azione di reintegrazione – quella che il legittimario come in veste di «terzo» – si riscontrano gli estremi dell’«agir contro», ed è appunto per questo che vi ha veste di «terzo»; nell’azione di simulazione si riscontrano gli estremi d’un «agire diverso» (eventualmente), ed appunto per questo il legittimario che la eserciti non ha veste di «terzo», come certo non l’avrebbe l’erede non legittimario, che pure al pari del primo la potrebbe esercitare». ( 15 ) D. Barbero, Op. ult. cit., 729. LA PROVA DELLA SIMULAZIONE DA PARTE DEL LEGITTIMARIO 135 la formazione della massa di calcolo della legittima» (16). È evidente, infatti, che un soggetto quando agisce nella veste di legittimario al fine di far accertare la inefficacia di un atto dispositivo posto in essere dal de cuius, lo fa finalizzato alla tutela esclusiva di un diritto proprio: quello, cioè, di garantirsi l’integrità della quota di riserva. Nel fare ciò egli terrà conto anche dei beni legati e donati, ponendosi così, inevitabilmente, contro la volontà del de cuius. In tali termini, è altresì evidente che non tutti gli eredi vanno posti sullo stesso piano nel momento in cui agiscono per la formazione del relictum. Come infatti osserva l’autorevole dottrina ora indicata, all’erede non legittimario che domanda la formazione della massa dei beni relitti si applicano tutti i limiti costituiti dal de cuius (tra cui il limite delle alienazioni simulate) giacché agisce per l’attuazione di un diritto derivato dal defunto (17). Paiono anche a noi poco persuasive quelle impostazioni che adottano un criterio più quantitativo che qualitativo per individuare nel legittimario un soggetto «terzo» a cui viene dato ingresso alla prova illimitata della simulazione; è proprio il caso della sentenza in commento la quale si conforma a quel diffuso orientamento giurisprudenziale secondo il quale è sempre necessaria la proposizione contestuale dell’azione di simulazione e di quella di riduzione per essere esonerati dai limiti probatori dell’art. 1417 c.c. Così operando, come già accennato, si istituisce un trattamento differenziato, nella gran parte dei casi ingiustificato, tra il legittimario che agisce in simulazione per svelare una donazione dissimulata (valida o invalida) e il legittimario che oltre a ciò chieda pure espressamente la riduzione dell’atto dispositivo gratuito. Con particolare riguardo al legittimario che si limita a chiedere l’accertamento di una donazione dissimulata valida, riservandosi di esercitare in un secondo momento l’eventuale azione di riduzione, si giunge, stando all’impostazione adottata dal giudice partenopeo, ad escludere costui dall’ampio regime probatorio riservato al «terzo» dall’art. 1417 c.c. per dare ingresso, invece, al legittimario che formula la medesima domanda di simulazione ma vi aggiunge quella di riduzione. La diversità di trattamento, a nostro avviso, crea non poche perplessità trattandosi in entrambi i casi di legittimario il cui interesse ad agire è dato dalla integrità della quota indisponibile trovandosi, così, a procedere «contro» la volontà del de cuius e, quindi, in qualità di «terzo». Roberto Senigaglia Teresa Lo Torto ( 16 ) L. Mengoni, Successioni per causa di morte, cit., 183. ( 17 ) L. Mengoni, Op. ult. cit., 184. Cassazione, Sez. II, 26 ottobre 2005 (dep. 10 novembre 2005) n. 10175 – Pres. Sirena – Rel. Fumu – P.M. Geraci (1) La disposizione in materia di infedeltà patrimoniale, ponendosi in rapporto di specialità reciproca con la fattispecie di appropriazione indebita, se da un lato tipizza le condotte infedeli connesse all’attività gestoria, dall’altro non esaurisce la tutela penale nei confronti di aggressioni ai beni sociali da parte de gestori. Preesistendo un interesse in conflitto, è sanzionato l’atto di gestione che lo persegue a danno della società; il profitto ingiusto null’altro essendo che la proiezione soggettiva del preesistente conflitto, quest’ultimo deve presentare caratteri di attualità e obiettiva valutabilità, in riferimento ai principi civilistici elaborati in materia. Non attiene all’ambito di applicazione dell’infedeltà patrimoniale l’ipotesi in cui un soggetto si appropri il denaro o la cosa mobile dell’ente, di cui abbia la disponibilità in ragione della carica, per l’assenza di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi quale presupposto della deviazione dell’atto di disposizione dal suo fine istituzionale. «[Omissis] La nuova disposizione tuttavia non esaurisce la tutela penale verso le aggressioni ai beni sociali da parte di soggetti qualificati, come se il legislatore avesse sottratto la materia degli illeciti societari alla generale disciplina dei reati contro il patrimonio; ne tipizza piuttosto le condotte di infedeltà connesse all’attività di gestione, lasciando impregiudicata la rilevanza criminale di quelle che, non previste dalla specifica normativa, risultino punibili secondo il diritto comune. Per quanto qui interessa si tratta dunque di esaminare il rapporto intercorrente fra le fattispecie di infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 c.c. e di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p., verificando se permanga spazio di operatività per la seconda. La risposta al quesito non può che essere positiva atteso il rapporto di specialità reciproca esistente fra le due diverse ipotesi criminose, siccome già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (sez. 1a, 24/06/2004, Bisignani). [...] Evidente, dunque, l’intento del legislatore di punire – pur ancorandolo, secondo la filosofia del- ( 1 ) Una massima della sentenza in epigrafe è già stata pubblicata in Le Società, 2006, 448, nonché con commento di Lombardo Margherita (2006), Commento a Cass. pen. Sez. II, 10 novembre 2005, n. 10175, in Giurisprudenza Italiana, fascicolo luglio, 1480-1482; Calò Raffaella (2006), Infedeltà patrimoniale e appropriazione indebita: un problema di delimitazione reciproca, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1072-1096; e Marini Consuelo (2006), Il rapporto tra appropriazione indebita e infedeltà patrimoniale, in Le Società, 1546-1556. 138 GIURISPRUDENZA la riforma, al dato dell’effettivo nocumento patrimoniale dell’ente – l’eccesso di potere per sviamento: preesistendo il conflitto, è sanzionato l’atto di gestione (non rileva se avente ad oggetto beni mobili o immobili, diritti reali o di credito) che direttamente (per sé) o indirettamente (per altri) persegue l’interesse confliggente, con detrimento di quello della società: la nuova fattispecie si tipizza dunque per la necessaria relatio fra conflitto di interessi (o meglio interessi in conflitto) e finalità sottese all’atto, relatio che di per sé colora di ingiustizia il profitto o il vantaggio perseguiti piegando nei fini la funzione sociale. E poiché il profitto ingiusto null’altro è che la proiezione soggettiva del preesistente conflitto, quest’ultimo, che nella struttura della norma vale a qualificare la condotta come infedele connotandola di illiceità in quanto tesa a risolverlo nell’interesse del singolo, deve possedere caratteri di attualità ed obiettiva valutabilità quale reale ed effettivo antagonismo di interessi economici che dovrebbe fisiologicamente trovare soluzione, secondo la disciplina dell’art. 2391 c.c., con la dichiarazione degli stessi, l’eventuale astensione e l’idonea motivazione della deliberazione che segue. Nè può fondatamente negarsi la necessaria riferibilità del concetto di conflitto di interessi di cui all’art. 2634 c.c. ai principi civilistici elaborati in materia, attesa la significativa collocazione sistematica della norma penale incriminatrice all’interno del codice civile, operata dal legislatore al chiaro scopo di non privarla del contesto normativo di riferimento. Diversa dalla fattispecie descritta è invece l’ipotesi in cui un soggetto ponga in essere atti di aggressione del patrimonio appropriandosi il denaro o la cosa mobile dell’ente di cui abbia la disponibilità in ragione della carica: se permane infatti un’area di interferenza fra le previsioni normative, richiedendo entrambe come elemento costitutivo la deminutio patrimonii della persona offesa e l’ingiusto profitto, l’appropriazione indebita attuata con l’interversione del possesso si qualifica non solo per la natura del bene che esclusivamente ne può essere l’oggetto e l’irrilevanza del perseguimento di un semplice vantaggio in luogo del profitto, ma anche e soprattutto per l’assenza di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi – da intendersi nel senso su richiamato – quale presupposto necessario per individuare la deviazione dell’atto di disposizione dal suo fine istituzionale e ricondurre quindi la condotta nell’alveo del reato societario. [...] E solo per completezza si aggiunge che alla medesima conclusione è pervenuta la giurisprudenza di legittimità non solo nella citata sentenza Bisignani ma anche nella decisione della sez. 5a, 23/06/2003, Sama, richiamata dal ricorrente, la quale, pur premettendo una generica affermazione della specialità (senza specificarne espressamente il connotato di reciprocità) dell’infedeltà patrimoniale rispetto all’appropriazione indebita, ha comunque dato prevalenza a quest’ultimo reato sul presupposto che nel caso esaminato non risultasse nemmeno contestato il conflitto di interessi (e non risultasse altresì provato alcun vantaggio compensativo atto ad elidere l’ingiustizia del profitto). [Omissis]». ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI INFEDELTÀ PATRIMONIALE. PROBLEMI E SOLUZIONI PROSPETTATE SUL TEMA DELLA SPECIALITÀ RECIPROCA CON L’APROPRIAZIONE INDEBITA 1. Dal 2003 a oggi la Corte di Cassazione ha avuto, in più di un’occasione (2), modo di pronunciarsi sul tema dell’infedeltà patrimoniale, fattispe( 2 ) Si segnalano, in particolare, Cass. pen. Sez. V, 24 aprile 2003 n. 23241 e Cass. pen. Sez. V, 18 novembre 2004 n. 10688, che affrontano la tematica dei vantaggi compensativi; Cass. pen. Sez. V, 5 giugno 2003 e Cass. pen. Sez. V del 29 gennaio 2007 n. 3248, che affrontano l’applicabilità della causa di non punibilità di cui al comma terzo dell’articolo 2634 c.c. in ambito fallimentare; Cass. pen. Sez. I, 24 giugno ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE 139 cie introdottaall’articolo 2634 del codice civile con la riforma dei reati societari. La motivazioni delle prime sentenze, che attestano gli sforzi della Suprema Corte di delimitare lo spazio applicativo del delitto in questione, evidenziano come le problematiche all’attenzione del giudice di legittimità siano state essenzialmente quelle che la dottrina si aspettava dall’introduzione della nuova fattispecie. Non senza l’emergere, tuttavia, di qualche interessante risvolto, che poteva scaturire solo dalla concreta applicazione delle norme, sempre più ricca di fattispecie concrete di quante mai il legislatore potrà prevedere. In effetti, due sono stati i poli principali attorno ai quali si è sviluppata la riflessione sul nuovo delitto di infedeltà patrimoniale, ossia il rapporto tra infedeltà patrimoniale ed appropriazione indebita e la natura giuridica della causa di non punibilità (3) di cui al comma 3 dell’articolo 2634; al tempo stesso, tuttavia, è del pari 2004 n. 30546, la prima pronuncia a negare espressamente che sia intervenuta alcuna abolitio criminis; e Cass. pen. Sez. V del 9 novembre 2006 n. 37033, sulla presentazione della querela. ( 3 ) Questa espressione, volutamente generica, è mutuata dall’articolo 129 c.p.p. In realtà il tema dei vantaggi compensativi meriterebbe un’autonoma trattazione, dal momento che non solo si dibatte sul sovvertimento di consecutio logica (su tutti, significative le riflessioni di Mucciarelli Francesco, Il ruolo dei «vantaggi compensativi» nell’economia del delitto di infedeltà patrimoniale degli amministratori, in Giurisprudenza commerciale, 2002, fascicolo 5, 630-634; Sacchi Roberto, Conclusioni all’articolo di Mucciarelli in Giurisprudenza commerciale, 2002, fascicolo 5, 634-639, ove peraltro si arriva ironicamente a parlare di «teoria dei vantaggi (che non si sa se siano) compensativi»; Acquaroli Roberto, Alcune osservazioni sul reato di infedeltà patrimoniale alla luce del nuovo diritto societario, in La riforma dei reati societari, Atti del seminario, Macerata, 21 marzo 2003, a cura di Piergallini Carlo, Milano, Giuffrè, 2004, 165196; Mezzetti Enrico, L’infedeltà patrimoniale nella nuova dimensione del diritto penale societario, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2004, fasc. 1, 193-241; Napoleoni Valerio, Geometrie parallele e bagliori corruschi del diritto penale dei gruppi (bancarotta infragruppo, infedeltà patrimoniale e «vantaggi compensativi»), in Cassazione penale, 2005, fascicolo 12, 3795-3802) che ha visto compiersi all’interno di una fattispecie penale il riconoscimento legislativo di una teoria nata dall’analisi delle operazioni interne ai gruppi di società, e sviluppata, sul versante fisiologico ancor prima che patologico, dalla dottrina commercialistica (sul tema della compensazione i maggiori contributi si devono a Montalenti Paolo, di cui si segnalano: Conflitto di interessi nei gruppi di società e teoria dei vantaggi compensativi, in Giurisprudenza commerciale, 1995, 710 e ss. e Operazioni infragruppo e vantaggi compensativi: l’evoluzione giurisprudenziale, Nota a Cass. civ. Sez. I, 5 dicembre 1998, in Giurisprudenza Italiana, 1999, 2318 e ss.). Il problematico inserimento, all’interno della disposizione sull’infedeltà patrimoniale, della previsione «non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo» ha prevedibilmente suscitato non solo difficoltà applicative (legate soprattutto al tempo cui circoscrivere il conseguimento dei vantaggi o la loro prevedibilità, oltre che all’individuazione del nesso causale tra l’operazione in conflitto di interessi e i successivi vantaggi compensativi), ma anche classificatorie. In effetti (come segnala anche Napoleoni Valerio, Geometrie parallele e bagliori corruschi del diritto penale dei gruppi (bancarotta infragruppo, infedeltà patrimoniale e «vantaggi compensativi»), in Cassazione penale, 2005, fascicolo 12, 3796) non può non sollevare perplessità l’aver legato il vantaggio compensativo all’elemento psicologico (l’ingiustizia del profitto è infatti oggetto del dolo specifico dell’agente), anziché prevedere che esso vada ad elidere il presupposto della condotta, cioè il conflitto di interessi. La mancanza di dolo, per recuperare il significato della clausola contenuta nel comma 3 dell’articolo 2634 c.c., non può essere semplicemente considerata quale causa di giustificazione, dal momento che una scriminante escluderebbe l’illiceità del comportamento (e sarebbero inoltre applicabili tutte le disposizioni in materia di scriminanti, compresa la disciplina dell’errore sulla sussistenza di una causa di giustificazione, di cui all’articolo 59 c.p.). In proposito, appare significativo che Mez- 140 GIURISPRUDENZA emersa l’interessante questione riguardante l’applicabilità, quale causa di giustificazione, del bilanciamento con vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, anche al di fuori della sfera di applicazione della specifica disposizione di diritto penale societario. In tal caso, il nuovo delitto societario avrebbe infatti introdotto nell’ordinamento italiano una nuova scriminante, di cui ancora è incerta l’estensione. Ciò è apparso con maggior rilievo in materia fallimentare, che pure esula dal tema della sentenza in epigrafe, giacché proprio in sede di applicazione del novellato articolo 223 L.F. gli interpreti si sono posti il problema della disparità sanzionatoria che si avrebbe in caso sussunzione di condotte infedeli nella previsione di cui al comma 1, che rinvia direttamente alla fattispecie di bancarotta fraudolenta, piuttosto che in quella di cui al comma 2, la quale, stante l’espresso collegamento con l’articolo 2634 c.c., potrebbe comportare un’estensione della causa di non punibilità anche all’ipotesi di bancarotta (4). Per venire più specificamente alla sentenza in commento, essa offre alcuni spunti di riflessione particolarmente interessanti, ponendosi oltretutto nel solco di una serie di decisioni (5) con le quali la Suprema Corte ha avuto modo di affronta- zetti Enrico, L’infedeltà patrimoniale nella nuova dimensione del diritto penale societario, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2004, fasc. 1, 232 e ss., parli di inizialmente di «causa di esenzione da responsabilità», considerando poi che la previsione del comma terzo non possa essere ricondotta allo schema delle cause di giustificazione, bensì a un elemento negativo del dolo specifico. Sul punto, tuttavia, è da evidenziare come appaia del pari assurda una previsione che si limiti a prevedere che un delitto caratterizzato da dolo specifico non sia punibile in assenza del dolo specifico. In questo contesto si inserisce infine l’argomentazione contenuta in Cass. pen. Sez. V, 27 maggio 203 n. 23241, ove da un lato si afferma che il vantaggio compensativo presuppone un conflitto di interessi tra il soggetto agente e la società, dall’altro che esso non può andare oltre la sfera dell’infedeltà patrimoniale (in argomento v. Lemme Fabrizio, Commento a Cass. pen. Sez. V, 27 maggio 2003, n. 23241, in Le Società, 2005, fascicolo 6, 750-752 e Giovanardi Elisabetta, Sull’impossibilità di estendere i «vantaggi compensativi» ai reati fallimentari, in Cassazione penale, 2005, fascicolo 4, 1366-1373). Il punto della questione si riduce a questo: se il vantaggio compensativo esclude il dolo specifico dell’ingiusto profitto, la necessità del presupposto conflitto di interessi può indicare solo che il dolo specifico non può già costituire un «inutile doppione» del conflitto di interessi (secondo l’espressione di Foffani Luigi, Infedeltà patrimoniale e conflitto d’interessi nella gestione d’impresa, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, 1997, Milano, Giuffrè, 486), bensì un quid pluris. ( 4 ) V. Cass. pen. Sez. V, 5 giugno 2003 n. 36629, Cass. pen. Sez. V, 24 aprile 2003 n. 23241 e Cass. pen. Sez. V, 29 gennaio 2007 n. 3248, che peraltro non esclude l’applicabilità in astratto delle cause di non punibilità, limitandosi a rigettare nel caso concreto; sempre sull’argomento, v. le riflessioni di Lemme Fabrizio (2005), Commento a Cass. pen. Sez. V, 27 maggio 2003, n. 23241, in Le Società, fascicolo 6, 750-752 e Giovanardi Elisabetta (2005), Sull’impossibilità di estendere i «vantaggi compensativi» ai reati fallimentari, in Cassazione penale, fascicolo 4, 1366-1373. Si veda poi la riflessione di Masucci Massimiliano (2006), Infedeltà patrimoniale e offesa al patrimonio, Napoli, Jovene, 48 e ss., il quale evidenzia come l’introduzione di un limite legale espresso possa contribuire a un’interpretazione più equilibrata della fattispecie di bancarotta fraudolenta, in relazione alla dinamica economica del gruppo. ( 5 ) Si vedano, in particolare, Cass. pen. Sez. V, 27 maggio 203 n. 23241; Cass. pen. Sez. V, 7 ottobre 2003 n. 38110; Cass. pen. Sez. I, 24 giugno 2004 n. 30546; Cass. pen. Sez. II, 26 ottobre 2005 n. 10175; Cass. pen. Sez. II, 10 novembre 2005 n. 40921. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE 141 re lo spinoso tema del rapporto di specialità intercorrente tra i reati di appropriazione indebita e infedeltà patrimoniale (6). L’esame delle motivazioni di questa pronuncia fornisce quindi una rappresentazione dello stato dell’arte sulla questione, dando al tempo stesso modo di apprezzare come sia stata superata, dopo i primi due anni di vigenza della norma, la problematica della successione di norme nel tempo. Nel contempo, la sentenza in esame valorizza il concetto di specialità reciproca tra norme, dal momento che né il criterio di specialità di cui all’articolo 15 del codice penale, né quello sussidiarietà o quello di consunzione riescono a disciplinare il concorso apparente di norme sorto con l’introduzione dell’infedeltà patrimoniale. Le questioni sottoposte all’attenzione della Corte di Cassazione, infatti, traggono principalmente origine dalla possibilità di configurare, con l’ingresso nell’ordinamento penale della nuova fattispecie di cui all’articolo 2634 del codice civile, un’ipotesi di abolitio criminis parziale. Contro una siffatta interpretazione, e soprattutto le sue probabili, destabilizzanti conseguenze applicative, il giudice di legittimità ha nettamente preso posizione (7), escludendo la configurabilità di qualsivoglia area di abrogazione. ( 6 ) Nelle motivazioni di queste sentenze, susseguitesi in un arco di tempo piuttosto breve e immediatamente successivo all’entrata in vigore della disposizione che introduce il delitto di infedeltà patrimoniale nel nostro ordinamento, è possibile notare in controluce la preoccupazione di dover gestire l’ingresso di tale nuova fattispecie dalle conseguenze potenzialmente deflagranti, quasi considerando come una sorta di Santa Barbara la giurisprudenza consolidatasi nel corso degli anni attorno all’applicazione del reato di appropriazione indebita per colpire illegittime condotte di gestione sociale. Quello che sembra essere trascurato, almeno in apparenza, è invece il ruolo svolto dalla dottrina che, in parallelo alle costruzioni giurisprudenziali sull’appropriazione indebita, contribuiva, negli ultimi cinquant’anni, a costruire una fattispecie di infedeltà patrimoniale che dunque, ed è un dato da non trascurare, era presente nelle riflessioni dei penalisti prima ancora della sua introduzione a livello normativo. In proposito vere e proprie pietre miliari sono rappresentate da Nuvolone Pietro (1941), L’infedeltà patrimoniale nel diritto penale, Milano, Giuffrè; Pedrazzi Cesare (1953), Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli amministratori, Milano, Antonino Giuffrè; Zuccalà Giuseppe (1961), L’infedeltà nel diritto penale, Padova, CEDAM; Marinucci Giorgio e Romano Mario (1971), Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli amministratori di società per azioni, in Il diritto penale delle società commerciali, a cura di Nuvolone, Milano, Giuffrè; Foffani Luigi (1997), Infedeltà patrimoniale e conflitto d’interessi nella gestione d’impresa, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano, Giuffrè. ( 7 ) Si veda infatti, sul punto, Cass. pen. Sez. I, 24 giugno 2004 n. 30546: «L’affermazione è insostenibile, trattandosi di norme che, invece, operano su piani solo parzialmente coincidenti e si pongono semmai in rapporto di «specialità reciproca. [...] In ogni caso, non si vede come il preteso rapporto di specialità potrebbe supportare la tesi dell’“abolitio criminis” situandosi, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, i fatti di appropriazione da lui commessi nell’“area di interferenza” delle due norme. Tale rilievo vale anche nell’ipotesi in cui si ritenga che il legislatore, nel disciplinare compiutamente “ex novo” la materia degli illeciti patrimoniali degli organi sociali, l’abbia sottratta alla generale disciplina dei reati contro il patrimonio, che pertanto in ambito societario non troverebbero (più) applicazione. Va detto, comunque, che tale opinione non trova alcun appiglio testuale né nella “ratio” normativa, non essendo sostenibile che si sia inteso esentare da sanzione gli amministratori, direttori generali e liquidatori per qualsiasi aggressione al patrimonio sociale non prevista dalla specifica normativa e – nei confronti di altri soggetti interni o esterni alla società – punibile secondo il diritto comune». Cass. pen. Sez. I, 24 giugno 2004 n. 30546. 142 GIURISPRUDENZA In questo contesto La Suprema Corte è dunque giunta ad argomentare, sia pure non approfonditamente, dei rapporti di specialità reciproca tra la nuova fattispecie di infedeltà patrimoniale e quella di appropriazione indebita, che a lungo aveva supplito alla mancanza di una norma penale che sanzionasse il comportamento infedele degli amministratori. Se quindi le posizioni espresse dalla Suprema Corte possono essere, almeno in parte, condivise (8), in realtà non appaiono del tutto tacitate le perplessità che gli interpreti hanno manifestato dal momento dell’introduzione della nuova fattispecie di infedeltà patrimoniale nello scenario del diritto penale italiano e in particolare per la sua collocazione tra i reati societari, proprio allorché si è scelto, in sede legislativa, di non seguire il modello tedesco dell’Untreue (9), che deve il suo successo in sede applicativa soprattutto agli apporti, negli anni, di dottrina e giurisprudenza (10), ( 8 ) Non solo o non tanto per la lucidità di analisi su questioni indubbiamente complesse, quanto soprattutto per i risvolti pratici delle decisioni. D’altro canto parte della dottrina aveva già da tempo espresso i propri timori circa una fattispecie penale, qual è l’infedeltà patrimoniale, talmente ricca di elementi strutturali, in omaggio al principio di tassatività, da limitarne quando non addirittura pregiudicarne l’applicabilità, con la conseguenza di un persistente ricorso alla fattispecie comune dell’appropriazione indebita; così Cipolla Pieluigi (2005), Brevi note in tema di rapporti tra l’appropriazione indebita e il nuovo reato di infedeltà patrimoniale societaria (art. 2634 c.c.), in Cassazione Penale, 468 e ss.; peraltro in dottrina contesta siffatta impostazione Aldovrandi Paolo (2007), sub Art. 2634 C.C., in Lanzi Alessio e Cadoppi Alberto, I reati societari: commentario aggiornato alla legge 28 dicembre 2005 n. 262 sulla tutela del risparmio, Padova, CEDAM, 207 e ss. ( 9 ) Nell’ordinamento tedesco la caratteristica di questa figura delittuosa è specificamente la protezione del patrimonio come tale e non delle cose mobili che lo compongono, come accade con l’appropriazione indebita. Pertanto, coincide con la truffa in quanto a oggetto della protezione, eppure si differenzia da questa perché non è richiesto l’inganno al titolare del patrimonio o a chi la rappresenta nell’atto di disposizione patrimoniale, dato che l’autore è precisamente quello che dispone in modo abusivo del patrimonio di colui che soffre il danno. In proposito v. l’ottima analisi di Bacigalupo Zapater Enrique (1995), La problemática de la administración desleal en el Derecho Penal español, in Hacia un drecho penal económico europeo, Jornadas en honor del profesor Klaus Tiedemann, 14-17 de octubre 1992, Madrid, Boletin Oficial del Estado, 390. ( 10 ) Allo scopo di superare un vecchio dibattito dottrinario sull’essenza dell’Untreue, fra abuso di potere (Mißbrauchstatbestand) e violazione di un dovere di fedeltà (Treubruchstatbestand), l’attuale fattispecie prevista al §266 StGB ha incriminato entrambe le modalità di realizzazione del reato (cfr. SCchünemann Bernd, Untreue, in Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, Großkommentar, Aa.Vv., Berlin, 1998, 20, opera citata da Miedico Melissa, I reati societari in Germania, in Il nuovo diritto penale delle società, a cura di Alessandri Alberto, Milano, IPSOA, 2002, 542). È punito, infatti, «chiunque abusa del potere di disporre di un patrimonio altrui o di obbligare altri, conferitogli per legge, per ordine dell’autorità o per negozio giuridico, ovvero viola l’obbligo di curare interessi patrimoniali altrui, del quale è investito in forza di legge, di un ordine dell’autorità, di un negozio giuridico o di un rapporto di fedeltà, arrecando con ciò pregiudizio a colui del quale deve curare gli interessi patrimoniali» (traduzione di Vinciguerra Sergio e Jescheck Hans-Heinrich, Il Codice penale tedesco, seconda edizione aggiornata, 2003, Padova, CEDAM, 266). La formula adottata dal legislatore si caratterizza, insomma, per una certa ampiezza. Nella teoria e nella pratica tedesche si considera che il testo del paragrafo 266 sia troppo ampio e che richieda un’interpretazione restrittiva (ancora Bacigalupo Zapater Enrique, La problemática de la administración desleal en el Derecho Penal español, in Hacia un drecho penal económico europeo, Jornadas en honor del profesor Klaus Tiedemann, 14-17 de octubre 1992, Madrid, 1995, Boletin Oficial del Estado, 392). Ciononostante, se sotto certi aspetti, comunque, gli interpreti hanno tentato di limitarne l’applicabilità, richiedendo che l’obbligo di fedeltà debba sempre fondarsi su un rapporto giuridico, nel quale la cura dell’altrui ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE 143 per creare invece un presidio nello specifico campo del diritto commerciale societario. 2. Dal momento che l’introduzione di una specifica fattispecie penale per sanzionare condotte gestorie infedeli è apparsa, quantomeno a livello di diritto positivo, come un’assoluta novità nel panorama del diritto societario, è forse opportuno cominciare la riflessione sulla recente giurisprudenza in materia dando atto delle maggiormente consolidate esperienze di altri ordinamenti. Un primo approccio comparatistico non può che partire dalla tradizione francese in materia di abus des biens, e più precisamente nella parte in cui si concentra sulla contrarietà all’interesse sociale. La condotta di tale fattispecie consiste infatti nell’usage, che significa «servirsi di qualche cosa», termine molto ampio, e lascia perciò all’espressione «contraire à l’intérêt social», che l’accompagna, il ruolo di fulcro del disvalore. È dunque sulla base della contrarietà all’interesse della società (11) che la giurisprudenza ha efficacemente scriminato le condotte punibili. In sintesi: «l’usage dégénére en abus lorsqu’il est contraire à l’intérêt social» (12). La giurisprudenza francese ha quindi individuato i limiti all’applicazione della sanzione alle ipotesi in cui, pur ricorrendo solo un pericolo per il patrimonio sociale, fosse evidente la contrarietà all’interesse sociale della condotta dell’agente. La giurisprudenza d’oltralpe, inoltre, ha ammesso pacificamente l’equiparazione tra danno e pericolo (13), e identifica nel cri- interesse patrimoniale rappresenti l’oggetto principale, e non già secondario o meramente occasionale (RGH 14 dicembre 1934, in RGSt, 1936, 58, da Foffani Luigi, Infedeltà patrimoniale e conflitto d’interessi nella gestione d’impresa, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, 1997, Milano, Giuffrè, 246), sotto altri invece non è stato posto un argine efficace alle possibilità di interpretazione estensiva. Così il soggetto passivo, che in generale nell’infedeltà dovrebbe identificarsi nel titolare della pretesa di fedeltà, è stato inteso in senso assai più ampio, al punto di «punire come Untreue, in campo societario, anche delle ipotesi come l’acquisto di azioni o quote proprie o la distribuzione di dividendi fittizi, ossia di fatti non tanto lesivi del patrimonio sociale – rispetto al quale, esclusivamente, può e deve costituirsi un obbligo di fedeltà degli amministratori – bensì lesivi, fondamentalmente, della garanzia dei terzi creditori rappresentata dall’integrità del capitale sociale» (Foffani Luigi, Infedeltà patrimoniale e conflitto d’interessi nella gestione d’impresa, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, 1997, Milano, Giuffrè, 255). Per queste ragioni la fattispecie è oggi baluardo di tutela sia del patrimonio della società sia, indirettamente, anche dei soci e dei creditori. Per un’analisi delle soluzioni alle quali si è spinta la prassi applicativa v. l’interessante articolo di Foffani Luigi e Nieto Martín Adán (2006), Corporate Governance y administración desleal: casos y problemas de derecho comparado europeo, in Revista penal, n. 17, 110-141. ( 11 ) Sarebbe questo l’elemento maggiormente qualificante, che distingue la fattispecie francese di abuso dal modello tedesco dell’infedeltà patrimoniale. Questo requisito modale della condotta costituirebbe perciò un passo in avanti, tuttavia non si può trascurare che si tratti di un concetto vago in mancanza di un substrato normativo extrapenale adeguato. Cfr. in proposito l’opinione di Manna Adelmo (2004), Abuso d’ufficio e conflitto d’interessi nel sistema penale, in Itinerari di Diritto Penale, Torino, Giappichelli, 132. ( 12 ) Rebut Didier (1997), Abus de biens sociaux, in Répertoire Dalloz de droit pénal, 2, paragrafo 15. ( 13 ) In effetti, nonostante il testo legislativo non preveda quale elemento costitutivo del reato il verificarsi di un pregiudizio per la società, la nozione di contrarietà all’interesse sociale è unanimemente inter- 144 GIURISPRUDENZA terio modale della contrarietà all’interesse sociale il discrimen tra condotte punibili o non punibili. D’altro lato ben tre sentenze della Cour de cassation hanno equiparato l’omissione dal richiedere pagamenti dovuti alla società a un atto positivo di usage (14). A sua volta, la dottrina francese effettua un peculiare inquadramento del concetto di usage. «L’usage est une notion qui se suffit à elle-même, en ce sens qu’elle n’implique aucune appropriation de la chose utilisée. C’est pourquoi le délit d’abus de biens sociaux existe indépendamment de toute appropriation. Cette solution ressort, il est vrai, explicitement des incriminations des différents abus, qui sanctionnent un simple usage sans exiger qu’il ait occasionné un préjudice à la société. Il est donc naturel que sa consommation soit acquise de seul fait de l’usage sans qu’il soit nécessaire que cet usage ait provoqué un autre résultat que lui-même.» (15). È insomma l’interesse sociale a costituire la bussola che indica agli organi societari la condotta che essi devono seguire e che consente di individuare le deviazioni e gli abusi nello svolgimento della vita della società; l’intérêt social domina il funzionamento della società e la sua violazione determina la necessità di sanzione penale (16). Si tratta però indubbiamente dell’elemento costitutivo più difficile da definire, essendo la nozione vaga, di incerti confini e poco compatibile con la determinatezza richiesta dalle norme penali (17). La dottrina e la giurisprudenza hanno, quindi, tentato di stabilire dei criteri guida. Il termine «sociale» può infatti essere inteso in senso restrittivo come l’interesse degli azionisti, o, secondo la dottrina francese oggi dominante, come l’interesse, oltre che dei soci, anche della società e dei terzi (18). pretata nel senso di atto pregiudizievole, che attenta al patrimonio sociale diminuendone la consistenza. Autorevole dottrina ha peraltro precisato che la contrarietà all’interesse sociale si manifesta qualora sia compiuto un «atto che espone la società a rischi anormali e gravi in cui non si sarebbe trovata». Dunque non servirebbe il danno, ma comunque si tratta di una tutela che sanziona ipotesi contrarietà all’interesse. Sul punto v. Delmas-Marty Mireille (1976), Nota alla sentenza 16 dicembre 1975, in Gazette du Palais, I, 298. ( 14 ) Rebut Didier (1997), Abus de biens sociaux, in Répertoire Dalloz de droit pénal, 4, paragrafo 19; e Médina Annie (2001), Abus des biens sociaux: Prévention, Détection, Poursuite, Paris, Dalloz, 32. Rebut osserva come tale giurisprudenza riguardi solo l’abuso di poteri, ma tale limitazione si spieghi «parce qu’il s’agit du seul délit capable de donner lieu a une commission par omission». ( 15 ) Rebut Didier (1997), Abus de biens sociaux, in Répertoire Dalloz de droit pénal, 3, paragrafo 17. ( 16 ) Cfr. Magno Daniele (2001), Il conflitto di interessi e l’abus de droit nel diritto societario francese, in Archivio CERADI http://www.archivioceradi.luiss.it/documenti/archivioceradi/impresa/corporate/ conflitto_magno.pdf ( 17 ) Giavazzi Stefania (2002), I reati societari in Francia, in Il nuovo diritto penale delle società, a cura di Aalessandri Alberto, Milano, IPSOA, 498. ( 18 ) Mestre Jacques, Velardocchio Dominique, Blanchard-Sebastien Christine (2000), Lamy Societés commerciales, Paris, Lamy, 579. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE 145 3. Niente di realmente simile può essere detto a proposito della disposizione italiana, la quale, peraltro, se nella rubrica rende omaggio alla contrapposta tradizione germanica dell’Untreue, si dimostra d’altro canto refrattaria ai tentativi di ricondurla a un paradigma già conosciuto (19). Non va trascurato, infatti, come il tipo penale dell’Untreue contenga due ipotesi di distinta struttura: in sintesi può dirsi che l’una, l’abuso di potere, protegga il patrimonio «dai pericoli derivanti dal conferimento a terzi di un potere di disposizione nei rapporti esterni»; mentre l’altra, la violazione dell’obbligo di fedeltà, si rivolga ai rapporti interni, «assolvendo una funzione di tutela contro qualsivoglia aggressione al patrimonio altrui condotta in forme extranegoziali» (20). L’abuso di potere consiste, secondo gli interpreti tedeschi, in un utilizzo illegittimo del rapporto di rappresentanza, un uso illecito del potere del soggetto, conferitogli per legge, per ordine dell’autorità o per negozio giuridico, verso l’esterno, in forza del quale egli fa sorgere un obbligo a carico del rappresentato (21). L’abuso di potere, inoltre, si realizza di regola tramite una condotta attiva, ma è configurabile anche l’ipotesi omissiva (22). D’altro canto, la formula della violazione del rapporto di fiducia è ancora più ampia. In conseguenza della previsione di questa seconda modalità di realizzazione della condotta è punito chi, titolare di un incarico fiduciario, viola il suo dovere di tutelare gli interessi patrimoniali altrui. Nella forma della violazione del rapporto di fiducia vengono perciò in considerazione soprattutto le relazioni all’interno del ( 19 ) In proposito parla di tre grandi paradigmi di tutela Calò Raffaella (2006), Infedeltà patrimoniale e appropriazione indebita: un problema di delimitazione reciproca, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1074 e ss.; si tratta di un modello in cui il conflitto di interessi è accompagnato da un atto di disposizione patrimoniale e il reato si configura di pericolo presunto (il riferimento è all’abrogato articolo 2631 c.c.); un secondo modello in cui l’infedeltà patrimoniale è costruita come un reato di evento, accompagnato da dolo generico, sicché è la condotta stessa a rivestire una connotazione «negativa» (sarebbe il caso dell’Untreue); e un terzo modello, incentrato sulla condotta di abuso (il riferimento è al modello francese), per il quale è del tutto irrilevante la causazione o meno di un danno patrimoniale. Ciò che maggiormente sorprende, a detta di questa Autrice, è l’apparente riconducibilità della fattispecie di cui all’articolo 2634 c.c. a tutti e tre i paradigmi. ( 20 ) Foffani Luigi (1997), Infedeltà patrimoniale e conflitto d’interessi nella gestione d’impresa, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano, Giuffrè, 249; Schmidt Wolfgang (2000), in Wirtschaftsstrafrecht: eine Gesamtdarstellung des deutschen Wirtschaftsstraf und ordnungswidrigkeitenrechts, a cura DI Müller-Gugenberger Christian e Bieneck Klaus, Köln, 744; Bacigalupo Zapater Enrique (1995), La problemática de la administración desleal en el Derecho Penal español, in Hacia un drecho penal económico europeo, Jornadas en honor del profesor Klaus Tiedemann, 14-17 de octubre 1992, Madrid, Boletin Oficial del Estado, 390. ( 21 ) Miedico Melissa (2002), I reati societari in Germania, in Il nuovo diritto penale delle società a cura di Alessandri Alberto, Milano, IPSOA, 543; Schmidt Wolfgang (2000), in Wirtschaftsstrafrecht: eine Gesamtdarstellung des deutschen Wirtschaftsstraf und ordnungswidrigkeitenrechts, a cura di MüllerGugenberger Christian e Bieneck Klaus, Köln, 744. ( 22 ) Schünemann Bernd (1998), Untreue, in Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, Großkommentar, Aa.Vv., Berlin, 57. 146 GIURISPRUDENZA rapporto, che non corrispondono a nessun potere di rappresentanza esterna (23). Per la consumazione del reato è, per altro verso, necessaria la realizzazione di un pregiudizio patrimoniale. Tale elemento del reato è stato però inteso in senso assai ampio, dal momento che, come accade in Francia, lo si ritiene integrato già con la semplice messa in pericolo del patrimonio (24). 4. L’esperienza spagnola, dal canto suo, risente della relativa novità di una fattispecie incriminatrice, l’administración desleal, destinata specificamente ai soggetti operanti nell’ambito delle società commerciali e sconosciuta sino all’entrata in vigore del nuovo codice penale. Peraltro, la dottrina spagnola, come quella italiana, aveva a lungo studiato il modello tedesco dell’Untreue, giungendo alla conclusione che nell’ordinamento spagnolo fossero innegabilmente presenti dei vuoti di tutela, tanto più che neppure le fattispecie generali di estafa e apropriación indebida conosciute dal diritto penale erano in grado di far fronte alle esigenze sanzionatorie sollevate dalle ipotesi concrete di amministrazione infedele. Non si ha infatti estafa qualora non ci sia inganno e per giunta in caso di amministrazione infedele colui che dovrebbe ingannare sarebbe poi lo stesso soggetto che realizza l’atto di disposizione patrimoniale, il che esclude del tutto la tipicità della fattispecie di truffa. D’altro canto è pacificamente esclusa altresì l’applicazione della fattispecie di appropriazione indebita, dal momento che l’amministrazione infedele non implica l’appropriazione di denaro o cose mobili, detenute con l’obbligo di restituirle o cederle, bensì un pregiudizio per il patrimonio in generale e non riguardante la proprietà di cose determinate (25). Nel diritto spagnolo, quindi, dal 1983, anno in cui era stata riformulata la fattispecie di estafa, l’introduzione di una fattispecie penale di amministrazione infedele era ritenuta «prácticamente imprescindible (26)». ( 23 ) Miedico Melissa (2002), I reati societari in Germania, in Il nuovo diritto penale delle società a cura di Alessandri Alberto, Milano, IPSOA, 544. ( 24 ) Schmidt Wolfgang (2000), in Wirtschaftsstrafrecht: eine Gesamtdarstellung des deutschen Wirtschaftsstraf und ordnungswidrigkeitenrechts, a cura di Müller-Gugenberger Christian e Bieneck Klaus, Köln, 800. ( 25 ) Bacigalupo Zapater Enrique (1995), La problemática de la administración desleal en el Derecho Penal español, in Hacia un drecho penal económico europeo, Jornadas en honor del profesor Klaus Tiedemann, 14-17 de octubre 1992, Madrid, Boletin Oficial del Estado, 387. Si tratta di un profilo non sufficientemente valorizzato dalla dottrina italiana, che all’applicazione giurisprudenziale dell’appropriazione indebita ha semmai contrapposto una raffinata distinzione tra distrazione e momento appropriativo o tra detenzione e possesso (v. meglio anche infra). Vi è tuttavia da segnalare come, pur essendo sia l’appropriazione indebita che l’infedeltà patrimoniale fattispecie penali poste a tutela del patrimonio, mentre per la prima l’offesa è diretta contro un bene mobile e determinato, per la seconda è il patrimonio sociale nel complesso a costituire oggetto di un’eventuale offesa, sicché sono compresi anche beni immobili e diritti di credito, per i quali non è configurabile un’indebita appropriazione. ( 26 ) Bacigalupo Zapater Enrique, ibidem. Prima, la configurazione del delitto di truffa aveva infatti ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE 147 Dall’analisi dell’articolo 295 dell’attuale código penal, che introduce il reato di administración desleal, emerge che, come nel delitto di Untreue tedesco, la fattispecie si caratterizza per la rottura della speciale relazione di fiducia esistente fra l’autore e colui che subisce la lesione del patrimonio (27); rispetto però al modello tedesco ha però poco d’altro in comune e al confronto anzi appare come una costruzione «barocca» (28). In effetti, a parte l’abuso del potere di disporre di beni altrui o contrarre obbligazioni a carico di altri, che costituiscono la condotta fondamentale di entrambe le fattispecie di infedeltà, la norma spagnola presenta tutta una serie di peculiarità (29), che le conferiscono quantomeno un carattere un po’ confuso, per non dire che la formulazione della norma presenta non poche imperfezioni, tali da suscitare notevoli difficoltà interpretative (30). In questa sede è opportuno evidenziare una stranezza di non poco rilievo: la fattispecie penale contempla un pregiudizio direttamente per i soci, che dovrà cioè essere verificato del tutto a prescindere dalle eventuali ripercussioni sul patrimonio sociale dal momento che la società, in questa particolare fattispecie, non è presente tra i soggetti passivi; quindi non solo nulla impone di andare alla ricerca di un pregiudizio per la società, ma a rigore quest’ultima potrebbe risultare addirittura avvantaggiata dall’illecito atto di gestione (31). In questo modo, tuttavia, ci si un’ampiezza tale da poter ricomprendere quasi tutti i fatti di amministrazione infedele, dal momento che l’inganno non costituiva un elemento essenziale e la condotta consisteva semplicemente nel «defraudar a otro», ma di fronte a una previsione così poco tassativa la riforma della estafa era avvertita come necessaria e venne accolta come un miglioramento; tuttavia ben presto cominciò a diventare evidente come vi fossero dei comportamenti che in tal modo era stati involontariamente depenalizzati. ( 27 ) Fernández Teruelo Javier Gustavo (1998), Los delitos societarios en el Código penal español, Madrid, 329. ( 28 ) Foffani Luigi (1999), I reati societari nel nuovo codice penale spagnolo del 1995, in Rivista trimestrale di diritto penale commerciale, 76. ( 29 ) Sulla tecnica normativa impiegata dal legislatore spagnolo nella stesura delle fattispecie di frode, v. le riflessioni di Quintero Olivares Ponzalo (2006), Fraudes y defraudaciones ante una reforma del código penal, in La reforma del Código Penal tras 10 años de Vigencia, Aa.Vv., Centro de Estudios Jurìdicos, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 82 e ss. ( 30 ) Tanto per esemplificare, notevoli perplessità suscita l’osservazione che tra i soggetti passivi non sia inclusa la società, il che è tanto più strano proprio perché oggetto della tutela sembrerebbero essere i beni della società, dal momento che proprio su di essi va a incidere la condotta infedele. V. in proposito Martínez Bujan Perez Carlos (1998), Derecho penal económico, Valencia, 270. Sintetico, ma particolarmente incisivo anche Del Rosal Blasco Bernardo (1998) Los delitos societarios en el codigo penal de 1995, Valencia, Tirant lo Blanch, 137: «El legislador de 1995 no ha cuidado suficientemente su tipificación, cometiendo errores tan absurdos como, por ejemplo, la referencia a los «depositarios» que, necesariamente, habrá de entenderse a los “depositantes”, o dejando sin aclarar si el delito se comete sólo perjudincando el patrimonio de los socios o, también, el patrimonio social real y optando, además, de forma inexplicable, por un tipo de lesión que, con toda probabilidad, será muy difícil de aplicar». ( 31 ) Foffani Luigi (1999), I reati societari nel nuovo codice penale spagnolo del 1995, in Rivista trimestrale di diritto penale commerciale, 80. Questo Autore mette peraltro in evidenza come si tratti, in fondo, di una trasformazione (consapevole o meno che essa sia, dal punto di vista dei compilatori del codice) tut- 148 GIURISPRUDENZA allontana radicalmente dal modello di infedeltà nella gestione societaria da cui si erano prese le mosse e soprattutto l’estensione della capacità di tutela della fattispecie all’esterno del rapporto sociale risulta di fatto compromessa – se non completamente paralizzata – dalla discrasia fra bene giuridico e oggetto materiale dell’azione; ciò è tanto più evidente in relazione ai beni dei terzi, tenuto conto che essi non divengono in nessun caso beni della società, stante il fondamentale principio di rigida separazione fra patrimonio dell’ente e patrimonio della clientela (32). Sul versante della condotta tipica, d’altro canto, la formulazione della norma incriminatrice appare, come in certa misura anche la disposizione italiana, eccessivamente carica di elementi idonei a polarizzare il disvalore: l’atto dispositivo dei beni della società, o dal quale deriva un’obbligazione a carico di quest’ultima, deve infatti caratterizzarsi come abuso di funzioni, ma anche come comportamento fraudolento. È questo secondo requisito ad apparire di particolarmente ardua interpretazione, nonostante alcuni autori rilevino che l’avverbio «fraudolentemente» permetterebbe di restringere l’operatività della norma in esame, escludendo la punibilità delle condotte di semplice mala gestio o delle mere infrazioni (33) oppure ancora sancendo l’inammissibilità del dolo eventuale (34). Non vi è comunque, nella norma, alcun riferimento alla posizione di conflitto di interesse in cui versino gli amministratori o i soci. 5. Dopo aver esaminato quali siano stati, in altri ordinamenti, i frutti di una consolidata giurisprudenza che in Italia, allo stato, ancora manca sul tema dell’infedeltà gestoria, non si può peraltro nemmeno ignorare come per settant’anni il nostro sistema penale abbia sì presentato una lacuna, colmata tuttavia proprio dal- to sommato coerente con l’assetto complessivo dei delitos societarios, dove la tutela delle minoranze azionarie e dei diritti individuali dei soci sembra aver esercitato una sensibile forza di attrazione nei confronti del legislatore. ( 32 ) Foffani Luigi (1999), I reati societari nel nuovo codice penale spagnolo del 1995, in Rivista trimestrale di diritto penale commerciale, 81. ( 33 ) Martínez Bujan Perez Carlos (2001), El delito societario de administración desleal, Valencia, Tirant lo Blanch, 43. ( 34 ) Fernández Teruelo Javier Gustavo (1998), Los delitos societarios en el Código penal español, Madrid, 347. Nel complesso, però, nulla vieterebbe di concludere che in questo contesto si tratti di un’espressione meramente pleonastica, anche se si segnala che la sentenza 13 aprile 2005 della Audiencia Nacional ha dato un significato a tale espressione, definendo la frode come una violazione del dovere di fedeltà, che si scompone a sua volta in tre «subdeberes»: trasparenza, osservanza di un procedimento che elimini gli abusi e osservanza dell’equità nella condotta degli amministratori, come ricordano Foffani Luigi e Nieto-Martin Adán (2006), in Corporate Governance y administración desleal: casos y problemas de derecho comparado europeo, in Revista penal, n. 17, 124 e ss.; a pagina 126, comunque, gli Autori fanno notare come la Audiencia Nacional abbia realizzato un’interpretazione eccessivamente complicata del delitto, nel tentativo di dotare di contenuto autonomo il termine fraudolento, che in realtà costituirebbe solo una reiterazione di quello di abuso. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE 149 la giurisprudenza, attraverso un ruolo di supplenza svolto dalle fattispecie di appropriazione indebita e peculato (quest’ultima ove fosse possibile ravvisare una parvenza di natura pubblicistica dell’ente), estese alle ipotesi di infedele amministrazione di patrimoni altrui (35). È soprattutto a questa consolidata interpretazione che va rapportato ogni tentativo di determinare lo spazio applicativo della fattispecie di cui all’articolo 2634 del codice civile. In effetti, il proposito del legislatore della riforma dei reati societari, di introdurre una fattispecie di infedeltà patrimoniale destinata ad operare nello specifico campo societario, venne inizialmente accolto con favore, dal momento che era evidente come quel settore necessitasse di una tutela peculiare, formulata in termini di infedeltà piuttosto che di appropriazione; al tempo stesso, riguardando una materia specifica, si riteneva che avrebbe più agevolmente potuto conformarsi alle esigenze di tassatività delle fattispecie penali. Gli entusiasmi inizialmente espressi (36) sono presto scemati allorché si è andati ad esaminare il contenuto della disposizione, dal momento che questa prevede una descrizione della condotta e dell’elemento soggettivo entro limiti talmente ristretti da pregiudicarne l’applicazione. In secondo luogo, occorre tener conto che, per come è strutturata, la fattispecie di cui all’articolo 2634 c.c. recherebbe in sé la pretesa di costituire una sorta di appropriazione indebita specializzata, sicché sarebbe preclusa la possibilità di una nuova supplenza giurisprudenziale, in virtù del criterio di specialità nel concorso tra norme. In questo modo si viene a compiere un passo indietro, anziché un passo in avanti, nella tutela (37). Ecco dunque che, prima che il legislatore del 2005 prendesse atto che per estendere la tutela penale in campo societario era necessario concentrarsi sul conflitto di interessi e introducesse quindi il delitto di omessa comunicazione del con( 35 ) In proposito, offre un lucido quadro sintetico Rainone Valeria (2006), Il delitto di infedeltà patrimoniale tra modernità e post-modernità penalsitica, in Banca borsa e titoli di credito, fascicolo 4, 440-468 e in particolare la nota 3. ( 36 ) La nuova disposizione era stata apprezzata come il segno di un recepimento del principio di necessaria offensività; così Seminara Sergio (2004), Considerazioni penalistiche sul disegno di legge in tema di tutela del risparmio, in Diritto penale e processo, n. 4, 509. V. anche Foffani Luigi (2002), Le infedeltà, in Il nuovo diritto penale delle società, a cura di Alessandri Alberto, Milano, IPSOA, 346 e ss., il quale riconosceva che «il legislatore italiano si è finalmente avviato a porre rimedio a gravi quanto ormai croniche lacune della tutela penale di settore, accogliendo istanze da lungo tempo formulate dalla dottrina». Altri vedeva in essa il segno di una maturazione legislativa, in quanto nell’articolo 2634 era possibile individuare un conflitto di interessi senza un rinvio espresso alla normativa extrapenale: v. Masucci Massimiliano (2006), Infedeltà patrimoniale e offesa al patrimonio, Napoli, Jovene, 33 e ss. ( 37 ) Una tendenza dimostrata peraltro in generale dall’intera riforma del 2002 dei reati societari, la quale, prevedendo soprattutto fattispecie di danno, ha segnato «un arretramento del fronte che confina con la smobilitazione» (così Pedrazzi Cesare (2002), Prefazione a Il nuovo diritto penale delle società, a cura di Alessandri Alberto, Milano, IPSOA, pagina XX). 150 GIURISPRUDENZA flitto di interessi (38), la giurisprudenza si assestava nel senso di continuare a riconoscere, pur nella specialità tra norme, un residuo ambito di applicazione per l’appropriazione indebita, l’ampiezza del quale è tuttora oggetto di discussione. Venendo dunque ad affrontare la prima problematica connessa all’introduzione del nuovo delitto, frutto della riforma del diritto penale societario, si tratta di comprendere se abbia implicitamente comportato un’abrogazione, quantomeno parziale, della fattispecie di appropriazione indebita, per le condotte riconducibili all’ambito societario. In caso di insanabile contrasto con una norma precedente, è in effetti configurabile un fenomeno di abrogazione implicita. O, meglio, nel caso in esame potrebbe trattarsi di un caso di deroga, dal momento che la nuova norma contrasta con la precedente non nel senso di farla venire meno in generale e in tutti i casi, ma nel senso di disciplinare in modo diverso solo determinati casi, che pure rientrerebbero nella previsione della prima (39). Ragionando in questo modo, tuttavia, si rischia di perdere di vista la fondamentale differenza tra le due norme, dal momento la vera novità che la riforma ha comportato è stata quella di concepire una nuova forma di tutela penale, che si esprimesse in termini di infedeltà anziché di appropriazione. Al tempo stesso è improprio parlare dell’infedeltà patrimoniale come di un’appropriazione indebita specializzata, atteso che è proprio nell’assenza del momento appropriativo che si concentra la principale differenza tra la condotta dell’una e dell’altra fattispecie. In questo senso si pongono altresì quelle pronunce della Suprema Corte, che rilevano come non possa sussistere alcuna area di abolitio criminis, dal momento che sarebbe irragionevole ritenere non punibili in ambito societario comportamenti compiuti dai soggetti attivi dell’infedeltà patrimoniale, che rientrerebbero però, se compiuti da altri soggetti e/o al di fuori dell’ambito societario, nel campo di applicazione dell’appropriazione indebita. ( 38 ) Quella disciplinata all’articolo 2629-bis del codice civile, tuttavia, non è una fattispecie di applicazione generale, perché dal novero dei soggetti attivi del reato si evince che fa riferimento esclusivamente alla grande impresa (fatta forse eccezione per le piccole banche rurali). Dunque, l’estensione di tutela è limitata. Per giunta, l’opportunità di una simile introduzione è messa ulteriormente in discussione dal mancato collegamento con l’infedeltà patrimoniale, quasi che l’esistenza di un’altra fattispecie penale, destinata a punire condotte se non propriamente analoghe quantomeno difficilmente distinguibili nella pratica, costituisse una circostanza assolutamente trascurabile. Ne consegue che anche tra queste due fattispecie, la nuova e la nuovissima, sussiste una assai problematica specialità reciproca, risolvibile, forse, solo ragionando nel senso di una parziale abrogazione o di un’implicita deroga. ( 39 ) V., in generale, Cuocolo Fausto (2000), Istituzioni di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, XI edizione, 47 e Falcon Giandomenico (2001), Lineamenti di diritto pubblico, Padova, CEDAM; VIII edizione, 33. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE 151 6. È giunto ora il momento di soffermarsi brevemente sul rapporto di specialità reciproca tra la fattispecie del 2634 c.c. e quella del 646 c.p.. Richiamate le due disposizioni e confrontati tutti i loro elementi tipici, rimane in effetti da svolgere qualche approfondimento, quanto mai d’uopo tra queste riflessioni. La fondamentale domanda, che ritengo occorra porsi, è in che termini e fino a che punto l’appropriazione indebita realizzi un comportamento infedele. Partendo dal dato letterale, infatti, non si nota alcun accenno all’infedeltà, e men che meno a un conflitto di interessi. Tuttavia, anche senza allontanarsi molto dalla lettera della disposizione, non si può tralasciare come alcuni autori (40) evidenzino come alla base dell’appropriazione indebita ci sia un rapporto di fiducia e che, pertanto, la caratteristica del delitto di appropriazione indebita consista nella violazione della fiducia che è insita nel rapporto da cui trae origine il possesso. Anche se tale concezione è messa in dubbio dalla mancata previsione, nel codice del 1930, del requisito dell’affidamento (41), non si può negare che vi sia un’affinità con la situazione tutelata dalla fattispecie di infedeltà patrimoniale, a monte della quale c’è proprio la scelta di affidare la gestione del patrimonio agli amministratori, perché ne usino nell’interesse della società. In definitiva, non si può ragionevolmente negare che ci sia un rapporto che nasce su basi di fiducia, ed è proprio questa a venire violata tutte le volte in cui gli amministratori considerano un interesse diverso da quello della società (42), titolare del patrimonio gestito, o dei terzi che ad essa hanno affidato, a loro volta, i propri risparmi. Se si pone prevalentemente l’accento su questo punto, tuttavia, il rischio è quello di perdere completamente il filo dell’interpretazione, non riuscire più a orientarsi tra le due fattispecie, con nefaste conseguenze in termini di applicazione, specialmente nelle ipotesi di fatti commessi prima dell’entrata in vigore della nuova norma penale. Nelle sue pronunce la Corte di Cassazione dimostra di essere ben consapevole della questione, ammonendo che con siffatti ragionamenti si offrirebbero pericolosi appigli a chi sostiene che l’unica distinzione tra 646 c.p. e 2634 c.c. sia negli ambiti di applicazione e dunque apra un vuoto (43) di tutela in ambito societario ( 40 ) V. in particolar modo, sul tema, Petrocelli Biagio (1933), L’appropriazione indebita, Napoli, Morano, 114 e ss. e Mantovani Ferrando (1989), Delitti contro il patrimonio, Padova, CEDAM, 100. ( 41 ) Lo ricorda Aantolisei Francesco, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. I, a cura di Conti Luigi (2002), XIV edizione integrata e aggiornata, 335 e ss. Questo Autore sostiene che non via sia nessun vincolo di fiducia alla base dell’appropriazione indebita, essendo la relativa fattispecie pacificamente applicabile anche qualora tale vincolo non sussista affatto. ( 42 ) Non è una caso che la norma tedesca sull’Untreue, a lungo vista come un faro per l’introduzione di un’analoga fattispecie nell’ordinamento italiano, contempli espressamente una condotta consistente nella violazione dell’obbligo di fedeltà. ( 43 ) Da cui il conseguente horror vacui, che è stato al centro delle riflessioni della Suprema Corte. 152 GIURISPRUDENZA ove, attorno a quel piccolo scoglio rappresentato dall’infedeltà patrimoniale, terreno eroso dai troppi elementi che caratterizzano e specificano la fattispecie, rimane un immenso mare ove potrebbero nuotare tranquillamente gli squali che il 646 c.p. non limiterebbe più. Lungi dal permettere la realizzazione di un simile scenario, la Suprema Corte si è premurata di indicare i confini entro cui tuttora opera l’appropriazione indebita e, com’era ragionevole aspettarsi, almeno finché l’infedeltà patrimoniale si presenterà così come oggi appare irrimediabilmente essere, tali confini sono proprio a ridosso della nuova fattispecie. Non c’è spazio per alcuna abolitio criminis. Rimane semmai da domandarsi come sia possibile conciliare il concetto stesso di appropriazione con un profitto tratto dalla gestione infedele, purché in assenza di conflitto di interessi, dal momento che su tale posizione si attesta una precedente decisione della Sezione V della Corte di Cassazione (44), espressamente richiamata dalla sentenza oggi in commento. In effetti, se appare coerente la scelta di ritenere applicabile la fattispecie di infedeltà patrimoniale solo quando sia presente un conflitto di interessi, dal momento che è la disposizione stessa a prevederlo, mentre si può forse argomentare sui suoi caratteri di attualità, obiettiva valutabilità e necessaria riferibilità alla normativa civilistica in materia (45), d’altro lato non è possibile ravvisare un’appropriazione in qualsivoglia gestione infedele, sol perché vi difetti un preesistente conflitto di interessi. Ciò che significa, in ultimo ordine, che quand’anche fosse tagliato il nodo gordiano della specialità reciproca, rimarrebbero delle aree di gestione infedele non presidiate da alcuna norma penale (46). ( 44 ) Si tratta della sentenza del 23/6/2003 (dep. 7/10/2003), n. 38110, Sama; v. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Penale, 2004, 656, con commento di Masucci Massimiliano, 885 e ss. e Martiello Gianfranco, in Studium Iuris, 2004, 400. ( 45 ) Il riferimento è alla disciplina di cui all’articolo 2391 c.c., che la sentenza in esame richiama. Si noti, tuttavia, che proprio tale disposizione prevede un obbligo di comunicazione per ogni interesse, non solo in conflitto. Se infatti un esplicito riferimento al conflitto di interessi era rinvenibile (qualche dubbio sulla portata di tale riferimento era peraltro sollevato: v. in proposito Antolisei Francesco, Manuale di Diritto Penale, Leggi complementari, vol. I – I reati societari, bancari, di lavoro e previdenza, dodicesima edizione, 2002, Milano, Giuffrè, 261, questo Autore notava come il codice civile ne accennasse nella rubrica dell’articolo 2391, ma non lo definisse) nella vecchia norma civilistica, di cui al previgente articolo 2391 del codice civile, il nuovo testo dell’articolo 2391 del codice civile impone all’amministratore un obbligo di informazione assai più pregnante. Il maggior rigore di questa disciplina vuole sottolineare non solo che qualsiasi amministratore, gestore di un patrimonio altrui, non può approfittare della sua posizione per conseguire diretti o indiretti vantaggi, ma, soprattutto il valore della trasparenza nella gestione della società (cfr. Galgano Francesco e Genghini Riccardo, Il nuovo diritto societario, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, 2004, Padova, CEDAM, vol. XXIX, 258-259). Si tratta di un profilo della riforma delle società che interferisce sulla disciplina dettata dalla fattispecie incriminatrice, di cui all’articolo 2634 del codice civile, sia sul piano dell’ambito di applicazione, sia riguardo all’interpretazione degli elementi costituivi della fattispecie. V. meglio infra. ( 46 ) Nell’attesa che la Corte di Cassazione affronti i rapporti di specialità reciproca a loro volta inter- ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE 153 È allora innanzitutto necessario chiedersi se, dato lo stretto legame che accomuna le due norme, in uno scenario che vede la fattispecie comune arretrare il passo rispetto a un fronte dove finalmente sono giunte forze fresche, il nuovo delitto di cui all’articolo 2634 c.c. abbia realmente, e in che misura, oltre alla collocazione, connotati di maggiore specificità rispetto all’appropriazione indebita. 7. Di qui, naturalmente, tutta l’attenzione degli interpreti torna a concentrarsi, imprescindibilmente, sulla presenza di un conflitto di interessi, espressione che, in effetti, l’articolo 2634 c.c. riporta, mentre non la contempla il 646 c.p.. Entrambe le disposizioni, tuttavia, non si dimostrano sul punto esaustive. In tema di appropriazione indebita non si può infatti escludere che sia in conflitto con l’interesse del proprietario della cosa quello del detentore che se ne appropria; in tema di infedeltà patrimoniale, d’altro lato, non vi è alcuna specifica indicazione riguardo ai caratteri del conflitto di interessi in cui debba versare il gestore infedele, né che espliciti se il suo interesse debba essere economico, se debba preesistere e in che rapporto si ponga con l’ingiusto profitto o altro vantaggio. Va peraltro segnalato che non è possibile affrontare la questione della specialità reciproca tra norme senza richiamare l’attenzione anche su problematiche che la giurisprudenza si è trovata a dover esaminare a fronte di eccezioni difensive, le correnti tra infedeltà patrimoniale e la (ancor più) nuova fattispecie di omessa comunicazione del conflitto di interessi di cui all’articolo 2629-bis c.c. In effetti, in seguito alla riforma introdotta dalla legge 262 del 2005, l’infedeltà patrimoniale non è più l’unica fattispecie penale, annoverata nel codice civile tra i reati societari, a sanzionare le condotte infedeli dei gestori. In realtà, proprio in conseguenza di tale scelta legislativa, solo se si considera l’articolo 2629-bis come volto a disciplinare un particolare settore economico, in cui sia esclusa l’applicabilità dell’articolo 2634, si giunge a un risultato interpretativo soddisfacente. Non sarebbe viceversa ammissibile l’esistenza di un sistema in cui un amministratore, poniamo ad esempio di società per azioni quotata, solo per aver omesso di comunicare un interesse proprio, quando si sia verificato un danno alla società, venga punito più gravemente di un altro amministratore, anch’egli di società quotata, il quale, oltre a non aver comunicato il suo conflitto di interessi, abbia cagionato intenzionalmente un danno alla propria società, al fine di trarre un profitto ingiusto. Orbene, immaginiamo, per meglio comprendere l’assurdità della situazione che si verificherebbe, la possibile difesa del primo amministratore: egli potrebbe cioè confessare di aver intenzionalmente voluto danneggiare la società, preferendo un’imputazione ex articolo 2634, piuttosto che una ex articolo 2629-bis; anche perché l’infedeltà patrimoniale è perseguibile a querela e non è poi così scontato che essa venga proposta. Peraltro si segnala come negli ultimi anni il legislatore si sia dimostrato decisamente propenso a favorire il verificarsi di simili, paradossali, situazioni, quando si tratti di coordinare il «nuovissimo» con il «nuovo». In proposito si può notare come una vera e propria sorta di «teatrino» sia configurabile rispetto all’infedeltà a seguito di dazione o promessa (2635 c.c.), compiuta dai revisori contabili, come messo in evidenza dalle riflessioni di Paliero Carlo Enrico (2006), La riforma della riforma penale del risparmio: continuità e fratture nella politica criminale in materia economica, in Il corriere del merito, n. 5, 619, ove l’Autore commenta l’articolo 174-ter del T.U.F., disposizione che non prevede, a differenza del 2635 del codice civile, né un nocumento, né la querela, pur comminando una sanzione più grave. Ecco allora aprirsi uno scenario in cui gli autori del reato «pietiscono le vittime la presentazione di una querela contro di loro» e i difensori «mobilitano prestigiosi collegi peritali per dimostare l’esistenza e la rilevanza del danno prodotto dal proprio assistito». 154 GIURISPRUDENZA quali si concentrano sull’assenza di danno o sulla perseguibilità a querela propria dell’infedeltà patrimoniale (47). Queste ultime meritano un cenno particolare, in quanto si dimostrano estremamente suggestive. In effetti, riflettendo circa l’applicazione della fattispecie di infedeltà patrimoniale, che a fronte di una forte connotazione soggettiva prevede d’altro lato la perseguibilità a querela, si può quasi considerare che convenga confessare l’esistenza di un conflitto di interessi e di un dolo specifico e sfuggire così alla sanzione comminata per la fattispecie di appropriazione indebita. Si tratta di una strategia solo apparentemente suicida, dal momento che si fonda su un calcolo in realtà estremamente razionale, contando sulla mancata proposizione della querela (48). Se ciò non bastasse, semmai, si potrebbe pur sempre calcolare di scampare alla sanzione evidenziando la mancanza di qualche altro elemento del 2634, come l’intenzionalità del danno, per tacere della possibilità di illustrare la prevedibilità di qualche (più o meno verosimile) vantaggio compensativo in favore di un (anche quello più o meno verosimile) gruppo di società. Non stupisce, dunque, che in ogni caso la preoccupazione principale, specie in sede di esecuzione penale, fosse comunque quella di chiarire fin dove si spingesse ancora l’applicazione dell’articolo 646 c.p., se fosse ancora possibile in materia societaria e, di fatto, se ancora una volta fosse necessario che la fattispecie dell’appropriazione indebita svolgesse una funzione di supplenza in ambito societario. ( 47 ) Perseguibilità pertanto sottoposta, di fatto, a valutazione di opportunità, alla quale sarebbe peraltro tenuta l’assemblea, in quanto i singoli soci si presentano solo quali soggetti danneggiati dal reato e dunque non legittimati alla proposizione di querela, con i prevedibili problemi applicativi che ne conseguono, dal momento che la rinuncia alla procedibilità d’ufficio rappresenta una scelta politico-criminale destinata verosimilmente a neutralizzare in partenza le chances di applicazione pratica della fattispecie incriminatrice. Non solo: si accentua altresì l’incoerenza interna della fattispecie, insita nella scelta di orientare la tutela in chiave di protezione del patrimonio sociale, piuttosto che di salvaguardia del solo dovere di fedeltà degli amministratori. Tale impostazione, rendendo disponibile l’offesa del bene tutelato attraverso la procedibilità a querela da parte della sola maggioranza assembleare, rende ancora più equivoca la rubrica di infedeltà patrimoniale, che non spiega la mancanza dell’aspettativa dei soci di minoranza a che gli organi sociali proteggano il patrimonio dell’ente. In dottrina si segnalano, in tema di persona offesa dal reato di infedeltà patrimoniale e proposizione della querela, le riflessioni di Militello Vincenzo (2002), L’infedeltà patrimoniale (art. 2634), in I nuovi reati societari: diritto e processo, a cura di Giarda Angelo e Seminara Sergio, Padova, CEDAM, 482; Foffani Luigi (2002), Le infedeltà, in Il nuovo diritto penale delle società a cura di Alessandri Alberto, Milano, IPSOA, 363; Masullo Maria Novella (2003), 2634, in Le leggi penali d’udienza, a cura di Padovani Tullio, Milano, Giuffrè, 1307; Seminara Sergio (2004), Considerazioni penalistiche sul disegno di legge in tema di tutela del risparmio, in Diritto penale e processo, n. 4, 503511; Fondaroli Désirée (2005), Introduzione ai delitti di infedeltà, in Reati societari, a cura di Rossi Alessandra, Torino, UTET Giuridica, 394 e ss; Rainone Valeria (2006), Il delitto di infedeltà patrimoniale tra modernità e post-modernità penalsitica, in Banca borsa e titoli di credito, fascicolo 4, 450 e ss. ( 48 ) Si consideri infatti che, nonostante anche la fattispecie di appropriazione indebita sia caratterizzata, in generale, dalla perseguibilità a querela, l’articolo 646 c.p., ultimo comma, prevede che si proceda d’ufficio nelle ipotesi indicate al numero 11 dell’articolo 61, ivi compreso, dunque, l’aver commesso il fatto con abuso d’autorità o di relazioni di ufficio o di prestazione d’opera. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE 155 Ebbene, la Corte di Cassazione ha avuto ben presto modo di confrontarsi con simili questioni (49) e il risultato è stato quello che si potrebbe ritenere il più razionale: dalle statuizioni della Suprema Corte si evince che la fattispecie comune non cede il passo al reato proprio, ciò che comporterebbe un arretramento del fronte, nei limiti in cui il reato proprio non è in grado di presidiare da solo il campo societario. Quando però la Corte di Cassazione ha indicato la non applicabilità dell’articolo 2634 c.c., in mancanza delle condizioni di conflitto di interesse, ritenendo quindi la punibilità ex 646 c.p., cioè appropriazione indebita, ha compiuto uno sforzo interpretativo notevole per sfuggire alla specialità reciproca tra le due norme, indicando come soluzione la via della disciplina civilistica del conflitto di interessi. Si tratta quindi di valutare in che misura le argomentazioni usate siano idonee a supportare una simile tesi. In proposito è necessario concentrare l’attenzione su come si esplichi la condotta infedele. L’articolo 2634 del codice civile la descrive infatti piuttosto asetticamente, dal momento che sono puniti i gestori che «compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali (50)», affidando al conflitto di interessi, al dolo intenzionale e a quello specifico, oltre alla causazione di un danno patrimoniale, il ruolo di catalizzatori del disvalore. 8. Così come è emerso anche dagli apporti comparatistici inizialmente esaminati il ruolo del conflitto di interessi, quantunque esso sia ravvisabile all’interno delle varie fattispecie, non è essenzialmente quello di scriminare le condotte punibili; o meglio, se sicuramente esso apporta elementi valutativi di rilievo per comprendere (e delimitare) le ipotesi di infedeltà e di abuso, ciò nondimeno esso non è il fondamento su cui basare ogni distinzione. Lo dimostra la semplice considerazione che ciascuno degli ordinamenti richiamati in questo approfondimento ha adottato, in proposito, una diversa soluzione. In questo, però, è innegabile il ruolo che rivestono dottrina e giurisprudenza, specie se consolidatesi nel corso di decenni di applicazione, com’è per Francia e Germania e com’è stato, in parte, per l’abrogata fattispecie di estafa. Orbene, la tradizione italiana, con ogni probabilità ed evidenza, ruota proprio ( 49 ) La Suprema Corte si è trovata investita della questione dell’ambito di applicazione dell’articolo 2634 in primo luogo con riguardo alla fattispecie di bancarotta di cui all’articolo 223 L.F.; v. in proposito Cass. pen. Sez. IV, 27 maggio 2003, n. 23241, che affronta il tema dell’estensione della disposizione relativa ai vantaggi compensativi al di fuori dell’ambito dei reati societari, con una soluzione che desta alcune perplessità. ( 50 ) Peraltro, si ricorda, il comma 2 commina la stessa pena «se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi». 156 GIURISPRUDENZA attorno al conflitto di interessi. Tuttavia c’è da domandarsi quanto sia matura la riflessione sul tema. Non vi è infatti da dimenticare che le applicazioni pratiche della norma su cui si è concentrata la dottrina in tema di conflitto di interessi sono state assolutamente marginali (51). Ecco perché suscita perplessità la statuizione della Corte di Cassazione secondo cui, affinché possa trovare applicazione la fattispecie di infedeltà patrimoniale, il conflitto di interessi deve presentare specifiche connotazioni. La finalità è facilmente comprensibile: respingere le pretese di chi, invocando un conflitto di interessi in sede di esecuzione penale speri di sottrarsi così a già pronunciate condanne per appropriazione indebita, nondimeno le argomentazioni a sostegno sono state troppo frettolose. La motivazione di una sentenza, in effetti, serve ad illustrare il percorso logico attraverso il quale si è giunti alla soluzione adottata nel dispositivo, non a sorreggerla ex post (52). In questo caso può forse anche sorgere qualche dubbio sulla reale capacità del riferimento al conflitto di interessi a limitare l’applicazione della fattispecie di infedeltà patrimoniale. Se infatti il conflitto di interessi deve, perché sia rilevante ai fini dell’articolo 2634, presentare dei caratteri che la Corte di Cassazione non sviscera a fondo, neanche l’interprete riesce ad attribuirvi maggiore chiarezza approfondendo la questione. Come può infatti parlarsi di un conflitto di interessi di rilevanza civilistica? Si può forse pensare di trovarci in una situazione analoga a quella del legislatore del 1930 quando inserì nel codice penale la nozione di pubblico ufficiale, convinto che la dottrina amministrativistica avrebbe saputo fornire ogni necessario chiarimento in merito. La realtà è che in alcuni casi gli altri rami del diritto, cui il penalista si appella, non riescono a fornire la chiarezza sperata, proprio in quanto le varie branche del diritto non esistono in funzione di quello penale. È necessaria allora una breve riflessione sulle ragioni della necessità del collegamento con la disciplina civilistica in materia di conflitto di interessi. Si tratta infatti di verificare innanzitutto quanto sia probante (53) la collocazione del reato di infedeltà patrimoniale nel tessuto del codice civile (54) e in secondo luogo, tema di ( 51 ) Il riferimento è, naturalmente, al previgente articolo 2631del codice civile. ( 52 ) Non si può non ricordare, in proposito, la lucidità espositiva delle pagine di Piero Calamandrei nel suo Elogio dei giudici scritto da un avvocato (Le Monnier, Firenze, 1954). ( 53 ) V. in proposito la sentenza in epigrafe, che a tale argomentazione, seppur trattandosi di affermazione presentata apoditticamente all’interno di un discorso logico più ampio, sembra voler attribuire un certo peso nelle motivazioni della decisione. ( 54 ) Sul punto possono richiamarsi le osservazioni dei primi commentatori delle fattispecie nate dalla riforma dei reati societari. V. ad es. Alessandri Alberto (2002), Alcune considerazioni generali sulla riforma, in Il nuovo diritto penale delle società a cura di Alessandri Alberto, Milano, IPSOA, 3 e ss.; parla ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE 157 certo non minor rilevanza, appurare in che termini si manifesti il conflitto di interessi alla luce della disciplina civilistica, qualora vi sia sul punto uniformità di vedute. Si tratta di una questione particolarmente stimolante, specie se si considera la convergenza tra fattispecie penale e civile. Infatti, quanto precedentemente non emerso all’interno dei rapporti societari, potrebbe essere oggi invocato dalle difese in sede penale, allorché l’infedeltà patrimoniale, ricca di elementi costitutivi, oltre a contemplare la perseguibilità a querela comporta maggiori oneri probatori. Ecco dunque che la configurazione in termini di conflitto di interessi diventa centrale: fino a che punto l’imputato può difendersi confessando il proprio conflitto di interessi e fino a che punto le sue affermazioni posso essere ritenute irrilevanti (55)? Il rischio da scongiurare, paradossalmente, sembrerebbe quello di una confessione parziale ai fini di garantirsi di fatto l’impunità. La giurisprudenza non ha potuto trascurare questo aspetto e proprio in tale prospettiva la Corte di Cassazione si è premurata di precisare, nella sentenza in esame, che non attiene all’ambito di applicazione dell’infedeltà patrimoniale l’ipotesi in cui un soggetto si appropri il denaro o la cosa mobile dell’ente, di cui abbia la disponibilità in ragione della carica, per l’assenza di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi quale presupposto della deviazione dell’atto di disposizione dal suo fine istituzionale. 9. L’affermazione della Corte è ineccepibile nella parte in cui insiste nel dire che l’appropriazione altro è rispetto alla gestione infedele, tuttavia è incomprensibile, perché non evidente, né adeguatamente motivato, il passaggio argomentativo in cui tale distinzione viene fatta derivare dall’assenza di un preesistente interesse in conflitto. Qualche esempio può forse essere d’aiuto. Assumendo che il soggetto attivo, in tutte le seguenti ipotesi, sia Tizio, amministratore delegato di una società, il problema è capire quando la sua condotta sia qualificabile come infedeltà patrimoniale e quando come appropriazione indebita e se il criterio distintivo enunciato dalla Suprema Corte sia efficace. addirittura di «peccato originale» di una regolamentazione penalistica che ha preceduto la riforma della disciplina civilistica Fondaroli Désirée (2005), Introduzione ai delitti di infedeltà, in Reati societari, a cura di Rossi Alessandra, Torino, UTET Giuridica, 392; considera invece positivamente la scelta, quanto alla collocazione sistematica della norma, di conservare l’impostazione tradizionale, con l’inserimento della previsione non in sede di codice penale, ma nella normativa dedicata alla società, secondo il modello francese, Militello Vincenzo (2002), L’infedeltà patrimoniale (art. 2634), in I nuovi reati societari: diritto e processo, a cura di Giarda Angelo e Seminara Sergio, Padova, CEDAM, 480 e ss. ( 55 ) Parla in effetti espressamente di mancata prova del conflitto di interessi Cass. pen. Sez. V n. 1236 del 7/10/2003. 158 GIURISPRUDENZA Se il nostro Tizio si appropriasse di uno dei quadri che arredano la sua sala riunioni, dopo aver scoperto che l’artista che l’ha dipinto è da poco diventato famosissimo, e lo rivendesse a un collezionista ricavandone decine di migliaia di euro, di primo acchito pochi dubbi sorgerebbero sulla riconducibilità della sua condotta alla fattispecie di appropriazione indebita. Se Tizio, nello scegliere tra diverse imprese quella a cui affidare l’edificazione di una nuova sede succursale, scegliesse Alfa, piccola società di cui egli è socio al 30%, trascurando le maggiori garanzie in termini di solidità ed esperienza offerte da Beta, con ogni probabilità rientrerebbe nell’ipotesi di infedeltà patrimoniale, tuttavia con il dubbio sulla sussistenza di un danno che Tizio abbia intenzionalmente causato alla propria società. Venendo a un’ipotesi più complessa, immaginiamo quindi che Tizio costituisca un fondo nero, sottragga cioè delle somme che cessano perciò di risultare a bilancio. Si tratta di un caso che la giurisprudenza tedesca fa pacificamente rientrare nella fattispecie di Untreue, dal momento che mette in pericolo (56) il patrimonio sociale, e che la stessa giurisprudenza italiana, anteriormente all’avvento dell’infedeltà patrimoniale, avrebbe con ogni probabilità sanzionato quale appropriazione indebita. Con l’introduzione della fattispecie di infedeltà patrimoniale, che non solo è reato di danno, ma richiede per di più l’intenzionalità del danno, occorre necessariamente approfondire il profilo soggettivo connesso alla condotta del nostro Tizio. Sarebbe infatti diverso se egli avesse costituito un fondo nero per offrire delle tangenti e assicurare così alla propria società fruttuosi contratti, piuttosto che se lo avesse fatto al fine di fuggire con quei soldi a fine mandato. Trascurando qui il profilo della corruzione, emerge però che nessuna delle due ipotesi rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’infedeltà patrimoniale: l’una per mancanza del conflitto di interessi, l’altra perché non si tratterebbe di deviazione di un atto di disposizione dal suo fine istituzionale, ma di vera e propria appropriazione indebita di somme, di cui Tizio aveva la disponibilità in ragione della propria carica. Peraltro rimane il dubbio se sia applicabile la fattispecie di appropriazione indebita, nel nostro ordinamento, alla prima delle due ipotesi, dal ( 56 ) Se si trattasse esclusivamente di fondi costituiti per scopi estranei alla società, non vi sarebbero dubbi sull’integrazione del delitto di infedeltà; rimane problematico invece il caso in cui i fondi neri servano proprio agli scopi della società stessa. In realtà, anche in questo caso gli interpreti sono in grado di configurare un pregiudizio patrimoniale ai sensi del § 266 StGB, dal momento che, una volta costituito un fondo nero, non vi sarebbe comunque più alcun controllo sul suo utilizzo e sussisterebbe il concreto pericolo che l’amministratore, che ha costituito il fondo, ne disponga a sua personale discrezione o a favore di un terzo. Cfr. Miedico Melissa (2002), I reati societari in Germania, in Il nuovo diritto penale delle società a cura di Alessandri Alberto, Milano, IPSOA, 546; e il richiamato Schmidt Wolfgang (2000), in Wirtschaftsstrafrecht: eine Gesamtdarstellung des deutschen Wirtschaftsstraf und ordnungswidrigkeitenrechts, a cura di Müller-Gugenberger Christian e Bieneck Klaus, Köln, 812. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE 159 momento che a essere carente è proprio, nell’esempio, il momento appropriativo (57). Orbene, si tratta ora di distinguere, tra gli esempi prospettati, le diverse fattispecie, in base al criterio della preesistenza del conflitto di interessi enunciato dalla Corte. Nella prima ipotesi Tizio ha un interesse personale ad avere per sé il quadro dal momento in cui scopre che esso è di valore, e questa sua conoscenza è anteriore al momento in cui lo stacca dalla parete della sala riunioni; d’altro canto è interesse della società sapere che un bene del patrimonio sociale ha acquisito nel tempo un enorme valore, ma Tizio si guarda bene dal comunicarlo. Dunque c’è un conflitto di interessi preesistente, è obiettivamente valutabile ed è anche attuale con riferimento alla condotta. Eppure quella di Tizio non ha una caratterizzazione sufficiente per essere considerata amministrazione infedele dei beni sociali. Il secondo esempio è più lineare: Tizio si trova in una preesistente situazione di conflitto di interessi, i cui due poli sono costituiti dalla sua carica di amministratore e dalla sua partecipazione nella società Alfa. Il conflitto diventa attuale nel momento in cui Alfa si propone quale contraente della società di cui Tizio è amministratore. Nel terzo esempio, cui sono riconducibili due diverse ipotesi, Tizio ha un interesse proprio soltanto nella seconda, dal momento che nella prima ipotesi egli persegue, se pur con mezzi discutibili, l’interesse della società. Anche concentrando l’attenzione sulla seconda ipotesi, quella in cui Tizio distrae delle somme di cui aveva la gestione e le occulta per servirsene in seguito, rileviamo però che il conflitto di interessi non presenta i caratteri indicati dalla Corte di Cassazione: non è infatti preesistente, né attuale, né riconoscibile, perché al momento di costituzione ( 57 ) La giurisprudenza ha compiuto delle distinzioni sul punto. Alcune sentenze propendono nel senso di considerare non idoneo a configurare il delitto di appropriazione indebita il versamento ad opera degli amministratori di una società di fondi extrabilancio su conti solo formalmente non riconducibili alla stessa, qualora li utilizzino per il perseguimento, sia pure con mezzi illeciti (quali il finanziamento occulto a partiti politici), di fini non estranei agli interessi sociali (Cass. pen. Sez. V, 13/6/1998, n. 10041). In ogni caso pare riconoscersi che la creazione di riserve occulte e l’utilizzazione extrabilancio di fondi sociali non siano di per sé sufficienti ad integrare il delitto di appropriazione indebita; deve infatti escludersi che possa essere qualificata come distrattiva, e tantomeno come appropriativa, un’erogazione di danaro che, pur compiuta in violazione delle norme organizzative della società, risponda a un interesse riconducibile anche indirettamente all’oggetto sociale, poiché per aversi appropriazione è necessaria una condotta che non risulti giustificata o giustificabile come pertinente all’azione o all’interesse della società (Cass. pen. Sez. V, 21/1/1998, n. 1245; nell’occasione la Corte ha precisato che l’appropriazione indebita è invece configurabile, e concorre pertanto con il delitto di cui all’articolo 7 l. 2 maggio 1974 n. 195, allorché l’illecito finanziamento di partiti politici con fondi occulti sia erogato nell’interesse personale ed esclusivo dell’amministratore). D’altro lato la disponibilità di ingenti fondi, costituenti riserve occulte, con erogazioni per fini affatto estranei allo spettro degli interessi delle società amministrate, dà ampiamente conto della sussistenza del dolo specifico che qualifica la fattispecie delineata dall’articolo 646 c.p. (Cass. pen. Sez. V, 9/7/1992). 160 GIURISPRUDENZA dei fondi non è dato sapere come Tizio intenda impiegare quelle somme. Un simile atto di gestione, che, come evidenziato, mette in pericolo i beni sociali distratti, non sarebbe dunque punibile quale infedeltà patrimoniale, né, probabilmente, come appropriazione indebita, dal momento che non vi è alcuna immissione nel patrimonio dell’agente (58), che peraltro ne aveva già il possesso in quanto amministratore. Rischia dunque di sfuggire l’utilità del criterio enunciato dalla sentenza in esame. In realtà, appare assai più pregnante il riferimento all’appropriazione, da un lato, e alla deviazione dell’atto di disposizione dal fine istituzionale, dall’altro, dal momento che chiarisce che la natura dell’infedeltà patrimoniale è insita nello sviamento della gestione, qualora al perseguimento dell’interesse sociali si anteponga un interesse diverso. D’altro canto, è anche agevole intuire che quanto più nel perseguire un profitto a danno della società gli amministratori percorrono vie traverse, tanto più ci si allontana dallo schema dell’appropriazione indebita (59). 10. È stato detto (60) che la fattispecie di infedeltà patrimoniale tipizza la necessaria relazione fra conflitto di interessi e finalità sottese all’atto, connotando di ingiustizia il profitto. Se questo è vero, rimane problematica la presenza del danno intenzionale, elemento che, comunque lo si guardi, costituisce un quid pluris rispetto al dolo di profitto, né può essere assorbito dalla posizione di conflitto di in- ( 58 ) Sulla distinzione tra condotta appropriativa e condotta distrattiva è stato evidenziato che, benché implichino entrambe la sottrazione del bene alle sue finalità istituzionali, tali condotte si diversificano nella fase successiva della nuova destinazione, che nell’appropriazione è soggettivamente ed oggettivamente orientata ad impadronirsi della cosa, cioè ad instaurare un completo dominio su di essa immettendola nel patrimonio dell’agente, mentre nella distrazione è rivolta semplicemente ad un uso arbitrario del bene con impiego per fini diversi da quello cui era destinato. Le conclusioni tratte dalla giurisprudenza non sono peraltro univoche, dal momento che talora si è detto che l’amministratore delegato della società capogruppo, che distragga fondi extrabilancio di società controllate senza vantaggio personale né fraudolente intese con i terzi destinatari dei singoli atti di disposizione, non realizza alcuna condotta riconducibile al modello di appropriazione indebita (cfr. Cass. pen., 23/6/1989); talaltra si è contestata proprio la teoria che l’attività distrattiva non costituisca modalità della appropriazione, in quanto, se l’autore di una distrazione agisce con la volontà di dare al bene una destinazione diversa da quella naturale, sarebbe automatico ritenere che agisca al di fuori dei poteri conferitigli e quindi eserciti sul bene un possesso diverso da quello legittimo (cfr. la nota sentenza Cusani, Trib. Milano, 28/4/1994, in Foro Italiano, 1995, II, 24-104, con nota di Amato Fausto Maria, 26-48, e Di Chiara Giuseppe, che peraltro si concentra sugli aspetti di diritto processuale, 24-26 e 49-58). Peraltro la questione della riconducibilità delle condotte distrattive nello schema dell’appropriazione indebita sembra esulare dalla sentenza in epigrafe, come ricorda anche Marini Consuelo (2006), Il rapporto tra appropriazione indebita e infedeltà patrimoniale, in Le Società, 1548-1551, atteso che le condotte poste in essere dagli imputati, che con fittizie operazioni infragruppo spostavano risorse finanziarie della società per farne un uso in parte anche personale, andavano oltre la mera distrazione. ( 59 ) Una considerazione, quest’ultima, addirittura elementare, lapalissiana, secondo l’espressione usata da Pedrazzi Cesare (2003), Gli abusi del patrimonio sociale da parte degli amministratori, in Rivista Italiana di diritto penale, 1953, 578, ora anche in Scritti di diritto penale dell’economia, Milano, Giuffrè, 559. ( 60 ) Cfr. la breve sintesi della sentenza in esame, in Le Società, 2006, 448. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE 161 teressi (61). Peraltro, vi è ragione di ritenere che proprio in ragione di questo elemento della fattispecie il percorso argomentativo della Corte di Cassazione abbia riconosciuto la necessità di richiamare la disciplina civilistica del conflitto di interessi, adducendo come motivazione «la significativa collocazione sistematica della norma generale incriminatrice all’interno del codice civile» (62). In questo senso dovrebbe emergere l’utilità del richiamo all’articolo 2391 c.c., che tuttavia pone, dal momento della sua riformulazione, delle questioni che sembrerebbero allontanare dal tema in esame. Con la riforma del 2003, in effetti, quella che era una norma sul conflitto di interessi degli amministratori è diventata una norma sull’informazione (63). Di qui la difficoltà di valutare se esista ancora nel nostro ordinamento una definizione di conflitto di interessi corrispondente al modello sanzionato dal delitto di infedeltà patrimoniale e schematicamente rappresentato dai due corni del dilemma, di cui uno, quello del profitto personale, viene scelto con preferenza rispetto all’altro, rappresentato dal profitto della società (64). Non perseguendosi il profitto della società, ecco che essa ne riceve un danno (65). ( 61 ) Connotandosi così quale rispettoso omaggio all’impostazione della riforma dei reati societari, di tutela patrimoniale, ma d’altro lato presentandosi anche come elemento apparentemente «distonico» della fattispecie; questa la sensazione anche di Calò Raffaella (2006), Infedeltà patrimoniale e appropriazione indebita: un problema di delimitazione reciproca, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1080. Cfr. inoltre Rainone Valeria (2006), Il delitto di infedeltà patrimoniale tra modernità e post-modernità penalsitica, in Banca borsa e titoli di credito, fascicolo 4, 450 e ss.; Masullo Maria Novella (2003), 2634, in Le leggi penali d’udienza, a cura di Padovani Tullio, Milano, Giuffrè, 1310; da notare peraltro Aldovrandi Paolo (2002), Art. 2634 Infedeltà patrimoniale, in I nuovi reati societari, a cura di Lanzi Alessio e Cadoppi Alberto, Padova, CEDAM, 141e ss. ( 62 ) Si tratta forse, più che altro, di un auspicio, dal momento che il dispregio del legislatore per il collegamento tra norme civili e penali in materia societaria, pur contenute nel codice civile, è emerso dal susseguirsi di riforme non coordinate tra loro. Per quel che riguarda il tema qui trattato, la disciplina della materia, così come oggi si presenta, si è modellata attraverso tre distinte riforme: quella dei reati societari, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, quella delle società di capitali e delle cooperative, di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e infine quella sulla tutela del risparmio, con la legge n. 262 del 28 dicembre 2005, che ha introdotto la fattispecie penale dell’omessa comunicazione del conflitto di interessi. ( 63 ) In questo senso la nuova previsione di cui all’articolo 2391 è perfettamente in linea con le esigenze della governance sostenute dalla riforma, che vede uno dei propri fili conduttori nella trasparenza e nell’informazione che ne è alla base. V. anche Zamperetti Giorgio Maria (2005), Il «nuovo» conflitto di interessi degli amministratori di s.p.a.: profili sparsi di fattispecie e di disciplina, in Le società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale, n. 9, 1085. ( 64 ) In questo senso si può affermare che il profitto ingiusto è la proiezione soggettiva del preesistente conflitto. In sintonia, come ricorda anche Calò Raffaella (2006), Infedeltà patrimoniale e appropriazione indebita: un problema di delimitazione reciproca, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, nota 34, Foffani Luigi (1997), Infedeltà patrimoniale e conflitto d’interessi nella gestione d’impresa, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano, Giuffrè, 354 e Militello Vincenzo (2002), L’infedeltà patrimoniale (art. 2634), in I nuovi reati societari: diritto e processo, a cura di Giarda Angelo e Seminara Sergio, Padova, CEDAM, 486. ( 65 ) Sull’equiparazione tra pericolo e danno in altri ordinamenti, cfr. quando detto supra ed in particolare circa la giurisprudenza francese, che ha individuato i limiti all’applicazione della sanzione alle ipotesi in cui, pur ricorrendo solo un pericolo per il patrimonio sociale, fosse evidente la contrarietà all’interesse 162 GIURISPRUDENZA Orbene, occorre preliminarmente rilevare che oggi l’articolo 2391 c.c. prevede, in nome della trasparenza, che ogni interesse debba essere ammesso ed esplicitato, al punto che ad una prima lettura della disposizione vi è addirittura da domandarsi se si tratti ancora di una norma sul conflitto di interessi. In realtà un’interpretazione più approfondita chiarisce che si tratta tuttora di una norma finalizzata a far emergere situazioni di conflitto di interessi, in considerazione del fatto che dovrà avvenire una valutazione di tutti gli interessi oggetto di comunicazione, ciò che è comunque in linea con la disciplina previgente, ma con il vantaggio di ovviare alle restrizioni che ne limitavano l’efficacia (66). Se infatti la disposizione previgente di fatto rimetteva all’amministratore interessato la valutazione del grado di incompatibilità degli interessi in gioco, con la possibilità di indulgenti autoassoluzioni (67), oggi, in nome della trasparenza, ogni interesse deve essere ammesso ed esplicitato. Inoltre, si può oggi osservare come, consistendo il giudizio sul conflitto in una valutazione ex ante, non serva la produzione di un’effettiva lesione; in questa prospettiva l’omessa comunicazione di un interesse, che sia di un’incidenza tale da apparire rilevante per orientare la decisione di un’operazione, già è carica di disvalore, ciò che se da un lato può apparire un irrigidimento della disciplina delle operazioni in conflitto d’interessi (68), dall’altro si pone come una scelta di coerenza del sistema: non è infatti immaginabile la possibilità di compiere ex ante un giudizio di danno. Con l’attuale stesura dell’articolo 2391 il fondamento della nuova disciplina è pertanto divenuto la preventiva comunicazione al consiglio e all’organo di control- sociale della condotta dell’agente. Ciò che d’altro canto è del tutto in linea anche con la concezione economica per cui il pericolo è una specie di danno. V. meglio Pedrazzi Cesare, Gli abusi del patrimonio sociale da parte degli amministratori, in Rivista Italiana di diritto penale, 1953, 578, ora anche in Scritti di diritto penale dell’economia, Milano, Giuffrè, 2003, 543-604; l’Autore, d’altro canto, evidenzia come quello degli amministratori sia possesso vero e proprio, e non detenzione, nel momento in cui si comportano come organi della società, traducendone la volontà di possesso che, in quanto mera persona giuridica, non potrebbe altrimenti avere; di qui la difficoltà a scindere, logicamente e cronologicamente, il momento appropriativo. Invece Foffani Luigi (2002), Le infedeltà, in Il nuovo diritto penale delle società, a cura di Alessandri Alberto, Milano, IPSOA, 353, richiamandosi all’esperienza tedesca, mette in evidenza l’esigenza di stare in guardia contro il rischio che nella concreta prassi applicativa il danno patrimoniale finisca con l’essere equiparato ad un semplice pericolo. ( 66 ) Semplicemente, la nuova norma priva l’amministratore del potere di decidere se un determinato interesse coincida o piuttosto contrasti con l’interesse sociale, e si attribuisce l’obbligo di valutare questa situazione al consiglio di amministrazione. In questo senso v. Blandini Antonio (2004), Conflitto di interessi ed interessi degli amministratori di società per azioni: prime riflessioni, in Rivista di diritto civile, n. 3, (maggio-giugno), 417. ( 67 ) Zamperetti Giorgio Maria (2005), Il «nuovo» conflitto di interessi degli amministratori di s.p.a.:profili sparsi di fattispecie e di disciplina, in Le società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale, n. 9, 1086. ( 68 ) È quanto afferma ad esempio Enriques Luca (2002), Afef e la pulce della società per azioni, intervento al Convegno di Varese del 20-21 settembre e reperibile in www.associazionepreite.it, 1. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE 163 lo di ogni interesse, per conto proprio o di terzi (69), anche compatibile con quello sociale, di cui l’amministratore sia latore rispetto a una certa operazione. La nuova disciplina di preventiva comunicazione, al consiglio e all’organo di controllo, di ogni interesse per conto proprio o di terzi, svolge così un’importante funzione in termini di disclosure (70). Per queste ragioni, e tenuto conto della visione fisiologica che il legislatore ha della possibile compresenza di più interessi nella dinamica della gestione societaria, si dovrà innanzitutto tentare di stabilire cosa debba intendersi per interesse dell’amministratore ai sensi dell’articolo 2391; solo successivamente si potranno compiere delle valutazioni su quali siano, a livello sistematico, i caratteri del conflitto di interessi (71). 11. Deve darsi conto della sensazione di profondo disagio (72) che l’interprete prova di fronte alla vaghezza e al carattere ambiguo (73) del termine interesse, di ( 69 ) V. in proposito Di Bernardo Maurizio e Mattia Salvatore (2005), Il conflitto di interessi degli amministratori nella nuova s.p.a., in Le società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale, n. 5, 558. Questi Autori si fanno latori dell’opinione secondo cui la cura dell’interesse del terzo deve trovare origine in un rapporto giuridicamente rilevante. In altri termini, l’amministratore deve curare l’interesse del terzo in virtù di un rapporto cui l’ordinamento riconosce rilevanza giuridica, quale ad esempio quello coniugale o quello contrattuale. In proposito si rifanno a Panzironi Valeria (2003), Il conflitto di interessi dell’amministratore di s.p.a. nell’elaborazione di dottrina e giurisprudenza, consultabile presso http:// www.archivioceradi.it. Di diverso avviso invece Visentini Bruno, La disciplina del conflitto di interessi nel mercato mobiliare: società azionarie società di intermediazione mobiliare società di gestione del risparmio, in Nuova Giurisprudenza Civile e Commerciale, 2002, 463, secondo il quale anche rapporti di fatto possono, se giuridicamente rilevanti, essere ragione di assunzione dell’interesse per conto altrui: ad esempio società di fatto, rapporto di lavoro di fatto, consulenza nei fatti coordinata; convivenze di fatto et cetera. Peraltro vi è anche chi in dottrina ha considerato l’inciso per conto proprio o di terzi poco più di un pleonasmo, essendo agevole rinvenire in capo a un amministratore che ha interesse per conto di terzi anche l’interesse proprio nell’accezione ampia. V. in proposito Enriques Luca (2000), Il conflitto d’interessi degli amministratori di società per azioni, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano, Giuffrè, 154. Nello stesso senso si esprime anche D’Alessandro Floriano (1990), Amministratore unico di s.p.a. appartenente a un gruppo e conflitto di interessi «per conto altrui», in Rivista di diritto dell’impresa, 49. ( 70 ) Analizzano lucidamente i profili della norma Di Bernerdo Maurizio e Mattia Salvatore (2005), Il conflitto di interessi degli amministratori nella nuova s.p.a., in Le società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale, n. 5, 557. ( 71 ) Una ricostruzione quanto mai opportuna, se solo si consideri, come già ebbe a rilevare Cesare Pedrazzi, che «il problema dei rapporti tra regolamentazione civile e penale non si pone sovente, per il penalista, in termini di scelta fra una supina importazione degli schemi civilistici e la ricerca di concetti propri, autonomi. Spesso si tratta di scegliere fra una considerazione integrale del regime civilistico e talune qualificazioni o etichette che non rispecchiano il regime civilistico nella sua completa interezza, ma piuttosto lo schematizzano in base a punti di vista limitati, che non sono necessariamente quelli rilevanti ai fini della tutela penale» (Pedrazzi Cesare, Gli abusi del patrimonio sociale da parte degli amministratori, in Scritti di diritto penale dell’economia, Milano, Giuffrè, 2003, 547). ( 72 ) Romano Mario (1967), Profili penalistici del conflitto di interessi dell’amministratore di società per azioni, Milano, Giuffrè, 52. ( 73 ) Luminoso Angelo (1984), Mandato, commissione, spedizione, Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu Antonio e Messineo Francesco, Milano, Giuffrè, 9. 164 GIURISPRUDENZA cui sono incerti l’oggetto e il contenuto (74). Può aiutare a comprendere la soglia normativa dell’interesse rilevante ai fini dell’articolo 2391 del codice civile una breve riflessione sui caratteri della decisione imprenditoriale, che è innegabilmente caratterizzata da un tasso di soggettività. Ovviamente, però, non può essere totalmente soggettiva, atteso che ha un punto di riferimento esterno, cioè il perseguimento dell’oggetto sociale e l’interesse della società, seppure questi possano essere conseguiti attraverso una serie molto ampia di percorsi (75). Dal momento che esistono interessi dei tipi più disparati si potrebbero immaginare innumerevoli esempi, con situazioni di ogni genere (76), relative ad interessi tanto patrimoniali, che extrapatrimoniali, perché l’articolo 2391 non contiene alcuna limitazione in tal senso. A questo punto conviene tornare a domandarci se davvero l’articolo 2391 rappresenti ancora una norma sul conflitto di interessi, sebbene attribuisca ad esso una portata più ampia di quanto non fosse desumibile dalla disposizione previgente. Premesso che non esiste nel nostro ordinamento una nozione unitaria di conflitto di interessi (77), si ha un interesse dell’amministratore in una determinata operazione quando vi sia ragionevole motivo di ritenere che egli, nelle concrete circostanze del caso, si rappresenti di ricavare dal compimento (o dall’omissione) dell’operazione un’utilità quantitativamente e qualitativamente rilevante, purché questa rappresentazione sia socialmente riconoscibile (78) in quanto tale e nel suo oggetto (79). ( 74 ) Donisi Carmine (1992), Il contratto con se stesso, in Pubblicazioni della Scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 134. ( 75 ) Zamperetti Giorgio Maria (2005), Il «nuovo» conflitto di interessi degli amministratori di s.p.a.: profili sparsi di fattispecie e di disciplina, in Le società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale, n. 9, 1088. ( 76 ) V. ancora Enriques Luca (2000), Il conflitto d’interessi degli amministratori di società per azioni, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano, Giuffrè, 143 e ss. A questo Autore, che pure si esprime a riguardo dell’articolo 2391 nella versione previgente, sono attribuibili molti interessanti esempi su cui riflettere, in parte tratti dalla cronaca. ( 77 ) Questo dato sembra accolto senza riserve da Maffeis Daniele (2002), Conflitto di interessi nel contratto e rimedi, Milano, Giuffrè, 18 e ss. Questo Autore nota che talora le discipline del conflitto di interessi non riguardano la conclusione di un contratto, com’è per la disciplina del conflitto di interessi degli amministratori di società. Tuttavia, ciò che è oggetto di specifica disciplina è l’attività esercitata in conflitto di interessi dove il conflitto di interessi è una situazione, che consiste nella presenza di un interesse in conflitto. ( 78 ) Naturalmente il problema concreto di valutare la sussistenza di un conflitto si pone in termini maggiormente ardui rispetto a utilità extra-patrimoniali, atteso che l’omogeneità di un interesse patrimoniale dell’amministratore con l’interesse della società alla massimizzazione dell’utile rende più facile apprezzare la significatività dell’interesse stesso. ( 79 ) Così si esprimono Di Bernardo Maurizio e Mattia Salvatore (2005), Il conflitto di interessi degli amministratori nella nuova s.p.a., in Le società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale, n. 5, 558; a loro volta questi Autori fanno riferimento a Enriques Luca (2000), Il conflitto d’interessi degli amministratori di società per azioni, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano, Giuffrè, 146, anche se in quell’occasione il ragionamento dell’Autore è parzialmente diverso. Essi inoltre ricordano, alla nota 5, che la giurisprudenza di legittimità a questo proposito ritiene che non sia rilevante soltanto l’inte- ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE 165 Deve però escludersi che l’amministratore sia tenuto a trasformare le adunanze consiliari in «sedute autobiografiche» (80) in cui analizzi e dichiari tutte le possibili utilità collegate alle sue vicende biografiche, familiari, mediche, religiose et cetera (81). Occorre allora piuttosto ricordare che la nozione di conflitto di interessi, intesa come situazione, presuppone che la sussistenza di un interesse in conflitto sia valutata ex ante, cioè prima che sia posta in essere l’attività. Se l’interesse proprio dell’amministratore è un interesse che può incidere sulla sua attività, rendendola contraria all’interesse alla cui cura è preposto, cioè l’interesse della società, l’amministratore si trova a dover valutare se egli sia o non sia portatore di un interesse in conflitto con quello della società. Questa valutazione presuppone che l’amministratore sia a conoscenza dell’interesse di cui egli è portatore e si raffiguri l’interesse della società in quell’operazione, e che quindi valuti se il proprio interesse sia tale da incidere sulla cura di quello della società. La stessa valutazione dovrà essere poi fatta dal giudice nel momento in cui si tratterà di stabilire se sussisteva una situazione di conflitto di interessi (82). Ecco allora che sembra trovare conferma l’impostazione che la Suprema Corte ha indicato nella sentenza in commento, tuttavia con qualche precisazione. In effetti, mentre l’amministratore è in grado di valutare se l’interesse di cui è portatore lo indurrebbe a votare contro l’interesse della società, il giudizio ex ante cui è invece chiamato, dall’esterno, il giudice, è meramente ipotetico, perché, una volta che sia chiaro quale fosse l’interesse dell’amministratore e quale fosse l’interesse sociale, il giudice non sarebbe comunque in grado, ex ante, di valutare se l’interesse dell’amministratore lo avrebbe o meno condotto a votare contro l’interesse della società: un simile giudizio può essere formulato esclusivamente ex post (83). resse di natura economico-patrimoniale. Si veda Cassazione 11 ottobre 1956, 3517, in Giustizia civile, I, 1957, 474 e ss. ( 80 ) Zamperetti Giorgio Maria (2005), Il «nuovo» conflitto di interessi degli amministratori di s.p.a.: profili sparsi di fattispecie e di disciplina, in Le società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale, n. 9, 1089. ( 81 ) A voler così ritenere, se solo si riporti alla mente come la riformata disposizione di cui all’articolo 2391 chiarisca che di ogni interesse vanno spiegate tutte le sfaccettature, precisandone natura, termini, origine e portata, si rischierebbero conseguenze devastanti riguardo alla durata dei consigli di amministrazione. ( 82 ) Maffeis Daniele (2003), Il nuovo conflitto di interessi degli amministratori di società per azioni e di società a responsabilità limitata: (alcune) prime osservazioni, in Rivista di diritto privato, n. 3, 521. ( 83 ) La nuova disciplina, invece, ed è questo il punto fondamentale, prevede un vero giudizio ex ante. Infatti, se non è ex ante possibile giudicare circa la sussistenza di un conflitto tra l’interesse dell’amministratore e l’interesse della società, è possibile giudicare ex ante circa la sussistenza di un interesse dell’amministratore, accanto all’interesse sociale nell’operazione. Ciò non significa che la nuova disciplina non sia una disciplina del conflitto di interessi: lo è, perché la sua ratio è di prevenire il pericolo dell’incidenza sull’attività di un interesse dell’amministratore, tuttavia una simile impostazione della disciplina civilistica non può fornire alcuna indicazione utile al penalista che si trovi a dover valutare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di infedeltà patrimoniale; semmai sussiste un collegamento tra la disciplina di cui all’articolo 2391 e quella, penale, di cui al nuovo delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi, 166 GIURISPRUDENZA Infatti, mentre non può essere dimostrato in via generale (84) che ogni volta che un amministratore ha un interesse il suo scopo sia contrario all’interesse della società, ciò non vale per l’affermazione secondo cui non tutte le operazioni sociali nelle quali l’amministratore abbia un interesse in potenziale conflitto sono necessariamente destinate a essere svantaggiose per la società (85). 12. Vi è poi chi distingue tra conflitto di interessi, che sarebbe preesistente e contrario all’interesse della società, e presa d’interesse, che concorrerebbe all’atto societario, dal momento che il gestore affianca un interesse proprio a quello della società, ma senza danno per la società stessa (86), giungendo ad argomentare che comporta responsabilità penale il solo conflitto di interessi attuale e solo in quanto assistito da dolo specifico e danno patrimoniale. Si tratta, di fatto, dell’esatto contrario di quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza in esame, che peraltro si dimostra assai più lineare proprio nella parte in cui non si premura di distinguere se il conflitto di interessi cambi natura a seconda che sia preesistente o meno. In un certo qual modo si può allora sostenere che se la Suprema Corte stabilisce la necessità di preesistenza del conflitto di interessi nella fattispecie di infedeltà patrimoniale, considerando questo conflitto solo a livello astratto, ne richiede però l’attualità al momento dell’atto di disposizione, proprio allorché sono richiesti anche dolo specifico e danno per la società. previsto dall’articolo 2629-bis del codice civile, che per l’appunto munisce espressamente di sanzione la disciplina civilistica. La differenza con la disciplina anteriore consiste semplicemente nel dato che oggi il conflitto di interessi richiede la presenza, accanto all’interesse della società, del solo interesse dell’amministratore, anziché quella contemporanea di due elementi, cioè l’interesse dell’amministratore e la sua possibile incidenza sulla cura dell’interesse sociale. Poiché questo secondo elemento non era valutabile ex ante, la sua eliminazione comporta che, «in base alla nuova disciplina, vi è conflitto di interessi dell’amministratore di società per azioni in presenza di un interesse dell’amministratore nell’operazione e del tutto indipendentemente dalla deliberazione adottata» (Maffeis Daniele, Il nuovo conflitto di interessi degli amministratori di società per azioni e di società a responsabilità limitata: (alcune) prime osservazioni, in Rivista di diritto privato, 2003, n. 3, 522). ( 84 ) Secondo l’insegnamento popperiano, una tale affermazione è infatti suscettibile di falsificazione e basterebbe quindi un solo caso, in cui un amministratore scegliesse, rispetto al proprio interesse, quello sociale, per negarle validità. ( 85 ) Enriques Luca (2000), Il conflitto d’interessi degli amministratori di società per azioni, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano, Giuffrè, 20 e ss. L’Autore pone in evidenza come sia ragionevole ipotizzare, oltre al rischio di falsi negativi, ossia di casi di abuso che rimangono impuniti, anche quello di falsi positivi, cioè di casi di mero conflitto potenziale di interessi non seguito da alcun abuso, nei quali cioè l’amministratore ha agito nel migliore interesse della società, e che il giudice non sia in grado di riconoscere come tali, ritenendo invece provato, erroneamente, il pregiudizio per la società. È altrettanto evidente tuttavia che esiste un trade-off tra questi due obiettivi. ( 86 ) Corsini Lorenzo (2006), L’interesse dell’amministratore di società, in Le Società, fascicolo 7, 848849; la particolarità del ragionamento di questo Autore sta nel ritenere l’irrilevanza, ai fini della legge penale, del conflitto di interessi come situazione preesistente (ed a maggior ragione quella della presa d’interesse), proprio in quanto la responsabilità penale consegue alle condizioni di conflitto d’interessi e dolo specifico, con danno patrimoniale. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE 167 Ciò costituisce una considerazione di non poco momento. È infatti dalla stessa distinzione tra conflitto di interessi e presa d’interesse che emerge la difficoltà a distinguere quando vi sia l’uno e quando l’altra, difficoltà che aumenta quando si voglia per giunta ricercare sul piano temporale l’elemento che li differenzia (87). L’intento semplificatore della Corte di Cassazione è dunque apprezzabile nella misura in cui sottrae il penalista a complesse distinzioni che, se rilevanti al fine di determinare l’ampiezza dell’obbligo civilistico di disclosure, allontanano dall’individuazione del focus della norma penale, che sanziona la condotta infedele che cagioni un danno alla società. 13. In conclusione, se per certi aspetti la tutela penale accordata dalla fattispecie di cui al riformato articolo 2634 del codice civile continua dunque a dimostrarsi carente, si tratta un problema che non può essere risolto dilatando o restringendo i confini del conflitto di interessi, richiamando o meno estesamente i criteri che caratterizzano l’interpretazione dell’articolo 2391 del codice civile, atteso che l’infedeltà patrimoniale già presenta degli elementi di dolo e di danno tali da far ritenere che, ove essi si concretino, vi sia anche un attuale conflitto di interessi. Piuttosto, se si vorrà dare applicazione alla fattispecie di infedeltà patrimoniale, perché la disposizione non resti lettera morta di fianco a un’esorbitante applicazione dell’appropriazione indebita, sarà necessario valorizzare l’elemento del danno, con l’auspicio che si sviluppi quanto prima una giurisprudenza consolidata, analogamente a quanto avvenuto per gli ordinamenti francese e tedesco. Al tempo stesso, sarà auspicabile che maturi una sempre più autonoma riflessione sulla rilevanza del conflitto di interessi ai fini della legge penale, tanto a livello dottrinale che giurisprudenziale, sulle orme di quella delineatasi riguardo al previgente articolo 2631 del codice civile e già frenata dalla scarsità delle possibili applicazioni pratiche, in considerazione, oggi, della vitalità che la materia presenta a livello normativo e della particolare sensibilità che pare si stia sviluppando in relazione a questo e analoghi temi. Enrica Piovesan ( 87 ) In effetti, come non considerare irrilevante una situazione di conflitto di interessi preesistente all’atto di disposizione compiuto dal gestore nel caso in cui l’operazione societaria venisse compiuta con profitto della società e senza che l’amministratore persegua con dolo specifico il proprio o altrui vantaggio, congiuntamente al danno della società? Tale situazione preesistente sarebbe peraltro del tutto irrilevante non tanto sul piano logico, quanto piuttosto a livello applicativo, atteso che la sua sussistenza ex ante sarebbe totalmente irrilevabile, e tanto più stante l’ovvia considerazione che cogitationis poenam nemo patitur, dal momento che nell’ipotesi descritta il gestore non ha mai attuato il perseguimento del proprio vantaggio a scapito dell’interesse sociale e, dunque, si è dimostrato un amministratore fedele. LEGGE E AUTORITÀ INDIPENDENTI: LE DIVERSE TECNICHE DI INTERVENTO NEL DIRITTO DEI CONTRATTI 1. Al giurista che si occupi in questi anni di diritto dei contratti difficilmente può essere sfuggito un paradosso. Accanto al progressivo affidamento al mercato e alla concorrenza di settori economici e di attività che in passato erano assoggettati a logiche diverse, quelle del controllo e della programmazione pubblica, sono aumentati i vincoli alla determinazione del contenuto, oltre che alla disponibilità degli effetti, dei contratti che le imprese concludono con altre imprese o con consumatori e risparmiatori, e sono aumentati i controlli da parte di pubblici poteri, per lo più affidati ad autorità indipendenti, sul rispetto di tali vincoli. Da un lato l’internazionalizzazione dei mercati ha portato al superamento del modello dello «Stato onnipresente», aprendo al mercato settori prima riservati all’intervento diretto dello Stato, ora gradualmente (ri)consegnati alla libera determinazione degli operatori economici. D’altro lato si è fatta sempre maggiore la presenza di norme imperative destinate a limitare la libertà contrattuale delle imprese, in nome della giuridificazione (1) di interessi collettivi, cioè a far acquisire a favore di soggetti dotati di poteri normativi della titolarità di decisioni a tutela di interessi collettivi, che sovente si traducono nell’imposizione di vincoli alla libera contrattazione. Ecco dunque il paradosso. A dispetto della diffusa proclamazione dell’avvento di un diritto dei contratti consegnato nelle mani delle potestà decisionali delle imprese a seguito dell’arretramento dello Stato dalla gestione delle dinamiche economiche, dell’internazionalizzazione dell’economia e dei mercati, e del mutato contesto economico-sociale con cui il diritto moderno si confronta, il dualismo tra autonomia ed eteronomia nella regolamentazione degli interessi privati, lungi dall’essere stato risolto a favore della prima, sopravvive sia pure sotto altra veste. I processi di liberalizzazione hanno ristretto i settori economici sottratti alle dinamiche del libero mercato, implementando l’autoregolazione contrattuale. Il li( 1 ) G. Alpa, La c.d. giuridificazione delle logiche dell’economia di mercato, Riv. Trim Dir. Proc. Civ., 1999, 3, 725. 170 GIURISPRUDENZA bero accesso al mercato e la libertà nella determinazione delle scelte imprenditoriali convivono però con l’aumento dell’intervento pubblico regolatore (specialmente nei settori di recente liberalizzazione), affidato tuttavia non più esclusivamente all’intervento del legislatore, ma anche a quello di soggetti diversi, in primis delle Amministrazioni Indipendenti. I civilisti hanno ormai ha da tempo segnalato la crescita dei vincoli di natura imperativa all’autonomia privata (2), legati prevalentemente agli interventi del legislatore comunitario in materia di contratti con i consumatori. Minore attenzione, invece, è stata dedicata all’intervento del legislatore in altri settori e alla natura e al «peso» dell’attività di regolazione e controllo delle Amministrazioni Indipendenti (3) specialmente per ciò che riguarda l’interferenza dell’uno e dell’altra con l’esercizio dell’autonomia contrattuale delle parti. Le seguenti brevi riflessioni saranno dedicate alla individuazione delle linee di tendenza di queste interferenze. 2. È necessario fare una premessa all’indagine. Parlare oggi di contratto significa far riferimento ad una realtà ben più articolata e complessa di quella coeva al legislatore del codice civile. La crisi della centralità del codice nel sistema del diritto privato contemporaneo, indotto specialmente dalla crisi del sistema delle fonti del diritto privato, ha avuto la sua più vistosa ripercussione proprio in materia contrattuale. Tramontata la mitologia del contratto in generale, e con esso la sua disciplina unitaria radicata nel Titolo II del Libro IV del codice, ci troviamo oggi di fronte al proliferare di forme e modelli contrattuali eterogenei non più facilmente riconducibili ad una disciplina unitaria. Del resto, la molteplicità dei modelli negoziali è di tangibile evidenza nell’esperienza quotidiana del giurista pratico. I contratti con i consumatori, standardizzati e contrassegnati da una strutturale asimmetria informativa e di potere contrattuale tra le parti, nei quali la rilevanza dell’accordo si stempera nella ripetitività meccanica dell’atto di consumo, arrivando secondo alcuni addirittura a scomparire definitivamente (4), appaiono una realtà completamente diversa da quella dei contratti ( 2 ) V. Roppo, Il contratto del duemila, II ed., Torino, 2005, passim. ( 3 ) Con alcune rilevanti eccezioni per quel che riguarda il problema del rapporto tra Autorità Indipendenti e autonomia privata, come nel caso della raccolta di alcuni interventi del convegno di Brescia del 2223 novembre 2002 nel volume a cura di G. Gitti, L’autonomia privata e le autorità indipendenti, Bologna, 2006. ( 4 ) È la tesi sostenuta da N. Irti, Scambi senza accordo, Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, p. 347 ss. In senso critico v. G. Oppo, Disumanizzazione del contratto?, in Riv. dir. civ., 1998, I, p. 525 ss. cui ha replicato N. Irti, «È vero, ma... (replica a Giorgio Oppo)», in Riv. Dir. civ., 1999. In senso critico alle tesi di N. Irti anche C.M. Bianca, Diritto civile, 3, Milano, 2000, p. 43, cui ha replicato Irti, Lo scambio dei foulards, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000, p. 601, cui ha replicato a sua volta C.M. Bianca, Acontrattualità dei contratti di massa?, in Vita not., 2001, p. 1120. LEGGE E AUTORITÀ INDIPENDENTI 171 tra imprese, connotati invece dalla forza creativa del consenso di soggetti posti in condizioni di sostanziale parità, in un dialogo attivo che giunge a plasmare regolamenti contrattuali alternativi a quelli «positivizzati» dal legislatore (non sempre modelli di allocazione di diritti e obblighi adeguati alle nuove esigenze di mercato), e che semmai fanno riferimento a modelli consolidati dalla prassi commerciale internazionale (v. infra). L’osservazione empirica trova conferma nell’esame della disciplina legislativa. Il crescente interesse dimostrato nell’ultimo decennio dal legislatore per i contratti fra imprese e consumatori (5) non ha analogo riscontro nell’ambito dei contratti fra imprese. Come noto, nel campo dei contratti fra imprese e consumatori il legislatore ha introdotto una serie di congegni normativi che prevedono tecniche di controllo del contenuto contrattuale e delle modalità di formazione della volontà negoziale aventi funzione di protezione del consumatore. Queste tecniche si sostanziano in una serie di divieti e di obblighi conformativi a carico dell’impresa, presidiati da un apparato sanzionatorio che incide sia sulla validità dell’atto che sull’efficacia del rapporto, e che giunge ad affidare al giudice poteri di intervento ex post nel «merito» dell’operazione contrattuale ridefinendone i contenuti, prevalentemente in nome della clausola generale di buona fede. Queste tecniche di controllo e i relativi strumenti sanzionatori definiscono un nuovo paradigma del rapporto tra autonomia individuale e ordinamento giuridico, che è sensibilmente diverso da quello proposto nel Libro IV del codice civile, nel quale la disciplina contrattuale è sostanzialmente disinteressata tanto al contenuto quanto agli equilibri o all’equità delle pattuizioni. La ragione fondamentale di questo iato risiede nella diversa considerazione sulla «posizione» dei contraenti. Il codice civile, nella definizione della disciplina generale dei contratti, non distingue fra soggetti aventi caratteri e qualità diverse, mentre le discipline dei contratti tra imprese e consumatori partono dal presupposto che il potere dei determinare il contenuto del contratto sia di fatto detenuto solo dalla parte imprenditoriale, che definisce unilateralmente il programma negoziale al quale il consumatore può solo aderire o meno, e che questa situazione generi una asimmetria di carattere strutturale che non si concilia più con la logica della parità formale dei contraenti presupposta nel codice. Questi interventi legislativi riflettono la consapevolezza dei mutamenti profondi che ha subito il mercato nell’epoca postindustriale. Con l’avvento della società del benessere e del consumismo e in conseguenza dell’apertura dei mercati internazionali che ha accresciuto la competitività complessiva del sistema economico, la domanda di prodotti e di servizi è aumentata esponenzialmente in termini sia ( 5 ) Le varie discipline legislative in materia di contratti con il consumatore si trovano oggi riprodotte nel Codice di Consumo adottato con D. Lgs. n. 206/2005. 172 GIURISPRUDENZA quantitativi che qualitativi, imponendo un profondo mutamento del sistema produttivo e distributivo che ha dovuto adeguarsi alla mutata conformazione della domanda. Ciò si è tradotto nella diffusione di prodotti e servizi di massa, offerti da un sistema imprenditoriale altamente selettivo, che premia gli operatori economici più forti, in grado di imporre i propri prodotti sul mercato offrendoli attraverso canali di distribuzione che azzerano la contrattazione individuale per sostituirla con la ripetitività della contrattazione standardizzata. Il contenuto dell’operazione è predeterminato unilateralmente dall’impresa, consentendo al singolo consumatore solo la possibilità di accettare o rifiutare le proposte contrattuali formulate dall’impresa, e non invece quella di contribuire a dare un contenuto alternativo al contratto. La predisposizione unilaterale del contenuto negoziale si è dunque trasformata da una delle possibili tecniche di determinazione del contenuto negoziale, assoggettata dal codice civile solo a cautele di tipo formale (artt. 1341 e 1342 c.c.), a vero e proprio sistema strutturato di contrattazione nell’ultima catena della filiera produttiva, acquisendo una fisionomia giuridica ignota al legislatore del codice civile e perciò oggetto di una disciplina completamente diversa. Il legislatore ha preso atto di queste peculiarità e, resosi conto della necessità di definire discipline alternative a quella codicistica, inidonea ad apprestare le tutele necessarie a far fronte ai problemi derivanti dalla massificazione dei contratti di consumo, ha predisposto una serie di strumenti di intervento particolarmente invasivi non solo nella definizione degli effetti ma anche nella determinazione del contenuto dei contratti di consumo, sovvertendo a prima vista il rapporto tradizionale tra legge e autonomia privata sancito dall’art. 1322, comma 1, c.c. A voler impostare il discorso in termini di consistenza dell’impatto della disciplina consumeristica sul sistema contrattuale tradizionale, si potrebbe essere allora tentati di affermare che sia stata l’autonomia contrattuale ad aver subito il ridimensionamento più significativo, nella misura in cui l’intervento del legislatore ha inciso sulla libertà delle parti di definire il contenuto del contratto. Tuttavia, di autonomia contrattuale si può parlare solo quando la libertà di determinare il contenuto del contratto è bilaterale, quando cioè il potere di determinare il contenuto del contratto è il frutto di una negoziazione. Nei contratti massificati e standardizzati con i consumatori, la condivisione di questo potere non sussiste, perché svanisce per la parte non imprenditoriale la possibilità di determinare qualsiasi profilo del regolamento contrattuale. Il mercato ha azzerato la capacità negoziale del consumatore, non il legislatore; il mercato, in altre parole, ha emarginato l’autonomia contrattuale dal settore della distribuzione finale. Il legislatore ha preso atto che l’autonomia delle parti si è trasformata nel potere incondizionato del contraente imprenditoriale di determinare i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto e nell’incapacità dell’altra parte di concorrere a regolamentare i propri interessi. È dunque su que- LEGGE E AUTORITÀ INDIPENDENTI 173 sto potere incondizionato che il legislatore ha deciso di intervenire, non sull’autonomia contrattuale, che il mercato aveva già allontanato da questa tipologia di scambi. La riprova viene, a contrario, osservando che il legislatore esclude l’applicazione della disciplina «protettiva» nel caso (evidentemente infrequente, ma non impossibile) in cui il consumatore dovesse riuscire a negoziare con l’impresa i termini del contratto (art. 34, comma 4, del Codice di Consumo). In questi casi il consumatore dimostra di poter dialogare con l’impresa e quindi dimostra di poter dare il suo contributo alla determinazione del contenuto del contratto, e l’autonomia contrattuale della parti torna a manifestarsi pienamente. Il legislatore, pertanto, lungi dal voler incidere sull’autonomia contrattuale delle parti, interviene con la consapevolezza che l’autonomia contrattuale non c’è, al punto che – come appena visto – la capacità di negoziazione delle clausole contrattuali segni il limite esterno di applicazione della disciplina in materia di clausole abusive. Potere pubblico e potere privato si confrontano qui in un contesto in cui il mercato priva il consumatore del potere di determinare il contenuto dello scambio, e il legislatore interviene per bilanciare l’asimmetria di potere contrattuale che ne consegue. La legge in questo tipo di rapporti realizza interferenze molto forti nella determinazione del «merito» delle pattuizioni. Le interferenze sono però giustificate dal fatto che autonomia non c’è nei contratti di consumo; c’è solo il potere unilaterale dell’impresa di predisporre il contenuto del contratto. 3. Naturalmente la radicalità della trasformazione del sistema economico e sociale di cui il legislatore ha preso atto nel definire le nuove regole per i contratti di consumo, non ha coinvolto solo l’ultima parte della catena produttiva, quella relativa – appunto – all’offerta del prodotto al consumatore finale, ma ha investito anche il resto della filiera a monte. Le questioni giuridiche, però, si sono poste in termini sensibilmente diversi. Sul versante contrattuale, in particolare, le logiche di protezione che hanno dato vita alle discipline speciali dei contratti tra imprese e consumatori nell’ultimo anello della catena produttiva non hanno senso (o quantomeno non hanno lo stesso senso) nei rapporti che stanno a monte, nei rapporti cioè fra imprese che operano nella filiera. È ben vero che anche in alcune relazioni fra imprese si riscontrano asimmetrie di potere che possono ricordare quelle tra imprese e consumatori, come nel caso del rapporto tra committente e subfornitore, tra franchisor e franchisee o tra concedente e concessionario di vendita. Ed è altrettanto vero che modelli di relazione economica come – appunto – la subfornitura, il franchising o la concessione di vendita si sono imposte nel mercato proprio in relazione alle stesse dinamiche di massificazione della produzione ed internazionalizzazione dei mercati che hanno generato il fenomeno del consumerism. Ciononostante i modelli contrattuali resta- 174 GIURISPRUDENZA no eterogenei e la convergenza delle discipline giuridiche, celato dietro l’utilizzo di espressioni ricorrenti (6), è solo apparente. Il contesto «relazionale» nel quale si inseriscono i rapporti contrattuali tra imprese della filiera (tanto sul versante produttivo che su quello della distribuzione) è diverso da quello che si osserva nei rapporti tra imprese e consumatori. Limitando l’analisi ai soli profili strettamente giuridici, anche laddove un’impresa sia in condizione di «dipendenza» economica da altra impresa, si colloca pur sempre con essa all’interno di un tessuto connettivo condiviso, all’interno di un medesimo meccanismo produttivo. A prescindere da chi governi questo meccanismo, imprese «grandi» e «piccole» svolgono la loro attività imprenditoriale relazionandola con quella del partner imprenditoriale; l’una e l’altra sono attori di un processo produttivo convergente se non unitario. Il rapporto contrattuale che lega allora imprese «dominanti» da imprese «dominate» è uno strumento attraverso il quale viene realizzata una forma di cooperazione imprenditoriale, tendenzialmente stabile, che assume carattere reticolare. Da questo peculiare contesto discendono alcune conseguenze sull’organizzazione dei rapporti contrattuali che vanno viste in controluce rispetto ai contratti di consumo. Anzitutto va considerato il profilo soggettivo. Al di là della mera osservazione superficiale che le parti qui sono entrambe imprese, è la non indifferenza del partner «dominato» che va messa in evidenza. Dovendo collaborare per la realizzazione di un progetto comune, le qualità, le capacità tecniche, l’esperienza e la professionalità dell’impresa in condizione di dipendenza non sono irrilevanti per l’impresa «dominante». Il franchisor o il concendente, ad esempio, dovranno assicurarsi che ogni singolo franchisee o concessionario possegga le caratteristiche che gli consentano di proporre, caso per caso, la formula commerciale del franchisor o i prodotti in concessione di vendita. Il committente a sua volta dovrà assicurarsi che il subfornitore sia in grado di realizzare l’attività a questi esternalizzata in modo corretto, confacente alle direttive tecniche e ai modelli produttivi assegnati. In definitiva, in questo tipo di rapporti imprenditoriali vi è sempre una forma di interazione assicurata proprio dal fatto di essere collocate nella medesima catena produttiva/distributiva, in un meccanismo che ciascuna impresa, sia pure con pesi e ruoli diversi, contribuisce a muovere. I consumatori invece non sono solo estranei all’organizzazione del processo produttivo, ma sono rispetto ad essa un quid indistinto e anonimo. Pur rappresentando per certi versi l’anello più importante della filiera, perché sono i destinatari finale della produzione che acquistando beni ( 6 ) Tanto l’art. 33, comma 1, del Codice di Consumo, quanto l’art. 9 della l. 192/1998 parlano di «squilibrio di diritti e di obblighi» in riferimento – rispettivamente – alle clausole vessatorie nei contratti con il consumatore e all’abuso di dipendenza economica. LEGGE E AUTORITÀ INDIPENDENTI 175 e servizi e sono coloro che assicurano il sostengono economico complessivo del sistema, i consumatori non interagiscono con il sistema imprenditoriale. Il singolo consumatore «vede» solo il distributore finale, ma non dialoga con lui, non collabora ad alcun progetto: in altre parole non è parte della rete. Il consumatore si limita ad acquistare il prodotto per soddisfare una sua esigenza immediata e contingente, non entra in rapporto organico con il sistema imprenditoriale. Come queste differenze si riverberino sulla conformazione dei rapporti contrattuali è presto detto. Contratti di subfornitura, di franchising o di concessione di vendita, per stare agli esempi fatti poc’anzi, istituiscono relazioni contrattuali stabili e non occasionali, che non hanno il carattere istantaneo dei contratti di consumo. Nel caso dei contratti di consumo la sorte del singolo rapporto contrattuale con un consumatore incide in misura irrilevante nel contesto dell’attività d’impresa e la sostituibilità del contraente è una caratteristica fisiologica del sistema distributivo finale, cosa che non accade invece nei rapporti di rete. Il carattere massificato e ripetitivo tipico della sola contrattazione con i consumatori impedisce dunque di considerare allo stesso modo i rapporti tra imprese lungo la filiera, ove la negoziazione delle clausole contrattuali è la regola mentre la predisposizione del testo contrattuale è l’eccezione. Va poi evidenziato che il carattere di «dipendenza» economica che caratterizza rapporti imprenditoriali come quelli di subfornitura o di franchising o di concessione di vendita, per stare agli esempi fatti in precedenza, non sempre dà luogo a condizioni di soggezione. Vi sono i casi in cui la produzione di un subfornitore dipende completamente da un committente, ma anche casi in cui è il subfornitore ad essere la parte «forte» del rapporto, soprattutto nelle filiere ad alta specializzazione tecnologica, dove subfornitori in grado di realizzare componenti ad alto contenuto tecnologico sono partner ideali per numerosissime imprese committenti, che spesso in questi casi hanno dimensioni economiche (in termini di volumi di produzione o di fatturato) inferiori al subfornitore. Tra questi due estremi esiste poi un’infinità di gradazioni intermedie. Ciò significa che la posizione di subalternità produttiva che caratterizza alcuni rapporti imprenditoriali non si traduce necessariamente in una asimmetria di potere a favore sempre della stessa parte imprenditoriale; e questo perché – come visto – asimmetria potrebbe anche non esserci, come avere un verso opposto a quello che ci si attenderebbe. La diversità di contesti relazionali trova conferma dall’esame della disciplina legislativa di alcuni di questi contratti di rete. A fronte di una disciplina consumeristica destinata a governare squilibri di potere economico o informativo offrendo alla parte «debole» del rapporto strumenti vari e di varia intensità per reagire alla sperequazione di diritti ed obblighi imposti dalla parte «forte», le leggi sulla subfornitura (l. 192/1998) e sul franchising (l. 129/2004) delineano un sistema di tu- 176 GIURISPRUDENZA tela della parte imprenditoriale in condizioni di «dipendenza» sensibilmente diversa. L’interesse del legislatore, rispetto ai rapporti di subfornitura e di franchising, non è diretto a proteggere la parte «debole» in quanto tale. Tanto la previsione dell’abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 della l. 192/1998, quanto le previsioni degli obblighi informativi a carico del franchisor e destinati ad assicurare al franchisee la definizione precisa degli elementi caratterizzanti della formula commerciale, prendono atto dell’esistenza di una situazione di dipendenza, che non vuol riequilibrare (realizzerebbe altrimenti un’intromissione ingiustificabile nelle scelte imprenditoriali delle parti), ma la monitora per evitare che comportamenti abusivi pregiudichino quel particolare equilibrio collaborativo voluto ed instaurato fra le parti. Il legislatore, dunque, predispone queste tutele non tanto aiutare le piccole imprese che decidano di organizzare la propria produzione in funzione di quella di altre imprese, ma per assicurare la stabilità della rete che così si è venuta a creare. è dunque nell’ambito di questi sistemi reticolari sul versante produttivo (come nel caso della subfornitura) o distributivo (com’è per il franchising o concessione di vendita) che va collocato l’intervento del legislatore. Il legislatore ha dunque a cuore la stabilità di questi sistemi reticolari, e intende garantirla fornendo alle imprese strumenti per prevenire (come nel caso degli obblighi informativi della l. 192/2004) o reagire (come nel caso della nullità dei patti che realizzano abusi di dipendenza economica) a strategie opportunistiche realizzate dalle imprese più forti profittando della situazione di dipendenza che altrimenti rientra nella fisiologia di questo tipo di rapporti di collaborazione. Lo scenario complessivo segna dunque un tratto di discontinuità tra contratti di consumo e contratti c.d. con asimmetrie di potere, che meglio potrebbero essere denominati contratti di rete. Se pure esiste una certa corrente di pensiero che tende ad evidenziare alcune convergenza delle discipline legislativa, la convergenza è meramente suggestiva (7). Mentre la disciplina dei contratti col consumatore entra profondamente negli equilibri di diritti ed obblighi del contratto, prevedendo strumenti di governo del contenuto del contratto che prendono atto dell’inesistenza di un dialogo negoziale tra parti che il mercato ha dotato di diverso potere di incidenza nella determinazione dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto, nel caso dei contratti fra imprese con asimmetrie di potere la disciplina legislativa prevede interventi di prevenzione o reazione a forme di abuso della situazione di supremazia, non tende a governare le asimmetrie, giacché alla situazione di «dominanza» sul piano dell’organizzazione imprenditoriale non necessariamente cor( 7 ) Per una ricostruzione del dibattito in chiave critica cfr. C. Camardi, Contratti di consumo e contratti tra imprese. Riflessioni sull’asimmetria contrattuale nei rapporti di scambio e nei rapporti «reticolari», in Riv. Crit. Dir. Priv., 2005, 549 ss. anche per ulteriori riferimenti dottrinali. LEGGE E AUTORITÀ INDIPENDENTI 177 risponde una privazione di potere negoziale, e comunque anche laddove coincida con una posizione di debolezza essa non assume quel carattere strutturale che rispetto ai contratti soggetti alla disciplina consumeristica porta a ritenere che non vi sia più alcuna autonomia contrattuale. Quest’ultima considerazione merita un ulteriore approfondimento. I consumatori non hanno a disposizione alcuna scelta. Non sono in condizione di poter decidere se prestare consenso all’offerta predisposta dall’impresa o negoziare con essa le condizioni contrattuali, perché nel mercato della distribuzione finale di beni e servizi non c’è lo spazio per una negoziazione differenziata per singole operazione contrattuali, se non in casi e condizioni del tutto marginali. Per le imprese che operano nella medesima filiera il discorso è diverso. Il mercato propone il modello concorrenziale nel quale tutti sono in competizione con tutti, nel quale ogni singola impresa opera sul mercato nella solitudine delle sue scelte imprenditoriali destinate a massimizzare la produzione e a minimizzare i costi a danno di imprese collocate sullo stesso o su diversi anelli della catena produttiva. Il mercato tuttavia consente in certi casi di operare anche una scelta alternativa, quella della cooperazione, per la quale il processo di produzione e distribuzione non è la somma individuale delle attività d’impresa di solitari operatori economici, ma l’esito di un meccanismo di collaborazione nel quale ciascuno per sua parte offre un contributo. Non sempre questa scelta è stata ritenuta compatibile con il sistema concorrenziale: basti pensare alle molte perplessità che in Europa hanno sempre accompagnato la valutazione di legittimità antitrust dei sistemi di distribuzione indiretta, passibili di essere considerate intese verticali. Ma nella misura in cui questi sistemi di auto-esclusione dalle dinamiche competitive debbono ritenersi legittime, rappresentano una valida alternativa di organizzazione dell’attività imprenditoriale. Le ragioni per le quali le imprese possono preferire questa soluzione sono diverse, e non necessariamente correlate all’alleggerimento della pressione concorrenziale. Nel settore della distribuzione, ad esempio, la crisi del succursalismo ha incentivato la creazioni di sistemi di distribuzione indiretta, come la concessione di vendita o il franchising, che rappresentano in molti casi una soluzione distributiva più efficiente e meno cara di quella diretta. Sul versante produttivo, le relazioni contrattuali di rete sono lo strumento di coordinazione di un’esternalizzazione produttiva, vale a dire della collocazione di fasi del ciclo produttivo all’esterno dell’impresa per ragioni di contenimenti dei costi, o di aumento dei volumi, o per ragioni di specializzazione produttiva. Spesso la rete è governata da un’impresa leader che governa ed è dunque responsabile del funzionamento della rete; attorno ad essa ruotano altre imprese, più o meno grandi, che collaborano a vario titolo e con diverso grado di importanza al processo produttivo così coordinato. Si possono certo creare situazioni di soggezione e dipendenza, ma non va perso di vista il 178 GIURISPRUDENZA quadro generale: ciascuna è tassello di un mosaico più o meno complesso ed esteso che per essere completo ha bisogno di tutte le sue tessere. È in questo contesto che va interpretato l’intervento del legislatore. Nella subfornitura come nel franchising troviamo discipline legislative che, al di là delle apparenze, non hanno la funzione di proteggere una parte contrattuale dall’altra, ma semmai quella di prevenire, sanzionare o compensare comportamenti opportunistici di operatori economici che, sfruttando la loro posizione di dominance acquisita nella rete, ne abusano o ne possono abusare a danno – ed è qui il punto – della tenuta complessiva del sistema reticolare. La disciplina sull’abuso di dipendenza economica, nel sanzionare il comportamento opportunistico dell’impresa leader a danno di un subfornitore, sanziona a ben vedere un comportamento che è tale solo all’interno di un sistema reticolare. La subfornitura, così come il franchising, non sono altro che segmenti di un sistema reticolare, nel quale il confronto competitivo è sospeso e le logiche collaborative che stanno sullo sfondo implicano il doveroso abbandono delle prospettive di protezione e governo delle «debolezze» tipiche della disciplina dei contratti con i consumatori. 4. Sono state prese in esame sin qui due ipotesi di intervento del legislatore nella disciplina dei contratti. Nel primo caso a sostegno di una parte contrattuale non imprenditoriale in un settore di mercato non caratterizzato da autonomia contrattuale in senso proprio, nel secondo caso a garanzia della tenuta complessiva di relazioni reticolari tra imprese. Un discorso parzialmente differente deve essere fatto invece per i contratti conclusi tra imprese che operano al di fuori di sistemi reticolari: in questo settore l’intervento del legislatore è stato minimo (8), specialmente se confrontato con quello che nel corso dell’ultimo decennio ha portato alla alluvionale disciplina consumeristica e – più di recente – alla disciplina di alcuni contratti di rete come il franchising o la subfornitura, nonostante le mutazioni dei sistemi economici nazionali e la mondializzazione del mercato abbiano portato cambiamenti epocali nel sistema imprenditoriale, che fino a qualche anno fa sarebbero stati impensabili. Se si dovesse misurare dalle iniziative adottate dal legislatore l’intensità del cambiamento nel mercato delle transazioni commerciali si direbbe invece che poco o nulla è cambiato, con la sola (per quanto rilevante) eccezione delle leggi di liberalizzazione di settori prima organizzati in regime di monopolio statale. Il disinteresse del legislatore si comprende osservando quali siano state le direttici lungo le quali si sono svolti i profondi cambiamenti del mercato. Chi ha ( 8 ) Si segnala, fra gli interventi di maggior rilievo, il D. Lgs. 231/2002 attuativo della direttiva 2000/ 35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. LEGGE E AUTORITÀ INDIPENDENTI 179 condotto il processo di trasformazione non sono stati gli ordinamenti giuridici nazionali, ma le imprese, e quindi il mercato stesso. Grazie anche all’impiego di tecnologie informatiche in grado di marginalizzare le barriere spazio-temporali, i mercati nazionali si sono gradualmente integrati, le imprese hanno smesso di guardare solo all’interno dei confini nazionali alla ricerca di partner commerciali, la cui dislocazione all’interno o all’esterno dei confini politici degli ordinamenti ha cominciato ad essere quasi indifferente. La dimensione trans-nazionale del commercio ha reso estremamente difficile per i legislatori nazionali fornire strumenti giuridici adeguati stante l’irriducibile dimensione domestica della legislazione e anche nel mercato unico europeo le politiche di armonizzazione dei sistemi giuridici dei Paesi Membri non sono riuscite a stare al passo con l’incalzante propulsione del mercato. La crisi del legislatore a cui si è fatto cenno è dunque il riflesso di questa crisi strutturale dei sistemi giuridici nazionali, che è la crisi della dimensione geopolitica della norma giuridica (9). Il vuoto lasciato dalla legislazione statale è stato riempito dalla capacità creativa del mercato, dalle regole nate spontaneamente dalla business community; regole che rispondono efficacemente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, che non soffrono le limitazioni territoriali del diritto statuale e che attingono alla prassi commerciale e arbitrale internazionale, in una moderna versione della lex mercatorum (10). È da questo corpus di regole derivate da usi commerciali, prassi imprenditoriali e decisioni arbitrali, che si sono andati diffondendo modelli contrattuali alternativi a quelli proposti dal legislatore nazionale e maggiormente in grado di rispondere alle esigenze del mercato, di cui di fatto «traduce» la fisionomia; ma soprattutto si tratta di modelli contrattuali tendenzialmente omogenei e uniformi, capaci di soddisfare le esigenze di imprese collocate in ordinamenti giuridici diversi proprio perché prescindono dai particolarismi giuridici dei sistemi legislativi nazionali. L’incapacità del legislatore nazionale di approntare strumenti e modelli contrattuali a fronte della dimensione trans-nazionale dei traffici e la contestuale formazione di modelli contrattuali nascenti dalla prassi mercantile, spiegano dunque la ragione per cui l’autonomia privata non trova limitazioni o condizionamenti eteronomi paragonabili a quelli dei contratti di consumo o dei contratti di rete. A dire il vero, però, vi sono alcune discipline legislative che, pur non avendo ad oggetto la regolazione dei rapporti di mercato o la disciplina del regolamento contrattuale, interferiscono ugualmente nella determinazione del contenuto delle transazioni commerciali. Si tratta in particolare della disciplina della concorrenza e quella sulla regolazione di alcuni specifici settori di mercato. In quest’ultimo caso ( 9 ) Cfr. N. Irti, Norma e luoghi. Problemi di geodiritto, Roma-Bari, 2001. ( 10 ) Cfr. F. Galgano, lex mercatoria, Bologna, 2001. 180 GIURISPRUDENZA l’intervento del legislatore è puntuale e circoscritto: si pensi agli obblighi a contrarre imposti alle imprese ex monopoliste che operano in mercati oggetto di recente liberalizzazione e che nel transito dal sistema monopolistico a quello concorrenziale necessitano di interventi diretti del legislatore a garanzia della effettiva apertura alla concorrenza di altri operatori (11). Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il legislatore non detta discipline regolative specifiche, ma lascia che le imprese si confrontino liberamente nel mercato determinando come meglio credono l’assetto dei rispettivi interessi senza alcuna interferenza. Il legislatore, in questi casi, si limita solo a prevedere norme proibitive di carattere generale a garanzia che le imprese, nella libera determinazione dei propri interessi, non adottino comportamenti che di fatto distorcano l’equilibrio concorrenziale di tutto o parte del mercato (art. 2 l. 287/1990 e art. 81 del Trattato CE). Dal momento che la legge antitrust colpisce l’accordo con cui si realizza una restrizione del mercato con la «sanzione» della sua nullità, di fatto essa introduce una limitazione esterna nella determinazione del contenuto degli accordi che si realizzano nel mercato concorrenziale. L’interferenza parrebbe in questi frangenti certamente significativa ma quantitativamente marginale e comunque indiretta; escluso ogni intervento diretto a conformare il contenuto delle pattuizioni, il legislatore nazionale e comunitario ha predisposto un sistema di limiti esterni, di norme proibitive di quelle iniziative imprenditoriali dirette a ridurre il tasso di concorrenzialità del mercato nelle limitate ipotesi in cui un accordo commerciale sia in grado di determinare una distorsione della concorrenza. Appare chiaro allora che non sia il contratto in quanto tale ad essere oggetto delle «attenzioni» del diritto della concorrenza, ma l’operazione economica che con esso viene realizzata tra le parti; solo quando e nella misura in cui l’esercizio della libertà contrattuale diventa fonte di un pregiudizio all’assetto competitivo del mercato il legislatore interviene. Si tratta di un intervento ex post, non conformativo né correttivo, ma sostanzialmente sanzionatorio. Dicendo che il legislatore interviene raramente nel merito della contrattazione tra imprese che operano nel mercato concorrenziale, sia per una precisa scelta di politica economica, sia per l’incapacità di governare le dinamiche di un mercato sempre più insofferente ai limiti geografico-politici degli ordinamenti statuali, sembrerebbe doversi concludere che in questo ambito l’autonomia contrattuale raggiunge la sua massima espressione, le parti sono libere di determinare forme e modi, contenuti e assetti della regolazione dei loro interessi senza alcuna interferenza statale salvo il solo limite esterno dei divieti di intese o pratiche concordate o abusi di posizione dominante distorsive della concorrenza. Sembrerebbe legittimo ( 11 ) Sul tema cfr. C. Osti, Nuovi obblighi a contrarre, Torino, 2004 anche per rintracciare i riferimenti normativi. LEGGE E AUTORITÀ INDIPENDENTI 181 affermare che, a differenza che nei contratti di consumo e di rete, l’autonomia privata riconquista nel tessuto concorrenziale del mercato quella pienezza che altrove è andata perduta. L’apertura del nostro sistema di mercato alle dinamiche concorrenziali avrebbe dunque determinato l’arretramento dello Stato e l’espansione della forza creativa ed autonoma (ancora una volta nel senso etimologico del termine) delle imprese, uniche e sole artefici del loro destino. Il binomio Stato-mercato, eteronomia-autonomia, si sarebbe dunque risolto in favore dei secondi. Ad un più attenta analisi, però, ci si accorge che le cose non stanno esattamente in questi termini. Se è certamente vero che l’internazionalizzazione e la sempre più marcata interdipendenza dei mercati nazionali ha accelerato anche in Italia un certo processo di de-statualizzazione del diritto, questo fenomeno non si è tradotto sic et simpliciter nella retrocessione dello Stato dal mercato, ma nella mutazione delle modalità e degli strumenti di intervento e regolazione. Ed è proprio nel campo dei contratti di commercio, nei quali l’autonomia contrattuale sembrerebbe a prima vista aver bandito ogni forma di eteronomia statale, che emergono i fenomeni di maggior interesse (12). Il rapporto fra Stato e mercato è profondamente mutato nell’ultimo mezzo secolo, soprattutto in Paesi come l’Italia e la Francia tradizionalmente caratterizzati da una forte presenza dell’intervento statale nella regolazione del mercato, soprattutto nei settori di maggior rilievo socio-economico come l’energia elettrica, il gas, la telefonia, ecc. La progressiva apertura dei mercati nazionali, che in Europa ha visto grande protagonista l’ordinamento comunitario, e il conseguente adeguamento delle politiche economiche nazionali ai principi della libera concorrenza fra imprese, considerato il sistema di mercato che meglio garantisce l’efficienza complessiva delle imprese e tutela in modo più efficace i consumatori, hanno avviato un processo di progressivo allontanamento dello Stato dalla gestione diretta delle fonti di produzione a cui si è accompagnata la liberalizzazione di sistemi monopolistici o oligopolistici pubblici via via recuperati al confronto concorrenziale delle imprese. L’abbandono della funzione gestoria dello Stato imprenditore, specialmente in quei settori «sensibili» che in precedenza erano in condizione di mono- ( 12 ) Va sgombrato il campo dal pericolo di cadere in un eccesso di semplificazione. Riferendo dell’interferenza del diritto antitrust nel diritto dei contratti ai contratti tra imprese non si intende escludere l’incidenza della disciplina antitrust anche rispetto ai contratti col consumatore e ai contratti di rete. La vicenda italiana della nullità dei contratti di assicurazione R.C. Auto conseguenza del cartello tra imprese assicurative dimostra quanto e come il diritto antitrust possa incidere sui contratti di consumo. D’altra parte l’introduzione del comma 3-bis all’art. 9 della l. 192/1998 sulla subfornitura (ad opera dell’art. 11, l. 5 marzo 2001, n. 57) ha affidato all’Autorità Antitrust poteri sanzionatori in ordine ad abusi di dipendenza economica che ridondino in ipotesi di abuso di posizione dominante. Non c’è dunque alcuna relazione di esclusività tra la disciplina del mercato concorrenziale e i contratti fra imprese al di fuori di sistemi reticolari, ma solo un rapporto di prevalenza. 182 GIURISPRUDENZA polio pubblico, ha reso necessario un intervento di tipo regolativo, inizialmente destinato a gestire la fase di passaggio al sistema concorrenziale senza causare pregiudizi ai consumatori, e poi orientato a dettare le «regole del gioco» concorrenziale, sia per singoli settori di mercato, sia per il mercato complessivamente inteso (è il caso della legge antitrust – l. n. 287/1990). In questo contesto l’intervento diretto dello Stato nella conformazione delle dinamiche imprenditoriali si è fortemente ridimensionato, e il mercato ha pienamente recuperato a se stesso settori che prima le erano interdetti o nei quali la presenza ingombrante dello Stato mortificava la libertà negoziale. Tuttavia, la necessità di regolare e controllare (non più il contenuto delle transazioni ma) le condizioni di esistenza e di persistenza del mercato concorrenziale non potevano arrestarsi con la sola predisposizione di discipline legislative generali o di principio. Era necessario definire sistemi di regolazione e controllo pubblici alternativi a quello politico-legislativo, a cui restava affidato il solo compito di definire la nervatura essenziale e cornice esterna del sistema economico. Per realizzare questi compiti gli ordinamenti nazionali hanno scelto di istituire Amministrazioni Indipendenti, organismi neutrali, distanti tanto dal potere politico quanto dalle lobbies economiche, composto da tecnici e non da burocrati, a cui sono stati affidati – sempre nel quadro della disciplina legislativa di settore – sia compiti di definizione delle regole di comportamento che le imprese debbono tenere in determinati settori di mercato, sia compiti di vigilanza e controllo sulla correttezza del comportamento degli attori di mercato a tutela del mercato in sé e per sé considerato e dei consumatori (13). Si distingue così tra autorità di regolazione e autorità di controllo: nel primo gruppo rientra ad esempio l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, nel secondo gruppo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (c.d. Autorità Antitrust). Nel caso delle autorità di regolazione, la ragione della loro istituzione va ricercata nella consapevole inadeguatezza del legislatore di gestire in modo equilibrato ed efficiente la delicata fase di passaggio al mercato di alcuni settori di grande rilevanza socio-economica, nei quali le pressioni politiche e gli interessi economici esistenti (soprattutto quelli delle imprese ex monopoliste) richiedono l’intervento di un organismo tecnico in grado di «neutralizzare» queste spinte e quindi di traghettare il settore di riferimento dal regime di monopolio pubblico a quello del mercato, anche affidando estesi poteri normativi che si estendono fino alla de( 13 ) La letteratura che si è occupata di Autorità Amministrative Indipendenti è ormai molto corposa. Tra i volumi di più recente pubblicazione v. S. Labriola (a cura di), Le autorità indipendenti Da fattori evolutivi ad elementi della transizione nel diritto pubblico italiano, Milano, 2000; G. Giraudi e M.S. Righettini, «Le autorità amministrative indipendenti. Dalla democrazia della rappresentanza alla democrazia dell’efficienza», Roma-Bari, 2001; S. Foà, I regolamenti delle Amministrazioni Indipendenti, Torino, 2002; M. Manetti, Le Autorità Indipendenti, Roma-Bari, 2007. LEGGE E AUTORITÀ INDIPENDENTI 183 terminazione autoritativa delle condizioni di offerta di beni e servizi al mercato finale. In questi casi dunque muta la governance dei rapporti tra Stato e mercato: settori prima gestiti direttamente dallo Stato in regime di monopolio vengono gradualmente aperti alla concorrenza di soggetti privati, ma necessitano ancora di un intervento regolativo pubblico che però viene sottratto al legislatore per essere affidato ad un organismo tecnico, distante tanto dalla politica quanto dagli affari. Le autorità indipendenti di controllo (o di garanzia) sono istituite invece per ragioni diverse. Concentriamo l’attenzione in particolare sull’Autorità Antitrust, laddove non ci siano esigenze di gestione graduale dell’apertura al mercato di settori economici, il confronto concorrenziale avviene senza alcun intervento pubblico, liberamente, fra imprese che sul piano formale e sostanziale sono poste sullo stesso piano. Lo Stato, proprio in considerazione del fatto che un libero mercato delle transazioni commerciali è un valore da conservare e proteggere, è un vero e proprio interesse pubblico, ha istituito sistemi di difesa degli equilibri concorrenziali dai comportamenti opportunistici di quelle imprese che, per massimizzare il proprio interesse, distorcano a proprio favore e a danno delle altre imprese e dei consumatori il mercato concorrenziale, sottraendosi ad un vero confronto concorrenziale. È il caso dei divieti di intesa anticoncorrenziale e di abuso di posizione dominante previsti sia dal Trattato CE che dalla l. 287/1990. Ritenendo inadeguata la magistratura o le strutture burocratiche ministeriali, il legislatore ha scelto di affidare il controllo del mercato e l’applicazione in prima battuta dei sistemi sanzionatori connessi all’accertamento della violazione della disciplina antitrust ad un organismo tecnico e non compromesso con gli interessi economici in gioco. È stata istituita così l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Questa autorità, non dovendo assolvere a compiti di regolazione del mercato, non dispone di poteri normativi: dispone però di poteri ispettivi e sanzionatori particolarmente significativi, analoghi a quelli di cui dispone la Commissione europea sempre in tema di applicazione della disciplina antitrust nei confronti delle imprese che si rendano colpevoli di comportamenti anticoncorrenziali che rientrino in una delle due fattispecie proibitive. Da questa pur sommaria descrizione delle funzioni delle amministrazioni indipendenti di regolazione e di controllo si possono trarre alcune prime conclusioni sulle interferenze tra la loro attività e l’autonomia contrattuale dei soggetti che operano nei mercati da esse presidiati. Per quel che riguarda quelle imprese che hanno voluto accedere ai settori di mercato in vecchio regime di monopolio, la loro autonomia è evidentemente condizionata (oltre che dalla legislazione di settore anche) dall’attività normativa delle amministrazioni indipendenti di regolazione. Certo il fatto in sé che l’accesso a questi mercati sia stato reso possibile rappresenta un significativo passo in avanti verso l’introduzione di un sistema di concorren- 184 GIURISPRUDENZA za che anche in questi settori consenta alle imprese di confrontarsi liberamente nel mercato, almeno per ciò che riguarda i contratti fra le imprese che operano in questi mercati. Quanto invece alle imprese che contrattano in settori non presidiati da autorità di regolazione, sembrerebbe di poter dire che l’interferenza delle autorità di controllo nella libera determinazione degli scambi sia limitato ai soli casi in cui le imprese realizzano operazioni di mercato anticoncorrenziali (14) restando per il resto indifferente il mercato, e quindi le imprese nella loro libera esplicazione della loro autonomia contrattuale, alla presenza di queste autorità. Queste ultime conclusioni però non sono del tutto vere. Sia sotto un profilo formale, in considerazione di alcuni poteri di cui l’Autorità Antitrust dispone sin dalla sua istituzione, sia sotto un profilo informale, la capacità di determinare o addirittura di conformare i comportamenti negoziali delle imprese che pure operano in un libero mercato da parte dell’Autorità Garante è tutt’altro che irrilevante. Anzitutto vanno presi in considerazione i poteri dell’Autorità Antitrust di autorizzare singole intese o intere categorie di esse, sia pure per un periodo limitato, alle condizioni descritte all’art. 4 della l. 287/1990, analogamente a quanto la Commissione europea può fare ai sensi dell’art. 81, n. 3, del Trattato CE, e i poteri di controllo delle operazioni di concentrazione ai sensi dell’art. 16 della l. 287/1990, sulla scorta di quanto previsto a livello comunitario dall’art. 6 del Regolamento (CEE) n. 4064/1989 del Consiglio. In entrambi i casi, l’esisto positivo o negativo del controllo sugli effetti pro-concorrenziali dell’intesa o sugli effetti anti-concorrenziali dell’operazione di concentrazione influisce in modo chiaramente determinate nelle scelte negoziali degli operatori economici, che potranno realizzare quel determinato assetto di interessi solo a condizione che l’esito del controllo vada a buon fine. L’interferenza può anche essere maggiore e determinare oltre alla possibilità di realizzare una determinata operazione, anche i termini concreti di tale operazione, quando l’Autorità condizioni l’esito positivo del suo controllo all’adozione di correttivi sulle operazioni negoziali comunicate o sotto inchiesta da parte delle imprese coinvolte (15). Sul piano informale, poi, la latitudine dei poteri ispettivi e sanzionatori dell’Autorità Antitrust produce in linea generale un consistente ( 14 ) La stessa previsione della nullità, che si accompagna all’irrogazione di sanzioni amministrative nel caso in cui le intese siano realizzate attraverso strumenti negoziali, non rappresenta una novità in senso assoluto per il nostro ordinamento giuridico almeno nel caso della nullità dell’intesa che abbia ad oggetto la distorsione della concorrenza: il codice civile, infatti, già conosce la fattispecie della nullità del contratto per violazione di norme imperative. Più problematica, invece, è la dichiarazione di nullità delle intese che pur non avendo ad oggetto la distorsione della concorrenza, sono ad effetto anticoncorrenziale. ( 15 ) Per un esempio tra i casi più recenti, cfr. il caso Capitalia S.p.A. – UniCredito Italiano S.p.A. (33/ 07 Bollettino AGCM) nel quale l’Autorità Antitrust ha dettato una serie di prescrizioni alla imprese bancarie coinvolte in questa operazione di fusione molto invasive, ma senza la realizzazione delle quali l’autorizzazione all’operazione di concentrazione non viene rilasciata. LEGGE E AUTORITÀ INDIPENDENTI 185 effetto di moral suasion nei confronti delle imprese che, temendo di realizzare operazioni economiche «al limite» della censura di anticoncorrenzialità, decidono di non concludere determinati contratti o di concluderli a condizioni diverse da quelle che erano nelle loro intenzioni, preferendo adottare comportamenti più virtuosi sotto il profilo concorrenziale. Frequentemente accade che una decisione dell’Autorità Antitrust che abbia sanzionato un’impresa per un comportamento ritenuto anticoncorrenziale, divenga di fatto «giurisprudenza antitrust» per tutte le altre imprese. La facilità di accesso alle banche dati delle decisioni dell’Autorità è un elemento che favorisce più di quanto possa sembrare una certa convergenza del comportamento concorrenziale delle imprese, specialmente di quelle che operano nel medesimo settore delle imprese sanzionate. Altrettanto importanti sono i documenti informativi che l’Autorità Antitrust realizza periodicamente: dalle linee guida alle indagini conoscitive, alle segnalazioni al Parlamento. Pur avendo carattere informale, questi documenti rivelano gli indirizzi interpretativi dell’Autorità è producono a loro volta un effetto di suasion molto efficace. In particolare, le linee guida con le quali l’Autorità suggerisce alle imprese il modo per dare corretta attuazione alle disciplina antitrust sono considerate di fatto dalle imprese come una fonte normativa. L’Autorità Antitrust, dunque, recupera sul piano della prassi applicativa poteri normativi di cui formalmente non dispone, ma che ha una ricaduta sulla determinazione delle scelte imprenditoriali molto significativa (16). L’interferenza che anche le autorità indipendenti di controllo sono in grado di realizzare non può dunque essere sottovalutata dall’interprete. L’Autorità Antitrust in particolare non si limita a compiti di vigilanza e di accertamento delle violazioni della disciplina antitrust intervenendo ex post e con poteri sanzionatori e repressivi, ma riesce a conformare anche attraverso strumenti informali di moral suasion il contenuto delle decisioni imprenditoriali e quindi il contenuto delle pattuizioni in cui tali decisioni si realizzano nel mercato. 5. Il quadro che emerge da questo breve excursus sui modelli di relazione tra autonomia contrattuale ed intervento pubblico, che non ha certo pretesa di completezza ma solo quella di indicare alcuni percorsi argomentativi, mostra che il rapporto tra autonomia ed eteronomia si modula con toni ed accenti sensibilmente diversi a seconda dei paradigmi contrattuali di riferimento. L’esame di alcune delle discipline in cui si articola oggi il diritto dei contratti (contratti di consumo, contratti di rete e contratti fra imprese nel mercato concorrenziale) suggerisce di ( 16 ) È la stessa Autorità Antitrust a svelare la forza di questi strumenti informali. Da ultimo cfr. la Relazione Annuale 2006 reperibile sul sito nella quale si possono trovare numerosi esempi di come talvolta comportamenti pro-competitivi sono indotti dalla sola pubblicazione di indagini conoscitive. 186 GIURISPRUDENZA abbandonare ipotesi ricostruttive unitarie e di verificare volta per volta come la relazione indagata si atteggia. Deve prevalere la consapevolezza che la frammentazione delle fonti, l’internazionalizzazione e l’integrazione dei mercati, e la graduale ma inarrestabile de-statualizzazione del diritto, mette in crisi gli strumenti concettuali che la tradizione mette a disposizione dell’interprete. È necessario allora riconoscere che diversi contesti di mercato hanno condotto il legislatore a differenziare il suo intervento, ora interferendo in modo molto penetrante nella determinazione del contenuto e delle condizioni dello scambio, come nel caso dei contratti di consumo, ora intervenendo in modo meno «invasivo», come accade per i contratti di rete, oppure facendo intervenire soggetti pubblici diversi, come nel caso delle Autorità Amministrative Indipendenti. È questo forse il profilo più delicato. L’interprete non deve lasciarsi suggestionare dall’idea che la dirompenza delle dinamiche di mercato abbia causato la totale perdita di controllo statale sull’economia, e risolvere frettolosamente il rapporto tra Stato e mercato a favore di quest’ultimo. Anche il civilista deve riconoscere che è avvenuta invece una riallocazione del potere statale in capo a più soggetti: non più solo il legislatore, incapace e inadatto ad aggiornare la disciplina contrattuale tradizionale, ma anche Amministrazioni Indipendenti di regolazione e di garanzia. Piaccia o non piaccia, ciò a cui stiamo assistendo è l’espansione all’interno dei territori del diritto dei contratti del diritto della concorrenza, con le sue logiche e i suoi caratteri peculiari, con i suoi strumenti di intervento formali e informali, che integrano e completano le tradizionali discipline contrattuali e che debbono essere studiate e comprese anche dal civilista: sarebbe un grave errore, a questo punto, voltare la testa da altra parte. Giuliano Zanchi
Scarica