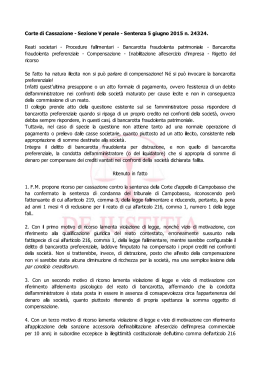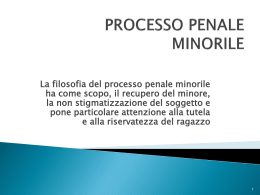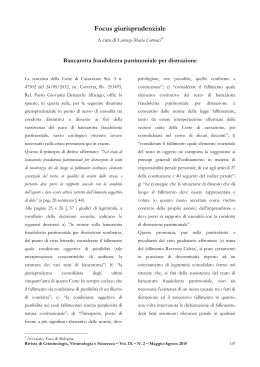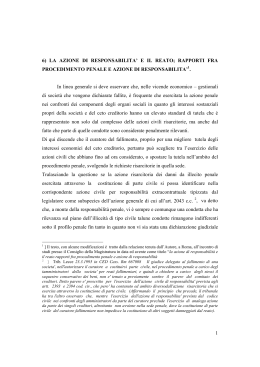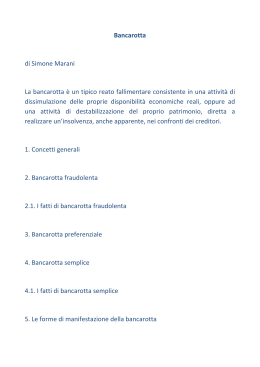QUESTIONI VECCHIE E NUOVE IN TEMA DI FALLIMENTO DELL’IMPRENDITORE La disciplina penale del fallimento, salvo isolate norme, è fondamentalmente quella della legge fallimentare n. 237 del 1942. Caratteristica comune ai reati fallimentari è di essere reati propri perché presuppongono una particolare qualifica o qualità dell’agente (imprenditore individuale o collettivo), il cui status è acquisito a seguito della dichiarazione giudiziale del tribunale fallimentare. La sentenza dichiarativa di fallimento si pone come il momento logico e cronologico propedeutico all’insorgere del processo penale. Natura giuridica della sentenza dichiarativa di fallimento In relazione alla natura giuridica della sentenza dichiarativa di fallimento, nell’ambito della struttura dei reati, si è discusso a lungo in dottrina e in giurisprudenza. Secondo taluni il fallimento viene assunto ad evento del reato; secondo altri la sentenza costituiva una condizione obiettiva di punibilità; secondo la giurisprudenza la dichiarazione di fallimento, “pur costituendo un elemento imprescindibile per la punibilità dei reati di bancarotta, costituisce una condizione di esistenza del reato o, per meglio dire, un elemento al cui concorso è collegata la esistenza dei reati, relativamente a quei fatti posti in essere anteriormente alla sua pronuncia (vedi la fondamentale sentenza delle S.U.25/1/58 n. 2, Mezzo). I riflessi che dall’accoglimento di una o dell’altra teoria derivano sul piano delle fattispecie concrete sono di enorme rilevanza. Configurare la sentenza come evento del reato, comporta che anche il fallimento, come qualsiasi altro elemento di reato, deve essere conosciuto e voluto dall’agente; ritenere che si tratti di una condizione obiettiva di punibilità (art. 44 c.p.) ha per conseguenza che il suo verificarsi incide solo sulla punibilità e non sull’esistenza del reato (per effetto della retroattività della condizione). 1 Oggi é consolidata nella giurisprudenza di legittimità la tesi, riscontrata anche in pronunce della Corte costituzionale (Corte cost. sent. n. 146 del 1982, e ord. n. 636 del 1987), secondo cui “La sentenza dichiarativa di fallimento non costituisce una condizione obiettiva di punibilita' dei reati di bancarotta, ma integra un elemento costitutivo di essi. Conseguentemente i fatti compiuti dall'imprenditore (atti di disposizione o altri atti enumerati dall'art. 216 l.F. come ipotesi di bancarotta) diventano penalmente rilevanti solo con la pronunzia della sentenza dichiarativa di fallimento” v. tra le più recenti Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010; Sez. 1, n. 33019 del 23/02/2011, Ferri e altri). Per effetto della sentenza di fallimento, atti di amministrazione del patrimonio, in precedenza compiuti non illeciti e anzi doverosi (come il soddisfacimento di una obbligazione) diventano delittuosi; fatti penalmente irrilevanti, come il mantenimento di un tenore elevato di vita, integrano la dissipazione di cui all’art. 216. Questa natura della sentenza spiega perché il momento consumativo del reato, quanto al tempus e al locus commissi delicti, si pone nel momento e nel luogo della sua pronuncia, con il rilevante effetto di determinare la decorrenza del termine di prescrizione del reato (Sez. 5, n. 20736 del 25/03/2010, Olivieri), la determinazione della competenza territoriale presso il Tribunale del fallimento, nonché la data di riferimento per l’applicazione dei provvedimenti di amnistia e indulto. Si è al riguardo osservato che l’imprenditore è “soggetto a rischio”, per essere gravato dal permanente obbligo di conservare la garanzia patrimoniale, imposta dall’art. 2740 cod. civ., e che il fallimento consente di illuminare a ritroso l’intero percorso di gestione dell’organismo fallito. Si impone però, per evitare l’iniquità che può derivare dal far diventare illeciti comportamenti e fatti che quando furono realizzati erano leciti, sopra tutto quando risalenti a tempi in cui non era prevedibile il dissesto dell’impresa – che 2 può insorgere anche a seguito di contingenze economiche improvvise o a scenari internazionali imprevedibili – individuare un correttivo sul piano della causalità. Se oggetto della tutela penale è l’intangibilità del patrimonio del fallito a garanzia dei creditori, non vi è ragione di assoggettare a punizione un comportamento che non aveva questo fine. Osserva Sez. V, n. 523/2007, Cito “È vero che la disciplina relativa alla bancarotta fraudolenta patrimoniale è in grado, nella sua concreta applicazione, di selezionare i comportamenti in ragione del tempo che li separa dalla pronuncia giudiziale, dovendo il giudice pur sempre dar conto dell'effettiva offesa alla massa dei creditori (oggetto della tutela penale), quale portato del comportamento illecito (anche mediato e consequenziale, derivato dalla perdita di ricchezza e non compensato "medio tempore" da alcun riequilibrio economico). Una diversa, meditata, soluzione –dettata probabilmente dalla particolarità del caso- è stata proposta di recente da Cass. Sez. V, 24 settembre 2012 (dep. 6 dicembre 2012), n. 47502, Pres. Zecca, Est. Demarchi Albengo, Imp. Corvetta secondo cui "Nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso, e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente, e deve altresì essere soggetto dall'elemento soggettivo del dolo": Effetti nel processo penale della sentenza dichiarativa di fallimento. Quanto alla efficacia nel processo penale della sentenza dichiarativa di fallimento, sia con riguardo alla sussistenza dello stato di insolvenza, sia con riguardo alla qualità personale del soggetto, la questione si è riproposta di recente a seguito dell’entrata in vigore della riforma della disciplina fallimentare che ha modificato i presupposti economici di fallibilità dell’impresa. Ci si è chiesti se era compito del giudice, individuare in base ai principi già affermati la natura del soggetto insolvente, e verificare l’applicabilità dell’art. 2 c.p.. 3 Militava a favore di questa possibilità - il rilievo che la sentenza di fallimento, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura, non fa più stato nel processo penale ed è inidonea ad integrare la prova della qualità di imprenditore (tra le altre, Cass. Sez. 5 36032/02) - la considerazione che, anche se il mutato regime giuridico non riguarda la norma incriminatrice in senso stretto, bensì un elemento extra penale estraneo al precetto, che concorre però ad attribuire al fatto contestato il requisito dell’antigiuridicità, quando l’elemento extrapenale muti sostanzialmente la fattispecie incriminatrice, e concorre a delineare il precetto penale, ciò comporta necessariamente l’applicazione del comma 2 dell’art. 2 c.p.. Si ricordava che le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 8342/87 affrontarono specificamente il caso in cui la modifica legislativa aveva mutato la qualificazione giuridica del soggetto agente, un operatore bancario, non più ritenuto incaricato di pubblico servizio ed affermarono il seguente principio “Invero, per legge incriminatrice deve intendersi il complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del fatto. Tra questi elementi, nei reati propri, e' indubbiamente compresa la qualita' del soggetto attivo. Se ne deve dedurre che, se la novatio legis riguarda la qualita' del soggetto attivo, nel senso che, come nella specie, fa venire meno al dipendente bancario la qualita' di incaricato di pubblico servizio, necessaria per integrare il reato di peculato, non puo' non applicarsi in favore di quel dipendente il principio di retroattivita' della legge piu' favorevole affermato dall'art. 2 C.P. La formulazione letterale del 2° comma dell'art. 2 e' abbastanza chiara nell'escludere la punibilita' per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce piu' reato. E per quanti bizantinismi si vogliono fare, non si potra' mai contestare che il fatto ascritto al Tuzet e al Borgatti, se commesso oggi, non costituirebbe reato. Quel fatto storico, illecito al momento in cui fu commesso, non corrisponde piu' alla fattispecie astratta del reato”. 4 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19601 del 28/02/2008 ha affermato il contrario principio che il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto ai presupposti oggettivo e soggettivi della dichiarazione. Ha osservato la Corte che, nella struttura dei reati di bancarotta, la dichiarazione di fallimento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento giurisdizionale, e non per i fatti con essa accertati, in quanto il presupposto formale perché possono prendersi in considerazione le condotte previste dagli artt. 216 e segg. l. fall. non sono le condizioni di fatto richieste per il fallimento (o l'ammissione alle altre procedure concorsuali), ma l’esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento, che essendo atto della giurisdizione richiamato dalla fattispecie penale, è insindacabile in sede penale. Come tale, la sentenza, in quanto atto, la cui legittimità può essere sindacata solo in via principale con i rimedi previsti dall'ordinamento per gli errori giudiziari (e cioè con i mezzi ordinari o straordinari di impugnazione previsti dalla disciplina processuale civile), e non da parte del giudice penale, che non può azionare alcun mezzo previsto dalla legge e compiere alcuna valutazione, neppure incidentale, deve essere solo verificata nella sua esistenza e nella sua validità formale. Ha quindi escluso che le modifiche, apportate all'art. 1 r.d. n. 267 del 1942 esercitassero influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso. La bancarotta: unita’ o pluralità di condotte La risposta a questo quesito di carattere dogmatico, ma con evidenti riflessi pratici, è stata data dalle Sez. U, Sentenza n. 21039 del 2011, Loy. Il caso pratico sottoposto all’esame della Corte è semplice. L’imputato era stato condannato con sentenza definitiva per fatti di bancarotta preferenziale. Successivamente era stato tratto a giudizio per episodi di bancarotta fraudolenta per distrazione commessi nell’ambito della stessa procedura fallimentare. Il GUP di 5 Trieste aveva emesso sentenza di non doversi procedere ex art. 425 non potendo l'azione penale essere proseguita – secondo la previsione dell'art. 649 cod. proc. pen. – per precedente giudicato, ritenendo che, dato il carattere unitario del reato di bancarotta, non era consentito, in presenza di un giudicato su tale illecito, l'inizio di un nuovo e differente processo per ulteriori e diversi fatti di bancarotta accertati successivamente, ostandovi il divieto del bis in idem, in quanto questi ultimi fatti, pur non sovrapponibili naturalisticamente ai primi, erano comunque assorbiti nel disvalore dell'unico reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale già giudicato e non davano luogo a una pluralità di reati. Il quesito cui la Corte parte deve rispondere è se il delitto di bancarotta, nel caso in cui siano poste in essere più condotte tipiche nell'ambito di uno stesso fallimento, sia un unico reato, con l'effetto di un aumento di pena in funzione di circostanza aggravatrice, o se – invece – la pluralità di condotte di bancarotta dia luogo ad un concorso di reati, con conseguente esclusione del divieto di bis in idem per l'eventuale giudicato intervenuto su alcune delle indicate condotte. Il discorso ruota intorno all’interpretazione da dare al comma secondo n. 1 dell'art. 219 legge fall. Per cui “le pene stabilite negli articoli suddetti (216, 217 e 218) sono aumentate, se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati”. Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la disposizione in esame era espressione della concezione unitaria del reato di bancarotta, posto che nel sistema del codice penale la circostanza aggravante può aggravare un solo fatto di reato, cui inerisce. Altro orientamento, riteneva che la riduzione ad unità della pluralità dei fatti di bancarotta posti in essere nell'ambito della stessa procedura concorsuale, doveva intendersi solo quoad poenam, senza potersi escludere l'autonomia ontologica dei singoli episodi delittuosi. Al di la della dizione usata, l’art. 219 introduceva una particolare ipotesi di continuazione tra i reati, che, in deroga all’art. 81 cod. pen., prevedeva l'aumento di pena fino ad un terzo. 6 La Corte parte dalla premessa che l’art. 216 l. fall., è inquadrabile nella categoria delle disposizioni a più norme perché prevede più ipotesi incriminatrici (distrazione, dissipazione, distruzione) aventi ciascuna una propria oggettività giuridica e autonoma rilevanza penale. Tali fattispecie sono alternative fra loro ponendosi come diverse modalità di commissione di un unico tipo di reato; tuttavia integrano un solo reato se hanno ad oggetto lo stesso bene o se sono realizzate in contiguità temporale fra loro. La configurazione unitaria della bancarotta trovava la giustificazione più significativa nell'antica concezione del fallimento come evento del reato, costruita sulla la spiccata omogeneità dei comportamenti realizzati dall'imprenditore nella fase della decozione. Nella realtà contemporanea, con l'abbandono definitivo della concezione del fallimento come evento e in considerazione del fatto che i comportamenti dell'imprenditore insolvente possono essere estremamente eterogenei per tipologia e per offensività, la Corte ritiene che i plurimi fatti di bancarotta nell'ambito del medesimo dissesto fallimentare, pur unificati normativamente nella previsione dell'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., rimangono naturalisticamente apprezzabili, se riconducibili a distinte azioni criminose, e sono da considerare e da trattare come fatti autonomi, ciascuno dei quali costituisce un autonomo illecito penale. L'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. disciplina, nella sostanza, un'ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente, in funzione mitigatoria della pena allo strumento tecnico della circostanza aggravante. La concezione unitaria, che contrasta tale conclusione, riconducendo a unità fatti autonomi e diversi, condurrebbe a conseguenze inaccettabili in contrasto con la logica del sistema penale e con gli artt. 3 e 112 Cost.: esemplificativamente, una condanna per bancarotta preferenziale di scarso rilievo condurrebbe all'impunità di altri e più gravi fatti di bancarotta fraudolenta commessi dallo stesso soggetto 7 nell'ambito dello stesso fallimento ed emersi solo successivamente al fatto già giudicato. La soluzione accolta dalla Corte comporta conseguenze rilevanti sul piano processuale: - la contestazione nel decreto che dispone il giudizio deve indicare ogni singolo fatto; - ogni singolo fatto deve essere oggetto di accertamento in sede di istruttoria dibattimentale; - ogni singolo fatto deve essere oggetto di un autonomo capo della decisione anche ai fini dell'effetto devolutivo in sede di eventuale impugnazione; - per ogni diverso e autonomo fatto di bancarotta che emerge nel corso di un processo riguardante altro fatto di bancarotta, relativo logicamente alla stessa procedura fallimentare, occorre procedere a nuova contestazione; - la diversità ontologica dei singoli fatti, unificati fittiziamente dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., si riflette sul giudicato e sul connesso problema dell'operatività dell'art. 671 cod. proc. pen. in materia di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato. Per conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza con rinvio al Tribunale di Trieste per nuova deliberazione. Brevi cenni sui singoli reati fallimentari Richiamo brevemente i principi normalmente applicati nei processi per bancarotta. Le dichiarazioni del fallito Ai fini della decisione, possono essere utilizzate le dichiarazioni rese da fallito al curatore. È infatti affermazione giurisprudenziale pacifica quella secondo cui: << In tema di dichiarazioni autoindizianti, non e' applicabile alle dichiarazioni rilasciate al curatore dal fallito la disciplina di cui 8 all'art 63 comma secondo dichiarazioni se cod. proc. pen. (che prevede siano state rese alla autorita' la inutilizzabilita' giudiziaria o alla di tali polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualita' di imputato); ne' tale esclusione puo' ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. (vedasi Corte cost. sentenza n. 136 del 1995)>> ( Cass. Sez. V, n. 41134/2001, Lottini). Si ricorda ancora come la sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata ha escluso che il regime dell’inutilizzabilità sancito dall’art. 63 possa essere riferito “al fallito relativamente agli atti della procedura concorsuale, e, più specificamente, all'esame del curatore, quest'ultimo essendo un soggetto che - può anche qui ripetersi - "non è da qualificare neppure ufficiale di polizia giudiziaria". È indubbio, ad avviso della Corte, che occorra discriminare l'ipotesi in cui il fallito rivesta la qualità di indagato da quella in cui, invece, tale qualità non abbia ancora assunto: con inevitabili riverberi anche in riferimento alla dedotta violazione del diritto di difesa, soltanto nel primo caso potendosi profilare ostacoli all'utilizzazione delle dichiarazioni. Ciò pure alla stregua del già ricordato principio in base al quale il divieto di esame opera solo con riferimento alle dichiarazioni rese "nel corso del procedimento" e non genericamente "in pendenza del procedimento" (v. sentenza n. 237 del 1993). Cosicché, conclude la Corte, il divieto di testimonianza posto dall’art. 62 c.p.p. non può coinvolgere le dichiarazioni rese al curatore. “Il divieto, infatti, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, presuppone pur sempre "che le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza de auditu siano state rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento" (sentenza n. 237 del 1993). Ed è sicuramente da escludere (cfr. la più volte ricordata sentenza n. 69 del 1984) che le dichiarazioni destinate al curatore possano considerarsi rese nel corso del 9 procedimento penale, non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una notitia criminis. La prova della distrazione Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita' in tema di bancarotta fraudolenta, il giudice è autorizzato a dedurre, senza necessità di ulteriore prova, che, per non essersi rinvenute nel patrimonio acquisito al fallimento le somme che pur figurano incassate, e non essendo stato provato dall’amministratore il loro impiego per le finalità sociali, esse dolosamente distratte, gravando sul fallito l'obbligo giuridico siano state di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio (v., fra le tante: Cass. Sez. 5^, 4.6.2004 n. 8007, Squillante; Cass. Sez. 5^ 21.4.1999 n. 7569, Jovino; Cass. Sez. 5^, 17.5.1993 n. 7726, Brancaccio ed altri; Cass. Sez. 5^, 17.3.1987 n. 644, Lombardi). Lo stesso principio vale per i beni che dovevano essere rinvenuti nell’azienda al momento dell’inventario. Le scritture contabili La giurisprudenza si è soffermata sulla differenza esistente tra il reato previsto dall’art. 216 e quello previsto dall’art. 217. Si è osservato in proposito che l'obbligo di tenuta di libri e scritture contabili imposto dalla legge, mira ad assicurare, a garanzia dei creditori, il retto e oculato svolgimento e l'agevole controllo dell'attivita' commerciale e a precostituire la prova della situazione economica dell'impresa, onde consentire agli organi dell'eventuale fallimento di acquisire attivita' e ricostruire rapporti senza ostacoli e lungaggini. Tra le due ipotesi di reato - artt. 216 e 217 - ricorrono, tuttavia, nonostante l'identita' di ratio, rilevanti differenze, in ordine sia all'elemento oggettivo, sia a quello soggettivo. Il primo e' un reato tendenzialmente di danno e coinvolge nella condotta anche soltanto le scritture facoltative, mentre il secondo, che concerne le scritture obbligatorie, e' un reato di pericolo presunto, per cui 10 e' irrilevante che la ricostruzione del patrimonio e degli affari possa avvenire anche aliunde. Il primo e' un reato doloso, in quanto lo scopo perseguito dall'agente e' nella prospettazione soggettiva, quello di conseguire un profitto o di arrecare un danno, e, nella prospettazione oggettiva, quello di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Il secondo reato, invece, e' punibile, indifferentemente, a titolo di dolo e di colpa, per cui e' superflua l'indagine sull'efficacia causale dell'omessa o irregolare tenuta che e' punita per se stessa, indipendentemente dalle conseguenze. Siffatta differenza comporta, sul piano processuale, semplice e' realizzata dalla omissione, che la bancarotta soggettivamente sostenuta imprudenza, negligenza e violazione di leggi, ed e' anche da provata dalla mancata produzione dei libri e scritture. La prova puo' essere vinta soltanto da una contraria, rigorosa duplice dimostrazione, gravante sull'imputato, della tenuta dei libri e della incolpevole impossibilita' a produrli per caso fortuito o forza maggiore. Comporta, inoltre, che, qualora sia mancante o insufficiente l'indagine sulla strumentalita' soggettiva e sulla finalizzazione oggettiva della condotta, richieste per la bancarotta fraudolenta documentale, la mera mancanza di libri e scritture contabili deve essere ricondotta nella bancarotta semplice. Nella pratica, l’accertata esistenza di fatti di distrazione patrimoniale, costituisce indice che la mancata tenuta delle scritture contabili fu funzionale a rendere impossibile agli organi del fallimento la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. L’amministratore di fatto Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez. 1, n. 18464/06) la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, con la precisazione che i caratteri della "significatività", e della 11 "continuità" non implicano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2003, Sidoli, rv. 224948). È utile altresì segnalare che la definizione legale contenuta nell'art. 2639 c.c., ha recepito i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale, sulla cui base era stato stabilito che la posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale; la disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto - quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive - in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare (Cass., Sez. 5^, 22 aprile 1998, Galimberti,). Va ancora specificato che la posizione di amministratore di fatto deve essere riconosciuta solo a coloro che hanno che compiuto tutti quegli atti di gestione competono all'amministratore, quali i contatti ed i rapporti con fornitori e clienti ed il controllo della contabilità e del movimento delle merci, quando con la loro attività hanno consapevolmente apportato un concreto contributo causale alla produzione del dissesto della società (Cass. 5, sent. n. 7583 del 1999). Diversa dall’amministratore di fatto è la posizione della cd. testa di legno, ovverosia di colui che solo fittiziamente, normalmente in prossimità del fallimento, assume la veste di amministratore. Quale amministratore di diritto, egli è senz’altro tenuto alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili. Su di lui grava formalmente l’onere del 12 corretto adempimento di tutti gli obblighi facenti capo all’imprenditore nella gestione dell’attività aziendale. Soltanto un completo e dimostrato esautoramento del responsabile formale dell’impresa potrebbe portare ad un addebito in via esclusiva degli atti di mala gestio in capo al soggetto effettivamente operante1. Diverso è invece il discorso ove si accerti la distrazione di beni. È vero che, sul presupposto che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo (art. 40 c.p., comma 2), si ritiene di regola integrato il concorso dell'amministratore di diritto ed anche del mero prestanome tutte le volte in cui tale soggetto, restando inerte e violando con ciò l'obbligo di vigilare e quello di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli (art. 2392 c.c.), abbia soltanto consentito ad altri il compimento di fatto di atti di depauperamento del patrimonio sociale o comunque di gestione. Questo orientamento non può tuttavia essere sospinto oltre i limiti assegnati dai principi di colpevolezza e personalità che governano la responsabilità penale e per i quali non può affermarsi la responsabilità di alcuno, neppure del prestanome, se il fatto non risulti, in concreto, realmente a lui rimproverabile, e cioè prevedibile e prevenibile. D'altro canto la "fraudolenza", intesa come connotato interno alla distrazione, implica, dal punto di vista soggettivo, che la condotta di tutti coloro che si predica concorrono nella attività distrattiva risulti perlomeno assistita dalla consapevolezza che si stanno compiendo operazioni sul patrimonio sociale, o su talune attività, idonee a cagionare danno ai creditori. Quindi, riguardo all'ipotesi della distrazione, non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella 1 Si ricorda come, secondo la giurisprudenza (Sez. V, n. 28007/04, Squillante) vi é il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture e, quindi, integra il reato contestato la condotta dell’amministratore di diritto consistita nella volontaria abdicazione a tal dovere specifico in uno al dato oggettivo della estromissione"fisica" delle scritture di legge dall'area del suo immediato e costante controllo. 13 disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, diventa legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto. Non e' perciò automatico in punto di dolo che ogni accettazione della carica di amministratore formale celi un disegno criminoso dell'amministratore di fatto (potendo questi trovarsi in una condizione che non gli consenta la gestione in prima persona). 14
Scaricare