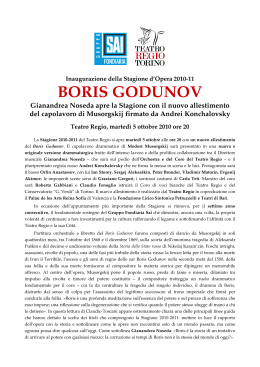— focus on Nekrosius Back in Venice M di Franco Quadri AI PIÙ QUEL giorno di metà dicembre 1985, sul tre- focus on no che da Mosca mi conduceva a Vilnius, immaginavo che quel viaggio teatralturistico sarebbe stato così importante per me. Sopravviveva ancora l’Urss ed ero accompagnato, o forse dovrei dire sorvegliato, dall’interprete e guida che aveva il lirico nome di Musa, in una trasferta desti- caratteristiche di universalità che in passato resero comprensibile ovunque il teatro di Kantor, al quale riportava l’armamentario ligneo creato attorno al protagonista immobile e al suo servo sordomuto, imponendo il visionarismo del silenzio che regnava tra i ritorni circolari del motivo trainante del Bolero di Ravel e l’affacciarsi di visi nati dal ricordo e dalla fantasia; e dopo i tentatori e i persecutori sarebbe apparsa la bella fatale donna vestita di nero a portare l’ordine della fine e il corpo dell’artista sarebbe stato portato via sulla sua bilancia, coperto di farina, come un pupazzo di neve. Ed è incredibile come, evocate tanti anni dopo, queste immagini ancora mi commuovano sollecitate dal ritorno onirico dei suoni. Ma Ejmuntas Nekrosius, e mi rendo conto ora che non avevo ancora dato un nome al protagonista, non era e non è un incantatore di serpenti. E ne ebbi la clamorosa conferma subito sul posto, dato che l’occasione della Biennale aveva fatto Ejmuntas Nekrosius nata a scegliere degli spettacoli d’oltrecortina per il Festival del Settore Teatro che allora dirigevo alla Biennale. Nella capitale russa il mio interesse si era focalizzato su un entusiasmante lavoro di Anatolij Efros, ma la meta più misteriosa del mio interesse era un lituano, direttore dello Jaunimo Teatras – il Teatro della Gioventù –, appena premiato al Bitef di Belgrado, allora zona franca di comunicazione tra est e ovest, dove era stato acclamato come «un Bob Wilson del Baltico». Il suo Pirosmani Pirosmani, ispirato alla biografia del pittore georgiano Nico Piromanisvili, si sarebbe rivelato in effetti un’opera mirabile: nonostante la lontananza della repubblica dove la storia era nata da quella in cui era stata realizzata, che rendeva scettico il capo della censura sovietica nel concedermi il visto preventivo a esportare il lavoro a Venezia, lo spettacolo aveva le Pirosmani Pirosmani montare una sorta di mostra del Maestro – questa era già allora la parola che gli spettava. Si poteva dunque passare alla semplicità di Quadrat, breve incontro carcerario in una scena quasi nuda ma suscettibile di sorprendenti trasfigurazioni, in cui un amore impossibile fioriva nonostante l’ossessiva sorveglianza, delineando un inferno esistenziale in grado di rappresentare il Paese. E Un giorno come un secolo, tratto da un romanzo di Aichmatov e ambientato in un remoto paese uzbeco prospiciente a un cosmodromo, dove sconvolgenti flashback trasferivano sulla scena i pogrom degli anni trenta o le più recenti manifestazioni di gioia popolare per la caduta di Stalin, con grande fantasia grazie a una decina di attori capaci di trasformarsi in un popolo e con una presa diretta sul pubblico, facendo sussultare la mia guida-spia, che mi diceva «Ma il roman- focus on — zo non è così», irritata anche perché io fruivo di una cuffia con traduzione italiana e lei di nessun aiuto che l’aiutasse a capire il lituano. E a questo grande lavoro registico si aggiungeva un Romeo e Giulietta, pardon Amore e morte in Verona, in versione da rivista rock, montato già nell’82 come suo primo Shakespeare dal regista, che una decina d’anni dopo avrebbe chiamato un cantante pop molto popolare a essere il suo Amleto: e quello «veronese» era uno spettacolo che importava per la prima volta in Lituania una musica ufficialmente sconosciuta oltre-cortina che mi colpì per l’audacia delle costruzioni sceniche, anche se quella coreografica guerra civile richiedeva forse particolari chiavi di lettura. Ma a ripagare il mio entusiasmo la Biennale, che, all’ultimo, aveva fissato la riunione delle diverse direzioni settoriali per l’approvazione definitiva dei programmi proprio negli stessi giorni in cui da mesi era stato fissato il mio appuntamento una troupe di servi, dominati da un fattore che faceva ripensare ai poteri delle burocrazie sovietiche, tra gag scandite da un motivo chapliniano ed esplicite citazioni della Règle du jeu, mentre all’utopismo del dottore, che coltiva l’ecologia attraverso gli ingrandimenti dei francobolli della sua collezione, si contrappone l’estetismo della splendida Elena che seduce tutti, anche i servi e la nipote, senza intaccare la propria sanità borghese. Alla base c’è il rifiuto del realismo, evidente anche dalle citazioni sceniche di imitazioni della pittura russa classica, e che si chiarisce quando l’odiato professore, prima che Zio Vanja fallisca il suo attentato contro di lui, riunisce il gruppo familiare per una foto ricordo ripresa in realtà dalle Tre sorelle, e si sprigiona con abbandono crescente, come un inno alla Resistenza, il coro del Nabucco, nel punto in cui un popolo in catene canta «Oh mia patria, sì bella e perduta…», identificando l’idiosincrasia di zio Vanja nei riguardi dell’ospite usurpato- focus on La danza della morte di Otello Zio Vanja con le autorità e i teatranti sovietici, approfittò della circostanza per togliere i fondi per la nuova stagione al Settore Teatro e, invece dell’invito a Nekrosius, io mi trovai costretto a proporre le mie dimissioni. Avrei ritrovato peraltro il regista un anno dopo a Vienna, alla prima di quello Zio Vanja, già in prova nei miei giorni di Vilnius, quando, alla mia domanda sulle sue linee di interpretazione, Nekrosius mi aveva sorpreso dicendomi che nella pièce lo colpivano in particolare due cose: quella «famiglia in strettezze» che viveva in una casa di 25 stanze e la contesa verso la fine tra il dottor Astrov e il protagonista per il possesso di un bottiglina di morfina. In effetti la prima cosa che si notava fin dalle prime repliche dello spettacolo, destinato come sempre a lunghe fasi di ritocco, era l’inesausto e inedito trattamento di pulizie dei suoli operato tutto il tempo da Macbeth re come motrice della storia di un’occupazione privata da produrre davanti al pubblico lituano – ed europeo – per confrontarla con quella pubblica. Lo spettacolo sarebbe arrivato finalmente in Italia, alla fine dell’aprile 1989, in un’edizione più compiuta rispetto alla prima viennese, insieme al leggendario Pirosmani Pirosmani, realizzando un sogno quadriennale, destinato peraltro con ritardo a divenire un’abitudine sempre più intensa col tempo, quando il regista prenderà a frequentare sempre più spesso i nostri festival, chiamato a provare e montare qui nuovi spettacoli, anche lirici, ottenendo sempre più spesso importanti riconoscimenti. La spinta si sviluppa a cominciare dalla seconda metà degli anni novanta particolarmente in Sicilia, da Palermo alle Orestiadi di Gibellina, dove si vedono diver- ▶ — focus on si stadi del Macbeth, o a Taormina col Premio Europa per il Teatro, dove vengono presentate Le tre piccole tragedie di Puskin e delle scene in anteprima delle Tre sorelle, provate in Lituania in preparazione alla prima di Roma. Ma il suo debutto di lavoro tra noi trova una sede nell’agosto 1999 a Fagagna nel Friuli, chiamato dal sottoscritto memore dell’antico debito, per 16 soli intensi giorni a dirigere il primo stage della sua vita con gli allievi trilingui dell’Ecole des Maîtres, ovvero 21 ragazzi di 4 paesi europei, posti a misurarsi con un romanzo complesso come Il maestro e Margherita e talmente esaltati dall’incontro da riuscire a montarne un inizio che coglieva con acutezza i tre grandi filoni dell’opera di Bulgakov, presentandone pure una pubblica dimostrazione finale in interni ed esterni, con tanto di tuffi dal balcone. L’anno successivo Nekrosius accetterà di ripetere l’esperienza ovviamente con un al- pubblico, dopo un corposo supplemento di lavoro, nel luglio 2001, in uno spettacolo della Biennale, seguito da una trasferta festivaliera a S. Pietroburgo, nelle sedi dell’Ecole e da una tournée molto apprezzata nelle maggiori piazze della penisola. E non è un caso che dopo di allora Nekrosius sia stato chiamato altre volte, aldilà delle tournée con la sua compagnia, a creare degli spettacoli con della compagnie italiane, come accadde con l’Ivanov di Cechov nel 2002 e con l’adattamento di Anna Karenina quest’anno, sempre con Mascia Musy protagonista. All’appuntamento leggendario con la Biennale, c’era già arrivato qualche mese prima con due fasi diverse del suo Otello che si chiudeva con una impressionante, vorticosa, appassionata, travolgente danza di morte così impregnata di amore per la vita. E devo al presidente Paolo Baratta e al direttore Giorgio Barberio Corsetti la soddisfazione di es- focus on Due momenti del Gabbiano Anna Karenina tro gruppo con le stesse caratteristiche, ma gode stavolta di un periodo di lavoro di due mesi e sceglie Il gabbiano, testo da lui amato ma mai realizzato, col preciso proposito di cancellarne la tristezza, lo psicologismo maniacale, la mostra dei samovar e dei luoghi comuni risaputi e, invece di mischiare le lingue degli stagisti, ne promuove due versioni separate, una in italiano, l’altra in francese, montandole con simbologie molto dirette come gli svariati tipi di contenitori in fila per rappreIl Gabbiano sentare il lago, ma al tempo stesso con grande attenzione all’inconscio, fino all’atto conclusivo degli addii o degli SOS, perché non mancano gli appelli disperati di aiuto. La versione italiana risultò nettamente la migliore, così sostenuta dalle forti e tenere personalità degli attori (tra cui spiccavano Fausto Russo Alesi e Pia Lanciotti), da poter essere presentata in sere stato chiamato allora a dibatterne con emozione insieme al regista e agli spettatori in uno degli incontri della Biennale con cinque grandi registi, a tre lustri di distanza dall’appuntamento mancato di Pirosmani Pirosmani. Ma riguardo alla continuità dei suoi spettacoli nel tempo vorrei chiudere con una frase che in quell’incontro Ejmuntas Nekrosius disse al proposito, riferendosi alle varie edizioni del suo Otello: «Quando uno spettacolo diventa definitivo perde sempre qualcosa. Inizio a capire che anche la sua incompiutezza, il non arrivare fino alla fine sia affascinante. Meglio non finire che esagerare e fare troppo. Inizio ad apprezzare le cose non finite: il detto e il non detto sono più interessanti rispetto alle cose finite e lucidate. Il teatro per me dev’essere proprio così.» Per un maestro leggendario per il suo perfezionismo non c’è male. ◼ focus on — Una delle sparute incursioni nella lirica del grande regista L di Sandro Cappelletto In alto, sullo sfondo del palcoscenico, il grano indica la terra, la natura, il ciclo della vita. Ma gli uomini, tutti gli uomini, lo zar Boris, la sua famiglia, il popolo, vivono sotto, in cunicoli, in catacombe, dove la luce non penetra mai. Tutti sono oppressi, anche chi opprime. Uomini talpe, uomini formiche, ammassati in un girone dantesco, piegati, curvi, stanchi, vittime della storia, più che di questo o quel tiranno. Senza più speranza. Figure della notte, come le civette e i barbagianni che occupano l’appartamento dello zar. Loro, nel buio, vedono perfettamente, a differenza degli esseri accecati che hanno accanto. Il Cremlino? Una parete rossa e infuocata, dove sono conficcate grandi accette. Il potere è sangue, morte, scannamento. La vita non abita lì: entra in scena una culla troppo grande, e vuota: Boris la copre di guanciali neri e grigi, la trasforma in una tomba, in un tumulo. Anche in questa occasione, Nekrosius lavora assieme al fi- ui non racconta, evoca. Non descrive, accenna, immagina e chiede di immaginare. Non impone una storia, la propone. La stazione ferroviaria di Anna Karenina? Bastano due fari, gli occhi del treno, portati da un gigantesco capo-stazione, a far intendere ogni cosa. Le streghe del Macbeth? Un misterioso soffio di vento che agita dei rami, in primo piano. L’addio al Giardino dei ciliegi? Una canzone russa che sfuma lontano. Ejmuntas Nekrosius, 56 anni, regista lituano, diplomato all’Istituto d’Arte Teatrale «Lunaciarskij» di Mosca. Prima lavora in diversi teatri della sua Vilnius, poi diventa responsabile del Festival Internazionale del Teatro Lituano e, nel 1998, fonda il «centro artistico indipendente» Meno fortas. Ai Scene dal Boris Gudonov propri spettacoal Maggio Fiorentino (2005) li originali, alterna messinscene dei classici: Shakespeare e Cechov, Tolstoj. glio Marius, autore delle scene, e alla moglie Nadezda GultDal teatro il passo verso l’opera lirica è cauto, ragionato. La yaeva che firma i costumi. Un’idea di teatro artigiano, di botprima regia affronta il Macbeth di Verdi, considerato – a ragiotega famigliare, adatta ai tempi lunghi che gli sono indispensane – come un autore epico, dunque adatto alla sua poetica che bili per concepire e realizzare i propri spettacoli. Tempi adatti rifugge la rappresentazione realistica a vantaggio di una fora un allestimento teatrale più che a un palcoscenico lirico, dote presenza di simboli: non astratti, ma naturali, vivi, di imve la regia, anche la più personale e convincente, entra in un mediata visibilità. E universali, dunque senza bisogno di vesistema di relazioni complesse con il direttore, i cantanti e innire attualizzati. terpreti, i ritmi e i costi della produzione. Per la stagione della Fenice arriva a Venezia, tre anni dopo E mentre, in teatro, Nekrosius smonta e rimonta un testo seil debutto al Maggio Musicale Fiorentino, il Boris Godunov di condo le proprie esigenze e convinzioni, all’opera la musica, Modest Musorgskij riletto da lui. il libretto, non sono delle entità variabili. Hanno le loro scanNekrosius ama la retorica del silenzio, che non intende mai sioni, esigenze, tempi. Lui li accetta, tentando sempre di rimacome una sospensione dell’azione, ma come un’attesa, una nere se stesso, di «proporre al pubblico la mia coscienza d’arconseguenza e un’anticipazione. Più dei personaggi, sembra tista, che non consola». preferire i loro gesti, le voci, gli oggetti che li circondano e che, Le sue regie liriche dividono: a Firenze, accanto agli apvia via, grazie a una presenza continua e varia, assumono eviplausi convinti per l’orchestra, il direttore, i cantanti, non denza e autonomia, si fanno storia nella storia. sono mancati i dissensi rivolti all’allestimento. Come e più del compositore, che in questa vicenChissà alla Fenice. Ma un difetto non potrà mai da ascolta e lascia vivere anche l’anima e il destino essere rimproverato a Nekrosius: la gratuità delVenezia della «grande madre Russia», il regista restituisce le sue invenzioni e della loro successione. In ogni Teatro La Fenice come dominante l’immagine oppressiva, ossessiscelta, e in tutte, vive una personale coerenza. 14, 16, 18, 20, 23 va del potere. settembre E questo è un tratto inconfondibile d’artista. ◼ focus on «Boris Godunov» secondo Nekrosius — focus on Il «Boris Godunov» di Modest Musorgskij Q di Elisabetta Fava focus on UANDO SI PENSA alla Russia dell’Ottocento come a una terra lontana, dove la cultura del resto d’Europa arrivasse come un’eco remota, non solo si sbaglia di grosso, ma addirittura si capovolge la realtà: era piuttosto l’Europa occidentale a saper poco o nulla dei popoli slavi, mentre Mosca e più ancora Pietroburgo, moderna città costruita da architetti italiani e protesa verso l’ovest, erano imbevute e persin condizionate dalla cultura d’oltre confine. Di quest’esterofi lia s’era già beffato Puskin, soprattutto nell’Eugenio Onegin, dove ne considerò gli aspetti quasi patologici; e senz’altro la vita musicale russa era una testimonianza palese di quanto stretti fossero i rapporti dei ceti colti e della vita ufficiale con Italia, Francia, Germania: con sicuro guadagno per la coscienza critica degli artisti, ma con notevole detrimento per la loro carriera. I criteri di giudizio per selezionare questa o quell’opera e ammetterla alle scene dei Teatri Imperiali, in particolare, erano determinati da consuetudini importate dall’estero e tipiche soprattutto del modello italiano. Fu questo il clima nel quale maturò la bocciatura del Boris Godunov, presentato da un Musorgskij trentenne alla Commissione dei Teatri Imperiali, che per un annetto non si prese nemmeno la briga di guardare il manoscritto, salvo liquidarlo poi come «non rappresentabile». Giudizio duro, che mandò l’autore prima su tutte le furie, poi in crisi; e che tuttavia era in un certo senso inevitabile. A opere di soggetto politico si era abbastanza abituati grazie ai frequenti contatti con il repertorio francese; ma lì la storia faceva spettacolo, portava con sé fasti scenografici di sicuro fascino visivo; mentre qui la politica entrava nei pensieri di un monaco chiuso nottetempo a meditare nella sua celletta, munito solo di calamus e pergamena; sconvolgeva il tranquillo ménage di una di quelle osterie di confine che sarebbero tanto piaciute a Joseph Roth, dove il caso raduna i tipi umani più diversi; si ripercuote- va sui volti dimessi e un po’ ottusi di un popolo sofferente e umiliato, oggetto di una rappresentazione tanto partecipata quanto cruda. Insomma, Musorgskij non s’era dato il minimo pensiero di «piacere», di lusingare le aspettative degli habitué d’opera; aveva lavorato come di solito facevano i suoi compatrioti, dilettanti dal primo all’ultimo nel senso più nobile del termine, vale a dire esponenti dei ceti più alti che si dedicavano all’arte per il puro diletto e che potevano quindi prendersi il lusso di sperimentare, innovare, saggiare nuove vie, senza far caso alla consistenza degli eventuali incassi. Ma nessuno aveva ancora osato tanto: la commissione imperiale trasecolò soprattutto nel non trovare traccia alcuna di parti femminili (l’ostessa è piuttosto una caratterista), Boris Godunov, regia di Andrei Tarkovskij, direzione di Claudio Abbado, Opera di Vienna, 1991 e quindi di vicende amorose. Per ritentare la fortuna Musorgskij non poteva che rimediare a queste due singolari latitanze; solo in apparenza per conformarsi al protocollo censorio, però; perché di fatto aveva già maturato da tempo e per conto proprio l’idea di tornare sul proprio lavoro e riequilibrarne i pesi interni. La sua fonte era il dramma omonimo di Puskin, la cui struttura a pannelli si prestava agli inevitabili tagli, ma da cui ancora si potevano estrarre snodi cruciali. Fu così che il Boris di Musorgskij si accrebbe (oltre al finale nella foresta di Kromi) dei due quadri ambientati in Polonia, dominati dalla figura della principessa Marina e dal suo ambiguo legame con il falso zarevič Dimitri. Non bastò per far accettare una partitura così radicalmente innovativa, è naturale; ma questi primi interventi, e altri a seguire, sarebbero stati determinanti a dare al Boris di Musorgskij il suo carattere di cantiere aperto, in cui ogni modifica ha la sua bellezza e la sua ragione drammatica, e rende difficile scegliere questa o quella versione: focus on — accorse benissimo e cassò Rangoni, in quella versione oggi vilipesa e che tuttavia restò l’unica tollerata e circolante per oltre metà del Novecento. Senz’altro la vera e propria riscrittura di Rimskij aveva intaccato il timbro dell’orchestrazione originale: plumbea, grigia, sinistra là dove quella di Rimskij è policroma come la cattedrale di San Basilio, come i quadri del giovane Kandinskij, con la «vita colorata» della Russia antica che prorompe in cento forme e gradazioni diverse. L’attacco pensato da Musorgskij vuole due soli fagotti, goffi e cinerei; Rimsky preferisce la coppia fascinosa di fagotto e corno inglese, e in questa incompatibilità dell’universo timbrico si condensa la distanza dei due punti di vista, quello luminoso di un folclore alla Gogol’ e quello polveroso degli «umiliati e offesi», finora destinati solo alle pagine della letteratura, non certo alla ribalta del palcoscenico: a piangere e gioire a comando (altro particolare assente in Puskin), sotto il knut di un gendarme, senza poterne sapere il motivo, in una rassegnazione atavica che di necessità appanna le tinte. Persino le campane che accompagnano l’incoronazione hanno nella partitura di Musorgskij un risalto bronzeo e spaventevole, senza brillio d’ori. Qui Musorgskij riesce a far trapelare i retroscena della politica, i meccanismi inconfessabili del potere e dei suoi burattinai: Boris sale al trono, ma vi resterà fin quando i boiari glielo permetteranno; la sua gloria, già macchiata di crimini, è quella di un colosso d’argilla, già incrinato alle fondamenta. La sfida di rappresentare una seduta consiliare era già stata affrontata nel Simon Boccanegra, «il figlio zoppo» di Verdi; Musorsgkij si addentra sullo stesso terreno (e proprio l’avventura russa di Verdi legittima l’inserimento di ben tre frati, impensabili prima del precedente della Forza del destino): e scava come mai prima d’ora nelle finezze dello stile declamatorio, ricavato in parte dal Sussanin di Glinka e dal Convitato di pietra di Dargomiskij, e come quest’ultimo direttamente modellato sulla perfezione dei versi puskiniani. Il boiaro della prima scena, BoBozzetto scenografico di Eduard Löffer, Mannheim 1928 ris, Pimen: tutti cantano in un regime di arioso che non dimentica mai la curva della frase e al tempo stesso sembra Quanto cromosomicamente anticonvenzionale sia il Bosempre sul punto di spiccare il volo lirico (basta il pensieris si capisce subito andando a controllare proprio il cosidro della figlia ad addolcire il dettato scultoreo di Boris); e detto «atto polacco»: dove Musorgskij si prese persino delanche l’Innocente che piange sul destino della patria e col le libertà verso Puskin, aggiungendovi la parte del gesuisuo lamento conclude l’opera nella versione del 1874, sta ta Rangoni, prete machiavellico che tesse occulte trame al bivio tra il profi lo inconfondibile del folclore slavo e per conto della chiesa di Roma e usa l’ambizione di Mal’attenzione millimetrica alla prosodia. Ma accanto a querina nella speranza di dare la Russia in pasto alla cattoliste calibrature millimetriche il Boris vive poi di un’enerca Polonia. Marina non ama Dimitri, infatti, ma il trono gia teatrale di rara potenza e immediatezza, dove preghieche lui potrebbe offrirle; e Rangoni le insegna la strategia re e imprecazioni, lacrime e giulive canzoncine coabitano con cui ottenerlo e sta come un nibbio a spiare il convecon l’impertinenza della realtà quotidiana: di cui è spaccagno dei due, appiattandosi nell’oscurità. Anomalia scandato geniale la scena all’osteria, con il suo vario affollarsi di losa, se pensiamo che l’opera in musica era il tempio delistantanee e l’irresistibile miscela di suspense e di ironia. ◼ l’amore incondizionato ed eroico; Rimskij Korsakov se ne focus on tanto che nei dischi si cerca spesso di stipare un’«integrale» di fatto irrappresentabile. Chi di musica s’intendeva, però, riconobbe subito il valore della partitura, a dispetto dei pregiudizi; primi fra tutti i cantanti, veri artefici della messinscena: quando Julia Platonova, primadonna del Teatro Marijnskij di Pietroburgo, minacciò le dimissioni se il Boris non fosse stato accettato (e fu poi la prima Marina), i soloni governativi cedettero le armi e l’opera andò finalmente in scena l’otto febbraio 1874, diretta da Eduard Napravnik e sempre acclamata dal pubblico, nonostante il numero non altissimo (26) di recite concesse.
Scaricare