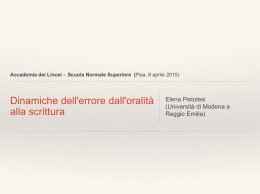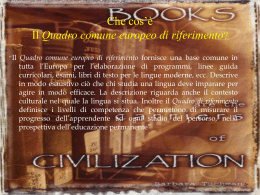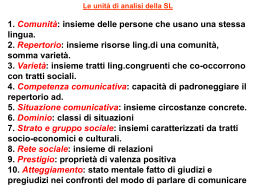UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO -BICOCCA A.A. 2015-2016 DISPENSE DI LINGUISTICA ITALIANA (A-L, M-Z) SOMMARIO 1. L’ITALIANO DI OGGI . STANDARD E NEOSTANDARD 1.1. L’ITALIANO STANDARD 1.2. ITALIANO DELL ’USO MEDIO O NEOSTANDARD 2. IL LESSICO DELL ’ITALIANO CONTEMPORANEO 2.1. OSSERVAZIONI GENERALI 2.2. I PRESTITI 2.3. I CALCHI 2.4. I PROCESSI DI NEOFORMAZIONE : LA DERIVAZIONE 2.5. I PROCESSI DI NEOFORMAZIONE : LA COMPOSIZIONE 2.6. LE UNITÀ LESSICALI SUPERIORI 3. LE VARIETÀ DELL ’ITALIANO 3.1. LA VARIAZIONE DIAMESICA 3.1.1. OSSERVAZIONI GENERALI 3.1.2. DIFFERENZE TRA SCRITTO E PARLATO 3.2. La vARIAZIONE DIATOPICA 3.2.1. LINGUA E DIALETTI 3.2.2. CARATTERI DELLA VARIAZIONE DIATOPICA 3.2.3. LE MINORANZE ALLOGLOTTE 3.3. LA VARIAZIONE DIASTRATICA 3.4. LA VARIAZIONE DIAFASICA 3.4.1. SOTTOCODICI E LINGUE SPECIALI 3.4.2. I LINGUAGGI TECNICO -SCIENTIFICI 1 1. L’ITALIANO DI OGGI . STANDARD E NEOSTANDARD Queste dispense si propongono di illustrare alcune delle strutture linguistiche fondamentali delle principali varietà dell’italiano contemporaneo. La prospettiva adottata è quella della sociolinguistica, che in linea generale si occupa delle relazioni che intercorrono tra il sistema lingua e gli elementi del contesto extralinguistico. Per molti secoli l’italiano è stato una lingua utilizzata fondamentalmente se non esclusivamente nella comunicazione scritta. Possiamo dire che una delle maggiori conquiste, e certo tra le più lunghe e difficili e comunque tuttora in atto, ottenute grazie all’unità d’Italia è stata quella di far parlare gli italiani con un’unica lingua. Questa lingua in realtà non è una lingua sola, nel senso che il panorama linguistico italiano, non diversamente da quello di altre lingue, è dominato da una condizione di variabilità che ha portato e porta al formarsi di diverse varietà di lingua. Prima di affrontare i problemi legati alla variazione linguistica è opportuno ricordare le principali ragioni non specificamente linguistiche, non cioè intralinguistiche, che hanno favorito la diffusione dell’italiano come lingua parlata (cfr. su questo De Mauro 1970; si veda anche il cap. 1 del libro della Lo Duca): - la diffusione della burocrazia (e dell’italiano burocratico) attraverso il decentramento amministrativo; - la deruralizzazione e conseguente urbanizzazione progressiva del Paese; - l’aumento della scolarizzazione; - la leva militare obbligatoria; - la nascita, lo sviluppo e la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa. Il processo che ha condotto al passaggio dell’italiano da lingua fondamentalmente scritta a lingua parlata (e certo anche scritta) da una percentuale sempre maggiore di popolazione non poteva non avere conseguenze sul modello di lingua che si era andato costituendo nel corso dei secoli. Nel giro di pochi decenni si è infatti passati da una situazione di diffuso monolinguismo dialettale con una ridotta percentuale di bilingui (italiano-dialetto) ad un diffuso bilinguismo, con una progressiva ampia percentuale di monolingui (a scapito evidentemente del dialetto). L’italiano cioè è via via diventato la lingua della socializzazione primaria e la lingua d’uso di una larga parte della popolazione. Nel processo di acquisizione della lingua nazionale tutti 2 gli apprendenti hanno così dovuto confrontarsi in varia misura con il cosiddetto Italiano standard. La nozione di standard è stata variamente discussa dagli studiosi, non solo italiani. Possiamo tenere presente il fatto che il concetto di standard ha a che fare con il concetto di modello, di lingua di riferimento per una determinata comunità di parlanti. In questo senso la lingua standard sembra disporre di una serie di requisiti o valori che possono essere indicati seguendo le indicazioni di Berruto: un primo possibile valore della nozione di standard equivale a quello di “neutro”, non marcato su nessuna delle dimensioni di variazione; un secondo valore è quello di normativo, codificato dai manuali e dalla tradizione scolastica, accettato come corretto e “buona lingua”; un ulteriore possibile valore, semplificando molto, è quello di normale (per i parlanti colti), statisticamente più diffuso. 1 Possiamo a questo punto definire l’italiano standard come la varietà di lingua, posseduta soprattutto dalle persone colte, che viene assunta, anche implicitamente, come modello da tutti i parlanti e gli scriventi, è prescritta come esemplare nell’insegnamento ed è descritta e disciplinata da dizionari e grammatiche. Per il fatto di avere un notevole prestigio, l’italiano standard è altresì tradizionalmente riservato agli usi scritti più nobili e formali, come quello intellettuale, scientifico, letterario e burocratico. 1.1. ITALIANO DELL ’USO MEDIO O NEOSTANDARD : Il contesto di partenza può essere sintetizzato con le parole di Berruto: Nello sviluppo recente dell’italiano, è indubbio che si sono affermati, o si vanno affermando, o ci sono sintomi che comincino ad affermarsi, come standard costrutti forme e realizzazioni che non erano presentate nel canone ammesso dalle grammatiche e dai manuali, o che, quando vi erano menzionate, lo venivano quali costrutti, forme e realizzazioni del linguaggio popolare o familiare o volgare, oppure regionali, e quindi da 1 Gaetano Berruto, Varietà diamesiche, diastratiche, diafasiche, in Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi, a cura di Alberto A. Sobrero, Roma-Bari, Laterza, 1993, pp. 37-92, qui p. 84. 3 evitare nel ben parlare e scrivere. È a questo insieme di fatti che qui diamo il nome di neostandard. 2 Se le dinamiche indicate da Berruto per inquadrare il processo di mutamento a cui è soggetto l’italiano contemporaneo trovano sostanzialmente d’accordo la maggior parte dei linguisti, una più articolata discussione si nota in merito alla valutazione complessiva del fenomeno e anche al nome da adottare per lo stesso. Francesco Sabatini ad esempio, che per primo ha individuato tale tipologia di variazioni, preferisce la denominazione di «italiano dell’uso medio parlato e scritto» e considera questa nuova varietà come destinata ad «occupare […] il baricentro dell’intero sistema linguistico italiano» (ivi, 175). Vale la pena, prima di passare alla fase descrittiva, ricordare alcune considerazioni dello stesso Sabatini, che aggancia questi fenomeni alla centralità che il parlato ha assunto nello sviluppo dell’italiano contemporaneo: i processi in corso nella situazione linguistica italiana hanno ormai portato alla diffusione e all’accettazione, nell’uso parlato e scritto di media formalità, di un tipo di lingua che si differenzia dallo “standard” ufficiale più che per i tratti propriamente regionali (via via sottoposti anche a conguagli), soprattutto perché è decisamente ricettivo dei tratti generali del parlato. 3 Vediamo ora una serie di fenomeni caratteristici dell’italiano neo-standard o dell’uso medio. L’elenco rappresenta una selezione di tratti desunta incrociando quelli individuati da Sabatini e Berruto: 1. FONOMORFOLOGIA . 1.1. assenza di distinzione e pertanto neutralizzazione dell’opposizione tra vocali aperte e chiuse nei parlanti non toscani; 1.2. assenza di distinzione tra s sorda ([s]) e sonora ([z]) in posizione intervocalica secondo la norma toscana. Nel settentrione la pronuncia è sempre sonora, a Roma e al Sud sempre sorda; 1.3. forte diminusione nell’uso scritto di elisione e troncamento. 2 Gaetano Berruto, Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1987, p. 62. Francesco Sabatini, L’“italiano dell’uso medio”: una realtà tra le varietà linguistiche italiane, in Holtus G.Radtke E. (Hrsg.), Gesprochenes Italienisch in Geschichte und Gegenwart, Narr, Tübingen, pp. 154-84. 3 4 2. MORFOLOGIA E MORFOSINTASSI . 2.1. Ristrutturazione del sistema dei pronomi. In generale è in corso un processo di semplificazione: 2.1.1. Pronomi personali soggetto: uso di lui, lei, loro in luogo di egli, ella, essi/e, ossia con funzioni di soggetto e non solo di complemento oggetto (come invece nello standard). La disponibilità a ricoprire anche le funzioni di soggetto di lui, lei, loro si nota nel parlato (non solo informale), ma anche nell’uso scritto di media formalità. Si tenga presente che l’uso di lui e lei come soggetto era vivo già nel Quattrocento (Bembo, Prose della volgar lingua, III 16, nota questo fatto e lo censura). La sostituzione di egli/ella con lui/lei avviene dunque in un lungo corso del tempo, dopo un periodo di convivenza delle due forme in cui però egli/ella occupa comunque il registro più alto e lui/lei quello più basso. Va considerato inoltre che il sistema si struttura con due opzioni che possono sostituire egli/ella: da un lato lui/lei (pronomi che mantengono pur sempre un valore marcato, di cambiamento del tema rispetto alla frase precedente), dall’altro l’assenza del pronome (o pronome zero: Ø). La scelta è marcata sul piano diafasico, nel senso che lui tonico appare accanto a Ø nel parlato mentre nello scritto di registro alto di solito il soggetto non è esplicitato attraverso il pronome (si ha cioè pronome zero, o si ricorre a perifrasi). Secondo Renzi (2012) dunque «l’introduzione di lui soggetto in it. mod. è stata sì una semplificazione da un lato, in quanto ha eliminato l’opposizione tra forma diretta e obliqua a favore di una sola forma, ma dall’altro ha introdotto una nuova distinzione: quella tra lui e Ø nel pronome soggetto». 2.1.2. Pronomi clitici: uso della forma dativale gli per il femminile le (gli ho dato = ‘ho dato a lei’) e per il plurale loro (gli ho dato = ‘ho dato loro’). 2.1.3. La particella pronominale ci ha ormai sostituito nella lingua parlata vi, che resiste in parte soltanto nello scritto; 2.2. Questioni relative a ci e vi. 2.2.1. Ci: in molti verbi non appare più come un elemento esterno, ma come componente di una unità lessicale nuova (averci, volerci), anche se formalmente mantiene libertà di movimento. Più in generale la particelle ci e ne in unione con altri clitici sono frequenti in verbi pronominali come andarsene, farcela, starsene ecc. Come tutte le forme obbligate ad alta frequenza d’uso, i pronomi 5 clitici in questi casi stanno perdendo il loro valore semantico, si stanno cioè grammaticalizzando: diventano dal punto di vista della funzione delle mere parti di parola, anche se formalmente si comportano ancora come morfemi liberi (nel senso che si dice me ne sto, non *stommene); 2.2.2. Notevole l’uso di ci in unione con il verbo avere, al punto che può essere considerata in tutto e per tutto una unità lessicale distinta (averci, c’ho). Frequentissima nel parlato, una forma come c’ho stenta a entrare nell’uso scritto per difficoltà legate al sistema di trascrizione grafica (resa della c palatale, elisione, la h del verbo motivata da mera convenzione). Le soluzioni possibili sarebbero tre, ma tutte in vario modo insoddisfacenti: c’ho (in italiano c + o, a è pronunciata velare), ciò (viola la morfologia non indicando graficamente i singoli elementi), ci ho (invita a pronunciare la i di ci); 2.3. Sugli interrogativi. 2.3.1. Prevalenza del semplice cosa (in origine settentrionale) in luogo di che cosa nelle interrogative. Il che interrogativo semplice, usato al Sud, a livello panitaliano si è specializzato in diverse formule (“che dire?”, “che fare?”); 2.3.2. Che aggettivo interrogativo prevale su quale (“Che strada bisogna prendere?” anziché “Quale strada bisogna prendere?”); 2.4. Concordanza a senso tra un nome collettivo soggetto e il predicato, coniugato al plurale. Questa concordanza si ha più spesso quando il nome collettivo è seguito da un partitivo costituito da un sostantivo al plurale (es.: “mi sono arrivati un sacco di regali”). Si tratta di una soluzione ritenuta accettabile nel neostandard; 2.5. Sull’uso dei verbi. 2.5.1. Il presente indicativo sta soppiantando quasi completamente, almeno nel parlato e in presenza di determinazioni temporali, il futuro semplice (“domani vado all’università”, “quest’estate vado in Provenza”): è il cosiddetto ‘presente pro futuro’; 2.5.2. Tendenza all’uso esclusivo del passato prossimo come realizzazione del perfetto o passato remoto. Tra i perfetti, la scelta tra passato prossimo e passato remoto è dettata sia dal grado di formalità del testo (cfr. variazione diafasica), sia soprattutto dalla zona di provenienza del parlante (cfr. variazione diatopica). Da parlanti colti settentrionali ad es., il p. remoto è usato solo in contesti di registro alto, mentre nel parlato è pressochè unico l’uso del p. 6 prossimo. La tendenza è destinata a radicalizzarsi, visto soprattutto il prestigio sociale della variante settentrionale. 2.5.3. Frequenza dell’uso modale dell’imperfetto esprimente non fattualità o controfattualità. L’imperfetto indica normalmente l’aspetto durativo, la natura stativa, continuativa dell’azione: ma oltre a quest’uso canonico l’imperfetto ha un possibile uso modale (il modo del verbo segnala l’atteggiamento del locutore, parlante o scrivente, nei confronti del contenuto dell’enunciato: certezza, comando, speranza, possibilità). Da notare che in questi casi il valore temporale dell’imperfetto è sacrificato: non indica più un tempo passato, ma una modalità dell’azione (imponendosi come forte concorrente soprattutto del condizionale): . imperfetto ipotetico: il caso più abituale è il doppio imperfetto per il periodo ipotetico dell’irrealtà (“se venivi prima, riuscivi a entrare”), o anche solo nella protasi (“se venivi prima, saresti riuscito a entrare”) o solo nell’apodosi (“se tu fossi venuto prima, riuscivi a entrare”). È una costruzione in origine tipica dei registri bassi e colloquiali, ma si sta notevolmente diffondendo nella lingua parlata, anche tra parlanti colti; . imperfetto potenziale: esprime una forma di supposizione (“non capisco cos’è successo, doveva essere qui alle 8”); . imperfetto ludico: relativo alla creazione di mondi possibili, come nei giochi dei bambini (“[facciamo che] io ero la principessa e tu il principe azzurro”); . imperfetto di cortesia: molto frequente è l’uso attenuativo dell’imperfetto, teso ad attenuare richieste (“volevo un chilo di mele”) o asserzioni (“volevo discutere con te questo problema”); . Imperfetto epistemico: richiama, in previsione del futuro, presupposti o conoscenze precedenti (“andavano al cinema, ma hanno incontrato Mario”). . Nel discorso indiretto, l’imperfetto è utilizzato spesso per indicare il futuro nel passato (“mi ha detto che veniva” = “mi ha detto che sarebbe venuto”). 2.5.4. Tendenziale calo dell’uso del congiuntivo nelle subordinate. Non tutti gli studiosi sono d’accordo sulla reale portata di questo calo, soprattutto nell’italiano scritto. Nell’italiano parlato invece – nel parlato semiformale – c’è una decisa tendenza a sostituire nelle frasi dipendenti il congiuntivo con 7 l’indicativo. La sostituzione è avvertita come più accettabile nelle frasi in cui viene espressa una certezza (“Sono certo che Giorgio è [sia] arrivato in tempo”), rispetto a quelle dove il congiuntivo segna una marca di eventualità (“Mi sembra che tu stia eludendo la mia domanda” vs “Mi sembra che tu stai eludendo la mia domanda”). La tendenza è maggiore tanto più il parlato è di livello informale, e tanto meno i parlanti sono colti. 2.5.6. Ampia diffusione del si passivante (“di questo si è parlato abbastanza”), utilizzato spesso per la diatesi passiva, la quale del resto è in grande calo. 2.5.7. Tra le forme perifrastiche è particolarmente diffusa ‘stare + gerundio’, che esprime aspetto progressivo (“sto arrivando”, “sto aspettando l’autobus”). Questa struttura è sempre esistita in italiano, ma è oggi fortemente incoraggiata dall’analogia con il presente durativo in -ing dell’inglese (“I’m cooking a fish” = “sto cucinando un pesce”). Si pensi a come “sto arrivando” stia soppiantando una forma come “arrivo”, o “arrivo subito”, un tempo più diffusa. 3. SINTASSI . 3.1. Sintassi del periodo o macrosintassi. Si nota una tendenza alla diminuzione delle subordinate (cioè una tendenza alla paratassi) e l’abbondanza di periodi monoproposizionali, spesso caratterizzati da frasi nominali (senza verbo); 3.2. Alta frequenza nell’italiano parlato del cosiddetto ‘che polivalente’, usato come: 3.2.1. subordinatore generico: il che serve per legare tra loro una reggente e una dipendente nei casi in cui la lingua scritta o comunque più formale farebbe uso di una congiunzione subordinante più specifica. Ess.: “vieni più tardi che ora non posso” (che = perché); “sono arrivato che il treno era appena partito” (che = quando); 3.2.2. sostituto di un pronome relativo (in caso) obliquo: nelle situazioni in cui la lingua più formale farebbe uso di un pronome relativo: “Gianni è uno che ci si può fidare” (che = di cui); “Roma è una città che ci andrei a vivere” (che = in cui), “maledetto il giorno che ti ho incontrato” (che = in cui), “è quello che hai conosciuto sua moglie” (che = di cui). Questi esempi hanno vari gradi di accettabilità (in genere il più accettabile è il che sostituto di in cui con valore temporale), e sono comunque da considerarsi tipici del parlato, e di quella variante scritta che imita, volutamente o no, il parlato (quindi in certi romanzi, o nello scritto semicolto). 8 4. SINTASSI DELLA STRUTTURA INFORMATIVA . Ogni periodo contiente un’informazione. Tuttavia un enunciato non si limita semplicemente a trasmettere un contenuto informativo, bensì organizza questo stesso contenuto, lo adatta in relazione al contesto nel quale è destinato a manifestarsi. Un enunciato: (1) può qualificare una parte del suo contenuto semantico come già “conosciuto” dall’interlocutore, il che può anche essere inteso come “presente all’attenzione dell’interlocutore”, in quanto già nominato nel contesto precedente o perché l’argomentazione in corso gli conferisce una particolare rilievo; (2) può qualificare un’altra parte come elemento informativo nuovo, non apparso in precedenza nel contesto comunicativo. Il modo in cui il contenuto informativo è strutturato (cioè il modo in cui si esprime la ‘struttura informativa’, information structure secondo la terminologia di Halliday) influenza la sintassi (micro- e macrosintassi: l’ordine delle parole e quello delle frasi all’interno del periodo). Le più importanti unità di analisi della struttura informativa sono le coppie (1) ‘dato / nuovo’ e (2) ‘tema (topic) / rema (comment)’. (1) Il dato è tutto ciò che viene dato per già conosciuto (perché è formalmente segnalato come tale, o per influenza del contesto o del cotesto (il contesto discorsivo), mentre il nuovo è ciò che viene dato come non (ancora) identificabile. Es.: “Ho visto un cane [nuovo]. Quel cane [dato] era un beagle”. (2) Il tema (o topic) è ciò di cui “parla” l’enunciato, il rema (o comment) è ciò che viene detto (la predicazione) del tema. È importante ricordare che non sempre il tema coincide con il soggetto grammaticale: dipende dall’ordine in cui l’informazione è presentata. Es. “Giovanni [tema] è andato a Genova [rema]”; “A Genova [tema], Giovanni non ci è andato [rema]”. Sotto questo riguardo l’italiano contemporaneo ha ampliato l’uso di alcuni mezzi di messa in evidenza della struttura informativa, peraltro da sempre esistenti nella lingua parlata. Ossia, con le parole di Berruto, l’italiano contemporaneo evidenzia «l’incipiente standardizzazione di costrutti originariamente marcati e specifici del parlato». Sono da ricordare: - la dislocazione a sinistra. Il tema viene messo in evidenza con la sua collocazione alla sinistra dell’enunciato: “il caffè, l’ho già preso”. Il tema viene marginalizzato a sinistra (pausa intonativa, oppure virgola nello scritto) e, in genere ripreso da un pronome clitico (= 9 atono) nella parte destra dell’enunciato (si parla allora di ripresa pronominale: nel caso citato il clitico lo in “l’ho già preso”); L’effetto di una dislocazione a sinistra è dunque quello di evidenziare ciò che il parlante ritiene centrale nel suo discorso, alterando l’ordine neutro (non marcato) dei costituenti, a beneficio del ricevente. Questa struttura è sempre più frequente nel parlato e dilaga anche nello scritto, specie là dove esso simula l’oralità o vi si vuole avvicinare. La forma più frequente vede dislocato a sinistra l’oggetto (“il libro, non l’ho letto”, “Giorgio, non l’ho visto”) e, se il soggetto grammaticale è di terza plurale, può sostituire una frase al passivo (“la casa, l’hanno venduta”;). In ordine di frequenza, segue la dislocazione del complemento indiretto dativo o genitivo (“di Mario, non ne so più nulla”; “a lei, non le dico più niente”; “a me, nessuno (mi) ha detto niente”); quindi altre espansioni: “A Roma, non ci voglio andare”. Tra i temi dislocati prevalgono quelli emozionalmente più coinvolgenti per il parlante. Alcuni esempi: “a scuola ci andavo poco”; “con lui non ci gioco”; “di difetti ne abbiamo tutti”. - la dislocazione a destra. Il tema viene marginalizzato (intonativamente, o con la virgola nello scritto) a destra dell’enunciato, in genere preceduto da un’anticipazione pronominale per mezzo di un clitico. Es. “l’ho già preso, il caffè”; - tema sospeso (nomativus pendens): è una struttura simile alla dislocazione a sinistra. L’elemento marginalizzato rimane però qui del tutto esterno alla frase, dal punto di vista sia sintattico (non è preceduto da preposizione e quindi manca l’indicazione della sua funzione sintattica) che intonativo (è sempre separato da una pausa, rappresentata nello scritto da una virgola): “Marco, gli è sempre piaciuto il gelato” (= “A Marco è sempre piaciuto il gelato”); “Francesca, non le parlo più” (= “Non parlo più con Francesca”). Questo costrutto viene definito dalla retorica tradizionale anacoluto, ed è ovviamente ristretto al parlato informale, anche se si può incontrare talora in altri contesti, per la sua particolare funzionalità espressiva. In particolare è molto utilizzato nei titoli dei giornali per ragioni di brevità e sintesi: “Sequestro Ilva, si dimette il Cda”, “Telecom, soci divisi sulla rete” («Il Sole 24 ore», 26 maggio 2013); - c’è presentativo. È il periodo con struttura ‘c’è x [tema] che’ (es. “c’è qualcuno che dice no”), in cui il tema viene messo in evidenza (presentato) dal c’è; - frase scissa. Si tratta di una costruzione del tipo È Luca che mi presta la bici, È con Maria che ne ho parlato. È dunque formata da una voce del verbo essere priva di soggetto seguita da un complemento (nominale, preposizionale, avverbiale) e da una subordinata 10 introdotta da che. Rispetto a una frase semplice con ordine lineare dei costituenti (Luca mi presta la bici, Ne ho parlato con Maria) la frase scissa serve a isolare un elemento (Luca, Maria) come focus, ossia come elemento informativamente più importante, quello che contiene l’informazione principale (per identificare il focus di una frase si può inserirla in un contesto di domanda e risposta: Chi mi presta la bici? Con chi ne hai parlato?: spesso, ma non sempre, coincide con il nuovo e con il rema). Stessa funzione hanno anche frasi implicite come È stato Fabio a chiedermelo, in cui la subordinata è una infinitiva introdotta da a (frasi scisse implicite). 2. IL LESSICO DELL ’ITALIANO CONTEMPORANEO 2.1. OSSERVAZIONI GENERALI Il lessico è la componente della lingua che attira maggiormente l’interesse del non linguista, ed è anche quella la cui evoluzione è più legata al contesto sociale. Il lessico cambia con la società, attraverso essa e a fianco di essa. Il lessico italiano ha una storia di grande stabilità, che dipende certamente dalla scarsità dell’uso parlato fino al XX secolo. La continuità del lessico italiano può essere testimoniata dai dati di vocabolari che riportino le date della – probabile – prima attestazione di un lemma. Dai quali dati si ricava ad es. che in un vocabolario di circa 140000 lemmi oltre 5000 parole sono già attestate nel Duecento, quasi 14000 nel Trecento e altrettanti in seguito solo nell’Ottocento; per superare questa quota occorre attendere il Novecento, dove si registrano più di 30000 nuove attestazioni. E la stabilità del lessico è ancora più vistosa se si considera il lessico di base, ovvero le parole a più alta frequenza nella lingua standard: ben il 21% dei lessemi è già attestato nel Duecento, il 31,5 nel Trecento (quindi più del 50% entro il XIV secolo) e gli stessi valori percentuali dell’Ottocento presenta anche il Cinquecento (10%), mentre il Novecento partecipa col solo 9%. Un risultato analogo, anche più retrodatante, si ottiene osservando i dati del GRADIT [= Grande Dizionario della lingua italiana, ideato e diretto da T. De Mauro, Torino, Utet, 1999, 6 voll.]: “le parole del vocabolario fondamentale di una lingua [i duemila vocaboli più frequenti nella lingua standard] occupano, in media, il 92 o 93% di tutte le parole che figurano nei testi e discorsi”, osserva De Mauro nella postfazione all’opera. Ebbene – nota De Mauro –, “quando Dante comincia a scrivere la Commedia il vocabolario fondamentale è già costituito al 60%. La Commedia lo fa proprio, lo integra e col suo sigillo lo trasmette nei secoli fino a noi. Alla fine del Trecento il vocabolario fondamentale è configurato e completo al 90%”. Anche una scelta di lessico un po’ più 11 ampia, il vocabolario di alto uso (che unito al vocabolario fondamentale, copre il 97-99% delle occorrenze lessicali in testi e discorsi in lingua italiana) ha origine per l’86% entro la fine del Trecento. Il lessico di una lingua, e dell’italiano come delle altre, si compone di: 1) lessemi patrimoniali, appartenenti a una lingua fin dalla sua origine; 2) lessemi esogeni, provenienti da altre lingue; 3) neoformazioni endogene, cioè lessemi che si creano a partire dalle basi fornite dai due primi gruppi attraverso i normali procedimenti di formazione delle parole. Il latino è alla base della larghissima parte del lessico patrimoniale, ma interviene anche come principale fonte esogena attraverso i passaggi definiti come esiti “dotti”, cioè ripescati direttamente dal latino senza la mediazione delle trasformazioni fonomorfologiche volgari. Tenendo conto che, ovviamente, l’italiano è il maggior fornitore di sé stesso (il 65% circa del patrimonio lessicale nasce da neoformazioni endogene), il latino viene subito dopo: i lessemi di origine latina – secondo il GRADIT – costituiscono il 14% circa del totale, ma ben il 52,2% se si prende in considerazione il solo vocabolario di base. La maggior parte di latinismi entrano in italiano nei primi secoli, e particolarmente nel Duecento e nel Quattrocento. Parecchi lessemi di origine latina entrano anche nei secoli XIX e XX, ma si tratta ormai quasi solamente di tecnicismi del latino scientifico, quello delle classificazioni tassonomiche. La lingua esterna che maggiormente alimenta l’italiano, dopo il latino, è senz’altro il greco antico. Un primo lotto di lessemi di origine greca entra nel latino classico, fonomorfologicamente adattato, e di lì passa in italiano. Altri lessemi greci compiono lo stesso percorso, ma conservando una forma più vicina all’origine greca, il che li rende maggiormente distinguibili (ad es. filosofia e filologia, che non a caso conservano l’accento sulla penultima come in greco, di contro ai lat. philosòphia e philològia). Un terzo strato di grecismi sono quelli passati in italiano senza un’attestazione latina classica o anche tarda (es. cosmo da κόσµος). La maggior parte dei grecismi dell’attuale lessico italiano, peraltro, è entrata soltanto nei secoli XIX e XX, attraverso il canale della terminologia tecnicoscientifica, fondata – fin dal Settecento – su neoconiazioni di base greca. Le lingue che hanno dato all’italiano almeno una cinquantina di lessemi di uso non peregrino (ci si riferisce ai lemmi registrati nel GRADIT: tra parentesi si inserisce il numero di lemmi per ogni lingua di origine che questo vocabolario accoglie) sono, in ordine decrescente: 12 • greco (8354); • giapponese (212); • inglese (6292); • portoghese (208); • francese (4944); • turco (172); • spagnolo (1055); • longobardo (114); • tedesco (648); • ebraico (113); • arabo (633); • sanscrito (92); • provenzale (240); • hindi (79); • russo (234); • cinese (62). Come è evidente, nessuna altra lingua – fatta eccezione per il caso particolare del greco antico – è paragonabile all’inglese (fornitore massimo nel XX secolo) e al francese (influentissimo nel Settecento, e poi anche nell’Ottocento) nel fornire apporti lessicali alla lingua italiana. Anche lo spagnolo, che pure ha fatto entrare nell’italiano parecchi lessemi nel Cinquecento e soprattutto nel Seicento, ha immesso una quantità di lessemi di oltre quattro volte inferiore rispetto al francese. In linea generale è da notare che molti forestierismi, o lessemi di origine straniera, sono riconducibili alla terminologia tecnico-scientifica, ciò che testimonia la prevalenza dei canali specialistici nel promuovere gli apporti esogeni. 2.2. I PRESTITI Importare parole nuove da altre lingue è una delle componenti di permanente innovazione di una lingua. Quando un lessema non fa parte del lessico patrimoniale ed è desunto da una lingua straniera si ha un prestito linguistico. Il prestito, valutato soprattutto come fenomeno di influsso lessicale, è strettamente connesso a fattori extralinguistici come i rapporti culturali fra le diversi paesi, gli scambi economici e commerciali, i viaggi e le scoperte. L’entità degli scambi fra le lingue è ovviamente influenzata da fattori geografici: due entità nazionali confinanti sono generalmente costrette a un certo grado di bilinguismo, almeno nelle zone di frontiere (si veda il caso della vicinanza geografica della Francia, che ha stimolato un afflusso costante nel tempo di gallicismi, favorito anche dal fatto che l’italiano e il francese sono strettamente imparentati per genesi e per storia). Tuttavia l’apporto lessicale di una lingua estera non è direttamente proporzionale alla vicinanza territoriale: lingue lontanissime ma di grande 13 rilevanza culturale come il cinese e il giapponese hanno portato più lessemi in italiano delle vicine lingue slave. Di particolare interesse è lo scambio fra lingue interferenti che avviene per via culturale, quando alla diffusione dei prodotti di una civiltà straniera consegue l’ingresso, nella lingua ricevente, di materiale lessicale allogeno. Generalmente, i rapporti di tipo culturale non hanno luogo su di un piano di parità poiché le lingue di maggior prestigio influenzano in modo più profondo quelle dotate di minor forza di espansione. Tra Sette e Ottocento, attraverso i contatti con i paesi colti d’Europa, l’italiano accoglie un numero altissimo di termini forestieri. Il grande rinnovamento che in questo periodo si manifesta nelle industrie, nei commerci, nei sistemi politici imprime un carattere sovranazionale alla circolazione delle terminologie speciali. L’egemonia culturale del paese dove è parlata fa insomma di una lingua il maggiore fornitore lessicale dei paesi geograficamente vicini, o tali in virtù delle reti di informazione. In italiano, come si è detto, nel Sette-Ottocento il maggior esportatore è stato il francese. Negli ultimi cinquant’anni del Novecento l’inglese ha sostituito il francese come lingua straniera più conosciuta e più influente in Italia, come nel resto del mondo occidentale; questo mutamento (che ha subito un’accelerazione a partire dagli anni Settanta) è comune ad altri paesi europei e dipende dall’affermarsi degli Stati Uniti come paese dominante dell’economia e della politica a livello mondiale. Nel Novecento, dunque, i prestiti vengono all’italiano principalmente dai paesi di lingua anglosassone che detengono la supremazia economica, tecnica e scientifica. I prestiti si possono distinguere per motivazione e per forma: a) per motivazione 1) prestito di necessità 2) prestito di lusso b) per forma 1) prestito non adattato (o prestito integrale) 2) prestito adattato Dal punto di vista della motivazione, i prestiti, secondo una distinzione ormai invalsa benché discutibile, si possono dividere in prestiti di necessità e prestiti di lusso. I prestiti di necessità riguardano quei lessemi stranieri che designerebbero concetti e oggetti sconosciuti alla lingua ricevente: in altre parole si acquisisce il lessema unitamente al suo referente. Si pensi a patata, parola haitiana giunta in italiano attraverso lo spagnolo 14 insieme al tubero che designa; caffè, dal turco; zero, dall’arabo; tram (da tramway), juke-box dall’inglese. I prestiti di lusso riguardano invece quei lessemi stranieri che incontrano nella lingua ricevente un termine semanticamente coesteso o almeno sinonimico. Il prestito di lusso può avere un fine espressivo-stilistico, oppure di promozione sociale, evocando una civiltà o cultura o modo di vita considerati prestigiosi; sono considerati prestiti di lusso ad esempio: leader, baby-sitter, weekend, lessemi sostituibili con capo, bambinaia, fine settimana. È vero che questa distinzione ha il merito di mettere in rilievo la centralità dei criteri extralinguistici per il trattamento dei prestiti, ma certamente pecca di semplicismo. In assoluto la necessità di un prestito non esiste, perché ogni lingua possiede i mezzi – formazione di composti, perifrasi, neologismi – per indicare i nuovi oggetti o concetti, senza ricorrere ai forestierismi. D’altra parte è evidente che l’uso di parole straniere risponde a qualche esigenza dell’emittente, sociale o stilistica che sia. Pertanto si può parlare di inutilità dei prestiti di lusso solo a un mero livello lessicale, poiché, nella prospettiva del parlante, il prestito di lusso è connotato da marche semantiche che sono assenti nella equivalente parola italiana. L’uso prevalente nella lingua standard del prestito linguistico sarà in primo luogo determinato dalla riconoscibilità sociale: in altre parole dalla moda, in evidente relazione con il prestigio che i parlanti attribuiscono alla civiltà e alla cultura espresse dalla lingua straniera. A un livello più conscio, il forestierismo può anche essere usato come testimonianza di appartenenza a un determinato gruppo sociale di cui si conosce e usa il codice distintivo, tagliando fuori e “impressionando” chi questo codice non possiede: si pensi al lettore semicolto che incontra sul quotidiano tecnicismi come governance, fiscal drag, spoils-system. Dal punto di vista della forma, i prestiti si distinguono in base al processo di adattamento che la forma ha subìto ad opera della lingua che la acquisisce: si discorre in questi casi di prestito adattato. Il processo di adattamento può interessare: − il piano fonomorfologico, come in bistecca (dall’ingl. beef-steak) e treno (ingl. train); − il piano fonetico, come in camion (fr. camion, ma con accento sulla sillaba finale) e computer (ingl. computer, ma pronunciato /kɘm’pju:tɘr/); − il piano puramente grafico, come in gol (ingl. goal) e sciampo (ingl. shampoo). Quando non si verifica processo di adattamento, come è oramai prevalente nell’italiano di oggi, il prestito è detto integrale o non adattato: si pensi alle tante voci pertinenti all’impiego 15 dei nuovi mezzi di comunicazione elettronici, da chat a mail, da mouse a webcam, e via dicendo. 2.3. I CALCHI Il calco è un neologismo formato con materiale italiano sul modello straniero: in altri termini, un lessema straniero viene tradotto con lessemi già disponibili nella lingua ricevente. Dal momento che non riproduce il significante, il fenomeno di interferenza linguistica risulta in genere meno facilmente avvertibile. Vediamone alcune tipologie: Calco semantico Il calco semantico o di significato comporta un mutamento della funzione semantica di un lessema preesistente sulla base della semantica di un lessema appartentente alla lingua presa a modello. Il calco semantico presuppone che siano soddisfatte alcune condizioni: 1) che il significato del lessema straniero sia articolato in tratti semantici che trovano una corrispondenza solo parziale in un lessema della propria lingua; 2) che nella propria lingua sia individuato un lessema preesistente il cui significato coincida con uno dei tratti semantici del lessema straniero; 3) che venga compreso il rapporto di motivazione tra i vari tratti semantici del lessema straniero e interpretato come significato fondamentale quello condiviso dai due lessemi, come significati secondari le accezioni che non trovano riscontro nel lessema della propria lingua. Il calco semantico consiste quindi nel fare combaciare nel modo più ampio possibile le funzioni semantiche delle due parole (quella della lingua straniera e quella della propria), fra le quali viene istituito un rapporto basato sulla esclusiva comunanza di tratti semantici. In tal modo viene colmata la divergenza semantica avvertita frai due termini. Esempi: - ingl. hawk ‘falco’ e nelle controversie internazionali ‘sostenitore di una linea politica drastica e intransigente’; it. falco (GRADIT: 1966). Il lessema italiano amplia il suo spettro semantico fino ad acquisire il tratto metaforico. Oggi la voce è diffusa nel lessico giornalistico, spesso associata al suo antonimo colomba (falchi e colombe; cfr. hawks and doves); - ingl. to pay ‘essere vantaggioso, utile’; it. pagare (“il crimine non paga”); 16 - ingl. to save ‘registrare nella memoria centrale di un computer o su altro supporto i dati, archiviare i dati’; it. salvare (“hai salvato il file della tesi?”). Calco strutturale Consiste nella riproduzione di un modello straniero dal punto di vista tanto del significato quanto della struttura; si attua utilizzando materiale linguistico preesistente nella lingua imitante, ma comporta di fatto la formazione di un neologismo, eminentemente per via di composizione. Anche in questo caso occorre sia compresa a fondo la motivazione formale e semantica del modello straniero, e dunque il rapporto semantico fra i costituenti dell’unità lessicale. Esempi: - ingl. skyscraper; it. grattacielo. Si notino la perfetta riproduzione della struttura composizionale e del significato ma l’imperfetta riproduzione dell’ordine fra costituenti, in quanto il calco rispetta il normale ordine delle parole vigente in italiano (grattacielo come lavavetri e tanti altri composti V+N: vd. il tipo al § 2.5); - ingl. flatfoot; it. piedipiatti ‘poliziotto’. Il calco strutturale è imperfetto come il precedente; - ingl. outlaw; it. fuorilegge. Il calco è strutturalmente perfetto. Si danno poi vari casi di calchi strutturali formati da prefissoide (vd. sotto al § 2.4) più sostantivo, ancora per spinta di modelli angloamericani che sfruttano elementi compositivi di antica matrice classica. Esempi: - ingl. selfdetermination; it. autodeterminazione ‘capacità che popolazioni sufficientemente definite etnicamente e culturalmente hanno di disporre di sé stesse; diritto che un popolo di uno Stato ha di scegliersi la forma di governo’. Il termine si diffonde con il celebre discorso dei “quattordici punti” del presidente statunitense Wilson nel 1918; - ingl. selfsufficient; it. autosufficiente; - ingl. selfgovernment; it. autogoverno. 17 Calco sintagmatico È un particolare tipo di calco strutturale che interessa non singoli lessemi composti ma sintagmi. In genere i sintagmi angloamericani mutuati dall’italiano sono costituiti da due elementi: 1) aggettivo e sostantivo (secondo l’ordine dei costituenti in inglese); 2) sostantivo + sostantivo, e si parla in tal caso di giustapposizione di sostantivi (in inglese secondo l’ordine determinante + determinato, dove il determinante funge da modificatore del determinato alla stessa stregua di un aggettivo). L’ordine delle parole italiano condiziona spesso la resa del calco, che presceglie l’ordine sostantivo + aggettivo o determinato + determinante, con l’esito di calchi sintagmatici imperfetti; talora si osserva l’inserzione di una preposizione (determinato + sintagma preposizionale). Esempi del tipo aggettivo + sostantivo: - ingl. fiscal drag; it. drenaggio fiscale ‘incremento del prelievo fiscale imputabile alla crescita artificiosa dei redditi monetari dovuta all’inflazione’. È un calco sintagmatico imperfetto non solo nell’ordine dei costituenti ma anche dal punto di vista semantico, dal momento che drag significa ‘traino, trascinamento’ e non ‘drenaggio’; ma ciò si dovrà ad influsso del significante ( DRenaggio – DRag), o forse a confusione con l’ingl. drain ‘drenaggio’; - ingl. underground economy; it. economia sommersa. Di qui in italiano l’estrapolazione dell’agg. sommerso, usato anche al di fuori del lessico economico, e della sostantivazione il sommerso ‘insieme di beni o attività non dichiarati al fisco’; - ingl. new frontier; it. nuova frontiera. Calco perfetto dello slogan usato da John Kennedy nelle elezioni presidenziali del 1960 per indicare un ampio programma di riforme sociali. Esempi del tipo sostantivo + sostantivo: - ingl. data base, data bank; it. base dati, banca dati. Si badi che è invece un prestito data base, con pronuncia adattata o meno; - ingl. press conference, press room; it. conferenza stampa, sala stampa; - ingl. shadow cabinet; it. governo ombra ‘membri dell’opposizione che svolgono compiti paralleli a quelli del governo ufficiale’, tipica istituzione anglosassone connessa alla tradizionale alternanza al governo di partito laburista e partito conservatore. In italiano si è verificata l’estrapolazione del lessema ombra (ministro ombra, giunta ombra, finanziaria ombra); Esempi con nesso preposizionale: 18 - ingl. count down; it. conto alla rovescia. Il calco è imperfetto non solo per l’introduzione della preposizione ma anche per l’imprecisa rispondenza semantica fra down e alla rovescia; - ingl. brain drain; it. fuga di cervelli. Con divergenza semantica: drain ‘prosciugamento, esaurimento’ non corrisponde a fuga. Calco sintematico Il sintema è una combinazione di lessemi nel quale i costituenti, “pur essendo in altro contesto autosemantici, diventano sinsemantici, perdono cioè la loro autonomia di significato” (Gusmani), acquistando dunque un unico significato complessivo, non analizzabile nei suoi componenti lessicali. Esempi: - ingl. cold war; it. guerra fredda ‘stato di acuta tensione fra due Stati senza scontri militari’ (il sintagma non è analizzabile dal punto di vista semantico: non è una guerra; non è fredda); - ingl. honey moon; it. luna di miele, con nesso preposizionale (non è una luna; non è di miele). Calco parziale È detto anche calco prestito. Si tratta di un calco sintagmatico nel quale uno dei costituenti non viene ricalcato ma acquisito attraverso prestito. Esempi: - ingl. brain trust; it. trust di cervelli. È diffuso però anche il prestito integrale brain trust; - ingl. generation gap; it. gap generazionale; il sintagma sostantivo + sostantivo è reso attraverso quello sostantivo + aggettivo. Prestito camuffato Affine per procedimento al calco semantico, il prestito camuffato è un calco solo in apparenza. Un tratto semantico di un lessema straniero viene acquisito a un lessema della propria lingua esclusivamente sulla base di una marcata assonanza formale fra i due (che spesso è l’effetto di una comune etimologia), prescindendo totalmente dall’eventuale esistenza di tratti semantici in comune. Non è sempre facile distinguere quando si sia in 19 presenza di un prestito camuffato e non già di un calco semantico, e ci sono casi che si collocano per dir così al confine fra l’una categoria e l’altra. Fra i criteri dirimenti per individuare un prestito camuffato si annoverano: 1) la discontinuità fra il significato originario del termine indigeno preesistente e il significato del neologismo (vd. sotto gli ess. di realizzare, suggestione); 2) l’appartenenza del termine straniero a lessici specifici ossia a lingue speciali (vd. sotto gli ess. di scenario, severo); 3) la simultanea adozione sotto forma di prestito non adattato, a dimostrazione del fatto che nel momento in cui si è verificata l’interferenza della lingua straniera il parlante non ha stabilito relazioni dirette con il termine preesistente (vd. sotto l’es. di casual). Esempi: - ingl. to realize; it. realizzare ‘rendersi conto, comprendere’ e non ‘portare a compimento’; - ingl. suggestion; it. suggestione ‘suggerimento’; - ingl. severe; it. severo ‘importante, preoccupante’, detto spec. di patologie nel lessico della medicina; - ingl. casual; it. casuale ‘disinvolto, informale’, detto spec. di abbigliamento. 2.4. I PROCESSI DI NEOFORMAZIONE : LA DERIVAZIONE Le neoformazioni si producono essenzialmente attraverso procedure di derivazione e di composizione. La derivazione è la formazione di una parola nuova che avviene attraverso la modifica di una base mediante un affisso, privo di autonomia a livello lessicale. La derivazione mediante affisso può risultare da suffissazione, da prefissazione, o dalla concomitanza di entrambe le procedure (si parla in tal caso di forme parasintetiche come disboscare da bosco o immangiabile da mangiare). La derivazione può dare origine a parole di uguale categoria lessicale – come obbligatoriamente nel caso dei prefissi – o diversa da quella della base di partenza (verbo → verbo: fare → rifare; sostantivo → aggettivo: polvere → polveroso). Quando la parola derivata di classe diversa è ottenuta senza bisogno di affisso si danno i casi di derivazione a suffisso zero (indennizzo, inoltro, collaudo dai rispettivi verbi) e quelli di conversione ossia cambio di categoria lessicale di un lessema: si pensi all’uso sostantivale o aggettivale del participio passato (l’accaduto, il fatto) e presente (il paziente) e all’uso sostantivato di verbi (ammontare, avere); si hanno anche aggettivi sostantivati attraverso l’articolo (un povero, gli 20 antichi); nomi da aggettivi con ellissi (la finanziaria, dal sintagma legge finanziaria; e così vale per arenaria, atomica, raccomandata). La composizione, che sarà oggetto del § 2.5, è invece l’unione di elementi lessicali autonomi. Si noti però che la neoformazione composta può essere costituita non solo da lessemi patrimoniali (attaccabottoni, portafinestra) ma anche da uno o entrambi i lessemi di origine latino-greca (telecomando, citofono). Questo particolare tipo di composizione, che adopera semiparole di origine greca o latina o anche forme italiane contratte (come elettro, da elettrico), è – per così dire – a metà strada tra la composizione e la derivazione: si parla pertanto a questo proposito non di prefissi e suffissi, ma di primi e secondi elementi di composizione o di prefissoidi e suffissoidi o anche forme semilibere o semiparole: per questa ragione il fenomeno verrà trattato nel presente paragrafo dedicato alla derivazione. Gran parte dei lemmi di un dizionario sono costituiti da lessemi derivati. In un dizionario di medie dimensioni (circa 140000 lemmi), ad esempio, sono circa 40000 a essere frutto di derivazione. Di questi, 30000 circa sono derivati per suffissazione (nell’ordine: sostantivi, aggettivi e verbi): la maggior parte (ben oltre un terzo) originatisi nel XX secolo, quasi due terzi tra il XIX e il XX secolo. I derivati per prefissazione, sono circa un decimo (4000); i più frequenti, in ordine decrescente, i derivati con ri-, in-, di- dis- de-, s-, a-; quelli con inparticolarmente attivi nel XVII e XVIII secolo e quindi anche nell’Ottocento e Novecento. I composti, per lo più sostantivi, si sono affermati con grande frequenza nel Novecento (circa il 60% del totale dei composti). Il più produttivo meccanismo di formazione di parole nuove nel XX secolo è certamente la suffissazione. Risulta che il 50% dei neologismi novecenteschi siano nati attraverso il processo della derivazione tramite suffisso (pulsionale 1968; programmazione 1931, privatizzare e privatizzazione 1963; la data della prima attestazione è quella fornita dal DISC [Dizionario italiano Sabatini Coletti, Firenze, Giunti, 1998 e succ. rist.]), magari anche con presenza contemporanea di prefisso (defibrillatore 1987); il 9,5% tramite prefisso (preriscaldamento 1968; prefabbricato 1942); il 17 % attraverso composizione di elementi latino-greci (gastroscopia 1960; omosessuale 1908; paramedico 1978; citofono 1942, stereofonia 1942); il 7% da composizione di lessemi nativi (portamonete 1958, paraurti 1941; lavastoviglie 1942). 21 Se si considerano gli stessi dati in diacronia (dal 1908 al 1989) si può notare: sostanziale stabilità della suffissazione, decrescita dei composti neoclassici, raddoppiamento della prefissazione, stabilità (con tendenza all’aumento) dei composti nativi, crescita forte dei composti con prefissoide (es.: multiproprietà 1978), e delle conversioni (un espresso, direttissima 1905, 740, cellulare nell’accezione di apparecchio telefonico radiomobile, 1990). Si veda una rassegna dei principali suffissi: -aro: palazzinaro 1966, paninaro 1981, panchinaro, metallaro; -ismo: liberismo, fascismo, garantismo 1925, abusivismo 1942, consumismo 1964, decisionismo 1972, pendolarismo 1975, celodurismo anni ’90, dal famigerato motto bossiano; -ista: basista, buonista, difensivista, forzista, migliorista ecc.; per i nomina agentis (chi fa qualcosa per caso abitudine, mestiere) è il suffisso più produttivo, mentre sono invece in regresso i suffissi in -aio (benzinaio, fornaio), relegato a mestieri pretecnologici e oggi insidiato dal concorrente -aro (vd. sopra) perlopiù di valore ironico, -aiolo (festaiolo) e -iere (bancarottiere); -tore, -trice: urlatore, parcheggiatore, posteggiatore, agopuntore, climatizzatore 1990, lavatrice 1932; -istica: anglistica, componentistica, insiemistica, italianistica, oggettistica, tempistica; -zione: delegittimazione, indicizzazione, informatizzazione 1981, lottizzazione, masterizzazione, ottimizzazione, parcellizzazione, cartolarizzazione (di recente diffusione, in dipendenza da un provvedimento della legge finanziaria del 2002); -ità: abitabilità 1881, affidabilità, fallosità, invivibilità, sportività; -aggio: depistaggio, monitoraggio, sciacallaggio, volantinaggio; -oso: caramelloso, sballoso; il suffisso ha avuto una certa diffusione nel linguaggio pubblicitario degli anni ’80-’90, ma ora sembra meno attivo; -ale: decisionale, occupazionale, promozionale, manageriale, digitale 1963; -ese: politichese, sinistrese 1976, sindacalese 1977, burocratese; -izzare: criminalizzare, digitalizzare, inizializzare, sponsorizzare, strumentalizzare; la fortuna di questo suffisso si inscrive nella più generale produttività dei verbi della prima coniugazione che dà una grande quantità di denominali (cioè forme che derivano da basi nominali) semplici come crossare, commissariare, formattare, implementare, movimentare, spintonare, testare (spesso da basi forestiere). La frequenza di -izzare è 22 dovuta all’influenza del francese (centralizzare, concretizzare) e dell’inglese (inizializzare, ottimizzare) e più in generale alla sua duttilità: è applicabile a basi di almeno tre sillabe, sostantivi in -ìa (etimologizzare, sodomizzare), -esi e -isi (ipotizzare, psicanalizzare), nomi propri (berlusconizzare), sigle (irizzare), forestierismi (containerizzare) e composti (cattocomunistizzare); è particolarmente attivo in ambito parascientifico coi tipi impermeabilizzare, informatizzare ecc. e nelle neoformazioni scientifiche sostituisce il suffisso tradizionale -eggiare; -ificare: ratificare, rettificare, fortificare; si applica a basi più brevi, nomi concreti (acetificare, pietrificare) e aggettivi (specie in -ido: acidificare, fluidificare, umidificare). È bene ricordare qui che le lingue speciali danno valori specifici ai suffissi. 1) Medicina: -ite (infiammazione acuta): appendicite, otite, nevrite; -osi (infiammazione – o, più in generale, patologia – cronica): foruncolosi, artrosi; -oma (tumore): adenoma, carcinoma, epitelioma. 2) Botanica e zoologia: -idi (famiglia animale): mustelidi, canidi; -acee (famiglia vegetale): liliacee, rosacee; -ali (ordine di piante): rosali, parietali. 3) Chimica: -oso (valenza minima): solforoso; -ico (valenza maggiore): solforico; -ano (idrocarburo saturo): metano, propano; -uro (idracido + base): cloruro. 4) Fisica: -anza, -enza: induttanza, reattanza, luminanza, risonanza, portanza, impedenza, luminescenza, turbolenza, coibenza. Una particolare forma di derivazione è l’alterazione, che mediante suffisso (o infisso, nel caso dei verbi) modifica una base senza variarne la categoria grammaticale, mutando il suo significato non nella sostanza ma solo per alcuni aspetti particolari come la quantità, la qualità o il giudizio del parlante nei confronti del referente (fuoco → fuocherello, pazzo → pazzerello, carattere → caratteraccio, pullman → pulmino). L’alterazione è una componente non secondaria nella formazione delle parole, perché gli alterati non sempre conservano il significato della base appena modificato, ma spesso danno vita a un nuovo lessema semanticamente autonomo: si pensi a lavoretto, posticino, attimino, stuzzichino, pensierino, leggiucchiare, ridacchiare, donnetta, donnaccia, o a casi di lessemi alterati che, specializzandosi in un nuovo significato, hanno perso qualunque valore diminutivo (patentino, fustino, pendolino, pennarello, panino, tramezzino, cassonetto, telefonino), 23 accrescitivo (tormentone, cazzone, ribaltone), o peggiorativo (battutaccia, figuraccia, bonazza). Passando alla prefissazione, si dovrà subito registrare come essa sia una procedura antichissima dell’italiano, per quanto la modifica di una base mediante prefisso sia nella lingua di oggi più frequente che in quella di ieri: ad s. rianimazione 1959, ricircolo 1991, riciclaggio 1971, diseconomico 1983, disinquinare 1983, sdemanializzare 1991, scongelare 1983. I prefissi più diffusi sono senza dubbio s- e ri-, seguiti da in- locativo e in- negativo, da aproveniente dal lat. AD, da dis- e a- negativo. Si vedano alcuni prefissi di origine latina: extra-: uterino, parlamentare, lusso (agg.), comunitario 1980; inter-: city, facoltà, stellare, classista; post-: operatorio 1954, moderno 1980, comunista 1989, laurea (agg.); pre-: pagato, pensionamento 1981, allarme, lavaggio 1964, scolare, fabbricato 1942; super-: accessoriato, attico, ego, bollo, dotato, nova 1960, potenza 1954; trans-: nazionale 1979, sessuale 1972. Altri prefissi diffusi sono di origine greca come: anti- (gr. antì ‘contro’): comunista, parassitario 1941, congelante, trust, polio 1963, fascista 1920. Ma anti- può anche derivare dal lat. ANTE : anticamera; iper-: ipermercato, iperattività. E anche: ana-, meta-, para-, peri-, ecc. Meno frequenti i casi di preposizione italiana patrimoniale come prefisso: contro-: proposta, informazione 1970, figura 1942, mano 1950, piede 1942; dopo- : partita, barba 1959 (anche agg.), lavoro 1925, sole (anche agg.); oltre-: oceano 1912, tomba, cortina; sotto-: sottoprefetto, sottofondo 1950, sottoimpiegato. A metà strada tra derivazione e composizione sta tutta una serie di lessemi in cui uno dei due elementi non è una semplice parola grammaticale, ma neppure un lessema 24 semanticamente autonomo. Si tratta di forme semilibere, per le quali, come si è detto, è invalsa la denominazione di prefissoidi e suffissoidi coniata da Bruno Migliorini: è una denominazione che gode ancor oggi di una certa fortuna e che anche qui per comodità si adotta. Va tuttavia ricordato che si tratta di una nozione molto problematica, data la labilità del confine che spesso si constata fra derivazione (e in particolare prefissazione) e composizione (cfr. gli ess. 18 e 20 della TAB. 2 di Scalise riportata al § 2.5). I prefissoidi sono in genere di origine classica e specialmente greca. Ecco una lista: aero- (gr.): linea, mobile, plano, porto; audio- (lat.): libro, visivo; auto- (gr.): certificazione, controllo, mobile, sufficiente; ma anche auto- da automobile: botte, radio, scuola, stop, strada, trasporto, treno; bio- (gr.): degradabile, ingegneria, tecnologie; cardio- (gr.): chirurgia, logia, patia; eco- (gr.): sistema, logia; ma anche eco- da ecologia: catastrofe, tassa; e pure ecodal lat. echo coniato sul gr. echó ‘suono’: grafia, cardiogramma; etero- (gr.): sessuale; fono- (gr.): assorbente, riproduttore (anche come secondo elemento: telefono, citofono); foto- (gr.): cellula, sintesi; ma anche foto- da fotografia: composizione, genico, montaggio, romanzo, tessera; geo- (gr.): linguistica, politica; idro- (gr.): massaggio, via, volante; macro- (gr.): biotico, economia, molecola, testo; maxi- (lat.): stangata; mega- (gr.): contratto, fono; micro- (gr.): processore; mini- (lat. via ingl.): condono, gonna; mono- (gr.): blocco, camera, colore; moto-: carro, compressore, furgone, peschereccio, scafo,; ma anche moto- da motocicletta: cross, raduno; multi- (lat.): proprietà, sala, razziale; narco- (gr. via ingl.): traffico; neo- (gr.): centrista, fascista; 25 pluri- (lat.): inquisito, linguismo; poli- (gr.): sportiva, valente; psico- (gr.): analisi, dramma, farmaco; radio- (lat.): amatore, mobile, segnale, trasmissione; ma anche da radio (apparecchio e trasmissioni): ascoltatore, cronaca, dramma, giornale, sveglia; tecno- (gr.): crate; tele- (gr.): comando, guidare, visione; ma anche tele- da televisione: dipendenti, schermo, utente; termo- (gr.): isolante, reattore; video- (lat.): cassetta, citofono, gioco, registratore, scrittura. È interessante notare la compresenza e diversità di valore di alcuni prefissi o prefissoidi dotti (greci e latini) semanticamente equivalenti a quelli patrimoniali. Spesso si ha l’intera serie a tre (greco, latino e italiano): ad es. trans- (alpino) e dia- (stratico, topico, sistema); sopra- (coperta, tassa), super- (sonico, strada) e iper- (teso, sensibile) o epi- (cardio); extra(parlamentare), fuori- (bordo, campo, classe), ecto- (ectoplasma) o eso- (esocarpo), nonché ultra- (violenza); intra- (introspettivo, entrobordo) ed endo- (endogeno, endovena); oltre(mare), ultra- (suono, moderno) e meta- (fisica, tarso, linguaggio); sotto- (passaggio, scrizione, occupazione, suolo), sub- (appalto, affitto), ipo- (tensione) o infra- (struttura, rosso); mezzo- (busto, mezzaluna), semi- (lavorato, vocale) e emi- (emiparesi. emicrania); bene- (benpensante) e eu- (ritmico); male- (maldicente) e caco- (fonia); contro(controffensiva, controproposta) e anti- (carro, anticomunista). Anche i suffissoidi sono per lo più di origine greca, e talvolta latina. Si veda questo breve elenco: -ficio (lat.): esami, pasti; -mania (gr.): tele, calcio; -metro (gr.): baro, tassa; -teca (gr.): cine, video; -crazìa (gr.): merito, partito; -filia (gr.): anglo, biblio; -fobia (gr.): claustro; -fono (gr.): cito, micro; 26 -grafia (gr.): cardio, eco; -logìa (gr.): bio, psico, cardio; -logo (gr.): massmediologo, tuttologo; -scopia (gr.): colon, gastro. 2.5. I PROCESSI DI NEOFORMAZIONE : LA COMPOSIZIONE Mentre nella derivazione si ha la concatenazione di una forma libera e di una forma legata, cioè priva di autonomo valore lessicale (sono i prefissi e i suffissi), nel processo di composizione si ha la concatenazione di due forme libere. Ecco alcuni esempi di composizione: TAB . 1 Parola1 Parola2 Composto campo N santo A → camposanto N alto A piano N → altopiano N lava V piatti N → lavapiatti N sali V scendi V → saliscendi N senza P tetto N → senzatetto N capo N stazione N → capostazione N agro A dolce A → agrodolce A [Fonte: S. Scalise, Morfologia, Bologna 1994] Dal punto di vista delle categorie lessicali (indicate in pedice alle parole: N = sostantivo, A = aggettivo, P = preposizione, V = verbo), si vede come il composto sia in genere un sostantivo; se però a combinarsi sono due aggettivi il composto che se ne ricava è a sua volta un aggettivo. Generalizzando si avranno le due regole seguenti: a. X+Y→ N b. A+A→ A Si vedano nel dettaglio le specifiche possibilità combinatorie dell’italiano, con indicazione dell’esistenza del tipo di composto e della sua produttività. 27 TAB . 2 categorie esiste produttivo esempi 1. N+N sì sì crocevia, pescecane 2. A+A sì sì dolceamaro, verdeazzurro 3. V+V sì no saliscendi, giravolta 4. P+P no – *dicon, *senzaper 5. Avv+Avv sì no malvolentieri, sottosopra 6. V+N sì sì scolapasta, cantastorie 7. V+A no – *pagacaro, *vedibello 8. V+P no – *metticon, *saltasopra 9. V+Avv sì no buttafuori, cacasotto 10. N+A sì no camposanto, cassaforte 11. N+V sì no manomettere, crocefiggere 12. N+P no – *scalasotto, *abitosenza 13. N+Avv no – *casamale, *tavolobene 14. A+N sì no biancospino, gentiluomo 15. A+V no – *gentileparla, *caropaga 16. A+P no – *bellocon, *biancosenza 17. A+Avv no – *bellobene, *biancooggi 18. P+N sì no sottopassaggio, oltretomba 19. P+A no – *congentile, *soprabello 20. P+V sì no ? contraddire, ?sottomettere [forme dubbie: si tratta di forme composte o di forme derivate con i prefissi contro-, sotto-?] 21. P+Avv no – *conbene, *senzaieri [Fonte: S. Scalise, Morfologia, Bologna 1994] Non tutte le combinazioni sono dunque possibili: irreperibili le nn. 4, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21. Se ne ricava in particolare che in posizione di secondo costituente non è ammissibile una preposizione, in accordo con le regole sintattiche dell’italiano che prevedono l’ordine P+N e non N+P (con pazienza e non *pazienza con); per le stesse ragioni di corrispondenza con le regole sintattiche la preposizione non crea composti con l’aggettivo (infatti: con gentilezza ma non *con gentile) e l’avverbio solo con il verbo, ma è pur vero che si dà un caso di composto N+Avv come centravanti, per calco dell’ingl. centre-forward. 28 La testa di un composto è quell’elemento che determina la categoria lessicale cui appartiene il composto stesso; è utile poter determinare la testa di un composto perché è dalla testa che derivano al composto una serie di proprietà. Ad es. in: campoN+santoA → camposantoN, la testa del composto è campo: potremo dire che la categoria N del composto camposanto deriva dalla testa campo. Per individuare la testa di un composto ci si potrà dunque porre la domanda «è un…?», tanto sul piano della categoria lessicale quanto sul piano della semantica. Nel primo caso ci si chiederà ad es.: cassaforte «è un» sostantivo (come cassa) o «è un» aggettivo (come forte)? Nel secondo caso: cassaforte «è una» cassa o «è una» forte? È questo il cosiddetto test dell’«è un», il modo più rapido di identificare la testa di un composto. Tuttavia non sempre il test categoriale dà una risposta chiara: capostazione «è un» sostantivo come capo e come stazione; ma i tratti semantici dei due costituenti sono differenti: capo [+maschile], [+animato], stazione [-maschile], [-animato]; essendo capostazione [+maschile], [+animato], se ne deduce che la testa del composto è capo, con cui concorda non solo nella categoria lessicale ma anche nei tratti semantici. Come conferma il test semantico: capostazione «è un» capo o «è una» stazione? È un capo. Quali elementi del composto derivano quindi dalla testa? a) La categoria; b) i tratti sintattico-semantici; c) il genere. Si noti che in alcune lingue la testa di un composto può essere anche individuata in base alla sua posizione. In inglese è comunemente a destra: blackboard ‘lavagna’, rattlesnake ‘serpente a sonagli’. Non così in italiano: pescecane, camposanto presentano testa a sinistra ma manoscritto («è uno» scritto), gentiluomo a destra. Ma si dovrà dire che l’ordine normale dell’italiano è generalmente rispettato, sicché nei composti la testa si trova a sinistra. I casi discordanti, con testa a destra, possono spiegarsi: a) con la provenienza dal latino (terremoto < TERRAE MOTUS ) o comunque con la loro origine non recente, in fasi della lingua in cui l’ordine di N+A in italiano era meno vincolato, a testimonianza quindi di regole compositive oggi non più produttive (gentiluomo); b) con calchi dall’inglese (scuolabus; ingl. school bus). Ne esce confermata l’idea che anche all’interno dei processi formativi si riflettano le regole sintattiche dell’italiano. Non tutti i composti presentano una testa. Ad es. nel caso di sali V+scendiV → saliscendi N, non dà esito il test categoriale di «è un» (saliscendi non è un verbo come i suoi costituenti), né 29 quello sintattico-semantico (non «è un» sali e non «è un» scendi). Si tratta dunque di un composto esocentrico, laddove quelli provvisti di testa si diranno composti endocentrici. Così vale per i composti V+N, molto frequenti in italiano. Ad es. portaV+lettereN → portalettereN: la testa non può riconoscersi sulla sola base della corrispondenza categoriale (portalettere «è un» sostantivo come lettere); è necessario che si considerino i tratti semantici discordanti (portalettere [+animato], [+maschile] [+singolare]; lettere [-animato], [-maschile], [-singolare]). E così in altri casi: pellerossa, purosangue, senzatetto ecc. Se ne conclude che la corrispondenza categoriale non è condizione sufficiente a individuare la testa: occorre che criterio categoriale e criterio semantico concordino. Per distinguere i composti dai sintagmi possono valere per l’italiano alcuni criteri. Nei composti si hanno: 1) atomicità sintattica: il composto è cioè indivisibile; non è possibile: a) inserire materiale lessicale all’interno di un composto (*portagrandiombrelli; cfr. invece il sintagma portatore di grandi ombrelli); b) i costituenti non possono venire spostati (Maria taglia carte → Cosa taglia Maria?; ma: Maria ha un tagliacarte → *Cosa ha un taglia Maria?); c) il costituente di un composto non può fungere da antecedente in una catena anaforica (*Gigi fa il lavapiatti. Li ha messi in credenza); 2) possibilità di costruzioni esocentriche: ad es. il composto lavavetri ma il sintagma lavatore di vetri; 3) limitato grado di ricorsività: una volta che in italiano si è formato un composto, questo non può di norma sottostare ad altre regole di composizione, come avviene invece ad es. in inglese. Si può pensare a casi rari come porta-asciugamani (portaV+[asciugaV+maniN]N → porta-asciugamaniN); ma in inglese, a partire proprio dal suo corrispondente towel rack ‘porta-asciugamani’, si può ad es. procedere addirittura nel modo seguente: bathroom towel rack → bathroom towel rack designer → bathroom towel rack designer training→ bathroom towel rack designer training course → bathroom towel rack designer training course notes ‘gli appunti del corso di formazione per designer di porta-asciugamani da bagno). 2.6. LE UNITÀ LESSICALI SUPERIORI Sempre nell’ambito del lessico vanno considerati anche i lessemi complessi, o unità lessicali superiori (vd. anche la nozione di sintema al § 2.3). Sono quei sintagmi che 30 presentano rapporto stabile tra forma e significato (conferenza stampa, teste di cuoio, alte sfere) e un ordine rigido della sequenza (carta verde ma non verde carta, stato civile ma non civile stato, cane poliziotto ma non poliziotto cane). Spesso il significato di un lessema complesso non è deducibile da quello delle singole componenti (faccia di bronzo, cavallo di battaglia, zoccolo duro). L’insieme di lessemi che costituisce un’unità lessicale superiore tende, quanto più cresce l’uso, a lessicalizzarsi, cioè ad assumere un nuovo significato stabile del tutto convenzionale. L’unità lessicale superiore più frequente è costituita da due nomi, di cui il primo può essere un deverbale e il secondo il suo soggetto: caduta di tensione, ritorno di fiamma; oppure da un verbo seguito da un nome argomento (in genere diretto) spesso in funzione sostitutiva di un unico verbo: aver bisogno (abbisognare), far finta (fingere), dare l’avvio (iniziare), fare allusione (alludere), dar retta (credere), venire in mente (ricordarsi). Particolare coesione hanno i cosiddetti verbi sintagmatici, formati da un nome seguito da un avverbio o da una preposizione: mettere dentro, mettere su, buttare giù, portar via. Non sempre il lessema complesso verbale è riducibile a un solo verbo equivalente (prendere aria, tenere banco) ma la sostanza non cambia: sono almeno due parole che si comportano come se fossero una sola. Tra i tipi di sintagma N+N è molto frequente quello in cui il primo elemento è determinato dal secondo (che è appunto il determinante), in genere un aggettivo: opinione pubblica, zoccolo duro, ammortizzatore sociale, stato giuridico, ordine pubblico, tempo pieno, tempo libero, carro armato, libro bianco, mercato nero, tavola calda, disco rigido, mucca pazza. Lo stesso accade nelle unità formate da un nome seguito da un altro nome in funzione aggettivale oppure coordinata: mobile bar, uccello mosca, effetto serra, legge quadro, stato cuscinetto, uomo rana, donna cannone, cane poliziotto, donna vigile, zona cuscinetto, caso limite. Sempre più frequenti però anche i lessemi complessi con determinante (aggettivo o nome in funzione aggettivale) a sinistra, secondo il modulo anglosassone: mass media, play boy, alta fedeltà (non a caso calco di high fidelity), pari opportunità, equo canone, pieno impiego, baby pensioni, belle lettere (fr. belles lettres), prima donna. Il sistema di formazione lessicale N+N è uno dei processi più nuovi dell’italiano, che si avvicina così a procedure poco praticate dal latino e invece molto sviluppate dalle lingue anglosassoni. Il fatto notevole è l’assunzione al ruolo di aggettivo di vari sostantivi come succede in vari casi, alcuni già citati: fiume (romanzo, istruttoria, discorso fiume), ombra (governo, ministro ombra), modello (carcere, detenuto, scolaro modello), lampo (matrimonio, 31 sciopero lampo), tipo (lezione, episodio, inglese tipo), killer (zanzara, batterio), bomba (notizia), nomi di colore (cammello: un vestito cammello; fucsia: una gonna fucsia). Caratteristica di questi aggettivi è l’indeclinabilità e un generalizzato vincolo alla posizione postnominale. Caratteristiche che si trovano anche quando l’aggettivo è esso stesso un composto: decreto salvaladri. Il lessema complesso del tipo N+N può essere legato da preposizione: ferro da stiro, macchina da scrivere, festa da ballo, alzata di spalle, carta di credito, bomba a mano, crema da barba ecc. La preposizione può anche essere oggetto di ellissi: busta paga, banca dati, conferenza stampa, angolo cottura, buono pasto, pausa caffè, silenzio stampa, prova finestra, carro attrezzi, vagone merci, motore diesel, servizio ristorante, ufficio informazioni, borsa valori, casa vacanze, servizio cassa, formato tessera. 32 3. L’ITALIANO DI OGGI . LINGUA , STILE E VARIETÀ All’inizio di queste dispense si è sottolineato il fatto che la lingua italiana, come tutte le lingue storico naturali, non solo cambia e si arricchisce continuamente, ma contiene in sé una pluralità di opzioni e possibilità: con le parole di Leopardi potremmo dire che quella italiana non è propriamente una lingua, ma una «molteplicità di lingue». Per distinguere e descrivere le diverse varietà della lingua la sociolinguistica ricorre ad alcuni parametri di natura extralinguistica, che tengono conto cioè del contesto in cui avviene la comunicazione, delle motivazioni che l’hanno attivata e di chi ne è protagonista. Tenendo presenti questi fattori si può dire che le varietà dell’italiano contemporaneo dipendono da cinque fondamentali parametri, che danno luogo ad altrettanti tipi di variazione: Variazione DIAMESICA → in base al mezzo o canale di comunicazione (scritto/parlato) Variazione DIATOPICA → in base all’area geografica Variazione DIASTRATICA → in base al gruppo sociale Variazione DIAFASICA → in base alla ‘situazione’ e/o funzione o contesto del messaggio Variazione DIACRONICA → in base al tempo (oggetto delle lezioni di storia della lingua) Per quanto ciascuna varietà abbia caratteristiche proprie e sia passibile di una descrizione particolareggiata, la lingua si definisce incrociando e sovrapponendo questi divesi parametri. Ogni parametro è rappresentabile come un asse che unisce due varietà contrapposte, ossia come un continuum fra due poli estremi. Fra le due varietà estreme possono individuarsi un numero non prestabilito, e potenzialmente infinito, di varietà intermedie. Vediamo dunque quali sono i poli relativi alle categorie di variazione sincronica (cfr. anche la rappresentazione grafica seguente): DIATOPIA → It. Standard normativo / it. regionale dal forte sostrato dialettale DIASTRATIA → It. colto ricercato / It. popolare basso DIAFASIA → It. formale aulico / it. informale trascurato DIAMESIA → It. “scritto-scritto” / it. “parlato-parlato” 33 34 3.1. LA VARIAZIONE DIAMESICA 3.1.1. OSSERVAZIONI GENERALI La varietà diamesica (dal greco diá- ‘attraverso’ + mésos ‘mezzo’) considera il mezzo fisico con cui la lingua trova espressione; la dicotomia fondamentale dell’asse diamesico è dunque tra scritto e parlato. Osserva opportunamente Berruto che si tratta di «un’opposizione che percorre le altre dimensioni di variazione e allo stesso tempo ne è attraversata». Se consideriamo lo schema a cerchi concentrici (nella pagina precedente) possiamo notare che si tratta del cerchio più interno, quindi condizionato dagli altri parametri poiché tutti lo contengono (nell’altro schema infatti la retta relativa alla diamesia incrocia quelle relative alle altre variazioni). Proprio per questo non è sempre facile individuare le peculiarità formali, specifiche, di scritto e parlato, in quanto cioè non pertengano ad altri livelli di variazione che si servono dell’uno o dell’altro canale comunicativo: in una produzione orale cosa dipende dal canale orale e cosa dipende dalle varietà che si servono del canale orale? È evidente che tra i due poli estremi di questa varietà, lo scritto e il parlato, si possano individuare diverse varietà intermedie, che partecipano ora dell’uno e ora piuttosto dell’altro polo. Tra gli autori che meglio hanno saputo individuare le peculiarità del parlato va ricordato senza dubbio Giovanni Nencioni. Lo studioso ha innanzitutto cercato di chiarire che cosa l’italiano parlato non sia: • non va considerato come l’opposto diametrale dell’italiano scritto, né come l’opposto diametrale del dialetto; • non si identifica con l’italiano regionale né tantomeno popolare • non è sovrapponibile all’italiano orale, perché anzi l’italiano orale lo comprende in quanto è un insieme più ampio e vario. Possono infatti appartenere all’italiano orale secondo Nencioni i testi formalizzati come lezioni accademiche, orazioni, preghiere, formule rituali, canti e filastrocche; testi scritti, letti ad alta voce; il discorso di comunicazione immediata e spontanea. Sul piano descrittivo poi, accanto ai due poli relativi al parlato-parlato (quello del libero scambio conversazionale) e allo scritto-scritto (ossia la scrittura non legata in alcun modo al parlato), Nencioni ha proposto di distinguere anche le seguenti tipologie: 35 • parlato-scritto: ossia il parlato relativo alle battute dentro un racconto, ma anche il parlato dei discorsi parlamentari e dei discorsi preregistrati per la radio e la televisione (quest’ultimo noto anche come italiano trasmesso); • parlato-su-scritto: rappresentato dall’intervista giornalistica e da discorsi tenuti in occasione di comizi e congressi; • parlato-recitato: ossia il parlato che trova rappresentazione in teatro, e che nasce anch’esso da un testo scritto (ma scritto per essere ‘eseguito’). 3.1.2. DIFFERENZE TRA SCRITTO E PARLATO Per cogliere le peculiarità dell’uno e dell’altro polo (parlato-parlato e scritto-scritto) è opportuno cercare di distinguere i fenomeni propri del parlato e assenti nello scritto. Si tratta in particolare di: • mezzi prosodici, con cui si indicano gli aspetti intonativi, legati all’esecuzione del testo da parte del parlante e relativi all’intonazione della frase, alla velocità di espressione, alle pause ecc. • tratti paralinguistici, ossia la gestualità degli interlocutori, la distanza spaziale ecc. Da notare anche che il ritmo veloce di pronuncia nel parlato conversazionale meno sorvegliato produce dei fenomeni di fusione a livello fonologico, noti come fenomeni di ‘allegro’, che hanno ricadute nella forma di alcune parole (ad es. nell’aferesi nei dimostrativi sto, sta ecc. non ancora registrati nella lingua scritta di media formalità). La lingua scritta può solo faticosamente ricostruire, in modo indiretto, attraverso l’uso di simboli grafici (detti segni soprasegmentali) i tratti prosodici del parlato, mentre per quelli paralinguistici è costretto spesso a ricorrere a inserti descrittivi. D’altra parte si può considerare che tutto ciò che in sostanza riguarda l’aspetto grafico di un testo (l’interpunzione, le sottolineature, le maiuscole, e in genere la mise en page o la presentazione d’insieme del testo), ed ha come obiettivo appunto quello di cercare di riprodurre la modalità di esecuzione o di interpretazione del testo, può essere rubricato tra i fenomeni propri dello scritto e assenti nel parlato. Più importanti sono le differenze tra scritto e parlato che agiscono sul piano della testualità e della pragmatica e che sono legate al fatto che nel parlato si riscontra: 1) un minor grado di pianificazione del discorso, ossia una maggiore difficoltà di organizzare le informazioni in un periodo complesso. Ciò si riflette in: 36 2) una modalità di organizzazione dell’enunciato in cui le esigenze della semantica e della informatività prevalgono su quelle della coesione sintattica. A questi caratteri generali corrispondono, nel parlato, i seguenti tratti linguistici: 1) alla micropianificazione corrisponde il prevalere dell’ordine marcato delle parole e quindi di costruzioni tematizzate (dislocazioni a destra e a sinistra, frasi scisse, tema sospeso), con bassa coesione testuale, pause, esitazioni colmate con interiezioni e altro, ripetizioni di chiarimento e ripresa, frammentarietà, segnali discorsivi o demarcativi (allora, dunque, eh, ma, insomma…); 2) sullo stesso piano a livello sintattico si deve notare la prevalenza della paratassi sull’ipotassi e di una ipotassi leggera su una più convoluta, con legami coesivi generici come che (vieni, che è tardi”), perché (“te lo dico perché tu ci stia attento”; “Chi c’è in casa? Nessuno, perché Francesca è uscita”), così (faccio un segno, così Giorgio ci vede). Si noti ancora che nel parlato le principali abbondano sulle subordinate, e si riscontrano spesso dei periodi monoproposizionali. 3) all’impossibilità della cancellazione corrisponde la frequenza delle autocorrezioni (cioè, volevo dire), parafrasi, particelle e avverbi modali metadiscorsivi (praticamente, per così dire, veramente, diciamo); 4) alla difficoltà di memorizzazione corrispondono fitte riprese e costruzioni anaforiche; 5) al forte ruolo dei mezzi prosodici corrisponde uno stretto rapporto tra sintassi e prosodia; 6) al ruolo della gestualità corrisponde la deissi; 7) alla compresenza di parlante e interlocutore corrisponde un incremento della funzione fatica: forme di allocuzione, i cosiddetti fatismi (sai, sa com’è, capisce?, capito?, no), forme di cortesia (scusi, mi segui?), pronomi di prima persona, segnali di conferma o dubbio (scusa, mah, permetti, certo, appunto, giusto); 8) alla condivisione enciclopedica corrispondono ellissi e implicitezza. Nel parlato risalta anche più che nello scritto il ricorso alle parole grammaticali pure (che, se, io, tu, e, non, ma ecc.) che accresce il già alto indice di frequenza dei monosillabi nella nostra lingua (si parla di una minore densità lessicale rispetto allo scritto). Rilevante anche il fatto che il parlato conosca una gamma di variazione lessicale assai minore dello scritto (un vocabolario meno vasto, come è anche intuitivamente comprensibile). 37 Inoltre nel parlato si avranno facilmente molte ripetizioni dello stesso lessema, soprattutto quando esso riveste un’importanza tematica, magari anche a livello psicologico, massima. Nella stessa direzione va l’uso frequente di termini generici, le cosiddette parole passepartout, ad alto tasso di iperonimia (cosa, roba, tipo, faccenda, affare, tizio, uomo, uno, donna, fare, dire) e di intensificanti (come bello forte tutto un sacco un mucchio tanto) superlativi: “c’è tanta di quella neve”, “c’è un sacco, un mucchio di neve”, estremamente) oppure riduttivi (attimino, momentino, cosina, pochino), esclamazioni (cavolo, caspita) ecc. In particolare, colpisce la frequenza, nell’attuale lingua parlata, dei dimunitivi con -ino come momentino, attimino e pochino; si tratta di diminutivi iperbolici, tipici proprio del parlato, così come lo sono, ma meno frequenti, gli accrescitivi tipo bacioni, salutoni. Ci sono poi i veri e propri dimunitivi, a testimoniare il grado di espansione del baby talk e dell’eufemismo colloquiale (paginetta, cosina, caffettino, formuletta, insalatina) e, in altra direzione, dell’espressionismo accrescitivo e peggiorativo (fallaccio, pancione, poveraccio, cagnaccio: questi magari più che altro di origine dialettale). La gestione del parlato avviene per lo più nell’interscambio dialogico. Qui una ritualità codificata e sempre eccepita regola l’avvicendarsi dei turni, il succedersi dei ruoli (parlante/ ascoltatore), la dinamica delle sovrapposizione e delle interruzioni, dei cambi di turno (con ampio uso dei segnali discorsivi), dei processi di cessione o presa della parola. 3.2. La vARIAZIONE DIATOPICA È la variazione determinata dalla dimensione spaziale, dal greco tópos che significa ‘luogo’. Al centro di questa varietà dunque si colloca il rapporto, articolato e complesso, tra italiano e dialetti. 3.2.1. LINGUA E DIALETTI La lingua nazionale, l’italiano, è nata dallo sviluppo di un volgare locale – quello fiorentino – e si è imposta come lingua parlata dalla maggioranza della popolazione soltanto dopo l’unificazione dello stato italiano, nel 1861. I dialetti che ancora oggi pertengono al sistema dell’italiano sono la prosecuzione di quei volgari locali che si svilupparono a partire dal latino nelle varie regioni del territorio italiano. Il dialetto non è qualitativamente “inferiore” alla lingua, semplicemente se ne differenzia per: • l’area d’uso più ristretta, dal punto di vista sia del territorio che della popolazione: è questa l’unica caratteristica davvero dirimente per distinguere lingua e dialetto; 38 • l’impiego prevalentemente orale; • la ridotta codificazione in ambito soprattutto grammaticale (numerosi sono invece i vocabolari dialettali). La lingua nazionale gode inoltre, rispetto al dialetto, di un maggior prestigio sociale, e di un più esteso impiego nel campo della cultura, anche se in realtà non mancano dialetti di forte tradizione letteraria e di grande valore sul piano storico e culturale (ad esempio il veneto ma anche il milanese o il romanesco). Il termine ‘dialetto’ è in genere usato, per le varietà locali, solo a partire dal Cinquecento, da quando cioè il volgare fiorentino (letterario trecentesco) diventa per opera di Bembo e delle sue Prose della volgar lingua (1525) il modello per l’italiano scritto letterario. Per il periodo precedente si parla di “volgari locali”. È opportuno distinguere, nel rapporto tra lingua e dialetti, tra tre condizioni: • bilinguismo: si verifica quando due sistemi linguistici compresenti in una determinata comunità sono equivalenti da un punto di vista socioculturale; • diglossia: si verifica quando i due sistemi linguistici sono differenziati in base all’uso, ossia un codice linguistico è usato per le situazioni ufficiali e solenni, mentre l’altro per quelle private e familiari e, in genere, la varietà riservata agli usi pubblici e formali è possesso più pieno delle classi sociali più alte (il che significa che può essere correlata anche al grado di studio). Si parla in questo senso di ‘bilinguismo verticale’ di contro al bilinguismo vero e proprio, ‘orizzontale’. • dilalia: si tratta di una situazione di bilinguismo in cui è mantenuta una separazione funzionale ma con ampie zone di sovrapposizione tra i due codici. Entrambe le varietà sono inoltre impiegate o impiegabili nella conversazione quotidiana. Nel repertorio linguistico degli italiani è evidente che, almeno fino ad anni recenti, la situazione è quella definita dalla diglossia, in cui l’uso del dialetto è riservato al contesto privato e familiare, mentre l’italiano per quello formale e ufficiale (comunicazioni ad es. con la scuola, o con l’autorità ecc.). In realtà, il rapporto oggi è in parte cambiato a causa della progressiva sparizione del dialetto nella comunicazione quotidiana, almeno nei grandi centri urbani. Il dialetto risulta così disponibile anche per una scelta, più o meno consapevole, di indicazione di appartenenza a un’identità di gruppo. 39 I dialetti dell’italiano sono divisibili in due grandi gruppi, a loro volta comprendenti diverse varietà: • settentrionali: gallo-italici (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia), veneti, istriani; • centro-meridionali: toscani, mediani (Nord del Lazio, dell’Umbria e delle Marche), meridionali intermedi (resto del Lazio, dell’Umbria e delle Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Lucania, Nord della Calabria e della Puglia), meridionali estremi (Sud della Calabria, Salento e Sicilia). Hanno caratteri particolari, slegati dal toscano, e sono quindi in genere considerate lingue a parte, pur rientrando del sistema dell’italiano: • il sardo, diviso nelle varietà logudorese (la più conservativa), campidanese, sassarese e gallurese; • il ladino, diviso in friulano e ladino dolomitico, cui andrebbe aggiunto – fuori dal territorio italiano – il romancio parlato nel Cantone dei Grigioni, nella Svizzera italiana. Le diverse zone dialettali sono divise da linee immaginarie che vengono dette isoglosse. Un isoglossa delimita il territorio in cui è presente un certo fenomeno linguistico (ad es. la sonorizzazione delle consonanti sorde in posizione intervocalica). I grandi gruppi sono separati tra loro da parecchie isoglosse l’una vicina all’altra, che costituiscono i fasci di isoglosse. Il principale fascio di isoglosse è la cosiddetta linea La Spezia-Rimini, che divide il gruppo settentrionale da quello centro-meridionale. Un altro importante fascio di isoglosse, anche se dall’andamento meno regolare, è quello delle linee che vanno dal territorio a sud di Roma fino alla provincia di Ancona, che separa i dialetti mediani da quelli centro-meridionali. Da ricordare anche le due serie di isoglosse che attraversano la Calabria e la Puglia, isolando grosso modo le province di Catanzaro e Reggio e il Salento, in cui si parlano dialetti meridionali estremi, in genere contraddistinti dal vocalismo di tipo siciliano (con 5 vocali toniche). 40 41 Secondo Pellegrini (1975) i rapporti tra lingua e dialetto nel caso italiano possono essere ricondotti alle seguenti quattro situazioni-tipo: 4 1. italiano comune (o standard); 2. italiano regionale; 3. koiné dialettale (o dialetto regionale); 4. dialetto. Ovviamente tali situazioni linguistiche vanno intese non come unità discrete, ma come parti di un continuum in cui solo i due poli estremi – l’italiano standard da un lato e il dialetto dall’altra – possono avere un certo grado di ‘purezza’ (mai comunque assoluta). Per italiano regionale si intende l’italiano parlato in una certa zona, condizionato dal tipo dialettale che in quella zona si pratica in un regime di diglossia rispetto all’italiano. L’influenza del dialetto è avvertibile prima di tutto sul piano fonetico (ossia nei tratti relativi alla pronuncia e all’intonazione), in secondo luogo anche sulla scelta del lessico, meno sugli altri livelli linguistici. Il dialetto regionale è una varietà di dialetto regionalizzata. Si pensi ad esempio alla situazione di egemonia in cui si è trovato un centro urbano come Venezia, il cui prestigio storico-politico ha avuto conseguenze anche sul piano linguistico, influenzando lo sviluppo dei dialetti presenti nel territorio regionale. Un fenomeno generale è la progressiva italianizzazione dei dialetti, ossia l’introduzione nel patrimonio linguistico dialettale di tratti derivati dalla lingua nazionale. Il livello linguistico più sensibile all’italianizzazione è senza dubbio quello del lessico, seguito da quello fonetico. Meno influenzata resta la morfologia e la morfosintassi. L’italianizzazione del lessico riguarda naturalmente soprattutto la sfera “pubblica”, dove i contatti sociali che si istituiscono devono spesso necessariamente varcare i confini della comunità. In particolare saranno interessati: l’ambito burocratico; l’assistenza sanitaria (parti del corpo, malattie); la religione; i livelli della parentela; il commercio. In genere sono importati dall’italiano la maggior parte dei termini astratti: in questo caso non sostituiscono termini dialettali, ma – spesso – risultano da un processo di lessicalizzazione primaria di un elemento extralinguistico prima non presente nel codice (non è nuovo solo il lessema, ma anche il concetto da esso denotato). Rimangono invece dialettali i termini legati agli oggetti materiali della vita quotidiana, almeno quando questi oggetti sono sopravvissuti (strumenti agricoli, ecc.) 4 Giovan Battista Pellegrini, Saggi di linguistica italiana, Torino, Boringhieri, 1975. 42 Si registra anche la presenza di dialettismi all’interno dell’italiano parlato, soprattutto con funzione espressiva, gergale o paragergale, o ancora come segnale più o meno scherzoso di appartenenza regionale. Tra i casi più ricorrenti e condivisi (che hanno quindi perso qualsiasi carattere di espressività o di identificazione regionale) di dialettismi ormai comuni nell’italiano segnaliamo: teppista e derivati, che sono di origine lombarda, come anche panettone e pirla; il pesto dalla Liguria; la pizza da Napoli; l’amatriciana da Roma; la cassata dalla Sicilia. Ecco comunque un elenco dei principali (e come si vede ben radicati) dialettismi accolti nell’italiano: piemontesismi: ramazza, manfrina; ligurismi: boa, cavo, lavagna, molo, scoglio; lombardismi: bettola, tapparella, pirla; venetismi: arsenale, traghetto, zattera; emiliani: birichino, mezzadro; romanismi: i sostantivi in -aro (palazzinaro ecc.), sbronza, caciara; napoletanismi, calabresismi: pennichella, bustarella (entrambi napoletani), pernacchia, vongole; 3.2.2. CARATTERI DELLA VARIAZIONE DIATOPICA La variazione regionale dell’italiano è senza dubbio la più palesemente sensibile nell’ambito del repertorio, specie nella lingua parlata. L’eventuale tratto regionale si rivela con diversa evidenza a seconda della variazione diastratica (cultura e posizione sociale del parlante) e diafasica (formalità o informalità del registro); talvolta l’unico elemento di regionalità – quindi di distinzione diatopica – è costituito da varianti fonologiche e intonazionali. È interessante notare che l’italiano regionale è segnato dal sostrato dialettale del parlante, anche quando questo non è mai stato dialettofono: la dialettalità areale si manifesta infatti nell’esecuzione dell’italiano anche nei non dialettofoni (una sorta di dialettalizzazione secondaria). Si è già detto che l’italiano regionale è una varietà di lingua influenzata dal dialetto parlato in una data zona. Ribadiamo l’evidenza che il fattore regionale è più forte a livello di intonazione (la cadenza), di fonetica (la pronuncia) e, in parte, di lessico, mentre risulta meno vistoso a livello di morfologia e di sintassi (e sempre più anche di lessico). E tuttavia certi costrutti morfosintattici degli italiani regionali (ad es. il tipo nordorientale: «non so quando 43 che verrà», «il paese dove che sei stato» ecc.) sono ben netti e non meno dei tratti fonologici imputabili al retrostante dialetto. Non è possibile occuparci qui dell’intonazione, che può essere descritta solo con strumenti e metodi sperimentali. Passiamo in rassegna ora, con particolare riguardo alla Toscana, i tratti più importanti e misurabili dell’italiano regionale, con la precisazione che l’italiano regionale di Toscana è un caso unico di dialettalizzazione forte e precoce dell’italiano, il quale in gran parte coincide col livello diastratico popolare. Vediamo dunque, partendo dai tratti fonetici: . italiano settentrionale: 1. realizzazione sempre sonora di s intervocalica ([’kaza]); 2. e tonica aperta in sillaba chiusa e finale ([mo’m ɛ nto], [per’kɛ ], [’trɛ ]); 3. riduzione delle consonanti geminate in posizione intervocalica (non [’bel:o], ma [’be:lo]); 4. realizzazione sonora della affricata alveolare sorda (z) all’inizio di parola ([’ ʣ i:o] invece di [’ʦi:o]). . italiano regionale toscano: 1. pertinenza dell’opposizione di apertura delle vocali e e o ([’peska] ‘attività del pescare) vs [’pɛ ska] ‘frutto’; [’bot:e] ‘recipiente’ vs [’bɔt:e] ‘colpi’); 2. pertinenza dell’opposizione tra sibilante sorda e sonora ([’fu:so] ‘strumento per filare’ vs [’fu:zo] ‘participio di fondere’); 3. monottongazione del dittongo uo (da [’bwɔno] a [’bɔno]); 4. gorgia, cioè spirantizzazione delle occlusive sorde intervocaliche anche in fonosintassi ([la ’ka:sa] > [la ’ha:sa]; 5. perdita dell’elemento occlusivo nelle affricate palatali [ ʧ ] e [ʤ ]: [’ka:ʧ o] > [’ka:ʃ o]; [’a:ʤ ile] > [’aʒile]; . italiano regionale centro-meridionale: 1. rafforzamento delle consonanti [b] e ʤ [ ] in posizione intervocalica o dopo una pausa ([’abile] > [’ab:ile]; [’aʤ ile] > [’aʤ :ile]; 2. realizzazione sempre sorda della sibilante intervocalica ([’vi:zo] > [’vi:so]); 3. sonorizzazione delle occlusive sorde dopo consonante nasale ([’kampo > [’kambo]) nell’area dei dialetti meridionali e meridionali estremi; 44 4. assimilazione regressiva di [r] e [l] seguite da consonante ([’per ’me] > [pe’m:e]; [’barba] > [’bab:a]) in Sicilia. A livello morfologico e sintattico le variazioni regionali sono meno fitte e più ampiamente distribuite. Inoltre non tutte sono ricevibili allo stesso livello diastratico, e talvolta la loro accettabilità cambia anche a seconda della zona in cui il fenomeno si manifesta. Anche qui forniamo un breve elenco dei tratti principali: italiano settentrionale: 1. forme perifrastiche sostitutive di stare + gerundio: essere dietro a, essere dietro che, essere qui che; 2. rafforzamento con particelle avverbiali di pronomi e aggettivi dimostrativi (questo qui, quella là, quel ragazzo lì); 3. preferenza per suffissi di alterazione dimunitivi in -ino (macchinina) e -etto (libretto), prevalenti rispettivamente nel Nord-Ovest e nel Nord-Est; 4. uso pressoché esclusivo del passato prossimo anche per azioni compiute e lontane («è arrivato a Milano cinque anni fa»); da notare che questo tratto, assolutamente privo di connotazioni diastratiche (viene cioè indifferentemente usato nelle varietà alte e basse) si sta diffondendo anche in zone dove fino a poco tempo fa resisteva l’opposizione con il passato remoto: il che può essere spiegato sia con il prestigio sociale delle varianti settentrionali, sia con un generale processo di ristandardizzazione delle forme verbali che produce lo stesso fenomeno, per esempio, anche in francese; 5. frequente aggiunta di “integranti semantici” (particelle locative in posizione finale e accentata rispetto alla forma verbale): ad es. star lì, prender su, ecc. Il tratto, pur tipico della Lombardia e delle Venezie, è diffuso in tutto il Nord; 6. uso del possessivo seguito dal nome di parentela senza articolo («mio papà»); 7. nomi di persona preceduti da articolo determinativo (la Lucia, il Mario): mentre per il femminile il tratto è diffuso in tutto il Nord e in parte del Centro (Toscana e Umbria settentrionale), l’uso del maschile preceduto da articolo determinativo è limitato a Lombardia, Canton Ticino e Trentino; italiano regionale centro-meridionale: 1. uso di tenere per avere, e stare per essere («qui non ci sta nessuno»; «tengo famiglia»), anche con valore di ausiliare; 45 2. uso dell’accusativo preposizionale, cioè il complemento diretto (oggetto) è preceduto dalla preposizione a («ho visto a Carlo»); 3. estensione di a sulle altre preposizioni («bello a mamma tua»), anche in dipendenza da stare («stiamo a mangiare»); 4. uso del passato remoto anche per azioni aspettualmente prossime o non finite («arrivò ora»); 5. uso transitivo di certi intransitivi (salire, scendere, uscire, entrare); 6. collocazione del possessivo dopo il nome («vieni da mamma tua»); 7. posposizione del verbo al predicato nominale o al soggetto nei casi in cui sarebbe normale la sequenza inversa, specie con il vb. essere (tratto soprattutto siciliano e sardo): «stanco è»; «Michele lo fece»: Si può chiudere ricordando la presenza dei geosinonimi ossia la presenza di sinonimi marcati in diatopia, di lessemi diversi, usati in regioni diverse, che tuttavia indicano lo stesso referente. Qualche esempio: bugie / chiacchiere; cacio / formaggio; lavandino / lavello / acquaio; idraulico / stagnino / lattoniere; avanzare / risparmiare; cencio / straccio; gruccia / stampella; anguria / cocomero / mel(l)one: spesso uno dei geosinonimi finisce per imporsi – in genere per ragioni di prestigio sociale di una certa variante diatopica – sugli altri e a prevalere anche nelle zone dove si usavano lessemi differenti. Per quanto riguarda infine la consistenza del lessico dialettale nell’ambito del patrimonio lessicale italiano, secondo i dati forniti dal Gradit l’apporto dei dialettismi e dei regionalismi sarebbe attestato sul 2-2,5% circa, poco meno di quello degli anglismi. Negli ultimi decenni tuttavia è stata notata una maggiore apertura del lessico panitaliano nei confronti dei dialettismi tendenzialmente già più diffusi, oggi non più sanzionati a livello di comunicazione standard. Così, da una parte il prestigio sociale delle varianti settentrionali, dall’altra la specializzazione comica e “sentimentale” di certo lessico meridionale e romanesco (e il suo uso nei media, nonché l’indubitabile romanocentrismo televisivo) ha fatto sì che molti lessemi entrassero nell’italiano tout court smarrendo in larga parte la loro connotazione regionale. 3.2.3. LE MINORANZE ALLOGLOTTE Il quadro delle varietà diatopiche presenti nel territorio italiano non può considerarsi completo se non si fa almeno un breve cenno alle minoranze linguistiche (o alloglotte). 46 Va precisato subito che bisogna tenere distinto il concetto di «minoranza linguistica» da quello di «minoranza nazionale», di formulazione tardo-ottocentesca. Un senso di appartenenza linguistica differenziato rispetto a quello della maggioranza non è sufficiente a definire di per sé una diversa identità nazionale, che ha evidentemente ragioni storiche e politiche di altra natura. Secondo Fiorenzo Toso infatti «se un gruppo minoritario afferma collettivamente un’alterità identitaria in competizione col senso di appartenenza nazionale, per la minoranza ne discendono, in rapporto dialettico di negoziazione con lo stato egemone, anche dei «diritti linguistici» che nei paesi a democrazia avanzata lo stato stesso ha il dovere di tutelare; nel caso di minoranze linguistiche che non siano al tempo stesso minoranze nazionali, la situazione è differente, e il problema che si pone è piuttosto quello di una tutela del patrimonio linguistico di tali comunità, poiché i “diritti linguistici” che riguardano (individualmente e collettivamente) gli appartenenti a tali gruppi non sembrano in ultima analisi diversi da quelli di qualsiasi altro membro della comunità statale in cui si integrano». 5 Si tratta di considerazioni che si trovano recepite già dalla Costituzione italiana. L’art. 3 dice infatti che «Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», mentre l’art. 6 assume in pieno la materia stabilendo che «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». Tale principio è stato però recepito dal legislatore solo in parte perché di fatto ad essere tutelate sono solo le minoranze linguistiche storiche. Il principale provvedimento legislativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche è infatti la legge 482 del 15 dicembre 1999, che ha dato dignità alle parlate alloglotte promovendo «la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge». Proprio in questa affermazione si colgono gli aspetti positivi e insieme quelli negativi della legge, che da un lato definisce una serie di situazioni chiamate a costituire una ‘categoria’ ritenuta meritevole di valorizzazione, dall’altro si produce in un elenco delle lingue da tutelare ponendo di fatto limiti in gran parte arbitrari. Manca cioè una definizione oggettiva e unificante del concetto di «minoranza linguistica storica», con la conseguenza che non solo rimane escluso da tutela il romans o romaní, a cui manca il requisito della stanzialità delle comunità parlanti, ma anche le altrettanto numerose comunità di immigrati recenti, di provenienza sudamericana, asiatica e africana. 5 Fiorenzo Toso, Le minoranze linguistiche in Italia, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 7-8. 47 Le principali isole di alloglossia in Italia, tutelate dalla legge 482, sono (cfr. anche la cartina che segue): • Provenzale. È attivo nelle valli del Piemonte sud-occidentale confinanti con la Francia (val Gesso, val Chisone, valle Stura, val Pellice, alta valle di Susa e altre, nelle province di Cuneo e Torino) per un totale di circa 50.000 persone. Oltre i confini dello stato il provenzale è ancora vivo nella Francia meridionale; • Franco-provenzale. I cosiddetti dialetti franco-provenzali sono concentrati soprattutto in Valle d’Aosta, ma sono parlati anche in alcune zone della provincia di Torino. Gli utenti cono complessivamente circa 100.000. In Valle d’Aosta la situazione è ancor più particolare perché accanto al patois locale (il franco-provenzale) convivono i dialetti piemontesi e come lingue ufficiali, sia l’italiano che il francese. • Tedesco delle Alpi. Si tratta di colonie tedescofone relative ad alcuni comuni nelle valli che si diramano dal Monte Rosa (Alagna, Macugnaga, Gressoney), la cui origine va fatta risalire alle migrazioni in età medievale delle popolazioni walser (del Vallese, nella Svizzera meridionale); • Tedesco dell’Alto Adige. Interessa la cospicua minoranza tedescofona concentrata nella provincia di Bolzano. I parlanti sono circa 300.000 e sono in maggioranza rispetto agli italofoni. Il tedesco è lingua ufficiale nella scuola e nella pubblica amministrazione, ma non coincide con le parlate locali, le parlate bavaro tirolesi, anche se rimane per queste la lingua culturale di riferimento. • Ladino dolomitico. Diffuso nelle valli attorno al gruppo dolomitico del Sella (Fassa, Gardena, Badia, Marebbe, Livinallongo). Interessa all’incirca 30.000 utenti. Il ladino dolomitico è legato agli altri due gruppi ladini del cantone svizzero dei Grigioni (dove il ladino si chiama romancio) e del Friuli. Per il settore che interessa la provincia di Bolzano il ladino è tutelato e inserito nei programmi scolastici alla pari del tedesco e dell’italiano. • Friulano. La popolazione che parla dialetti di ceppo friulano (circa 430.000 persone) è concentrata in gran parte delle province di Udine, Pordenone e Gorizia e in alcune zone di quella di Venezia; ma va ricordato che nei principali centri urbani della regione è parlato il dialetto veneto, ora in assenza del friulano (Trieste, dove il friulano è scomparso nel secondo Ottocento) ora in compresenza del friulano (Udine, dove il veneto rappresenta la varietà diastraticamente alta). 48 • Sloveno. Interessa il settore di confine nord-orientale del Paese. Si possono distinguere gli sloveni della provincia di Trieste e quelli dell’area udinese e goriziana. • Croato. In alcuni centro del Molise resiste, ma interessa un numero sempre minore di utenti, il croato importato da emigrati provenienti dalla Dalmazia nel XV secolo. • Albanese. Anche le parlate albanesi che si trovano sul territorio italiano sono in gran parte il risultato di antichi movimenti migratori (a partire dal XV secolo). La minoranza consta di circa 100.000 persone, sparse però in tutta l’Italia meridionale, con nuclei più consistenti in Calabria (ma con propaggini in Sicilia, a Palermo). • Grico. Si tratta dei dialetti di origine greca che ancora sopravvivono in alcune località della Puglia salentina e in Calabria, alle pendici dell’Aspromonte. Sono connotati diastraticamente e diafasicamente in quanto ormai usati solo dai ceti più bassi o nelle situazioni meno formali. L’origine di questa minoranza è stata inizialmente attribuita all’antica civiltà classica della Magna Grecia (dall’VIII sec. a.C., ma il nome emerge nel III sec. a.C.), ma oggi si propende a ritenere che si tratti di un residuo della più tarda occupazione bizantina dell’Italia meridionale (dal VI sec. d.C.). • Catalano. Interessa la zona di Alghero, in provincia di Sassari. Risale alla deportazione in città di coloni provenienti dalla Catalogna e dalle Isole Baleari, effettuata nel 1354 per volontà di Pietro IV d’Aragona. • Sardo. Rappresenta un insieme dialettale fortemente originale nel contesto delle varietà neolatine (caratterizzato dall’affiorare di tipologie arcaiche), e nettamente differenziato rispetto alla tipologia italoromanza, al punto che gli studiosi sono sostanzialmente concordi nell’affermarne l’originalità come gruppo a sé stante. La varietà più arcaica e prestigiosa è il logudorese, che presenta una serie di tratti conservativi, più vicini al latino. È opportuno precisare che nei casi di minoranze alloglotte, i parlanti hanno in genere competenza oltre che della lingua madre, anche della lingua nazionale (o comunque dominante). Il rapporto è di bilinguismo o di diglossia, a seconda dei casi. Naturalmente, come per tutte le varianti diverse dalla lingua dominante, il numero dei parlanti attivi è in calo (tranne il caso particolare del valdostano): il che però in genere significa che la minoranza stessa, come popolazione, è in calo. 49 3.3. LA VARIAZIONE DIASTRATICA La variazione diastratica (dia + strátos ‘strato’) riguarda la correlazione della lingua con la stratificazione sociale dei parlanti. Le variabili sociolinguistiche (i tratti che variano in funzione della posizione sociale del parlante) sono stati studiati soprattutto a livello fonologico, a partire dai classici lavori di William Labov sui contrassegni sociolinguistici nella pronuncia dell’angloamericano (per un approfondimento sul lavoro di Labov cfr. Lo Duca, Lingua italiana ed educazione linguistica, par. 1.4.2). Naturalmente anche gli altri livelli della lingua sono interessati dalla variazione sul piano della diastratia, per quanto la raccolta dei dati, lo studio empirico e in particolare la creazione di corrispondenze biunivoche fra tratti linguistici e condizioni sociali dei parlanti sia meno facile che nello specifico fonologico. Mentre è difficile trovare dei tratti costanti nelle varietà diastratiche alte, gli studiosi sono da diversi decenni concordi nell’isolare una varietà bassa di italiano diastraticamente connotata, che viene generalmente identificata con l’etichetta di italiano popolare, da intendersi come un caso di formalità e marcatura diafasica alta dell’uso linguistico di un soggetto diastraticamente basso: nel senso che per un parlante che si colloca ai livelli più bassi della dinamica sociale quella varietà di italiano – l’italiano popolare appunto – sarà comunque la più alta che egli è in grado di utilizzare, per quanto lontana dallo standard essa sia. Attenzione: l’italiano popolare – marcato in diastratia – non va confuso col registro informale, substandard dell’italiano medio – marcato in diafasia. Anche se alcuni tratti possono essere comuni, l’italiano popolare è, diversamente dall’altro, marcato sociolinguisticamente dal contatto col dialetto e dalla scarsa cultura del parlante (o scrivente). In particolare, mentre il registro informale convive con altri registri, rappresenta cioè una scelta determinata sulla base del contesto comunicativo, l’italiano popolare, per un parlante e/o scrivente che si colloca in questa fascia diastratica, è invece l’unico codice a disposizione nella lingua. In un certo senso esso è nato dal momento in cui si è fissata una lingua di riferimento, configurandosi già a partire dal Seicento come una varietà propria dell’utente non istruito nel momento in cui si propone di abbandonare il dialetto, e determinandosi poi via via come una varietà propria del semicolto. Gli studi sull’italiano popolare sono nati all’alba del Novecento, a cominciare dall’esame linguistico delle lettere dei prigionieri italiani della prima guerra mondiale fatto dal grande 50 filologo romanzo Leo Spitzer. Il rilancio di questi studi è avvenuto negli anni SessantaSettanta ed ha portato all’elaborazione di due tesi diverse in merito al concetto di italiano popolare, la prima che si può far risalire a Tullio De Mauro l’altra a Manlio Cortelazzo. Nello specifico: . Cortelazzo ha messo in primo piano il retroterra dialettale dell’italiano popolare, che viene perciò definito «il tipo di italiano imperfettamente acquisito da chi ha per madre lingua il dialetto» (Cortelazzo 1972). 6 . De Mauro punta invece sull’autonomia della varietà detta italiano popolare, definita come il «modo di esprimersi di un incolto che, sotto la spinta di comunicare e senza addestramento, maneggia […] la lingua ‘nazionale’» (De Mauro 1970 [1963]). 7 Dalla proposta di De Mauro risultano esaltati i tratti unitari e sovraregionali dell’italiano popolare, che però – a ben vedere – sono largamente derivanti dal fatto che la documentazione disponibile è soltanto scritta. Molti studi hanno infatti messo in rilievo la presenza di una varietà di italiano popolare già nel passato, da quando perlomeno è chiara la norma dell’italiano alla quale tentano di avvicinarsi i semicolti. Insomma, i fenomeni linguistici sono generalmente di lunga durata e questa varietà non fa eccezione, in quanto i suoi tratti peculiari provengono dalla sfera del parlato e delle soggiacenti strutture dialettali. Da precisare però che la supposta unitarietà dell’italiano popolare, sostenuta soprattutto da De Mauro, si dilegua quando viene considerata la varietà parlata: se alcuni tratti morfosintattici e testuali sono infatti in linea di massima panitaliani, è però vero che il lessico e soprattutto la pronuncia sono fortemente connotati a livello diatopico. Del resto in Italia la variazione diatopica è di gran lunga più forte che in molti altri paesi, il che conduce a una grande rilevanza dei fattori diatopici anche nella variazione diastratica e diafasica: in entrambi i casi più la varietà si abbassa (sull’asse sociale e su quello dell’informalità), più emerge la caratterizzazione diatopica. Vediamo ora alcuni tratti riconducibili alla media dell’italiano popolare, formati – secondo Berruto (1987, p. 16) – sulla base di tre meccanismi principali: • interferenza con il sostrato dialettale; • ipercorrettismo; • processi di semplificazione. 6 Manlio Cortelazzo, Lineamenti di italiano popolare, Pisa, Pacini, 1972, p. 106. Tullio De Mauro, Storia linguistica dell’Italia unita, Roma-Bari, Laterza, 1963 (1° ed.); 1970 (nuova edizione riveduta, aggiornata e ampliata), p. 47. 7 51 A livello grafico-fonetico sono state ben osservate • le allografie di certe consonanti e nessi consonantici (Itaglia, gnente, siagura); • le oscillazioni per c velare e palatale, e per la labiovelare cu/qu; • l’uso errato di h (anno preso la medicina; andare ha Roma); • l’esecuzione incerta delle consonanti geminate; • l’uso logicamente incoerente dei segni di interpunzione. In fonologia si dovranno notare soprattutto fenomeni di • epentesi (pissicologico per psicologico); • aferesi (dirizzo per indirizzo); • assimilazioni («è un, come se dice, crettomane» [per cleptomane]). In morfologia: • largo impiego di ci tuttofare («ci dico» per ‘a lui’, ‘a lei’, ‘a loro’); • si per ci («quest’uva, se la portavamo a casa, si facevamo il vino»); • li/i per gli (li italiani, i scrutini, i gnocchi, «gli italiani li manca il senso di responsabilità»); • me e te in funzione soggetto; • lui/lo/gli come pronomi allocutivi («scusi signore gli posso chiederci un favore?», «Lui lo sa dov’è via Roma?»; • suo per loro («non ne sanno niente delle sue cose»); • oggetto preposizionale («a me non mi ha visto nessuno»); • morfologia verbale analogica (venghi, vadi, potiamo, soddisfava); • scambio di ausiliare («hanno cresciuto»); • analogia regolarizzante per i nomi irregolari («i ginocchi», «nessune parti», «molti complicazioni»); • forme analogiche del comparativo sintetico: il più superiore; il più meglio; la più male); • concordanza a senso, presente in modo assai più frequente rispetto all’italiano neostandard («la gente l’applaudivano»). Quanto alla sintassi, spiccano: • i temi sospesi («perché non mi va di andarci al mare io»); 52 • il periodo ipotetico con conguaglio di protasi su apodosi («se sarebbe venuto oggi, non sarebbe successo»; «se venisse, glielo dicessi»; «se venivi, ci vedevi»: quest’ultima forma è, ovviamente, diastraticamente meno connotata). • l’uso pervasivo del che polivalente, che in questo contesto si trova spesso dopo altra congiunzione subordinativa (mentre che, quando che, come che) e si presenta anche con clitico di ripresa disambiguante: «vidi un armadio che c’erano dei vestiti»; «una casa grande, che l’aveva comprata suo zio»; «un soldato vicino a me che gli dissi di andare»; • i cumuli di avverbi e congiunzioni con pleonasmo: invece anche, ma però, tuttavia comunque; avverbi e preposizioni: dentro da, sopra della casa; • l’aggettivo in funzione avverbiale e gli avverbi aggettivati oltre la frequenza media («siamo venuti diretti qui», «i nostri meglio amici»). Quanto alla sintassi della struttura informativa, sono naturalmente frequenti i fenomeni di tematizzazione (soprattutto le dislocazioni a destra e a sinistra già visti per la varietà neostandard). Nel lessico spiccano i malapropismi (cioè la ricostruzione analogica di lessemi malintesi: bimboniera < bimbo; palché ‘parquet’ < palco; micragna < emicrania) e le ricostruzioni paretimologiche di termini (celebre per celere, tavolato per tabulato, covalicenza per convalescenza, febbrite per flebite, comprativa per cooperativa ecc.). Sono presenti anche i cosiddetti popolarismi espressivi (tribolare ‘essere in pena’, macello ‘disastro’) e i popolarismi semantici (cioè il significato del lessema cambia rispetto al suo uso standard: ho un lavoro da fare ‘ho una faccenda da sbrigare’, non mollare ‘non cedere’ ecc.), spesso interpretabili – come gli esempi qui prodotti – anche come colloquialismi. Questi ultimi sono spesso connotati regionalmente. Se i malapropismi sono una marca peculiare dell’italiano popolare, va però osservato che popolarismi espressivi e popolarismi semantici possono entrare anche in varietà diafasiche orientate verso il basso. Il che significa che il confine tra ‘popolare’ e ‘colloquiale’ può essere labile. Non ha infine trovato conforto di dati l’esistenza di tipi diversi di marcatura diastratica: ad esempio, non corrispondono – a quanto pare – a una varietà socialmente connotata la lingua degli uomini o delle donne, distinta secondo il sesso, e le varietà generazionali. 53 3.4. LA VARIAZIONE DIAFASICA La variazione diafasica individua la varietà di lingua che dipende dalla situazione comunicativa, ossia dal contesto generale nel quale si compie lo scambio linguistico, contesto che determina le funzioni e le finalità del messaggio. In questa variazione assume dunque particolare importanza l’interazione tra parlante (o scrivente) e ascoltatore (o lettore), in base alla quale si articolano i registri di una lingua (sull’asse formale / informale: aulico, solenne, medio, colloquiale, trasandato, volgare, ecc.); assume altresì particolare importanza anche l’argomento del discorso e il riferimento enciclopedico che esso presuppone, in base ai quali si organizzano i sottocodici o lingue speciali (il cui riflesso in diastratia coincide più con i gruppi professionali che con le classi sociali). Facciamo un esempio. Si consideri il messaggio dei parenti che devono comunicare il decesso del signor Mario Rossi. È chiaro che il messaggio può subire delle variazioni anche molto significative a seconda della varietà diafasica scelta dal parlante (o scrivente). Naturalmente l’esempio ha un valore puramente indicativo, e i singoli enunciati potrebbero essere assegnati anche a una varietà vicina sull’asse della formalità. Inoltre, andrebbe anche precisata la situazione contestuale e pragmatica in cui si colloca l’enunciato, che ovviamente ne determina la specificità diafasica in modo assai rilevante. Registro formale aulico: «Ha lasciato la dimora terrena Mario Rossi»; «i parenti annunciano la dipartita di Mario Rossi»; registro sorvegliato: «È mancato all’affetto dei suoi cari Mario Rossi»; registro medio-alto: «il 27 marzo 1994 Mario Rossi è mancato»; registro medio: «Mario Rossi è morto»; registro informale: «Mario Rossi, se n’è andato»; registro trascurato: «Mario Rossi ci è rimasto secco»; registro basso: «Mario Rossi è crepato»; «Rossi ci ha lasciato le penne»; «… ha tirato le cuoia». Si capisce che quanto più è informale il registro (marca bassa della diafasia) tanto più la lingua è marcata in diastratia e diatopia: ospita cioè tratti socialmente bassi e regionalmente connotati. 54 Una osservazione anche distratta della precedente sequenza di esempi potrà mostrare che il livello linguistico più vistosamente interessato dalla variazione diafasica è, senza dubbio, quello del lessico, con estensione alla fraseologia. Tra le varietà diafasiche, quella che maggiormente ha sollevato l’interesse degli studiosi, dato il suo largo uso e la parziale sovrapposizione con alcuni tratti dell’italiano popolare (ma per le differenze cfr. il precedente paragrafo) è il cosiddetto italiano colloquiale. Una importante precisazione: «l’italiano colloquiale è adoperato in maniera indipendente dalla classe sociale di appartenenza, da parlanti di ogni ceto e di ogni grado di istruzione; anzi, nella misura in cui parlanti culturalmente sfavoriti hanno a disposizione solo l’italiano popolare, l’italiano colloquiale è varietà non degli strati bassi» (Berruto 1987, p. 139). La definizione di registro è un po’ limitativa per l’italiano colloquiale: siccome infatti esso può variare tra due poli di lieve diffrazione dalla formalità e di vistosa e trascurata informalità, Berruto (ibidem) ha proposto di definirlo come «una sorta di ‘superregistro’». Sono tipici del registro informale alcuni tratti lessicali: • le forme abbreviate (cine, bici, tele); • le forme gergali (farsi per drogarsi, ghirba, pelle); • i termini espressionisticamente connotati (andare in tilt, fare un macello, bestiale, smammare, trombare, rimorchiare ecc.); • le forme disfemiche (avere culo, farsi il culo, prender(se)lo in culo, di merda) Sul piano dell’espressività invece sono tipiche dell’italiano colloquiale le opzioni del tipo schiaffo / sberla, fuggire / scappare, prendere / pigliare, entrambi / tutt’e due, automobile / macchina; e l’uso di colloquialismi come aggiustare (‘conciare’), andare (‘passare’), bazzicare (‘frequentare’), beccare (‘colpire’), bestiale, cagnara, dare fuori; fare benzina, – fuori, – il biglietto, – in fretta, – una malattia, – la pace; filarino, fregare, partire (‘rompersi’), pazzesco, pizza (in senso traslato), prendere (‘costare’), sagoma, sbolognare, sfegatato, sfottere, sganciare, sciropparsi, spaghetto. Inoltre: i deverbali in -ata (stupidata, carognata, pensata, imbarcata); e di genericismi: tipo, coso, arnese, elemento, roba, affare, faccenda. Sono poi frequenti i costrutti elativi con forte («è acido forte questo vino»; «che forte!»), bello («un caffè bello caldo») con tutto («tutto pulito», «tutto arredato»), nonché il forte uso di demarcativi e particelle modali (allora, guarda, senti, in pratica, effettivamente, cioè, dico, dunque, insomma, un po’). A livello morfosintattico notiamo: 1. tendenza a evitare il passivo («l’hanno portato in ospedale»); 55 2. perifrasi aspettuali: (non sto a dirti, non stare a muoverti, essere lì per o lì che); 3. valore allusivo dei deittici quello e così: «ha preso tanti di quei colpi»; «gli ha fatto una testa così»; 4. il solito che polivalente, anche se con alcune restrizioni rispetto agli impieghi estremi del substandard popolare; 5. abuso di diminutivi (attimino, posticino, bellino) e forme nuove di elativi (da matti, un sacco, un mucchio, un casino, d’accordissimo, a postissimo, assolutamente). Scendendo nella scala dei registri si infittiscono imprecazioni, interiezioni, formule disfemiche, gergalismi (crepare, smenare, ganzo ecc.), talvolta anche marcati localmente. Al lato opposto, il registro formale aulico esporrà nessi e costrutti complessi, con forte elaborazione della sintassi e preferenza per l’ipotassi, o comunque per un maggior tasso di subordinazione; latinismi e forestierismi; allotropi e doppioni aulici (affinché invece di perché, giacché invece di poiché, questi pronome invece di questo, rammentare invece di ricordare, cagione per causa ecc. ); uso di forme impersonali e del passivo («si è preferito»; «M. fu vista arrivare»); perifrasi verbali (venire a, andare + agg. come in andare deluso) ecc. 3.4.1. SOTTOCODICI E LINGUE SPECIALI Si tratta di un settore particolarmente interessante anche per l’importanza che le lingue speciali hanno assunto nel contesto dell’attuale società della comunicazione. Pier Vincenzo Mengaldo ha operato un’importante distinzione tra lingue speciali, cioè sottocodici dotati di lessico particolare e tratti caratteristici a livello morfosintattico e di organizzazione testuale, e lingue settoriali, contaddistinte da una scelta lessicale e da formule sintattiche e testuali, ma prive di un lessico specialistico. Sempre secondo Mengaldo, a queste condizioni, soltanto il linguaggio della scienza e della tecnica e quello dello sport (forse) possono dirsi lingue speciali.8 Riprendiamo ora, e facciamo reagire con la proposta di Mengaldo, l’articolata definizione che di lingua speciale ha dato un altro studioso, Michele Cortelazzo.9 Dunque la lingua speciale è «una varietà funzionale di una lingua naturale, dipendente da un settore di conoscenze o da una sfera di attività specialistici, utilizzata, nella sua interezza, da un gruppo di parlanti più ristretto della totalità dei parlanti la lingua di cui quella speciale è una varietà, per soddisfare i bisogni comunicativi (in primo luogo quelli referenziali) di quel settore 8 9 Pier Vincenzo Mengaldo, Il Novecento, Bologna, Il Mulino, 1994. Michele Cortelazzo, Le lingue speciali, in Lingue speciali. La dimensione verticale, Padova, Unipress, 1990 2. 56 specialistico; la lingua speciale è costituita a livello lessicale da una serie di corrispondenze aggiuntive rispetto a quelle generali e comuni della lingua e a quello morfosintattico da un insieme di selezioni, ricorrenti con regolarità, all’interno di forme disponibili nella lingua» (Cortelazzo 1990, pp. 7-8). 3.4.2. I LINGUAGGI TECNICO -SCIENTIFICI Il linguaggio tecnico-scientifico rappresenta quindi l’esempio più tipico di lingua speciale in senso stretto. Il lessico dei linguaggi tecnico-scientifici si distingue da quello della lingua comune per almeno tre caratteristiche: 1. necessità di impiegare segni aggiuntivi rispetto a quelli componenti la lingua comune, allo scopo di ottemperare ai bisogni di denominazione del settore specifico a cui la lingua speciale afferisce, più vasti e più sottili in confronto all’offerta lessicale della lingua comune. Tali bisogni saranno motivati dall’esigenza di riferirsi: - a oggetti e nozioni non percepibili dall’esperienza del non specialista; - a elementi riguardanti nuovi prodotti tecnici sovente immessi nel mercato in rapida successione (ad esempio si pensi alla pletorica invasione di cose e di parole cui ci ha sottoposti l’industria informatica); - a porzioni di realtà cui la lingua comune fa fronte con termini troppo generici rispetto a una maggiore analiticità richiesta dalla lingua speciale (ad es. cefalea, emicrania vs mal di testa; tonsillite, faringite vs mal di gola); 2. tendenza alla monoreferenzialità; il lessico di un linguaggio scientifico si organizza nella forma di nomenclatura, cioè di un insieme di termini definiti e tassonomicamente ordinati, ciò che dovrebbe evitare la concomitanza di sinonimi, in quanto ogni termine può essere sostituito solamente da una sua definizione o perifrasi. In realtà l’univocità semantica non solo è limitata al campo disciplinare in cui il termine viene impiegato, ma anche all’interno di un singolo settore specialistico fatica ad attuarsi in virtù della presenza di diverse tradizioni storiche nella denominazione, ovvero di discrepanze terminologiche comportate da diverse prospettive teoriche. In casi estremi, dunque, ma non infrequenti, la monosemia è da intendersi come circoscritta al testo in cui il termine scientifico appare; 57 3. presenza di tecnicismi collaterali, cioè di espressioni stereotipiche che, pur non necessitate dal bisogno di denotatività, sono preferite per la loro connotazione tecnicoscientifica: prive della precisione veicolata dalla monosemia, esse vengono usate appunto per il loro alone settoriale (ad es. «il paziente accusa un dolore», «la parotite può esitare in pancreatite»). Diverse sono le tecniche di formazione o adozione di termini scientifici, che per altro non differiscono qualitativamente da quelle peculiari alla lingua comune. Si segnalano dunque i seguenti fenomeni notevoli: 1) rideterminazione semantica di termini già presenti nella lingua comune, che vengono resi monoreferenziali cancellandone la storia precedente attraverso un convenzionale “accordo di definizione” (Bloomfield). Si vedano ad es. i termini della fisica (ad es. massa, forza, momento), che passano dal significato generico a quello definito e univoco quando sono impiegati in ambito scientifico (di tale metodo si serviva in genere Galileo). 2) rideterminazione semantica di termini appartenenti ad altre lingue speciali, ad es. dalla medicina all’astrofisica (collasso ‘rapida contrazione di stelle dovuta al prevalere delle forze di gravità su quelle di pressione’); 3) neoformazioni, quasi mai assolute, in genere ottenute per derivazione o per composizione da parole delle lingue classiche, spesso rese oggetto di un cospicuo mutamento semantico. Il procedimento di neoformazione più frequente è l’aggiunta di affissi (prefissi, suffissi e suffissoidi) peculiari alle lingue speciali (emi- e -oma in medicina) ovvero identici a quelli presenti nella lingua comune, ma in ogni caso dotati all’interno del settore specialistico di un univoco significato convenzionale (-oso e -ico in chimica, -osi e -ite in medicina). La relativa trasparenza del significante che contraddistingue i neologismi per derivazione è alla base della analoga fortuna dei composti nominali, in cui spesso è forte l’influsso della lingua inglese, ciò che comporta caratteri innovativi rispetto ai composti tradizionali della lingua italiana (ordine determinante-determinato, la possibile presenza di elementi nella composizione in numero superiore a due, mancata grammaticalizzazione del rapporto fra gli elementi compositivi); La sintassi dei linguaggi tecnico-scientifici si offre ancor meno del lessico all’individuazione di fenomeni specifici, in quanto si basa su procedimenti presenti nella lingua comune, dei quali varia soltanto la frequenza, che diventa pervasiva. Questi i fatti principali, largamente interdipendenti: 58 1) diffuso processo di nominalizzazione, cioè ai sintagmi verbali si preferiscono sintagmi nominali equivalenti, caratterizzati dalla presenza di nomina actionis (es.: «dopo l’accensione, verificare per qualche minuto il regolare funzionamento dell’apparecchio»); 2) frequenza di forme nominali del verbo, participi presenti e passati, sia con valore verbale ancora percettibile, sia in usi cristallizzati simili all’ablativo assoluto latino (ad es. dato + sost. nelle discipline matematiche); 3) radicale riduzione di tempi, modi e persone verbali, con prevalenza del presente indicativo (com’è ovvio, stante la prevalente natura descrittiva degli scritti scientifici) e continuo uso della diatesi passiva e di forme impersonali; notevole è poi la presenza di espressioni tendenti alla cancellazione del soggetto enunciante, trasposto in tal modo alla terza o alla quarta persona (ad es. chi scrive, l’autore, uso del plurale d’autore: chiameremo, procederemo ecc.); 4) uso di un parco piuttosto esiguo di verbi generici (essere, consistere, rappresentare, riferirsi, comportare, verficarsi), impiegati perlopiù in sintagmi del tipo verbo + sostantivo, nei quali la seconda parte, sostantivale, rappresenta il nucleo semantico (es. «si verifica una deflagrazione»); 5) impiego di un gruppo particolare di connettivi testuali tendenti all’articolazione del discorso argomentativo, specie di causalità e di conseguenza (perciò, pertanto, cioè, appunto, quindi, dunque) o alla enumerazione (prima-poi-infine, in primo luogo-in secondo luogo-in terzo luogo); 6) largo uso di formule limitative come «a quanto sembra», «sembra lecito dedurre», «si può dire plausibilmente che», «si può avanzare l’ipotesi», «risulta possibile affermare che» ecc. L’osservazione più immediata che deriva dall’analisi di tali fenomeni non può che vertere sulla evidente perdita di importanza del verbo, cui corrisponde un largo aumento quantitativo e qualitativo dei sostantivi e delle parti sostantivate: ne deriva l’alta densità semantica di questi testi, espressione di una tendenza all’economia tipica del discorso scientifico. Un’altra caratteristica facilmente rilevabile è la tendenza alla desoggettivizzazione, conforme al proposito di descrivere fenomeni e processi da un punto di vista impersonale e oggettivo; non a caso le frequenti forme passive sono in genere prive di indicazione di causa o agente. Anche se poco studiato, il livello testuale può forse essere identificato come quello che distingue maggiormente i linguaggi scientifici tra di loro, dalla lingua comune e anche dai linguaggi scientifici stranieri. 59 Una prima vistosa caratteristica dei testi scientifici è la frequente presenza di schemi, tabelle, grafici e illustrazioni; notevole importanza rivestono poi gli aspetti di coerenza e coesione testuale più comuni, che sono: 1) la referenza anaforica, che si realizza soprattutto come rinvio testuale, sia del tipo «cfr. infra», «v. oltre», sia in forma di sintagmi anaforici e cataforici (ad es. «detta ipotesi», «come si vedrà nel capitolo seguente»). Rispetto alle anafore pronominali nei casi di coreferenza invece il linguaggio scientifico preferisce in genere la ripetizione lessicale, che consente una maggiore precisione; 2) la funzione organizzatrice dei connettivi testuali di causa e conseguenza; 3) la rigidità della struttura testuale, compensata però dal largo numero di tipi testuali disponibili per le diverse aree disciplinari, più o meno tutti basati sullo schema fondamentale a quattro parti: 1. introduzione; 2. problema; 3. soluzione; 4. conclusione. Qualsiasi testo scientifico dovrebbe poi soddisfare alle condizioni di (a) chiarezza, (b) coerenza, (c) assenza di contraddizioni. Come hanno dimostrato studi recenti, le lingue speciali conoscono una variazione sul piano sociolinguistico. La stratificazione diafasica dei linguaggi tecnico-scientifici può essere individuata in tre livelli: 1) lingua speciale a livello alto, tipica della comunicazione scritta ufficiale tra esperti. La differenza dalla lingua comune è massima, soprattutto per la estrema precisione settoriale del lessico; 2) lingua della comunicazione diretta informale tra tecnici, perlopiù orale (ma anche scritta ad es. in appunti). Permette una forte economia verbale, dato il contesto situazionale comune e la condivisione di ampie conoscenze enciclopediche. Si possono così registrare formulazioni linguistiche abbreviate (ad es. bianchi per globuli bianchi), forme mistilingui con lessico straniero e morfologia italiana (ad es. formattare, resettare); 3) lingua della divulgazione, che viene usata nel contatto fra esperto e profano, nella divulgazione attraverso i mass media, nella didattica. La lingua scientifica a livello divulgativo si avvicina alla lingua comune, che svolge la funzione di metalingua: parole del lessico specialistico vengono sostituite da parole del lessico comune o da perifrasi, pur non del tutto equivalenti, ovvero vengono accompagnate da una glossa esplicativa in lingua comune; frequente è il tentativo di spiegare i concetti tecnici con l’aiuto di metafore o 60 analogie; le forme verbali godono di una ben maggiore libertà e si dissolve la rigidità dell’organizzazione testuale. Un’altra forma di stratificazione sarà da individuare anche nell’ambito della ricezione: non tutti i destinatari associano a un termine scientifico lo stesso significato. Per molti termini della lingua d’uso (termini di genere naturale, soprattutto), esiste una varietà nella capacità dei parlanti di individuare il riferimento, motivata da quella che il grande filosofo analitico americano Hilary Putnam ha chiamato «divisione del lavoro linguistico»: in una comunità soltanto un gruppo ristretto di “esperti” conosce precisamente i criteri di riconoscibilità (e dunque la definizione scientifica) di un termine indicante un dato oggetto (ad es. “acqua”); gli altri parlanti associano invece a tale termine uno «stereotipo», cioè dispongono di una competenza ristretta ad alcuni «fatti essenziali» circa l’oggetto referente della parola. Putnam distingue tra «stereotipi forti» (il parlante conosce le condizioni sufficienti per l’appartenenza di un oggetto a una classe, ad es. nel caso di limone o tigre) e «stereotipi deboli» (il parlante non ha idea di tali condizioni, ad es. nel caso di molibdeno). Va da sé che i termini scientifici detengono nella competenza media dei parlanti stereotipi deboli, anzi nella maggior parte dei casi inesistenti, consentendo al parlante al più di orientarsi vagamente nella classificazione (comprendendo ad es. che la osteomielite è un’infiammazione), oppure di comprendere soltanto l’area disciplinare di provenienza del termine (ad es. catalisi enzimatica, per la relativa familiarità con la parola enzima), ovvero impedendo qualsiasi riconoscimento, a parte la facilmente congetturabile appartenenza del termine alla sfera della scienza (ad es. mirmecofilia, che forse solo un discreto conoscitore del greco antico può assegnare alla zoologia, trattandosi della ‘tendenza di piante o animali a vivere in rapporto simbiotico con formicidi’). Si può concludere dunque che una larga quantità di termini scientifici non comunicano altro al destinatario medio se non di essere, appunto, termini scientifici. L’influsso esercitato dai sottocodici tecnico-scientifici sulla lingua comune è certamente notevole. Mentre è difficile verificare, se non in tempi molto estesi, il passaggio dagli uni all’altra di tratti sintattici, del resto quasi tutti potenzialmente presenti già nella lingua comune, ben più visibile risulta il trasferimento di termini del lessico tecnico-scientifico nel lessico comune, che avviene principalmente attraverso il vettore dei mass media, oltre che, in misura minore, in virtù dell’incontro diretto del parlante non esperto con parlanti del settore specialistico. La tendenza all’ingresso di tecnicismi nella lingua d’uso, in parallelo con il progresso tecnico-scientifico, non ha fatto, naturalmente, che acuirsi, in particolare dopo il boom 61 industriale degli anni ’50: il parlante, inserito nei processi di produzione, si è trovato ad acquisire una competenza minima tecnico-scientifica (soprattutto tecnica), per nominare con precisione gli oggetti che lo affiancano sul lavoro, nonché quelli che la produzione tecnica dell’industria neocapitalistica gli offre come consumatore. Questo ampliamento del lessico non rimane però senza effetti. Quando si trasferisce dal sottosistema della lingua speciale al sistema della lingua comune il termine tecnico-scientifico può mantenere il senso proprio, o acquistare un senso metaforico. Anche nel primo caso, comunque, il passaggio comporta la riduzione, quando non l’annullamento, dei caratteri propri del lessico scientifico: monoreferenzialità, precisione, collocazione in una tassonomia gerarchica, rapporto con termini riferentisi alla stessa area settoriale, legame privilegiato con la cosa significata. In conseguenza di ciò il termine perde parte della sua funzione denotativa e acquisisce potere connotativo, fregiandosi di un margine evocativo, che lo differenzia dalle parole vicine a grado zero di connotazione. Il termine tecnico-scientifico si trova così in molti casi non a denotare con precisione, ma a evocare la precisione mediante il suo aspetto esteriore, quasi un camice bianco. L’illusione di precisione scientifica non serve che a certificare l’autorità dell’emittente e a conferire maggiore prestigio ai contenuti del messaggio. Tale impiego mistificatorio del linguaggio tecnico-scientifico, con fini di persuasione, viene sfruttato principalmente nella lingua della pubblicità (infiniti potrebbero essere gli esempi: si va dai pretensionatori delle cinture di sicurezza di un’automobile ai radicali liberi di una crema anti-rughe). In altri casi il lessico specialistico viene utilizzato in accezione impropria, metaforica, allo scopo di ottenere un discorso incisivo e brillante, in ossequio alla moda e alla contiguità con le sfere di pensiero privilegiate. Se, insomma, può esistere un uso onestamente referenziale del linguaggio tecnicoscientifico (ad esempio nella seria divulgazione), è poi senza dubbio vero che nella comunicazione di tutti o giorni prevale un impiego che si può anche chiamare feticistico. Feticistico perché il valore d’uso del lessema (l’individuazione di un significato condiviso) viene sostituito da un mero valore di feticcio, che millanta lo status up to date della cultura scientifica del parlante, mentre non fa che dimostrarne l’alienazione, linguistica e non solo. Proprio il mero funzionalismo referenzialista del linguaggio come pratica sociale porta a quello che Günther Anders ha chiamato «monologo collettivo»: tutti conoscono – o credono di conoscere – le stesse cose, pertanto le informazioni che circolano sono del tutto inutili, configurando null’altro che uno «scambio tautologico» di parole ribattute come palle da tennis. È evidente che proprio la veste “tecnica” del lessico usato – del tutto rescissa dal 62 vincolo del significato – ha un decisivo ruolo sul piano diastratico: mostra, anzi esibisce l’appartenenza, autentica o simulata, di un parlante a un gruppo sociale alto, quello che appunto si identifica nella disponibilità dei mezzi tecnici più avanzati. In conclusione è opportuno rilevare come la grande e crescente presenza dei linguaggi speciali e settoriali anche e soprattutto all’interno della lingua d’uso sia uno dei fattori più rilevanti della lingua di oggi, e come tale registrato a livello lessicografico nei più recenti strumenti del settore (tantissimi i tecnicismi riportati nel GRADIT). Va però detto che molto spesso l’uso di tecnicismi non è dettato da scopi denotativi, ma da logiche di identificazione e (relativa) emarginazione sociale. Se dunque un miglioramento delle conoscenze scientifiche va senz’altro incoraggiato, è altrettanto opportuno mettere in guardia dalla opacità (o addirittura doppiezza) comunicativa che l’uso eccessivo o improprio di tecnicismi può comportare. 63
Scaricare