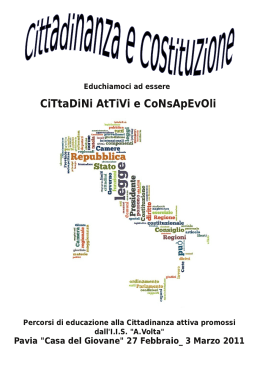RASSEGNA STAMPA venerdì 22 maggio 2015 L’ARCI SUI MEDIA INTERESSE ASSOCIAZIONE ESTERI INTERNI LEGALITA’DEMOCRATICA RAZZISMO E IMMIGRAZIONE DIRITTI CIVILI E LAICITA’ BENI COMUNI/AMBIENTE INFORMAZIONE SCUOLA, INFANZIA E GIOVANI ECONOMIA E LAVORO CORRIERE DELLA SERA LA REPUBBLICA LA STAMPA IL SOLE 24 ORE IL MESSAGGERO IL MANIFESTO AVVENIRE IL FATTO PANORAMA L’ESPRESSO VITA LEFT IL SALVAGENTE INTERNAZIONALE L’ARCI SUI MEDIA Da Redattore Sociale del 21/05/15 Cultura, "per le imprese non profit bandi ad hoc, non pacche sulle spalle" Forum terzo settore: "La cultura è l’ambito in cui l’impresa sociale prevista dalla riforma potrà funzionare meglio”. l"Borgomeo (Fondazione con il Sud): “Basta incoraggiamenti, serve coinvolgimento in interventi di sviluppo” ROMA - “La cultura è l’ambito in cui l’impresa sociale prevista dalla riforma potrà funzionare meglio”: lo ha affermato il direttore del Forum Terzo Settore Domenico Iannello nell’ambito dell’incontro “Il no-profit e le politiche culturali” che si è tenuto questa mattina a Roma con l’obiettivo di coinvolgere organizzazioni no-profit, enti locali e istituzioni in una riflessione sul ruolo del terzo settore nelle attività artistiche e culturali, che possa incidere nel percorso di definizione della riforma complessiva in corso. Iannilli ha evidenziato come il settore culturale possa sostenere gli interventi sociali: “La cultura è un elemento di coesione, dove le attività di recupero delle tradizioni, di salvaguardia ambientale e valorizzazione dei beni culturali, incontrano le attività svolte con carcerati e da comunità di recupero”. Carlo Testini dell’Arci ha sottolineato come secondo gli ultimi dati Istat le organizzazioni non profit che promuovono attività artistiche e culturali in Italia sono 54mila, con 65 mila occupati e 2 milioni e 815 mila volontari: “Si occupano di valorizzazione del patrimonio culturale, di accesso alla cultura organizzando attività culturali, di advocacy di volontariato per la salvaguardia del paesaggio, di progettazione culturale per lo sviluppo territoriale”. “Le imprese profit attive nello stesso settore sono circa 28 mila”, ha aggiunto Testini, evidenziando come le imprese profit coinvolte nel mondo della cultura siano un numero molto inferiore a quelle non profit. “Vi sono nove associazioni nazionali di cultura cinematografica riconosciute dal ministero della cultura – ha detto Testini – che associano più di mille circoli del cinema, luoghi fortemente legati al territorio, che promuovono 300 film che altrimenti non vedremmo nelle sale”. “25 delle società concertistiche più importanti in Italia sono associazioni no profit”, ha aggiunto. “Queste attività coinvolgono moltissimi giovani e ciò le rende interessanti dal punto di vista occupazionale - ha affermato il rappresentante dell’Arci - ma l’83 per cento di queste organizzazioni non fa raccolta fondi”. Marco Cammelli, presidente della Commissione Attività e Beni Culturali Acri ( Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa) ha evidenziato l’esigenza di “distinguere tra volontariato e impresa”: “E’ necessario che la promozione culturale sia fatta da un’impresa, altrimenti i volontari guardano verso il finanziatore (fondazione o ente pubblico) e non all’utente. “E’ necessario tenere una contabilità separata per attività di impresa e quella volontaristica” ha aggiunto. Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud ha evidenziato come tra il mondo della cultura e il mondo dell’impresa vi siano “analogie importanti da riscoprire e mettere sul tavolo”, date dal fatto che “rispetto alle politiche generali di sviluppo entrambe sono considerate marginali”. “La battaglia oggi è quella di capovolgere il paradigma”, ha aggiunto. “Non bisogna investire in sociale e culturale, perchè è moda o per fare un favore a qualcuno ma perché significa sviluppo”, ha detto Borgomeo. “A Lamezia il terzo datore di lavoro è un consorzio di cooperative sociali”, ha sottolineato. “Per questo – ha concluso 2 Borgomeo – non servono pacche sulle spalle ma bandi, come i Pon, che siano destinati alle imprese non profit”. “Il capitale sociale si rafforza con la cultura e non è un lusso che ci potremo permettere quando i conti saranno in ordine, ma una premessa dello sviluppo”. (lj) del 22/05/15, pag. 7 A Carpi la festa nazionale dell’Anpi Si svolgerà a Carpi (Mo) dal 30 maggio al 2 giugno la quarta Festa nazionale dell’Anpi. «E’ il 70° anniversario della Liberazione e svolgere questa iniziativa in un luogo a brevissima distanza dal Campo di Fossoli, gestito dai fascisti e di ’smistamento’ per destinazioni terribili - i campi di sterminio della Germania - assume un significato particolarmente pregnante. Saranno quattro giorni ricchi di incontri, dibattiti, eventi musicali e teatrali da cui uscirà un quadro del Paese, nonché una rappresentazione significativa dello stato attuale della Associazione», ha detto il presidente Carlo Smuraglia. Tante le tematiche dei forum politico-culturali in programm a: dal punto sul contrasto giuridico e politico ai neofascismi, alle modifiche della Costituzione, dal contributo del sud alla Liberazione, all’emancipazione femminile fino alla tavola rotonda sul «significato del 2 giugno oggi » condotta da Gad Lerner con Susanna Camusso, Cecilia Strada e Francesca Chiavacci. Da Redattore Sociale del 22/05/15 Decreto accoglienza. Asgi e Arci: "Delusi dal mancato dialogo con il governo" I pareri tecnici delle organizzazioni aderenti al Tavolo asilo scartate dal governo nel decreto legislativo di recepimento delle direttive europee. Schiavone (Asgi): "Meritavamo trattamento diverso". Miraglia (Arci): "Per questo governo le organizzazioni sociali sono solo un fastidio” ROMA - C’è delusione tra le associazioni del tavolo asilo dopo essere state messe di fronte ad uno schema di decreto legislativo che recepisce le direttive europee sull’accoglienza e sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Dopo la notizia del decreto approvato in Consiglio dei ministri e commentata con una nota congiunta, gli interrogativi sul mancato dialogo restano ancora senza risposta. “Il governo – spiega Filippo Miraglia, responsabile immigrazione Arci -, nel recepire le due direttive non ci ha minimamente consultato. Abbiamo chiesto noi di essere consultati e il sottosegretario all’Interno, Domenico Manzione, ci ha ricevuti e abbiamo fatto le nostre osservazioni. Non ci hanno risposto e alla fine Manzione ci ha dato la versione finale del testo”. Una brutta sorpresa, spiega Gianfranco Schiavone, dell’Asgi, l’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, dopo un confronto “interessante” a cui le associazioni hanno partecipato con impegno. “Abbiamo presentato proposte di modifica o integrazione a bozze informali che ci erano state sottoposte – spiega Schiavone -, ma in un’ottica assolutamente costruttiva. Sono state mandate proposte che non avevano lo scopo di stravolgere l’impianto iniziale, ma di migliorarlo. Non ci aspettavamo un completo 3 accoglimento, ma innanzitutto una risposta, positiva o negativa”. Dal Viminale, però, nessuna risposta fino al giorno un cui al Tavolo asilo, composto da Acli, Arci, Asgi, Caritas italiana, Federazione Chiese Evangeliche in Italia, Centro Astalli, Comunità di S. Egidio, Consiglio Italiano per i Rifugiati, Casa dei diritti sociali, Save the children, non è stato proposto il testo approdato al Consiglio dei ministri. “Tutto si è perso in un autentico porto delle nebbie – spiega Schiavone -. Per via informale, oggi sappiamo che i testi non sono stati modificati o solo in maniera minima. Ci si chiede perché, visto che su molte cose abbiamo proposto misure di buon senso. Abbiamo avuto come la percezione che la macchina si fosse chiusa su se stessa”. Per Schiavone, però, non tutto è perduto. Al testo serviranno altri passaggi, su cui il Tavolo asilo promette di fare pressione. “Quello presentato è uno schema di decreto – spiega -. Il governo deve andare in conferenza unificata e assumere il parere delle commissioni competenti di Camera e Senato. Ci sono dei pareri che devono essere tenuti in considerazione, come quelli degli enti ad oggi non adeguatamente utilizzati. Lo spazio di modifica c’è ed è anche molto ampio. Noi riproporremo al governo e alle commissioni parlamentari le nostre proposte”. Tuttavia, nonostante non manchi un margine di intervento, ad oggi predomina la delusione. “Sì, c’è – afferma senza mezzi termini Schiavone -. Da parte nostra c’è stato un lavoro molto meticoloso che meritava un trattamento diverso. Nel momento in cui il governo si trova di fronte a interlocutori competenti e unificati, quando queste proposte sono sicuramente non in rotta di collisione col governo, la domanda è: che concezione c’è del confronto? Esiste o no?”. Stesso sentimento per Miraglia, che spiega: “Ci è sembrato ancora una volta un modo per segnare il fatto che per questo governo le organizzazioni sociali sono solo un fastidio”. Oltre alla delusione, però, c’è anche forte preoccupazione sul futuro dell’accoglienza in Italia. Un sistema che non riesce ancora a scrollarsi di dosso l’etichetta “emergenza”. Per Miraglia, infatti, “la vicenda continua ad essere gestita in maniera del tutto emergenziale – spiega -, senza porsi l’obiettivo di chiudere la stagione dell’emergenza e iniziare a fare una programmazione. Se non smetti di reclutare albergatori e privati che non hanno nessuna competenza, non ne uscirai mai. In questo momento si sta continuando a chiedere ai privati di mettere a disposizione posti letto perché ne hanno bisogno e mettono queste persone che arrivano dove capita”. Preoccupano anche i cosiddetti “hub” o centri di smistamento. “La nostra più grande preoccupazione - spiega Schiavone - è che il sistema, articolato tra hub e sistema di accoglienza territoriale, sia una previsione che rischi di naufragare. C’è il rischio che con gli hub si ripropongano di fatto le stesse modalità dei Cara. Si ripropone, quindi, ciò che si dice di voler abrogare. Noi avevamo chiesto che venisse distinta la funzione di centro di primo ingresso dall’accoglienza vera e propria e che l’incardinamento delle domande d’asilo avvenisse sui territori e in nessun caso negli hub, altrimenti c’è solo un cambio di etichetta truffaldino”. Torna l’incubo dei Cie. C’è poi la questione dei tempi d’accoglienza nei Cie che nel decreto rischia, secondo Schiavone, di avere profili incostituzionali. “Bisognerà vedere il testo finale – chiarisce Schiavone -. L’allungamento dei tempi, però, prevede un trattamento dei richiedenti asilo peggiore rispetto agli altri stranieri in generale. Questo solleva problematiche di legittimità costituzionale”. Per Schiavone, infatti, è “paradossale che mentre la legge prevede il trattenimento fino ad un massimo di 90 giorni nei Cie, per una particolare categoria di stranieri si preveda un trattamento enormemente maggiore. C’è una chiara incongruenza giuridica. Si parla di portare i tempi fino a 12 mesi”. In realtà le richieste del tavolo andavano nella direzione opposta, nell’alleggerire il sistema. “Neanche immaginavamo che i tempi potessero essere superiori degli stranieri in generale e non si poteva immaginare l’ipotesi che fossero trattenuti anche i richiedenti asilo che 4 hanno avuto un diniego, hanno presentato ricorso e che hanno ottenuto una sospensiva. Anche il testo è linguisticamente assurdo perché parla di prosecuzione del trattenimento dello straniero autorizzato a soggiornare. Non serve essere particolarmente raffinati per notare una clamorosa incongruenza”. Infine la delusione per quanto riguarda le commissioni esaminatrici delle richiede d’asilo. Secondo Schiavone, nel testo “non ci sono né misure di carattere minimo, né sostanziale, quando invece il governo ha ben presente il problema, cioè quello della conformità dell’attuale normativa alla direttiva europea laddove parla di possesso dei necessari requisiti di competenza da parte degli organi incaricati”. Sulla promessa del presidente del Consiglio, Matteo Renzi, di voler recuperare delle salme delle vittime del naufragio del 19 aprile costato la vita a circa 800 migranti, è Miraglia a commentare. “Bisogna riconsegnare alle famiglie una notizia certa sulla loro morte – spiega -. Alle persone che sono rimaste vive bisogna dare la possibilità di avere un tomba con un nome su cui poter piangere o pregare. A noi sembra incredibile che il governo italiano possa prendere in considerazione l’ipotesi che questi corpi possano essere lasciati a marcire in mezzo al mare. Bisogna fare tutto il possibile per restituire alle famiglie la notizia certa della morte di queste persone. Si tratta di persone a cui va data la possibilità di essere seppelliti come tutti gli altri”.(ga) Da il FattoQuotidiano.it del 22/05/15 Giornata internazionale di azione europea: l’operazione Eunavfor Med attira più delle quote Erika Farris Giornalista, mediatrice culturale Oggi, venerdì 22 maggio, è la Giornata internazionale di azione per la libertà di movimento, lavoro e residenza in Europa. Per l’occasione numerose piazze europee si animeranno di iniziative ed eventi, come la manifestazione promossa dalla Coalizione internazionale sans-papiers e migranti (Cispm) insieme all’Unione sindacale di base (Usb) e alla Carovana europea dei migranti, che si terrà in piazza dell’Esquilino a Roma dalle ore 15. “Siamo parte degli oltre 33 milioni di migranti, di cui 12 milioni già appartenenti all’Unione Europea – spiega il comunicato stampa dell’iniziativa – che vivono in uno dei 28 paesi membri e rappresentano il 4% dei 509 milioni di abitanti. […] Siamo quei richiedenti asilo e rifugiati diventati ‘pacchi di spedizione’ tra i vari Stati dell’Ue a causa del Regolamento Dublino III: un vero sistema di apartheid che esprime tutta l’ipocrisia dell’Europa e dei suoi Stati membri, Italia compresa!” Nel frattempo le numerose associazioni che compongono il Tavolo Nazionale Asilo si sono apertamente schierate contro il decreto legislativo di recepimento delle normative europee sull’accoglienza e le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri durante la giornata del 19 maggio. “Il decreto istituisce i cosiddetti Hub – spiega il documento diffuso dal Tavolo Asilo – centri di accoglienza regionali/interregionali dove dovrebbero essere realizzate le operazioni di 5 identificazione e formalizzazione della domanda di protezione. C’è il timore che questi centri possano replicare l’inefficace e segregante esperienza dei Cara (Centri accoglienza per richiedenti asilo, ndr).” Composto da Acli, Arci, Asgi, Caritas italiana, Federazione Chiese Evangeliche in Italia, Centro Astalli, Comunità di S. Egidio, Consiglio Italiano per i Rifugiati, Casa dei diritti sociali e Save the children, il Tavolo Nazionale Asilo reputa inoltre “allarmante il tema della detenzione dei richiedenti asilo nei Cie (centri identificazione ed espulsione, ndr), che la proposta di decreto prevede di estendere sino a 12 mesi per quanti presentino un ricorso contro il diniego alla loro domanda di protezione. Il Tavolo Asilo chiede di limitare fortemente sia i tempi sia le fattispecie per il trattenimento nei Cie, disponendo una chiara esclusione delle situazioni vulnerabili e prevedendo che in caso di ricorso con accoglimento dell’istanza sospensiva all’espulsione il richiedente sia ricevuto nelle strutture ordinarie di accoglienza.” Dopo circa un mese dal tragico naufragio che ha contato oltre 700 nuovi morti nel Mediterraneo, l’Unione Europea non sembra dunque riuscire ad affrontare con lungimiranza e responsabilità la questione dei flussi migratori. La triplicazione dei fondi destinati alla missione Triton, passata da 3 a circa 9 milioni di euro al mese, pare principalmente finalizzata a sorvegliare i confini Europei piuttosto che a garantire soccorso in mare, come dimostra il ruolo e la mansione assegnata all’agenzia Frontex, coordinatrice dell’operazione. A ciò si aggiungono gli 11,82 milioni di euro stimati per l’avvio della missione militare Eunavfor Med: un’operazione proposta dai ministri degli Esteri e della Difesa dell’Ue e che verrà valutata durante il prossimo Consiglio Europeo previsto per il 25-26 giugno. Un piano d’azione che dovrebbe essere guidato dall’ammiraglio italiano Enrico Credendino e che si porrebbe l’obiettivo di bloccare, ispezionare e distruggere i barconi utilizzati dai trafficanti per il trasporto dei migranti, operando in acque internazionali e sotto il consenso delle autorità libiche. Al momento Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna e Grecia hanno già messo a disposizione le proprie navi militari per prendere parte alla missione, e la grande maggioranza degli altri paesi dell’Ue si è detto favorevole all’operazione. Meno disponibilità è stata invece dimostrata quando si è parlato di quote percentuali per ridistribuire i richiedenti asilo fra i vari stati europei, a emblematica dimostrazione di quando poco unita sia questa Unione e di quanto opportunismo e indifferenza si celi dietro l’ipocrisia di tante belle parole. http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/22/giornata-internazionale-di-azione-europealoperazione-eunavfor-med-attira-piu-delle-quote/1705706/ del 22/05/15, pag. 6 Con “Si, Toscana a sinistra” e il candidato Tommaso Fattori Contro la mutazione genetica Televisioni e giornali ripetono ogni giorno che le prossime elezioni regionali sono «una conta per Renzi». Come se quell’articolo 3 della nostra Costituzione che afferma il diritto di ogni cittadina/o a contribuire a determinare le scelte politiche del paese potesse tradursi in una risposta al quesito: ti piace? O non ti piace? La prima cosa su cui pronunciarsi col voto è proprio questa: se acconsentiamo o meno a che la democrazia possa ridursi all’accettazione passiva di decisioni che le cittadine e i cittadini non hanno contribuito a determinare. Perché la partecipazione in questi decenni si 6 è ridotta al minimo, spariti i partiti, sparita quella fitta rete di organizzazioni, di sedi comuni, che un tempo dava voce a tutti. L’approvazione della nuova legge elettorale – per via del metodo seguito per imporla e per la sua sostanza autoritaria – ma più in generale tutto il modo di governare di Renzi, al di là dei pur gravi contenuti delle singole scelte (manomissione della Costituzione, scuola, jobs act, ecc.), hanno espropriato e mortificato ulteriormente la sovranità delle cittadine e dei cittadini, accelerando l’erosione del tessuto democratico del nostro paese(…). Quanto è accaduto è un vero stravolgimento dell’identità e natura del Pd. Le elezioni regionali sono, pur nei loro limiti, l’occasione per ridare fiducia nella politica (…) Coloro che hanno dato vita alla lista “SI’ Toscana a sinistra” che candida Tommaso Fattori alla presidenza della Regione – giovani soprattutto, ma anche meno giovani, impegnate/i nelle organizzazioni della società civile, nei movimenti, nei partiti di sinistra tuttora esistenti, un’aggregazione di volenterose/i che però i sondaggi danno a più del 10 % – si propongono per prima cosa di riattivare l’impegno, di combattere la passività e la sfiducia, il disfattismo verso qualsiasi tentativo a sinistra, il superamento di antiche divisioni (…). Il Pd toscano ha subìto una profonda mutazione genetica, ed Enrico Rossi non ha più alcun margine di indipendenza politica dalla linea di Matteo Renzi. Quel modello è finito. Lentamente ma inesorabilmente gli interessi forti hanno infatti riguadagnato terreno, hanno piegato le politiche pubbliche ai loro obiettivi, insensibili alle minacce al territorio, al paesaggio, all’efficienza e alla universalità dei beni comuni: sanità, scuola, acqua, servizi. Hanno tradito le aspettative delle donne di veder concretizzati i loro diritti nell’organizzazione della vita sociale. Hanno affogato i nostri storici monumenti in un bosco di shopping centers. Hanno sollecitato un turismo che sta stravolgendo le città e non consente un rapporto vero con gli esseri umani e la loro storia. Hanno indotto all’abbandono di qualsiasi strategia capace di indicare un nuovo modello economico per la Toscana. Un modello in grado di dare lavoro: a chi lo ha perduto con lo smantellamento della industria tradizionale, e a chi lavoro non ne ha ancora mai avuto. Noi invece vogliamo che la Toscana continui ad essere un punto di riferimento per chi pensa che «l’Italia ha ancora qualcosa da dire» (Piero Calamandrei). (…) Vi chiediamo di tornare a essere protagonisti della nostra democrazia, cittadini fino in fondo: non sudditi del mercato e della politica di plastica che ha divorato la sinistra italiana. PROMOTRICI E PROMOTORI: Tomaso Montanari, Adriano Prosperi, Sandra Bonsanti, Salvatore Settis, Paul Ginsborg, Enzo Collotti, Donatella Della Porta, Giancarlo Fasano, Francesco ‘Pancho’ Pardi, Carlo Cecchi, Davide Riondino, Maria Luisa Boccia, Laura Barile, Sandra Teroni, Luciana Castellina Da Repubblica.it del 22/05/15 (Bologna) Bimbincittà, quelli del Betti in festa alla Montagnola Cinema, laboratori e letture animate: cosa fare nel week end con i bambini Torna per la IV edizione la Festa di Primavera di “Quelli del Betti…”, in programma domenica 24 maggio (dalle 15.30) al Parco della Montagnola a Bologna. Da quattro anni le famiglie degli oltre 200 bambini che frequentano le due scuole dell’infanzia Betti 2 e Betti 3 e il nido Betti organizzano una grande festa nel parco in cui le scuole sono immerse 7 per aprirlo alla città e per raccogliere fondi da destinare alle scuole. Partner per la realizzazione dell’evento – patrocinato dal Comune e dal quartiere San Vitale – sono l'Arci Bologna e Antoniano onlus che dal 2010 gestiscono il Parco con Comunicamente. Alla festa vengono invitate ogni anno associazioni sportive e ludico/ricreative del territorio che offrono attività a tutti i bambini. "Buone pratiche dal basso - spiegano i promotori - per condividere uno spazio pubblico così importante e centrale, un polmone verde in mezzo alla città, dove gli utenti abituali si adoperano ogni giorno per tenere lontani pericoli e degrado". In programma, lezioni di prova di skate, pattini a rotelle e mini-basket, arco Sarà possibile passeggiare a cavallo dei pony. Oltre all’angolo truccabimbi sono previsti due laboratori creativi: uno per diventare “sfoglini” provetti e l’altro per imparare a coltivare una pianta utilizzando materiali di riciclo. Alla festa parteciperanno anche gli allievi dell’Ic15 del corso di musica del maestro Gino Marzocchi con il saggio di fine anno e verrà offerto a tutti un laboratorio di percussioni. http://bologna.repubblica.it/cronaca/2015/05/22/news/bimbincitta_-114974060/ 8 INTERESSE ASSOCIAZIONE del 22/05/15, pag. 38 I RISCHI DI CHI DECIDE SENZA DELIBERARE NADIA URBINATI LA CRISI economica ha cambiato il carattere e lo stile delle democrazie europee. Ha messo in discussione il rapporto tra deliberare e decidere facendo pendere il piatto della bilancia dalla parte degli esecutivi, come ha ricordato Marc Lazar su questo giornale. L’amichevole inimicizia tra deliberazione e decisione è proverbiale nella democrazia, che i detrattori hanno per secoli identificato con la perdita di tempo in chiacchiere, il troppo deliberare e poco decidere. Queste sono le opinioni ingenerose e non provate dei suoi detrattori. La decisione nelle democrazie è un momento finale, mai ultimo, di un processo deliberativo al quale partecipa, direttamente e indirettamente, un numero ampio di soggetti, singoli e collettivi. Nei governi rappresentativi la deliberazione è un gioco complesso che si avvale sia della selezione dei rappresentanti sia di un rapporto permanente del Parlamento con la molteplicità delle opinioni che animano la società. Se le elezioni concludono temporaneamente il flusso deliberativo, la discussione non è tuttavia mai interrotta né lo sono la riflessione ragionata del pubblico e l’influenza che i cittadini cercano di esercitare sulle istituzioni. La deliberazione non ostacola o ritarda la decisione, quindi, ma la incalza, la prepara e la cambia. I pensatori democratici si trovano in disaccordo sull’intensità di questa tensione e sull’ampiezza dell’apporto deliberativo a elezioni concluse. Quarant’anni fa, nel 1975, la Commissione Trilaterale (ispirata da Samuel Huntington) pubblicava il suo primo rapporto sulla “governabilità” nei Paesi occidentali dal titolo eloquente, “La crisi della democrazia”. Il rapporto diceva, in sostanza, che la governabilità è messa a rischio dalla troppo ampia deliberazione, dai movimenti per i diritti civili e sociali e dalle richieste che questi rivolgono ai governi, i quali per mantenere il consenso dei cittadini sono indotti ad ampliare il loro intervento sociale così da generare una spirale di nuove richieste. Secondo Huntington, gli Stati democratici stavano perdendo autorità a causa del peso troppo forte rivendicato dal pluralismo sociale: era questa la crisi di governabilità decretata dalla Trilaterale, che suggeriva agli Stati occidentali (soprattutto quelli a democrazia parlamentare) di rafforzare gli esecutivi, deprimere lo stato sociale, contenere la contestazione e i movimenti. “Eccesso di democrazia” era il problema: come nel mercato così anche nella politica, un’alta partecipazione era indice di un forte bisogno; ma contrariamente al mercato, in politica questo attivismo era segno di instabilità. All’opposto stava l’apatia, indice di soddisfazione. La concezione deliberativa della democrazia, associata a Jürgen Habermas e alla teoria critica francofortese, prese corpo proprio in quegli anni, discutendo sul significato della “crisi” e della governabilità, e contestando la visione minimalista del processo decisionale. Deliberare era più che votare; aveva un significato ampio, proprio come i critici della Trilaterale avevano temuto: la decisione per Habermas è una conclusione temporanea di un processo al quale in modo diretto e indiretto partecipa una pluralità di attori sociali e politici. Una società civile vibrante e non apatica è il segno non di una crisi di governabilità ma di una forte legittimità del sistema perché la decisione, ottenuta comunque a maggioranza, viene percepita da tutti non come un esito divisivo di una parte contro l’altra. In Europa, la visione deliberativa ha caratterizzato la natura della democrazia nei decenni a partire dagli anni Settanta, mettendo a segno importanti risultati in termini di politiche 9 sociali nazionali e di impulso alla costruzione dei trattati costituzionali dell’Unione Europea. Il suo declino, che la crisi economica ha accelerato, corrisponde oggi a un’impennata della volontà decisionale degli esecutivi sia nazionali che comunitari, e a un desiderio di allentare i lacci imposti dalla deliberazione, parlamentare e sociale, e di alleggerire l’impegno dei governi nelle politiche sociali. A livello europeo, questo cambio di passo è stato impresso dalla pratica dei trattati inter-governativi che hanno depresso la consuetudine comunitaria e, nello stesso tempo, esaltato il ruolo degli esecutivi degli Stati. La sterzata verso un federalismo di e tra esecutivi, con credenziali democratiche deboli, ha avuto un effetto a valanga negli Stati membri. La crisi sembra rilanciare il progetto della Trilaterale, dunque. Mette al tappeto la democrazia deliberativa decretando la centralità del potere di decisione dei governi centrali. Si tratta di vedere se la democrazia decisionista ci darà più efficienza nel rispetto dei fondamenti democratici, meno sprechi e meno corruzione, come promette di fare. 10 ESTERI del 22/05/15, pag. 4 Nelle casse di Atene solo 800 milioni Tsipras incontra Merkel e Hollande. In vista una riunione dei ministri europei dell’economia entro i primi di giugno Bollate dai greci come “fantascienza” le voci di un accordo parziale in arrivo. No comment da parte di Bruxelles ALBERTO D’ARGENIO DAL NOSTRO INVIATO RIGA . Le casse di Atene sono ormai vuote. Nel giorno in cui i leader europei incontrano a Riga i sei colleghi del partenariato orientale, dall’Ucraina alla Bielorussia, sono ancora una volta Angela Merkel e Francois Hollande dover prendere in mano il dossier greco in un incontro d’emergenza con Alexis Tsipras: si cerca di organizzare un Eurogruppo straordinario entro fine mese per tamponare la crisi. Al governo greco restano solo 800 milioni di liquidità, cifra non sufficiente ad arrivare a luglio. Non una sorpresa visto che Atene è a secco da un paio di mesi e nonostante gli ultimatum sulla necessità di trovare un nuovo accordo sulle riforme in cambio di soldi è arrivata fin qui recuperando in modo creativo i fondi per allungare il negoziato e spuntare condizioni migliori sui nuovi prestiti. Ma il ministro delle Finanze tedesche, Wolfgang Schaeuble, gela Atene: ora il default non può essere escluso. Dalla vittoria elettorale Tsipras non è riuscito a trovare l’accordo con l’Europa su un nuovo piano di riforme che avrebbe sbloccato gli ultimi 7,2 miliardi di aiuti e avrebbe consentito di rinegoziare un nuovo programma, il terzo, per rimettere la Grecia in carreggiata. In questi mesi Atene ha bruciato i sacrifici degli scorsi anni e la crescita che iniziava ad affacciarsi dopo un lustro di recessione. Così a Riga tornano i timori di molti leader che Tsipras sia ostaggio della parte più estremista di Syriza e dell’alleato di destra Anel, contrari alle richieste di Fmi, Ue e Bce in cambio dei nuovi aiuti. Atene ha già minacciato di non pagare i 305 milioni che deve restituire all’Fmi il 15 giugno e comunque il prossimo mese non riuscirà a versare stipendi e pensioni. Così indiscrezioni rilanciate dalla Suddeutsche Zeitung parlano di un accordo parziale in arrivo: i creditori darebbero 4 miliardi a Tsipras per evitare il crack e il governo approverebbe la riforma dell’Iva per reperirne altri 5. La riforma del lavoro e della previdenza verrebbero invece rinviate a dopo l’estate con un prolungamento del secondo piano di salvataggio in scadenza il 20 giugno. Yanis Varoufakis ha definito questa ipotesi «fantascienza ». Bruxelles non ha commentato. Se dalla Commissione europea emerge che il dossier greco è ormai in mano al presidente Juncker, uno dei suoi vice, Valdis Dombrovskis, sottolinea che «è importante accelerare i negoziati, c’è ancora tanto da fare e la questione liquidità è piuttosto complicata». Poi la doccia fredda di Schaeuble, che non condivide il recente ottimismo del governo greco: «Non c’è niente di sostanziale negli annunci su un accordo vicino, si tratta solo di apparenza». E a chi chiede lumi sul rischio di insolvenza, risponde: «Non escludo niente». Quindi indica che la prossima settimana il caso greco sarà al centro del G7 di Dresda. Nella notte a Riga Merkel e Hollande vedono Tsipras per un ennesimo, drammatico incontro d’emergenza alla ricerca di una soluzione. Sbarcando nella capitale lettone Hollande spiega che l’obiettivo è «organizzare un Eurogruppo tra la fine di maggio e inizio giugno» per chiudere almeno temporaneamente la partita. 11 del 22/05/15, pag. 3 Tsipras e creditori internazionali sono sempre più vicini a un accordo Grecia. Il governo: «La priorità resta la crisi umanitaria» Pavlos Nerantzis ATENE Le distanze tra Grecia e i suoi creditori internazionali sembrano accorciarsi. Anche se al vertice europeo di ieri e oggi a Riga non sará direttamente discusso il caso greco e non si aspettano delle grandi novitá, le trattative sono alle battute finali. É quindi questione di tempo, al massimo entro l’inizio di giugno, per arrivare ad un accordo finale che permetterebbe — dopo ovviamente la sua ratifica dai parlamenti dei paesi dell’eurozona — al governo greco di incassare almeno una parte della tranche di 7,2 miliardi di fondi di salvataggio. Questa é la visione di Alexis Tsipras che a margine della riunione del Consiglio europeo a Riga durante un incontro tete-á-tete con Angela Merkel e Francois Hollande ha chiesto ieri sera la ristrutturazione del debito greco. Atene punta ad un accordo totale entro le prossime settimane, mentre a Bruxelles sono a favore di un trattato ratificato step by step. La Grecia ha aderito agli accordi del 20 febbraio e ha dimostrato di rispettare le procedure, le normative e l’ambito operativo dell’eurozona, il che significa, ha sottolineato il premier greco che «è giunto il momento per i partner del Paese di dimostrare il loro rispetto nei confronti delle decisioni democratiche del popolo greco nel comune ambito europeo». Dall’ altra parte i partner europei, nonostante l’intrasigenza di alcuni, si rendono conto che un default ellenico avrebbe ripercussioni serie nell’ Ue e nell’economia mondiale. L’obiettivo di Atene che punta inanzitutto ad una soluzione politica e a compromessi reciproci, rimane sempre lo stesso: un’accordo che non aggravi la crisi umanitaria greca sapendo che dovrá comunque comprendere la ristrutturazione del debito. Le cosidette «linee rosse» per il governo greco sono gli stessi argomenti che di fatto aggravano la recessione, vale a dire la questione del mercato di lavoro e quella delle pensioni. Le altre promesse elettorali, invece, di fronte al pericolo di un fallimento del paese potrebbero essere solo rinviate. «Ci dovrebbe essere una soluzione entro maggio in modo da poter risolvere i nostri problemi di liquiditá» ha detto il portavoce greco, Gavriel Sakellaridis, escludendo l’ eventualitá di un prelievo forzoso sui depositi bancari per raccogliere denaro, come era avvenuto a Cipro nel marzo del 2013. Sakellaridis, senza nascondere la difficile situazione finanziaria e l’ urgenza di Atene di trovare entro la fine del mese soldi per pagare stipendi e pensioni — (ndr senza dimenticare che entro agosto deve rimborsare ai suoi creditori 24 miliardi di euro) — ha messo in evidenza il punto critico delle trattative, al livello tecnico ma anche politico alla vigilia del vertice di Riga e della riunione del Brussels Group (che comprende Fmi, Ue, Bce, Esm) che da Mercoledi sta esaminando le proposte elleniche per una revisione del regime d’ imposta sul valore aggiunto (Iva), considerato finora come una delle spine dei negoziati. Che «l’accordo stavolta é effettivamente vicino» lo ha sostenuto pure il ministro delle finanze greco, Yanis Varoufakis, escludendo categoricamente l’introduzione della doppia moneta in Grecia. «Non esiste una “soluzione Mayer”. C’è soltanto una soluzione politica» ha detto Varoufakis, riferendosi alla proposta dell’americano Thomas Mayer, ex capo economista di Deutsche Bank, il quale per primo aveva prospettato questa ipotesi. 12 Ora il probabile, significativo avvicinamento delle posizioni viene confermato per la prima volta da alti funzionari europei. A sentire la stampa greca, il presidente della Commissione Ue, Jan Claude Juncker, è intervenuto personalmente per ottenere il tanto voluto «compromesso storico» senza schiacciare la faccia di Alexis Tsipras, ma neanche la volontá dei rappresentanti della vecchia troika (Fmi, Ue, Bce) che insistono sulla necessità di riforme e di nuove misure di austerità. Secondo il «piano Juncker» le trattattive per nuove misure di austerità potrebbero essere rinviate all’autunno prossimo. Duro, invece, nelle sue dichiarazioni il vice-presidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovkis, che avverte che «solo se la Grecia completa il prossimo passo del programma di riforme, (compresi i tagli stipendi e pensioni) potranno essere corrisposte le ultime tranche di aiuti». Per il momento l’esecutivo di Tsipras e le «istituzioni» sembrano aver trovato un’intesa su alcuni dati macroeconomici, visto che la recessione continua, il debito pubblico supererá per la prima volta nel 2015 la soglia del 180% del Pil e il deficit nell’ anno precedente si é attestato al 3,5%. Ambedue le parti concordano che l’economia ellenica crescerà dello 0,5%, una crescita, quindi, in pratica inesistente, mentre l’ obiettivo per l’avanzo primario sarà molto minore (al 1,5% quest’anno, al 2% nel 2016 e al 3,5% dal 2017) rispetto a ció che volevano all’inizio i creditori internazionali, permettendo in questo modo al governo greco di prendere misure per far fronte alla crisi umanitaria. Un’intesa che sta per concludersi — negli ultimi giorni ci sono state già due teleconferenze del Brussels Group — riguarda appunto il regime d’imposta sull’Iva, tenendo conto che l’ammontare dell’evasione fiscale in Grecia è stimato in circa a 9.5 miliardi di euro l’anno. Il progetto greco per la riforma dell’Iva prevede due aliquote di imposta sul valore aggiunto invece delle attuali tre. La più alta sarebbe fissata al 18% e verrebbe applicata a quasi tutti i servizi e prodotti ad eccezione di alimentari e medicinali con uno sconto di tre punti percentuali per gli acquisti con carta di credito. L’aliquota più bassa sarebbe invece fissata al 9,5% e si applicherebbe agli alimentari, ai farmaci e ai libri con lo stesso sconto per le transazioni non in denaro contante. Tali proposte sembrano rientrare nell’ambito di un più vasto progetto del ministro delle finanze teso ad aumentare le transazioni non in contanti allo scopo di combattere l’evasione fiscale. E Tsipras, di fronte all’Unione europea, non smette di sottolineare che il suo governo deve proteggere i lavoratori, i pensionati e le famiglie che hanno sofferto a causa dell’austerità provocata dal piano di «salvataggio» dell’economia del Paese. del 22/05/15, pag. 1 (inserto Sbilanciamo l’Europa) La realtà inedita della politica spagnola Luca Tancredi Barone BARCELLONA La politica spagnola sta vivendo il suo primo, vero terremoto dall’avvento della democrazia, nel 1978. Per la prima volta si profila uno scenario completamente diverso dal rigido bipartitismo che ha caratterizzato la vita poli-tica di que-sto paese. Le mag-gio-ranze asso-lute saranno l’eccezione. La politica deve adattarsi a una realtà inedita: la necessità di scendere a patti con altri partiti, e di dover condividere le responsabilità istituzionali. Domenica 24 maggio si vota in 13 delle 17 comunità autonome, e in tutti i più di 8100 comuni spagnoli. E il tutto a pochi mesi dalle elezioni generali (la legislatura, se Rajoy non convoca elezioni anticipate dopo le amministrative, si chiude a novembre), due mesi dopo 13 le elezioni anticipate in Andalusia e a tre mesi dalle (quasi certe) elezioni anticipate in Catalogna (che dovrebbero tenersi il 27 settembre, se il presidente catalano Artur Mas non cambia idea). Insomma, un 2015 che lascerà il segno, e in cui finalmente i semi gettati dal 15M proprio quattro anni fa inizieranno a dare i primi frutti. I due storici grandi partiti, il Pp e il Psoe, vengono ormai dati a meno del 50% dei voti a livello nazionale, con un leggero vantaggio per i popolari. Irrompono con forza due nuovi partiti che si battono per il terzo posto e che sommano circa un 30%: Podemos, che si è imposto un anno fa alle elezioni europee, contro ogni pronostico, con un inaspettato 8%, e che oggi è dato intorno al 16%, in discesa rispetto a pochi mesi fa; e Ciudadanos, partito nato in ambito catalano su posizioni anti-indipendentiste e molto vicine a quelle del Pp (di fatto il suo leader, Albert Rivera, aveva militato nei giovani popolari), con percentuali molto vicine a quelle di Podemos. Izquierda Unida nel migliore dei casi otterrebbe al massimo un quinto posto (attorno al 5% dei voti). Ma è ancora più interessante osservare quello che succederebbe a livello delle comunità autonome che in Spagna, proprio come in Italia, gestiscono la gran parte delle spese sociali. Salvo pochissime eccezioni (come la Catalogna e i Paesi Bassi), nei parlamenti regionali entravano tipicamente due o al massimo tre partiti. Questo scenario semplificato è finito per sempre. Ne abbiamo un esempio nel parlamento di Siviglia, dove si è votato due mesi fa e che è ancora senza governo: i socialisti, da sempre egemoni nella comunità e dunque poco abituati alla cultura del patto, detengono la maggioranza relativa. Ma dopo aver rotto con Izquierda Unida nella scorsa legislatura, oggi si trovano davanti non due ma quattro forze politiche, nessuna delle quali disposta all’astensione (almeno prima delle elezioni del 24) per far eleggere Susana Díaz presidente. Il modello andaluso è destinato a riproporsi nella maggior parte delle comunità, oggi quasi tutte in mano del Pp. L’unica speranza per i popolari di riuscire a mantenere il governo di alcune di queste comunità (dove oggi vanta maggioranze assolute) è di trovare un accordo con Ciutadanos, che è riuscito, come Podemos, a diluire il proprio messaggio ideologico con la retorica del «non è tempo di destra o sinistra» e che si spaccia come di sinistra moderata anche se in realtà è su posizioni neoliberali. L’attenzione si concentrerà su tre comunità roccaforti del Pp: Madrid, Comunità valenziana (dove gli scandali di corruzione stanno affogando il partito) e Castilla-La Mancia (la cui presidente è anche braccio destro di Mariano Rajoy). Se qui il Pp non riesce in qualche modo a «salvare i piatti», come si dice in spagnolo, persino l’imperturbabile Rajoy vedrà la terra muoversi sotto i suoi piedi. Ai socialisti non va molto meglio. Se il telegenico Pedro Sánchez è riuscito a fermare l’emorragia di voti (che hanno portato il partito a raggiungere i suoi minimi storici), difficilmente il Psoe riuscirà a governare in solitario in nessuna comunità, anche se forse riuscirà ad ottenere alcune maggioranze relative. Resta da vedere come giocheranno le loro carte Ciudadanos, che si vede volentieri come ago della bilancia, e Podemos, il cui radicale discorso anti-casta renderà difficile la collaborazione con Pp o Psoe. Entrambi i partiti pagano il fatto di non avere una forte struttura territoriale. Ciudadanos, benvista dall’establishment in chiave anti-Podemos, ha fatto il salto a livello nazionale, approfittando della lenta scomposizione del partito UPyD, guidato da Rosa Díez e su posizioni molto simili; ma la fretta ha giocato brutti scherzi in molte liste dove si sono intrufolati candidati imbarazzanti. Podemos invece sta pagando l’eccessivo annacquamento del suo discorso radicale per attrarre elettori meno schierati politicamente. Proprio per questo ha avuto la prima importante defezione: l’ex numero tre di Pablo Iglesias, il professore universitario Juan Carlos Monedero, ha lasciato. Monedero era comunque diventato scomodo per il partito (che lo ha difeso a spada tratta) dopo che 14 si è scoperto che con un trucco contabile aveva cercato di pagare meno tasse sui consistenti proventi delle sue consulenze con i governi sudamericani. In Izquierda Unida, vittima della sua incapacità di canalizzare il malcontento, se la gioca il giovane e combattivo Alberto Garzón, proveniente (come Iglesias) dalle file del 15M e disposto a fare fronte comune con Podemos contro le politiche di destra. Ma i suoi principali nemici sono dentro la stessa Iu che antepongono l’identità e la bandiera alla strategia politica. Il dopoterremoto per molti dei partiti inizierà lunedì 25. Nei comuni le realtà sono molto variegate. Al contrario di Ciudadanos (che presenta un migliaio di liste), Podemos ha scelto di non concorrere con le sue sigle: troppo difficile controllare tanti candidati locali. Ma ha comunque dato l’ok per la confluenza con piattaforme cittadine, come per esempio a Barcellona e Madrid. Le quattro principali città spagnole sono Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia. A Madrid l’ex presidente della comunità Esperanza Aguirre sta giocando il tutto per tutto per frenare la caduta del Pp (in maggioranza assoluta da 24 anni) di fronte alla piattaforma dell’ex giudice Manuela Carmena, Ahora Madrid, che non comprende Iu (in forte polemica con Iu federale), e ai socialisti, che cercano di riconquistare la città da anni. A Valencia il potere della storica sindaca popolare Rita Barberà vacilla sotto i colpi della magistratura e per la prima volta un tripartito di sinistra (socialisti, Podemos e la piattaforma Compromís) potrebbe sfrattare il Pp. E a Siviglia, dove per la prima volta i popolari erano riusciti a conquistare il potere quattro anni fa, Pp e Psoe sono oggi alla pari (30%), ed entrerebbero Ciutadanos, una piattaforma cittadina e Iu. A Barcellona, dove il consiglio comunale sarà frammentatissimo, lo scontro è fra l’attuale sindaco Xavier Trias, di Convergència i Unió (democristiani egemoni in Catologna) che quattro anni fa per la prima volta conquistò la città ai socialisti e ai loro alleati, e la piattaforma Barcelona en comú, guidata dall’ex attivista della Piattaforma vittime delle ipoteche (Pah), Ada Colau, che ha agglutinato una piattaforma ampia che comprende Podemos e la marca catalana di Iu (Icv-Euia). Entrambi sono dati attorno al 21%. Ciudadanos si prospetta come il terzo partito (intorno al 13%), guidato dall’ex deputata popolare Carina Mejías. I socialisti e gli indipendentisti di Esquerra Republicana lottano per il quarto posto, i popolari hanno da sempre un ruolo residuale in città (anche se a guidarli è il fratello dell’attuale ministro degli interni spagnolo). Mentre entrerebbe per la prima volta l’assemblearismo della Cup con il nome di Capgirem Barcelona («mettiamo sottosopra Barcellona»), indipendentisti di estrema sinistra molto legati alle lotte sociali, economiche e cittadine, guidati dalla sindacalista Maria José Leche. La loro affermazione sarà chiave nel caso di vittoria di Colau per garantirne l’elezione, anche se ci vorrà almeno un terzo partito per raggiungere la maggioranza dei seggi. del 22/05/15, pag. 3 (inserto Sbilanciamo l’Europa) Gli obiettivi del referendum di Cameron Sbilanciamo l'Europa. Londra ha già 4 opt out: euro, Schengen, la giustizia e la Carta dei diritti fondamentali Anna Maria Merlo PARIGI 15 Il referendum sull’adesione all’Unione europea promesso da David Cameron potrebbe essere anticipato al 2016, un anno prima del previsto. Il cambiamento di data è stato evocato dal ministro degli esteri, Philip Hammond, per venire incontro alle inquietudini del mondo degli affari, preoccupato per un periodo troppo lungo di incertezza su un eventuale Brexit. Questa mossa ha anche lo scopo di aumentare la pressione di Londra su Bruxelles. Il 2017, difatti, è un anno difficile per negoziare, visto che due grandi paesi – Francia e Germania – saranno in campagna elettorale. Parigi e Berlino, del resto, già rifiutano oggi la richiesta di Cameron di rivedere i Trattati, avventura dall’esito incerto in questo periodo di disamore della Ue, che non riguarda solo l’Inghilterra. Cameron vuole ottenere delle concessioni importanti da Bruxelles, per poter fare campagna a favore della permanenza nella Ue. Come propone Open Europe, organizzazione legata al padronato britannico, l’obiettivo di Cameron è «restare in Europa, ma negoziando una riforma radicale per essere più liberi». Nei quotidiani popolari anti-Europa (quasi tutti, eccetto il Daily Mirror), Bruxelles è accusata di essere il regno dei burocrati, che vivono per limitare la sovranità britannica e minacciano, nella loro follia, tutto ciò che costituisce la tradizione inglese, dal bollitore al tostapane. Ma al di là di questo folklore, cosa può negoziare la Gran Bretagna con Bruxelles? Londra ha già quattro opt out: euro, Schengen, la giustizia e la Carta dei diritti fondamentali. Prima del voto, Bruxelles aveva già messo il freno su circa 300 nuove regole in discussione, per non dare nuovi argomenti agli euroscettici. Ma il folto gruppo di deputati conservatori ultra – circa un centinaio — non si accontenta di questo rallentamento sulla burocrazia di Bruxelles. Questo gruppo chiede a Cameron di ottenere nuovi poteri per la Camera dei Comuni, di modo che sia possibile per Westminster mettere il veto su ogni legge europea. Il ministro delle finanze, George Osborne, in collaborazione con l’euroscettico Philip Hammond, guida i negoziati con Bruxelles, che devono partire già nei primi cento giorni del nuovo governo. Vogliono ottenere da Jean-Claude Juncker, il presidente della Commissione che Cameron ha fatto di tutto per non far eleggere, un «gesto»: a Bruxelles sono allo studio delle proposte per cambiare le regole sulla «mobilità dei lavoratori», richieste del resto anche da Olanda e Germania. Questi paesi intendono lottare contro il «turismo sociale» dei cittadini Ue, sospettati di emigrare nei paesi solo per il welfare. Potrebbe venire imposto un periodo – fino a due anni di residenza – prima di poter accedere ai diritti sociali. Anche la Francia è d’accordo per regole più severe contro i «lavoratori distaccati», accusati di concorrenza sleale. Questi cambiamenti possono essere fatti senza modificare i Trattati. Ma la Gran Bretagna non riuscirà ad ottenere modifiche sulla libera circolazione dei cittadini, uno dei fondamenti della Ue. Resta il «no» deciso a nuova immigrazione extra Ue, ma il rifiuto delle «quote» di rifugiati proposte da Juncker è ormai condiviso da molti altri paesi, comprese Francia e Spagna. Cameron è tra due fuochi: da un lato, il peso degli euroscettici nel suo campo — non più moderato dai LibDem, ormai assenti dal governo – e il mondo degli affari dall’altro, che teme un Brexit ed è favorevole al mercato unico, dal quale dipendono 3,5 milioni di posti di lavoro in Gran Bretagna. L’export britannico è quasi al 50% diretto verso i partner Ue. Per Open Europe, un’uscita dalla Ue significherebbe un calo del pil di almeno il 2,3%. Il settore bancario fa pressione. La Deutsche Bank, per esempio, (9mila impiegati in Gran Bretagna) ha già incaricato un gruppo di lavoro per «misurare l’impatto potenziale» di un Brexit e minaccia di rimpatriare in Germania le attività che ora svolge sul suolo britannico. 16 «Un periodo di incertezza prolungata sull’adesione della Gran Bretagna alla Ue e il suo accesso al mercato unico potrebbe rendere più fragili le banche internazionali che sono grossi datori di lavoro nel paese», ha messo in guardia il direttore dell’Associazione dei banchieri britannici, Anthony Browne. del 22/05/15, pag. 4 In un’intervista al New York Times il ministro svela i segreti dell’Eurogruppo di un mese fa. La rabbia di Dijsselbloem Bufera su Varoufakis “Ho registrato i vertici Ue” La replica: “Sono riservati” ETTORE LIVINI MILANO . Yanis Varoufakis colpisce ancora. Un mese fa la Ue ha chiesto (e in parte ottenuto) la sua testa dopo un drammatico Eurogruppo in cui — riferiva allora l’agenzia Bloomberg — era stato definito dai partner europei «dilettante, perditempo e giocatore d’azzardo». Ieri il vulcanico economista ha consumato a freddo la sua diabolica vendetta: «I media, non solo per colpa loro, sono finiti in un vortice di bugie e mistificazioni — ha buttalo lì nel finale di una chilometrica intervista al New York Times — . Nessuno mi ha mai insultato. Lo nego con tutte le fibre del mio corpo». La prova? «Ho registrato tutta la riunione del 24 aprile». La bomba sganciata da Varoufakis è esplosa pochi minuti dopo la pubblicazione tra i salotti ovattati di Bruxelles. Il vertice di Riga del mese scorso non è stato un summit qualsiasi. Dietro le porte chiuse si sarebbe consumato uno scontro 18 (il resto dei ministri delle finanze dell’area euro) contro 1 (il loro omologo greco) «a tratti molto teso ed emotivo», come ha ammesso francamente il presidente dell’Eurogruppo Jeroen Dijsselbleom. Insulti? Ne ha parlato solo la stampa. Di sicuro però nei giorni successivi Alexis Tsipras ha tolto al suo braccio destro il ruolo di capofila dei negoziatori di Atene, affidandolo al fedelissimo vice-ministro degli esteri Euclid Tsakalotos. Peccato che tutti avessero fatto i conti senza l’oste. Varoufakis ha custodito per un mese come un segreto di Fatima il suo file audio. Senza lamentarsi del declassamento. Ma in questi giorni in cui si decide il futuro della Grecia, ogni arma è lecita. E lui – sapendo benissimo quello che faceva – ne ha rivelato al mondo l’esistenza, facendo correre un brivido freddo sulla schiena della diplomazia di Bruxelles. Cosa succederebbe se venissero date in pasto alla stampa quelle tre ore di registrazione segreta in cui le massime autorità europee si prendono a male parole accanendosi contro il più debole (Atene)? «Le riunioni dell’Eurogruppo sono riservate», ha sibilato ieri mattina livido di rabbia l’ufficio stampa di Dijsselbloem. Figuriamoci, ha risposto sibillino Varoufakis, «tutti conoscono la mia riservatezza e il mio rispetto per le istituzioni». Sarà. Ma il timore che la registrazione possa diventare pubblica penderà come una spada di Damocle nelle prossime ore sui negoziati per il salvataggio della Grecia, quando i protagonisti di quel 24 aprile di fuoco – ministro ellenico compreso – torneranno a guardarsi negli occhi. Sapendo che da qualche parte, ben conservato in una cassaforte, c’è la prova del livello (probabilmente non proprio oxfordiano) cui scende il dibattito in Europa quando i suoi leader si chiudono in conclave per decidere del futuro del continente. 17 Qualcuno, forse, ha già avuto la fortuna di ascoltare i documenti audio messi assieme da Varoufakis. «È sicuro al 100% che il ministro ha ragione. A Riga nessuno ha pronunciato le parole “giocatore d’azzardo”, “dilettante” o “perditempo”», ha twittato Peter Spiegel, capo della redazione di Bruxelles del “Financial Times” e uno dei giornalisti più credibili e informati sulla Grecia. Bene così. Le forme sono salve. La sostanza invece – vale a dire il resto delle conversazioni registrate – potrebbe diventare l’arma segreta di Atene per ammorbidire le posizioni della Troika nelle trattative dei prossimi giorni. del 22/05/15, pag. 22 Mosca sta vincendo la sua battaglia ideologica con l’Occidente grazie al potere di persuasione e di pressione psicologica nel quale era maestra l’America Il trionfo viene sancito a Riga, dove si conferma il fallimento del Partenariato orientale con l’Ue Il “soft power” di Putin l’attrazione fatale per la Russia che contagia i paesi dell’Est PAOLO GARIMBERTI È QUASI un paradosso che Vladimir Putin, dopo aver fatto due guerre armate (una dichiarata alla Georgia, e una mascherata per interposti mercenari all’Ucraina) ed essersi annesso porzioni di territori altrui, finisca per vincere la sua ostinata battaglia ideologica all’Occidente con il “soft power”: quel potere morbido di attrazione e di convincimento, ma anche di pressione psicologica, nel quale l’America era un tempo maestra. Il vertice in corso da ieri a Riga, capitale di un’ex repubblica sovietica oggi indomita campione del fronte europeo anti-Putin, tra l’Unione europea e i sei Paesi dell’abortito “Partenariato orientale” (Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina) sancirà la vittoria, almeno ai punti se non per ko tecnico, del presidente russo. Silenzio totale sulla Crimea, argomento ormai tabù per non urtare la sua suscettibilità, e un pallido, impalpabile documento sul «diritto sovrano di ogni partner di scegliere liberamente il livello di ambizione (!) e gli obiettivi ai quali esso aspira nei rapporti con l’Unione europea». Un bruscolino negli occhi di ghiaccio dell’ex colonnello del Kgb. Ma la capitolazione era stata annunciata dalla visita, il 12 maggio scorso e dopo ben due anni di assenza, del segretario di Stato americano John Kerry a Sochi, località molto amata da tutti gli uomini forti della storia russo-sovietica (e quindi sommamente simbolica per Putin). È stato il segnale che Obama aveva gettato la spugna: le sanzioni decretate per l’aggressione all’Ucraina non hanno funzionato, non hanno indebolito il leader russo, semmai lo hanno rafforzato in termini di consenso popolare solleticando l’orgoglio e la capacità di soffrire dei russi. E così il presidente americano, prima di vedersi rinnegato dagli alleati (sempre più riluttanti) europei, pronti a ridare a Putin la verginità economicocommerciale, ha giocato d’anticipo. Kerry a Sochi? Un segnale «molto positivo» hanno detto i portavoce gongolanti del Cremlino. In realtà questo “Partenariato orientale”, di cui in queste ore si decide l’eutanasia, aveva avuto un parto molto travagliato ed era nato già monco a Vilnius nel 2013. Viktor Janukovich, l’allora presidente ucraino, di provato ossequio e «servile encomio » a Putin, aveva tradito sfilandosi. Senza il piatto forte dell’Ucraina erano rimasti i due Stati postsovietici non a caso amputati di pezzi di territorio annessi dalla Russia: rispettivamente l’Abkhazia e l’Ossezia, e la Transnistria. Nel 2014, dopo Majdan, l’Ucraina è tornata a 18 bussare alle porte dell’Europa e, guarda caso, Putin ha nuovamente usato l’affettatrice, tagliando via la Crimea e le province russofone. L’America ha tuonato, l’Europa ha mormorato, ma la montagna delle sanzioni ha partorito un topolino. Ci sono almeno quattro ragioni per spiegare il fallimento del braccio di ferro che l’Occidente, con differenti gradi di muscolarità (e anche questa disunione ha favorito il disegno del Cremlino), ha ingaggiato con la Russia. Il primo è che Putin usa il “soft power” in maniera piuttosto hard. Ha strangolato le economia dei filo-europei fino ad asfissiarle. La Georgia, per fare un esempio, si è vista bloccare le esportazioni verso la Russia di tre delle maggiori risorse produttive: i vini (tra i pochi decenti in tutta l’ex Urss), le acque minerali, la frutta e la verdura, che da sempre sono le uniche di qualità reperibili sui mercati di Mosca (sui ricchi e invadenti mercanti dei kolkhoz georgiani a Mosca si possono scrivere pagine e pagine di storie). Perfino l’eccellente cognac armeno è finito vittima delle rappresaglie putiniane. Di fronte alla lentezze e all’eccesso di burocratismo della Ue l’attrazione dell’Unione euroasiatica offerta da Putin è apparsa ad alcuni di questi ex sudditi una via d’uscita dalla recessione. Il secondo fattore è stata l’incompetenza e la superficialità dell’Occidente a partire dagli Stati Uniti. Con la caduta dell’Urss negli Stati Uniti e in Europa si è diffusa la convinzione che la Russia fosse finita in basso nel ranking delle potenze mon- diali. Il focus delle ricerche e delle previsioni strategiche si è orientato altrove. Molti leader occidentali hanno pensato con arrogante condiscendenza di conoscere e interpretare il personaggio Putin, di «sapergli leggere l’anima»: da Bush figlio fino a Obama, ci sono caduti tutti. Altri, come Berlusconi, ne hanno cercato il consenso e l’amicizia, invidiandone forse l’arroganza del potere (la sua “democrazia controllata”) e lo schiacciamento delle opposizioni. La terza causa è certamente la nefasta influenza di una Chiesa ortodossa che ovunque si è sentita minacciata nel suo utilitaristico conservatorismo dai “valori occidentali” che le adesioni all’Unione europea avrebbero potuto comportare. Non solo in Russia. Dove Putin l’ha blandita e servita, con un opportunismo che gli ha fatto riscoprire valori religiosi che certo non facevano parte del catechismo delle scuole del Kgb. Ma anche nelle altre ex repubbliche sovietiche: la Chiesa georgiana sostiene senza pudore che un avvicinamento alla Ue significherebbe soprattutto la promozione dei diritti dei gay. Ultimo, ma non meno importante, fattore di disincanto verso l’Europa è la corruzione e il malgoverno dilaganti nell’ex Urss, l’incapacità dei governi post-sovietici in repubbliche diventate Stati autonomi di avviare riforme politiche ed economiche, che le popolazioni si attendevano. A cominciare dall’Ucraina di Poroshenko. Ma non solo. Se il 31 percento dei georgiani, a 12 anni dalla dolce rivoluzione che ha portato al potere i tecnocrati filoamericani, dice di preferire l’Unione eurosiatica all’Unione europea qualche serio problema ci sarà. All’inverso di quello che disse Enrico Berlinguer ormai tanti anni fa, la gente preferisce «stare di là che di qua» (dell’ex cortina di ferro). Anche se di là comanda Putin. Da il manifesto del 22/05/15, pag. 3 Ora Kiev vuole lo scudo antimissile. Ma gli Usa (e la Nato) frenano Vertice di Riga. Washington: «Né Usa, né Nato pianificano tali azioni contro la Russia» Fabrizio Poggi Il vertice di capi di Stato e di governo apertosi ieri pomeriggio e che si conclude oggi a Riga — principale argomento odierno dovrebbe essere la Grecia — è formalmente 19 dedicato alla discussione dei rapporti economici e politici tra i 28 paesi Ue e i 6 del cosiddetto Partenariato orientale: Ucraina, Georgia, Moldavia, Armenia, Bielorussia e Azerbaigian. Nella sostanza, la crisi ucraina e i rapporti con la Russia tengono banco. Sul secondo fronte, è noto che Armenia e Bielorussia si rifiuteranno di sottoscrivere la dichiarazione finale contenente la condanna di Mosca per «l’annessione della Crimea». Ma il punto focale del vertice sembra riguardare l’Ucraina. Mercoledì scorso infatti, il Presidente del Consiglio di sicurezza e di difesa ucraino, Aleksandr Turcinov, aveva parlato di prossime consultazioni per il dislocamento su territorio ucraino del sistema di Scudo missilistico, volto a difendere l’Ucraina dalla «aggressione russa e contrapporsi al pazzo che minaccia la pace con un potente potenziale nucleare». Pur se il summit lettone appare dedicato per lo più ai rapporti economici, sembra evidente che un tale tema non possa venir ignorato. Ad ogni modo, commentando a caldo le dichiarazioni di Turcinov, il portavoce di Vladimir Putin, Dmitrij Peskov aveva detto che un simile passo, se intrapreso, renderebbe necessaria una risposta adeguata di Mosca, per garantire la propria sicurezza. Peskov aveva però aggiunto che, a suo parere, si tratta di una «discussione eventuale». In effetti, non si era fatta attendere nemmeno la risposta statunitense. Lo stesso 20 maggio, la portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Marie Harf, dichiarava che «Né Usa, né Nato pianificano di dislocare sistemi missilistici su territorio ucraino», aggiungendo che tali sistemi «sono dislocati e possono essere dislocati solo in Paesi membri dell’Alleanza». Harf, secondo l’agenzia Lenta.ru, aveva tenuto anche a sottolineare che lo scudo missilistico «non è diretto contro la Russia», ma è volto a respingere le minacce che vengono dal Medio Oriente. Alle domande dell’agenzia Rbk riguardo le dichiarazioni di Turcinov, anche alla Nato avevano risposto «Per ogni commento sulla questione rivolgetevi alla parte ucraina». Turcinov aveva motivato tali piani con il dislocamento «di bombardieri strategici e armi nucleari russe in Crimea, dirette in primo luogo contro i Paesi europei» e la Turchia. Ancora una volta, da occidente, nel corso del vertice dei capi di Stato maggiore della Nato, tenutasi ieri a Bruxelles, il comandante delle forze Nato in Europa, generale Usa Philip Breedlove, ha dichiarato che «Non abbiamo visto indicatori diretti di un qualsiasi dislocamento di armi nucleari» da parte della Russia; dunque «Non c’è la necessità di modificare la nostra strategia nucleare». Breedlove ha tuttavia detto che è invece allo studio la richiesta dei Paesi baltici per un rafforzamento della presenza Nato nella regione. La questione del dislocamento in Ucraina dello scudo missilistico, sembra dunque fare il paio con quella della futura abolizione del regime dei visti. Tutte le indicazioni vanno nella direzione di un «raffreddamento» delle aspettative ucraine da parte della Ue. Anche a Riga non è dato attendere novità di rilievo rispetto al rapporto pubblicato lo scorso 11 maggio dalla Commissione europea, secondo cui né Georgia, né Ucraina sono «pronte per la liberalizzazione del regime del visto». Pare dunque che a Poroshenko il quale, nel 2014, aveva dichiarato «Dal 1 gennaio 2015 tutti gli ucraini avranno diritto a viaggiare senza visto nell’Unione europea» non rimanga altro che «il diritto di sognare. Sognare l’Europa», come ha detto il presidente del Consiglio d’Europa Donald Tusk. Chissà se al vertice del Partenariato orientale qualcuno solleverà invece la questione della risoluzione adottata ieri dalla Rada ucraina sull’abbandono da parte di Kiev, nel Donbass, degli impegni dati dalla Convenzione sui diritti dell’uomo. Il Presidente della commissione esteri della Duma russa, Aleksej Pushkov, ha detto che «Quando un paese si lascia le mani libere, è semplicemente il riconoscimento del carattere criminale di quello stato». 20 del 22/05/15, pag. 13 Il “sultano” della Nato e il doppio-gioco libico Erdogan arma le milizie di Tripoli e alimenta la frattura col governo di Tobruk, minando la possibilità d’intese da parte Ue di Roberta Zunini L’Italia e l’Occidente tutto stanno cercando di ricomporre la frattura tra il governo libico riconosciuto internazionalmente con sede temporanea a Tobruk e quello illegale di Tripoli, animato da figure legate ad Alba, la coalizione di partiti e movimenti islamici difesa da milizie agguerrite e ben equipaggiate. In questa spaccatura si è infilato l’Isis. Per evitare che i due governi sanciscano la divisione creando due Stati, la Cirenaica e la Tripolitania o trasformino il paese in una seconda Somalia, con il contributo decisivo dei jihadisti del Califfo, la diplomazia internazionale le sta provando tutte. Peccato ci sia una pedina cruciale che fa, neanche troppo nascostamente, il gioco della squadra avversaria. Si tratta della Turchia, già messa sul banco degli imputati per il ruolo ambiguo nei confronti degli estremisti islamici , lasciati agire indisturbati sulla frontiera con la Siria e lanciare i loro attacchi contro il regime di Assad, inviso a Erdogan per calcolo politico. Secondo membro della Nato per numero di soldati dispiegati sul campo, nonché snodo geopolitico cruciale dell’area mediorientale e nordafricana per eredità storica e posizione geografica, la Turchia del “sultano” Erdogan sta dando palesemente del filo da torcere agli altri paesi membri, compreso il più potente del patto Transatlantico, gli Usa, specialmente riguardo la questione libica. Dopo essersi opposto al bombardamento francese contro Gheddafi nel 2011, Erdogan, oggi capo di Stato, allora premier, aveva cambiato idea una volta intuito che il rais era ormai alle corde. A quel punto iniziò a sostenere le milizie più legate alla Fratellanza musulmana, come quella di Misurata, la più fedele al movimento islamico moderato nato in Egitto e diffusosi poi in Libia. Da politico scaltro e cinico Erdogan sta giocando su più tavoli: quello interno e quello internazionale. In attesa delle elezioni del 7 giugno che, se vinte plebiscitariamente dal suo partito, l’Akp, serviranno al presidente per cambiare la Costituzione e trasformare la repubblica parlamentare in presidenziale con lui a capo, l’uomo forte di Ankara usa la tragedia libica per ottenere ancora più consenso e tamponare le frizioni con gli altri esponenti di punta dell’Akp, stufi del suo strapotere e arroganza. Nel mondo sunnita sostiene i Fratelli musulmani libici dopo aver difeso a spada tratta il deposto presidente Morsi in Egitto, appena condannato a morte, e vincere la gara per la leadership della Umma (comunità islamica, ndr) attualmente sotto il controllo dell’Arabia Saudita. Il premier del governo di Tobruk, Abdullah al-Thinni, già tre mesi fa aveva criticato la Turchia per la fornitura di armi alle milizie anti-governative in violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza. “La Turchia è uno stato che si comporta in modo disonesto con noi. Esporta armi con cui le milizie di Tripoli uccidono altri libici”, ha detto il premier al canale televisivo egiziano Cbc. La settimana scorsa una nave turca è stata bombardata al largo della Libia dalle forze di Tobruk perché avrebbe trasportato armi per Alba. Gli analisti ritengono un dato di fatto che la Turchia stia fornendo armi, sostegno politico ed economico alla milizia di Misurata (200 chilometri a est di Tripoli) senza rispettare il governo riconosciuto a livello internazionale, democraticamente 21 eletto nel giugno 2014. La Turchia è uno dei pochi paesi che ha pubblicamente ricevuto funzionari da milizie che attualmente controllano Tripoli. I critici di Ankara bollano la sua politica in Libia come pro-islamista. del 22/05/15, pag. 1/3 Lo scacco a Obama di Massimo Gaggi Non si tratta solo della scarsa efficacia di una strategia basata su attacchi dal cielo condotti prevalentemente coi droni: la caduta di Palmira in Siria e, ancor più, quella di Ramadi in Iraq, sono il termometro di un fallimento ben più vasto che un columnist certamente ostile a Barack Obama, ma acuto come Charles Krauthammer, sintetizza in modo efficace: «In Siria c’era gente pronta a combattere contro i terroristi dell’Isis e il carnefice Assad, ma noi americani abbiamo deciso di non aiutarli dicendo che erano ingegneri, medici, banchieri: poco credibili con le armi in mano. In Iraq, invece, abbiamo continuato a cercare di costruire un esercito locale con capi settari e soldati corrotti che non avevano voglia di combattere». Parole forti ma nelle quali c’è del vero e adesso per l’Iraq, anche al di fuori dei circoli repubblicani, si comincia a parlare apertamente di strategia fallimentare di due presidenti. Certo, Obama aveva ereditato da Bush una situazione impossibile a Bagdad: l’invasione del 2003 aveva eliminato Saddam Hussein e la sua classe dirigente sunnita senza riuscire a costruire, come da promesse, uno Stato democratico e multietnico. Il presidente democratico ha, in diversi modi, cercato il disimpegno. L o ha fatto ritirando i soldati dal Paese, responsabilizzando la nuova dirigenza locale, favorendo un ricambio al vertice quando il regime di Al Maliki è divenuto apertamente filoiraniano, rendendo così impossibile il dialogo con i sunniti. La Casa Bianca ha puntato sul nuovo premier, Al Abadi, che sembrava impegnato a conquistarsi la fiducia di tutte le etnie del mosaico iracheno. Ma anche lui è ora alle prese con una «crisi di rigetto» dei sunniti, schiacciati tra i massacri dell’Isis e l’arrivo delle milizie sciite che, vista la scarsa resistenza opposta dall’esercito iracheno, rimangono l’unica difesa efficace contro l’avanzata del «Califfato» verso Bagdad. Ancora pochi giorni fa, con l’incursione delle forze speciali Usa in Siria per eliminare il «ministro del petrolio» dell’Isis, la Casa Bianca ha sostenuto la narrativa di una coalizione di Paesi occidentali e del Golfo che, nonostante qualche rovescio, è all’attacco contro lo Stato Islamico. «Non credo che con l’Isis stiamo perdendo», ha detto Obama in un’intervista alla rivista The Atlantic rilasciata martedì e pubblicata ieri. Ma ora le tv continuano a riproporre quelle e altre dichiarazioni — Obama sicuro che «la nostra coalizione è all’offensiva» e il suo portavoce Josh Earnest che definisce «un successo» la strategia Usa contro il «Califfato», riducendo la caduta di Ramadi a un episodio — solo per deriderle: «Spero che quello di Obama sia puro cinismo», taglia corto Krauthammer, «se crede davvero in quello che dice, siamo nei guai». Guai che l’ex ministro della Difesa di Bush e di Obama, Robert Gates, definisce con poche, crude parole: «Il gap tra la retorica e i risultati sul campo è molto vasto. I nostri nemici hanno Ramadi, Falluja e Mosul: cacciarli da queste città è un lavoro tremendamente difficile». Il presidente Usa ha confermato il suo no all’ipotesi di truppe Usa sul campo. «Non possiamo fare quello che dovrebbero fare gli iracheni». Piani di riserva non sembra averne, salvo un maggior ricorso alle milizie sciite davanti alla pochezza dell’esercito 22 iracheno: ma quei miliziani sono incontrollabili. Al massimo rispondono agli ayatollah di Teheran, non certo al governo di Bagdad. E la campagna elettorale Usa complica ulteriormente le cose: si guarda al passato anziché al futuro, coi repubblicani che continuano ad attaccare Hillary Clinton per gli errori fatti in Libia e Obama per il ritiro Usa dall’Iraq giudicato prematuro, visto che il vuoto creato da quel disimpegno è stato riempito dall’Isis. E il nuovo presidente che si insedierà nel 2017 non si troverà in una posizione migliore, visto che in America prevalgono gli umori contrari a un ritorno in guerra, mentre in tutto il Medio Oriente, dallo Yemen al Libano, si assiste a una progressiva disintegrazione del sistema degli Stati-nazione e a una frantumazione del fronte sunnita. Unica consolazione per Washington, secondo Roula Khalaf, commentatrice libanese del Financial Times: l’Arabia Saudita è pronta a sostituire gli americani nel ruolo di «Grande Satana» agli occhi degli iraniani. Magra consolazione. Del 22/05/2015, pag. 9 L’Isis marcia su Damasco e Baghdad L’ultima difesa sono le milizie dell’Iran Gli eserciti iracheno e siriano in ritirata dopo gli attacchi subiti a Palmira e Ramadi Ora contro gli jihadisti rimangono i gruppi che rispondono al capo dei Pasdaran Maurizio Molinari L’imam iracheno ribelle, il generale siriano a corto di truppe ed il regista iraniano dell’«Asse di resistenza» delle milizie sciite: sono i capi militari che difendono Baghdad e Damasco dall’avanzata delle truppe del Califfo dello Stato Islamico (Isis). L’imam ribelle è Moqtada al Sadr, già leader della rivolta sciita anti-Usa, guida l’«Esercito del Mahdi» ovvero almeno 20 mila armati con la roccaforte a Sadr City, cuore di Baghdad. Appena Ramadi è caduta, con Isis a soli 112 km e il Califfo intento a preannunciare la «liberazione di Baghdad e Kerbala», è stato l’imam ribelle a rispondere: «Venite avanti, riempiremo la terra con i vostri cadaveri». Se il Califfo Abu Bakr al-Baghdadi teorizza il genocidio degli sciiti - che sono maggioranza a Baghdad e Kerbala - Al Sadr è il leader più carismatico e violento dell’Hashd al-Shaabi, la Forza di mobilitazione popolare che riunisce 90 mila miliziani sciiti addestrati dall’Iran, agli ordini del generale Falih al Fayyadh e di Hadi Al Amiri. Ciò significa che a difendere la capitale, e a guidare i tentativi di allontanare Isis, non sono i soldati dell’esercito del premier Al Abadi ma i miliziani che, dall’inizio della guerriglia anti-Usa nel 2003, combattono con metodi simili a Isis. I Kataeb Hezbollah, per esempio, dopo la presa di Tikrit hanno fatto scempio dei sunniti al punto da dover essere ritirati in fretta. Un mini-Stato di Hezbollah La difesa di Damasco è in condizioni più critiche perché dopo quattro anni di guerra civile l’esercito di Bashar Assad è allo stremo: dei 250 mila soldati che aveva ne sono rimasti la metà, a cui si aggiungono 125 mila miliziani sciiti - libanesi, iracheni, pakistani ed afghani dell’«Asse della resistenza». È un esercito senza gli armamenti Usa lasciati all’Iraq, ridotto a difendere sacche isolate ed alle prese non solo con l’avanzata di Isis - giunto a Palmira, 210 km della capitale - ma anche con quella dell’Esercito della Conquista, la coalizione di ribelli sostenuti da Turchia, Qatar e sauditi, che in aprile ha catturato la provincia di Iblib. 23 Questi motivi hanno spinto il ministro della Difesa siriano, Fahd Jassem al-Freij, a recarsi a Teheran per chiedere l’invio di reparti di terra. «L’Iran sta costruendo uno Stato dentro lo Stato in Siria come polizza di assicurazione sul dopo-Assad» spiega Charles Lister, analista del Brookings Doha Center in Qatar, secondo cui il crollo del regime portebbe ad un mini-Stato Hezbollah, la milizia libanese che ha 5000 combattenti in Siria e non ha mai perso una battaglia con Isis. Che si tratti di dover coordinare le milizie sciite irachene o di sostenere il traballante esercito siriano, a decidere con quali risorse e metodi farlo è Qassem Soleimani, il leader della forza Al Quds dei guardiani della rivoluzione che dal 1998 è dietro ogni fazione alleata di Teheran in Medio Oriente. È lui ad aver creato l’«Asse della resistenza» sciita e non lo cela. Quando nel 2007 il comandante americano David Petraeus gli rendeva la vita difficile in Iraq, reagì inviandogli un sms sul cellulare: «Dovrebbe sapere che sono io a guidare la politica iraniana in Iraq, Libano, Gaza e Afghanistan, l’ambasciatore a Baghdad è un mio uomo e anche il prossimo lo sarà». Come dire, qui comando io. Il generale Suleimani Se allora Suleimani si muoveva di nascosto, oggi le sue foto a fianco dei miliziani, dentro e fuori Baghdad, dilagano sul web perché vuole far sapere al Califfo che, in ultima istanza, il duello è con lui. A intuire quanto matura è la Casa Bianca che con il portavoce Josh Earnest dice: «Siamo molto preoccupati per la cattura di Palmira da parte di Isis, vi saranno sfide difficili». del 22/05/15, pag. 8 Israele senza sfumature I bus dell'apartheid e non solo. Quando il primo ministro ha detto che questo governo lavorerà per la pace, le sonore risate dell’opposizione hanno rappresentato il lato comico della tragedia Zvi Schuldiner Per gli smemorati: Israele è l’unica democrazia del Medio Oriente… O forse le cose sono un po’ diverse? Meno di una settimana fa, il premier Benjamin Netanyahu ha presentato al Parlamento il nuovo governo; un numero da circo, fino all’ultimo momento non si sapeva chi sarebbe stato nominato ministro, chi viceministro – carica onorifica, quasi priva d’importanza. L’agitazione più grande era all’interno del partito del primo ministro, che mantiene diversi ministeri fra i quali Esteri e Comunicazioni. Teoricamente la situazione si spiega con l’intenzione di invitare i Laburisti a far parte della coalizione, ma questo è molto poco probabile nel futuro prossimo, la faccenda potrebbe dunque essere molto più grave. È davvero un governo di destra. Puro, radicale, senza dubbi o sfumature. Nel suo discorso inaugurale, il primo ministro ha detto che questo governo lavorerà per la pace; le sonore risate dell’opposizione hanno rappresentato il lato comico della tragedia: è un governo che difficilmente può presentarsi al mondo come democratico, e quanto all’interesse per la pace, ne è del tutto sprovvisto. Poco dopo il ministro della Difesa ha annunciato il grande passo destinato a proteggere la vita dei coloni israeliani nei territori occupati: i palestinesi che hanno il permesso di lavorare in Israele non potranno viaggiare sugli stessi pullman dei coloni israeliani «per ragioni di sicurezza». In seguito alle forti proteste, dopo poche ore il governo ha annunciato la sospensione del proveddimento. L’ex comandante militare della regione 24 centrale aveva già dichiarato la sua indisponibilità ad applicare la norma, richiesta dai coloni israeliani nei Territori Occupati. Logicamente, era stato accusato di essere un sinistrorso – delitto piuttosto grave nell’Israele di oggi; anche se il carattere di apartheid della misura pretesa dai coloni era più che evidente. Altre prove del carattere del nuovo regime. La ministra della Giustizia ha dichiarato che si deve rispettare il sistema giudiziario… Ma ovviamente i giudici devono tener conto del fatto che non possono prendere decisioni contrarie alla volontà del Parlamento, dal momento che questo rappresenta la volontà popolare. La ministra della Cultura – già nota per le sue dichiarazioni contro i rifugiati dall’Eritrea (ovvero: Sono un cancro») — ha promesso di essere il ministro di tutti e di tutelare le diverse espressioni culturali… Ma ovviamente questo non significa accettare gli estremismi di destra o sinistra: «Se è necessario, si può censurare, non è possibile criticare i nostri soldati o collaborare con chi delegittima Israele…». Certo, bene i tribunali e la democrazia, ma pochi giorni fa la Corte Suprema ha approvato con due voti contro uno la demolizione di un piccolo villaggio beduino, perché lì dovrà sorgere un nuovo insediamento ebraico! Il Primo ministro è anche ministro delle Comunicazioni e in quella veste si è affrettato a predisporre provvedimenti che metteranno in pericolo l’esistenza del canale televisivo 10, eccessivamente critico. Democrazia, ma senza esagerare… Netanyahu ha negato un’intervista a questo canale perché odia personalmente l’apprezzato giornalista Raviv Druker, il quale, incaricato della sezione politica, in più occasioni ha trasmesso analisi e notizie critiche rispetto al Primo ministro. E chi aspetta una riedizione del Netanyahu del 2010 – allora egli accettò la soluzione dei due Stati come base per i negoziati di pace – bene, dovrà attendere a lungo. Oggi Israele ha uno dei peggiori governi di destra che si possano immaginare, senza reali prospttive di pace, con fortissime tendenze antidemocratiche, con correnti filo-fasciste e misure da apartheid. Chi ha creduto al vecchio ritornello dell’unica democrazia della regione – diventata, negli ultimi anni, etnocrazia – dovrà trovare il modo di far capire all’opinione pubblica internazionale che questo è un governo pericoloso, per tutta la regione, per la pace, per la stessa Israele. Il ministro della Difesa ha sospeso l’applicazione della misura relativa ai pullman, ma non l’ha cancellata. L’ha sospesa a causa delle reazioni internazionali. Ma non l’ha annullata, a causa delle proteste della destra radicale. Questo è un governo di estrema destra ed è opportuno che lo capiscano tutti, senza le solite reticenze, senza la delicatezza abituale, senza tirare in ballo le scuse e accuse del passato: «È antisemitismo», «vogliono annientarci»… 25 INTERNI del 22/05/15, pag. 6 Il giorno della strage Touil era a Gaggiano La conferma dai registri: poche ore dopo era in classe. Alfano: gravi indizi, ma l’indagine non compete a noi MILANO La grafia è incerta e quasi infantile. Il quaderno ha le righe a spazi larghi, quelle dei primi anni delle elementari. Abderazzak, il fratello maggiore di Abdel Majid Touil, lo sfoglia in cerca di una pagina precisa: «Giove, 19 marzo 15. Trasforma al plurale/singolare». È la pagina scritta il giorno dopo l’attentato nel museo del Bardo di Tunisi. Il 22enne marocchino Abdel Majid Touil è in carcere da martedì con l’accusa, formulata dalle autorità tunisine in un mandato di cattura internazionale, di avere partecipato alle fasi organizzative ed esecutive della strage. «Questo è il quaderno sul quale mio fratello studiava l’italiano. Era a scuola, quei giorni: come avrebbe fatto a rientrare dalla Tunisia?». L’interrogativo è lo stesso al quale cercano di dare una risposta gli investigatori dell’antiterrorismo, coordinati dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli: hanno spiegato che alla luce delle testimonianze di familiari, amici e insegnanti del corso per stranieri nella scuola di Trezzano sul Naviglio, è altamente probabile che il marocchino arrestato a Gaggiano (dopo pedinamenti e controlli sulle sue frequentazioni per almeno una settimana), nel giorno dell’attentato fosse in Italia. Dalle indagini, comprese quelle sul materiale sequestrato nella casa di via Pitagora 14, come due schede telefoniche e alcune pen drive, «non è emersa prova di un viaggio all’estero di Touil dopo l’arrivo a Porto Empedocle il 16 febbraio». Il marocchino, come ribadito agli investigatori dalla professoressa della scuola d’italiano Flavia Caimi, «è stato segnato presente sui registri scolastici sia il giorno 16 sia il 19 marzo». Ora, è da provare che a una dichiarata presenza ne corrisponda una reale. Ma le versioni di vertici e docenti dell’istituto coincidono. E poi, perché dovrebbero mentire? Touil aveva iniziato a frequentare la scuola ai primi di marzo. «Lo faceva per cercare lavoro. Un bravo studente. Terrorista? Non aveva neanche i soldi per le sigarette» dice Fatiha Boualy, 28 anni, marocchina. Era stata la madre del ragazzo, la 44enne Fatima, badante di un’anziana, a convincerlo a iscriversi al corso che frequentava da tempo. Entrambi appartenevano al corso di «livello A», quello di alfabetizzazione. Il test d’ingresso è datato 6 marzo, la prima lezione l’11. A scuola, come a Gaggiano dove abitava con madre, fratello e una sorella, Touil non sarebbe mai dovuto esserci: aveva ricevuto un ordine del questore di Agrigento di abbandonare il suolo italiano, ordine disatteso tanto che dalla Sicilia era subito salito nell’hinterland milanese. L’istituto non sapeva dell’irregolarità del ragazzo e in ogni caso «non avremmo potuto effettuare verifiche sulla sua identità». Gli investigatori attendono gli atti dal Tribunale di Tunisi. Per valutare meglio i reati contestati, per leggere cos’abbia fatto e chi abbia incontrato Touil prima di lasciare il Nordafrica. Il ministro Alfano ha spiegato che il marocchino «è gravemente indiziato di essere coinvolto nell’efferata azione terroristica a Tunisi. Ma l’indagine non compete a noi». Oggi Touil comparirà davanti ai giudici della quinta corte d’Appello di Milano. L’antiterrorismo, che vuole andare fino in fondo a questa storia, ha ascoltato i conoscenti della famiglia. Qualcuno ha raccontato che Fatima avrebbe detto di dover raccogliere soldi per i viaggi del figlio tra Italia e Marocco, e sono partite ipotesi sul vero «utilizzo» del denaro. È stata la donna a spiegare: «In casa lo 26 stipendio lo porto io. Una parte la mando a mio marito in Marocco, che non lavora per un problema alla schiena. Il resto lo affido ai figli. Sì, ho contribuito ai viaggi del primogenito. Ma non di Abdel Majid. Per il semplice motivo che non era mai stato in Italia». Andrea Galli Cesare Giuzzi del 22/05/15, pag. 6 Dieci righe dell’Interpol e piste senza riscontri quella cattura “mediatica” che ora imbarazza Alfano CARLO BONINI LA STORIA della cattura del giovane marocchino Abdelmajid Touil è un pasticcio che racconta l’ultimo azzardo del ministro dell’Interno Angelino Alfano. E una “verità” presentata in modo assai generico e soprattutto a metà, ancora ieri in Parlamento. Un pasticcio lievitato sulla base di un arresto dalle basi probatorie ancora molto scivolose e opache ma rapidamente venduto al mercato della paura e della campagna elettorale, nell’imbarazzo degli apparati della nostra sicurezza nazionale, come «un successo investigativo in cui non è stata risparmiata nessuna pista». Secondo quanto riferiscono cinque diverse fonti qualificate della nostra Intelligence e del nostra Antiterrorismo, «non c’è stata alcuna indagine», e «nessuna pista è stata battuta» semplicemente perché «nessuna pista esisteva ». Abdelmajid Touil è stato arrestato sulla base di dieci righe inserite in fretta e furia nel sistema Interpol dalle autorità tunisine il 19 maggio dopo che il ragazzo era già in stato di fermo e senza avere alcuna indicazione di fatto, neppure informale, della sua asserita responsabilità nella strage del Bardo. E tutto questo, al termine di una ricerca cominciata 45 giorni fa, con due fonogrammi dei servizi tunisini alle nostre due agenzie di Intelligence: l’Aise, lo spionaggio estero, e l’Aisi, il controspionaggio interno. I fatti, dunque. IL CABLO DA TUNISI Sono i primi giorni di aprile. L’Aise e l’Aisi ricevono dall’Intelligence tunisina un elenco di nomi sospettati di aver avuto un ruolo nella pianificazione della strage del Bardo. Tra loro, c’è il nome di Abdelmajid Touil, cittadino marocchino di 22 anni, la cui madre risiede in Italia. Tunisi è convinta che il ragazzo possa essere nel nostro Paese e chiede che venga individuato e fermato. Della richiesta viene immediatamente informato Palazzo Chigi e alla faccenda — come è ovvio — viene data la massima priorità. L’informazione viene lavorata in tempi molto rapidi. L’elenco dei nomi ricevuti dai tunisini viene sfrondato fino a ridursi al solo Abdelmajid. Che, tuttavia, non risulta in nessuna banca dati domestica o europea. Per il nostro Paese è un illustre sconosciuto. C’è però una traccia che le due agenzie sviluppano. La madre di Touil, Fatima, ha presentato la denuncia di smarrimento del passaporto del figlio alla questura di Milano. Il 15 aprile, i nostri Servizi trasmettono dunque questa informazione alla Polizia di Prevenzione e al Ros dei carabinieri, con un margine di approssimazione molto ridotto che invita a procedere con le ricerche nei comuni di Legnano e Trezzano sul Naviglio. La Digos e il Ros di Milano si mettono al lavoro. Hanno come riferimento la madre di Touil e un indirizzo di Gaggiano (comune vicino a Trezzano), dove la donna risiede. IL FERMO DEI VIGILI URBANI 27 Trovare Abdelmajid non è dunque complicato. Non si nasconde e vive in casa della madre. Viene individuato qualche giorno prima del 19 maggio. Anche se chi lo pedina ha un dubbio. Del ragazzo non esistono infatti né foto, né impronte digitali (i tunisini non hanno trasmesso né l’una, né le altre). Soprattutto, il ragazzo ha un fratello che pure potrebbe rispondere somaticamente alle indicazioni ricevute dai Servizi. E’ un’impasse da cui Digos e Ros, dopo qualche giorno di inutile attesa di informazioni dai tunisini, decidono di uscire con uno stratagemma. Il 19 maggio fanno fermare il ragazzo dai vigili urbani di Gaggiano per un controllo dei documenti. Che non ha. È la conferma — alla luce della denuncia di smarrimento del passaporto — che si tratta della persona che cercano. Abdelmajid Touil viene dunque preso in consegna dalla Digos. Ma come semplice clandestino. In quel momento, infatti, non esiste alcun titolo formale per arrestarlo per complicità nella strage del Bardo. Perché la richiesta di “ricerca” dei tunisini è rimasta fino a quel momento nel solo circuito informativo dei Servizi. In fretta e furia, le autorità tunisine inseriscono allora nel sistema informatico del circuito Interpol le dieci righe che consentono o, meglio, impongono l’arresto del ragazzo. È un elenco di reati senza alcuna indicazione di fatto: «Omicidio volontario, cospirazione al fine di commettere attenta- ti contro la sicurezza dello Stato, commettere un attentato al fine di mutare la forma di governo, incitare la popolazione ad armarsi, sequestro di persona a mano armata, partecipazione ad addestramento militare per commettere atti terroristici, reclutamento e addestramento di terroristi». LA “SCOPERTA DELLE IMPRONTE” C’è di più. Una volta in Questura, ad Abdelmajid vengono prese le impronte digitali. E solo allora si scopre che quelle impronte sono nella banca dati della Polizia. Intestate a tale Abdimajid Tawil, soccorso il 17 febbraio nel canale di Sicilia dal pattugliatore della Marina Militare “Orione”. Abdimajid Tawil è un nome la cui pronuncia fonetica è identica a quella di Abdelmajid Taouil ed è verosimilmente figlia di un errore materiale di chi, a Porto Empedocle, aveva registrato quel ragazzo al momento dello sbarco. Ma quell’incrocio di impronte svela improvvisamente una storia “politicamente sensibile”: l’arrivo in Italia di «un terrorista» su un barcone di disperati. Miele per la campagna sui migranti di Salvini, della Destra e dei 5 Stelle. LA MOSSA DI ALFANO Alla fine di quel convulso martedì 19 maggio, la situazione richiederebbe massima cautela e profilo basso. Per come sono andate infatti le cose, sul grado di coinvolgimento di Abdelmajid nella strage del Bardo nessuno può scommettere. Tanto più per le modalità con cui si è arrivati alla cattura del ragazzo. Che non solo non si nasconde, ma ha fatto denunciare alla madre la scomparsa del suo passaporto dando delle generalità esatte (non esattamente un comportamento da martire di Allah). Ma Alfano ha altro in testa. Decide di vendere l’arresto e una delicata faccenda di sicurezza nazionale — che come tale dovrebbe essere neutra alla politica — come un successo personale e del governo. Il 20, giovedì, alle 9.50 viene data notizia alle agenzie e convocata una conferenza stampa a Milano. Il ministro, a Roma, parla di «successo investigativo », «piste», «prevenzione », «funzionamento del sistema di identificazione attraverso le impronte digitali». E trascina con sé il presidente del Consiglio Renzi che twitta le sue congratulazioni per l’operazione. Di cosa abbia realmente fatto Abdelmajid non importa niente a nessuno. E solo quando la frittata è fatta si “scopre” che il giorno della strage il ragazzo era nella scuola dove nessuno, prima di “ Repubblica”, aveva visto bene di bussare. 28 del 22/05/15, pag. 6 Da armiere a uomo del commando Tutti i buchi nelle accuse dalla Tunisia Fiorenza Sarzanini ROMA Due settimane dopo l’attentato al Bardo le autorità tunisine chiesero collaborazione ai servizi di intelligence italiana. E indicarono Abdel Majid Touil come l’armiere della cellula terroristica che aveva attaccato il museo. Dopo il fermo eseguito tre giorni fa hanno invece fatto sapere che il marocchino era uno dei componenti del commando che entrò in azione uccidendo 24 persone tra cui 4 italiani. Una circostanza smentita dalle verifiche effettuate dai poliziotti della Digos e dai carabinieri del Ros che invece ritengono di poter dimostrare la sua presenza a Gaggiano il 18 marzo scorso, giorno della strage. E su questo continuano a ruotare i misteri che ancora avvolgono la vicenda, alimentati da nuovi dettagli, altre circostanze che certamente peseranno al momento di decidere se estradare il giovane a Tunisi. Si torna dunque agli interrogativi ancora aperti, in attesa che venga messo a disposizione dei giudici italiani il fascicolo con le accuse formali e la ricostruzione delle indagini svolte dalla magistratura tunisina. Dubbi alimentati anche da una fotografia pubblicata dal quotidiano Akher Khabar Online che mostra Abdel Majid Touil molto più anziano, con un paio di baffi neri. Possibile che ci sia stato un errore di identità? Gli investigatori italiani tendono ad escluderlo «perché la data di nascita indicata dai tunisini coincide con quella dello straniero fotosegnalato a Porto Empedocle il 17 febbraio scorso, poche ore dopo il suo arrivo in Italia a bordo di un barcone». E allora come mai le contestazioni al giovane che vive con la madre in provincia di Milano appaiono così infondate? Che cosa è davvero accaduto in questi due mesi dopo l’attentato? La segnalazione giunta a metà aprile ai Servizi Segreti italiani parla di Touil come del terrorista che ha procurato i kalashnikov per l’attacco. L’allerta girato alle forze dell’ordine è invece generico, nel documento c’è un elenco di nominativi indicati come «sospetti» fondamentalisti ma senza fornire ulteriori informazioni. Al Bardo sono morti quattro italiani, la procura di Roma ha avviato un’inchiesta. Se c’era il dubbio che uno dei terroristi fosse giunto nel nostro Paese perché non sono stati sollecitati controlli urgenti? Come mai si è corso il rischio di lasciare libero un personaggio tanto pericoloso? Gli investigatori avrebbero potuto compiere accertamenti, pedinarlo e tenerlo sotto controllo per scoprire se davvero aveva strane frequentazioni, se aveva contatti con la Tunisia o addirittura che prima di imbarcarsi alla volta dell’Italia avesse trascorso due settimane in un campo di addestramento in Libia come assicuravano alcune indiscrezioni circolate ieri e rimaste senza riscontro. E invece nulla accade fino a martedì scorso quando le autorità tunisine sollecitano il fermo riservandosi di chiedere il trasferimento per poterlo giudicare. La consegna dello straniero appare tutt’altro che scontata, anche tenendo conto che in Tunisia c’è la pena di morte e secondo il nostro ordinamento è possibile chiedere l’inserimento di una clausola che condizioni l’estradizione alla certezza che l’imputato non possa essere sottoposto a pena capitale. E comunque bisognerà verificare la fondatezza delle contestazioni, stabilire se sia davvero un componente della cellula, se si tratti di un fiancheggiatore o se possa essere addirittura estraneo. In ogni caso, proprio perché esiste un fascicolo aperto anche dagli inquirenti della Capitale, non è escluso che alla fine si decida di trattenerlo per motivi di giustizia, di processarlo qui e, in caso di condanna, di mandarlo nel suo Paese d’origine, il Marocco, per scontare la pena. 29 Molto dipenderà anche dalle trattative diplomatiche già avviate tra Roma e Tunisi. I due Paesi hanno ottimi rapporti, esistono trattati bilaterali di cooperazione in materia di immigrazione e terrorismo e anche le forze di polizia hanno lavorato insieme dopo l’attentato proprio per scambiarsi informazioni. Un’intesa che in queste ore viene messa duramente alla prova . del 22/05/15, pag. 15 Il piano pd per le norme sui partiti E arriva la stretta sul dissenso interno La strategia legata all’Italicum: con 25 voti di maggioranza necessarie disciplina e unità ROMA Un partito che vince anche senza alleati, realizzando il sogno veltroniano della «vocazione maggioritaria». Un partito che rafforza l’azione del governo grazie a gruppi parlamentari compatti come una falange macedone, dove i voti in dissenso sono ridotti a pochi casi di libertà di coscienza e dove chi si smarca paga pegno. «In segreteria — ha dichiarato Debora Serracchiani lasciando il Nazareno dopo la riunione — abbiamo fatto il punto sia sui numeri che sulla tenuta del Pd, che è buona ovunque». Con la sua squadra Matteo Renzi non ha parlato di partito della nazione, ma ha confermato la direzione di marcia. «Fatto l’Italicum diventa urgente costruire il partito adatto alla nuova legge elettorale — spiega Giorgio Tonini —. Un Pd che si apra a nuovi apporti, da Dellai alle realtà civiche. Chi vince avrà 25 voti di maggioranza e senza un senso forte di disciplina e unità interna la stabilità è a rischio». Con l’Italicum i deputati che fanno capo a Speranza e Bersani basterebbero a buttare giù il governo. E così Renzi accelera, annunciando una «tre giorni per pensare, tutti insieme, al nostro modo di stare nel Pd». Chi vota in dissenso subisce sanzioni? Questo è il punto politico da affrontare dopo le regionali. Il premier non ha parlato di espulsioni, ma ha detto che «è ora di darci delle regole su come si sta insieme». Matteo Orfini le vorrebbe stringenti e lo dice senza giri di parole: «Il Pd non prevede provvedimenti per i voti in dissenso, ma forse una riflessione dove si garantisce che il nostro partito non diventi una federazione di correnti dobbiamo farla». Su questioni etiche e materia costituzionale la libertà di coscienza sarà garantita. Su temi come scuola, lavoro o legge elettorale invece, con le nuove tavole della legge sarà più difficile smarcarsi. E qui Orfini è durissimo con Bersani e compagni: «Trovo che votare contro decisioni assunte assieme nei gruppi sia una interpretazione molto discutibile di come si sta in un partito — è il monito del presidente alla minoranza —. Soprattutto da parte di quelli che non ebbero alcuna perplessità a chiedermi, in nome della disciplina di partito, di votare la fiducia a un governo con Berlusconi». Il seminario annunciato da Renzi potrebbe non essere indolore vista la battuta con cui Nico Stumpo, di Area riformista, saluta la notizia: «Lo Statuto dobbiamo riscriverlo, ma il Pd ha già delle regole e il saggio Dei delitti e delle pene esiste già, lo ha scritto Cesare Beccaria». Al Nazareno una commissione ad hoc, presieduta da Orfini e Guerini, lavora da mesi alle modifiche statutarie e agli eventuali regolamenti, un pacchetto che dovrà essere votato dall’assemblea nazionale. La commissione ha anche concluso il lavoro per una proposta di legge sui partiti in applicazione dell’articolo 49 della Costituzione, che sarà depositata martedì con le firme di Guerini, Orfini, Stumpo e De Maria. «Oltre alla trasparenza e alla 30 democrazia, prevediamo che i partiti abbiano personalità giuridica — spiega Guerini —. Un tema dibattuto ciclicamente dai tempi della Costituente». Il cuperliano Andrea De Maria è soddisfatto per «l’ottimo lavoro unitario» della commissione e si è convinto che «regole condivise per la disciplina di voto siano un elemento di chiarezza importante per tutti, forse ancora di più per chi dissente». Vista la scarsa compattezza della minoranza, il divieto di procedere in ordine sparso potrebbe togliere molti non-renziani dall’imbarazzo. In particolare al Senato, dove i voti della sinistra dissidente sono decisivi. Renzi si appresta anche a fare il tagliando alle primarie per evitare inquinamenti e a chiudere le polemiche sulla forma partito. E qui la decisione è presa. Il nuovo Pd sarà «un partito di iscritti ed elettori». Monica Guerzoni del 22/05/15, pag. 6 M5S, caccia al primato. E al futuro leader Regionali. Quella dei 5 Stelle potrebbe risultare la lista più votata. Valeria Ciambarino è la candidata presidente. Ma il test è anche per Luigi Di Maio Adriana Pollice NAPOLI Nel 2010 il Movimento 5 Stelle in Campania muoveva i primissimi passi, alle elezioni regionali prese l’1,33%, il candidato governatore Roberto Fico l’1,34. Alle politiche del 2013 erano già sopra il 20% in regione, l’anno dopo alle europee al 22,9. I sondaggi li danno ancora sopra il 20% anche per le regionali campane di fine mese, con la possibilità di risultare il primo partito. La candidata alla poltrona di presidente è Valeria Ciarambino, quarantenne di Pomigliano d’Arco, impiegata di Equitalia, selezionata attraverso il voto on line degli aderenti al movimento. Tutta la campagna elettorale è stata indirizzata a diffondere la sua immagine potendo contare sulla spinta, fortissima, di Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera pure lui di Pomigliano. Anzi, le regionali campane saranno un banco di prova per testare anche la presa sull’elettorato di Di Maio, il nome su cui i grillini potrebbero puntare come presidente del consiglio quando si tornerà a votare. Degli altri candidati M5S al consiglio si sa poco: in Campania si cerca di evitare un nuovo caso Bartolomeo Pepe, sfiduciato dal Meet up di Napoli e approdato nel 2014 al gruppo misto del Senato. Scoraggiare anche personaggi come Angelo Ferrillo, per molto tempo dato tra i volti di spicco del movimento, da cui poi si è staccato per presentare una propria lista (Mai più terra dei fuochi), collegata al governatore uscente di Fi Stefano Caldoro. I grillini sono impegnati anche nelle comunali, soprattutto nell’hinterland partenopeo: si giocano la possibilità di vittoria a Pomigliano, San Giorgio a Cremano e Quarto dove, grazie al loro ricorso, il Consiglio di Stato ha eliminato per irregolarità sette liste, compreso il superfavorito candidato sindaco del Pd. La campagna elettorale la finanziano i simpatizzanti, attraverso la raccolta fondi in rete, e i parlamentari, che danno appuntamento nelle pizzerie dove si trasformano in camerieri per una sera: «A Napoli — racconta Ciarambino — abbiamo raccolto 6mila euro. Riccardo Fraccaro si è mantenuto agli studi facendo il pizzaiolo in Trentino, quindi è il più bravo del gruppo». Valeria Ciarambino è l’unica, tra gli aspiranti governatore, che è anche capolista: entra in consiglio solo il secondo classificato che abbia superato il 10%, a meno che non 31 venga votato anche tra i consiglieri. La Ciarambino ha poche chance in un’elezione a turno secco, con la possibilità del voto disgiunto, soprattutto per un movimento che non ha liste collegate. Il paracadute la porterà comunque in consiglio. Intanto, chi voleva candidarsi come assessore ha avuto modo di mandare il curriculum via internet: «Bisogna dichiarare prima chi sarà nella squadra di governo così l’elettore sa cosa vota — prosegue -. Altrimenti si apre la strada alla lottizzazione delle poltrone. Vincenzo De Luca probabilmente si farà dare da Ciriaco De Mita il nome da mettere alla Sanità. La nostra idea prevede un presidente, un vice e 5 assessori, uno per ogni dipartimento. Stiamo vagliando i curricula arrivati, a breve pubblicheremo i nomi». La scorsa settimana la candidata del M5S si è presentata al depuratore di Cuma, dove da anni si attende che venga sistemato un semplice tubo che consenta di sversare al largo e non nelle vicinanze del litorale. Poi, accompagnata da Di Maio, è stata la volta dell’ospedale del Mare, inaugurato a marzo da Caldoro: «Ci siamo dovuti andare con i caschetti, come gli operai, perché è ancora un cantiere. Funziona solo il 5% della struttura, non si possono nemmeno fare le analisi. Il governatore ha inaugurato la reception. Non ci sono neppure i collegamenti pubblici. Ci si arriva solo in auto». Ieri è stata a Paestum, simbolo, spiega, di quello che potrebbe essere la Campania: patrimonio archeologico, paesaggistico, la risorsa mare e le eccellenze alimentari in un’unica offerta ecosostenibile. Il cavallo di battaglia però anche qui è il reddito di cittadinanza. Il candidato presidente per la lista Mo!, Marco Esposito, l’ha ripresa sul tema della copertura per i 500 euro al mese per 460mila famiglie: «Si tratta di prendere un impegno politico — la replica -, le coperture si trovano, cominciando dai tagli ai costi della politica, alle consulenze, agli stipendi dei dirigenti pubblici, vitalizi, affitti, auto blu. Poi naturalmente ci sono i fondi europei. Noi abbiamo la credibilità per proporlo, a Ragusa l’abbiamo fatto». E ancora, il lavoro. A Pomigliano c’è una delle sedi Alenia minacciate dal piano Finmeccanica che si sta trasformando in una fuga a tappe dalla Campania: «Bisogna puntare sull’innovazione ma, intanto, difendere le attività produttive che ci sono. La regione è stata debole e complice, ai tavoli romani si è seduta per barattare il futuro dei lavoratori con le poltrone. Non hanno mosso un dito quando i 3miliardi e mezzo del fondo di Coesione per il sud sono finiti a copertura delle detrazioni del Jobs act». Due settimane fa Ciarambino è stata a Bruxelles, il M5S ha depositato una richiesta di intervento dell’Ue nella Terra dei fuochi, dove si continua a sversare e bruciare. Unica nota positiva, secondo i grillini, la legge sugli ecoreati. Molti ambientalisti l’hanno criticata perché lascerebbe le porte aperte agli inquinatori di professione: «Per noi è un successo. Lo dedichiamo alle mamme delle Terre dei fuochi disseminate per l’Italia. Se ci fosse stata 20 anni fa avremmo evitato molti morti». del 22/05/15, pag. XV Blitz contro gli orchi di Termini I ragazzini rom, tra i 13 e 15 anni, si vendevano per pochi euro. In manette anche un sacerdote e il pr di alcune discoteche del litorale GIUSEPPE SCARPA MARIA ELENA VINCENZI «AL BINARIO 29, lo conosci il binario 29? C’ho uno fisso che me vie’ con 10 euro e me lo tengo, hai capito? Anzi, te volevo fa’ vede’ chi era, almeno te lo facevi pure tu». Il fulcro di tutto era il binario 29 della stazione Termini. Lì, su qualche treno fermo in attesa dei 32 pendolari, ragazzini rom tra i 13 e i 17 anni vendevano il loro corpo. Maschi e femmine, soprattutto maschi. Giovanissimi in condizioni disagiate che, per 10, 20, 30 euro si concedevano a uomini tra i 35 e gli 80 anni. Spesso su un vagone, a volte in un bagno pubblico, altre a casa loro. Passeggeri di passaggio ma più spesso habituè che i giovanissimi aspettavano sulle scale mobili o in fondo al binario. E’ questo il giro smascherato dalla procura di Roma e dalla Polizia Ferroviaria che ieri hanno arrestato otto persone per prostituzione minorile. Diversi gli indagati: la procura aveva chiesto 17 misure e le indagini continuano perché il giro era piuttosto grosso. Tra i clienti indagati anche un ex sacerdote mentre è finito in manette un sacerdote ancora in servizio in due parrocchie nel viterbese, Placido Greco, detto Don Dino. Il giudice per lui non aveva disposto alcuna misura, ma ieri quando gli agenti si sono presentati nella sua casa di Fiumicino per perquisirlo (era comunque inquisito), hanno trovato sul suo computer 1700 immagini pedopornografiche. Arrestato in flagranza per la detenzione, è da ieri sera in carcere. E durante i pedinamenti erano stati registrati due episodi con due minori rom, entrambi maschi, uno su un treno e uno a casa. Ma il sospetto di chi indaga, vista la quantità di materiale trovata sul suo pc è che le vittime possano essere molte di più. Ma Don Dino non era il solo. Gli arrestati ieri sono otto e tra questi c’è anche il pr di una discoteca del litorale. Il giro che, secondo il procuratore aggiunto Maria Monteleone e il pm Cristiana Macchiusi, non era gestito dall’alto ma basato sul passaparola, aveva diversi clienti e una quindicina di ragazzi coinvolti. Che aspettavano i loro aguzzini per cifre che non superavano mai i 50 euro. Gente che non si faceva scrupoli nemmeno a parlarne per telefono. Quasi fosse una cosa normale. Nell’ordinanza firmata dal gip Chiara Giammarco, ci sono foto di incontri hard e, soprattutto, centinaia di telefonate intercettate non solo con i ragazzini per fissare gli appuntamenti (basti pensare che uno degli arrestati tra marzo e agosto dello scorso anno incontra lo stesso teenager per ben 51 volte), ma anche tra di loro, i pedofili, per scambiarsi consigli, commenti, pareri. Cose del tipo: «Io ti volevo sentire, l’altro giorno so’ stato benissimo! Tu? Ti è piaciuto l’altro giorno? A casa?». Alla risposta affermativa, il cliente continuava: «Ma sì poco o tanto?». L’indagine è andata avanti per un anno circa. Gli inquirenti sapevano che nello scalo c’era qualcosa che non andava. E a un certo punto sono iniziati i controlli della polizia che hanno messo in allarme gli indagati. «C’è un sacco di polizia — racconta uno degli indagati a un amico, probabilmente un altro frequentatore del binario 29 — mo’ se li so’ presi tutti e l’hanno portati all’ufficio. So tanti in borghese. Tanti di qua, tanti di là». L’amico chiede: «Quindi non si fa più niente?». «C’è stata la retata, amo’, la retata. No, amo’ c’è un sacco di controllo». 33 LEGALITA’DEMOCRATICA del 22/05/15, pag. 1/13 Pena fino a 8 anni per chi manipola i dati aziendali. Superata la norma del 2001 varata da Berlusconi che prevedeva solo una contravvenzione e di fatto aveva depenalizzato gli abusi. Più facile licenziare i dipendenti pubblici condannati Dopo 14 anni torna il falso in bilancio chi patteggia deve restituire il “bottino” LIANA MILELLA ROMA . Due anni e due mesi. Troppo tempo per una legge anti-corruzione. In 797 giorni si sarebbe potuto, e dovuto, fare molto di più, anziché litigare su una manciata di settimane aggiuntive per punire la corruzione. Renzi si vanta di aver sconfitto l’idrovora della prescrizione, ma dovrà fare ancora i conti con le tante notizie di cronaca che rassegnano ben altra realtà. Quella di processi per corruzione che vanno in fumo per il tempo scaduto. Certo, la corruzione per un fatto contrario ai doveri di ufficio passa da 8 a 10 anni. Ma quale sarà la conseguenza sulla prescrizione? Solo due anni in più. Ancora troppo pochi. Ora la sfida per Renzi è un’altra, se la troverà di fronte con la prossima legge sulla prescrizione, il grattacapo della maggioranza dopo il voto amministrativo. Lì, il premier potrà farsi valere e seguire i consigli del Csm e dell’Anm. Stop alla prescrizione dopo il primo grado. Ma purtroppo anche lì rischia di prevalere la linea iper garantista di Ncd e quella garantista di una parte consistente del Pd. È il confine insuperabile che ha stretto le norme contro la corruzione. Certo, il falso in bilancio ritrova la dignità di reato. Ma bastava seguire la linea Grasso per cavarsi d’impaccio. Da senatore del Pd, nel primo giorno a palazzo Madama, Piero Grasso aveva depositato il suo ddl contro la corruzione, frutto di una vita spesa da magistrato antimafia. Frutto delle decine di audizioni nelle commissioni parlamentari. C’era tutto. Il falso in bilancio intercettabile nelle sue distinzioni. Via la confusione tra vecchia concussione e nuova induzione, conseguenza della divisione dell’ex Guardasigilli Severino che ha messo a rischio i vecchi processi e crea confusione nei nuovi, la confisca dei beni per i corrotti come per i mafiosi. E ancora la “gola profonda”, il testimone di fatti corruttivi protetto come negli Usa. Fino a ipotizzare l’agente provocatore. Per fare tutto questo bisognava essere convinti che la corruzione è un reato gravissimo come la mafia e il terrorismo. Quindi da punire e da trattare al pari dei più gravi reati. Ha prevalso la paura politica e ha vinto il compromesso. Il risultato comunque c’è. È una mezza vittoria contro i corrotti. Poteva essere un grande trionfo. del 22/05/15, pag. 15 Tensioni in commissione Antimafia sulla lista di tredici «impresentabili» 34 ROMA Sembrava una missione quasi impossibile, invece la commissione Antimafia è vicina al traguardo. Se tutto va bene martedì la presidente Rosy Bindi potrà ufficializzare l’elenco dei candidati alle elezioni regionali che, a norma del codice di autoregolamentazione approvato dalla commissione, gli elettori dovrebbero guardarsi bene dal votare. L’Antimafia ha passato al setaccio le liste di Liguria, Campania e Puglia e sta procedendo alla verifica delle altre quattro Regioni che il 31 maggio andranno alle urne, Veneto, Marche, Umbria e Toscana. Di ufficiale non c’è nulla e su richiesta della Bindi i membri della commissione osservano il più assoluto riserbo. Ma alla Camera ieri girava la voce di una tempestosa riunione mercoledì sera nel chiuso di palazzo San Macuto, dove l’ufficio di presidenza dell’Antimafia si è riunito. I cinquestelle Gaetti e D’Uva, in asse con Fava e De Cristofaro di Sel, spingevano per la linea dura. L’azzurro Falanga e il socialista Buemi frenavano in nome del garantismo: niente pagelle di moralità. E il pd Mirabelli si mostrava cauto, per il timore che una nuova ondata mediatica contro gli «impresentabili» allontani gli elettori dalle urne. Ieri mattina l’organismo ristretto della commissione è tornato a riunirsi e ha trovato un’intesa. Si è scelto (all’unanimità) di dare alla Bindi il mandato di diffondere l’elenco dei candidati non in linea con il codice, non prima però di aver acquisito ulteriori elementi di valutazione sulle posizioni processuali di ciascuno. La scrematura ha evidenziato tredici nomi. In Campania due candidati non idonei farebbero capo alle liste di De Luca e uno a quelle di Caldoro. Mentre in Puglia quattro nomi non specchiati sarebbero in corsa con Emiliano e due con il fittiano Schittulli. Nel Transatlantico di Montecitorio rimbalza il nome di Tommaso Barbato. L’ex senatore dell’Udeur, che fu determinante per far cadere Prodi nel 2008, è candidato con Campania Libera, la lista civica di De Luca. Famoso per aver sputato in aula a Nuccio Cusumano — gesto per il quale rivendica il diritto all’oblio — Barbato è accusato di voto di scambio dalla Procura di Napoli. Ma le pagelle dell’Antimafia non lo preoccupano: «Sono una persona per bene. Se avessi saputo di questi attacchi strumentali avrei evitato di candidarmi». E la presunta compravendita? «Nessun voto di scambio, non ho mai fatto affari con la politica. È solo accanimento e dopo le elezioni chiarirò tutto». E l’abuso di ufficio dell’inchiesta Arpac? «Sono stato sfiorato da una accusa che non esiste, mio figlio al concorso Arpac fu bocciato». Enrico Buemi ritiene utile il lavoro di denuncia, ma teme strumentalizzazioni. Per il senatore socialista «non è compito dell’Antimafia diventare un comitato ideologico». Marco Di Lello (Psi), altro «garantista estremista», propone di chiedere aiuto alle prefetture: «Se mandassimo gli elenchi dei candidati con un mese di anticipo, i partiti potrebbero presentare delle liste “mafia free”, con tanto di bollino». M. Gu. 35 RAZZISMO E IMMIGRAZIONE del 22/05/15, pag. 8 Quote rifugiati, ecco il piano Ue aiuti a Italia e Grecia: “Ma più controlli” ANDREA BONANNI BRUXELLES POTREBBE essere molto superiore alle previsioni iniziali il contingente di rifugiati attualmente in Italia e Grecia che la Commissione proporrà di ridistribuire tra tutti i Paesi europei. Le cifre che circolano nelle discussioni tra i gabinetti dei commissari sono infatti comprese in una forbice tra 35 e 40 mila persone: circa il doppio delle ipotesi avanzate finora. Nonostante le forti resistenze che l’idea di una ricollocazione obbligatoria di emergenza ha suscitato in molte capitali, l’esecutivo comunitario guidato da Jean-Claude Juncker non sembra orientato a fare marcia indietro, forte anche dell’appoggio del Parlamento europeo e del fatto che le resistenze francesi sembrano in gran parte rientrate. Mercoledì dunque proporrà formalmente ai governi di decidere con una procedura di urgenza la ricollocazione di un forte contingente di richiedenti asilo, prevalentemente siriani ed eritrei, che dovrebbero essere ridistribuiti sulla base di quote vincolanti per ciascun Paese europeo. La Commissione conta sul fatto che la procedura di urgenza comporta un voto a maggioranza qualificata e che Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca, avendo deciso di far valere il loro opt-out, non parteciperanno alla votazione. Il 15 e 16 giugno, quando i ministri degli interni voteranno sulla proposta, ci dovrebbe pertanto essere una maggioranza sufficiente per approvarla. Ma il piano di Bruxelles non arriverà senza condizioni. L’idea della Commissione è quella di seguire, per l’emergenza immigrazione, lo stesso modello utilizzato ai tempi della crisi dell’euro per venire in aiuto dei Paesi che si trovavano sull’orlo della bancarotta. La solidarietà, insomma, viene data in base ad un preciso impegno del Paese beneficiato a mettere in atto una serie di misure in ottemperanza alle norme europee. In quella circostanza, i prestiti salva-stati vennero concessi a condizione di varare una serie di riforme e di mettere in atto un radicale risanamento delle finanze pubbliche. In questo caso, i Paesi europei si farebbero carico di alleggerire di una quota-parte di rifugiati l’Italia e la Grecia, che sono i due Paesi maggiormente colpiti dall’emergenza, a condizione che questi si impegnino a rispettare rigidamente una serie di norme europee in materia di accoglienza dei migranti. Tre sono i temi su cui punteranno le condizioni europee: identificazione, custodia e rimpatrio. L’identificazione, e il prelievo delle impronte digitali, devono avvenire immediatamente dopo lo sbarco dei profughi e i dati devono essere tempestivamente comunicati a tutti gli altri stati membri in modo da rendere più difficile per i clandestini il passaggio dall’Italia agli altri Paesi (in particolare Germania e Francia) che sono l’obiettivo ultimo del loro viaggio. Inoltre un clandestino già identificato in Italia che venisse fermato per esempio in Germania, potrebbe essere rispedito in Italia in attesa dell’espulsione. Per quanto riguarda la custodia l’Europa vuole essere sicura che i rifugiati, molti dei quali non hanno diritto all’asilo, non possano fuggire con facilità dai centri di accoglienza italiani e greci come avviene adesso per poi disseminarsi negli altri Paesi. Quindi, oltre a garantire condizioni umane per gli ospiti dei centri, che si trovano ora in stato di sovraffollamento, l’Italia e la Grecia dovranno impegnarsi a renderli più sicuri impedendo le fughe che oggi sono all’ordine del giorno. 36 Infine il rimpatrio, per coloro che arrivano sulle nostre coste pur non avendo diritto all’asilo, deve essere «tempestivo ed efficiente ». Il caso di Abdel Majid Touil è indicativo che le operazioni di rimpatrio in Italia non funzionano come dovrebbero. Arrivato con un barcone e identificato come migrante economico clandestino senza diritto all’asilo, Touil ha ricevuto un decreto di espulsione ma, invece di essere rimandato in Marocco, ha potuto tranquillamente raggiungere la madre a Milano dove si era insediata. L’Europa sarà pronta a mettere a disposizione uomini, mezzi e fondi per aiutare l’Italia e la Grecia a fronteggiare meglio le operazioni di identificazione, custodia e rimpatrio. Ma su questi punti esigerà un rispetto rigoroso delle norme come condizione per dare prova di solidarietà accollandosi l’onere di decine di migliaia di rifugiati che oggi stanno portando al collasso le nostre strutture. del 22/05/15, pag. 9 Lo sfogo di Renzi: «Inaccettabili i dubbi dei leader sui migranti» «Se i contrari al piano Ue aumentano, salta tutto» DAL NOSTRO INVIATO RIGA Mentre l’Europa corregge il tiro sull’allargamento del suo modello ai Paesi che erano parte della Russia sovietica, ripensa il suo approccio di partenariato orientale, Matteo Renzi arriva in Lettonia guardando a Sud, alla battaglia di Roma su una politica di asilo per i rifugiati che sia realmente accettata nella maggior parte delle capitali del Vecchio continente. Nella cena dei capi di Stato e di governo, insieme alla Merkel e ad Hollande, ieri sera la concentrazione era tutta rivolta alla crisi ucraina, agli aiuti allo sviluppo che Bruxelles può ancora promettere a dei Paesi che sono geograficamente e politicamente indecisi se scegliere Mosca o la Ue, ma per Renzi l’occasione di confronto con i colleghi è servita anche a ribadire che per l’Italia in questo momento la questione più urgente è quella dei rifugiati e del piano cha la Commissione europea ha proposto ai 28 membri dell’Unione. Negli ultimi giorni il capo del governo si è sfogato più volte con il suo staff, l’indecisione di Paesi come la Francia rischia di pregiudicare il progetto di quote definito a Bruxelles, cosa che per Palazzo Chigi sarebbe «inaccettabile». Secondo i collaboratori del premier, Renzi sarebbe così deciso nel difendere il piano europeo che introduce una politica condivisa per i richiedenti asilo da essere pronto a minacciare di far «saltare tutto» se a giugno, al Consiglio europeo, i Paesi contrari alle quote dovessero essere più di quelli che una decisione di questo tipo richiede. Per Renzi quello delle quote è un principio sacrosanto, che fa parte di un pacchetto complessivo che comprende tutto quello che la Ue sta facendo contro l’immigrazione clandestina. E’ pur vero che una decisione sarà presa a maggioranza qualificata, che su un tema come l’immigrazione non esiste diritto di veto, ma nel governo italiano la preoccupazione è non solo che prevalgano posizioni dal sapore populista, ma che anche Paesi che formalmente si dichiarano d’accordo, per esempio la Francia (Hollande ha in qualche modo corretto il primo ministro Valls due giorni fa) in concreto non facciano molto per far decollare il progetto. Insomma «Hollande deve darci una mano e fare la sua parte», è quello che si ascolta nella delegazione italiana, dove l’aiuto richiesto significa in primo luogo una mano a coagulare un consenso che sia ampiamente maggioritario quando ci sarà da prendere una decisione, a giugno. E anche se per Renzi è più importante che passi il principio generale, 37 che venga accettata una reale e condivisa politica di asilo per i rifugiati a livello comunitario, i numeri che circolano non sono secondari. Ieri fonti della Commissione europea hanno reso noto che il meccanismo di redistribuzione dei rifugiati, che verrà proposto agli Stati membri, comprenderà i richiedenti asilo siriani ed eritrei, e gli Stati beneficiari dell’iniziativa saranno principalmente Grecia e Italia. Ma il numero complessivo di persone che si prevede di spostare dai due Stati che maggiormente fronteggiano gli arrivi di migranti sulle proprie coste sarà indicato solo nel corso della riunione del collegio dei commissari del 27 maggio, da cui si attende il via libera alla proposta legislativa. Attualmente, a seconda dei parametri e delle condizioni che potrebbero essere discussi e approvati, la forchetta oscilla fra 20 e 50 mila persone che dovrebbero essere distribuite fra i diversi Stati dell’Unione europea. Ovviamente si tratta di un punto molto delicato e politicamente molto sensibile. «Nelle prossime settimane vedremo se è tutta fuffa o se c’è qualcosa di concreto», ha detto Renzi due giorni fa, annunciando la decisione del governo italiano di ripescare il barcone che giace in fondo al mare, nel Canale di Sicilia, con un carico di morte — secondo le stime furono più di 800 — che provocò forse per la prima volta una reale indignazione internazionale. Un’operazione che potrebbe servire anche a combattere gli egoismi nazionali di molte capitali europee. Marco Galluzzo Del 22/05/2015, pag. 6 Schedature, fughe ed espulsioni Ecco cosa succede dopo gli sbarchi Centinaia di migranti cercano di raggiungere ogni giorno l’Italia. Chi ci riesce deve passare attraverso una lunga serie di controlli, mapochi vengono rimpatriati Grazia Longo Quando scatta il decreto di espulsione? E nei confronti di chi? Vengono espulsi gli stranieri che non hanno un regolare visto di ingresso o un permesso di soggiorno. Sono ritenuti clandestini gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto d’ingresso. Mentre sono considerati irregolari gli stranieri che hanno perso i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (per esempio il permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano però in possesso all’ingresso in Italia. Il decreto di espulsione scatta quando si scopre che gli stranieri sono clandestini non richiedenti asilo: non manifestano cioè l’esigenza di una protezione internazionale. In che modo vengono individuati e schedati i clandestini? Quasi tutti arrivano sulle coste italiane viaggiando sui barconi, le cosiddette carrette del mare. Una volta soccorsi e trasferiti sui mezzi della Marina militare e Guardia Costiera, i clandestini vengono sottoposti a un primo screening sanitario. Il secondo li aspetta al momento dello sbarco, quando hanno inizio anche le operazioni di identificazione. Fotosegnalazioni e impronte digitali vengono spediti al presunto Paese d’origine dichiarato dal clandestino per poter avere dati certi sull’identità del migrante. Come scatta il decreto di espulsione? Attraverso il decreto firmato dal Prefetto. «A questo documento segue il decreto di trattenimento e ordine del Questore per il trasferimento nei Cie - spiega il responsabile dell’ufficio immigrazione della Questura di Roma, Fabrizio Mancini -. Perché per essere 38 espulso il clandestino ha bisogno del passaporto o di un documento di identità equipollente. Nell’attesa di ottenerlo, viene sistemato nei «Centri identificazione espulsione». Il decreto di espulsione, quindi, scatta solo se si è ricostruita l’identità del clandestino, che altrimenti rimane dentro il Cie. Quali sono i tempi di permanenza nei Cie? La legge prevede che un immigrato debba rimanere all’interno del Cie fino a quando non si sia risalito alla sua identità. Un procedimento in realtà molto difficile, spesso impossibile. I termini di legge sono 90 giorni, dopo di che il clandestino, anche se non è in possesso del passaporto, deve uscire dal Cie. A questo punto gli viene intimato di abbandonare il territorio italiano entro 7 giorni. Il termine dell’abbandono del nostro Paese viene rispettato? Raramente. Spesso i clandestini vengono, dopo qualche periodo, nuovamente scoperti nel nostro Paese senza documenti. Per loro scatta una seconda volta il ricovero nei Cie nella speranza che si possa finalmente procedere alla loro identificazione. Molti, invece, abbandonano l’Italia non per rimpatriare, ma per recarsi in altri Paesi dell’Unione europea come Svezia, Francia, Germania. Il decreto di espulsione viene dunque applicato poco? Sì, rispetto al numero dei clandestini. «A Roma, per esempio - precisa ancora il dirigente dell’immigrazione Mancini - lo scorso anno abbiamo registrato circa 4500 immigrati di cui è stato effettivamente espulso, rimpatriato, solo il 25%». Il maggiore ostacolo all’espulsione è la difficoltà a identificare i clandestini? Proprio così. Con alcuni Paesi c’è collaborazione - Nigeria, Gabon, Tunisia, Egitto, Algeria - per ottenere la documentazione necessaria, ma se nessuno li riconosce i migranti non possono essere espulsi. 39 DIRITTI CIVILI E LACITA’ del 22/05/15, pag. 40 L’Isola di smeraldo era la nazione più conservatrice d’Europa Oggi decide con una consultazione popolare se introdurre le nozze tra omosessuali. Tutti i partiti invitano a votare “sì”. E perfino parte della Chiesa è a favore Matrimonio all’irlandese ENRICO FRANCESCHINI DAL NOSTRO INVIATO DUBLINO TOC , toc. Una simpatica vecchietta apre la porta in una viuzza dietro il porto di Dublino. «Buongiorno signora, sono qui per chiederle il permesso di sposarmi», le dice con prontezza Rebecca Murphy, 34 anni, volontaria della campagna per il “sì” al matrimonio gay nel referendum che si tiene oggi in Irlanda. «Dio ti benedica, figliola, non capisco perché hai bisogno della mia autorizzazione ma sono ben lieta di dartela, il matrimonio è una cosa meravigliosa », risponde sorpresa la nonnina. Quindi domanda chi è lo sposo. «Eccola», replica Rebecca, indicando Mary Burgen, la ragazza che fa campagna porta a porta insieme a lei, «è la mia girlfriend e vorrei che diventasse mia moglie, ma ho bisogno del suo voto per poterlo fare. Me lo darà?». L’elettrice dai capelli bianchi tace, deglutisce, scuote la testa e poi chiude la porta in faccia alle due lesbiche che sognano di sposarsi. «Le reazioni negative o imbarazzate non mancano», commenta Mary. «L’altro giorno un tizio ci ha rincorse con un crocefisso gridandoci “sodomiti”, già questo un segno di confusione in materia di sessualità. Ma la maggior parte della gente è genuinamente interessata alla questione. E chi ha dei dubbi sembra felice di poterseli chiarire: capita che ci facciano entrare, ci invitino a prendere un tè e poi non la smettano più di interrogarci ». Dubbi e interrogativi non devono meravigliare. L’Isola di Smeraldo, come è soprannominata per il colore dei suoi prati, era il Paese più cattolico, tradizionalista e moralmente conservatore d’Europa. Qui l’omosessualità ha smesso di essere un reato soltanto nel 1993. Il divorzio è stato approvato due anni dopo, con un referendum, per appena 9mila voti di differenza. L’aborto rimane illegale. Niente di strano, dunque, nella reazione della vecchietta alle due militanti del Lbgt, il movimento Lesbian Bisexual Gay Transgender, che ora ha una sua sezione anche in Irlanda. La meraviglia, casomai, è che in una nazione del genere si faccia una consultazione popolare per introdurre le nozze tra i gay, e che tutti i partiti politici irlandesi, di centrosinistra, di centro e di centro-destra, invitino apertamente a votare “sì” alla nuova legge: compreso il primo ministro Enda Kenny, un tempo fiero oppositore dei diritti dei gay, quindi convertito sulla via di Damasco, anche in virtù dell’annuncio del suo ministro della Salute Leo Varadkar di essere omosessuale, primo segretario irlandese della storia apertamente omosessuale. «Votate “sì” al matrimonio fra gay e cambiate la storia », afferma ora il premier. Da mesi i sondaggi predicono una netta maggioranza a favore dell’approvazione della legge. La percentuale è diminuita man mano che si avvicinava il giorno del voto, passando dal quasi 70 al 65 al 58 per cento nell’ultimo rilevamento, pubblicato dai giornali alla vigilia del referendum. Ma l’opinione dominante è che, seppure di misura, oggi prevarranno i “sì”. Manifesti e cartelli elettorali, lungo le strade della capitale, riflettono questa apparente tendenza: sono più numerosi quelli per la riforma costituzionale necessaria a introdurre il matrimonio fra persone dello stesso sesso (“vota sì per un’Irlanda più equa”) di quelli 40 contrari (“vota no perché l’amore di una madre è insostituibile” — altro segno di confusione riguardo all’universo gay, ironizzano le militanti lesbiche, considerato che di madri, un loro figlio, ne avrebbe addirittura due). Si sono espressi per il “sì” alcuni degli irlandesi più famosi, come l’ex-calciatore e ora co-allenatore della locale nazionale di calcio Roy Keane, l’attore emigrato a Hollywood Colin Farrell, lo scrittore Colm Toibin, lui stesso omosessuale (ne ha approfittato per ricordare le discriminazioni sofferte dal più famoso romanziere omosessuale irlandese di tutti i tempi, Oscar Wilde). Sono per il sì i giornali di Dublino, come l’ Irish Examiner, che motiva così in un editoriale la sua posizione: «Le società si evolvono lasciandosi alle spalle credenze e abitudini un tempo ritenute eterne e abbracciando alternative più adatte al mondo com’è oggi». E sono per il sì i leader delle aziende della rivoluzione digitale, Apple, Facebook, Google, che hanno portato a Dublino (per ragioni fiscali) il loro quartier generale europeo. Perfino la chiesa cattolica non ha reagito con un “no” uniforme e compatto. «Voterò sì in nome dell’eguaglianza, per riconoscere che l’amore può esistere anche fra due persone dello stesso sesso», afferma padre Peter McVerry, giovane prete. Gli fa eco suora Stanislaus Kennedy, 75enne fondatrice di un’associazione di carità: «Sposarsi è un diritto umano, dunque deve essere un diritto di tutti ». Il vescovo di Dublino, monsignor Diarmuid Martin, dichiara che lui voterà “no” ma non si sente di dire alla gente come deve votare. Soltanto l’arcivescovo Eamon Martin, primate della chiesa cattolica d’Irlanda, tuona contro le unioni dello stesso sesso, «nemmeno lontanamente previste dai piani di Dio per il matrimonio e la famiglia». La diocesi irlandese ha inviato alle parrocchie direttive sul referendum, invitando a votare “no”. Ma le parrocchie non sono più le stesse. Hanno perso fedeli. Trent’anni fa il 90 per cento degli irlandesi andava a messa tutte le domeniche, oggi ci va solo il 30 per cento. Gli scandali su pedofilia e abusi sessuali che hanno coinvolto sacerdoti e monache sono una causa dell’allontanamento di molti irlandesi dalla fede. Un’altra è il boom economico degli ultimi due decenni, che ha trasformato un paese di contadini ed emigranti nella “Tigre Celtica” e laicizzato fortemente la società. «Quando ero bambino, mio padre ci faceva leggere il rosario tutte le sere», ricorda Emon, l’autista insieme al quale seguo il porta a porta della campagna. «Io stesso quando avevo vent’anni andavo a messa tutti i giorni, alzandomi presto, prima del lavoro. Adesso però sono incerto su come votare, perché da un lato aderisco ai precetti della chiesa, dall’altro non voglio discriminare nessuno. E i miei figli, pur sentendosi cattolici, voteranno “sì” alla riforma». Taglia corto Brian Sheehan, fondatore di Yes Quality, la campagna per il “sì” al referendum: «La maggioranza della popolazione irlandese è favorevole alla nuova legge e la maggioranza della popolazione irlandese è cattolica. Significa che la chiesa non è più al passo con i propri fedeli». Permane, ciononostante, un alone di incertezza. Nei villaggi, il cattolicesimo è più forte e restio alle innovazioni. Nelle città, la campagna Fathers and Mothers Matter (I padri e le madri contano) ottiene consensi sostenendo che la sua non è un’opposizione omofobica: «I gay hanno già il patto di unione civile, che bisogno c’è di dargli anche il matrimonio?». E per due volte, nel 2001 e nel 2008, l’Irlanda votò “no” in referendum sull’Unione Europea in cui tutti prevedevano la vittoria dei “sì”. Si tratta insomma di convincere la parte più anziana e conservatrice della popolazione, come Rebecca e Mary provano a fare, bussando di porta in porta. «Buongiorno, signora, mi dà il permesso di sposare la mia girlfriend? ». 41 BENI COMUNI/AMBIENTE del 22/05/15, pag. 12 Disastro California Petrolio. Dopo quella del 1969, seconda «marea nera» per Santa Barbara. A causa di un guasto a un oleodotto 80.000 litri di petrolio sarebbero finiti nell'Oceano Pacifico. Ma il rischio è che la quantità totale di oro nero sulle coste possa essere di 400.000 litri. Il governatore ha proclamato lo «Stato di emergenza» Marina Catucci NEW YORK Un vero disastro ambientale. È quanto avvenuto sulle coste di Santa Barbara, in California,una delle zone più belle d’America: circa 80 mila litri di petrolio si sono riversati nell’Oceano Pacifico a causa della rottura delle condutture di un oleodotto. La società che gestisce l’oleodotto, la Plains All American Pipeline, ha dichiarato di temere un disastro per una cifra di petrolio ancora più alta; e nonostante il flusso di greggio sia stato interrotto subito dopo la rottura, sarebbero finiti in mare quasi 400.000 litri di petrolio. La Plains in un comunicato, aveva fatto sapere di essere impegnata a fare ogni sforzo possibile e necessario per limitare l’impatto ambientale del disastro. Gli stessi termini erano stati usati da Greg Armstrong, presidente ed amministratore delegato della compagnia. L’ad era arrivato in California direttamente dal Texas per tenere un’imbarazzata e dolorosa conferenza stampa. La macchia nel mare Il primo a dare la notizia del disastro è stato il Los Angeles Times online che ha riportato di una macchia di petrolio larga 50 metri e lunga quasi 6 chilometri; proporzioni sufficienti per colpire le spiagge di Goleta Beach e Refugio State Beach. Le cause che hanno portato alla rottura delle condutture non sono ancora state accertate e si spera possano esserlo a breve. Jerry Brown, governatore della Calfornia, ha dichiarato lo stato di emergenza per la contea di Santa Barbara e Richard Abrams, responsabile delle emergenze, ha mobilitato la guardia costiera e il dipartimento per la salvaguardia di pesca e fauna della zona, per monitorare le operazioni di pulizia. Una forza ulteriore di circa 300 persone starebbe aumentando il regolare numero di lavoratori solitamente impiegato nella zona, compresi i membri della California Conservation Corps. È la seconda volta che avviene un disastro di queste proporzioni in california e anche in precedenza la zona colpita era stata la costa di Santa Barbara. Nel 1969 la macchia di petrolio che si era riversata in quella parte dell’oceano era di oltre 300.000 litri ed era stato il più grosso disastro ambientale della storia americana fino a quel momento. Da allora altri disastri, che hanno finito per indurire la percezione dei rischi ambientale degli americani. Dal ’69 ad oggi la coscienza ambientalista si è rafforzata e più di tutto ha preso forma declinandosi in una prassi propositiva che è passata dal dire no all’uso del petrolio e di altre fonti di energia sporche e potenzialmente (e a quanto pare anche praticamente) pericolose, all’invocare l’utilizzo di energia alternativa e pulita. In questo momento in California e non solo lì ci si domanda quanto ancora si dovrà aspettare per un cambio di investimenti energetici, per i quali ci sono tutte le condizioni potenzialmente favorevoli. Cambio di investimenti 42 Da tempo l’assolata California ha un problema di siccità non più trascurabile che porterebbe direttamente, come effetto collaterale positivo, verso la scelta di uno sviluppo energetico solare, non solo come fenomeno di eccellenza ma come prassi sistematica. Nella percezione collettiva il petrolio è ormai considerato un agente nemico: quello cercato all’estero porta a guerre decennali e quello estratto in America a disastri per la popolazione e l’ambiente. L’oleodotto della Plains All American Pipeline era stato costruito con il proposito di trasportare 150.000 barili al giorno, nel 1991: un’altra epoca. Oggi la costruzione degli oleodotti viene osteggiata dal basso, organizzazioni ambientaliste e cittadini si mobilitano per fare in modo che questi disastri, bene o male annunciati, non si ripetano. Ma non è il solo aspetto rilevante, perché questa enorme macchia di petrolio si è riversata sulla costa della California, durante l’amministrazione Obama, che pure si è dimostrata attenta alle questioni climatiche ed ambientali. Poche ore prima dell’incidente Barack Obama era in Connecticut, alla Us Coast Guard Academy, e si stava rivolgendo ai laureandi invitandoli ad agire sull’ambiente come priorità assoluta. Le preoccupazioni di Obama «Il cambiamento climatico rappresenta una seria minaccia alla sicurezza globale, un’immediata minaccia alla nostra sicurezza nazionale» aveva affermato Obama paragonando il rischio ambientale a quello «terroristico», per il grado di pericolosità potenziale ed effettivo. «Dobbiamo agire e dobbiamo farlo ora. Negare o rifiutare di affrontare il tema mette in pericolo la nostra sicurezza nazionale e la prontezza delle nostre forze armate». Obama pronunciava queste parole poche ore prima di conoscere il disastro, ma non è di certo la prima volta che il presidente degli Stati Uniti rimarca il concetto di emergenza riguardo ai problemi ambientali e non sembra che parte della sua amministrazione voglia lasciarlo solo in questa battaglia. Dopo l’uragano Sandy, Andrew Cuomo, governatore dello Stato di New York aveva dichiarato che dire «mai più» sarebbe stato fuori luogo «Non è epoca di “mai più”, — aveva detto Cuomo — ora resta solo di domandarci quando un altro uragano ci colpirà di nuovo. Il danno è fatto, il cambiamento climatico è una realtà contemporanea, ora abbiamo solo il dovere di far fronte e cercare di rimediare ai danni giá compiuti». Sembrerebbe la situazione ideale, visto che nello stesso momento coesistono una volontà sociale ed una politica ad agire nella stessa direzione, ma bisognerà fare i conti con un terzo pesantissimo convitato: quello delle multinazionali del petrolio che non sembrano pronte ad abbracciare un nuovo business di energia alternativa. Proprio in questi giorni si parla della costruzione di una nuova piattaforma sulle coste dell’Alaska e la sua approvazione o meno riguarderà questa amministrazione. Braccio di ferro Si tratta di un braccio di ferro annunciato in un periodo pre elettorale che fin da ora vede schierati repubblicani e democratici su posizioni opposte riguardo ambiente e sfruttamento delle risorse. Uno dei candidati alla presidenza, il texano Jeb Bush, proviene da una famiglia che è nell’industria del petrolio fin dagli anni ’50 e che nel giorno del disastro californiano ha dichiarato: «Il fatto che il clima della Terra stia cambiando è vero ma la ricerca scientifica non mostra chiaramente che questa variazione sia dovuta alle scelte dell’uomo e quanto invece sia per cause naturali. Affermare che sia per cause umane è semplice arroganza». 43 INFORMAZIONE del 22/05/15, pag. 16 L’accelerazione per riformare la Rai entro luglio Il gruppo del Pd del Senato vuole accelerare con la riforma della Rai voluta da Matteo Renzi, ora all’esame della commissione Comunicazioni che sta procedendo a una serie di audizioni. L’intenzione del Pd di Palazzo Madama sarebbe riuscire a portare in aula intorno al 10 giugno il disegno di legge varato dal Consiglio dei ministri il 27 marzo. Se davvero questo fosse l’itinerario, allora potrebbe diventare verosimile l’approvazione del disegno di legge (ora in discussione alla commissione Comunicazioni) entro la fine di luglio, dopo la votazione alla Camera. Così la nomina dei nuovi vertici (gli attuali scadono il 25 maggio, e restano automaticamente in proroga) avverrebbe con la legge voluta da Matteo Renzi. Si tratta di ipotesi, di voci. Ma l’accelerazione c’è. Le difficoltà non mancheranno. Un’anima del Pd (per esempio il senatore Federico Fornaro) non vuole che l’amministratore delegato venga indicato dall’azionista, cioè dal ministero dell’Economia, ovvero dal governo. E per molti non è chiaro se il suddetto amministratore delegato possa nominare direttori di tg e reti e altri dirigenti senza vincoli. L’espressione «sentito il consiglio di amministrazione» appare ambigua. Un voto vincolante o solo consultivo? 44 SCUOLA, INFANZIA E GIOVANI del 22/05/15, pag. 4 A giugno un’ora di sciopero degli scrutini Contro il Ddl Renzi-Giannini-Pd. Fiaccolate venerdì 5 in tutto il paese. Camusso: «Nel Ddl scuola ci sono molte cose importanti che vanno cambiate». Renzi «apre» ai docenti precari di seconda fascia Roberto Ciccarelli ROMA Lo sciopero degli scrutini si estende ai sindacati più rappresentativi della scuola con modalità diverse da quello proclamato da Cobas, Unicobas e Usb. Ieri Flc-Cgil, Cisl e Uil Scuola, Snals e Gilda hanno confermato l’astensione dalla prima ora di servizio per tutti gli scrutini in ciascuna delle prime due giornate delle operazioni («Il Manifesto», 16 e 21 maggio). La protesta unitaria non sarà dunque di un’intera giornata, ogni docente di asterrà per un’ora a turno facendo slittare gli scrutini di cinque giorni. «Avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali, salvaguardando le legittime aspettative di studenti e famiglie» precisano i sindacati in una nota. È la risposta alle esternazioni del loquace Roberto Alesse, presidente dell’Autorità di garanzia per gli scioperi, i cui reiterati pre-avvisi di precettazione degli insegnanti non hanno fatto arretrare i sindacati, né li hanno divisi come auspicavano il Partito Democratico e la ministra dell’Istruzione Giannini. Lo sciopero si farà e, come previsto dalla legge, non riguarderà le «classi terminali», quelle cioè che affrontano l’esame di terza media o di maturità, ma tutte le altre, di ogni ordine e grado. Venerdì 5 giugno, dalle 21, saranno organizzate fiaccolate di protesta contro la riforma della scuola ormai giunta in seconda lettura al Senato. Titolo dell’iniziativa: «La cultura in piazza». «Abbiamo molte idee su come migliorare la riforma e non si tratta di aspetti marginali» ha confermato la segretaria Cgil Susanna Camusso. Alla manifestazione nazionale contro il governo Renzi le maggiori sigle sindacali sembrano avere preferito le fiaccolate. Il profilo basso si spiega con la volontà di tenere aperta la trattativa e «apportare al testo «profondi cambiamenti»: estensione del piano di assunzione ai docenti con contratto a tempo determinato e al personale amministrativo; abolizione della «chiamata diretta» dei docenti da parte del «preside manager»; rifiuto della valutazione dei docenti con concetti arbitrari e rinnovo del contratto nazionale. Praticamente un altro mondo rispetto a quello sognato da Renzi che ha festeggiato il passaggio alla Camera del Ddl come la fine dei «presidi passacarte». A parole, l’apertura di modifiche al Ddl al Senato viene ventilata da giorni. Una delle minoranze Pd alimenta le voci con l’infelice battuta di Bersani che si è detto «felicissimo di votare la riforma» in caso di cambiamenti sui presidi e le assunzioni. Parole che produrranno contraccolpi e malumori tra i docenti che chiedono il ritiro del Ddl e attaccano il Pd.Dal governo non arrivano segnali di vero cambiamento, quelli attesi dai sindacati almeno. Giannini crede di «avere bilanciato le funzioni del preside». Così è difficile instaurare un dialogo. Per sviare il movimento, Renzi ha aperto all’ipotesi dell’assunzione per gli insegnanti di seconda fascia delle graduatorie di istituto, abilitati ma esclusi dalle 100.701 assunzioni previste nel Ddl. «Ci stiamo ragionando — ha detto– mi dà noia che qualcuno ha fatto il Tirocinio formativo attivo e lo ha pure pagato». Per la cronaca, sono migliaia i detentori di un Tfa pagato all’incirca 3 mila euro per alimentare il business delle abilitazioni che non valgono, ad oggi, un’assunzione. E che forse domani 45 potrebbe valere una chiamata diretta dal preside, con un anno di prova e massima disponibilità ai suoi voleri. Senza contare che al concorso del 2016 per 60 mila docenti lo Stato chiederà un altro contributo. Tra tattica e annunci, i sindacati e la ministra Giannini si incontreranno nuovamente lunedì 25 maggio per la quarta volta. Gli altri incontri non hanno avuto esito. del 22/05/15, pag. 5 Pisa, rappresaglia contro chi boicotta l’Invalsi La scuola quiz. La protesta di 25 studenti contro la scuola quiz ridotta a "vandalismo". Forte reazione degli universitari e della sinistra «Una città in comune» e «SI-Toscana», interrogazione parlamentare di Nicola Fratoianni (Sel). Flc-Cgil: «La protesta c’è sempre stata. La Buona Scuola di Renzi si propone di "metterli a posto"?» Riccardo Chiari PISA Alla vigilia degli scrutini avevano ricevuto l’avviso di sospensione. In venticinque. Capo d’accusa: disobbedienti ai test Invalsi. Per bloccare il provvedimento c’è stato bisogno, nell’ordine, delle proteste dei rappresentanti degli studenti e degli universitari, e poi dell’opposizione di sinistra a Pisa (i consiglieri comunali Ciccio Auletta e Marco Ricci) e di quella toscana, grazie ai candidati alle regionali Andrea Corti e Tiziana Nadalutti di SìToscana a Sinistra. Alla fine, anche di fronte all’interrogazione parlamentare presentata da Sel, perfino il sottosegretario all’istruzione Davide Faraone aveva alzato il pollice: «Spero che preside di Pisa ci ripensi e non sospenda i ragazzi che hanno boicottato i test Invalsi. Meglio il dialogo». Concetto declinato a modo suo dal dirigente scolastico dell’istituto per geometri Santoni, che ha comminato comunque ai reprobi un’ammonizione scritta, e due ore di lezione supplementare sui diritti e doveri degli studenti. Tra i doveri, evidentemente, c’è anche quello di non contestare i quiz che dovrebbero accertare la preparazione studentesca. Come se la scuola fosse un programma di Mike Bongiorno. A denunciare il caso sono stati i coetanei della Rete degli studenti medi: «Ci siamo trovati a far fronte a un grave episodio nell’istituto Santoni. Nei giorni precedenti la mattina di martedì 12, i rappresentanti degli studenti avevano proposto ai ragazzi di consegnare il foglio in bianco in segno di protesta. E questi, oltre ad averlo fatto, hanno deciso legittimamente di cancellare anche il loro codice identificativo, in modo da rendere anonima la prova». L’avessero mai fatto: a parere del preside Marco Salardi, il gesto è valso ai ragazzi l’accusa di danno a proprietà pubblica. Con annesso l’avviso di sospensione generale. A quel punto le prese di posizione critiche si sono moltiplicate. Abbattendo progressivamente il muro di gomma della comunicazione nel tempo della «buona scuola» renziana. «L’obbedienza non è più una virtù – hanno messo nero su bianco i consiglieri comunali Auletta e Ricci di «Una città in comune-Prc» con Corti e Nadalutti di «Sì– Toscana a sinistra» — lo insegnava don Milani ai suoi studenti per costruire una scuola capace di far crescere dentro quell’idea di scuola pubblica che la nostra Costituzione sancisce all’articolo 34. Per questo riteniamo ingiustificabile la decisione di sospendere gli studenti che hanno deciso con un atto di disobbedienza civile, critico e consapevole, di 46 boicottate i test Invalsi. Ed è pretestuoso, quasi comico, che gli studenti siano stati accusati di danno a proprietà pubblica per aver cancellato il codice identificativo del test”. Anche i sindacati si sono fatti sentire. Dai Cobas («i quiz non consentono neppure lo sviluppo di un ragionamento. E neppure sono in grado di valutare la qualità dei docenti: al massimo possono valutarne la preparazione, ma non la capacità di insegnare, relazionarsi con i ragazzi, trasmettere il sapere»), fino alla Flc Cgil, che si è fatta anche una domanda scomoda: «Il boicottaggio dei test Invalsi c’è stato anche in passato – ha ricordato Alessandro Rapezzi — perché solo ora le sospensioni? Forse la “buona scuola” si propone di “mettere a posto” i ragazzi?». Il resto è storia di ieri. Con l’interrogazione annunciata da Nicola Fratoianni di Sel, pisano d’adozione, che ha provocato l’ecumenica risposta del renziano Faraone, e l’autodifesa del preside Salardi: «Non c’è stata alcuna rappresaglia. Abbiamo semplicemente seguito la procedura prescritta dalla legge. E nessuno degli studenti è stato sospeso: il consiglio di classe non ha sanzionato la mancata partecipazione ai test degli studenti ma la vandalizzazione del modulo, con un’ammonizione scritta del preside e due ore di lezione sui diritti e doveri degli studenti». Pronta la replica di Fratoianni: «Il punto non cambia. La questione non sta nell’entità della “punizione” ma nel fatto che si immagini di reagire in termini disciplinari di fronte ad una protesta del tutto pacifica e pienamente legittima. E cancellare il numero di matricola non può essere spacciato per vandalizzazione». del 22/05/15, pag. 19 “Per i prof di sostegno carriere separate” ma scoppia la polemica Le associazioni dei disabili si dividono sulla proposta del Pd “Discriminante per alunni e docenti”. “No, occorrono percorsi ad hoc” ROMA . Sulle deleghe, anche lì, il governo della Buona scuola deve subire contestazione. Su una delega in particolare (ne ha in grembo otto): la legge sul sostegno. Entro diciotto mesi il sottosegretario Davide Faraone, che ne è promotore da inizio legislatura insieme alle federazioni Fish e Fand e ne ha presentata una a sua firma lo scorso settembre, dovrà varare quella definitiva come iniziativa autonoma dell’esecutivo. Provando a superare la legge quadro del 1992, la riforma del sostegno a scuola si fonda su quattro elementi: laurea speciale per gli insegnanti interessati, carriere separate tra docenti di curriculum e docenti di sostegno, continuità didattica per i secondi e i loro alunni, quindi, specializzazione per le diverse forme di disabilità. La legge già depositata, che si occupa anche di diritti degli alunni, rapporti con le famiglie e possibilità di somministrare farmaci a scuola, chiede innanzitutto di ridisegnare i corsi di laurea per gli insegnanti di sostegno e introduce il principio della formazione obbligatoria (venti milioni a bilancio) per docenti, presidi e personale amministrativo. Una forte specializzazione che, ha raccontato ieri Adriano Sofri su Repubblica , molti docenti e diverse associazioni radunate attorno al portale Disabili.com contestano. Le parole migliori — per spiegare l’opposizione — le trova la professoressa Daniela Boscolo, docente di inglese che da undici anni si è convertita all’istruzione a sostegno diventando una delle cinquanta insegnanti segnalate nel mondo dalla Varkey Gems Foundation. «Creare un percorso speciale è discriminante per l’alunno disabile e per l’insegnante. La nuova figura di docente che viene fuori dalla legge Faraone non è né 47 carne né pesce: il laureando perde due anni di discipline del curriculum, italiano, inglese, matematica, e sul piano psicopedagogico e medico avrà in cambio solo un’infarinatura teorica. Come potremmo spiegare a una famiglia che suo figlio, bisognoso di un’attenzione speciale o affetto da una forma di autismo, non può imparare l’inglese come gli altri? Dallo stesso tipo di prof?». L’insegnante Boscolo sostiene che bisogna fare esattamente il contrario: «Allargare le nozioni del sostegno a tutti i docenti nella fase di formazione e chiedere a tutti, magari con un aumento di stipendio, di sostenere il ragazzo insieme al resto della classe. Questa è didattica inclusiva». Quindi? «La prof di francese, latino e chimica andrà affiancata da un docente che ha scelto la strada del sostegno, si chiama codocenza. Oggi un insegnante di sostegno sta con un ragazzo bisognoso nove ore a settimana, troppo poco. E poi quando nella sua scuola non ci saranno ragazzi da sostenere che ne facciamo di quell’insegnante, lo mandiamo a fare le pulizie? Ho presentato una proposta al sottosegretario: la sua legge è una resa a 40 anni di errori, rischia di essere impugnata per discriminazione». La legge Faraone è criticata dalla Ledha e avversata dal Comitato nazionale insegnanti Bis-Abili. Dicono: «Rischiamo la deriva verso la medicalizzazione del sostegno scolastico». (c. z.) del 22/05/15, pag. 5 Giannini, la ministra dei «concetti» proibiti su Expo Grandi eventi. Secondo il Miur all'Expo non si entra con una spilletta di partito o una Bibbia Fabrizio Tonello Gli hacker italiani sono tremendi: sembra che nei giorni scorsi abbiano preso il controllo non solo del sito dell’Expo ma perfino di quello del Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca. Su entrambi i siti, infatti, compare un testo uguale, destinato alle scuole, dove si legge che all’interno del sito espositivo milanese «non è consentito introdurre qualsiasi tipo di materiale stampato o scritto, contenente propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti diversi da quelli esplicitamente autorizzati dalle Autorità di Pubblica Sicurezza». Dice proprio così: «asserzioni o concetti diversi da quelli esplicitamente autorizzati dalle Autorità di Pubblica Sicurezza», il che implicherebbe che misteriose Autorità di Pubblica Sicurezza possiedano una lista di «asserzioni e concetti autorizzati» e passino il loro tempo a confrontarla con tutte le innumerevoli asserzioni che proliferano su Facebook o Twitter, per verificarne la congruenza. Basterebbe Salvini a riempire le loro giornate lavorative, figuriamoci se poi si volesse controllare ciò che viene detto o scritto nelle scuole italiane che, com’è noto, contengono circa un milione di insegnanti e parecchi milioni di studenti. Questa improbabile parodia di uno stato totalitario, dove occorre imbavagliare ogni studente che manifesti un «morboso interesse per le questioni politiche e sociali» (come recitava la motivazione dell’espulsione di Giancarlo Pajetta da tutte le scuole del Regno, anno 1927) sembra però che esista davvero e che non sia opera di hacker perché è stata fatta propria niente meno che da Maria Elena Boschi. Il Ministro per le riforme istituzionali, palesemente non rendendosi conto di ciò che diceva, ha sostenuto alla Camera che 48 «Expo Spa è una società privata» e quindi «ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile, chiunque voglia accedere ad Expo deve sottostare al regolamento», compreso il divieto dei concetti non preventivamente autorizzati. Peccato che Expo non sia una società privata poiché i soci sono tutti pubblici, come ha riconosciuto esplicitamente il Consiglio di Stato in una sentenza del 4 febbraio scorso. E peccato che in Italia esista ancora un libercolo (che il ducetto maleducato e Maria Elena vorrebbero abrogare ma che per il momento resta ancora in vigore) dove all’art. 21 si specifica: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». Si chiama Costituzione della Repubblica Italiana. Il che significa che se i deliri dell’Expo e del Miur, palesemente ispirati ai testi di golpisti cileni o argentini sono reali, ci sarebbero parecchie persone che dovrebbero prendersi una lunga vacanza alle Antille: da Giuseppe Sala (commissario del governo e amministratore delegato di Expo) a Stefania Giannini (ministro dell’Istruzione) fino alla già citata Boschi che ignora non solo la natura giuridica dell’Expo ma perfino l’abc del libretto su cui ha giurato entrando in carica il 22 febbraio 2014. 49 ECONOMIA E LAVORO del 22/05/15, pag. 33 Ocse: “Cresce la disuguaglianza in Italia l’1% ha il 14 per cento della ricchezza” ROSARIA AMATO Il 20% più ricco della popolazione possiede il 62% del patrimonio Il tasso di povertà tra gli under 25 è salito con la crisi al 14,7 per cento ROMA . Il “top 10%” tra il 2007 e il 2011 ha subito una decurtazione annua dell’1% delle entrate, mentre il 10% più povero ha perso in media il 4%. Risultato, in Italia la disuguaglianza è arrivata a livelli mai visti primi, e adesso l’1% più ricco della popolazione si gode il 14,3% della ricchezza nazionale, una percentuale tre volte superiore a quella della ricchezza detenuta al 40% più povero, che si ferma al 4,9%. Se ci si sposta dai due estremi non va comunque molto meglio: il 21% degli italiani detiene infatti il 60% della ricchezza. L’allarme viene dall’Ocse, e non è limitato all’Italia: il 10% più ricco della media dei 34 Paesi dell’area ha un reddito di 9,6 volte superiore a quello del 10% più povero. La forbice era di 7,1 volte negli anni Ottanta, ma aveva già raggiunto le 9,1 volte nei primi anni Duemila. «La disuguaglianza nei Paesi Ocse ha raggiunto il livello più alto da quando abbiamo dato inizio alle rilevazioni. — dice il segretario dell’organizzazione, Angel Gurrìa — L’esperienza ci mostra che una disuguaglianza eccessiva incide negativamente sulla crescita. E dunque le ragioni per un intervento sono economiche, non solo sociali. Se i governi non affronteranno il problema, colpiranno la coesione sociale nei loro Paesi e danneggeranno le prospettive di crescita a lungo termine». Una prospettiva che è il cuore del rapporto Ocse, che s’intitola infatti “In it Together. Why Less Inequality Benefits All”, (tutti insieme, perché una riduzione della diseguaglianza beneficia tutti). Un tempo, ricordano gli analisti dell’organizzazione, molti economisti amavano sottolineare i pregi della disuguaglianza, che sprona i lavoratori della parte bassa della piramide a fare meglio e di più per godere degli stessi vantaggi dei ricchi. Mentre adesso ci si è resi conto che «più disuguaglianza significa che alcuni — i ricchi — sono in grado di godere di maggiori opportunità economiche dei poveri». E poiché i poveri non hanno la possibilità di offrire ai propri figli i vantaggi di una buona istruzione, gli svantaggi si perpetuano, e si allargano. Alla base della polarizzazione attuale c’è innanzitutto una sempre maggiore sproporzione dei salari tra posizioni di vertice e lavori precari: tra il 1995 e il 2013 il 50% dei posti di lavoro creati nell’area Ocse sono part-time, con contratti temporanei o autonomi. Moltissime di queste posizioni insicure e spesso malpagate sono andate ai giovani. In Italia questo fenomeno è amplificato: il 40% della popolazione nel 2013 era impiegata in lavoro non standard, contro il 33% dell’area Ocse, anche perché il lavoro precario è cresciuto del 24% tra il 1995 e il 2007, la percentuale più alta tra i Paesi Ocse, che presentano una media del 7,3%. E non c’è dubbio, sottolinea il direttore della sezione Lavoro dell’Ocse, Stefano Scarpetta, che «in Italia i contratti temporanei sono più precari che in molti altri Paesi», e garantiscono una remunerazione «molto inferiore» rispetto al tempo indeterminato. Se si fissa a 100 il guadagno medio del lavoratore con posto fisso, quello del lavoratore atipico si ferma a 57. La precarietà ha danneggiato soprattutto i giovani: infatti la percentuale di poveri tra i 18 e i 25 anni in Italia è del 14,7%, superiore alla media Ocse del 13,8%. Al contrario, si sono rafforzate le posizioni degli anziani: solo il 9,3% degli ultrasessantacinquenni è povero contro il 12,6% della media Ocse. Si tratta di 50 una tendenza in peggioramento, infatti la povertà tra i bambini in Italia raggiunge il tasso del 17% contro una media Ocse del 13%. L’organizzazione di Parigi dà una serie di suggerimenti al nostro Paese: promuovere maggiormente la partecipazione delle donne al mercato del lavoro (il gender gap in Italia è tra i più alti), migliorare la qualità del lavoro, favorire l’istruzione di alto livello non solo tra i giovani ma anche tra chi già lavora, incidere sulla tassazione e sull’evasione fiscale per una più equa distribuzione dei redditi. Suggerimenti che si ripetono un po’ ovunque, fatta eccezione per i “soliti” Paesi nordici Danimarca e Norvegia, che continuano a presentare un basso tasso di disuguaglianza, insieme però a Slovenia e Slovacchia. del 22/05/15, pag. 2 Ocse, mai così tante diseguaglianze di Anna Maria Merlo Siamo arrivati a "un punto critico, le ineguaglianze non sono mai state così forti nei paesi Ocse", afferma Angel Gurria, segretario generale dell’organizzazione che riunisce i 34 paesi più industrializzati. "Stiamo cambiando di dimensione", spiega un economista. Nel terzo rapporto Ocse sulle ineguaglianze, presentato ieri al Château de la Muette, la situazione appare peggiorata rispetto ai precedenti studi (2008 e 2011): dall’inizio della crisi, il 40% della popolazione più povera ha registrato un calo di reddito; tra il 2007 e il 2011 il reddito reale (corretto dagli effetti inflazionistici) della fascia più debole è diminuito di circa il 40%, mentre il 10% più ricco, dal 1995 ha accumulato un aumento del 51%. All’origine dell’aumento delle ineguaglianze c’è l’esplosione del part time imposto, dei contratti a termine, del precariato, dei tagli al salario per spingere le persone al lavoro autonomo, accollandosi tutti i rischi, forme di occupazione che hanno rappresentato più della metà dei nuovi posti creati nei paesi Ocse dal 1995 al 2013. In più, sottolinea l’Ocse, nei principali paesi industrializzati più della metà del lavoro precario riguarda i giovani sotto i trent’anni. Le donne restano indietro, con salari in media del 15% più bassi degli uomini e il 16% in meno di possibilità di occupare un impiego. Oggi, nei 34 paesi più ricchi del mondo il 10% della popolazione più agiata ha un reddito 9,6 volte superiore a quello del 10% più povero. Nel 1980 questo scarto era di 7,1 volte superiore, nel 2000 era già salito a 9,1, cioè siamo di fronte a una progressione costante delle diseguaglianze. Questi scarti aumentano in modo esponenziale se si calcolano i patrimoni delle famiglie. La crisi ha aggravato la situazione e accelerato questo fenomeno. L’Ocse sottolinea le conseguenze negative della crescente ineguaglianza: nei 19 paesi esaminati, avrebbe amputato la crescita di 4,7 punti tra il 1990 e il 2010. E per il futuro il perpetuarsi di questa tendenza è destinato a distruggere il capitale umano e a decurtare le possibilità di crescita dell’economia. C’è stato l’aumento del precariato che è andato di pari passo con la diminuzione dell’efficacia dei meccanismi di redistribuzione, le tasse sono diminuite per i ricchi e ad esse sfuggono largamente le multinazionali grazie al ben oliato meccanismo dell’"ottimizzazione fiscale", oggi sotto accusa anche nella Ue. I tagli alle imposte per i più ricchi, in un mondo dove ormai si è diffusa l’intolleranza fiscale (prima dell’era Reagan, negli Usa il decile più alto era tassato a più dell’80%, percentuale che oggi sarebbe considerata insopportabile), hanno contribuito all’esplosione delle ineguaglianze. Nel mondo industrializzato ci sono paesi più ineguali di altri. Cile, Turchia, Messico, ma anche Usa e Israele sono tra i più ineguali, mentre Danimarca, Norvegia, Slovenia e Slovacchia sono quelli dove le differenze sono minori, come mette in evidenza la tabella 51 del rapporto Ocse che presenta il coefficiente Gini. La Francia è in una posizione critica, ormai al 21esimo posto per ineguaglianza su 34 paesi: la situazione si sta aggravando con la crisi, il 10% delle persone più ricche ha registrato una crescita del reddito del 2% l’anno (cioè più della media Ocse), mentre il 10% più povero ha subito un calo dell’1% (un po’ meno della media), grazie agli ammortizzatori sociali, non ancora del tutto distrutti. Ma, dal punto di vista della concentrazione patrimoniale, il 10% più ricco controlla più della metà del patrimonio delle famiglie. La presidenza del socialista Hollande non sembra aver avuto alcuna influenza su questo trend di diseguaglianza. Quest’ultimo rapporto Ocse suggerisce agli stati membri di intervenire, per reintrodurre più efficaci politiche redistributive. Siamo di fronte a un caso di schizofrenia dell’organizzazione, che in numerosi altri rapporti non fa che suggerire da anni la liberalizzazione del mercato del lavoro e il taglio ai diritti come soluzione per uscire dalla crisi e combattere la disoccupazione. È questa la ricetta che viene presentata come Tina (there is no alternative) a tutti gli stati della Ue, dall’Italia fino alla Grecia. La progressiva distruzione della classe media, che in gran parte si impoverisce, ha già conseguenze politiche, con l’irruzione della destra populista, la crescita della paura e l’illusione di una soluzione nel rifiuto dell’altro. La classe media, che si assottiglia e perde terreno, si sente vittima della mondializzazione e questo comincia ad avere effetti anche geopolitici. In Europa, cresce l’euroscetticismo e la chiusura nazionalista. Perfino negli Usa si diffonde lo scetticismo verso le proposte di Obama su accordi internazionali di liberalizzazione commerciale, come il Ttip con la Ue o il Tpp con il Giappone e l’area del Pacifico. 52
Scarica