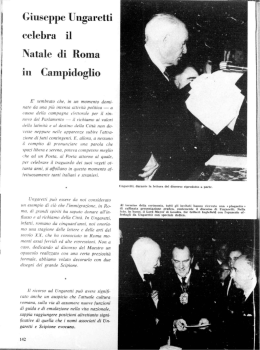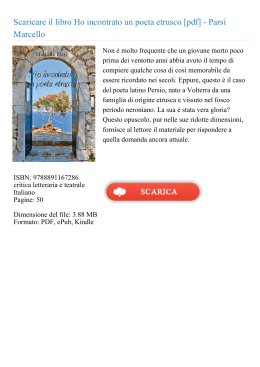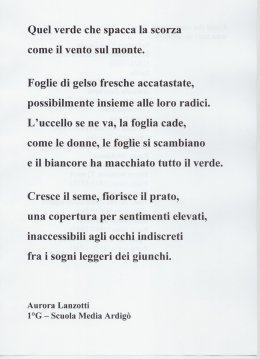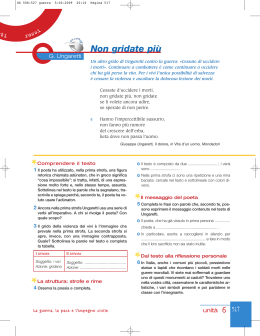ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA (RE) Classi terze A-C-E Villa Rossi 2012 “Tra barche, acqua, terre e … patrie lontane” Letture: - F. Fontana: “Il canto degli emigranti” - Ispettorato Immigrazione USA: “Relazione, ottobre 1912” Brani musicali: - Vangelis, da 1492, Conquest of Paradise: “Light and Shadow” - Anonimo: “Mamma mia dammi cento lire” - G. Ungaretti: “In memoria” - K. Jenkins: “Hymn” - G. Ungaretti: “I fiumi” - G. F. Händel, dal Rinaldo: “Lascia ch’io pianga” - S. Quasimodo: “Lamento per il Sud” - J. Horner - W. Jennings: “My heart will go on” - D. Abdelkader: “La ballata di riva” - E. Cannio - A. Califano:“‘O surdato ‘nnamurato” “Tra barche, acqua, terre e … patrie lontane” “Tra barche, acqua, terre e … patrie lontane” è il titolo del nostro progetto didattico; proposta che tratta tematiche riguardanti vicende migratorie legate al nostro paese: eventi che si fondono, con diverse connotazioni, nel passato e nel presente, unitamente a genti e popoli diversi, tra fame e guerre mai estinte. Mediante alcuni brani letterari e musicali, tenderemo a far emergere alcune peculiarità della nostra identità culturale: consuetudini, costumi, aspetti emozionali e comportamentali che, a torto o a ragione, in positivo o in negativo, fanno ormai parte, nell’immaginario, di luoghi comuni o di stereotipi riconducibili a noi italiani. È però, questa, anche l’identità collettiva di un paese rievocata e consolidata da memorie individuali o da percorsi esistenziali di massa lontani, talvolta tragici, talvolta coronati da successo. Una consapevolezza che ha costituito e che rappresenta il terreno su cui cresce e si modella il presente, affinché si possano comprendere e riscoprire valori universali come la conoscenza, l’accoglienza, l’accettazione, il confronto, l’adattamento, l’integrazione: requisiti che implicano e richiedono azioni reciproche, concrete e feconde, tra autoctoni e “nuovi arrivati”. Quando Albert Einstein sbarcò negli Stati Uniti, come tutti gli emigrati, ricevette un modulo da compilare. Tra le molte domande alle quali bisognava rispondere ce ne era una che chiedeva: “A quale razza appartieni?” E lui rispose: “A quella umana!” Ferdinando Fontana, 1881 “Il canto degli emigranti” “Noi siamo pecore, figli di pecore”. Di generazione in generazione i lupi si scaldano con la nostra lana e si cibano con la nostra carne. Un giorno vennero a dirci che in un paese molto vasto, ma molto lontano, noi avremmo potuto campare meno peggio. Oh pecore, pecore – ci gridarono - badate che c’è il mare da attraversare. E noi lo attraverseremo E se fate naufragio e vi annegate? Meglio morire d’un colpo che agonizzare tutta la vita. Oh povere pecore, ma voi non sapete che in quel paese molto vasto e molto lontano ci sono delle malattie tremende. Nessuna malattia potrebbe essere più tremenda di quella che noi soffriamo di padre in figlio: la fame”. Teodorico Rosati, ispettore sanitario sulla nave degli emigranti “Accovacciati sulla coperta, presso le scale, con i piatti tra le gambe, e il pezzo di pane tra i piedi, i nostri emigranti mangiavano il loro pasto come i poveretti alle porte dei conventi. E’ un avvilimento dal lato morale e un pericolo da quello igienico, perché ognuno può immaginarsi che cosa sia una coperta di piroscafo sballottato dal mare sul quale si rovesciano tutte le immondizie volontarie ed involontarie di quella popolazione viaggiante. L’insudiciamento dei dormitori è tale che bisogna ogni mattina fare uscire sul ponte scoperto gli emigrati per nettare i pavimenti. Secondo il regolamento i dormitori sono spazzati con segatura, occorrendo, si mescolano disinfettanti, sono lavati diligentemente ed asciugati. Ma tutte le deiezioni e le immondizie che si accumulano sui pavimenti corrompono l’aria con forti emanazioni e la pulizia è difficile.” Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l’acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano quattro, sei, dieci. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l’elemosina, ma, sovente, davanti alle chiese, donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro. Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano non solo perché poco attraenti e selvatici, ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma, soprattutto, non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o, addirittura, attività criminali. Si privilegino i veneti e i lombardi, tardi di comprendonio e ignoranti, ma disposti più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli americani rifiutano, purché le famiglie rimangano unite, e non contestano il salario. Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa prima relazione, provengono dal Sud dell’Italia. Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare i più. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione. Ottobre 1912: relazione dell’Ispettorato per l’Immigrazione al Congresso Americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti. Giuseppe Ungaretti In memoria I versi che compongono In memoria sono incentrati su un fatto riguardante la sfera personale dell’autore: la poesia rievoca la sfortunata vita dell’amico Moammed Sceab, suicida nel 1913, con cui il poeta aveva condiviso l’indirizzo di Parigi, all’albergo di rue des Carmes. Moammed Sceab si toglie la vita perché si sente senza radici. Esule in Francia e nel proprio paese, subisce una crisi di identità. Rimane come sospeso tra la tradizione che ha lasciato alle spalle e il nuovo orizzonte culturale, non sufficientemente interiorizzato. La condizione di Moammed rispecchia molto da vicino quella del poeta che, pur di origine italiana, era nato in Egitto, da dove era successivamente emigrato in Francia. Anche il poeta si era sentito “senza patria” in rue des Carmes. Giuseppe Ungaretti In memoria Locvizza, 30 settembre 1916 Si chiamava Moammed Sceab Discendente di emiri di nomadi suicida perché non aveva più Patria Amò la Francia e mutò nome Fu Marcel ma non era Francese e non sapeva più vivere nella tenda dei suoi dove si ascolta la cantilena del Corano gustando un caffè E non sapeva sciogliere il canto del suo abbandono L’ho accompagnato insieme alla padrona dell’albergo dove abitavamo a Parigi dal numero 5 della rue des Carmes appassito vicolo in discesa Riposa nel camposanto d’Ivry sobborgo che pare sempre in una giornata di una decomposta fiera E forse io solo so ancora che visse. Giuseppe Ungaretti I fiumi Lasciandosi cullare dalle onde dell’Isonzo, il fiume nei cui pressi si sono combattute tante battaglie della prima guerra mondiale, Ungaretti ritorna indietro nel tempo, ricordando altri corsi d’acqua che hanno caratterizzato la sua vita. Con grande nostalgia, riaffiora il passato del poeta, visto il dramma della guerra che ne caratterizza il presente. Lo scrittore rammenta il Serchio, che simboleggia Lucca, città d’origine dei genitori, il Nilo, che rimanda alla sua città natale Alessandria d’Egitto, la Senna, fiume parigino sulle rive del quale trascorse parte della sua giovinezza. Questo componimento rappresenta la presa di coscienza, da parte dell’autore, dell’assurdità della guerra, di come essa turbi anche l’armonia della natura e renda tutto incerto e precario. Giuseppe Ungaretti I fiumi Cotici, 16 agosto 1916 Mi tengo a quest’albero mutilato Abbandonato in questa dolina Che ha il languore Di un circo Prima o dopo lo spettacolo E guardo Il passaggio quieto Delle nuvole sulla luna Stamani mi sono disteso In un’urna d’acqua E come una reliquia Ho riposato L’Isonzo scorrendo Mi levigava Come un suo sasso Ho tirato su Le mie quattro ossa E me ne sono andato Come un acrobata Sull’acqua Mi sono accoccolato Vicino ai miei panni Sudici di guerra E come un beduino Mi sono chinato a ricevere Il sole Questo è l’Isonzo E qui meglio Mi sono riconosciuto Una docile fibra Dell’universo Il mio supplizio È quando Non mi credo In armonia Ma quelle occulte Mani Che m’intridono Mi regalano La rara Felicità Ho ripassato Le epoche Della mia vita Questi sono I miei fiumi Questo è il Serchio Al quale hanno attinto Duemil’anni forse Di gente mia campagnola E mio padre e mia madre. Questo è il Nilo Che mi ha visto Nascere e crescere E ardere d’inconsapevolezza Nelle distese pianure Questa è la Senna E in quel suo torbido Mi sono rimescolato E mi sono conosciuto Questi sono i miei fiumi Contati nell’Isonzo Questa è la mia nostalgia Che in ognuno Mi traspare Ora ch’è notte Che la mia vita mi pare Una corolla Di tenebre Salvatore Quasimodo Lamento per il Sud Il poeta, vivendo da molto nel Nord, non sente più lo “strappo” dalla sua terra natia, ed ormai, al mare, alla gente ed ai paesaggi siciliani, si è sostituita la natura del settentrione, il viso della sua donna, le nebbie. Con un forte grido il poeta rivendica, però, la sorte della sua patria ed esprime una aspra denuncia per le condizioni in cui si trova. Lo sdegno del poeta è sincero, ma discorde: da una parte i suoi ricordi dolci e pieni d’amore, dall’altra la realtà attuale cruda e colma di risentimento. Solo i ricordi lo riporteranno ancora nel Sud. Salvatore Quasimodo Lamento per il Sud La luna rossa, il vento, il tuo colore di donna del Nord, la distesa di neve … Il mio cuore è ormai su queste praterie in queste acque annuvolate dalle nebbie. Ho dimenticato il mare, la grave conchiglia soffiata dai pastori siciliani, le cantilene dei carri lungo le strade dove il carrubo trema nel fumo delle stoppie, ho dimenticato il passo degli aironi e delle gru nell’aria dei verdi altipiani per le terre e i fiumi della Lombardia. Ma l’uomo grida dovunque la sorte di una patria. Più nessuno mi porterà nel Sud. Oh, il Sud è stanco di trascinare morti in riva alle paludi di malaria, è stanco di solitudine, stanco di catene, è stanco nella sua bocca delle bestemmie di tutte le razze che hanno urlato morte con l’eco dei suoi pozzi che hanno bevuto il sangue del suo cuore. Per questo i suoi fanciulli tornano sui monti, costringono i cavalli sotto coltri di stelle, mangiano fiori d’acacia lungo le piste nuovamente rosse, ancora rosse, ancora rosse. Più nessuno mi porterà nel Sud. E questa sera carica d’inverno è ancora nostra, e qui ripeto a te il mio assurdo contrappunto di dolcezze e di furori, un lamento d’amore senza amore. Abdelkader Daghmoumi La ballata di Riva L’autore di questa poesia è originario del Marocco. Ha conseguito una laurea in Italia, dove vive e lavora. In questi versi esprime la delusione che gli immigrati spesso provano quando vedono i loro sogni spezzati, infranti, traditi e la diffidenza con cui spesso sono accolti; però, soprattutto, il poeta esprime la speranza che la diversità portata da un’altra cultura sia per l’Italia un dono, e che l’incontro tra culture diverse sia un arricchimento per tutti. Daghmoumi Abdelkader La ballata di riva Noi siamo i figli della sabbia, del sole e dei fiori, siamo i figli del mare. Siamo venuti dai campi e dalle grandi città. Noi ragazzi dai mille sogni spezzati, infranti e traditi, col cuore tenero e con gli occhi asciutti e bruni, noi dalla chioma color pece, siamo venuti a ballare nelle vostre piazze luminose, nelle vostre case. Siamo venuti a ballare per i vostri occhi stanchi e immobili come specchi. Siamo i bambini nati da gocce d’acqua di fiume in secca che fino a ieri scorreva lento. Siamo spighe di grano piene e forti siamo venuti a cantarvi le nostre canzoni d’amore. Canzoni dolci come mandorle e miele. Le canteremo ad alta voce finché toccheremo i vostri cuori per poi cantarle piano, piano assieme, nelle vostre case, nelle vostre piazze, nelle vostre città. “Tra barche, acqua, terre e … patrie lontane” Guida all’ascolto dei brani musicali Light and Shadow La colonna sonora del film “1492: la conquista del Paradiso”, realizzato nel 1992 in occasione del cinquecentesimo anniversario della scoperta dell’America, è stata composta da Vangelis, un noto compositore contemporaneo di origine greca. La musica del brano “Light and Shadow”, luce ed ombra, infonde all’ascoltatore un grande senso di maestosità e di inquietudine al tempo stesso. Sembra quasi di udire gli idiomi e le voci degli uomini e delle donne che hanno solcato, nei secoli, le acque profonde e pericolose dell’oceano. Su navi negriere trasudanti dolore, prima, e su piroscafi colmi di speranza, poi, la meta era sempre la stessa: le Americhe. Mamma mia dammi cento lire “Mamma mia dammi cento lire” è un canto della tradizione popolare del Nord Italia, databile verso il 1850 circa. Di autore ignoto, pare sia stato ispirato dalla ballata “La maledizione della madre”, in cui si narra la storia di una giovane che, per amore, abbandona la casa materna per poi concludere la sua misera esistenza in un naufragio. L’America era l’America, era il nuovo mondo, il simbolo della libertà, e non offriva soltanto lavoro: dava a tutti l’opportunità di diventare ricchi e famosi. Per l’America si partiva con i bastimenti, le vecchie navi a vapore, e dall’Unità d’Italia in poi furono diversi milioni gli italiani emigrati all’estero. Questo esodo di massa ispirò la nascita delle prime canzoni che ci narrano la nostalgia del paese natio con crudezza e dolore, attraverso il dramma dell’emigrazione visto dalla parte di chi l’ha vissuto e sofferto; “Mamma mia dammi cento lire”, che ne racconta l’epopea attraverso le diverse versioni a noi note, ne diventò il simbolo. Hymn Songs of Sanctuary è la prima raccolta musicale del compositore gallese Karl Jenkins. Realizzato nel 1995, l’album include anche il brano “Hymn”. Come in molti pezzi musicali di questo autore, la composizione non prevede un testo strutturato e comprensibile, ma un insieme di sillabe e fonemi inventati dallo stesso Jenkins, il quale attribuisce alle voci, pur traboccanti di sfumature e nuance suggestive, una funzione neutra, puramente strumentale. Malinconico e delicato, il brano si dipana come una leggera brezza speziata d’oltreoceano. Lascia ch’io pianga Georg Friedrich Händel, compositore tedesco del periodo Barocco, è considerato uno dei più grandi musicisti della storia della musica. “Lascia ch’io pianga” è una celeberrima aria tratta dal suo Rinaldo, un’opera su libretto di Giacomo Rossi, basata su alcuni episodi narrati nella Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso. Almirena, prigioniera in catene, piange la sua dura sorte, desiderando la libertà: Lascia ch’io pianga mia cruda sorte, e che sospiri la libertà. Il duol infranga queste ritorte de’ miei martiri sol per pietà. Let me weep my cruel fate, and I sigh for liberty. May sorrow break these chains of my sufferings, for pity’s sake. Nelle vicende narrate nei melodrammi spesso emergono, impetuose, le emozioni e i sentimenti peculiari del genere umano. L’amore, la sofferenza, la paura, la speranza erano passioni comuni a tutti gli emigranti, i quali tentavano di mantenere un legame profondo con la madrepatria, anche cantando le arie d’opera della propria terra. My heart will go on Nell’immaginario collettivo, il naufragio per antonomasia è riconducibile a quello del Titanic, ma moltissime furono le tragedie accadute in mare nei primi decenni del ‘Novecento. Naturalmente, al trasporto degli emigranti erano assegnate carrette galleggianti con una vita media di navigazione altissima. Si trattava di piroscafi in disarmo, chiamati “vascelli della morte”, i quali non potevano contenere più di 700 persone, ma spesso ne caricavano più del doppio. Queste navi partivano senza la certezza di arrivare a destinazione. My heart will go on è il brano musicale portante del film Titanic. Composto da James Horner su testo di Will Jennings è stato portato al successo dalla cantante canadese Céline Dion nel 1997. La canzone, coinvolgente e passionale, si spinge nelle note più acute del registro vocale femminile. ‘O surdato ‘nnammurato Se nella sciagura del Titanic, la più grande tragedia di tutti i tempi della storia della Marina Civile, persero la vita 1523 dei 2223 passeggeri imbarcati, quest’anno sono stati quasi duemila i decessi di emigranti naufragati nel Mediterraneo. Molti di loro si sarebbero potuti salvare, ma pochi sono intervenuti. La maggior parte di quelle persone, soprattutto donne e bambini, la cui resistenza è più fragile, proveniva dalla Libia, quindi da una zona di guerra che dava loro il diritto di ricevere rifugio e ospitalità in Europa. Infatti, non erano emigranti clandestini, ma profughi. ‘O surdato ‘nnammurato, Il soldato innamorato, è una delle più famose canzoni in lingua napoletana, scritta dal poeta Aniello Califano e musicata da Enrico Cannio nel 1915. La canzone descrive la tristezza di un soldato che combatte al fronte durante la Prima Guerra Mondiale e che soffre per la lontananza dalla donna della quale è innamorato. Le parole esprimono malinconia e scoramento, ma la musica è briosa e trascinante. Nelle vecchie stive dei bastimenti, durante le lunghe traversate oceaniche, c’era sempre chi la proponeva… con un giro di danza. ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA (RE) Classi terze A-C-E Docenti: Mario Bonacini Stefano Cugini Antonella Grande Alessia Pilastri Simonetta Zanoni
Scaricare