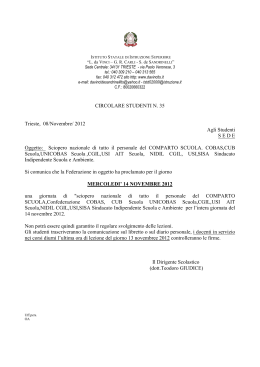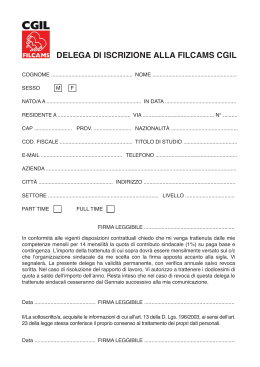problemi d’oggi COS’E’ DI SINISTRA? Un sindacato invecchiato, pesante, con un tasso di sindacalizzazione degli attivi sempre decrescente, ma soprattutto tuttora incapace, per mancanza di coraggio, di disegnare il sindacato del futuro, adatto ai grandi cambiamenti intervenuti nel mondo del lavoro e nella società. Il rischio che la leadership del partito democratico non sia che la somma, blindata, delle due nomenclature. Intervista a Roberto Fasoli. Roberto Fasoli, già segretario generale della Cgil di Verona, è consigliere comunale a Verona per il gruppo dell’Ulivo. Partiamo dal sindacato, anche se non ci sei più, per poi arrivare al partito democratico… Non faccio più parte del sindacato ma, ovviamente, sono ancora iscritto, ci mancherebbe altro. Mi sono iscritto nel 1976 e dal dicembre ’85 a gennaio 2006 sono stato nella Segreteria della Cgil di Verona. Negli ultimi otto anni, ho fatto il segretario generale. Sono uscito per completamento dei mandati a gennaio e la Cgil ha eletto -con voto segreto, com’è obbligatorio- una segretaria donna, l’unica nel Veneto e una segreteria con il 40% di donne, come da regolamento. Non avviene quasi da nessuna parte e questa è la cosa di cui sono più soddisfatto. Lo dico perché, secondo me, se è importante il giudizio che si dà sul lavoro che uno ha fatto, lo è altrettanto anche quello su come uno lascia l’organizzazione. Io ho lasciato un’organizzazione in piedi, con gli iscritti cresciuti, i dati sono lì, e con un gruppo dirigente che non ha perso un giorno a litigare sulla leadership. Per venire al cuore della domanda. Nell’ultimo anno e mezzo in particolare, ma dovrei dire in tutti gli ultimi anni, ho spinto perché il sindacato fosse protagonista di un processo di ripensamento, di rinnovamento di se stesso e il Veneto aveva, da questo punto di vista, costruito una bella cosa che si chiamava “conferenza di progetto” con un bel titolo, “Il sindacato e la grande trasformazione”. L’idea era che il sindacato del XXI secolo non potesse avere gli stessi impianti culturali, gli stessi modelli organizzativi di quello della seconda grande industrializzazione. L’economia e la società della conoscenza, il post-fordismo, il superamento dei bisogni primari per grandi fette di popolazione, la trasformazione dell’economia, la nuova gerarchia anche delle priorità per le persone, richiedevano un sindacato che appunto sapesse fare con grande intelligenza un’opera di ripensamento e di riorganizzazione. Cosa che, devo dire, a tutt’oggi non è riuscito a fare. Continua ad annunciarla, ma non sarà certo la conferenza di organizzazione a portarla a termine perché questa, a rigore, dovrebbe seguire il cambiamento di posizionamento politico-culturale e di modelli organizzativi. Non è certamente inserendo due donne e due giovani in più che si riesce a ricalibrare la propria capacità di interpretare i bisogni del XXI secolo. Il sindacato fa tre mestieri sostanzialmente: la contrattazione, e già su questo ci sarebbe molto da dire, la tutela dei diritti e la promozione anche del desiderio e dell’aspettativa delle persone con le strutture di servizio, un lavoro prezioso ma a tutt’oggi considerato di rango inferiore, poi la rappresentanza generale degli interessi, che è il tema generale di cui si occupa la confederazione, quindi pensioni, scuola, sanità, ecc. Ebbene, noi soffriamo su tutti e tre i fronti. Ma ci tengo a puntualizzare una cosa: non è che io sia genericamente critico, sono critico in modo preciso e sono, soprattutto, molto preoccupato. Non ho l’atteggiamento tipico di chi, quando se n’è andato, comincia a criticare il sindacato come se fosse cosa altra da sé, io continuo a voler bene al sindacato, e parlo di sindacato, non della Cgil, perché mi sono sempre sentito un rappresentante del sindacato, quindi Cgil-Cisl-Uil, ovviamente più della Cgil perché è lì che ho partecipato, ma mai con un’azione ostile nei confronti degli altri. Le cose che dirò -ci tengo a dirlo- le ho dette e scritte quando ero segretario generale… Hai fatto cenno al ricambio generazionale... Sulle questioni del ricambio generazionale, più che altro esponiamo dei desideri, ma la struttura del sindacato è pesante e fortemente invecchiata nel gruppo dirigente. Chiamiamo giovani persone che hanno 40 anni. Quando entrai nel sindacato e divenni segretario di categoria avevo 27 anni, quando entrai nella segreteria confederale ne avevo 33. Oggi, a 33 anni, uno fa i corsi per delegati. 2 Quindi c’è un problema serissimo, anche nel sindacato, di leadership generazionale. Dicevi che il sindacato sta eludendo tutte le grandi questioni sul tappeto... Tutte. La riforma della contrattazione, la riforma delle pensioni, i ricambi generazionali, il sistema del welfare, gli investimenti in formazione, il tema dei giovani, le questioni del territorio. Sono state tutte rinviate e non c’è niente di peggio in politica che rinviare i problemi perché ti ritornano addosso con violenza. Mi sarebbe piaciuto, per esempio, che il Congresso, invece che rinviarli, i problemi li avesse affrontati, ma era evidente che facendolo in campagna elettorale si finiva per fare un congresso in cui si sosteneva la vittoria di Prodi contro Berlusconi. Ti faccio l’esempio del pubblico impiego: non affrontare il tema dell’efficienza della pubblica amministrazione significa che noi a sinistra non avremo mai la garanzia di non essere scavalcati, perché se tu tieni una linea, come il sindacato ha sempre tenuto, con una certa razionalità, uno spazio a sinistra ti si apre comunque, di quelli che chiedono tutto e il contrario di tutto senza alcuna contropartita, e quindi anche la linea “nessun nemico a sinistra” non va, perché un pezzo ce l’hai sempre contro, come stiamo verificando sulle pensioni. Il dato drammatico è che rischiamo di deludere tutta una fascia di persone ragionevoli, dotate di spirito riformatore, con un buon profilo professionale, ecc., che ci chiederebbe dei gesti di coraggio. Premiare la professionalità e anteporre, a volte, i meriti e la responsabilità alla tutela dei diritti, nel sindacato è considerato blasfemo. Ma la tutela dei diritti, che è stato uno slogan efficacissino, rischia di diventare un motto difensivo e sul quale, a volte, finiamo per impiccarci, perché la tutela dei diritti non può significare mai appiattimento. Se non coniughiamo i diritti con merito e responsabilità, tutte quelle persone che anche nella pubblica amministrazione, parlo della sanità, della scuola, ecc., ci mettono del loro e hanno retribuzioni risibilmente differenziate rispetto a quelle che tirano a mezzogiorno o al fine settimana, fanno fatica a capire che noi siamo i sostenitori di una linea d’innovazione. Quindi anche nell’immaginario collettivo finiamo per essere visti come una grande agenzia di protezione dei diritti dei lavoratori, ma non di cambiamento. E questo s’incrocia anche coi temi della questione settentrionale della politica e del voto. Interi settori di operai e pensionati, soprattutto quelli con bassi titoli di studio, nel voto allegramente tradiscono gli ideali della Cgil votando centro-destra e non ne fanno più nemmeno mistero. se ho potuto fare quelle scelte lì è perché sapevo che comunque avevo un posto di lavoro dove potevo ritornare Mentre prima chi teneva la tessera della Cgil si vergognava di votare la Lega o Forza Italia o An, adesso non è più così. Te lo dicono tranquillamente: un conto è il sindacato e un conto è la politica. Questa in sé sarebbe persino una banalità, però non è che tu puoi pensare che il sindacato continui a tutelarti se vincono le forze politiche che vorrebbero ammazzarlo, com’è successo nel caso del governo di centro-destra. Credo che a noi sfugga in modo drammatico la percezione di com’è fatta la nostra gente, di che cosa pensa veramente, di quali siano le gerarchie delle persone iscritte al sindacato in termini di sistema di valori. Dopodiché noi continuiamo a illuderci che basti lo sciopero, la manifestazione… Le adesioni come vanno? Ci dicono qualcosa. Ti do un dato prendendo un periodo ragionevolmente lungo: dal 1980 al 2000 il sindacato perde 2 milioni di attivi, e vengono sostituiti tutti da pensionati. Adesso ha ripreso a crescere un po’ tra gli attivi, di qualche decina di migliaia in più a livello nazionale. Ma stiamo parlan- UNA CITTA’ do di numeri assoluti, in realtà c’è solo un rallentamento di un declino in termini di rappresentatività, perché gli occupati sono cresciuti molto di più, quindi il tasso di sindacalizzazione è continuato a calare. Se tu ragioni solo in termini di iscritti hai la percezione che il sindacato sia una cosa formidabile: 11 milioni e mezzo di iscritti, 5 milioni e mezzo alla Cgil, 60.000 a Verona, 350.000 in Veneto… Una potenza! Ma togli i pensionati e i 350.000 già diventano 150.000. A fronte di quanti lavoratori attivi? Noi siamo poco più del 10% degli attivi, e complessivamente Cgil, Cisl e Uil arrivano a sfiorare solo il 30%. Allora, questo è un problema. Si dice: ma in altre parti il sindacato sta peggio. Ho capito, ma da altre parti si sta meglio. E che politiche hanno fatto? Hanno fatto le politiche di gestione di alcuni pezzi di welfare come nel famoso patto di Gand. Puoi spiegare questa cosa? Nei paesi nordici il sindacato gestisce alcune responsabilità che sarebbero del pubblico, ad esempio la disoccupazione. Questo, ovviamente, droga l’iscrizione. E però quelli sono gli unici posti dove il sindacato tiene. Oppure, altro dato più vicino ai nostri interessi, il problema degli enti cosiddetti bilaterali. Gli enti bilaterali sono quelli costituiti dal sindacato e dai datori di lavoro per gestire alcune problematiche.La Cgil ha fatto una guerra mondiale per evitare che gli enti bilaterali avessero in gestione determinate politiche… Può darsi che abbia avuto ragione, io allora ho anche condiviso la scelta, ma forse potremmo ridiscuterne. Per esempio in edilizia gli enti bilaterali gestiscono tutta una serie di pratiche dei lavoratori, che in altri settori vengono fatte dal pubblico. Non voglio dire che hanno ragione tutti quelli che dicono che il sindacato è antiquato, però quel che mi pare drammatico è che non ci sia un luogo di discussione su questi temi. Ma c’è il problema di una burocrazia sindacale poco incline alla battaglia delle idee? Beh, io comunque vieterei di assumere le persone. Penso che se ho potuto fare quelle scelte lì è perché sapevo che comunque avevo un posto di lavoro dove potevo ritornare. Tu ora torni a fare l’insegnante? Sì, e ovviamente so bene che tornare a scuola è un conto, tornare in fabbrica dopo che sei fuori da vent’anni non è propriamente la stessa cosa. Comunque sapere che puoi tornare al lavoro di prima ti dà una libertà che non hai se fai di mestiere il sindacalista. E’ come fare di mestiere il consigliere comunale. E’ sbagliato. Se tu eleggi negli organi dirigenti qualcuno che è già dipendente della Cgil non è che poi, se non lo eleggi più, non fa più il sindacalista, lo tengono lì, da qualche altra parte, perché altrimenti bisognerebbe licenziarlo. Questa sembra una banalità, ma io trovo che per molti ragazzi -ma vale anche per la politica- avvicinarsi è quasi un modo per risolvere dei problemi di lavoro. Certo, nel sindacato è molto più difficile che in politica perché la remunerazione che dà il sindacato è molto modesta. Infatti c’è anche il problema contrario: persone di valore che sul mercato del lavoro possono avere retribuzioni medio-alte nel sindacato ci rimetterebbero solo. Però chi viene da fasce basse del mercato, dalla militanza sindacale può ricavare alcune libertà e agi e, soprattutto, un reddito che, diversamente, per esempio in fabbrica, non avrebbe. Ma da tutte le fasce alte impiegatizie, non parliamo di quelle dirigenziali, un quadro del sindacato se non esce col distacco,cioè con la legge 300 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, è spacciato dal punto di vista economico. Sono tanti gli assunti rispetto ai distaccati? Non sono tantissimi perché le agibilità sindacali funzionano, ma se su queste intervenisse il governo, e quello di centro-destra lo aveva minacciato, sarebbe un massacro. Le agibilità sindacali consentono al sindacato di avere dei bei vantaggi, compresa la contribuzione figurativa, che vuole dire che se tu hai un mandato sindacale i contributi vengono coperti forfettariamente, quindi tu non li paghi, ma ti vengono riconosciuti, ovvero se ne fa carico il pubblico, lo stato. Se ai sindacalisti tu dovessi pagare anche i contributi o ne mandi a casa una parte o dovresti aumentare in modo considerevole gli iscritti. Intendiamoci: chi critica questo avendo i benefici come partito politico o come organo di stampa, fa morire dal ridere, perché i partiti vengono strafinanziati, gli organi di stampa legati alla politica pure. Rispetto a quelli i benefici che ha il sindacato sono modestissimi. I rimborsi elettorali sono uno scandalo come spiega anche il libro di Stella. Però questo lo dicevo per far capire che il sindacato non attraversa una fase tranquilla e quello che fa impressione è che molti sembrano non accorgersene oppure, semplicemente, rimandano. Ma il tempo, a mio avviso, sta scadendo. Torniamo al mancato rinnovamento. Secondo te il sindacato rischia di non interpretare pezzi interi di società... Faccio un esempio: abbiamo costituito una categoria che si chiama Nidil, Nuova identità di lavoro, per i cosiddetti parasubordinati. Intuizione positiva, c’ero anch’io, tra i tanti, a Milano in sala parto, ma quanti iscritti credi che abbia il Nidil? A Verona ne ha qualche centinaio. Ma in Italia sono milioni i lavoratori para-subordinati, temporanei, precari, interinali. Allora, l’intuizione è giusta, ma se tu non strutturi anche le politiche diversamente rischi di essere un soggetto interessante solo da un punto di vista dei servizi: uno viene lì quando ha bisogno di un aiuto per un contratto, quando viene licenziato, quando ha il sospetto che lo imbroglino, ma non sei un veicolo di organizzazione di questi soggetti, che hanno poi la particolarità di essere, tranne che nei call center, quasi sempre in pochi, sparpagliati nei posti di lavoro, poco considerati anche dagli attivi tradizionali… Adesso le cose stanno un po’ cambiando, ma questi per molto tempo sono stati visti o come turabuchi da usare negli interstizi in cui nessuno voleva prestarsi, sabati, domeniche, notti, orari disagiati, oppure come traditori perché magari non scioperavano o se ne sta- vano isolati, oppure si rapportavano direttamente ai capi o alla direzione. Ma cosa deve fare un ragazzo o una ragazza che entra in fabbrica in quelle condizioni lì? Se poi nessuno gli spiega, lo accoglie, lo fa sentire a casa sua e poi, in termini di politiche, non si fa nulla che lui percepisca come utile? Ripeto, chiacchiere ne ho sentite tante, ma poi di politiche e di scelte… Per esempio, il Veneto aveva fatto uno sforzo, è agli atti un lavoro di analisi e di discussione durato quasi due anni con Carrieri, con Anastasia e con altri che ci hanno aiutato. Certo, non era né completo né dava tutte le risposte, ma affrontava i problemi sul tappeto, per esempio la contrattazione territoriale. Non mi è parso che alla Segreteria nazionale sia fregato molto di tutto questo lavoro. Quando la Cgil ha dovuto rinnovare il gruppo dirigente del Veneto, con un’assoluta noncuranza prima ha proposto un candidato riformista, com’era Agostino Megale, che poteva stare in linea con questa discussione, poi, non essendo passato Megale per una serie di nefandezze, con la stessa noncuranza ha proposto Paolo Patta (poi è diventato sottosegretario) che scadeva come segretario nazionale della Cgil, ma che, essendo della minoranza della Cgil, aveva posizioni esattamente opposte alle nostre. perché non affrontiamo il problema di organizzare quelli che lavorano da soli, senza dipendenti? Siccome in un posto bisognava dare qualcosa anche alla minoranza, cosa importava a loro se il Veneto aveva un progetto e forse era buona cosa mandare qualcuno che fosse coerente con quel progetto? Ecco, queste sono le cose per le quali io poi ho lasciato. Potevo restare, se solo mi avessero detto: “Tu vai avanti con quel lavoro lì in un organo di direzione della Cgil in Veneto”. Pur avendo tutte le mie perplessità francamente sarebbe stato più difficile per me dire di no, visto che non sono andato via sputando sulla Cgil. La Cgil è la mia scuola, ho imparato quasi tutto da lì, però avrei voluto continuare quel lavoro. Adesso che vedo il sindacato da fuori mi accorgo con grande preoccupazione che le cose sono peggio di come me le immaginavo “stando in corsia”. Perché mi pare che il sindacato non si accorga che la sua discussione rischia di non interessare a nessuno. Io me la ricordo la polemica tra D’Alema e Cofferati qualche congresso fa. Allora ci fu un’insurrezione della Cgil nei confronti di D’Alema quando osò criticare il sindacato per conservatorismo, adesso si rischia che socialmente ci sia un’insurrezione a sostegno di D’Alema per le cose che ha detto a Epifani alla Festa sul lavoro a Serravalle. Questo, poi, è un altro tema interessante, il rapporto fra il sindacato e il Partito democratico… Già, e nessuno ne parla. Quando ho chiesto di discutere di questo mi hanno guardato come se fossi matto… C’è un problema di riferimenti politici. Il sindacato non può fare anche il lavoro dei partiti, lo abbiamo fatto per troppo tempo in supplenza a una politica che andava a ramengo, ma noi siamo un’altra cosa, dobbiamo dialogare con la politica che ha un compito diverso dal sindacato. E con quale politica dialoghiamo? C’è il rischio concreto, lo capisce anche un bambino, che la Cgil, per la storia e le collocazioni che ha, rischi di diventare interlocutore più della sinistra radicale che del Partito democratico. Quindi puoi avere una spaccatura frontale con Cisl e Uil, che dialogano maggiormente con questa nuova espressione che tutti ci auguriamo nasca bene, innovatrice, e sappiamo che non è così semplice. Ma la Cgil? Che cosa fa, resisterà? I temi del lavoro dentro il Partito democratico non potranno essere declinati solo con la logica della tutela dei diritti, ma anche dei meriti e delle responsabilità, è scritto così nel manifesto. Anche qui non vedo nessuna discussione in piedi. Quindi i temi sono molto intrecciati. Il sindacato e la politica, il sindacato e il territorio, il sindacato e il Nord… Ecco, la cosiddetta questione settentrionale… Stiamo in una delle due regioni in Italia a maggioranza Cisl. Il divario fra Cisl e Cgil è aumentato negli ultimi anni nonostante tutte le manifestazioni, l’ira di dio che abbiamo fatto. Allora questo pezzo di mondo del lavoro per quali ragioni si associa a un sindacato? E perché non ci ha premiato? La Cisl è cresciuta in modo enorme nei pensionati, superandoci, mentre prima era sotto, e negli attivi percentualmente ha perso più di noi, anche se rimane il primo sindacato in termini di cifra assoluta, ma ha avuto una flessione più alta della nostra. Ma questo ci può consolare? Il divario si è allargato: perché non discutiamo di questo? Ma ancor più perché non ci interroghiamo sul fatto che nel Veneto produttivo, regione ricchissima in Italia e in Europa, e nella Lombardia, altro punto di crisi, il sindacato fa fatica a rappresentare i lavoratori dipendenti? Poi -blasfemo- perché non affrontiamo il problema di organizzare quelli che lavorano da soli senza dipendenti, perché dobbiamo lasciarli agli artigiani, cos’hanno di diverso? E non è che il problema della piccola e media impresa il sindacato non se lo sia mai posto, purtroppo non ha mai fatto nulla. Di fronte al calo della grande impresa, dove tu facevi gli iscritti col cappello, dovremo pur far qualcosa. Ma questo lo sa anche Epifani, che lo ha ripetuto nel libro sui cent’anni della Cgil, ma tra esserne consapevoli e fare delle politiche passa il fatto che bisogna spostare i pesi. Dal nazionale al regionale innnanzitutto. Qui c’entra anche il federalismo? Da un punto di vista sindacale come stanno le cose? Il sindacato, in termini di federalismo, è una tragedia. Tu hai un’organizzazione piramidale gerarchica antica, dove il direttivo nazionale discute le stesse cose che poi vengono discusse al direttivo regionale, ai direttivi di categoria, ai direttivi delle camere del lavoro, ai direttivi delle categorie delle camere del lavoro… Se uno sta in tutti quei posti lì -scusate- si fracassa i coglioni e poi non avrà discusso mai di cose del Veneto. Certo, bisogna discutere anche della linea nazionale, ma la Cgil di Verona dovrebbe occuparsi innanzitutto e soprattutto della città di Verona, della provincia di Verona, dovrebbe discutere prevalentemente di quei temi lì perché è il sindacato di quella roba lì… Perché fa così fatica il sindacato a muoversi? Ci vorrebbe coraggio e la Cgil in certi momenti l’ha avuto. Nella mia relazione al congresso di Verona riporto una citazione bellissima, commovente, quella che Trentin fa rispetto a Di Vittorio. La leggo: “Resto sempre segnato e lo sarò fino alla fine della mia vita dalla straordinaria lezione che Di Vittorio diede a tutti noi, in splendido isolamento, in un comitato direttivo della Cgil che si sentì offeso dalla sua autocritica. la lezione di Di Vittorio quando il comitato direttivo della Cgil si sentì offeso dalla sua autocritica... Voleva capire se per caso nella sconfitta della Fiom alla Fiat -ricordo che allora la Fiom passò dal 65 al 36%, la Fim dal 25 al 41, la Uilm dal 10 al 23, imperversava la repressione padronale, i licenziamenti, i reparti confino- non c’era forse una responsabilità della Cgil”. E prosegue Bruno Trentin non senza una punta di amarezza: “Questa è un’altra cultura, un altro modo che un grande dirigente sindacale che veniva dalle lotte bracciantili ha insegnato a molto di noi”. Cioè Di Vittorio prese e sbattacchiò il direttivo dicendogli: “Va beh, che c’erano i reparti confino lo sapevamo, che la Fiat reprimeva i nostri lo sapevamo, e perché non siamo stati capaci di tener conto di questo e abbiamo subìto al punto che ci hanno dimezzati?”. Grande lezione di un sindacalista che capiva che bisognava cambiare. Ma se tu leggi il libretto di Foa ed Epifani,100 anni di Cgil, ti accorgi che le parti innovative sono tutte in bocca a Vittorio Foa. I punti di criticità li propone, con molta leggerezza e con una sua arguzia e curiosità, Vittorio Foa. Ma lui, si dirà, lo può fare perché è un libero battitore, ma non è solo un libero battitore, è uno che nella vita, e come lui tanti altri dirigenMestre UNA CITTA’ 3 ti sindacali, ha fatto delle cose forti. Bruno Trentin firmò l’accordo del 1992 e poi si dimise da segretario della Cgil perché non aveva il mandato per firmarlo. Dico, per fortuna che firmò, ha salvato probabilmente l’Italia da una crisi economica spaventosa. Ma se fosse andato a domandare al direttivo della Cgil, non avrebbe firmato. Puoi raccontare? Era l’accordo del 31 luglio del 1992, il primo grande patto di concertazione, poi ripetuto con quello che si ricorda sempre, del 3 luglio del ’93. Quello del ’92, Trentin lo firmò nella notte e poi, subito, si dimise da segretario dicendo che non poteva infrangere il mandato, ma che aveva dovuto firmare perché, in tutta onestà, riteneva che fosse giusto farlo. A settembre ci fu un direttivo con lui seduto in platea, in prima fila, come sempre con quella faccia impenetrabile che scrutava tutto e tutti, e, alla fine, il direttivo gli chiese di ritornare a fare il segretario generale. Ecco, la Cgil oggi avrebbe bisogno di persone con il coraggio di fare grandi scelte. In buona sostanza, l’ultima strategia che noi abbiamo è quella dei diritti, ma oggi credo che per primo Trentin, anche per le cose che ha scritto dopo essere uscito dalla Segreteria generale della Cgil, ci direbbe che la strategia dei diritti, giustissima nel legare il lavoro all’idea di cittadinanza, oggi rischia di essere immobilizzante, perché è una condizione necessaria ma non sufficiente per interpretare i cambiamenti. Ecco, i cambiamenti… In fondo noi subiamo le conseguenze del nostro successo. Siamo riusciti a riscattare, per buona parte, le condizioni del lavoro dipendente, dei pensionati, da una situazione di assenza di diritti e di privazioni. Quanta gente non aveva la casa o non aveva le condizioni minime per avere una vita dignitosa? Non sono così giovane da essermi dimenticato che nelle nostre terre c’era il cosiddetto cesso nel cortile, col buco per terra e i giornali attaccati al chiodo. Nell’arco di 45 anni c’è gente che ha più telefoni delle orecchie, più auto che mani per guidarle. Questo benessere introduce anche nei comportamenti un’altra gerarchia di valori, di desideri, di aspettative, che non sono più quelle di una volta. Ma tu ne tieni conto o no? E so che c’è una fascia di persone che vive in una condizione di povertà, ma da noi il grosso della popolazione ha migliorato sensibilmente le proprie condizioni di vita e ora ha paura di perdere molti dei benefici che sono stati conquistati con tanti sacrifici da parte di queste generazioni. E ora, anche per le difficoltà sopraggiunte, la globalizzazione, eccetera, ha paura di tornare indietro. Non è legittimo pensare di mantenere questa condizione? E il sindacato e la sinistra cos’hanno da dir loro? La destra sappiamo cosa dice: mani libere così che tutti si potranno arricchire. E danno anche da intendere che quella condizione sia stata raggiunta a prescindere dalla politica, quasi grazie all’assenza della politica. Il che non è vero, perché la Dc sia in Lombardia che in Veneto ha saputo anche pilotarli i processi. Si può discuterne la qualità, ma non è che sia mancata la politica. Ma adesso, che ci sarebbe bisogno di più politica perché le cose sono diventate più complesse? Niente, questo bisogno di politica non trova risposta nelle proposte che facciamo noi. Tranne in alcune realtà come Venezia o in certe aree della bassa Polesine, del Rovigino, la sinistra arranca in Veneto. Come si spiega che a Verona il governo di centro-sinistra uscente supera di poco il 30% e un sindaco leghista, giovanotto di belle speranze, supera il 60%? Sì, certo, c’è la responsabilità del governo, ma quella c’è anche da altre parti; qua evidentemente ci abbiamo messo del nostro nel non capire il tipo di domanda che veniva dalla nostra terra. Qua abbiamo avuto gente di sinistra che ha votato per la Lega. E’ acclarato dall’analisi dei flussi di voto. Se avessimo perso perché il governo era moderato ci sarebbe stato un successo delle liste di sinistra e di Rifondazione. Nel Consiglio comunale di Verona, Rifondazione dopo molti anni non ha il quorum per entrare, dopo 22 anni non c’è un consigliere verde in Consiglio. Le risposte semplificate conducono a disastri. Noi abbiamo operai, lavoratori dipendenti e pensionati che sottoscrivono la petizione dei commercianti contro gli studi di settore. Ora, per carità, può essere che il governo abbia sbagliato a interpretare, non lo abbia fatto correttamente, può darsi che dovesse discuterne con le associazioni, concedo tutto, ma il senso di appartenenza a una condizione dovrebbe guidare lavoratori dipendenti e pensionati a domandarsi come può essere possibile che il reddito dichiarato da un imprenditore che fa la raccolta delle firme contro gli studi di settore sia uguale all’ammontare delle tasse pagate da un lavoratore dipendente come me. Ci sarà qualcosa che non va. Gli studi di settore possono non andare bene, ma è assolutamente evidente che il margine di evasione che può fare un lavora- 4 tore dipendente o un pensionato è ridicolo. Può essere che non dichiari il secondo lavoro, che non metta tutti i beni che ha, le case le deve mettere, ma è infinitamente impari la condizione. E allora perché alcuni lavoratori si sentono di solidarizzare con certi personaggi, pur sapendo -dico la cosa più banale- che quando accompagnano i bambini all’asilo nido o gli anziani alla casa di cura o al centro di assistenza loro saranno nella fascia più alta, mentre il lavoratore autonomo risulterà o esente o nella fascia più bassa? se uno fa osservare a un immigrato che il biglietto sul bus si paga è razzista o è un bravo cittadino? Da noi i nidi o le case di riposo si pagano in base alle fasce di reddito. Poi, casomai ti incazzi con l’immigrato che è un lavoratore, come te e dici: prima noi, poi lui. Come lo spieghiamo tutto ciò? Beh, e come si spiega? Certamente un sacco di argomenti li regaliamo alla destra. Il tema della legalità, per esempio. E bisogna essere dei matti perché questo finto buonismo conduce a dei disastri. Se uno viene qua irregolare ha ragione Zanonato, il sindaco di Padova, a dire che siccome un irregolare non può lavorare, può solo lavorare in nero, allora o lavora in nero e già è nell’illegalità o fa altre cose peggiori del lavoro nero che gli diano reddito. Quindi lì non ci sono storie: i clandestini o li regolarizzi tutti o li espelli. Se li regolarizzi tutti diventi l’unico paese al mondo che non ha alcun filtro sugli ingressi; se li espelli devi sapere come fare, perché è tutt’altro che facile, ma devi decidere di fare una politica vera di allontanamento. Questo è di destra o di sinistra? Un mio amico diceva: “Se uno fa osservare a un immigrato che il biglietto sul bus si paga è razzista o è un bravo cittadino?”. Credo che noi abbiamo commesso degli errori spaventosi. Intendiamoci, per fortuna che c’è stato il sindacato per gli immigrati, altrimenti sarebbe stato un massacro. Gli imprenditori chiamano queste persone poi se ne strafregano del loro destino come cittadini, gli chiedono quasi di scomparire una volta finito il lavoro. Però a questi bisogna dire che se si viene qua ci sono delle regole che vanno rispettate. Basterebbe l’esempio drammatico dell’infibulazione. Non c’è un problema di cultura, in questo paese è vietata, non si può fare, punto. La poligamia è vietata. Se uno viene qua deve stare alle regole che ci sono qua. E’di destra o di sinistra dire queste cose? Secondo me è di sinistra, perché vuol dire che tu proponi all’immigrato un percorso di integrazione, che non vuol dire assimilazione. Io non posso sindacare se tu non bevi il vino o non mangi la carne di maiale perché la tua religione te lo impedisce, ma non è che tu puoi guidare andando a sinistra perché sei abituato, vieni da un paese in cui la circolazione della strada dice che si può girare a sinistra come in Inghilterra. Il rispetto delle stesse regole del gioco deve valere per tutti. Queste cose perché le regaliamo alla destra? Ormai va per la maggiore l’idea che la sinistra è conservatrice e la destra per l’innovazione... Pare una maledizione. In questo scorcio di secolo, improvvisamente, per una specie di capriola della storia, la sinistra viene considerata conservatrice e la destra innovatrice. Che non è vero perché la destra ha dato al governo pessime prove di sé, di centralizzazione statuale, di liberismo ottuso, senza regole, di polarizzazione della ricchezza. Quindi non è affatto innovatrice. Ma allora perché nell’immaginario collettivo, anche della povera gente, si ha questa percezione? Vogliamo discutere o diamo la colpa al destino cinico e baro o alla perversione dei giornalisti? Io credo, ad esempio, che da parte della sinistra ci vorrebbe una maggiore attenzione alla persona. Forse la sinistra è stata per troppo tempo ancorata all’idea della classe, delle masse, del popolo, dell’azione collettiva. Oggi le persone si muovono più come singoli che come soggetti collettivi. Faccio un esempio: se uno, com’è successo recentemente a un ragazzo che lavora alla Cgil, va a prenotare un elettrocardiogramma, perché si è sentito male in strada, e lo mandano alla primavera prossima, ci si incazza come bufali. E si dovrebbero incazzare tutti, destra, sinistra, il mondo. Come mai una struttura pubblica ti manda a 8 mesi le visite? Perché funziona solo al mattino? Perché le macchine degli ospedali o le scuole non devono funzionare anche per la collettività per l’intero arco dell’anno tutta la giornata? Se tu parli con un lavoratore autonomo serio, che vuole rispettare le sue regole, ti dimostra che lui perde metà del suo tempo per seguire le cose burocratiche. Non sono balle, io ci parlo con alcuni, c’è da diventare matti per smaltire i rifiuti, o per compilare tutte le carte necessarie. Forse non si UNA CITTA’ può fare diversamente, ma perché non può essere la sinistra che prende su di sé tutta la partita della semplificazione della pubblica amministrazione e della maggiore efficienza del servizio pubblico? Perché deve essere di destra differenziare le retribuzioni nel sistema pubblico o nella scuola? Non saranno mica tutti uguali gli insegnanti? C’è gente che fa progetti, lavora coi bambini al pomeriggio, a casa si fa in quattro… “Ah, ma poi sarebbe il preside a decidere…”. “Bene, togliamo di mezzo il preside, istituiamo un organo terzo che sia capace di fare la valutazione”. Ogni 5 anni si fa la revisione della patente, magari è una puttanata, guardano se sei cieco o no, ti ordinano gli occhiali o ti dicono che puoi girare. E perché uno che insegna o che fa il medico o l’infermiere non dovrebbe avere periodicamente una prova di verifica seria e rigorosa? E magari, legata a questa, anche un riconoscimento incentivante. E’ proprio di destra una roba così? Non lo so. Penso che molti dei nostri che lavorano con grande impegno e con grande serietà si infuriano a vedere che hanno le stesse retribuzioni di gente che si gratta o, in qualche modo, rispetta il mansionario. Io credo che abbiamo etichettato come di destra posizioni corrette, di buon senso, ma a forza di dire che sono di destra la gente la convinci: “Ah, va ben, voto la destra. Se tu dici che sono di destra io voto la destra”. Poi gli altri ci montano sopra e le condiscono anche con l’ideologia: ti tieni le tue tasse, i neri a casa, gli zingari fuori dai coglioni, prima i veronesi o i veneti nei posti pubblici, niente puttane per le strade, non si possono mangiare i panini… Non è che si dice di non buttare le carte per terra, dicono che non si possono mangiare i panini seduti sui monumenti. Voglio dire, è come se avessimo lasciato senza risposte tutta una serie di domande alle quali l’individualismo di destra dà la sua, che diventa l’unica, anche per persone che di destra non sono. Non è che la gente è diventata di destra. Qualcuno lo è sempre stato, ma tanti glieli stiamo regalando. Bersani è l’unico per ora che ho sentito dare una motivazione del perché sceglie la parola “democratico”, che oggi il cittadino viene prima dell’essere lavoratore. Il lavoro resta importantissimo, ma va dentro la cittadinanza… Quello che dice Bersani non solo è giusto, ma è poi l’impostazione che ha l’Europa. Quando Alain Supiot scrive il rapporto sul lavoro commissionato dall’Europa, pubblicato in Italia da Carocci, parla di diritti del lavoro come diritti di cittadinanza. Allora anche qua, torniamo al discorso di prima. Sinistra e sindacato debbono affrontare il tema in termini diversi perché alcuni diritti del lavoro vanno estesi non solo a tutti i lavoratori, quindi anche agli autonomi, con una grande riunificazione del tema del lavoro, ma anche ai cittadini in quanto lavoratori potenziali o non più lavoratori o non ancora lavoratori. I temi della salute, i temi della previdenza, i temi della formazione… Io, per esempio, ho avuto difficoltà nel sindacato a spiegare che la cosiddetta centralità del lavoro andava ripensata e reinterpretata. E non nel senso che il lavoro sia diventato marginale nella vita delle persone. Intanto va tenuto sempre presente che ci sono dei lavori dove ti realizzi e altri che non vedi l’ora di andartene a casa, di smettere e di andare in pensione. Quindi il lavoro è prima di tutto condizione di libertà delle persone in quanto possibilità di autosufficienza economica. come mai una struttura pubblica ti manda a 8 mesi le visite? Perché funziona solo al mattino? Questo è importante da tenere presente per capire anche i giovani di oggi. Tu vai a parlare con questi ragazzi nelle fabbriche, li vedi magari tutti con la divisa da lavoro, poi quando escono ti accorgi che se non si occupano di sindacato sono impegnati nel volontariato, fanno sport, musica, viaggiano, hanno diecimila interessi che costituiscono la loro vera identità, e il lavoro lo considerano una pratica più o meno strumentale che gli serve a raggiungere un reddito. Detto questo, che per me è importante da tenere presente, si tratta certo di rendere il lavoro anche un elemento di significato nella vita delle persone. E’ più facile per alcuni lavori e più difficile per altri, ma torniamo al discorso che facevamo all’inizio. Bisogna premiare la professionalità, dare un senso alla partecipazione. Che cosa vuol dire, per esempio, la responsabilità in azienda? Che cosa vuol dire assumere parte del rischio di impresa? Non sto parlando di azionariato popolare, sul quale è perfino banale capire come, se vuole, il datore di lavoro può imbrogliarti, e così se tu leghi i risultati al bilancio. Le pratiche per occultare risorse anche legalmente o per spalmarle in modo tale da rendere i dividendi quasi ne- gativi sono note. Sto parlando, per esempio, di considerare, cosa che negli anni Settanta sembrò blasfema, il salario una variabile dipendente. Su questo allora Lama uscì su Repubblica e lasciò esterrefatta tutta la sinistra. D’altra parte una variabile indipendente il salario non lo era mai stato, anche quando noi lo teorizzavamo. Se tu andavi a fare una rivendicazione salariale e l’azienda ti presentava il piano di esubero o la chiusura, la piattaforma per l’aumento dei soldi veniva buttata nel cesso in due secondi e si discuteva della salvezza del posto di lavoro. Faccio un altro esempio: tu vuoi che un collaboratore abbia a cuore il suo lavoro? Ma allora bisogna che lo senta una cosa che dipende anche da lui. Bisogna che l’impresa gli dia, per esempio, una forma di riconoscimento della professionalità, bisogna che anche la formazione diventi remunerativa. In cambio però io, impresa (mettiamo sia una realtà seria che investe su te, ti manda a scuola, ecc.) devo avere una qualche garanzia che tu, se trovi un altro che ti dà due soldi in più per la formazione che hai, non te ne vada dopo due mesi… Di fronte a un rischio simile infatti l’impresa finisce per essere incentivata ad avere sempre carne fresca man mano che serve, per poi buttarla via, pratica autolesionista per l’impresa stessa. A quel lavoratore lì puoi chiedergli di essere compartecipe alle sorti dell’impresa se lui per primo sa che starà lì per il tempo strettamente necessario a svolgere una funzione? In realtà nessuna impresa può diventare di qualità continuando a usare i lavoratori man mano che servono. Alcuni imprenditori si rendono conto che il contratto cosiddetto di fidelizzazione è per loro vantaggioso: io ti do determinate cose, ma tu ti impegni a non andartene per un tot di anni. Nello stesso tempo bisognerebbe decidere che il lavoro para-subordinato costa il doppio del lavoro normale: tu hai il disagio di essere para-subordinato, di essere a termine? Invece di costarmi 50 mi costi 100. Allora sì, che l’impresa potrebbe avere incentivo a formarsele queste capacità, ma se sul mercato le trova a minor prezzo, e può poi espellerle quando vuole, siamo a un’aporia: si chiede il senso di attaccamento all’impresa e si trasmette invece il senso della precarietà. Quindi anche per me la cittadinanza è il termine semanticamente più pregnante, perché della cittadinanza attiva e consapevole fa parte l’essere lavoratore attivo e consapevole e professionalmente riconosciuto e retribuito adeguatamente. Questa cosa dei diritti… Nella Cgil c’è sempre stata una confusione enorme fra diritti e tutele. Si dice che i diritti non sono negoziabili. Ma quali sono i diritti? L’articolo 18, per dirti, è un diritto o una tutela? Il non essere licenziato senza giusta causa è un diritto, ma il reintegro è una tutela. E le tutele sono tutte negoziabili. Perché se fosse un diritto indisponibile, e su questo la Cgil ci ha un po’ marciato, allora avrebbe ragione Bertinotti a volerlo estendere anche alle piccole imprese, cosa che la Cgil non ha mai detto. Dopodiché, se è un diritto indisponibile, in Italia vai pure al referendum, puoi anche dire che in tutta Europa, dove le forme di tutela sono diverse, sono tutti a-democratici. Questa cosa che scrive Ichino l’altro giorno sulla prima pagina del Corriere della Sera… Io in quegli anni lì continuavo a spiegare alla Cgil che la lotta contro l’articolo 18 non si faceva perché era un diritto di democrazia, ma perché accettare l’attacco della Confindustria significava incentivare un modello di sviluppo che privilegiava i costi sulla qualità e quindi l’idea sbagliata che bisognasse abbassare le tutele per rendere l’impresa più libera. Capisco che era più difficile spiegarlo così ed era più efficace dal punto di vista mediatico dire che è un diritto inalienabile… Aris Accornero scrisse un libro L’ultimo tabù, dove il primo capitolo era legato al licenziamento. Però, anche lì, sono libri che hanno fatto poca fortuna alla Cgil. Accornero già nel ’92, ne La parabola del sindacato, scrisse parole preveggenti su quello che poteva diventare il sindacato se non faceva una serie di scelte. Si può dire che Accornero sia contro la Cgil? Non scherziamo. Quindi è questa cultura che, secondo me, manca. Io mi aspetto che il Pd faccia questo, che porti innovazione nella politica e anche nel rapporto con le grandi organizzazioni di massa, in questo caso il sindacato, altrimenti non serve a niente. D’altra parte, come ho già detto, credo che il sindacato non discuta di Partito democratico, perché facendolo non potrebbe non pensare anche ad alcune scelte che lui fa. Gli esempi sono tanti. Prendiamo il collocamento… E’successo un disastro da quando hanno passato il collocamento da numerico a nominativo? Quando si è fatta questa discussione qua sembrava che crollasse il mondo se tu sostenevi che non si faceva più il collocamento numerico con la graduatoria. Invece? Nulla, non è successo nulla. La gente andava a la- vorare senza passare attraverso il collocamento, che alla fine mediava il rapporto domanda-offerta per una percentuale talmente piccola di lavoratori da essere insignificante. Si è fatta una gran battaglia su tutta questa roba qua col risultato di abbandonare alle Province i servizi per l’impiego. Ma all’estero, dove non ci sono le graduatorie, c’è un servizio pubblico che media l’incontro domandaofferta perché conosce le esigenze delle imprese, conosce le esigenze del mercato, fa dialoghi veri, interviste vere con i lavoratori… Fanno un’opera da facilitatori? Sì. Io l’ho visto a Stoccolma, lì le imprese ci vanno veramente dal sistema pubblico, ma il sistema pubblico non è come qua, inaccessibile, è un luogo dove tu vai, hai i computer dove digiti le offerte di lavoro e le risposte arrivano sul serio. Qui gli imprenditori non ci credono al sistema pubblico e si rivolgono a società private o al passaparola. Ma se ci fosse un luogo pubblico d’intermediazione della domanda-offerta, l’imprenditore potrebbe scegliersi i lavoratori, ma anche tu potresti sceglierti i datori di lavoro, magari assistito da qualcuno che sa fare questo mestiere e capisce le caratteristiche che hai e ti dice dove andare a cercare. Perché una società non la può fare una cosa del genere? E’così diseconomico? Anzi, sarebbe molto più vantaggioso che lasciare le persone in balia di se stesse a girovagare come dei cretini o a farsi raccomandare da tizio o da caio. In fondo da noi questo lo fanno le agenzie di lavoro interinale e anche qua sono tutti tabù… Il prolungamento del periodo di prova. Lavoce.info (www.lavoce.info) propone di allungare il periodo di prova, e nel periodo di prova lasciare libera l’impresa di licenziare, sospendere, cioè, l’art. 18. E’una bestialità? Ma quando uno fa 3 anni di missione di lavoro interinale avanti indietro da un’azienda, oppure fa 3 anni di lavoro a tempo determinato che cos’è quella roba lì? Lì non ci sono quei diritti: finita la missione, finito il lavoro a tempo determinato, a casa e basta… E se dopo un mese rivoglio quel lavoratore, lo chiedo all’agenzia di lavoro interinale e me lo mandano e così posso andare avanti per 10 anni in teoria, o per tutta la vita. Allora? Non è meglio quel che propone Tito Boeri? Facciamo un accordo per cui per un primo periodo tu puoi farla questa cosa, dopodiché basta. Questo ridurrebbe o aumenterebbe le precarietà? Forse aumenterebbe il potere di ricatto verso i lavoratori nei primi anni, ma se poi tu questa roba la estendi anche a tutte le piccole fabbriche... Capisci? Insomma, mi piacerebbe che si discutesse fuori dalla gabbia delle ideologie. Certo, dopo qual è il problema? L’obiezione me la faccio da solo: con questo tipo di imprese tu ce l’hai un interlocutore? No, perché gli imprenditori che avevano preso un punto di diminuzione fiscale da Berlusconi gli hanno fatto infinite peana, ne hanno presi cinque da questo governo e gli hanno tirato addosso secchiate di merda. Allora si fa fatica a discutere. quali sono le tasse che puoi pagare? Quelle lì? Bene, però se poi non mi paghi neanche quelle, ti chiudo. Bisognerebbe ricostruire un patto diverso anche con gli imprenditori su questo tema, ed è la stessa ragione per cui bisognerebbe costruire un patto fiscale, un patto previdenziale. Incominciamo a rendere vantaggioso lasciare i soldi in impresa invece che nel risparmio finanziario. Finché uno se i soldi li mette in titoli, ha il 12,5% di trattenute, mentre se li lascia in impresa che produce reddito ha tasse al 40%, che cosa è probabile che faccia? Allora facciamo un’altra cosa: quali sono le tasse che puoi pagare? Quelle lì? Benissimo, però se poi non mi paghi neanche quelle, ti chiudo. Tu mi dici che il lavoratore lo devi poter prendere e poi mollare, facciamo una discussione vera su cosa vuol dire prendere o mollare. Se a te interessa solo prendere e mollare perché non vuoi avere oneri, allora questo non te lo do… Per le pensioni? Che cos’è di destra e cos’è di sinistra sarebbe un bel gioco da fare che aiuterebbe la politica. E’ più di sinistra tutelare i lavoratori che sono andati a lavorare a 14-15 anni o i più giovani? Uno ti direbbe: tutte e due le cose. Grazie. Io dico questo: intanto un accordo sensato di prolungamento graduale dell’età pensionabile l’avevamo già sottoscritto nel ’95. Perché noi poi siamo maestri nel trovare le scuse, tipo “sì, ma non dipendeva solo da…”. Avevamo detto che per i coefficenti, che sono le rendite delle pensioni, uno degli aspetti da tener conto era l’andamento demografico? Bene, nell’arco di 10 anni l’andamento demografico ti dice che tendenzialmente la vita si allunga. Allora tu dici che, intanto, questo è un dato di verità, secon- do che è un successo perché vuol dire che le persone stanno meglio, dopodiché puoi proporre di toccare i coefficenti, per esempio, graduando la modifica a partire da una fascia di reddito che non tocchi. Questo diventerebbe già più comprensibile alla gente. E stiamo attenti, perché non aver fatto quel pezzo di riforma indebolisce anche la credibilità dello stato, che poi chiede di prolungare. Dammi quelle cose lì, separami la previdenza dall’assistenza, mostrami sul serio la contabilità com’è… Queste sono le cose che un partito nuovo, non un nuovo partito, e un sindacato dovrebbero fare. Dico un’altra eresia, che in realtà è una banalità: con la nascita del partito democratico si riapre o no la discussione sull’unità sindacale? a qualcuno hai aggiunto una quota per la mancia ai nipoti e a qualcun altro hai dato un bicchiere di acqua fresca Che senso ha andare in Europa in tre senza che nessuno riesca a spiegarne il motivo? Lasciamo stare i non sindacati tipo la Francia, ma di fronte alle trade-union inglesi e al sindacato tedesco che, nonostante le difficoltà che anche loro attraversano, sono i modelli per tanti aspetti più solidi, noi avremo tre centrali sindacali. Perché? Da che cosa sono divise? Da poche cose, i termini dell’unità sono molto maggiori dei temi della divisione. Conviene aprirla o no questa discussione? No, e la Cisl penserà di guadagnare ritagliandosi un ruolo da interlocutrice con i governi, più attenta al merito, schiacciando la Cgil sull’estrema, così la Cgil, come dicevo, rischia di diventare il sindacato “che resiste”... Ma ha senso dialogare con il sistema politico con queste tre centrali sindacali che sono ancora frutto di una divisione che risale alla fine degli anni Quaranta-inizio anni Cinquanta? Ho dei fortissimi dubbi. Secondo te la gente si iscrive al sindacato perché sa la differenza tra Cgil, Cisl e Uil? Io scommetto che quasi tutti lo sanno dopo perché si sono iscritti a quel sindacato lì e non a un altro. Ce lo dicono i lavoratori nel modo più chiaro che il veicolo dell’iscrizione è la persona che te la chiede o la sua credibilità o il fatto che è presente in fabbrica. Saranno il 5% quelli che sanno perché la Cgil e non la Cisl… Anche il tema dei servizi è interessante. E’ considerata l’attività meno nobile del sindacato… Anche su questo noi abbiamo dato scandalo. Chi dice che il direttore dell’Inca, il patronato, è meno importante del segretario dei metalmeccanici o del segretario della camera del lavoro? Sappiamo quanta gente va lì solo per i servizi? E c’è una gerarchia tra il rinnovo del contratto e la tutela previdenziale o l’assistenza nel caso che tu abbia problemi col fisco? Per me può essere ugualmente importante del tuo cavolo di contratto che, magari, mi costa 20 ore di sciopero per avere 50 euro scaglionati in 3 anni. C’è una gerarchia? Una delle cose che non è piaciuta a molti è che noi abbiamo detto che non c’è una gerarchia tra la contrattazione, la tutela individuale e la rappresentanza degli interessi. Sono tre funzioni che, a pari titolo di dignità, costituiscono l’essenza del fare il sindacato. Quindi i servizi di tutela individuale, i cosiddetti “servizi” (che a me fa pensare all’espressione “tre camere più servizi”, sembrano accessori) sono parimenti significativi della tutela collettiva. Chi è che mi spiega perché no? So anch’io che un sindacato che non contratta non esiste, ma siete proprio sicuri che non esista? Negli anni in cui noi abbiamo fatto pochi contratti, abbiamo fatto fatica, il sindacato è stato tenuto insieme anche dalle attività dei servizi che abbiamo fatto e molta parte degli iscritti arriva dai servizi, dalla gente che viene lì per farsi la pensione, per farsi il 730, per farsi la pratica e poi, magari, si trova bene e si iscrive anche. Ti faccio un altro esempio: la contrattazione individuale. Anche qua discutiamo. Se uno dice: mi accordo col padrone per i fatti miei, questa non è contrattazione individuale, o meglio, è contrattazione individuale e quindi fai fatica a dare una prospettiva sindacale a quel tipo lì. Intanto questo tradisce già il fatto che tu non sei rappresentativo di quel lavoratore, ma possiamo decidere di essere del tutto contrari alle contrattazioni individuali? Io dico: dipende. Allora, stabiliamo che il premio del risultato è 200 euro al mese, tu sei un giovane che deve farsi una famiglia e hai il mutuo da pagare, quindi dici: “Gli schei, li voglio tutti”. Se invece sei un lavoratore studente e devi completare il corso di laurea e vieni da me sindacato: “Ascolta, a me dei 200 euro non me ne frega niente. Perché non posso avere, oltre alle ore che ho disponibili per fare gli esami -al posto dei soldi- delle ore in più per studiare, senza diventare matto che la sera sono rincoglionito?”. Sarebbe una contrattazione che tiene conto dei diversi desideri delle perso- ne e dà a me la rappresentatività di altri che se no vanno a farsela direttamente col padrone questo tipo di trattativa. Quindi ci vuole anche elasticità, capacità di distinguere. Ti faccio un altro esempio: i pensionati. Altro tabù. Parlare male dei pensionati sembra come sparare sulla Croce rossa. Ma ci sono pensionati e pensionati. “Ma cosa vuol dire, ci sono pensionati che prendono 400 euro al mese…”. Dipende, dipende. Se fossero da soli senza casa di proprietà sarebbero in condizioni di povertà estrema, ma se sono coniugati con un signore che ne prende altri 1.500 di reddito e abitano in una casa di proprietà, hanno un pezzo di orto, due conigli e tre galline, come i miei suoceri, con i 400 euro di una pensione danno la mancia ai figli e ai nipoti. Allora, bisognerebbe stabilire il quoziente familiare. “No!!! perché questo viola la libertà della persona!”. Ma come? Le condizioni materiali, anche nelle erogazioni degli aumenti, devono essere tenute presenti. Se dai un aumento prescindendo dall’analisi concreta delle condizioni in cui questi vivono, sei sicuro di aver fatto un’operazione realmente equa? A qualcuno hai aggiunto una quota per la mancia ai nipoti e a qualcun altro hai dato un bicchiere di acqua fresca. Ti posso fare casi concreti. C’è una signora che abita in questo palazzo che prende il doppio di una pensione minima, ma vive da sola in una casa in affitto. Questa gran miliardi non li ha, uno che prende metà pensione e, ripeto, vive in una casa di proprietà e ha, finché ce l’ha, il coniuge e domani ha la reversibilità di questo, non sarà mica nelle stesse condizioni? Allora? Le gabbie salariali. Foa, in quel libro che citavo prima, dice di provare un po’ a ripensare sta cosa del Nord e del Sud, le regioni, il costo della vita. Dice che è giusto aver tolto le gabbie salariali allora, ma siamo proprio sicuri che lo sia ancora? In buona sostanza: se tu vai in taxi qua a Verona costa 10 euro andare in stazione, a Roma con 10 euro ti portano in giro per tutta la città, e dico Roma. E’ vero, ma poi -si dice- va guardato tutto l’insieme, a Roma costa di più l’università… Sì, ma siamo sicuri che sia vero e che la gente lo percepisca così? Perché noi spesso decidiamo che una cosa non è un problema vero, ma non è che così abbiamo tolto alle persone la percezione che sia un problema vero. Intanto tu cominci a dire: discutiamo di questo problema. Invece la prima cosa che dici è: no, di questo non si discute perché è di destra… Altro argomento: la contrattazione aziendale si fa solo qui da noi, invece al Sud, o da molte parti, non la fanno. Ho capito, ma in quanti posti la fai la contrattazione? E nel sistema pubblico la contrattazione la fai tanto al Nord quanto al Sud perché non c’è il problema del padrone grosso o piccolo. Su questi argomenti fai una fatica tremenda a discutere. Parliamo un po’della nascita del partito democratico. E’ parecchio tormentata... Io credo che la questione vera sulla quale ci misureremo e che rischierà di essere quella assolutamente più complicata è legata alla classe dirigente che sapremo mettere in campo. Le leadership ai diversi livelli devono essere contendibili e oggi, per come si sta strutturando il sistema delle regole, sono leadership non contendibili o, comunque, difficilissimamente contendibili soprattutto da persone al di fuori dell’attuale nomenclatura dei partiti protagonisti di questo percorso. Sul piano dei contenuti c’è una discussione in corso e non è che uno avrà la parola definitiva, sarà poi la vita stessa del partito che la potrà giocare, ma quando tu nasci creando una condizione di impermeabilità… Per dirti, i soggetti che la pensano come me, che non sono iscritti ai partiti o che non sono omologati possono essere cooptati, ma io non voglio entrare in un partito come contorno o come servizio. Vorrei sentirmi a casa mia, essere coprotagonista, cofondatore... Questo non è solo un problema mio, è il problema di tanti che fanno volontariato, e non politica, perché oltre a trovarci un senso non hanno quei diecimila sbarramenti e non sono disponibili a passare per forme di selezione che non hanno niente a che vedere con la competenza, col merito e con le capacità, bensì solo con la fedeltà e il tempo da perdere. Allora: vuoi fare un partito nuovo? Su queste cose non dico di cambiare tutto, ma di dare un segno, di provare a fare qualcosa di nuovo, questo sì. Temo, invece, che si vada nella direzione opposta… Si faccia la somma delle due nomenclature… Se vuoi l’unica cosa che scombinerà saranno le donne che devono scegliere, perché se accettano questa idea, come pare, di mettere metà uomini e metà donne, le donne diventano il sistema per lasciare a casa qualcuno dei gruppi dirigenti. Ma non sono sicuro che di per sé questo possa bastare, perché se sono donne assegnate a questa o a quella componente siamo solo parzialmente nella novità. Cioè, è un insieme di fattori che debbono cambiare, che possono essere il genere, le genera- zioni, la terza G, cioè le genti, tema che non abbiamo affrontato. Anche qui, bisognerà pur parlare del ruolo anche di responsabilità che possono avere gli immigrati nella politica e nel sindacato. Quando hai 4 milioni di persone che vivono qua il problema della loro rappresentanza prima o dopo dovrai portelo… E dopo c’è proprio il problema di rendere la politica friendly, cioè qualcosa… come dire? E’ poco dire “col sorriso”, tu devi dimostrare che uno che ha voglia e che ha capacità può starci da subito, sentendosi a casa sua… Sembra una perorazione personale, ma io non ho da perorare niente. Personalmente mi reputo strasoddisfatto: ho fatto il segretario della Cgil per 20 anni, 8 anni il segretario generale, l’ho fatto senza dover iscrivermi o essere stato iscritto al Partito comunista di allora o al Partito socialista, quindi ho affermato l’idea che si potesse farlo, sono andato via nel modo che ho voluto, sono stato in sindacato per il tempo che mi era stato concesso, mi sono presentato alle elezioni del Consiglio comunale e ho ricevuto un consenso consistente, significativo nel momento in cui i numeri sono quelli che dicevo prima, 1436 preferenze e il secondo dell’Ulivo ne prende meno della metà. Non è un problema personale. E’ che mi domando quante altre persone si dovranno allontanare perché non riescono a stare in questo tipo di competizione. Nessuno mi ha chiesto di avere una responsabilità per il gruppo dell’Ulivo, anzi, l’unica cosa di cui erano assolutamente convinti Ds e Margherita insieme era che il capogruppo non lo potevo fare io. Uno dice: “Ma scusa, a ridosso del Pd, perché?”… Questo ti dice le difficoltà che ancora noi troveremo. Quindi la vera cifra dell’innovazione, anche se può sembrare blasfemo per i vecchi ortodossi della politica, non è il programma politico del Pd, ma il suo comportamento politico e organizzativo. non siamo in America che eleggiamo presidente e vice. Perché il vice e perché della Margherita? Dico due debolezze della candidatura di Veltroni: non siamo in America dove si elegge il presidente e il suo vice. Perché il vice e perché della Margherita? E perché non doveva essere possibile che alla fine del percorso, se si candida, per esempio, Rosi Bindi, e prende il 40% il vice segretario non lo potesse fare lei? Prima questione, che non è banale… La gente dall’esterno l’avrà visto come un accordo “inter loro”, un segnale di “tutto deciso”… Esattamente. La seconda questione: che senso ha dire di essere d’accordo col referendum, ma di non poter firmare per non creare problemi al governo? Se sei d’accordo firmi. Perché se no domani ci spiegherai che siccome la sinistra radicale ha potuto mettere in difficoltà il governo siamo di nuovo ai pasticci della politica. Ha ragione Bersani quando dice che vorrebbe un partito di combattimento e non di parata. Lì c’è il grande effetto mediatico, televisione, Lingotto, il leggio trasparente…, tutto bello, hai dietro molte cose che sono condivisibili, però il primo messaggio pratico è stato ambiguo… Voglio proprio vederli i 2.460 delegati quando sarà finita la corsa. Si vedrà come sono stati fatti. I segretari regionali devono essere eletti il 14 di ottobre: secondo te, c’è qualcuno che può ambire alla carica di segretario regionale fuori dalle attuali nomenclature di Margherita o Ds? Partendo l’11 luglio per presentarsi il 14 di ottobre con 1.500 firme? Ma ti dico un’altra cosa che uscirà da queste regole: finiremo per votare con la legge elettorale che noi vogliamo abolire col referendum, perché siccome non ci sono le preferenze e il voto è proporzionale, la posizione in lista è decisiva per essere eletti. Noi abbiamo proposto, detto e scritto che la posizione in lista deve essere decisa attraverso una costruzione democratica delle liste, se serve con le primarie di collegio. Se a decidere l’ordine della liste saranno i partiti a tavolino con le associazioni siamo nelle stesse condizioni della legge elettorale che vogliamo abolire. Se togli le preferenze, come ha fatto la Regione Toscana, devi rendere obbligatorie le primarie. Questo dice la democrazia, se no un cittadino si troverà in lista qualche nome, più o meno conosciuto, che si è prestato a fare l’indipendente. Torniamo agli indipendenti non più del Pci, ma del Pd. In questo modo per cambiare una classe dirigente dovrai smaltirla per morte naturale… In due parole cosa dev’essere per te la sinistra? Penso a una sinistra, che, per dirla con il nostro sempre amato vecchietto Foa, creda, a differenza della destra, che la felicità tua non può essere un fatto privato, non può essere disgiunta anche da quelle degli altri… Tutto qui. UNA CITTA’ 5 buone pratiche di cittadinanza LA TV DI STRADA La storia di un’associazione, Anelli Mancanti, che vive quasi esclusivamente grazie alla generosità dei volontari e degli immigrati che da ‘utenti’ si trasformano presto in soggetti attivi, tenendo corsi e partecipando alle varie iniziative. L’esperienza della telestreet e quella di un torneo di calcio multiculturale nato al parco delle Cascine, con alcune squadre improvvisate... Intervista a Silvia, Marco, Giorgios, Costanza. Anelli Mancanti (www.anellimancanti.it) è un’associazione di Firenze che offre vari servizi gratuiti a cittadini italiani e a migranti, svolti da operatori e mediatori culturali per promuovere la cultura multietnica. In particolare vengono svolte attività di accoglienza, orientamento al lavoro e assistenza legale. Silvia, Marco, Giorgios, Costanza sono volontari e si occupano delle varie attività dell’associazione. La vostra associazione ha molte attività tutte rivolte alle questioni dell’immigrazione. Come volontari spesso vengono coinvolti gli stessi ragazzi immigrati, potete spiegarci la ragione di questa affezione? Silvia. E’vero, molti ragazzi immigrati, passata la fase del bisogno, rimangono a fare qualcosa con l’associazione -e anche i volontari si fermano a lungo. Forse dipende dalla convivialità, che è una peculiarità dell’associazione: oltre a lavorare assieme, facciamo cene, feste… Credo che anche la scelta di responsabilizzare le persone giochi un ruolo importante. Infatti a chi viene da noi, alla seconda o terza volta, vengono affidate delle cose da fare in modo che possa sentirsi riconosciuto, parte attiva del gruppo. Cerchiamo di non fare del mero assistenzialismo, piuttosto offriamo la possibilità di conoscere altre persone, di scambiare esperienze, di fare amicizia. E poi ci sono le varie attività pratiche: insegniamo la fotografia, l’informatica, le altre lingue o come fare un giornale. Generalmente non si pensa che queste cose possano interessare o fare parte del bagaglio di conoscenze di un ragazzo immigrato, ma è una visione miope: perché non dovrebbe aver voglia di imparare le tecniche di ripresa e montaggio? Anche perché posso dire per esperienza che questi ragazzi hanno molte più risorse di quanto in genere siamo indotti a credere. Senza voler fare della retorica posso dire che per i lo scorso anno era un mio allievo al corso di italiano, quest’anno io sono l’allieva nel suo corso di spagnolo... bisogni primari riescono a cavarsela molto bene, meglio dei loro colleghi italiani. Le difficoltà riguardano l’inserimento e appunto la possibilità di allargare i propri orizzonti conoscitivi. C’è una grossa difficoltà a fare amicizia fuori dal proprio gruppo, che in genere coincide con quello del paese di provenienza. Se ci pensi, ciascuno di noi ha voglia di uscire con persone nuove, di imparare, di fare foto, di scrivere. I loro desideri sono molto simili a quelli dei loro coetanei italiani. Hanno bisogno di sentirsi meno soli. Molti hanno voglia di imparare e cercano le occasioni per uscire dal loro ambiente che finisce per offrire sempre le stesse cose. Forse in questo modo riescono ad acquistare anche una cittadinanza consapevole, o come si dice oggi, attiva. Tante associazioni si adoperano in attività di sostegno per i documenti, la consulenza legale o magari dando indicazioni su posti di lavoro e contratti: questi servizi non portano necessariamente ad uno scambio con le persone, è il classico rapporto servizio-utente. Anche noi abbiamo lo sportello legale, ma i nostri sforzi si allargano anche verso ambiti, diciamo, insoliti che però aiutano i tentativi di integrazione. L’intuizione e la sfida per l’associazione è quella di coinvolgere attivamente chi viene qui. E’così che finito il corso di lingua molti decidono di rimanere per partecipare e organizzare altre attività. Per dire, abbiamo iniziato facendo i corsi di lingua italiana per stranieri e oggi ci sono anche corsi di arabo, francese, spagnolo tenuti dalle stesse persone che frequentavano i corsi di italiano. Alcuni ragazzi che venivano a fare il corso avanzato si sono infatti proposti di insegnare la loro lingua madre; conoscendo bene l’italiano avevano questo vantaggio di poter insegnare a loro volta. Costanza. Ad esempio, il corso di spagnolo è tenuto da un signore che in Cile era professore di biologia e qui in Italia si mantiene, ormai da qualche anno, facendo le pulizie. Lo scorso anno era un allievo del corso di italiano tenuto da me e quest’anno io sono l’allieva del suo corso di spagnolo. Un’altra ragazza del Togo, oltre a redigere il giornale dell’associazione, insegna francese... Silvia. E’ così: oggi, oltre agli stranieri, vengono italiani che per pochi soldi possono imparare una lingua; allo stesso modo alcuni ragazzi decidono di imparare una terza lingua ancora: si aprono varie possibilità. Questo permette poi di fare amicizia perché si creano i legami classici di qualsiasi corso, ma in un contesto diverso: difficilmente le stesse persone in ambienti neutri riuscirebbero ad allacciare nuove relazioni. Anche le feste che vengono organizzate sono un modo per trasmettere questa atmosfera di convivialità e accoglienza. E’ un clima che coinvolge anche chi qui ci lavora. I volontari all’inizio vengono con l’idea di fare due ore alla settimana o di concentrarsi in qualche attività, però poi ti accorgi che finiscono per organizzare delle cose magari non previste, oppure si trovano coinvolti nelle attività più disparate, la “telestreet” o il torneo di calcio. Giorgios. Io vengo dalla Grecia e mentre frequentavo la scuola di italiano ho deciso di iscrivermi anche al corso di fotografia, così da rendere più sopportabile la mia permanenza in Italia, visto che non conoscevo molte persone; ora sono qui da più di un anno e faccio parte della redazione della tv di Anelli Mancanti… Come arrivano i ragazzi immigrati alla vostra associazione? Marco. I ragazzi della scuola di italiano arrivano per passaparola; tra di loro si dicono: “Guarda che c’è una scuola dove puoi imparare l’italiano a 5 euro”. Qualcun altro arriva grazie ad altre associazioni che conoscono la nostra attività; altri leggono di noi su Fuori Binario -il giornale di stradae vengono per chiedere assistenza legale riguardo Almanacco delle buone pratiche di cittadinanza 2006 il mutualismo di ieri e di oggi - il dilemma: cittadini o utenti? - le “dame” nelle corsie d’ospedale - il diritto all’autobiografia - il malato cittadino - quella palestra dove giovani delinquenti son diventati campioni... - il circuito virtuoso del recupero delle rimanenze dei grandi magazzini - parlare della malattia non guarisce ma fa bene - quel paternalismo fatale dell’istituzione verso le donne in difficoltà - la libertà che è nelle relazioni, nel legame - aprire dei bar invece che dei centri di salute mentale? - e poi le storie di ieri che ancora, forse, ci possono insegnare qualcosa... 288 pagine di interviste e foto, edizioni Una Città 18 euro - 15 per gli abbonati (spese di spedizione comprese). Per richiederlo: 0543.21422 [email protected] 6 UNA CITTA’ i documenti; o si rivolgono allo sportello di accoglienza che dà una serie di indicazioni pratiche riguardo le docce pubbliche, le mense sociali, dove trovare dei vestiti o un alloggio temporaneo. A volte diamo una mano per fare il curriculum, gli indichiamo dove rivolgersi per un lavoro. Il contatto avviene in questi modi. Costanza. Facciamo anche un piccolo giornale, che facilmente arriva nelle mani dei conoscenti o delle comunità di chi frequenta la scuola; inoltre lo diffondiamo nel quartiere dove abbiamo la sede. Viene preparato dai volontari e dagli stessi migranti che si preoccupano di fare le traduzioni degli articoli più importanti, infatti pubblichiamo in arabo, albanese, russo, francese, spagnolo. Non tutti riescono a leggere bene l’italiano. C’è un laboratorio di giornalismo e chiunque può proporre un’idea, un tema o una rubrica, poi ne discutiamo tutti insieme per vedere se c’è la possibilità di pubblicarlo. con la tv ci piacerebbe far crescere un senso di appartenenza e anche di responsabilità tra gli abitanti Prestiamo attenzione sia alle questioni locali che a quelle cosiddette globali; trattiamo una serie di questioni legate all’immigrazione e allo scambio interculturale: una ragazza albanese cura una rubrica dove racconta le storie di personaggi della cultura o dello spettacolo albanese, del tutto sconosciuti qui in Italia. Una ragazza peruviana, molto brava a disegnare, si occupa della parte grafica. Abbiamo parlato della situazione dei somali che lo scorso anno avevano occupato una casa. Usciamo in maniera irregolare per via delle risorse limitate, ma non pretendiamo di essere giornalisti. Come siete organizzati per mandare avanti le varie attività, come vi finanziate? Marco. Sono le attività stesse che strutturano l’organizzazione, questa viene da sé: man mano che si va avanti ti accorgi che da una situazione aperta (anche se di veramente improvvisato non c’è niente) si arriva a una qualche forma, a una qualche struttura. Nelle varie attività sono coinvolte circa duecento persone e siamo una trentina di volontari. Non c’è una gerarchia precisa, le mansioni di coordinamento e raccordo sono molto flessibili e la gestione risulta molto più vivace; la riunione periodica dei responsabili delle varie attività assicura che la visione e i fini dell’associazione siano rispettati. Le persone che vengono qua ad imparare l’italiano pagano 5 euro al mese che è un prezzo simbolico, questo evidentemente non ci permette neanche di coprire l’affitto della struttura. Se passa un progetto, con i pochi soldi che ci arrivano possiamo permetterci l’acquisto di qualche attrezzatura, ad esempio una telecamera più funzionale, un computer più potente, ma fondamentalmente sono i volontari che ci danno una mano. Non è con i progetti che sopravviviamo, anche perché, nelle dinamiche dei poteri locali, non siamo appetibili. Non “interessiamo”, non siamo granché spendibili in termini di rientro per i partiti, che so, di immagine, di interesse elettorale. Comunque ce la facciamo. Silvia. Quello che funziona con Anelli Mancanti è che quando si individua l’idea si parte, facendo le cose anche senza avere fondi. Le attività poi vengono portate avanti di anno in anno grazie all’impegno dei volontari che vengono qua e si spendono. Marco. E’stato sempre così. In fondo la nostra storia inizia nel 1997, in un’altra struttura, un ex-cantiere dove erano presenti alcune baracche che sono state occupate e rimesse a posto da alcuni di noi facendo poi una vertenza con il Comune per ottenere l’agibilità. Tra le varie iniziative, fate anche la televisione di strada, di che cosa si tratta? Marco. Storicamente le street tv nascono a Bologna, il retroterra infatti è quello delle radio libere. L’obiettivo all’epoca era quello di interrompere il monopolio e quindi guadagnare spazi di libertà. La nostra telestreet adesso ha circa due anni e mezzo e si pone gli stessi scopi. Noi siamo partiti sfruttando la trasmissione nei cosiddetti coni d’ombra. In pratica nelle frequenze di proprietà esistono degli spazi che in determinate zone non sono utilizzati, per varie ragioni. Ad esempio noi trasmettiamo occupando le frequenze di una emittente di Prato il cui segnale qui non arriva e perciò il suo spazio di frequenza non viene coperto dalle sue trasmissioni. Ogni telestreet sceglie cosa programmare in base alla storia e alle esigenze del territorio dove opera. Noi che ci occupiamo di immigrazione ci rivolgiamo prevalentemente agli immigrati che vivono in zona, ma non solo, infatti le persone che frequentano la nostra telestreet sono molto eterogenee, c’è chi si occupa di video artistici e qualcun altro che preferisce montare le partite del torneo di calcio multietnico; c’è infine chi documenta invece i cambiamenti del quartiere… Giorgios. In tutto siamo una decina, ma il numero è variabile, succede che una persona va via per due mesi poi ritorna e riprende il discorso che stava portando avanti, in questo c’è una grande libertà di azione che a noi va bene: rende molto fluida la creazione e la produzione di idee. In genere non c’è una “linea”, chi frequenta la redazione è parte dell’associazione e quindi c’è una visione comune delle cose che nasce dalla condivisione delle varie attività. Il torneo di calcio è stato l’oggetto della prima trasmissione realizzata da Anelli Mancanti tv dopo il corso di tecnica che avevamo organizzato. Marco. La parte più difficile rimane la realizzazione e la redazione di quello che giriamo. E’ un’attività che comporta una certa costanza e molto tempo, infatti per passare dalla ripresa alla messa su dvd occorre parecchio lavoro e appunto una certa regolarità, e nei gruppi di volontariato è molto difficile mantenere questa continuità nell’impegno. All’interno della tv nessuno di noi copre una professionalità in modo specifico: il video-artista che realizza il suo progetto è anche quello che poi monta i filmati, chi come me organizza la programmazione magari va insieme ai ragazzi camerunensi a fare i documenti per il torneo, i ruoli sono assolutamente intercambiabili. L’idea della tv di quartiere è iniziata con il corso di fotografia; c’era la voglia da parte di alcuni di approfondire e si è andati avanti imparando tecniche più sofisticate come l’uso dell’immagine, le tecniche di ripresa e montaggio, la post-produzione. Quello che avevamo imparato lo abbiamo applicato alla prima occasione che è stata appunto la prima edizione del torneo di calcio. All’epoca disponevamo di una tecnologia “rudimentale”, salivamo su un tetto per collegare l’antenna ad un trasmettitore con 0.5 watt di potenza, arrivavamo ad una distanza di 400 metri, cioè quasi tutta la via dove ci troviamo. La difficoltà di trasmettere con una frequenza settimanale ci ha fatto riflettere sul fatto che la televisione di “strada” ha una funzione di animazione culturale piuttosto che di intrattenimento. Anche adesso -viste le difficoltà di produrre materiali video con regolarità- preferiamo trasmettere per eventi: quando abbiamo del materiale pronto diffondiamo la notizia che quella sera andremo in onda; informiamo le persone del quartiere con i volantini e anche con il megafono per avvertire che “fra tot minuti si va in onda”; se le persone sono anziane magari saliamo noi in casa per aiutarli a sintonizzare il televisore. Il quartiere è coinvolto in questa cosa, si sente partecipe? Giorgios. L’idea di una telestreet è quella di far vedere alle persone qualcosa che li riguarda direttamente. Quando organizziamo la festa nel quartiere mettiamo uno schermo in piazza e tutti possono rivedere il lavoro di tutto l’anno. Di solito le persone si mostrano interessate a condividere la visione di qualcosa che li riguarda, noi riscontriamo una disponibilità a partecipare. In quelle occasioni poi si crea un’atmosfera stile anni ’50, quando la gente si riuniva nei bar per vedere la televisione. Per quanto riguarda Anelli Mancanti tv, l’idea è quella di non ingrandirci, la nostra ambizione è costruire un rapporto stretto con questa strada e con il quartiere, preferiamo trasmettere per questa piccola zona; ci piacerebbe far crescere un senso di appartenenza e anche di responsabilità tra gli abitanti rispetto al luogo in cui abitano. Considera che questa via è abitata da gruppi di persone molto diverse tra loro: i vecchi residenti, gli americani, i giapponesi, i somali, i sudamericani... Marco. Crediamo che la televisione -l’immagine in generale- sia uno degli strumenti più potenti della società contemporanea. Come laboratorio di produzione, la tv di strada di Anelli Mancanti è soprattutto un luogo di trasferimento e diffusione di conoscenze, tecniche e non solo; si tratta di mettere tutti i partecipanti nella condizione di una relativa autonomia espressiva riguardo al mezzo. Il storie di ragazzi nostro obiettivo essenzialmente è quello di moltiplicare le energie creative, e far circolare le competenze tecniche, soprattutto tra i ragazzi. Abbiamo realizzato alcune piccole produzioni a partire dalle storie dei ragazzi che frequentano la scuola. Lo scorso anno abbiamo progettato la formazione di un gruppo di immigrati per quanto riguarda l’uso della comunicazione video e della telecamera oltre che del montaggio per realizzare un cinegiornale. Siete stati promotori e organizzatori del torneo di calcio “Mondi Aperti”. Puoi raccontare? Marco. Qui a Firenze c’è un grosso parco, le Cascine, che da qualche anno è diventato luogo di incontro, oltre che per i fiorentini, anche per intere comunità di immigrati, soprattutto la domenica. Qui ad esempio si riuniscono molti sudamericani per pranzare insieme e ascoltare musica, e non mancano i problemi di ordine pubblico. Comunque la presenza di questi grossi prati ha fatto sì che con le belle giornate le diverse comunità abbiano iniziato a organizzare delle partite di pallone per conto loro. Partite del tutto informali come succede da qualsiasi parte. Mano a mano è successo che queste squadre improvvisate hanno iniziato a sfidarsi tra di loro, che so la comunità marocchina con quella senegalese, i peruviani con gli albanesi. L’agonismo, il divertimento e quindi anche lo spettacolo erano così coinvolgenti che molte persone venute a passeggiare si fermavano a guardare fino a che molti avevano iniziato a venire apposta in quelle ore domenicali per vedere le partite. L’idea era già lì. Molti ragazzi che frequentano gli Anelli ci raccontavano di queste partite e ad un certo punto ci hanno proposto di organizzare un vero e proprio torneo. La prima edizione del campionato multietnico è nata così, senza un soldo, senza un campo, senza niente. Abbiamo organizzato una prima edizione nel 2002; noi abbiamo fornito il minimo indispensabile: le magliette, i pantaloncini e l’affitto del campo di calcio; i ragazzi invece si sono pagati le analisi mediche. La prima volta hanno partecipato otto squadre, poi visto il successo -che non ci aspettavamo -la richiesta è raddoppiata e per far fronte e mantenere questa iniziativa che ci sembrava molto importante abbiamo ottenuto un piccolo finanziamento dagli enti locali come la Provincia, assieme alla concessione di uno spazio adeguato dove poter fare il torneo. Addirittura lo scorso anno è stato fatto a Coverciano -dove si allena la nazionale! Ad ogni edizione siamo riusciti a migliorare un po’, e ora il torneo viene disputato con le divise ufficiali delle rispettive nazionalità. Lo scorso anno hanno partecipato tredici nazionalità diverse, cioè tredici comunità immigrate presenti sul territorio fiorentino come il Marocco, il Camerun, l’Albania, la Romania, la Turchia, la Cina, il Perù, lo Sri Lanka, ecc.; il Senegal è stato il vincitore delle prime due edizioni. La squadra degli Anelli Mancanti, che pure partecipa, non ne ha vinta una, anzi ha subito più gol di tutti gli altri. Le squadre poi si ritrovano insieme ed è un’ottima esperienza che permette la nascita di relazioni e amicizie che in altri contesti sono più difficili. la squadra della Cina ci ha fatto dono di un drago che apriva la sfilata come augurio e portafortuna La giornata inaugurale faceva impressione per la cura dei dettagli con cui le squadre si erano preparate: ogni nazionalità faceva sfilare i suoi giocatori con la maglia ufficiale, la mascotte in testa e la bandiera nazionale, poi il tifo al seguito, gli inni nazionali… La squadra della Cina ci ha fatto dono di un drago che apriva la sfilata d’inizio come augurio e portafortuna. Ora, visto il successo dell’iniziativa, c’è l’idea di far nascere una polisportiva dell’associazione con l’obiettivo di unire, grazie allo sport, persone di ogni nazionalità, religione e colore. E’ un torneo molto rappresentativo delle comunità che vivono e lavorano qui a Firenze. Vorrei aggiungere che spesso si presentano occasioni inattese: ad esempio, ora con l’associazione vorremmo mettere in piedi una squadra di cricket, dato che la comunità cingalese ci ha invitato al torneo che organizza ogni anno. Questo dà l’idea di quanto siano ricche e vitali le comunità al loro interno. Il rischio, anche come volontari, è quello di voler vedere solo i loro problemi o le difficoltà di vita a cui vanno incontro, ma non c’è solo questo. Parliamo di persone che comunque riescono ad organizzarsi e a ricreare spazi di relazione che a noi italiani rimangono invisibili. ORA LAVORO DA PLATTI... La vita, semplice, in un paesino dell’Afghanistan e poi il padre che un giorno ti abbraccia e ti dice che devi andare via e quindi l’avventuroso viaggio attraverso il Pachistan, l’Iran, la Turchia e poi il Mediterraneo fino ad arrivare alle coste della Calabria... Intervista a Sadegh. Sadegh, afgano, 23 anni, in Italia da quattro anni, è fuggito dal suo paese per evitare di essere arruolato nelle milizie talebane. Ha attraversato il Pakistan, l’Iran, la Turchia e il Mediterraneo per approdare, infine, sulle coste della Calabria. Oggi lavora come pasticcere in uno dei caffè più antichi del centro di Torino. In Afghanistan, prima di partire, la mia vita era molto semplice. Andavo a scuola e quando tornavo aiutavo i miei genitori. Qualche volta giocavo con gli amici. Vivevo in un paesino, non era proprio una città, era un piccolo paese di contadini. Un bellissimo posto. Avevamo tanta frutta, non compravamo cose da fuori, veniva tutto dalla terra. Compravamo solo la benzina. Avevamo una vita tranquilla, finché purtroppo sono arrivati i talebani e hanno rovinato tutto. La cittadina in cui abitavo si trova nel nord dell’Afghanistan, nella zona dove vive la popolazione di etnia hazara. Io stesso sono hazara. Quel giorno avevo 14 anni, dopo mangiato, è venuto un mio amico e siamo andati a giocare a pallavolo. Quando sono rientrato con il pallone, mio papà mi ha abbracciato: “Guarda Sadegh, io e tua mamma abbiamo deciso che devi andare via”. Era arrivata la notizia che i talebani sarebbero entrati nella nostra zona arrivando dai territori pashtun. I pashtun erano insieme ai talebani a quell’epoca, e io vivevo proprio vicino ai confini con i pashtun. I talebani prendevano i ragazzi giovani e li arruolavano portandoli a combattere contro la nostra stessa gente. Mio padre mi ha dato dei soldi e mi ha detto che li dovevo legare intorno ai polpacci. L’indomani, la mattina molto presto, ho salutato mia madre. Mio padre mi ha accompagnato per un’ora poi è tornato indietro e ho proseguito da solo. Ho camminato per quasi dodici ore. Dovevo passare una montagna molto alta, molto brutta, ed ero preoccupato, pensavo che sicuramente avrei incontrato qualche animale. Avevo paura. Superata la montagna mi sono fermato a fianco di una pietra a passare la notte. Ho mangiato gli ultimi panini che mi ero portato dietro. La mattina dopo sono rimasto lì dove avevo dormito e ho cercato di farmi caricare su un camion. Aspettavo che ne passasse uno, lo fermavo e gli chiedevo di portarmi a Kandahar. Alla fine un camionista mi ha preso, mi ha fatto salire e mi ha portato a Kandahar. Gli ho spiegato la mia situazione, le mie difficoltà, e sono stato fortunato perché mi ha aiutato un po’. Quando siamo arrivati a Kandahar mi ha trovato un taxi. Sono rimasto sette ore chiuso dentro quel taxi perché il proprietario doveva trovare altri passeggeri prima di partire. Mi diceva che se volevo potevo pagare da solo per quattro persone e saremmo partiti subito, ma io non avevo abbastanza denaro, avevo anche dato un po’ di soldi al camionista. Io aspettavo in macchina, perché eravamo in una zona talebana e a guardarmi in faccia si capisce subito che sono hazara. Di faccia siamo molto diversi da loro, siamo simili a quelli che vengono dalla Mongolia. Faceva caldo, molto caldo. Quando ha trovato qualche altro passeggero siamo partiti, diretti verso il Pakistan. Passato il confine, sono arrivato dopo diverse ore nella città di Quetta. Ho parlato con il taxista e gli ho detto che i soldi per pagare non li avevo, ma potevo dargli l’orologio. Lui ha accettato. Mi ha portato in un hotel gestito da afghani. I pochi soldi che avevo li usavo per pagarmi da dormire, e quasi non mangiavo. Poi un giorno sono andato a parlare dal proprietario dell’hotel, a spiegare la mia situazione, a dirgli che ero in difficoltà, che cercavo lavoro. Lui mi ha detto che di lavoro non ne aveva ma conosceva una persona che cercava un ragazzo. Dopo tre o quattro giorni mi ha portato in quel posto, era una pasticceria, e mi hanno preso a lavorare lì. Io lavoravo e loro mi davano da mangiare, altro non avevo. Non avevo neppure un orario fisso, lavoravo tutta la giornata. Un giorno mi sono anche scottato, la pentola era troppo grande, piena di acqua bollente, non sono riuscito a sollevarla e mi sono scottato questa parte del corpo. Mi lasciavano dormire lì dove lavoravo. Ogni tanto mi davano un po’ di soldi. Sono rimasto due anni a lavorare così. Nel frattempo ero riuscito a mettermi in contatto con mio papà. Il mio padrone dava la lettera a quelli dell’hotel, se qualcuno andava in Afghanistan se la portava dietro e cercava di consegnarla ai miei genitori o a della gente che abitava nella mia zona. Così raccontai a mio padre come stavo, cosa facevo, e lui mi scrisse cosa stava succedendo nel mio paese. Finché non è arrivata una lettera che diceva che sarebbe arrivata una persona a cercarmi e io sarei dovuto andare con lui. Avrei dovuto seguire quella persona senza lasciarla mai. Un giorno questa persona è arrivata, mi ha preso e portato in Iran. Siamo andati fino al confine e poi l’abbiamo superato a piedi, nel deserto. Quella persona aveva dei soldi e quando prendeva da mangiare pagava anche per me. Abbiamo camminato fino a una città molto bella dell’Iran, nella regione del Baluchistan. Sono rimasto dieci giorni in Iran. La persona che mi aveva portato non esisteva più, mi aveva consegnato ad altre persone, iraniani. Io un poco di quello che dicevano lo capivo, anche noi hazara parliamo persiano, ma loro usavano il dialetto e non potevo capire proprio bene. Mi hanno preso e portato in Turchia. In Turchia sono rimasto tre giorni ad aspettare in una stalla. Eravamo tantissime persone, forse quaranta, quarantacinque. Afghani, del bangladesh, iraniani, arabi, indiani... Da una parte c’eravamo noi e dall’altra c’erano gli animali, pecore, capre, mucche. Era buio, la stalla non aveva neanche una finestra. Ogni ventiquattro ore ci davano un pezzo di pane, non di più, e un bicchiere d’acqua. Dopo tre giorni è venuta una persona e ha scelto alcuni di noi: degli afghani, degli indiani, dei pakistani e degli iracheni. Ci ha fatti salire su un camion. Dopo ventiquattro ore o qualcosa di più eravamo su una nave, diretti verso la Calabria. La notte in cui siamo arrivati era molto buio e non si vedeva nessuno. La nave si era fermata lontano dalla costa e quello che guidava la nave era sparito. Era fuggito via su un’altra piccola nave. Ci aveva lasciato lì, non troppo lontano dalla costa. C’eravamo solo noi quella mattina sulla nave, e ognuno piano piano prendeva coraggio e si buttava in acqua. Mi sono buttato anch’io. C’era tanta, tantissima acqua, ed ero molto preoccupato. Devo ringraziare un ragazzo curdo che mi ha preso e mi ha portato fino alla riva. Siamo rimasti sulla spiaggia, non sapevamo cosa fare. Dopo un po’ qualcuno è andato in direzione del paese. La polizia lo ha visto, lo ha preso e gli ha chiesto da dove veniva, lui ha detto che veniva dalla Turchia, che era arrivata una nave, e li ha portati da noi. Così la polizia ci ha presi tutti quanti e ci ha portati in un campo di militari. A Crotone. La polizia italiana si è comportata bene, veramente. Io ho conosciuto la polizia pakistana, quella iraniana... erano molto diverse, picchiavano. Gli italiani invece si sono comportati bene. Non capivo niente di quello che dicevano, capivamo solo quando facevano il segno dell’ok con il pollice alzato. Siamo andati in un centro di accoglienza, ci hanno dato da mangiare, da bere, e ci siamo potuti fare una doccia. Dormivamo in container attrezzati con letto e tutto, ognuno per quattro persone. E poi il cibo veniva da fuori, pranzo, colazione e cena. Da quando ero partito dal Pakistan non avevo mai mangiato per bene. Ogni ventiquattro ore un pezzo di pane, quello era il nostro cibo. Sono rimasto due mesi lì, a Crotone. I tre amici afghani che erano venuti con me dalla Turchia se ne sono andati in Inghilterra. Io invece sono rimasto in Italia perché ero minorenne. Se no, in verità, sarei andavo dove andavano gli amici, perché ero da solo e guardavo a loro, vedevo dove andavano e li seguivo. Ma ero minorenne e mi è stato detto: tu non puoi andare, non sei neanche responsabile, e allora ho risposto va bene, resto qua. Dopo due mesi mi hanno mandato vicino a Macerata, dove sono rimasto un anno. Stavamo in un hotel, anche lì ci davano da mangiare. Era una comunità gestita da un gruppo umanitario che si chiama Gus. Eravamo tanti ragazzi, tutti minorenni. L’hotel era molto lontano dalla città, in montagna. Ognuno parlava la sua lingua e c’era anche qualche afghano. Le educatrici ogni giorno ci facevano un’ora di lezione per insegnarci l’italiano. Per il resto stavo lì, non facevo niente. Aspettavo che mi chiamassero per fare un’intervista a Roma, per ottenere il permesso di soggiorno. Chiedevo sempre quando mi avrebbero chiamato per fare l’intervista e loro rispondevano che bisognava aspettare una lettera da Roma. Dopo un anno mi hanno mandato in un’altra comunità vicino a Torino, a Cuorgné. Purtroppo anche quella comunità era in montagna. Era tranquilla, non c’era nessuno, c’eravamo solo noi e non avevamo il permesso di uscire, neppure di giorno. Sono rimasto un anno a Cuorgné finché finalmente è arrivata la lettera da Roma. E sono andato a fare l’intervista. Parlavo ancora molto poco l’italiano e per l’intervista c’era una traduzione in persiano. Mi facevano delle domande e io rispondevo. Mi hanno chiesto se avevo dei documenti afghani, e io ho detto che non li avevo così come non li aveva mai avuti mio padre, perché in Afghanistan non c’è uno stato, non c’è un’anagrafe che ti dà queste cose. Allora mi hanno fatto tante domande sull’Afghanistan, chi erano i talebani, chi era il presidente, chi c’era nella mia zona, e io ho dato le risposte che sapevo per dimostrare che ero davvero afghano. Mi hanno chiesto se ero al corrente di quello che stava succedendo nel mio paese. Ho detto: gli americani, gli italiani, tutti quanti sono andati lì a controllare, a portare la pace. Ho raccontato quello che avevo sentito alla televisione, alla radio, perché qual- cosa capivo. L’intervista è andata bene, ha avuto un esito positivo e mi hanno riconosciuto come rifugiato politico. Così ho potuto lasciare la comunità di Cuorgné. Però non conoscevo nessuno e avevo bisogno di lavorare. C’era un ragazzo dello Sri Lanka che era stato nella comunità con me e quando era uscita la sanatoria era andato a Torino dove aveva degli amici. Avevo il suo numero e l’ho chiamato, gli ho detto che non ero più nella comunità e gli ho chiesto se da lui potevo trovare qualcosa. Lui mi ha detto: “Vieni, non c’è problema”. All’inizio mi sono trovato in difficoltà, ero sempre da solo. Camminavo a lungo da solo, ma non mi piaceva. Poi il ragazzo dello Sri Lanka mi ha portato in un’associazione che si chiama Asai. Mi ha presentato al responsabile, che si chiama Sergio, e a una donna che si chiama Danila e che mi ha aiutato tantissimo. Danila mi ha aiutato a trovare lavoro, mi ci accompagnava persino, mi ha anche portato a casa sua, a conoscere i suoi figli... Lavoravo a Leinì, in una fabbrica di grissini, e vivevo in un dormitorio a Mirafiori. Poi mi hanno mandato in un’altro posto che si chiamava “La città dei ragazzi”. Anche quello era un dormitorio, ma era meglio dell’altro. Poi Danila mi ha presentato a sua mamma e sono andato a vivere con lei. Dalla mamma di Danila mi sentivo come uno di famiglia. Non ero più solo. E ho trovato un altro lavoro, in una pasticceria molto famosa a Torino, che si chiama Platti. A Danila avevo raccontato che avevo lavorato in una pasticceria in Pakistan, così mi ha trovato il posto da Platti, ho fatto un tirocinio di sei mesi e poi sono stato assunto. Ora non vivo più dalla mamma di Danila. Ho trovato una casa in affitto assieme a quel ragazzo dello Sri Lanka. Sono in contatto con altri afghani che vivono qui a Torino. Quando sono arrivato eravamo solo in due, poi ne sono venuti altri e adesso siamo quasi una decina. Conosco le moschee di Torino, so dove sono, a Porta Palazzo, a Porta Nuova, ma non le frequento perché ci sono troppi problemi tra sciiti e sunniti e se vado mi sento rivolgere tante domande, troppe. Io sono sciita, le moschee a Torino sono tutte sunnite. Se io mi comporto secondo ciò che dice la religione sciita, loro fanno tante domande, ci mettiamo a discutere, e va male. Io non capisco loro o loro non capiscono me... Da quando ero partito dal Pakistan non avevo potuto comunicare con la mia famiglia. A Torino ero in collegamento telefonico con quei ragazzi che stavano con me a Crotone e adesso sono in Inghilterra. Qualcuno aveva il passaporto e andava in Afghanistan così potevano portarmi delle notizie. Un giorno mi ha chiamato un amico da Berlino e mi ha detto che i miei genitori erano emigrati in Iran. Così ho potuto raggiungerli per telefono. L’anno scorso sono riuscito persino ad andare a trovarli. A Roma, dopo l’intervista, mi hanno dato dei documenti che funzionano come un passaporto. Non posso andare in Afghanistan, però posso visitare altri paesi. Questo finché non prendo la cittadinanza. Così l’anno scorso ho incontrato la mia famiglia in Iran. Quando sono arrivato non sapevo neanche che mio padre era morto. L’ho scoperto così, dopo tanti anni che non l’avevo visto. Ci sono rimasto malissimo, è stato un grande dolore. Ho visto mia mamma, le mie sorelle, i miei fratelli. La mamma diceva che non bisognava uscire tanto perché prendono gli afghani e li rimandano in Afghanistan. Io avevo tutto, i documenti italiani, il permesso di soggiorno, il visto dell’Iran, ma lei diceva che mi avrebbero preso lo stesso e mi avrebbero portato in questura. Così non uscivo volentieri, ero preoccupato a girare per strada. Ogni mese mando dei soldi alla mia famiglia. Loro non fanno niente in Iran. Quando c’era mio padre lui lavorava, ma ora mia madre non lavora e così le mie sorelle. Fino a poco tempo fa non avevano neppure il permesso di soggiorno, non li prendevano a scuola e stavano tutti a casa. Meno male che posso mandare cento euro al mese e là con cento euro si vive. E meno male che il nuovo governo ha dato il permesso di soggiorno a tutti gli afghani, così due mie sorelle hanno ricominciato ad andare a scuola. I miei fratelli sono ancora troppo piccoli. Ho chiesto a mia mamma se vuole venire in Italia, ma lei non è d’accordo. Ha detto che stanno bene là e che vogliono tornare in Afghanistan appena sarà possibile. Anche io prima o poi voglio tornare a vivere nel mio paese. Ma qui in Italia sento che sto costruendo un futuro migliore. Volevo un lavoro in pasticceria e già l’ho trovato. Vivo in un sogno, imparo un mestiere molto buono e per me questo è incredibile. Quando ero in Afghanistan non avevo prospettive di imparare una professione del genere. Ogni giorno dopo la scuola tornavo a casa ad aiutare mio papà, a fare il contadino. UNA CITTA’ 7 problemi di lavoro IL VALORE AGGIUNTO DELLA PARTITA IVA Il lavoro autonomo, pena anche l’uso di categorie obsolete, resta ‘invisibile’ nella sua specificità. Oggi la vulnerabilità non riguarda più gli ‘ultimi’, ma una parte consistente della società. L’autonomo è disposto a uno scambio tra l’ansia dell’incertezza e la possibilità di determinare le proprie scelte, il dipendente no. Gli enti minaccianti: ordini e università. Un dialogo tra Sergio Bevilacqua e Pietro Lembi. Sergio Bevilacqua si occupa di politiche del lavoro, svolge attività di counselling professionale ed è stato per molti anni un lavoratore autonomo. Pietro Lembi, architetto, si occupa di politiche urbane e sociali e collabora con il Laboratorio di Politiche Sociali del Politecnico di Milano. Il confronto che segue è stato raccolto nell’ambito di una ricerca sul nuovo lavoro autonomo condotta dal Laboratorio di Politiche Sociali (coordinato da Costanzo Ranci) assieme all’Osservatorio sui Ceti Medi coordinato da Arnaldo Bagnasco. Pietro Lembi. In questi anni abbiamo condotto una serie di indagini sui fattori di rischio e sulla vulnerabilità; abbiamo studiato il modo in cui abitazione, cura, lavoro, regolazione e protezione sociale si intrecciano e influiscono nelle vite di tipologie familiari diverse: coppie bilavoro con figli piccoli, famiglie con anziani a carico, famiglie con sfratto in quartieri degradati. Ecco, quello che emerge è che la vulnerabilità non riguarda i cosiddetti “ultimi”, il disagio estremo, ma una parte consistente della società che oggi sembra presentarsi più fragile ed esposta a fattori di rischio. Abbiamo allora deciso di interrogarci sulle “Partite Iva”, per vedere chi sono, quali valori hanno, che tipo di protezioni ricevono dallo stato, che tipo di protezioni vogliono o non vogliono, come sono rappresentate, ecc. Sono una parte consistente di lavoratori finora quasi per nulla presi in considerazione dalla sociologia, così come dai sindacati e da altri organismi di rappresentanza. Generalmente le rilevazioni ufficiali dividono tra lavoratori dipendenti e indipendenti, e questi sono suddivisi tra imprenditori, liberi professionisti, lavoratori autonomi o “in proprio” e, da alcuni anni, lavoratori a progetto. Ma sappiamo che il nostro oggetto è in parte trasversale a queste definizioni. Sergio Bevilacqua. Le forme di lavoro che escono da questo rigidissimo schema non sono visibili. Pietro. Studiando la letteratura e le banche dati, mi sono reso conto che l’oggetto rimane molto sfuggente, e cambia anche radicalmente a seconda del punto di vista da cui lo si guarda. Aiutami ad inquadrare il problema dal tuo punto di vista, a definire l’oggetto. un lavoratore in cassaintegrazione fino a poco tempo fa per l’Istat era forza lavoro dipendente Mi chiedo per esempio quale sia il confine tra l’informatico co.co.pro. e l’informatico che apre la partita Iva, oppure quello che decide anche di iscriversi alla Camera di Commercio e magari ha pure due o tre persone che lavorano per lui. Sergio. La mia risposta implica un passaggio culturale, la sociologia se vuole districarsi in questa situazione complessa deve confrontarsi con altre discipline. Su questi temi o si ha un approccio diverso dal passato o si rimane imbrigliati nella rigidità. Provo a spiegarmi facendoti un esempio: sai com’era considerato un lavoratore in cassaintegrazione dall’Istat fino a poco tempo fa? Forza lavoro dipendente. Un disoccupato a tutti gli effetti viene considerato dipendente e qual è il motivo di questa strana scelta? Perché risulta ancora in organico all’azienda. Penso che per comprendere e agire sulla realtà si debbano scardinare queste categorie concettuali. La sociologia questo passaggio poderoso l’ha già fatto negli anni ’70, l’hanno fatto Frey, Sylos Labini, Massimo Paci rivisitando le rappresentazioni delle classi sociali. Hanno incominciato a studiare la forza lavoro nascosta, quella che sarebbe andata a lavorare e che l’Istat non considerava col risultato ultimo di abbassare il numero dei disoccupati presenti nel nostro paese. Si sono fatti veri e propri scandagliamenti di un mondo sconosciuto, che stentava ad emergere e che non trovava alcuna forma di rappresentazione culturale e anche politica. Per fare questo è stato necessario definire un approccio culturale basato su riferimenti concettuali che semplicemente non 8 c’erano. Penso che la situazione presenti molte analogie: o ci dotiamo di altre categorie concettuali o certi fenomeni sociali non li vediamo, con il rischio di fare come fa la Cgil, che identifica certe fette di società, come appunto i professionisti delle partite Iva, con gli autonomi, nei confronti dei quali c’è un’unica logora categoria: evasori cioè avversari dei lavoratori dipendenti. Per cambiare questo approccio limitato e riduttivo penso sia necessario un approccio interdisciplinare, in cui la psicologia dialoghi con la sociologia, l’economia con la sociologia. Bisogna riuscire ad evidenziare quali sono i legami tra economia, sociologia e psicologia. Se non vogliamo continuare a ignorare pezzi consistenti della società in cui viviamo è necessario che alcune riflessioni della psicologia sull’identità del lavoratore, la percezione del lavoratore vengano recepite dalla sociologia, dall’economia e dalla politica. Il rischio è che il professionista a partita Iva sia assolutamente invisibile perché non si considera la sua identità professionale, il fatto che questa persona sia particolarmente interessata alla sua autonomia. E non vale il luogo comune per cui tutte le persone che lavorano sarebbero interessate ad una dimensione di autonomia perché ciò che cambia fra un dipendente ed un autonomo è la predisposizione a reggere le ansie generate dall’incertezza legata al lavoro, che può arrivare ma che può anche non esserci, ai pagamenti che tardano mentre costi e tasse sono costanti e certi. L’autonomo è disposto ad uno scambio fra l’ansia legata all’incertezza e la possibilità di determinare le proprie scelte. Il dipendente assolutamente no. La prova è data dalla difficoltà con cui nel pubblico impiego si riesce a far passare il concetto di valutazione delle prestazioni. Con questo non voglio dire che un lavoratore sia più bravo dell’altro, che una scelta sia giusta e l’altra erronea. Semplicemente sono scelte diverse che è bene conoscere ed approfondire dando valore a quelle che portano all’autonomia ed evitando accuratamente luoghi comuni o approcci ideologici come invece si continua a fare. Questo ragionamento sull’identità è un patrimonio della psicologia mentre dal punto di vista sociologico potremmo definire le persone che dimostrano indipendenza rispetto all’organizzazione del lavoro come persone orientate a gestire il proprio compito lavorativo trovando soluzioni autonome. Per l’economia i professionisti producono valore aggiunto utile alle organizzazioni tanto più se orientate ad una logica di flessibilizzazione organizzativa. Questo per dire che nel vocabolario della psicologia, della sociologia e dell’economia ci sono categorie che individuano un elemento comune. Se vogliamo la troviamo anche nel vocabolario della politica: alcuni ceti sociali mirano alla propria autonomia nella gestione di alcuni bisogni, in primis nella gestione del processo decisionale e del proprio tempo. Quindi c’è un modo di definire le caratteristiche del vasto mondo dei professionisti a partita Iva, il problema è la voglia di continuare ad approfondire queste connessioni utilizzando le contaminazioni fra discipline per precisare i contorni di questa parte del mondo del lavoro. Pietro. Questo mi ricorda il concetto di individualizzazione riproposto da Paci, che fa risalire alla fine del Settecento la voglia delle persone di liberarsi dai vincoli dei sistemi tradizionali e sempre di più affermare la propria autonomia come espressione di sé. Tutto ciò secondo me ha a che fare con il ceto medio, con la voglia di esprimersi nel lavoro… Sergio. Penso abbia a che fare con una spinta individuale che ha riguardato anche la classe operaia; in questo caso la spinta individuale è stata incanalata nel partito e nel sindacato. Come mai il sindacato è così ortodosso, privo di una conflittualità interna? Forse -e so di dire un’eresia- perché il tipico quadro medio può essere paragonato agli “yes man” aziendali che pur di far carriera non osteggiano niente. Forse questo approccio ci aiuta a leg- UNA CITTA’ gere buona parte dell’ortodossia del partito comunista italiano di cui parla anche Rossanda nella sua recente biografia. Il carrierista tradizionale aziendale in genere è un “yes man” che non produce valore aggiunto, costituisce quella massa grigia che mantiene un collante organizzativo ed è molto orientato alla conservazione. Pietro. Una delle parole chiave, che ho sentito utilizzate dai rappresentanti di Acta, l’associazione che rappresenta i professionisti del terziario avanzato, è “valore aggiunto”. Mi sembra interessante perché è la prima definizione positiva, visto che di solito si identifica il lavoratore autonomo con l’evasore, il parassita o comunque quello che si fa i fatti suoi. Sergio. Il lavoratore autonomo è funzionale ad una circolazione di idee, allo scambio di conoscenza e di competenza, dimensione necessaria per non perdere il ruolo economico e sociale che il nostro paese ricopre in questo periodo. non solo penalizzano chi ha la partita Iva, ma ne negano l’identità equiparandolo ad un precario Pietro. Mi dicevi che secondo te non è centrale, per comprendere le condizioni dei lavoratori autonomi, la differenza tra appartenenza a un ordine professionale e non appartenenza. Sergio. In cosa consiste il potere di un giovane avvocato? Mi sembra sia minimo se non addirittura inesistente. Il potere contrattuale è dato, come direbbe Marx, dal potere di scambio. Tu puoi avere un valore d’uso assolutamente rilevante, puoi essere specializzato, avere un elevato numero di competenze, ma il valore commerciale è dato da altro, dalla capacità di scambio. Su questo meccanismo agiscono tante dimensioni, tra cui l’identità del lavoratore autonomo, perché è la sicurezza, la fiducia in sé che consente di negoziare il prezzo delle prestazioni, i tempi di pagamento, la qualità del lavoro con il cliente. Si negozia quando ci si ritiene “forti”, cioè capaci di fare questa operazione tutta legata a dimensioni di tipo psicologico. Purtroppo non vedo un interesse vero a censire questo genere di cose. Il ministro Damiano, la Cgil pensano che per rafforzare gli autonomi sia necessario farli uscire dalla condizione di precarietà con alcuni “trucchi” come l’innalzamento dell’Iva. Non si accorgono che in questo modo non solo penalizzano economicamente chi ha la partita Iva, ma addirittura ne negano l’identità equiparandolo ad un precario. Allo stesso modo il cassaintegrato ha una sua specifica identità legata al concetto di esclusione dal mercato del lavoro, ha quindi una notevole vulnerabilità. E’un autentico insulto considerarlo un dipendente. Negli anni ’80 a Torino si sono suicidate 150 persone che si trovavano in cassaintegrazione; questo dramma invisibile, considerato solo da pochi specialisti, vorrà pur dire qualche cosa a proposito di identità fragile. Gli intellettuali che accettano la definizione burocratica dell’Istat, che paragona un lavoratore in cassaintegrazione ad un dipendente esclusivamente perché lo risulta ancora ufficialmente, finiscono per accettare una lettura della società basata su elementi formali, non sui processi reali. Tornando al caso delle persone con la partita Iva e alla loro identità, possiamo ricorrere ad un paradosso. Non è il dato formale che definisce un professionista. Per esempio, se una persona lavora a casa propria, ma ha un solo cliente che ne determina le scelte e il valore delle prestazioni, può essere equiparato ad un lavoratore dipendente “nascosto”. Non è certo il luogo fisico dove esercita il proprio lavoro che determina la differente identità, ma il suo sistema di relazioni, la sua capacità di valorizzare autonomamente il proprio lavoro individuando committenti che rispondono alle proprie esigenze ed aspettative. Questa è la differen- za tra un professionista “vero” e il precario, il dipendente “nascosto” che sta tanto a cuore al ministro Damiano e al sindacato. Pietro. Allora si deve valutare se sei mono-committente: se hai un unico cliente oppure no … Sergio. Penso che sia la questione fondamentale. Personalmente ho lavorato come libero professionista per tre anni in un’agenzia regionale e per quattro anni in una legata alla Camera di Commercio. In tutti questi anni ero di fatto un dipendente mascherato, anche se io stesso pensavo di essere un libero professionista avendo maggiore libertà nella definizione del mio orario di lavoro. Quando l’agenzia regionale ha chiuso io mi sono ritrovato nei guai: ero ad altissimo rischio di fragilità sociale. La mia fragilità era data dal fatto che quella era la mia unica fonte di reddito e in questo genere di condizioni il tuo livello di potere decisionale è basso, così come la capacità contrattuale. La stessa cosa per quanto riguarda la capacità di fare scelte professionali che consentissero di uscire dalla situazione. Pietro. Questo ragionamento, legato al potere negoziale, ci consente di determinare se quella persona con la partita Iva, o quel lavoratore con contratto co.co.pro., sia più o meno indipendente. Sergio. Dal punto di vista giuridico-formale è indipendente, ma si tratta di un’astrazione formale perché, a parte la possibilità di definire il mio orario, la mia condizione era quella di non avere un’autonomia sostanziale dal mio cliente dal quale dipendevo, come i miei colleghi che avevano un rapporto di lavoro dipendente; ma a differenza di loro avevo meno forme di tutela nel momento in cui l’agenzia regionale ha concluso la sua attività. Penso che in questo contesto sia l’Istat a dover modificare i propri riferimenti concettuali: alla fine degli anni ‘70 la statistica è stata in grado di considerare la forza lavoro nascosta. Si è concepito che il ricercatore facesse alcune domande in più per approfondire il problema cercando di capire se a fronte di condizioni favorevoli (per esempio la possibilità di trovare un impiego) la persona sarebbe stata interessata ad attivarsi nella ricerca di un lavoro. Pietro. Infatti guardando le varie banche dati esistenti abbiamo capito che c’è pochissimo, ad esempio, sulla dimensione di scelta e gradimento del lavoro autonomo: quanto è frutto di una scelta, quali sono i valori che ci stanno dietro? E neppure sulla cultura civica: quali sono le regole alle quali decidi di aderire, che cosa chiedi? Sergio. Ma come mai non ci sono domande in questo senso? Questo indica come quella indagine venga condotta con categorie obsolete e ormai inutili. Pietro. Tu adesso hai aperto una s.r.l., quindi in realtà non sarai più nella “gestione separata”, ma stai diventando “altro”. Sergio. Siamo quattro soci ed incomincia ad esserci una dimensione organizzativa. Ma la mia amica che ha anche lei una s.r.l. e a differenza di me ha fatto la scelta di rimanere sola, che differenza di approccio può avere rispetto ad una partita Iva? Ribadisco: la differenza non può essere confinata ad un aspetto di carattere giuridico-formale. Pietro. E se invece avesse tre persone che lavorano con lei? Sergio. Intanto c’è da chiedersi perché si trova nelle condizioni di avere tre persone. Probabilmente perché ha una capacità di gestire la sua attività commerciale tale per cui ha bisogno di decentrare una parte del lavoro. Stiamo dicendo, quindi, che ha un potere negoziale non indifferente: non ha un solo cliente, ne ha diversi che sovrastano la sua capacità produttiva e quindi deve avvalersi di collaboratori. Pietro. Voi siete quattro soci, ma tu hai una tua partita Iva personale. Cosa vuol dire essere soci? Sergio. La nostra società è stata fondata da due soci, abbiamo iniziato nel 1994 a trovarci in riunioni per farci forza l’un l’altro. Fino al 1998 venivamo riconosciuti come un marchio anche se dal punto di vista giuridico-formale eravamo solo due partite Iva. Eravamo due professionisti, ma per i nostri clienti eravamo un’organizzazione che dava loro più garanzie. Il Centro di formazione professionale della Regione Lombardia, per il quale abbiamo lavorato per quattro anni, ad un certo punto ci ha proposto una commessa molto articolata. Noi abbiamo dovuto ricorrere ad altri colleghi perché non potevamo gestire cinque corsi contemporaneamente, la percezione degli attori economici e sociali era differente dalla nostra collocazione “formale”. Pietro. Cambia molto essere percepiti come un’organizzazione e non come singoli professionisti? Sergio. Certo, sei più forte, hai più potere contrattuale. Abbiamo provato a chiedere tempi di pagamento diversi, con buona pace di tutti gli ordini professionali che non ti danno alcun aiuto in que- Bologna, Fiera sto senso. L’organizzazione è considerata dal cliente un interlocutore che ha dei vincoli, che ha a sua volta dei collaboratori da pagare, per cui si sa che le relazioni sono tra organizzazione e organizzazione, in un certo senso alla pari. Pietro. Allora anche l’aspetto materiale, strutturale, conta: se lavoro in casa, se ho una sede propria… Sergio. Ai sociologi ed anche ai pubblicitari piace molto l’immagine della persona che lavora da internet in vacanza, affacciandosi sul golfo meraviglioso, in realtà è una panzana colossale, irreale. O sei famoso o vieni percepito come uno che non ha neanche un ufficio. Se l’amministrazione dell’ente cliente se ne accorge, il ragionamento è molto pratico: “Che spese vuoi che abbia, lavora da casa, quindi non ha esigenze particolari perché non ha costi da sostenere e se mi manca la liquidità il primo su cui rifarmi è lui e lo pagherò non a 120 giorni ma a 180”. Pietro. E anche avere l’Iva o non averla cambia? Anna Soru, presidente di Acta, sostiene che per il committente sapere che hai la partita Iva ti rafforza. Sergio. Noi ora diventiamo s.r.l. ed abbiamo 4 partite Iva; cosa ce ne facciamo? Secondo questo ragionamento dovremmo tenerle in vita perché se un cliente ci chiama per fare una docenza in aula, avendo noi la partita Iva dovremmo ottenere una quota oraria maggiore, tempi di pagamento migliori, cioè un potere di scambio maggiore, in quanto professionisti. Io invece sto pensando di chiuderla perché ho un costo e al cliente posso tranquillamente chiedere un prezzo più alto, ma questo atteggiamento me lo posso permettere oggi perché ormai ho un potere contrattuale maggiore di quando lavoravo presso l’agenzia regionale che era la mia unica cliente. Pietro. Lo puoi fare perché hai un potere contrattuale maggiore e hai una s.r.l. Sergio. Potrei anche non avere l’s.r.l., ma ho ormai una relazione tale con quel committente che arrivo a decidere quali sono le condizioni che mi vanno bene e soprattutto, per mia fortuna, non ho solo lui come cliente, ma ne ho altri, quindi me lo posso permettere. Pietro. Dal punto di vista organizzativo, c’è un primo passaggio in cui ti associ a livello organiz- zativo con delle persone e magari ti registri alla Camera di Commercio. Adesso voi fate un altro passaggio, diventate un s.r.l., ed avete una persona che lavora per voi con delle competenze amministrative. Quando iniziamo a chiamarti imprenditore? Sergio. Quando ho un rapporto di forza nel valore di scambio tale per cui io posso essere anche un co.co.pro. ma al mio cliente posso dire che se vuole che collabori deve darmi non più 100 ma 150 e io una parte di quei 50 li do ad un mio collaboratore. Si può avere qualunque rapporto, Iva, non Iva, co.co.pro., ma in questo caso si è imprenditori. Pietro. Le caratteristiche del lavoro indipendente cambiano molto da un territorio ad un altro? piace molto l’immagine della persona che lavora con internet affacciata sul golfo... una panzana colossale Sergio. Beh, se lavorassi in una zona con pochi clienti ovviamente sì… Pietro. Di che territori stiamo parlando? Funziona ancora la lettura delle tre Italie? Sergio. Se abitassi a Nuoro il mio potere contrattuale quale sarebbe? Potrei avere un valore d’uso notevole, ma il valore di scambio purtroppo sarebbe basso. Pietro. Stiamo quindi parlando di metropoli, Milano e Roma e basta? Sergio. Diciamo territori in cui il tuo valore d’uso ha un valore di scambio già di per sé elevato. Può essere anche in Sardegna, ma in quel distretto particolare in cui ho diversi clienti... Pietro. Quindi parliamo di alcune competenze su alcuni distretti... e ovviamente di Milano, dove ci sono tutte le competenze... Sergio. E’importante il valore aggiunto che tu porti e la presenza di una domanda di servizi, se no il mio potere contrattuale cade, come ai tempi in cui lavoravo in agenzia regionale. Pietro. E’ interessante la difficoltà di queste persone di riconoscersi nelle politiche sia di destra che di sinistra; e questo non vuol dire neppure essere al centro. Da dove passa una costruzione po- litica di queste identità? Sergio. Intanto alcune regole mi aiutano: in primis torno alla mia biografia, e mi serve moltissimo. Chi sono i miei concorrenti? Come dice Sergio Bologna: chi sono gli enti minaccianti? Lo Stato? Ma figurati! Al massimo l’Inps. Sai chi mi minaccia? Il dispositivo della Regione che definisce le tariffe previste nei corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo e stabilisce delle categorie: i docenti universitari automaticamente hanno il massimale più elevato in quanto tali, mentre agli altri la Regione chiede 10 anni di anzianità. Questa concorrenzialità, dal punto di vista economico si definisce concorrenza sleale; l’ente minacciante in questo caso è il mondo universitario, non è certo lo Stato. Pietro. Lo sai che in realtà i sociologi e quindi i professori universitari, faticano a leggere questo mondo? Sergio. Non faccio fatica a pensarlo, vorrebbe dire rileggere criticamente i propri comportamenti personali e infrangere un tabù che li riguarda da vicino, è un’operazione culturale difficile. Pietro. Prova a dirmi un altro concorrente, oltre all’università. Quali sono i nodi critici, politici? Sergio. Noi lavoriamo ad alcuni progetti per una provincia piemontese. La Regione Piemonte, di sinistra, non paga le Province e l’esito finale è che la Provincia che non percepisce i pagamenti non ti paga. Lo Stato non ha obbligato la Regione a saldare i propri debiti e le conseguenze sono ritardi di pagamento che nel caso specifico superano i 390 giorni. Sai chi è un’altra minaccia? Gli ordini. Esempio: io faccio l’orientatore e mi occupo di counselling dal 1990. In quel periodo saremo stati poche decine in tutta Italia ad avere un profilo del genere. Adesso si sta definendo la normativa per regolamentare la figura del counsellor. L’ordine degli psicologi ha dimostrato un elevato interesse nei confronti delle due figure orientatore e counsellor, perché garantirebbero ambiti occupazionali a chi esce con la laurea in psicologia. Il ragionamento è destinato a fallire perché per gli ordini tira brutta aria, ma se il problema si fosse posto alcuni anni fa come si sarebbe conclusa la vicenda? Le mie competenze, in assenza di un ti- tolo ad hoc, che fine avrebbero fatto? Pietro. Questo concretamente significherebbe che tu non puoi essere counsellor se non sei laureato in psicologia ed iscritto all’ordine? Sergio. Sì, questa è la loro speranza. Anche se io so bene che pur essendo laureato in lettere sono in grado di fare questo lavoro. Ma potrei anche essere laureato in ingegneria, purché abbia vissuto nella mia biografia certi passaggi formativi, la terapia e la supervisione per esempio. La competenza è un problema altrettanto complesso e non può ovviamente essere garantito da un atto formale. Il nostro paese dovrebbe liberarsi dalla ossessiva presenza dell’atto formale che non aiuta a conoscere la realtà così come non garantisce il cliente. Pietro. Vedi che, anche nella creazione dell’identità, gli ordini contano, in qualche modo tutelano perché ti danno una riconoscibilità pubblica, una cassa, un orizzonte, ti garantiscono che probabilmente sarai tu ad accedere a quel lavoro... Sergio. Sì, dopodiché il singolo professionista rimane comunque isolato se non trova il cliente. Può trovare un ambito in più, questo è vero, però poi in quell’ambito si riverserebbero in tanti e la situazione alla lunga non cambierebbe. Perché una volta che stabilisco nuovi confini e viene definito che gli orientatori devono essere necessariamente psicologi, il problema per il singolo psicologo non cambia, accadrà solo che una valanga di giovani psicologi si riverserà lì e il problema della ricerca del cliente non cambia. Pietro. Il Cnel sta facendo una specie di albo di tutte le associazioni di professionisti, ordini e non solo: la sua proposta è quella di recensire non tanto la professione quanto le attività, recependo una normativa europea. Sergio. Ma cosa mi darebbe questo albo? Potere contrattuale nei confronti della Regione sì o no? Pietro. Tutelare le competenze e non la professione non aiuta a scardinare il potere degli ordini e a legittimare un po’ di più i singoli professionisti? Sergio. Sì tutelare le competenze potrebbe essere un primo iniziale passo, dopodiché ce ne vorrebbero altri finalizzati a tutelare il valore di scambio e a contrastare l’invasione di “oligopoli”, università in primis. UNA CITTA’ 9 storie di lavoro L’ABBIAMO IMPAGINATO AL CONTRARIO, ALL’ARABA Una casa editrice nata lavorando con i detenuti che hanno condiviso il desiderio di fare libri per i più piccoli. La voglia di sperimentare idee, ma anche formati “strani”; una collana di libri bilingui scritti da immigrati che si traducono, e poi le fiabe, i libri per dislessici con un font e una carta ad hoc, e ancora l’impegno civico con volumi sulla mafia, la costituzione e l’uso del denaro... Intervista a Della Passarelli. Della Passarelli è presidente della casa editrice Sinnos (www.sinnoseditrice.com), che recentemente ha ricevuto il Premio Andersen per la ricchezza e il coraggio del progetto. Dove nasce l’idea di una casa editrice? Sono state due le strade che mi hanno condotto qui: l’impegno politico e la passione per il teatro. Tra l’84 e il ‘93 lavoravo al Gruppo parlamentare di Democrazia Proletaria e ci occupavamo anche di problemi di detenzione, degli stranieri in particolare; era nata un’associazione, Cidsi (Centro di informazione per Detenuti Stranieri in Italia) composta da detenuti e da volontari, che volevamo seguire perché la detenzione degli immigrati era un fenomeno allora nuovo che desideravamo capire e quell’esperienza sembrava interessante. Così Dp mi diede l’incarico di seguire questo lavoro, insieme ad altre questioni specifiche, come l’indulto per i detenuti politici. Nello stesso periodo -premetto che io mi sono laureata in Storia del teatro- ero stata invitata ad uno spettacolo nel carcere penale di Rebibbia. Era un’Antigone: rimasi colpita dalla forza di questi attori assolutamente non professionisti e sentii che lì il teatro poteva essere uno strumento importante; così, oltre che collaborare col Cidsi, cominciai ad insegnare in un corso di teatro legato all’università. Dedicando sempre più tempo al carcere (passavo lì gran parte dei miei fine settimana), si sono stabiliti dei veri e propri rapporti di amicizia con i detenuti. Alcuni di loro avevano fatto un corso di videoimpaginazione per l’editoria che era stato finanziato dalla Regione Lazio e decisero di creare una cooperativa che avrebbe dovuto offrire servizi ad altri editori, come impaginare, curare la grafica, pur essendo essa stessa una casa editrice. A quel punto (siamo nel ’90) abbiamo fondato la Sinnos: sono andata io con altri volontari da un notaio perché ovviamente i ragazzi non potevano farlo. Sinnos vuol dire “segni”, cercavamo un nome evocativo, l’idea è venuta a un detenuto sardo Dopodiché ho detto ad Antonio Spinelli, il vero fondatore di questa cooperativa -e che purtroppo non c’è più- che per me comunque erano dei pazzi, perché fare dei libri dal carcere, per ragazzi, mi sembrava una vera follia. Nei primi tre anni li ho visti crescere e li ho sostenuti dall’esterno. Alla fine mi hanno convinto a entrare in cooperativa e nel ’94 ne sono diventata presidente: sono rimasta intrappolata perché avevo scritto una storia per ragazzi che era stata premiata, Antonio l’aveva voluta pubblicare e a quel punto… Sinnos vuol dire “segni”. L’idea è venuta a un detenuto sardo, noi cercavamo un nome che fosse evocativo, che desse il senso del segno, della lingua e sinnos significa “segni” in sardo. Perché avete scelto la forma della cooperativa? Soprattutto Antonio e altri volontari, tra cui Elisa, la nostra vicepresidente, come pure alcuni ragazzi (che ora sono andati a lavorare in altri settori o sono tornati nel loro paese perché erano immigrati) desideravano creare una struttura in cui tutti quanti avessimo il nostro ruolo e potessimo decidere, una struttura che avesse come obiettivo il reinserimento dei detenuti; in particolare una cooperativa cosiddetta di tipo B, poiché ci occupiamo del reinserimento di soggetti svantaggiati e ci impegniamo a riconvertire gli utili in altre possibilità di lavoro. Ciò che mi rende abbastanza orgogliosa di Sinnos è che è riuscita a mantenere realmente questa struttura: noi prendiamo le decisioni generalmente insieme, anche discutendo animatamente e in questi 17 anni siamo riusciti a reinserire una decina di soggetti cosiddetti svantaggiati (alcuni si sono fermati, altri sono andati via), ma soprattutto Sinnos ha dato lavoro a tanti “liberi”. Noi abbia- 10 mo grafici, impaginatori, gli stessi nostri autori sono persone che non hanno nulla a che vedere con il carcere. Questa scelta di uscire all’esterno credo sia stata importante, perché resta un’iniziativa nata in carcere e però guarda oltre. Qual è stato il percorso di Sinnos? La primissima tappa è stata la collana i Mappamondi. Il primo presidente di Sinnos, Paolo Traniello, docente di Biblioteconomia all’Università Roma Tre, conosceva un maestro elementare, Vinicio Ongini (oggi esperto di intercultura per il Ministero della Pubblica Istruzione). Ebbene, Vinicio aveva un bambino filippino nella sua classe e, anche alla luce dell’esperienza francese, si era reso conto che presto anche in Italia sarebbero arrivati bambini stranieri per cui ci sarebbe stato bisogno di libri scritti nelle loro lingue. Così sono nati i Mappamondi: libri bilingui scritti da immigrati che raccontano in italiano -e poi traducono nella loro lingua- la loro storia di vita partendo dalle radici, i paesi di provenienza, per arrivare poi all’incontro con l’Italia e alla loro esperienza in questo nuovo paese. Il passaggio dal carcere al mondo dei ragazzi è stata un’esperienza straordinaria, magica. Il fatto che quei detenuti, che avevano vissuto esperienze terribili, abbiano voluto fare dei libri per bambini e per ragazzi… Non so, è come se avessero intuito che, se si semina nei piccoli… e poi i bambini sono dei fantastici mediatori culturali a tutto campo. Dopo i Mappamondi, libri dal formato tascabile e poco illustrati, è venuta Fiabalandia, una collana quadrata; il primo libro è stato Il signore delle farfalle di Silvia Roncaglia e Cristiana Cerretti. Mi ricordo che l’autrice venne a proporci il libro in questo formato “strano” che tutti gli editori le rifiutavano. Ecco, siccome i piccoli editori sono capaci di rischiare e a noi il libro era piaciuto, abbiamo collaudato questo formato “21x21”, un grande quadrato. Era una storia inventata da Silvia sull’uguaglianza, sulla diversità; all’inizio i librai ci dicevano che non sarebbero potuti andare in distribuzione; oggi siamo già, credo, al cinquantottesimo volume e posso dire che “funzionano”; intendo dire che noi ne stampiamo 2000 copie, ne vendiamo circa 6-700 all’anno (se ci va bene), quindi esauriamo le 2000 copie in due anni, due anni e mezzo. Oltre a Fiabalandia, destinata ai più piccoli, con molte immagini, c’è una collana che si chiama Zefiro, sempre connessa al discorso dell’intercultura, che raccoglie fiabe e racconti narrati da immigrati a partire dalla loro tradizione personale. Vengono riscritti in italiano da loro stessi o aiutati da un nostro autore; a curare la collana è Sofia Gallo, una fantastica “cacciatrice” di storie. Questa collana ha una ulteriore particolarità: alla fine di ogni libro inseriamo un approfondimento sulla struttura grammaticale della lingua d’origine. Noi speriamo che questo possa servire agli insegnanti che hanno in classe bambini e ragazzi stranieri: sapere che i cinesi non usano alcuni verbi, o che i peruviani non hanno il verbo avere ma ne usano un altro, può essere molto utile. La caratteristica particolare della Sinnos, quando parlo di interculturalità, è che per la prima volta in Italia il testo a fronte non è quello della lingua classica tradizionale come il greco, il latino, l’inglese, ma diventa il tagalog, l’eritreo, il cinese, l’egiziano invece dell’arabo classico, ecc. Ciò significa dare vita, valorizzare quello che i nuovi cittadini hanno portato con sé, a partire dalla loro lingua. Questo, soprattutto nelle classi, produce effetti straordinari: per dire, il bambino egiziano, che la maestra magari ci presenta come un ragazzino strano, che non si integra, quando si parla della sua cultura, della sua lingua, passa al centro dell’attenzione, i suoi compagni gli danno valore, lo scambio diventa davvero reciproco… Ovviamente questo tipo di percorso implica un lavoro costante con gli insegnanti. A scuola non si arriva senza la loro collaborazione. All’inizio sono stati proprio alcuni di loro a contattarci per capire cosa si potesse fare assieme. Ora l’intercultura è diventata quasi una moda, se ne parla tantissimo, nelle linee-guida del Ministero della pubblica UNA CITTA’ istruzione i libri bilingue sono addirittura indicati come strumento importante. Questa è una cosa molto recente, all’inizio invece ci cercavamo reciprocamente per capire come entrare nelle scuole, anche perché i nostri non sono testi scolastici, cioè non possono essere adottati, quindi è tanta la fatica degli insegnanti nel proporli alle famiglie. Economicamente riuscite a mantenervi con i libri? Il settore editoriale in Sinnos ripaga gran parte delle spese, però per sopravvivere dobbiamo continuare a fare altri lavori, come quello di “service” per altri editori, ma soprattutto elaborare progetti. Oltre alla formazione in carcere, dal ’97 gestiamo uno sportello d’informazione per gli immigrati in convenzione con il V Municipio romano (con tre persone che lavorano a tempo pieno): noi forniamo non solo tutta la modulistica, ma siamo in grado di accompagnare gli immigrati in tutte le pastoie burocratiche che si creano, dal permesso di soggiorno al ricongiungimento familiare, come pure la semplice carta d’identità. Contribuiamo a snellire il lavoro destinato all’utenza italiana e questo sportello è diventato importante anche per la città. così i nostri bambini possono compiere quel gesto di aprire il libro al contrario, che è proprio interculturale Per quanto riguarda la formazione in carcere, abbiamo appena presentato un progetto alla Regione Lazio, in risposta a un bando denominato “Chance” per la formazione professionale: ciò che possiamo offrire ovviamente è la nostra competenza sia nel campo della mediazione culturale, che in quello dell’informatica, dell’impaginazione e della grafica. Da poco abbiamo concluso la formazione di alcuni detenuti bibliotecari perché il sistema delle biblioteche di Roma ha aperto le biblioteche in carcere e quindi si è resa utile una formazione specifica. Noi abbiamo gestito il coordinamento dei docenti, abbiamo seguito i detenuti che dovevano lavorare per catalogare, e infine ne abbiamo anche assunto uno! Ma in quanti siete a fare tutto questo lavoro? Siamo in dodici, è un numero piccolo rispetto alla quantità d’impegni. Tieni conto che, di questi dodici, tre sono impegnati continuativamente allo sportello (non li vediamo mai); poi c’è il “service” (impaginazione, grafica, redazione, correzione di bozze) per altri editori, mentre il grosso del lavoro è assorbito dalla nostra editoria: c’è tutto il commerciale da seguire, i contatti con le librerie. Finalmente da tre anni siamo distribuiti da Dehoniana Libri, un grande distributore nazionale che è anche “umano”, con il quale si può dialogare. I nostri infatti non sono libri commerciali, non sono apprezzati da tutti i distributori. Il nostro incubo è il Topo, Geronimo Stilton: è presente dappertutto, nei supermercati, con gli sconti del tre per due, regalato insieme alle merendine; i libri della Sinnos non possono entrare in questo tipo di competizione. La collocazione ideale per i nostri libri sarebbero le biblioteche scolastiche perché noi ci occupiamo di intercultura. Come vi promuovete? Abbiamo imparato a fatica che essere presenti è importante, perciò giriamo tanto, facciamo le fiere del libro più importanti in Italia: quella di Roma Piùlibri piùliberi, che è diventata fondamentale, poi abbiamo Bologna, con la Fiera internazionale del libro per ragazzi, poi c’è Torino.. a queste cerchiamo di partecipare: sono un grande impegno economico e di fatica, però pian piano le persone si sono abituate a trovarci, c’è sempre qualcuno che scopre e apprezza la nostra produzione di libri in tante lingue. Sono fondamentali anche le recensioni, il passaparola delle persone che ci seguono, i librai indipendenti specializzati che non si arrendono e le biblioteche. Questi sono i nostri circuiti. Ora abbiamo anche un sito www.sinnoseditrice.com, stiamo imparando, anno dopo anno correggiamo il tiro. Per la diffusione bisogna avere molta pazienza: ogni libraio può avere un libro della Sinnos, però soprattutto le grandi catene a volte non hanno voglia di ordinarli, e quindi, se qualcuno cerca un nostro libro, possono dire che è esaurito o addirittura che non esiste. Perciò ci auguriamo che i nostri lettori non si scoraggino, che vadano da librai indipendenti, che siano disponibili ad aspettare magari qualche giorno per tornarlo a prendere… Oltre ai temi dell’interculturalità vi siete occupati anche di mafia, della costituzione, in qualche modo di educazione civica... Recentemente abbiamo pubblicato La Scelta, di Luisa Mattia, un libro che parla di mafia e che ha ottenuto il premio Pippi 2006, un premio biennale per autrici donne per ragazzi, offerto dal Comune di Casalecchio di Reno. Attualmente abbiamo più di 160 titoli in catalogo. Tra le varie collane, ce n’è anche una dedicata al diritto, Nomos, che nasce con Lorenzo e la Costituzione. E’ anche questo un libro quadrato un po’ più grande; abbiamo stampato questo testo per la prima volta nel ’96 e continuiamo a ristamparlo. Per il prossimo anno scolastico ne faremo un’edizione dedicata all’anniversario della nostra Costituzione che compie sessant’anni. Insieme a questo libro sono nati Chiara e l’uso responsabile del denaro, Tina e i diritti dei bambini che mostrano ai ragazzi che esistono delle regole, delle norme. Questi testi contribuiscono alla crescita del futuro cittadino. Questo è un lavoro che ci appassiona e ci dà grandi soddisfazioni. Il volume sulla mafia è uscito in una collana che si chiama Zona Franca, anch’essa nata da un’idea di Antonio Spinelli, morto nel 2005, a soli 40 anni. La sua figura resta per noi fondamentale. Infatti, per ricordarlo, abbiamo messo in piedi un progetto che si chiama “Le biblioteche di Antonio”: tutti gli anni noi compriamo dei libri da piccoli editori di progetto, cioè dai nostri colleghi -che sono circa 23/24 nella nostra rete- e li doniamo ad una biblioteca scolastica che dimostri di essere in una zona con scarsa promozione alla lettura e però di avere un progetto di biblioteca, di sapere come portarla avanti. Il primo anno la nostra scelta è caduta necessariamente sul paese di nascita di Antonio, che è San Michele di Bari; quest’anno è stata selezionata la scuola di Miglionico, in provincia di Matera: è una scuola molto piccola in un paese dove non c’è nemmeno una biblioteca comunale. Sia a livello nazionale che internazionale, avete fatto della rete proprio una scelta strategica. Puoi raccontare? A livello nazionale è molto importante la rete dei piccoli editori: per un certo periodo ci chiamavamo (eravamo allora meno di 23) “meno piccoli di quel che sembra”. Ci siamo uniti su un obiettivo, quello delle biblioteche scolastiche. E’ stata un’esperienza entusiasmante, anche perché devo dire che nei primi 7-8 anni della nostra storia eravamo visti come una piccola casa editrice nata in carcere e venivamo poco considerati dalle riviste specializzate, ci consideravano un po’“naif”. Poi pian piano ci siamo fatti strada: abbiamo migliorato la qualità delle nostre copertine, dei nostri illustratori (adesso ce ne sono di molto bravi che lavorano anche per editori più importanti) e quindi si sono accorti che c’era anche una capacità editoriale; così abbiamo cominciato insieme ad altri editori e a librai a stimolare e a sollecitare il gruppo dei piccoli editori. Questa rete ci consente di confrontarci, di scoprire come le nostre difficoltà siano simili a quelle degli altri; ci scambiamo idee e soluzioni per i problemi comuni e questa condivisione è un bel successo. Dal punto di vista internazionale invece, c’è un’istituzione che si chiama Ibby, di cui l’Italia è appena entrata a far parte. E’ una realtà importante, anche per la sua storia: questo organismo è nato alla fine della seconda guerra mondiale per iniziativa di una signora ebrea tedesca -Jella Lepman- tenacemente convinta che la lettura avrebbe potuto salvare i bambini tedeschi dall’orrore a cui avevano assistito; cominciò a farsi mandare in dono da tutti i paesi dei libri per ragazzi. Adesso a Monaco c’è la più grande biblioteca per ragazzi. L’Ibby ha come obiettivo quello di promuovere la lettura tra i giovani, anche sostenendo le esperienze e i libri più meritori, dalla biblioteca che viaggia sui muli in Palestina ai libri fatti in fotocopia in Rwanda… Anche noi quest’anno siamo stati segnalati per gli Outstanding Books con il libro per disabili Matteo è sordo. Infatti, oltre a fare i libri in tante lingue, ne abbiamo fatti alcuni anche in Lis, la lingua dei segni… A questo proposito c’è un’ultima collana che voglio ricordare; si chiama Leggimi e sono libri per tutti, ragazzi dai nove ai dieci anni, ma soprattut- to per bambini dislessici. L’idea viene da una piccola casa editrice che si chiama Biancoenero con cui abbiamo fatto una coedizione (abbiamo condiviso le scelte e le spese); Sinnos ha individuato un font adatto ai dislessici, abbiamo utilizzato una carta giallina e abbiamo applicato delle particolari “cure di stile”. Non solo, poiché gli autori italiani non erano preparati a scrivere per ragazzi con difficoltà di lettura, noi abbiamo acquistato e tradotto i primi libri di questo genere da una casa editrice inglese. La prima autrice italiana che ha scritto per noi in italiano è stata Lia Levi che ha pubblicato L’amica di carta. Lia Levi ha una scrittura già semplice di per sé, quindi non è stato complicato inserire questa scrittura chiara e limpida nei parametri di questa collana che sta riscontrando un certo successo. In Italia c’è poi l’associazione “Nati per leggere”, sorta dall’unione tra l’Associazione Italiana Biblioteche (Aib) e l’Associazione Culturale Pediatri (in molti oggi sostengono che, invece di dare farmaci ai bambini iperattivi, se noi leggessimo per loro ad alta voce, questo funzionerebbe meglio). Si tratta di una splendida iniziativa che va avanti da diversi anni: c’è un sito, così come c’è il sito di Ibby, dove vengono consigliati i libri da leggere ad alta voce ai bambini. a volte è faticoso gestire una vera piccola azienda e al contempo non perdere la passione degli inizi Purtroppo, dall’altra parte, abbiamo una scuola che in genere non ha soldi per comprare libri e nemmeno le strutture: spesso le biblioteche sono chiuse a chiave, o gestite da insegnanti poco interessati. Tra l’altro gli insegnanti formati come bibliotecari, se non è cambiato nulla nella finanziaria e nella legge che era stata approvata quando c’era la Moratti, nel 2008 passeranno ad altri incarichi amministrativi. C’è un ulteriore progetto in cantiere, “Amico Libro”, per cui il Ministero darà dei soldi alle scuole per comprare libri. Il timore è che arrivino pacchetti messi a punto dai grandi editori proprio per entrare nelle scuole. Noi scontiamo anche un ritardo culturale su que- sto piano. Nella scuola francese, che pure ha tante pecche, c’è l’ora di “biblioteca” dove i ragazzini vanno, leggono, scelgono. Io insegno letteratura italiana anche all’università americana e ormai gli studenti fanno le tesine solo su internet, se la cavano con un copia e incolla anche perché gli insegnanti spesso non se ne accorgono. Però come studente non hai elaborato niente, non hai preso una pausa, non hai pensato. Inoltre affinché la lettura diventi un piacere e non solo un dovere ci vuole una forma di educazione, di esercizio. Gianni Rodari diceva che la lettura è un sesto senso: noi non ci nasciamo come con gli altri sensi, e quindi va allenato. Quest’azione può essere svolta benissimo dai genitori. Ma la scuola ha un compito importante da questo punto di vista, perché non si legge in tutte le famiglie e invece tutti i bambini e i ragazzi hanno il diritto di leggere e di avere dei libri a loro disposizione. In questi ultimi anni avete pubblicato anche alcuni “scrittori migranti”. Abbiamo pubblicato vari scrittori. Ricordo Igiaba Scego, italo-somala, una scrittrice tra le più famose che abbiamo ospitato (infatti temo che ora parta per altri lidi…). Gli scrittori migranti sono autori che ormai utilizzano l’italiano come lingua, e che però portano dentro un’altra tradizione, un’altra cultura, un’altra storia insomma. Questo crea anche nella lingua italiana una specie di meticciato perché l’autore assume un certo modo di narrare, una struttura della frase che è diversa, come diversa è la forma del racconto. Su questo tipo di scrittura c’è un grande dibattito ed è uscito, con l’editore Città aperta, un bel libro che s’intitola Nuovo planetario italiano, curato da Armando Gnisci, un’antologia su quello che c’è oggi in Italia come scrittura migrante. E’ un fenomeno molto interessante. Devo dire che non era per noi usuale, ma recentemente abbiamo acquistato i diritti per un bellissimo libro iraniano intitolato Il mercante e il pappagallo, dove non solo abbiamo lasciato il testo in parsi a fronte, ma l’abbiamo impaginato in modo che possa essere aperto anche al contrario, all’araba, per così dire, così i nostri bambini possono fare quel gesto che è proprio interculturale. Avete avviato un rapporto privilegiato con l’Egitto… Grazie all’Istituto di Cultura italiana, siamo andati al Cairo a presentare, insieme ad altri editori, a bibliotecari e a due librai, la produzione italiana per ragazzi. Abbiamo fatto un convegno in cui raccontavamo i nostri progetti, affiancati da editori egiziani che presentavano i loro. Stiamo ora concludendo un contratto con Jakub Al Sharouni, un simpatico autore per ragazzi del Cairo, per un libro inedito, Il tesoro delle sirene, che dovremmo pubblicare per la prossima Fiera di Torino, nel 2008, dove l’ospite d’onore sarà proprio l’Egitto. nella scuola francese c’è l’ora di “biblioteca” dove i ragazzini vanno, leggono, scelgono... Noi siamo interessati a importare la cultura egiziana moderna contemporanea, sia per farla conoscere ai nostri ragazzi, sia per farla leggere in italiano ai ragazzi di origine egiziana, così che si possano riconoscere, in particolare in questo autore che viene tradotto per la prima volta nella nostra lingua (in generale la letteratura egiziana per ragazzi è scarsamente presente nel nostro paese). E’ evidente che loro sono meno interessati ai nostri libri, non c’è una grande immigrazione italiana in Egitto, e poi a volte le nostre tematiche non sono adatte, apprezzate da loro; infatti si lamentavano proprio del fatto che non trovavano punti di contatto. Però la vicinanza può crescere piano piano: già il fatto di esserci conosciuti meglio (nelle fiere internazionali ci eravamo già incontrati), di essere stati tre giorni a parlare, a scoprire anche che tipo di pubblicazioni facevamo noi e quelle che facevano loro, può creare sinergie; per esempio la casa editrice che fa le fiabe classiche con illustrazioni fantastiche, che vadano bene con il loro formato, può tranquillamente vendere al Cairo. Loro poi hanno album illustrati molto grandi anche per i ragazzi delle medie, da noi invece è molto faticoso portare questo tipo di produzione alle medie. Volendo tracciare un bilancio? Premetto che gli ostacoli principali sono quelli economici, e sono grossi. Dodici persone possono sembrare poche, ma per noi è un impegno gravoso anche perché siamo tutti quanti assunti regolarmente con il contratto nazionale delle cooperative. Insomma, pagare ogni mese dodici stipendi, oltre a tutte le tasse che questi comportano... A volte è faticoso gestire una vera piccola azienda e al contempo mantenere la passione degli inizi. C’è poi un altro fattore: noi siamo una cooperativa prevalentemente femminile e quasi tutte siamo madri. Fin dall’inizio abbiamo deciso che la passione non doveva travolgerci, facendoci fagocitare dal lavoro, ci siamo quindi impegnate a mantenere orari vivibili, a non sovraccaricarci. Ecco, è difficile tenere assieme tutto questo. Quello a cui noi aspiriamo non sono tanto i finanziamenti a pioggia, ma circuiti alternativi più ampi. In Francia editori come noi vivono solo grazie alle biblioteche scolastiche, non hanno bisogno di altro mercato. Noi vorremmo solo riuscire a vendere i nostri libri, siamo degli imprenditori come gli altri: il successo dei nostri prodotti dovrebbe essere misurato dal fatto che vengono apprezzati e quindi acquistati. Il fatto è che non riusciamo ad accedere ad un mercato più ampio. Quella delle biblioteche scolastiche resta per noi una battaglia importante. Purtroppo si dà più importanza al laboratorio di informatica o all’aula multimediale… Invece i libri sono importanti. Leggere insegna a maturare un senso critico, a fermarsi, a riflettere… La nostra ambizione principale è quella di scegliere libri sempre più belli, magari producendo di meno, ma curando sempre di più la qualità sia dei contenuti, sia della loro “confezione”. A lato vogliamo proseguire nella formazione, e riprendere l’attività in carcere. L’ultima esperienza a Regina Coeli è stata abbastanza positiva, come dicevo, abbiamo assunto un ragazzo; ci piacerebbe formare un’altra persona in carcere sul nostro lavoro di videoimpaginazione, potendo magari accoglierlo tra noi tra circa un anno… Che altro dire, in fondo il nostro sogno è anche quello di diventare un po’ famosi, che quando si nomina la Sinnos, dicano: “Sì, la conosciamo bene!”. Parigi UNA CITTA’ 11 un luogo Harlem, New York Foto di Federico Visi Nel luglio del 2006 alcune decine di afro-americani del Consiglio degli inquilini di Harlem si sono recati davanti alla Fondazione di Bill Clinton al grido di “Bill go home”. L'accusa era di quelle pesanti. La scelta di Bill Clinton, nel 2001, di trasferire lì il suo quartier generale -tra l’altro per “solidarietà” con la comunità locale- ha avuto un imprevisto effetto-boomerang. Molti dei locali infatti hanno accolto molto male la coincidenza temporale tra il suo arrivo e il fatto che gli affitti e i prezzi delle case sono saliti alle stelle. Del resto anche il suo discorso d’insediamento nel nuovo quartiere, quel 30 luglio del 2001, era suonato pieno di nuove speranze, ma anche in qualche modo malaugurante: “Voglio assicurare che cercherò di essere un buon vicino di casa per Harlem. Sono felice che il valore delle proprietà immobiliari sia in crescita, ma non voglio che i piccoli commercianti siano costretti ad andarsene perché arrivo io”. La “gentrification”, la metamorfosi sociale ma anche urbanistica del quartiere nero di New York era in realtà iniziata da tempo. E la colpa, più che dell’ex presidente, è del boom immobiliare di Manhattan; i grandi costruttori stanno acquistando e ammodernando interi isolati cacciando di fatto gli inquilini, come accaduto al Delano Village, un complesso di 1800 alloggi proprio nelle vicinanze degli uffici di Clinton. Il cosiddetto “rifugio” del ceto medio nero di New York è ora la meta di giovani liberi professionisti, agenti di Borsa, imprenditori. In vista del loro arrivo, i negozi avevano già aumentato i prezzi, costringendo i più poveri a spostarsi nel Bronx per far la spesa. Per alcuni, tra cui il sindaco Bloomberg, la rinascita di Harlem è una rivincita sulla storia. Il suo declino era incominciato negli anni Cinquanta, con l’afflusso dei neri dal Profondo Sud e il progressivo allontanamento dei bianchi, man mano che Harlem acquistava la fama di un covo di criminalità e droga. Ora tra la 125a e 133a strada, da Broadway al fiume Hudson, è prevista la creazione di un Campus della Columbia University. Per realizzarlo verranno però rase al suolo tutte le autofficine, i laboratori e le case popolari della zona. Sono a rischio 1600 posti di lavoro, come pure un parco sorto di recente nella zona, dopo anni di lotte per averlo. Se si dovesse arrivare alle strette l’università potrebbe avvalersi della controversa legge sugli sfratti legali, detta anche “Rimozione dei Neri” perché usata per decenni dalle amministrazioni locali per confiscare proprietà private ed eliminare interi quartieri afro-americani in nome del “rinnovamento urbano”. In questi stessi giorni, dopo 50 anni di attività, sta chiudendo Copeland’s, storico locale che era sopravvissuto alle rivolte degli anni caldi -ma non alla gentrification. Il proprietario di quello che più che un ristorante era un’istituzione è molto amareggiato, ma rassegnato: le famiglie, sia bianche che nere, della middle class, che hanno iniziato a comprare e ristrutturare i bei palazzi dai mattoni scuri di Harlem non vanno pazze per il suo gustoso pollo fritto come i vecchi abitanti.
Scaricare