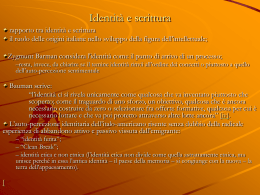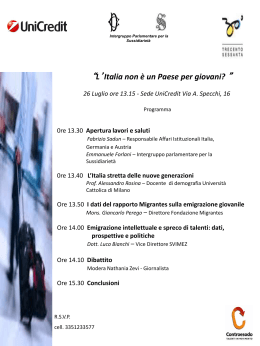Glocale. Rivista molisana di storia e scienze sociali (www.storiaglocale.it) Direttore: Gino Massullo ([email protected]) Comitato di redazione: Rossella Andreassi, Antonio Brusa, Oliviero Casacchia, Renato Cavallaro, Raffaele Colapietra, Gabriella Corona, Massimiliano Crisci, Marco De Nicolò, Norberto Lombardi, Sebastiano Martelli, Massimiliano Marzillo, Gino Massullo, Giorgio Palmieri, Roberto Parisi, Rossano Pazzagli, Edilio Petrocelli, Antonio Ruggieri, Saverio Russo, Ilaria Zilli Segreteria di redazione: Marinangela Bellomo, Maddalena Chimisso, Michele Colitti, Antonello Nardelli, Bice Tanno Direttore responsabile: Antonio Ruggieri Progetto grafico e impaginazione: Silvano Geremia Questa rivista è andata in stampa grazie al contributo di: Provincia di Campobasso Unioncamere Molise Unioncamere Molise Redazione e amministrazione: c/o Il Bene Comune, viale Regina Elena, 54 – 86100 Campobasso, tel. 0874 979903, fax 0874 979903, [email protected] Abbonamento annuo (due numeri): € 25,00. Per abbonamenti internazionali: paesi comunitari, due numeri, € 37,00; paesi extracomunitari, due numeri, € 43,00. I versamenti in conto corrente postale devono essere effettuati sul ccp n. 25507179 intestato a Ass. Il Bene Comune, Campobasso Garanzia di riservatezza per gli abbonati. L’editore fornisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti agli abbonati. Ai sensi degli artt. 7, 8, 9, D. lgs. 196/2003 gli interessati possono in ogni momento esercitare i loro diritti rivolgendosi a: Il Bene Comune, viale Regina Elena, 54 – 86100 Campobasso, tel. 0874 979903, fax 0874 979903, [email protected] Il garante per il trattamento dei dati stessi ad uso redazionale è il direttore responsabile 4 Migrazioni Novembre 2011 Argilli / Casacchia / Chieffo / Chiodi / Colucci / Costa / Crisci / De Clementi / De Luca / De Martino / Di Rocco / Di Stasi / Faonte / Izzo / N. Lombardi / T. Lombardi / Marinaro / Martelli / Massa / Massullo / Melone / Palmieri / Pazzagli / Pesaresi / Piccoli / Pittau / Presutti / Ruggieri / Scaroina / Spina / Tarozzi / Verazzo In copertina: Berga, Gli emigranti, tecnica mista, tela, 110 x 140 cm, 2012 © 2013 Glocale. Rivista molisana di storia e scienze sociali, Edizioni Il Bene Comune Tutti i diritti riservati Registrazione al Tribunale di Campobasso 5/2009 del 30 aprile 2009 / 4 / 2011 Indice 9 Migrazioni, dal secondo dopoguerra ad oggi FACCIAMO IL PUNTO 17 L’emigrazione meridionale nel secondo dopoguerra di Andreina De Clementi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 37 I limiti della riforma agraria Forme e tempi dell’esodo Il sorpasso meridionale I quartieri italiani Il polo europeo L’inarrestabile cataclisma Ruoli e percorsi di genere L’impiego dei risparmi e delle rimesse Il futuro nel passato Governi, partiti, sindacati: le politiche dell’emigrazione di Michele Colucci 1. Le posizioni dei partiti e dei sindacati all’indomani della guerra 2. Le sinistre 3. La Democrazia cristiana IN MOLISE 51 I molisani tra vocazioni transoceaniche e richiami continentali di Norberto Lombardi 1. 2. 3. 4. 5. Cade lo steccato del Molise «ruralissimo» Esodo e spopolamento Vecchie traiettorie transoceaniche Nuovi approdi transoceanici La scoperta dell’Europa 5 / 4 / 2011 6. La svolta europea 7. Molisani nel mondo 8. Le reti associative 9. Le leggi e le Conferenze regionali 10. Studi e rappresentazioni dell’emigrazione dei molisani 11. Conclusioni: quasi un inizio 107 Appendice: Le associazioni di Molisani in Italia e nel mondo a cura di Costanza Travaglini 117 L’esodo dal Molise tra il 1952 e il 1980. Nuove destinazioni e riflessi socio-economici di Cristiano Pesaresi 1. Il quadro d’insieme 2. Le principali destinazioni nell’intervallo 1962-68 e le condizioni socioeconomiche del Molise 3. Le tendenze degli anni 1972-80 e le condizioni socio-economiche del Molise 131 La mobilità silente: i molisani nei percorsi globali di Oliviero Casacchia e Massimiliano Crisci 1. 2. 3. 4. 151 La mobilità residenziale dagli anni novanta ad oggi Concetto e fonti della mobilità temporanea di lavoro I flussi temporanei per lavoro Alcune conclusioni L’immigrazione nel Molise: presenze, aspetti sociali e occupazionali di Renato Marinaro e Franco Pittau 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 165 Il Molise nell’attuale quadro nazionale dell’immigrazione I dati principali sulle presenze Gli indicatori sociali Le statistiche occupazionali Immigrazione e integrazione L’emergenza del 2011: l’accoglienza dei flussi in provenienza dal Nord Africa Conclusioni: potenziare le politiche migratorie e la sensibilizzazione Letteratura come autobiografia: la scrittura di Rimanelli tra le due sponde dell’oceano di Sebastiano Martelli 6 Indice INTERVISTE 185 Testimonianze d’altrove: domande per alcuni giovani diplomati e laureati che hanno lasciato il Molise negli ultimi anni a cura di Norberto Lombardi IERI, OGGI E DOMANI 205 Risorse umane Tavola rotonda a cura di Antonio Ruggieri RIFLESSIONI 247 Dal globale al locale. Riflessioni sul progetto territorialista di Rossano Pazzagli 1. 2. 3. 4. 253 Ritorno al territorio Il territorio come bene comune Urbano e rurale Nuovi sentieri nell’orizzonte della crisi Territorialità, glocalità e storiografia di Gino Massullo 1. Comparazione e contestualizzazione 2. Territorialità e glocalità WORK IN PROGRESS 261 Identità, emigrazione e positivismo antropologico di Paola Melone 1. 2. 3. 4. Introduzione Considerazioni concettuali La corrente del positivismo antropologico L’emigrazione italiana negli Stati Uniti: la classificazione etnica e gli stereotipi culturali 5. Conclusioni 275 Donne e corporazioni nell’Italia medievale di Jacopo Maria Argilli 7 / 4 / 2011 DIDATTICA 289 Tra “buona pratica” e teoria efficace. Quando la Storia aiuta la persona, stimola il gruppo, sostiene un popolo di Clara Chiodi e Paola De Luca 1. Primi giorni di scuola 2. Cognizione e metacognizione 3. Dal bisogno educativo all’azione didattica STORIOGRAFIA 297 Fra storiografia e bibliografia. Note sui “libri dei libri” di Giorgio Palmieri 1. Un “libro dei libri” 2. Altri “libri dei libri” 3. I “libri dei libri” MOLISANA 307 Almanacco del Molise 2011 Recensione di Antonella Presutti 313 Salvatore Mantegna, Giacinta Manzo, Bagnoli del Trigno. Ricerche per la tutela di un centro molisano Recensione di Clara Verazzo 316 I di Capua in Molise e il controllo del territorio. Note a margine della presentazione del volume curato da Daniele Ferrara, Il castello di Capua e Gambatesa. Mito, Storia e Paesaggio di Gabriella Di Rocco 321 Abstracts 327 Gli autori di questo numero 8 / 4 / 2011 / Facciamo il punto FACCIAMO IL PUNTO L’emigrazione meridionale nel secondo dopoguerra di Andreina De Clementi Al termine della seconda guerra mondiale, le già provate condizioni materiali degli italiani non trassero alcun sollievo dalla politica economica della nuova classe dirigente. Il concatenarsi della stretta creditizia con la chiusura delle imprese meno competitive deflagrò in una disoccupazione di inusitata ampiezza. Il Mezzogiorno ne subì le conseguenze più pesanti e l’unica possibilità di sopravvivenza apparve ancora una volta l’espatrio. Sulle orme dei nonni, che l’avevano sperimentato oltre mezzo secolo prima. Lo stato italiano, che al tempo della grande emigrazione postunitaria era rimasto pressoché inerte limitandosi a incamerare e mettere a frutto la valanga di rimesse piovuta da altri mondi, in questa difficile congiuntura se ne fece invece promotore, sollecitò paesi a corto di mano d’opera alla stipula di trattati bilaterali – regolarmente inapplicati specie in fatto di tutela degli emigranti – e si prodigò nell’incoraggiare le partenze, onde smaltire altrove le schiere di disoccupati e le turbolenze politiche di quegli anni. Senza preoccuparsi troppo degli arrivi. Di questo nuova ondata si possono distinguere quanto meno due fasi: il decennio della ricostruzione, in cui si riannodarono vecchi fili, specie con i maggiori paesi dell’America latina, e quello successivo che vide il declino delle rotte transoceaniche, l’alterno protagonismo dei paesi europei e la prepotente irruzione degli epicentri del “miracolo” italiano. Il consolidamento si può far risalire alla metà degli anni sessanta, quando emergono «le caratteristiche di una vera e propria emigrazione di massa, di un fenomeno netto e permanente»1. 1. I limiti della riforma agraria Dopo che, dapprima nel 1947 poi con la sconfitta elettorale dell’anno successivo, il Partito comunista venne definitivamente estromesso dal governo, la classe dirigente democristiana si trovò a dover fronteggiare le esasperate 1 Fortunata Piselli, Parentela e emigrazione, Einaudi, Torino 1981, p. 326. 17 / 4 / 2011 / Facciamo il punto lotte per la terra ingaggiate dalle masse contadine meridionali. E lo fece tanto a colpi di fucile, quanto con tentativi assai guardinghi di riforma agraria, che nel decennio 1948-59 segnarono un notevole incremento della piccola proprietà contadina2. Quegli interventi rimasero tuttavia sporadici e frammentari: nel maggio 1950, entrò in vigore la legge Sila che assegnò alla Calabria oltre 4 mila ettari di terra e subito dopo, in ottobre, la legge stralcio, allargata alle zone tradizionali del latifondo contadino (Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna) e comprensiva del bacino del Fucino, situato nel territorio abruzzese-molisano3 e considerato «una delle zone di riforma più importanti, in cui praticamente ogni comune aveva partecipato alla turbolenta lotta per la terra»4. La distinzione tra poderi (o lotti) e quote, prevista dal legislatore, stava a indicare ampiezze e destinazioni disparate; i poderi designavano piccoli appezzamenti da ripartire tra i braccianti senza terra, mentre le quote servivano a integrare le microaziende. Nei fatti, le quote furono usate «per lo più indiscriminatamente per distribuire la terra al maggior numero possibile di contadini»5. In modo da ampliare l’area del consenso politico, e a costo di far proliferare, al tempo stesso, all’infinito la parcellizzazione fondiaria. Del resto, ogni podere superava di poco l’ettaro, vale a dire che era quanto di più lontano dall’autosufficienza. Non erano trascorsi neanche dieci anni che la gran parte delle speranze riposte in questo che era apparso il coronamento di aspirazioni secolari si rivelarono illusorie. Non è questa la sede per tracciare un bilancio della politica governativa nel Mezzogiorno – sulla quale i giudizi sono andati sempre più raffreddandosi –, il fatto si è che la gran parte delle aree coinvolte vennero via via abbandonate. In una zona del catanzarese, ad esempio, l’Ente Sila aveva elargito quote distanti fino a 20 chilometri dall’abitato, e perciò in breve disertate da assegnatari 2 La riforma distribuì nel complesso 279.880 ha tra poderi e quote: nella zona del Fucino 13.495 ha divisi in quote da 1,50 ha assegnate a 9.026 famiglie; in Campania 14.914 ha per 3.529 famiglie con poderi di 7,40 ha e quote di 1,53; in Puglia, Basilicata e Molise 174.098 per 31.534 famiglie con poderi da 8,46 ha e quote da 2,40; in Calabria 77.373 ha per 18.902 famiglie, poderi da 5,72 ha e quote da 2,97. Nel Molise, in particolare, vennero sottoposti a riforma 4.700 ha nei comuni della fascia litoranea adriatica di Campomarino, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecifone, Montenero di Bisaccia, Petacciano, Portocannone, Rotello, Termoli, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis e Santa Croce di Magliano. Gino Massullo, Dalla periferia alla periferia. L’economia del Novecento, in Id. (a cura di), Storia del Molise, Donzelli Editore, Roma 2006, p. 490. Crebbero anche le piccole proprietà contadine per un totale di 212.148 per 263.048 ha, di cui 46.759 per 49.128 ha in Abruzzo e Molise. Francesco Barbagallo, Lavoro e esodo nel sud, 1861-1971, Guida, Napoli 1973, p. 202. 3 Il banchiere romano Alessandro Torlonia ne era entrato in possesso verso la metà dell’Ottocento e ne aveva realizzato la bonifica. 4 Sidney Tarrow, Partito Comunista e contadini nel mezzogiorno, Einaudi, Torino 1972, p. 323. 5 Ivi, p. 325. 18 De Clementi, L’emigrazione meridionale nel secondo dopoguerra carichi di debiti6. Un esito analogo a Gaudiano, uno dei baricentri della legge stralcio in Lucania, dove le 400 famiglie che si erano trasferite in case costruite dall’ente riforma erano state abbandonate a se stesse7. E a Minervino Murge, dove le campagne erano state lasciate senza energia elettrica né acqua8. Secondo il meridionalista più autorevole della seconda metà del secolo scorso, Manlio Rossi-Doria, proprio nel regno del «latifondo contadino», e della «più acuta miseria contadina», si era avuto il 50% degli espropri per un totale di 350 mila ettari, ma tutto era avvenuto «in modo capriccioso e disordinato, a seconda della casuale distribuzione delle grandi proprietà espropriate»9. Neppure i fondi erogati dalla Cassa del mezzogiorno, istituita il 10 agosto 1950, dettero risultati sensibili. Tra i tanti, l’industriale biellese Rivetti aveva impiantato a Maratea una fabbrica tessile, ma, discriminazioni a parte, i salari della mano d’opera locale erano risultati dimezzati rispetto a quelli corrisposti al nord10. E se ciò non fosse bastato, le fonti di occupazione locale non fecero che assottigliarsi. Durante e dopo la guerra una parte cospicua del patrimonio boschivo silano era andata distrutta, le grandi segherie erano state costrette a chiudere e lasciare senza lavoro migliaia di operai11. Le antiche forme di industria agricola, esercitate dalle donne nel chiuso dell’ambito domestico e votate alla perpetuazione di un’economia di sussistenza, avevano anch’esse i giorni contati. L’artigianato di tessuti e canestri tipico delle campagne sarde era in via di estinzione12. Il 19 aprile del 1960 il quotidiano “Il Tempo” pubblicò una lettera inviata dal sindaco democristiano del paese lucano di Sant’Arcangelo che non aveva trovato altro modo di rivolgersi alle autorità per fare presente che le frane causate dall’ultimo inverno molto piovoso avevano interrotto in più punti l’unica strada che collegava ad altri centri i settemila abitanti del paese, senza contare che le periodiche piene del fiume Agri avevano travolto circa mille ettari di un fertile territorio, «coltivato ad orti-giardini che costituivano la vera ricchezza agricola della popolazione»13. I toni esasperati della denuncia del sindaco scivolavano nel sarcasmo: L’unico vantaggio che si è avuto in un secolo è stata l’acqua in paese […] e la luce elettrica che consentendo l’uso della radio e della televisione, rendo6 Giuseppe Pace, Lo spopolamento della Calabria, «Cronache meridionali», 1960, 9, p. 566. Donato Scutari, L’emigrazione dalla provincia di Potenza, ivi, p. 572. 8 Svimez, Ricerca sull’emigrazione interna nel Mezzogiorno. Indagine su Minervino Murge, Roma 1963, p. 11. 9 Manlio Rossi-Doria, La riforma agraria sei anni dopo (1957), in Augusto Graziani (a cura di), L’economia italiana 1945-1970, Il Mulino, Bologna 1972, p. 253. 10 D. Scutari, L’emigrazione, cit., p. 566. 11 G. Pace, Lo spopolamento, cit., p. 567. 12 Svimez, Ricerca sull’emigrazione, Indagine su Lodè, Roma 1963, pp. 6 e 65. 13 D. Scutari, L’emigrazione, cit., p. 573. 7 19 / 4 / 2011 / Facciamo il punto no consapevoli i cittadini che esistono altrove nel vasto mondo, e anche in Italia, aeroporti, aerei a reazione, ultrasonici, elicotteri, strade ferrate, autostrade bellissime, lussuose e costosissime, che li inducono a paragoni e contrasti col biblico somarello cui devono essere ora relegati dopo tanto decantato progresso!14. La televisione era arrivata fino in Sicilia quattro anni prima e che il suo sguardo sul mondo fosse un potente stimolo a cambiar vita sarebbe difficile negare. 2. Forme e tempi dell’esodo Stando così le cose, non c’è di che meravigliarsi se una parte consistente della popolazione meridionale si ingegnò a cercare altrove le proprie fonti di sussistenza. Tocca a noi ricostruirne le strategie migratorie con una approssimazione non troppo lontana dal vero. Cerchiamo anzitutto di fissare alcuni punti fermi: 1. L’abbandono dell’agricoltura precedette nel tempo l’abbandono della residenza 2. e la migrazione estera precedette quella interna 3. con meta prevalente nei paesi europei e carattere temporaneo, spesso stagionale; 4. il declino dell’emigrazione estera venne compensato dall’ascesa dell’emigrazione interna 5. che determinò il trasferimento definitivo di interi nuclei familiari e lo spopolamento delle campagne. Nel ventennio cinquanta-settanta, l’agricoltura si ritrovò depauperata di circa due milioni di addetti. Ma attribuire questa perdita al salvacondotto di un’emigrazione immediata sarebbe fuorviante. Secondo le analisi più avvedute, infatti, il distacco dalla terra si consumava col passaggio alle attività extra-agricole, cioè con un trasferimento tra settori; l’emigrazione subentrava solo in un secondo momento. I nuovi insediamenti industriali del meridione avevano suscitato aspettative molto superiori alle loro potenzialità, la loro capacità di assorbire occupazione aveva soddisfatto la sola offerta dei comuni capoluogo, mentre a chi veniva dall’entroterra erano rimaste le briciole, ingaggi brevi, precari e saltuari. Poiché inoltre il tessuto produttivo locale e i posti di lavoro preesistenti ne erano stati distrutti, si era passati «da situazioni di disoccupazione o sottoc14 20 Ibid., corsivo mio. De Clementi, L’emigrazione meridionale nel secondo dopoguerra cupazione occulta a situazioni di disoccupazione aperta, e quindi il ricorso all’emigrazione»15. Una parte importante avevano svolto in questa dinamica i cantieri aperti dal 1955-56 dalla Cassa del mezzogiorno: la loro naturale temporaneità non aveva affatto facilitato il ritorno all’agricoltura. Una volta terminati i lavori, si pensava piuttosto a cercarsene altri16. Tuttavia, per quanto prevalente, questo modello non era universale. Secondo il suo stesso autore «il trasferimento intersettoriale, per lo più in posti di lavoro precario, precede in due casi su tre quello interregionale, cioè la vera e propria emigrazione»17. Come sembrava tipico del foggiano, dove questa era stata la sola forma di esodo dall’agricoltura, «non opere pubbliche o altro»18. Secondo Barbagallo, lo sfollamento dell’eccesso di popolazione provocò, tra il 1956 e il 1964, una notevole espansione dell’agricoltura e un mutamento significativo nell’occupazione, che vide scemare quella maschile e guadagnare parecchi punti quella femminile tra i coadiuvanti e tra i lavoratori in proprio19. Ma questa valutazione ottimistica collide con le considerazioni conclusive dell’Inchiesta Svimez secondo cui la minore pressione demografica sortì soltanto l’abbandono dei terreni meno produttivi20 e tendeva a occultare situazioni locali tutt’altro che rassicuranti: l’assenza di investimenti registrata nel Chietino, ad esempio21, lo scarseggiare della mano d’opera e la sempiterna bassa produttività del Tavoliere22, l’abbandono dell’agricoltura nelle zone interne della Sardegna per un pascolo reso sempre più stentato dalla frammentazione fondiaria23, o impedito del tutto, per questo stesso motivo, in ampie aree del Molise24. Dagli anni sessanta in poi, l’emigrazione di lunga distanza – specie la definitiva – avrebbe conosciuto un declino irreversibile. Nella mappa migratoria transoceanica alcuni vecchi sentieri erano ormai impraticabili, primo fra tutti quello verso gli Stati Uniti, altri erano tornati invitanti fino alla lusinga: il Brasile, ma soprattutto l’Argentina, millantata dalla 15 Guido Cella, Industrializzazione ed emigrazione: il caso del Mezzogiorno nel decennio 1961-1971, «Rassegna economica», 1974, 4, pp. 1067-1088. Che l’abbandono dell’agricoltura abbia preceduto nel tempo quello delle residenze è stato sostenuto anche da Salvatore Cafiero e Giovanni Enrico Marciani, L’emigrazione dalle zone povere, in: A. Graziani, L’economia italiana, cit., p. 275. 16 Svimez, Ricerca sull’emigrazione, cit., Rapporto generale, p. 15. 17 G. Cella, Industrializzazione, cit., corsivo mio. 18 Svimez, Indagine su Biccari, cit., p. 16. 19 1951-6: dipendenti da 726.814 maschi a 581.593 e da 362.201 femmine a 405.572; tra gli autonomi le donne da 75.170 a 90.289. F. Barbagallo, Lavoro e esodo, cit., p. 206. 20 Svimez, Ricerca, Rapporto generale, cit., p. 36. 21 Svimez, Ricerca, Indagine su Guardiagrele, cit., p. 21. 22 Ivi, Indagine su Minervino Murge, cit., p. 38. 23 Ivi, Indagine su Lodè, Roma 1963, p. 5. 24 William A. Douglass, Emigration in a South Italian Town. An Anthropological History, Rutgers Univ. Press, New Brunswick 1984, p. 179. 21 / 4 / 2011 / Facciamo il punto demagogia del nuovo caudillo Juan Peròn. Erano poi apparsi nuovi soggetti: l’Australia, la cui ascesa dissimulava molte fragilità e che coltivava abissali distanze culturali, e il Canada, cui si sarebbe aggiunto più tardi il Venezuela. Seppellita una volta per tutte la mitopoietica del paese della cuccagna, le destinazioni transoceaniche si ridussero in breve a poca cosa, schiacciate da politiche restrizioniste, tracolli finanziari, delusioni di ogni tipo25. 3. Il sorpasso meridionale Fin dagli esordi del nuovo ciclo migratorio il Mezzogiorno fece la parte del leone; l’esodo settentrionale, Veneto escluso, era acqua passata. Quali che fossero le mete, ovunque si verificò il sorpasso: i nuovi arrivati in Argentina «provenivano soprattutto dall’Italia nord orientale e dal meridione»26. Dei 500 mila emigrati in Canada fino al 1975, il 70% veniva dal sud (Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise, Lazio, Veneto e Campania)27: tra il 1959 e il 1979, «il 56% degli emigrati italiani in Australia è arrivato dall’Italia meridionale e il 25,5% dall’Italia insulare, con Calabria e Sicilia tra le regioni con le percentuali più alte»28. Sud e Sicilia erano andati ad affollare il Venezuela29. La mano d’opera migrante venne in prevalenza assorbita nell’edilizia urbana e nelle infrastrutture – cuore degli ambiziosi progetti dell’Argentina peronista – nella più tardiva modernizzazione venezuelana, nella ricostruzione europea dalle rovine della guerra e nella crescita delle città. Anche laddove era decollato un imponente sviluppo industriale, come nella Rft e nello stesso nord Italia, l’ingresso in fabbrica era una conquista faticosa e remota, a causa dell’alterità professionale di tutta una popolazione dedita al precariato agricolo. La ripresa dell’emigrazione transoceanica ebbe inizio nell’immediato dopoguerra in parziale continuità con l’esperienza di fine Ottocento: Stati Uniti a parte, che tuttavia per un breve periodo non smisero di accogliere nuovi arrivi, Argentina e Brasile tornarono ad aprire le loro frontiere. Col governo argentino, e grazie a buoni auspici politici, vennero siglati allo scopo due accordi30, che sembravano dischiudere un promettente avvenire. Errore. Le 25 Per l’architettura complessiva del presente saggio, rinvio a Andreina De Clementi, Il prezzo della ricostruzione, Laterza, Roma 2010. 26 Fernando Devoto, In Argentina, in Piero Bevilacqua, Andreina De Clementi, Emilio Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana. Arrivi, Donzelli Editore, Roma 2002. 27 Gabriele Scardellato, A Century and More of Toronto Italia in College Street Little Italy, «Studi Emigrazione», 2007, 166, pp. 273-294. 28 Adriano Boncompagni, In Australia, in P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, Storia dell’emigrazione, cit., p. 116. 29 Vittorio Cappelli, In Venezuela, ivi, p. 108. 30 «Al successo dell’accordo giovava anche la promozione della destinazione argentina da parte del mondo cattolico italiano, in primis il Vaticano e la Democrazia cristiana e in generale della destra, che vedeva l’Argentina peronista più adatta a conservare i “valori” degli italiani piuttosto che la Francia (preferita invece dalla sinistra)», in F. Devoto, In Argentina, cit., p. 51. 22 De Clementi, L’emigrazione meridionale nel secondo dopoguerra smargiassate del pur popolarissimo dittatore ebbero, per così dire, le gambe corte. Il paese sprofondò in una gravissima crisi economica e pesanti ripercussioni si riversarono sull’immigrazione: disoccupazione, drastiche sforbiciate all’invio di rimesse, una crisi degli alloggi senza precedenti e l’addio alla possibilità di farsi raggiungere dalla famiglia 31. A farla breve, le cattive notizie rimbalzarono attraverso l’oceano e gli arrivi presero a rarefarsi fino ai 10.000 l’anno dal 1955 per scomparire quasi del tutto dal 1959. Il Brasile non fece una migliore riuscita. E non poteva farla, dal momento che già nel 1902 il governo italiano ne aveva bloccato l’afflusso a seguito di allarmanti resoconti. Nessun mutamento sostanziale era da allora intercorso che potesse far sperare in un’inversione di rotta. Ad ogni modo, pur avendo perso parecchio terreno, l’emigrazione di lunga distanza aveva guadagnato i nuovi spazi dei paesi emergenti. Offrivano i lavori più faticosi e peggio pagati, baracche e alloggi di fortuna, il disprezzo dei nativi e discriminazioni a ogni piè sospinto. In aggiunta agli stereotipi razzisti che volevano gli italiani fannulloni, concorrenti sleali nel lavoro e “sciupa femmine”, gli si imputavano anche il passato fascista e la guerra perduta. In Australia e in Canada, dove si approdava da soli, le donne giravano al largo e i giorni di riposo annegavano nell’inerzia e nella noia 32. E perciò i rimpatri fioccavano33 e i censimenti recavano avarissime tracce di passaggi viceversa molto più numerosi. La comunità italiana in Australia si era formata tra il 1941 e il 1961 alimentata dai richiami, ma l’internamento di 4.727 dei suoi durante la guerra l’aveva precipitata in uno stato di profonda prostrazione. La fragile economia australiana si era rivelata meno prospera delle previsioni, nei lunghi periodi di ozio forzato l’unica scappatoia era il taglio della canna nel Queensland, dove finivano anche i più specializzati34. In Canada, invece, giocavano a sfavore l’ansia di lasciare la campagna per le città e il rimpianto dei nativi per i belgi, stimati agricoltori provetti e gran lavoratori. Specie nel biennio 1952-54, il Belgio fu spesso la tappa intermedia, o in attesa della traversata o in fuga dalle miniere35. Rimesse, lettere, giornali, nuovi arrivi e nuove partenze, era tutto un viavai di gente e di notizie che tenevano in vita rapporti a rischio di spezzarsi. Chi aveva 31 Andreina De Clementi, Il prezzo della ricostruzione. L’emigrazione italiana nel secondo dopoguerra, Laterza, Roma 2010, pp. 15-18. 32 Ivi, pp. 73-89. 33 Nel periodo 1960-69, furono dell’ordine del 33,5%, scesi al 25,8% sul lungo periodo 1947-80. I rimpatri più numerosi in Venezia Giulia (77,5%) e in Veneto (71,3); all’altro estremo la Calabria col 14,1%, il Molise col 14%. In Stefano Luconi, I paradigmi recenti dell’emigrazione italiana e il caso australiano, «Studi emigrazione», 2009, 46, pp. 793-816. 34 Francesco Cavallaro, Italians in Australia: Migration and Profile, «Altreitalie», 2003, 26, pp. 65-87. 35 Maccari-Clayton, From ´Watchdog´ to ´Salesmen´: Italian re-emigration from Belgium to Canada after the II World War, «Studi emigrazione», apr.-giu. 2007, pp. 327-336. 23 / 4 / 2011 / Facciamo il punto attraversato l’oceano, o anche soltanto valicato le Alpi, doveva vedersela con parenti e compaesani rimasti in patria e con le società ospiti. Con i primi era un canale sempre aperto, fatto di reiterate conferme affettive e di altrettanto reiterate richieste di denaro – la festa, l’ospedale, l’asilo infantile, le vittime di epidemie, di terremoti, della guerra – che non restavano mai lettera morta36. Dall’altra occorreva difendersi, e affidarsi a solidarietà trascorse o ritrovate. 4. I quartieri italiani Un’istituzione tipica dell’emigrazione transoceanica era stato il quartiere italiano, sbrigativamente denominato ovunque Little Italy, locuzione vigente in realtà nei soli Stati Uniti. Vero è che, da una meta all’altra, differenze ce n’erano, ma il modello statunitense aveva dalla sua la linearità e la riproducibilità. Garroni ne riassume la definizione elaborata negli anni trenta dalla scuola di Chicago in questi termini: una «formazione sociale con una propria forma di organizzazione interna legata ad una dimensione spaziale, geografica […] che svolge un ruolo autonomo, caratterizzante l’intero gruppo ad essa collegata»37. Si potrebbe aggiungere che la Little Italy era in grado di soddisfare una gamma molto estesa di bisogni, dall’assistenza ai nuovi arrivati alla disponibilità di servizi, alle esigenze affettive, alle molte forme di reciprocità. Va da sé che tutto ciò non poteva certo esorcizzare tensioni e conflitti. Anzitutto intergenerazionali. Italiani erano certo i nuovi arrivati, ma portavano con sé un bagaglio culturale – provenienza, vissuto storico (il fascismo e la guerra) e contesto sociale – spesso tale da estraniarli dai connazionali di lunga residenza. I contrasti erano ovunque all’ordine del giorno; gli ultimi erano sempre meno poveri e più evoluti, e tendevano a non riconoscersi nei traguardi raggiunti dai primi. I requisiti primari della comunità etnica risiedevano in un’immigrazione di genere – famiglio-centrica – e in un’appartenenza geografica di tipo molecolare, fondata su reti parentali e paesane. In forza di ciò, le recentissime istituzioni regionali italiane di età repubblicana avrebbero avuto buon gioco a stringere legami con l’associazionismo d’oltre oceano e a promuovere un gran numero di federazioni gemelle. Un’importanza a sé spettava alle feste dei santi patroni, tali e quali – almeno nell’immaginario dei partecipanti – a quelle celebrate in patria, coagulo di una forte esigenza identitaria. La vitalità di queste micro-società autosufficienti venne messa a dura prova nel secondo dopoguerra, quando la sopraggiunta prosperità dei tardi anni 50 36 Douglass riferisce con tutti i particolari del caso della generosità degli agnonesi all’estero. Emigration in a South Italian village, cit., pp. 120 e passim. 37 Maria Susanna Garroni, Little Italies, in P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, Storia dell’emigrazione, cit., p. 212. 24 De Clementi, L’emigrazione meridionale nel secondo dopoguerra trasformò da cima a fondo le città, modernizzò i trasporti, creò nuovi quartieri e infoltì la varietà dei servizi, e gli italiani si sparpagliarono a loro volta nelle zone residenziali suburbane. Le fortune delle Little Italy nordamericane si palesarono così inversamente proporzionali al progressivo grado di integrazione e di riuscita sociale dei loro abitanti. Ma politiche migratorie disomogenee potevano sortire esiti altrettanto diversi. Come sembrerebbe dimostrare il parallelismo USA-Canada analizzato da Bruno Ramirez38. La chiusura delle frontiere statunitensi era stata in parte compensata dall’alternativa canadese, e ne aveva fatto scattare i 152 mila arrivi a 750 mila, concentrati a Toronto e Montreal. Gli USA accoglievano ormai soltanto 25 mila italiani l’anno, una goccia nel mare dei 6-7 milioni di vecchi immigrati – ormai parecchie generazioni – affatto americanizzati durante la guerra e nel corso della guerra fredda; gli ultimi arrivati venivano introdotti all’american way of life senza mettere mai piede nei vecchi quartieri. I quali, già attanagliati dalla crisi, erano stati resi anche più pericolanti dalla vicinanza con gli insediamenti afro-americani sorti da quella recente, imponente, immigrazione – tre milioni e mezzo tra il 1940 e il 1966 –, teatro di frequenti conflitti interrazziali. Situazione che aveva persuaso gli antichi abitanti ad abbandonare il campo e inflitto così alle Little Italy il colpo di grazia. A fronte di questa débacle del melting-pot, il multiculturalismo canadese sembrava aver fornito un’attrezzatura più adatta alle prove di sopravvivenza assecondando il reintegro dei vecchi quartieri nella loro vocazione di comitato di accoglienza. Al punto che la Little Italy di Toronto aveva dovuto ampliare i suoi confini39. La forza del modello venne dimostrata dal suo riproporsi nelle nuove destinazioni post-belliche. Nuclei abitativi su base territoriale erano sorti in Australia, dove tra gli altri il ceppo siciliano, disarticolato nelle sue diramazioni di Messina, Naso e Vizzini, si era disseminato in zone e città diverse40. Sul fatto che comunque la disponibilità di un network di riferimento potesse spianare la strada al successo sociale c’era poco da dubitare, e non ne mancavano esempi di indubbia efficacia. Fernando Devoto riprende da uno studio apparso nel 1992 il caso di due gruppi approdati nel secondo dopoguerra nella città argentina di Rosario, rispettivamente dal Molise e dalla Basilicata. Nel volgere di pochi anni, le loro sorti si erano divaricate: il primo, forte dell’appoggio di parenti e compaesani da tempo inseriti nel commercio della panificazione, aveva risalito i ranghi della classe media; l’altro invece, 38 Bruno Ramirez, Decline, Death and Revival of Little Italies: the Canadian and U.S. Experience Compared, «Studi Emigrazione», 2007,166, pp. 337-354. 39 G. Scardellato, A century and More, cit. 40 F. Cavallaro, Italians, cit. 25 / 4 / 2011 / Facciamo il punto affatto privo di contatti, era rimasto abbarbicato al primo impiego in una fabbrica siderurgica ubicata nella periferia cittadina41. Le Little Italy, o comunque li si chiamassero i quartieri italiani, erano un’esclusiva dei paesi transoceanici, e per ragioni facilmente intuibili: nell’emigrazione europea regnavano temporaneità e mascolinità e in molti casi gli alloggiamenti erano predisposti dagli stessi datori di lavoro per ammucchiare insieme intere squadre operaie; nei bacini minerari belgi e, più tardi, nella Germania Federale gli uomini venivano stipati nei campi costruiti dall’occupazione nazista per i prigionieri russi. Se a sistemazioni così infelici andavano a sommarsi gli intralci ai ricongiungimenti familiari, va da sé che l’idea del “mordi-e-fuggi” tendeva a soffocare qualsiasi programma di lungo respiro. Dove viceversa, come in Francia, si era in presenza di un’emigrazione consolidata e di una domanda agricola soverchiante, che aveva finito con l’aprire agli italiani anche la esclusiva coltivazione delle barbabietole, questi avevano mano libera e potevano, a seconda delle esigenze, tanto disperdersi nelle campagne quanto rifugiarsi nelle enclaves urbane. 5. Il polo europeo Il trattato di Roma stipulato nel 1958, che liberalizzava la circolazione intercontinentale, aveva irrobustito la capacità di attrazione dei paesi europei. Con i quali – e a differenza dai connazionali del nord -, gli emigrati meridionali non avevano mai avuto gran dimestichezza. Una comunità pioniera come la molisana Agnone si era diretta fin dai primordi in Argentina e lì aveva intessuto le proprie fortune: l’Europa era stata una scoperta del nuovo dopoguerra42. Nel primo decennio postbellico richiesero mano d’opera aggiuntiva la Svizzera e la regione dei grandi giacimenti carboniferi franco-belgi. La Francia continuò ad accogliere italiani a qualsiasi titolo (assistiti, liberi e clandestini), fedele al doppio regime lasciava convivere indisturbate durezza legislativa e sfacciata tolleranza della clandestinità. Bruciante l’esperienza del Belgio, che scambiava carbone con uomini. Il carbone era ormai una fonte energetica obsoleta ed era in procinto di cedere al petrolio; i due grandi monopoli che controllavano le miniere cercavano di sfruttarle fino allo spasimo rifuggendo da qualsiasi investimento: venivano riaperti vecchi pozzi già abbandonati e gli incidenti spesso mortali si susseguivano senza tregua. I vantaggi salariali avevano nondimeno la meglio su quelle avvilenti condizioni di vita e di lavoro, ma erano in molti a girare i tacchi alla prima discesa nei pozzi o prima ancora di calarvisi. Fino alla tragedia di Marcinelle nella quale morirono 262 lavoratori, di cui 132 italiani, e che segnò la fine di quell’emigrazione italiana. 41 42 26 F. Devoto, In Argentina, cit, p. 52. W. A. Douglass, Emigration in a South Italian village, cit., p. 198. De Clementi, L’emigrazione meridionale nel secondo dopoguerra Sorprendente l’ostracismo britannico. Un patto di ferro stretto tra il governo laburista e le potenti Trade Unions aveva consentito di scaricare sulla classe operaia il fardello della ricostruzione in cambio del blocco delle frontiere a tutela della piena occupazione. E sì che nel volgere di qualche anno, un ormai incolmabile deficit di mano d’opera avrebbe fatto perdere al Regno Unito lo scettro di massimo esportatore di carbone. La capacità di far rispettare il patto dipendeva dal potere di ciascun sindacato, in specie delle agguerrite “logge” locali che non intendevano minimizzare le contropartite ricevute dal governo. Per contro, i settori meno protetti dell’occupazione femminile aprirono le porte alle straniere. Di operaie tessili, domestiche, inservienti ospedaliere c’era grande richiesta e, per la prima volta nella storia dell’emigrazione italiana, frotte di giovani donne sole attraversarono la Manica sopravanzando il contingente maschile43. Non prima di aver portato a termine una ricostruzione di imprevedibile successo, la Repubblica Federale Tedesca balzò in vetta alla graduatoria dei paesi importatori di mano d’opera e nei primi anni sessanta assorbì il 40% del totale transalpino. Alla fine del decennio strappò il primato alla Francia. La sconfitta bellica aveva interrotto i rapporti di lavoro italo-tedeschi, dapprima assai intensi. Ma la memoria di quei trascorsi era rimasta viva se nel settembre del 1961 il direttore generale della Volkswagen ebbe a dichiarare che il bisogno di mano d’opera straniera andava coperto da soli italiani, i quali avevano già lavorato lì nel 1938-39, alla costruzione della fabbrica e della stessa città di Wolfsburg. A rafforzare questa preferenza, la difficile convivenza con altri gruppi nazionali e la intermediazione del Vaticano con i parroci e le ACLI, garanti della docilità dei soggetti selezionati. I quali lavoravano a più non posso per guadagnare il massimo e affrettare il rientro44, superando di parecchie lunghezze la spiccata tendenza al turn-over tanto caratteristica di questo ciclo migratorio. In effetti, un vero record: «In nessun caso – scrive Enrico Pugliese – la differenza tra quanti hanno vissuto l’esperienza migratoria e quanti sono rimasti nei paesi d’arrivo è stata così modesta, né così alto è stato mai il numero dei rientri». Infatti, tra il 1955 e il 1999, erano approdati in Germania quasi quattro milioni di italiani, e vi erano rimasti in 466.370, pari al 12% del totale45. Con grande soddisfazione delle autorità tedesche, che, fino a tempi recentissimi, hanno ostinatamente rifiutato la definizione di paese di immigrazione, insistendo sulla formula dell’ospitalità temporanea in spregio ad ogni evidenza e, in forza di ciò, escogitando svariati stratagemmi intimidatori, dagli ostacoli al ricongiungimento familiare alla emarginazione scolastica. 43 Nel censimento britannico del 1951, su 34.000 italiani, le donne erano 21.000 (60%). Lucio Sponza, Gli italiani in Gran Bretagna. Profilo storico, «Altreitalie», genn.-giu. 2005, pp. 4-23. 44 Katiuscia Cutrone, Italiani nella Germania degli anni ’60. Immagine e integrazione dei “Gastarbeiter”. Wolfsburg 1962-73, «Altreitalie», 2006, 33, pp. 19-44. 45 E. Pugliese, In Germania, in Storia dell’emigrazione, II, cit., p. 124. 27 / 4 / 2011 / Facciamo il punto E quando il nord Italia irruppe sulla scena, a contendersi la mano d’opera con Germania ovest e Svizzera, la cultura migratoria meridionale colse al volo questa nuova occasione. 6. L’inarrestabile cataclisma Durante quello che Augusto Graziani ha definito «il periodo dell’espansione più brillante dell’economia italiana»46, e cioè il 1950-1963, la carta demografica nazionale venne investita da una sorta di cataclisma inarrestabile, che abbatté barriere, rimodellò il paesaggio urbano, rimescolò dialetti, travolse gusti e abitudini, risvegliò speranze e paure; tutto avvenne come se una grande mano sbucata dal nulla si fosse divertita a mettere a soqquadro l’ordine esistente: vere e proprie fiumane di uomini e donne lasciarono per sempre i villaggi natii per approdare in centri meno angusti, città piccole e grandi che sembravano promettere un futuro migliore. Una vertiginosa industrializzazione fece da traino a quella mobilità febbrile; come è noto, non fu solo il sud a svuotarsi, e non solo le capitali del triangolo industriale a riempirsi. Secondo le rilevazioni statistiche disponibili, nel ventennio 1951-1971 il Mezzogiorno subì la perdita di quattro milioni di individui causata dal saldo migratorio. Più colpite le province molisane e calabresi, seguite da Basilicata e Abruzzi, di contro a una crescita complessiva di Campania e Puglia. Ma solo nelle prime due gli ammanchi erano grosso modo omogenei; in Basilicata, il ritrovamento del metano rivitalizzò Matera, mentre gli abbandoni abruzzesi erano in parte defluiti su Pescara. Infine, neppure le due regioni rimaste a galla risultavano indenni: in Campania si erano svuotate le zone interne dell’Irpinia e del Sannio, e in Puglia la provincia di Foggia. A complicare il quadro, un processo di inurbamento aveva investito Pescara, Salerno, Bari, Taranto, Potenza e Cosenza47. Di fatto, l’intero assetto demografico dell’area venne nel ventennio modificato da cima a fondo, complice anche la migliore viabilità. L’inchiesta Svimez rilevava come la generale tendenza a spostarsi verso centri maggiori e meno isolati scaturisse dalle ragioni più disparate, scambi matrimoniali tra comunità limitrofe, domanda di addetti all’edilizia insorta dalle città in espansione, e di domestiche che attirava le giovani contadine, desiderio di maggiori servizi, ad esempio di scuole, ricerca di occupazioni meno faticose e precarie, quali i portierati48. La stessa fonte gettava luce su una sorta di emigrazione di risulta, osservata a Lucera, dove gli abitanti del comune foggiano di Biccari andavano ad occupa46 A. Graziani, Introduzione, in L’economia italiana 1945-1970, cit., p. 13. F. Barbagallo, Lavoro e esodo, cit., p. 187. 48 Svimez, Ricerca su le migrazioni interne nel Mezzogiorno. Rapporto generale sulla ricerca, cit., pp. 19-20. 47 28 De Clementi, L’emigrazione meridionale nel secondo dopoguerra re servizi e terreni di luceresi partiti per il nord49, e sul calo dei centri più poveri e il progressivo abbandono delle case sparse denunciato dal chietino50. Il ventaglio delle opportunità migratorie era di dominio pubblico, al punto che in ogni paese erano pressoché tutte rappresentate51. Quindi le strategie sottostanti dovevano riflettere calcoli ben precisi e valutazioni complesse. Con un progetto a due uscite: partenza solo maschile con rientro embedded, oppure a famiglia intera, a poco più di cinquecento chilometri di distanza. Quale fosse, caso per caso, l’argomento decisivo è difficile dire. Certo è che il legame con la terra rendeva i piccoli proprietari restii alle rotture definitive, e quindi meno inclini a tagliare i ponti dietro di sé; mentre nessuna remora tratteneva il ceto bracciantile. Quando poi, nel 1958, l’imponibile di mano d’opera fu dichiarato incostituzionale, e i grandi proprietari si affrettarono a sradicare le colture intensive, non rimase altro che andarsene. A imprimere una svolta alla propria vita concorrevano anche le forme di emulazione e di rassicurazione reciproca che trasformavano le aspettative individuali in comportamenti collettivi. Le mete più chiacchierate venivano di colpo tralasciate per altre assai promettenti ma ancora da sperimentare. Le informazioni correvano di bocca in bocca e, nel contesto dato, nessuna decisione veniva mai presa alla cieca. E tra il salto nel buio verso il triangolo industriale e il pendolarismo stagionale oltr’Alpe, se veniva preferito quest’ultimo era perché offriva salari più alti e costi di mobilitazione assai contenuti, ma soprattutto la certezza del rientro, un rapporto ininterrotto con la terra e un immediato miglioramento del tenore di vita. Sull’altro piatto della bilancia pesava la quotidianità malinconica di chi consumava in solitudine la gran parte dell’anno e tirava la cinghia per risparmiare il più possibile. E poiché condizioni del genere erano tagliate su misura per un soggetto maschile di un nucleo familiare stabile ed efficiente, in ultima analisi «il successo dell’emigrazione dipendeva dalla moglie»52. L’alternativa Torino o Milano appariva più temeraria: si risparmiava di meno, l’inserimento – in primis una casa – era di gran lunga più oneroso e preceduto da partenze solitarie con riunioni tardive, oppure si bruciavano le tappe con richiami affrettati e patimenti condivisi. Ma era sul lungo periodo, 49 Id., Indagine su Biccari, Roma 1963, p. 15. Nel centro cosentino di Altopiano, i contadini affluivano in paese «a sostituire gli abitanti dei rioni vecchi». F. Piselli, Parentela e emigrazione, cit., p. 322. 50 Svimez, Ricerca … Indagine su Guardiagrele, cit., p. 4. 51 Degli 11.035 abitanti del centro chietino di Guardiagrele, tremila, tra il 1951 e il 1961, si erano recati per 9-10 mesi in Svizzera, in Germania o in Francia, ed erano rientrati a casa per Natale, secondo «un flusso stagionale tipico di molte regioni del sud». Ivi, p. 11. E ad Agnone, nel 1946-1972, 708 tra maschi e femmine si erano distribuiti tra Francia, Germania, Svizzera, Belgio e Inghilterra. W. A. Douglass, Emigration, cit., p. 197. 52 Amalia Signorelli, Migrazioni e incontri etnografici, Sellerio Editore, Palermo 2006, p. 139. 29 / 4 / 2011 / Facciamo il punto e superate le prove più ardue, che i conti potevano tornare e la nuova vita mantenere le sue promesse; i rientri in paese si facevano sempre più rari e i ricordi tendevano a sbiadire. E comunque, come è prassi nel fenomeno migratorio, i ripensamenti non si contavano. Oltrepassata la linea gotica, il primo impatto era da shock. Un giovane maschio, celibe o coniugato che fosse, partiva in avanscoperta per valutare la realizzabilità del progetto e precostituire il necessario per l’arrivo di moglie e figli o di altri congiunti. Ma ad aspettarlo non c’era nessuna Little Italy, nessuna congrega di compaesani pronta a guidarne i primi passi in quel mondo sconosciuto; mancava un retroterra migratorio. C’erano invece i tuguri, le baracche di lamiera delle “coree” e i meccanismi di esclusione e di rigetto attivati dalla società ospite e dallo stato. Il più grave in assoluto, il perdurare fino al 1961 della legge fascista contro l’inurbamento. Vale a dire che per quasi tutto il quadriennio 1958-62 – il periodo più critico –, l’afflusso nelle grandi città industriali avvenne in tutta clandestinità: niente residenza = niente libretto di lavoro, con quel che ne conseguiva: lavoro nero e sottopagato, negate le cure mediche e le case popolari. Vero è che l’on.Terracini aveva presentato un progetto di legge abrogativo approvato dal Senato all’unanimità il 17 febbraio 196053, ma la Camera lo aveva recepito un anno dopo, a cose fatte. Questa condizione di marginalità coatta non faceva che incrudelire la istintiva ostilità dei primi per gli ultimi arrivati; gli stereotipi si fecero pietre difficili da rimuovere: «Noi siamo della bassa Italia – ragionava Alessandro, facchino ventiquattrenne di Poggio Reale, rispondendo alle domande di Franco Alasia – ci chiamano terroni che siamo sporchi e non abbiamo voglia di lavorare […]. Uno mi dice: sei terrone, non hai voglia di lavorare […] venite qui a levare il pane ai milanesi». E lui di rimando: «Vedrai chi si stanca prima. Perché sono abituati tutti al lavoro negli stabilimenti, hanno il loro lavoro pulito, sono specializzati, sono andati a scuola e non fanno niente»54. La mobilità traduceva in gerarchia etnica le differenze: «Non sono ancora riuscito a convincermi che un meridionale possa diventare una persona onesta e leale come gli altri […] Al momento di agire fanno anche presto a passare alle coltellate […] Le ragazze guardano alla cultura di una persona e noi dell’Alta Italia sappiamo più parlare», così il polesano Siro, venticinque anni, fissava i termini della sua superiorità stracciona55. 53 Alvo Fontani, L’emigrazione meridionale. Un bilancio negativo, «Cronache meridionali», 1960, 9, p. 557. 54 Franco Alasia e Danilo Montaldi, Milano Corea, Donzelli Editore, Roma 2010 (Feltrinelli 1960), p. 199. 55 Ivi, p. 225. 30 De Clementi, L’emigrazione meridionale nel secondo dopoguerra 7. Ruoli e percorsi di genere L’assenza maschile rovesciò sulle donne le incombenze più disparate, dalla cura dei microfondi alla gestione familiare e all’impiego delle rimesse. E vennero loro spalancate le porte di luoghi – banche, uffici postali, studi notarili – fino a ieri interdetti, ricadevano su di loro anche i ruoli più esclusivi: il villaggio lucano di Satriano celebrava con una processione la ricorrenza di Sant’Antonio che cadeva il 13 giugno, cioè in un periodo di assenza di uomini validi talmente assoluta che la statua veniva portata a spalla da mogli, figlie, sorelle56. Su di loro si riversò la parte maggioritaria dell’occupazione agricola. Nel 1960, a fronte di una media nazionale di genere pressoché paritaria – il 31% ai maschi e il 30,6% alle femmine – bastava allungare lo sguardo per leggere, nel nord, un rapporto del 19% a 12,3%, e una sua decisa inversione nelle regioni meridionali57. L’occupazione extradomestica di genere mostrava del resto dati sconfortanti; la quota maschile raggiungeva in tutta la penisola oltre il 50% del totale con punte del 65% nel triangolo industriale, mentre quella femminile si aggirava tra il 10 e il 20%. I dislivelli crescevano di molto separando l’agricoltura dall’industria, nella quale le lavoratrici erano il 48,6%, pari al doppio delle meridionali58. Questa forbice era a sua volta causa ed effetto di una ripartizione sperequata dei prodotti più rappresentativi della esordiente società dei consumi, gli elettrodomestici. Non che il loro ingresso tra le pareti domestiche si fosse arrestato alle soglie dell’area più disagiata, dove anzi l’afflusso delle rimesse era più che sufficiente allo scopo, ma difforme ne era la distribuzione tipologica, stando alla quale nelle regioni del sud scarseggiavano lavatrici e lavastoviglie, superate di parecchie lunghezze dagli apparecchi televisivi. Secondo una curiosa indagine dell’epoca59, tra le cause più ovvie occorreva annoverare in primo luogo i deficit della rete distributiva di energia elettrica, che sacrificavano di molto gli usi diversi dall’illuminazione, e non trascurare una diffidenza tutta contadina per l’innovazione. Ma l’autore azzardava anche l’ipotesi che la rarità di elettrodomestici sostitutivi di lavoro umano (= 56 D. Scutari, Emigrazione, cit., p. 571. Campania m. 31%, f. 52,3%; Abruzzo-Molise m. 46,7%, f. 61,6%; Puglia Basilicata Calabria m. 44%; f. 59,8%; Sicilia m. 40,9%, f. 29,5%; Sardegna m. 46,6%, f. 19,5%. Per un totale di 41,8% e 44,5%. Rispetto poi alla popolazione attiva, la media nazionale del 37% saliva al 42,9% nel triangolo e scendeva al 31,4% in tutto il meridione. I dati sono tratti da una ricerca pubblicata da Nora Federici sulla rivista «Statistica», ampiamente riportati in: Antonio Gerace, Gli elettrodomestici nella società meridionale, «Nord e Sud», luglio 1961, p. 98. 58 E più in dettaglio: in Campania il 19,0%; in Abruzzo e Molise 14,8%; in Puglia, Basilicata e Calabria 18,7%; in Sicilia 21,4%; in Sardegna 14,6%. Media nazionale: 19,7%. 59 A. Gerace, Gli elettrodomestici, cit., passim. 57 31 / 4 / 2011 / Facciamo il punto femminile) fosse dovuta altresì alla mediocre occupazione extradomestica delle donne, che rendeva quella mano d’opera esuberante, e superflua l’esigenza di labour-saving, avvertita soprattutto nelle città. Cambiando punto di osservazione si può aggiungere che, come aveva ben chiaro il già citato sindaco di Sant’Arcangelo, la diffusione del messaggio televisivo poteva ridestare la voglia di altre vite e di altri mondi. Peraltro, a ben vedere, anche l’emigrazione ottocentesca era lievitata sulla narrazione delle esperienze altrui – i giramondo delle arti e dei mestieri, al loro rientro, lasciavano sbalorditi i compaesani favoleggiando di luoghi lontani e ricchezze inenarrabili, tarli che scavavano nelle menti degli astanti fino a farli passare all’azione60. Rispetto a quel passato era cambiato il mezzo, ma non il messaggio, e l’oralità la faceva ancora da padrona. La disoccupazione femminile del sud non fece che peggiorare. In uno studio promosso dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno si legge: La situazione attuale è particolarmente grave per la popolazione femminile, il cui tasso di attività è bassissimo, specie nel Mezzogiorno, dove soltanto il 15% delle donne svolge attività retribuita extra domiciliare. I tassi di attività femminile hanno risentito dell’esuberante offerta di lavoro maschile e della scarsissima preparazione professionale che, quando anche le condizioni del mercato del lavoro lo consentissero, impedisce a molte lavoratrici uscite dall’agricoltura e a molte casalinghe di inserirsi in processi produttivi. Ci sono però alcuni indizi […] che lasciano intendere come in ogni caso la partecipazione al lavoro delle donne nell’area meridionale sarebbe ben più intensa se maggiori e più adeguate fossero le opportunità di lavoro»61. E gli indizi consistevano in «una percentuale crescente di donne sul totale degli espatri per motivi di lavoro, una rilevante quota di ingressi nelle forze di lavoro all’estero di donne emigrate in condizione non professionale e, soprattutto, un aumento delle donne in cerca di prima occupazione»62. Al tempo della grande emigrazione le donne non erano certo rimaste immote, ma la regola le voleva viaggiatrici al seguito o al richiamo di padri, mariti e figli, il che non impediva loro l’ingresso nei mercati del lavoro esteri appena messo piede oltre frontiera. In altre parole, partivano imbozzolate in un ruolo familiare e arrivavano pronte a rivestirsi di un ruolo sociale. Ma di donne sole se ne erano viste poche. La novità rimarcata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno era balzata agli occhi degli osservatori più attenti prima ancora che apparisse nelle rilevazioni ufficiali: la «cospicua partecipazione di donne e ragazze all’emigrazione 60 Andreina De Clementi, Di qua e di là dall’oceano. Emigrazione e mercati nel meridione (1860-1930). Carocci Editore, Roma 1999, pp. 26-33. 61 A. Fontani, L’emigrazione meridionale, cit., p. 563. 62 Ibidem. 32 De Clementi, L’emigrazione meridionale nel secondo dopoguerra – si leggeva nella breve inchiesta sull’Irpinia del 1960 – si è verificata per la prima volta in provincia di Avellino solo in questo dopoguerra. Mai ciò si era verificato per il passato, sebbene vi siano stati anche antecedentemente alla prima guerra mondiale periodi di intensa emigrazione»63. Bastava un’occhiata alle cifre: dal 1948 al 23 aprile del 1957, dal comune di Scampitello in Alta Irpinia su 1.860 abitanti erano emigrati in mille, di cui 450 uomini e 550 donne, disseminati tra varie mete, interne ed estere. Nel 1953, continuava l’autore, l’Ufficio del Lavoro aveva ingaggiato 2.360 emigrati, 1.584 erano compresi tra i 14 e il 30 anni, 1.081 maschi, di cui 729 celibi, e 503 donne, di cui 382 nubili. Su un altro scaglione di 5.771 individui, 1.500 erano donne, tutte classificate casalinghe. Le ragazze si dirigevano per lo più in Svizzera, dove le attendevano lavori domestici. E il deflusso andava ad aumentare: nel 1960, nei soli marzo e aprile, la Svizzera aveva accolto 2.000 giovani lavoratori e lavoratrici, altri 1.500 si erano diretti in Germania nei mesi estivi, quando cioè fervevano i lavori agricoli: «[…] ne deriva per conseguenza che, pur dopo un così incisivo dissanguamento di energie umane, l’Irpinia resta tuttavia un inesauribile serbatoio di forze produttive inutilizzate». Al tempo del taglio del canale di Suez, dalla provincia di Catanzaro erano partite molte donne, che «facevano da balie ai bimbi delle ricche straniere, di sede in Alessandria, con uno stipendio di cento lire mensili circa, mentre ai loro paesi ne guadagnavano in media dieci»64. Si parlava di cento anni prima, e di un episodio abbastanza eccezionale se, tra i fatti nuovi dell’ultimo triennio, si sottolineava che «decine di giovinette dai diciotto anni in su si spostano, da sole, nel nord Italia per trovare una qualche occupazione negli opifici»65. E, nel Molise, Agnone non era da meno: sui 708 emigrati in Europa nel 1946-1972, 316 erano donne66. 8. L’impiego dei risparmi e delle rimesse In un saggio del 1967, Pasquale Saraceno affermava: «Per la prima volta nella sua storia, il Mezzogiorno appare partecipe del generale processo di espansione del paese a un ritmo non minore di quello pur molto intenso di cui hanno beneficiato le regioni più progredite»67. A comprovarlo, l’aumento del reddito pro capite, cresciuto al saggio medio del 5,1% nel quindicennio. 63 Enrico Vuotto, L’esodo dai comuni irpini, «Cronache meridionali», 1960, 9, pp. 575-581, in part. p. 575. 64 G. Pace, Lo spopolamento, cit., p. 567. 65 Ibidem. 66 W. A. Douglass, Emigration, cit., p. 197. 67 Pasquale Saraceno, Il Mezzogiorno quindici anni dopo, in: A Graziani, L’economia italiana, cit., p. 265. 33 / 4 / 2011 / Facciamo il punto E poiché questo aumento era stato destinato in toto alla massa dei consumi, era logico imputarlo alle sole risorse esterne, vale a dire la spesa pubblica, gli investimenti privati e le rimesse degli emigranti. Secondo calcoli attendibili, queste ultime ammontavano in media a mezzo milione di lire l’anno, pari al doppio del reddito individuale realizzabile in patria68. Lo scarto era di molto superiore nelle zone più povere, la provincia di Avellino, ad esempio, dove, nel 1958, il reddito procapite si aggirava intorno alle 106.473 lire69. Sulle rimesse, molto ci dice un capitolo della ricerca promossa dal Formez nel 1975 su Progetto di studio operativo sull’emigrazione meridionale nelle zone di esodo, effettuata dall’Isvi di Catania sulla base di 594 interviste con altrettante famiglie coinvolte a vario titolo nell’emigrazione, raccolte nella Sicilia interna, e precisamente in quindici comuni delle due province di Enna e di Caltanissetta che «presentano tra i più elevati tassi di emigrazione e sono forse l’aggregato territoriale meno sviluppato dell’intero Mezzogiorno»70. L’inchiesta si sofferma in sostanza su due temi capitali: la capacità di risparmio dei soggetti migranti e l’impiego delle rimesse, attorno alle quali l’emigrazione ruota. La prima si diramava in due direzioni, il massimo accumulo di denaro a scapito dei consumi, proprio dell’emigrazione temporanea maschile, e le ingenti spese di integrazione necessaria al trasferimento di un intero nucleo familiare che poco o nulla permettevano di accantonare; anche a voler dilazionare i ricongiungimenti, occorreva comunque essere già in possesso di «un posto di lavoro molto remunerato». Insomma, spostarsi in Italia o spostarsi all’estero faceva parecchia differenza. Dicendo “estero”, del resto, si era ben lungi dal menzionare, anche a questo proposito, una realtà omogenea. A fronte, infatti, di invii di denaro costanti nel tempo e perfino in crescita da Svizzera e Germania, «in Francia, Belgio, Gran Bretagna, le rimesse sono in complesso in diminuzione, segno che la situazione per gli immigrati diventa sempre più difficile, sia dal punto di vista occupazionale sia per gli aumenti che ha subito il costo della vita». Quanto all’impiego, quel denaro se ne andava per metà nei consumi correnti (alimenti, vestiti, ecc.), l’altra metà poteva servire: - a ripagare i debiti, contratti per la costruzione della casa, per il sostentamento della famiglia, ad es. nei periodi di disoccupazione forzata, ecc.; 68 S. Cafiero e G. E. Marciani, L’emigrazione dalle zone povere, cit., p. 277. E. Vuotto, L’esodo dai comuni irpini, cit., p. 578. 70 Nanda D’Amore, Emanuela D’Andrea, Maria Scuderi, Bilanci familiari e rimesse degli emigrati meridionali, «Studi emigrazione», 1977, 45, pp. 3-37. 69 34 De Clementi, L’emigrazione meridionale nel secondo dopoguerra - all’acquisto di beni durevoli: in cima a tutti, l’automobile, che «rappresenta per molti emigrati […] una prova concreta della condizione economica raggiunta in emigrazione», uno status symbol, insomma. Tanto più ostentato quando a partire era stato uno scapolo, a riprova della «forte spinta consumistica che caratterizza l’emigrazione più giovane». E in cui erano compresi anche l’arredamento dell’abitazione e gli elettrodomestici, di cui si è detto. Una voce a sé era poi riservata al matrimonio, non solo e non tanto per via della dotazione, che poteva indurre padri all’espatrio, ma non era più d’obbligo, quanto «per le spese che comportano i soli festeggiamenti nuziali [che] rendono necessario un risparmio di parecchi anni». E ad Altopiano di rimando: «C’è chi profonde nel matrimonio di una figlia, in un solo giorno, i risparmi di dieci anni di emigrazione»71. Quanto infine agli investimenti immobiliari, vi primeggiava la casa, che ne assorbiva tra il 60 e l’80%, si trattasse di un acquisto ex novo, o di un restauro o dell’ampliamento di una vecchia costruzione, oppure di un congegno “fai-da-te” con l’aiuto di qualche familiare. La terra aveva perso tutto il suo valore reale e simbolico, monetizzato nella destinazione di area edificabile. Tirando le somme, «L’obbiettivo fondamentale degli emigrati resta la casa, che costituisce il principale investimento, e non si è soddisfatti se non si riesce a raccogliere i risparmi necessari ad acquistarla o costruirla»72. E in linea di massima c’erano riusciti. Infatti, al termine dell’inchiesta, la stragrande maggioranza degli intervistati (l’84,4%) si era dichiarata soddisfatta della propria scelta e dei risultati ottenuti. Con grande sconcerto delle autrici: Sembra che solo pochissimi si rendano conto che i propri risparmi, frutto dei sacrifici in emigrazione, sono riusciti solo a migliorare un poco e transitoriamente le proprie condizioni di vita, ma non hanno modificato in nulla l’ambiente di origine né hanno innescato alcun processo per cui sia più facile trovare un lavoro senza dover emigrare73. 9. Il futuro nel passato Un terremoto come questo non ingenerò nelle aree di partenza la palingenesi che in molti si erano aspettati. I risultati indiscutibilmente più vistosi furono l’ondata di benessere scaturita da una affatto inusitata capacità di spesa 71 F. Piselli, Parentela, cit., p. 269. D’Amore, D’Andrea, Scuderi, Bilanci familiari, cit., p. 30. 73 Ibidem. 72 35 / 4 / 2011 / Facciamo il punto e un colossale drenaggio demografico che allontanò in forma sistematica o definitiva le energie migliori. E tuttavia, la società meridionale rimase in sostanza uguale a se stessa, l’agricoltura saldamente ancorata alla sussistenza. Tra il 1948 e il 1959, altre 212.148 unità andarono ad aggiungersi alla miriade di micro-fondi, per un totale di 263.048 ettari, che quindi non superavano di molto la media di un ettaro ciascuno74. La parcellizzazione sembrava non avere mai fine75, e il reddito agricolo incideva sempre meno sul totale delle risorse, «la compresenza di molteplici fonti di reddito – concludeva l’inchiesta Svimez76 – produce un alto livello del tenore di vita, ma al tempo stesso una situazione di equilibrio statico, a causa del quale non si attua una radicale trasformazione delle strutture economiche, sociali e culturali»77. I pochi ritocchi alterarono la gerarchia comunitaria: crebbe «in molte zone di fuga, il peso relativo del piccolo proprietario contadino»78, emerso dal precariato agricolo, i notabili divennero l’ombra di se stessi, soverchiati, per denaro e prestigio, dagli emigrati più intraprendenti, e sulla stessa china finirono gli artigiani, il secondo pilastro dell’economia locale. Poiché ad andarsene erano sempre i più istruiti e i più ambiziosi, «la gente del posto è adesso una specie di categoria residuale, che mette insieme a casaccio gli anziani, gli handicappati e i meno creativi»79. Un giudizio impietoso, e alquanto eccessivo, che, oltre agli attuali abitanti, non risparmiava nemmeno la città di Agnone, che aveva conosciuto una brillante stagione al tempo della prima emigrazione e che era ormai ripiombata nell’insignificanza. 74 Con la seguente ripartizione: Campania: 77.851 unità per 64.213 ettari; Abruzzo e Molise: 47.759 per ha. 49.128; Puglia: 58.325 per ha. 98.952; Basilicata: 17.461 per ha. 36.220; Calabria: 10.732 per ha. 14.535. F. Barbagallo, Esodo, cit., p. 220. 75 Douglass calcola che in Agnone esistevano nel 1816 7838 terreni individuali, che nel 1950 erano diventati 41.753. W. A. Douglass, Emigration, cit., p. 176. 76 Svimez, Indagine su Guardiagrele, cit., p. 28. 77 Una diagnosi per nulla obsoleta, come dimostra il recentissimo: Bruno Amoroso, a cura di, Il “Mezzogiorno” d’Europa, ed. Diabasis, Reggio Emilia 2011. 78 Svimez, Le migrazioni interne, Rapporto generale sulla ricerca, cit., p. 31. 79 W. A. Douglass, Emigration, cit., p. 204. 36 Finito di stampare nel mese di gennaio 2013 da Arti Grafiche Solimene s.r.l. Via Indipendenza, 23 - Casoria per conto delle Edizioni Il Bene Comune
Scaricare