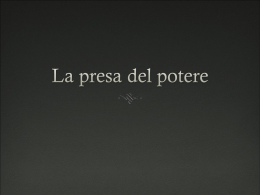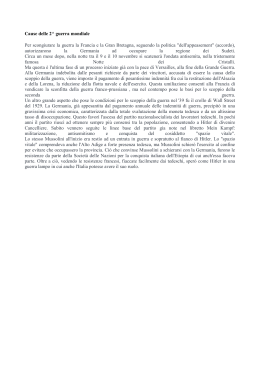GIUGNO 2006 - contiene inserto redazionale Editoriale Dolce mangiare NUMERO 21 zione e del consumo di zucchero in Europa: 70.000 nel 1508; 380.000 nel 1570; 1.240.000 nel 1600; il fenomeno ha subito un’ulteriore accelerazione nei secoli successivi. Il consumo di zucchero ha progressivamente interessato tutti gli strati sociali; nell’Ottocento, il suo impiego è ben documentato nelle campagne e nel Novecento si tratta ormai di un prodotto a buon mercato, quello che senza dubbio fornisce la maggior quantità di calorie al prezzo più basso. Naturalmente nei secoli precedenti l’aumento del consumo di zucchero riguardava essenzialmente l’élite, così come si riferiscono alle classi superiori le trasformazioni del gusto e delle pratiche alimentari rivelate dallo studio dei ricettari che ci sono pervenuti. I libri di cucina fanno la loro comparsa nell’Europa Occidentale intorno al 1300. Lo studio statistico degli ingredienti menzionati in ogni ricetta dà un’idea delle abitudini alimentari delle classi elitarie. Non diversamente da noi, le popolazioni del Tre-Quattrocento utilizzavano in cucina olii o grassi vari, pur facendone un uso meno frequente. A parte rare eccezioni, per esempio, le loro salse non contenevano né burro né olio; ai condimenti grassi si preferivano allora, in tutta l’Europa occidentale, quelli speziati. L’analisi statistica rivela tuttavia differenze di gusto nelle varie gff nazioni. I Francesi del Trecento avevano una vera e propria passione per i sapori aciduli e utilizzavano vini più o meno agri o agresto (mosto di uva acerba) in quasi il 70 per cento delle loro ricette. Per la tornata estiva del Tribunato di Romagna, domenica In ciò si distinguevano dagli Inglesi, dagli Italiani e dai 14 maggio, ci siamo trovati presso la Biblioteca di “Casa Catalani. Oriani” gentilmente concessaci dal direttore dott. Dante Altro elemento di differenza è lo scarso interesse per i dolci Bolognesi, amico tribuno. e per gli ingredienti zuccherati (miele, zucchero d’uva o vini Il tema seguiva il filo conduttore di questo anno, vale a dire cotti, fichi secchi, datteri, prugne), i quali ricorrono in una perle “Eccellenze romagnole” ed era stato proposto nell’ ulticentuale inferiore all’8 per ma tornata dal collega tricento nelle ricette francesi, e buno on. Stefano Servadei. in metà circa di quelle ingleIl tema relativo: Il porto si, catalane e veneziane. di Ravenna, la sua storia Col passare dei secoli i gusti e l’importanza nel territosi modificano. I Francesi rio è stato brillantemente hanno gradualmente addoltrattato dal dr. Giuseppe cito i loro condimenti, non Parrello, presidente l’Autanto eliminando gli ingretorità Portuale e dall’ing. dienti acidi, quanto piuttosto Leonello Sciacca, direttore attenuandoli con zucchero, generale della S.A.P.I.R. burro e olio. per il porto intermodale Lo zucchero, che figurava di Ravenna, di fronte ad nel 5 o 6 per cento delle riun numeroso pubblico di cette durante il XIV secolo, tribuni e familiari. sale al 20 per cento alla fine Prima di trattare il tema, del XV, e supera il 30 nella il nostro presidente sen. prima metà del XVI. Il burLorenzo Cappelli ha riro, che era impiegato dall’1 cordato la figura dell’avv. al 3 per cento delle ricette francesi nel XIV secolo, Massimo Stanghellini supera il 7 alla fine del XV, Perilli, ravennate, per il 33 nel XVI, oscillando La “claziò” alla osteria , disegno di Celso Anderlini dodici anni nostro Primo fra il 35 e il 60 per cento Tribuno. nel XVII e XVIII secolo. Ci sarebbe da meravigliarsi se una Quindi sono stati nominati tribuni e incaparellati il simile trasformazione dei gusti e delle abitudini alimentari non dott. Matassoni Mauro di Rimini, medico chirurgo, avesse avuto ripercussioni sul grado di corpulenza di uomini il rag. Giuseppe Mercatali di Modigliana, funzionae donne. rio Confartigianato e segretario dell’Accademia degli In effetti, nulla fa supporre che cibi più grassi e dolci siano Incamminati, l’avv. Gianluca Riguzzi di Ravenna, consustati assunti in quantità minori, nonostante le tenaci leggende lente aziendale e il prof. Nevio Spadoni di Ravenna docente che circolano a questo proposito. delle scuole medie superiori. Semmai è vero il contrario: se esaminiamo quadri e incisioni L’ottimo pranzo conviviale si è svolto nella Enoteca Cà de con scene di pranzi aristocratici, nella maggior parte delle Vèn. opere medievali colpisce l’ascetismo, laddove l’iconografia Per gentile concessione dell’Autorità portuale la giornata del Sei-Settecento è sovraccarica di vivande. Tutte le ricerche si è poi conclusa con una visita in barca nel Porto Canale. condotte nel nostro secolo mostrano d’altronde che l’aggiunta La CCX tornata a Ravenna di zucchero in un alimento ne accresce il consumo, e si conosce con molta precisione l’enorme incremento della produ- 1 IL PORTO DI RAVENNA Darsena del porto di Ravenna a fine Ottocento 2 Il Porto di Ravenna è una grande struttura in grado di offrire la più completa gamma di servizi ad ogni tipo di merce. I grandi investimenti pubblici e privati effettuati negli ultimi anni ne hanno ulteriormente migliorato le dotazioni infrastrutturali ed i collegamenti alle grandi reti dei trasporti merci, facendone uno scalo all’avanguardia, bene inserito sulle principali reti di traffico. Questo grande sistema logistico ed industriale affonda le sue radici in una antichissima tradizione portuale che, in virtù della sua fortunata posizione geografica, risale al I secolo a.C. quando l’imperatore romano Ottaviano Augusto dislocò nel porto di Classe una delle due flotte imperiali. Il legame tra Ravenna ed il porto romano, da sempre vivissimo, è oggi rinnovato dall’apertura dell’imponente sito archeologico di Classe. Il porto continuò ad essere attivo anche dopo la crisi dell’impero nel III sec. e conobbe nuovo splendore in età bizantina, di cui ci è data testimonianza nei mosaici di Sant’Apollinare Nuovo. La storia del porto è successivamente contrassegnata da interramenti, da eventi alluvionali e dai necessari spostamenti da un’ansa all’altra della laguna che circondava la città fino a quando, nel 1738, il porto Corsini (dal cognome della famiglia di Papa Clemente XII), ha iniziato la sua attività con un canale lungo undici kilometri che collega Ravenna al mare. Il suo decollo come grande porto di rilevanza economica internazionale si ha nell’ultimo dopoguerra, in coincidenza con l’insediamento sulle sponde del porto canale di raffinerie e del petrolchimico legato alla scoperta di estesi giacimenti di metano nelle acque antistanti la città. La sua caratteristica, allora unica in Italia, lo rendeva non invasivo sul territorio urbano circostante e quella di non essere proprietà del Demanio statale, lo svincolava dal monopolio tariffario delle Compagnie Portuali. Con la crisi petrolifera degli anni 1970 si accentuano le caratteristiche commerciali dello scalo e, a quelli già avviati, si aggiungono, sempre per iniziativa di privati con tariffe economiche, nuovi terminali specializzati nella movimentazione di “rinfuse”, merci varie e container. Da allora il porto è teatro e fulcro promotore di un incessante sviluppo che lo ha portato ad ampliare ed al contempo specializzare l’offerta di servizi, ottenendo standard qualitativi sempre più elevati ed a raggiungere posizioni di primato in Italia quanto all’importazione di merceologie alla rinfusa ed al traffico di merci varie ed in container con il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero. In virtù della sua strategica posizione geografica il Porto di Ravenna si caratterizza come leader in Italia per gli scambi commerciali con i mercati del Mediterraneo orientale e del Mar Nero e svolge una funzione importante per quelli con il Medio e l’Estremo Oriente. L’inclusione di Ravenna nei sistema della grande viabilità ed il collegamento con le principali reti trasportistiche ne fanno un porto facilmente raggiungibile dai maggiori centri italiani ed europei. La connessione con la rete autostradale assicura rapidi trasferimenti verso le regioni settentrionali dell’Italia, dei paesi transalpini e dell’Europa centrale e settentrionale. Il collegamento con Roma ed il Sud è assicurato dalla superstrada E 45 e dalla autostrada A 14. Le potenzialità del porto sono rafforzate dall’inserimento di Ravenna nell’European Freeways Network e dalla sua collocazione quale snodo fondamentale del “Corridoio Adriatico”. Alla rete viaria si sovrappone, in pratica, quella ferroviaria, alla quale i principali terminali sono raccordati con vari fasci di binari, in corso di prolungamento lungo la sponda sinistra dei porto canale. In particolare, i terminal di movimentazione container e merci varie, costituiscono veri e propri nodi intermodali. Il Porto di Ravenna è sempre stato gestito da operatori privati che hanno costruito i terminal investendo capitale proprio. I terminal, perciò, operano da sempre in regime di concorrenza ed hanno conseguito, in tal modo, alti standard qualitativi, di efficienza e di affidabilità. Nei corso dei tempo le imprese private che gestiscono il porto si sono specializzate: 15 terminal e 9 depositi costieri sono operativi nel porto dove può essere movimentata qualsiasi tipologia di merce. Ai terminal con banchina in concessione si sono aggiunte altre imprese specializzate nelle operazioni di sbarco. Le imprese portuali ed i depositi costieri dispongono di una grande quantità di mezzi per lo sbarco/imbarco e di strutture che consentono una grande capacità di stoccaggio. Il traffico marittimo del Porto di Ravenna ha seguito un trend di costante crescita, facendo registrare dai 1990 un tasso di incremento medio annuo del 4,2 % e raggiungendo nel 2001 una movimentazione complessiva di circa 24 milioni di tonnellate. Tra le merci movimentate, gli incrementi più rilevanti registrati negli ultimi anni, hanno riguardato i prodotti metallurgici, provincipalmente coils, minerali greggi e materiali da costruzione, in particolare le materie prime per l’industria della ceramica, tipologie merceologiche per le quali il Porto di Ravenna è leader nazionale. Lo scalo ravennate è inoltre il principale porto italiano per la movimentazione di cereali, fertilizzanti e sfarinati ad uso animale. Ravenna è collegata con servizi di linea e “navi tramp” con tutto il mondo, ma il bacino di traffico principale è costituito dal Mediterraneo e dal Mar Nero (circa 70% del traffico). Significativi anche gli scambi con l’America Meridionale e Settentrionale, da cui provengono sfarinati, oli combustibili e combustibili minerali solidi, con l’Europa Settentrionale, con il Far East e l’Oceania, aree di importazione dei coils. Per quanto attiene il movimento dei contenitori, il Porto di Ravenna è leader in Italia per i traffici con i Paesi del Mediterraneo Orientale e del Mar Nero; via “feeder” vengono invece effettuati collegamenti con il resto dei mondo. Ravenna rappresenta inoltre un polo primario per i servizi di cabotaggio nazionale e costituisce uno snodo fondamentale nello sviluppo delle nuove direttrici delle “Autostrade dei Mare”. Veduta aerea delle banchine del porto. LA CANTINA GRANDE del Palazzo Rasponi a Raffanara di Russi 3 Russi, villa San Giacomo Che il territorio di Russi, ed in particolare la zona di San Giacomo, siano sempre stati territorio di coltivazione della vite è suffragato dalla presenza di un antico pressatoio situato all’interno del perimetro degli scavi della Villa romana, a poche centinaia di metri dal Palazzo Rasponi. Questo pressatoio restò probabilmente attivo sin verso la fine del V o VI secolo ed era abbastanza capiente da assicurare una quantità di vino e di mezzo vino che certamente eccedevano le esigenze interne di tale insediamento1. Tra i vitigni che rifornivano di uva l’antico pressatoio c’erano quasi senz’altro il Trebbiano e l’Albana ma si presume vi fossero anche vitigni spontanei o locali, oltre ad altri provenienti dalla Grecia. Tra le uve rosse si può supporre vi fosse la Canina Nera, chiamata anche Canicola da de’ Cresenzi nel suo testo del 1308. Dopo l’abbandono della villa romana la viticoltura continuò probabilmente il suo corso ed un nuovo sviluppo fu promosso, soprattutto a partire dal 1400, grazie ai contratti ad milioratum stipulati tra i monaci dell’Abbazia da Porto di Ravenna ed i loro affittuari. I primi possedettero la Tenuta di Raffanara Madrara a partire dal Duecento sino al 1663, anno in cui venne acquistata dalla famiglia Rasponi. Ai primi del Seicento questa tenuta, avente una superficie di 1106 tornature ravennati, era suddivisa in una trentina di unità poderali (poderi veri e propri e siti per casanti) ed i terreni erano censiti, per circa l’80%, come arativi vitati ed arborati. L’indirizzo viticolo (vite promiscua) era quasi esclusivo nei poderi più alti e posti nelle immediate vicinanze del Palazzo: podere Palazzo, podere Gamberina, podere Pino, ecc. Facendo un passo indietro nei secoli si rileva anche come questa importante famiglia si fosse già indirizzata verso l’acquisto di terre da grano e vite2 nel territorio di Russi: nel 1492 Ludovico Rasponi aveva comprato a Raffanara una possessione con viti et porcis; alla fine del Cinquecento possedeva alcuni poderi ad indirizzo viticolo arborato nella frazione di Cortina. E’ però a partire del ‘600 che affiorano numerosi documenti inerenti la gestione agricola di questa Tenuta. Tra l’altro gli antichi proprietari, i frati dell’Abbazia da Porto di Ravenna, si preoccupavano di ricevere dai loro affittuari i vini migliori. In un diacetto del 1657, conservato presso l’Archivio di Stato di Ravenna, si legge che i contratti d’affittanza prevedevano, oltre a canoni espressi in grano, la consegna in Ravenna a gratis di carra quattro di vino rosso di Gualdo, di carra uno di vino Trebiano di Madrara e di carra sette di Uva Dora di S. Giacomo. In sostanza i monaci Portuensi, pur possedendo migliaia di ettari di terreni agricoli distribuiti tra il ravennate, le colline del forlivese e del riminese, eleggevano come loro preferiti due vini della tenuta di Raffanara Madrara (il Trebbiano e l’Uva Dora), oltre al vino rosso di Gualdo (frazione di Meldola) che, presumibilmente, doveva trattarsi di un buon uvaggio a base di Sangiovese. Nel 1663 Guido Carlo Rasponi, fratello del Cardinale Cesare, acquistò la tenuta e impresse un certo sviluppo ai poderi. Si passò ad una gestione più diretta eliminando, tra proprietà e coloni, le figure degli affittuari. Inoltre si pose particolare attenzione alla coltivazione della vite e alla produzione e vendita di vino, da cui dipendeva gran parte dei flussi di cassa dominicali. Si favorì inoltre la coltivazione di vitigni rossi di maggior pregio, quali il Marzemino o Barzemino, che era già presente in Romagna sin dal Seicento e serviva molto probabilmente a migliorare la qualità degli antichi vini rossi, quali ad esempio quelli ottenuti dalla Canina Nera. I Rasponi erano ben consci della buona qualità dei loro Marzemini tanto che, nei patti colonici del Settecento, vi era una clausola che stabiliva l’integrale inclusione di queste uve nella quota dominicale. In sostanza la Canena di Russi e di Ravenna, citata in letteratura (Poletti, Bacco in Romagna, 1818) ed ampiamente consumata sin dai primi dell’Ottocento nelle osterie di Ravenna, era anche allora un uvaggio a base di Canina Nera, più una certa quota di Barzamino ed altri vitigni locali minori. E’ pure immaginabile che questa tenuta, al pari di altre situate nell’Alta pianura e nella Bassa collina romagnola, avesse instaurato in campo vitivinicolo quella che noi potremmo oggi definire “filiera di settore”3. Non è neppure escluso che queste tenute avessero, sia pure indirettamente, adottato nei confronti del consuma- 4 tore un sistema di comunicazione o di capacità attrattiva analogo a quello dei moderni marchi: il lento scorrere per le vie delle città dei carri pieni di vino recanti lo stemma dei Rasponi, solleticava forse i clienti del Seicento, al pari di quanto oggi accade per un accattivante messaggio pubblicitario. L’uva veniva allora vinificata, oltre che nella Cantina Grande di San Giacomo, anche in quella di Ravenna. In particolare la Canina Nera viene chiamata in causa nei Libri Mastri, sia come uva destinata alla vinificazione sia come vino venduto a vari osti del territorio. In un documento contabile del 1690 si parla inoltre di una lite sorta tra i Bonaventura (ramo dei Rasponi) e gli altri eredi, per il fatto che i primi avessero consumato il vino Rossa Canina contenuto nelle botti della Cantina grande di San Giacomo. Negli anni che vanno dal 1679 al 1685, la tenuta di Raffanara Madrara produsse una media annua di 3559 quintali di uva, con una punta di quasi 4300 quintali nel 1680. La quota di uve dominicali (2060 quintali in media all’anno) si vinificava nella Cantina grande, che era collocata sul retro ed in adiacenza dell’attuale Palazzo. L’uva restante (1500 quintali circa) era ripartita tra i vari coloni e casanti e serviva a produrre vini destinati essenzialmente alla sussistenza di queste famiglie. La Cantina Grande di San Giacomo produceva soprattutto vini rossi: 74,5% contro il 25,5% di bianchi. Le uve prevalenti venivano indicate in modo generico come Uve rosse (58,1%) e si può supporre che si trattasse di Canina Nera, anche in relazione al minor prezzo rispetto all’Uva Dora e al Trebbiano, allora considerate di maggior pregio. Tra i vitigni rossi seguivano l’Uva Dora (11,2%) e l’Uva Dolze o Guizzadola (5,2%). Tra le uve bianche si produceva una non meglio definita Uva Bianca (17,8%), oltre al Trebbiano o Trebiano (7,7%). In sostanza San Giacomo era anche in passato territorio di elezione per i vitigni a bacca rossa, i quali venivano utilizzati per produrre tre tipi di vino: un generico Vino rosso, l’Uva D’Oro e la Canina Nera. Il primo era quasi senz’altro un uvaggio a base di Canina Nera, l’Uva D’Oro era un vino monovarietale, mentre il vino Canina Nera veniva battezzato come l’omonimo vitigno solo nelle annate migliori o per partite raccolte in modo selettivo. Facendo ora un confronto tra la situazione del Seicento e quella odierna potremmo constatare come la viticoltura della pianura romagnola sia rimasta sostanzialmente fedele alle proprie radici. E’ stata lasciata un po’ in disparte l’Uva D’Oro poiché non risponde più alle attuali preferenze dei consumatori, mentre si utilizzano alcuni vitigni internazionali, per lo più nella misura consentita dai disciplinari. Il passato potrebbe offrire interessanti spunti per il rilancio dei vini rossi della pianura romagnola e ravennate in particolare; la proposta potrebbe essere così sintetizzata: - un generoso vino rosso (es. Rosso Ravenna, di cui esiste già l’IGT); - l’antica e briosa Canena, da vinificare assieme ad altri autoctoni della tradizione (es. Barzamino, Curnacia, ecc.) ed avvalendosi di un’accurata conduzione di vigna; - l’autoctono Burson, che completerebbe la gamma offrendo un prodotto corposo e di lungo affinamento. D’altra parte, l’odierna produzione di massa potrà sussistere solo se sarà suffragata da improbabili ritorni economico-aziendali. La qualità territoriale, obiettivo cui deve tendere anche la pianura, richiede tuttavia investimenti a più livelli (tecnico-strutturale, di marketing e in politiche di comunicazione). Solo così si potrà fare affidamento sui consumatori affinché inseriscano i nostri vini nel loro ideale paniere dei prodotti di qualità. Donati Francesco Docente di Marketing e Comunicazione Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia Università degli Studi di Udine Per avere un’idea precisa dell’importanza di questa cantina si fornisce la tabella con i quantitativi di uva vinificati per singolo vitigno, dal 1679 al 1685. Tenuta di Raffanara: uve prodotte e uve vinificate nella cantina di San Giacomo Totale uve prodotte (qli) di cui uve bianche (qli) 1679 2609,5 599,0 2010,5 1651,0 1680 4293,0 1146,0 3147 2677,0 1681 3064,9 659,7 2405,22 1942,5 1682 3230,0 563,0 2667 2025,0 1683 3803,5 1072,4 2731,11 2316,2 1684 4132,6 1074,7 3057,97 2299,8 1685 3777,2 1178,6 2598,56 1510,3 Media annua 3558,7 899,1 2659,6 2060,2 Anni di cui uve Uve vinificate rosse (qli) a S. Giacomo (qli) 1 L. G. Moderato Columella, De Agricoltura. Questo autore afferma (Libro 3.2-5) che il territorio di Faenza (Faventino agro) era famoso per l’elevata rese di uva e vino (oltre 200 hl di vino ad ha). Anche Varrone commenta le elevate rese di vino del Faentino (300 anfore di vino a iugero, equivalenti a 309,5 hl/ha). E’ quindi da supporre che la zona di Russi, distante poche miglia e con caratteristiche pedologiche analoghe, presentasse analoga produttività. 2 Il conte Raspone Rasponi aveva comprato a Ravenna, nel 1519, una vigna posta fuori Porta Giulia; un’altra vigna venne acquistata nel 1575 a S. Lusa di Faenza (S. Lucia), al prezzo di scudi 704. Altri terreni vitati ed arborati si trovavano nella loro tenuta di Savarna, più vari poderi posti a Campiano, Filetto, Santerno, Bagnacavallo, ecc. Russi, villa San Giacomo e cappella 3 Le uve venivano vinificate in cantina; c’era inoltre un reparto distilleria che produceva acquaviti; nei libri contabili sono puntualmente annotate le spese sostenute per l’acquisto di sostanze usate nella correzione dei vini nonché le prestazioni di specialisti impegnati a tal fine. Inoltre il trasporto del vino, sino alle località romagnole o bolognesi di consumo, veniva effettuato usando carri della tenuta che recavano, sulla trave posteriore, lo stemma dei Rasponi ed analogo logo si presume fosse impresso sul fondo delle botti per facilitarne il riconoscimento. LE STRADE ROTABILI Dovadola, una via di comunicazione, tempera di A.Fedin, 1788. Nel caso particolare della Romagna toscana, la realizzazione di strade rotabili appariva questione della massima urgenza, in quanto si trattava di rompere un isolamento ormai secolare, dovuto, oltre che alla colpevole negligenza di circa due secoli di dominio mediceo, in massima parte alla asperità del suolo e alle avverse condizioni climatiche che per molti mesi all’anno rendevano quasi impossibili i collegamenti con la Capitale. È ovvio che il problema aveva risvolti tecnici (oltre che politici) di grande complessità: il riattamento di una o più delle vecchie mulattiere lungo le quali per secoli si erano svolti, in modo alquanto disagiato, gli spostamenti attraverso l’Appennino, comportava non solo l’individuazione con estrema chiarezza di una direttrice privilegiata capace di mettere in moto l’economia dell’intero comprensorio (da collegare con l’asse principale della vita economica del Granducato, situato sul basso corso dell’Arno lungo la direttrice Firenze-Livorno), ma anche un eccezionale impegno di risorse umane, economiche e di ingegneria.. Ne era presupposto fondamentale il superamento della tradizionale concezione secondo la quale gli elementi fisici (e prima fra tutti la montagna) erano considerati, dal punto di vista militare, come i cardini del sistema difensivo toscano. Si affacciò cosi sempre più insistentemente il progetto di una transappenninica, capace di collegare il porto di Livorno con i porti dell’Adriatico e lungo la quale trasportare, con risparmio di tempo e di denaro, i prodotti (cereali, sale, seta grezza, ecc.) di cui la Romagna era ricca. Già sotto il governo della Reggenza si procedette a interventi sulla strada Bolognese (1749-52) che lambiva la Romagna toscana ad est di Firenzuola attraverso il passo della Futa, lungo la direttrice Monte Carelli-Covigliaio-Filigare; ma l’opera, condotta con approssimazione, lasciò insoddisfatti molti, anche perché fu necessario aspettare il completamento dei lavori sul versante pontificio (1759-64) perché essa potesse essere percorsa completamente da Firenze a Bologna. A fianco della Modenese per il passo dell’Abetone (progettata dallo Ximenes negli anni 1760, e aperta a regolare transito già nel 1779) il sovrano Pietro Leopoldo caldeggiò la realizzazione di una terza rotabile transappenninica, al fine di collegare il Granducato con l’Adriatico attraverso la Romagna toscana (o in alternativa il Casentino), per assolvere la doppia funzione di direttrice di scambi con lo Stato Pontificio e di rivitalizzazione di queste terre di confine. In questo ambito si collocano senz’altro la costruzione della Pontassieve Ponticino di San Godenzo (1783-87), e della Pontassieve-Consuma (1787-89). Sul versante romagnolo, nel 1787 furono inoltre avviati i lavori nel tratto tra Terra del Sole e Rocca San Casciano. Ancora all’inizio dell’Ottocento, nonostante i provvedimenti presi nella seconda metà del XVIII secolo, la viabilità della Romagna toscana, data la generale mancanza di opere di regimentazione idraulica nei fondovalle (sedi stradali non protette, mancanza di ponti, ecc.), era costituita per lo più dai numerosi percorsi di costa situati lungo le pendici dei crinali secondari sub appenninici e dai sentieri di attraversamento congiungenti una vallata all’altra. L’obiettivo, perseguito durante tutta l’età della Reggenza e soprattutto durante l’esperienza di governo di Pietro Leopoldo, di collegare la Romagna toscana al cuore produttivo del Granducato, era stato sostanzialmente mancato, condizionato pesantemente dall’indecisione su quale linea seguire nell’attraversamento dell’Appennino e dalle eccessive spese già sostenute o soltanto preventivate. Al termine della dominazione francese (1799-1815), durante la quale soltanto nel distretto di Modigliana furono compiuti interventi di ammodernamento della rete stradale (rotabili per Marradi e Faenza), toccò al governo della restaurazione affrontare con rinnovato impegno l’annoso problema della costruzione di una rotabile transappenninica. Dopo le ristrettezze seguite alle guerre napoleoniche, era necessario incentivare in ogni modo un aumento del volume di scambi, nonostante il perdurare (almeno fino al 1828) di una sfavorevole congiuntura economica; inoltre lo sviluppo delle conoscenze di ingegneria garantiva il superamento di quelle difficoltà tecniche che avevano tante volte rimandato l’ultimazione dell’opera. Le stesse magistrature comunitative (in cui erano ampiamente rappresentati i potentati locali, costituiti da proprietari terrieri e ceti borghesi ormai definitivamente convertiti al credo liberistico, si mostrarono in quel periodo più attente alle possibilità insite in un adeguato sviluppo della rete delle infrastrutture stradali e più pronte ad effettuare i lavori di manutenzione necessari. Infatti l’abolizione degli ultimi divieti di esportazione per lana, seta, bestiame, olio e cereali intorno al 1820, dette il decisivo impulso alla costruzione delle rotabili, destinate ad accogliere i crescenti flussi di traffico. I primi interventi riguardarono la Faentina, resa carrozzabile dal confine con lo Stato Pontificio fino a Crespino e nel tratto immediatamente a monte della Madonna dei Tre Fiumi (1816-22). Nel 1817 fu redatto il progetto per rendere carreggiabile il tratto Marradi-Crespino e la stessa cosa avvenne nel 1820 per il tratto 5 6 montano del valico della Colla, tra Ronta e Razzuolo. Il percorso scelto fu quello attraverso l’Alpe di Pratiglioni e la valle del Montone: a favore di questo tracciato giocò senz’altro, rispetto agli altri proposti, la sua centralità e la sua minore permanenza ad altitudini elevate. Negli anni 1820-1830 prese avvio la fase in cui con maggior intensità si procedette all’ammodernamento della rete stradale della Romagna toscana. Tra il 1829 e il 1834 venne reso carrozzabile il tratto da Imola lungo la direttrice per Firenzuola attraverso la valle del Santerno, ma la cosiddetta «strada montanara» fu ultimata, con estrema lentezza, soltanto nel 1882. Alla nuova strada «Regia Forlivese» si affiancò ben presto un’altra transappenninica e cioè quella per la valle del Lamone. Negli stessi anni infatti riprese la costruzione della «provinciale Faentina», reclamata con forza dagli abitanti di Borgo S. Lorenzo e Marradi. I lavori approvati nel 1838, cominciarono l’anno seguente e si protrassero fino all’inizio del 1843.. Nel 1836, Leopoldo II aveva ordinato la costruzione della cosiddetta «Traversa di Romagna», destinata a collegare Bagno di Romagna a Rocca S. Casciano; era la nuova strada, che attraversava longitudinalmente le vallate romagnole toccando Galeata e S. Sofia, attraverso i passi di Centoforche, delle Forche e del Carnaio ultimata nel 1840. A questa arteria si affiancarono altre due «traverse provinciali»: la Modigliana-Marradi e la «traversa della Busca», congiungente Portico a Modigliana (attraverso Tredozio), fino al confine pontificio verso Faenza. L’ammodernamento del sistema stradale della Romagna toscana riguardò anche il settore della viabilità forestale: la costruzione di nuove piste di smacchio permise un abbattimento dei costi di estrazione del legname ad alto fusto, primo fra tutti quello che dalle grandi selve appenniniche poste sul versante romagnolo (già di proprietà dell’Opera del Duomo di Firenze) tradizionalmente veniva portato per via fluviale verso Firenze (legname da costruzione) e verso gli arsenali dei porti tirrenici. La diffusione delle rotabili ebbe un positivo riflesso anche sull’endemica “piaga” del contrabbando, che andò progressivamente riducendosi nel corso della prima metà dell’Ottocento: per grossi quantitativi di merce, la diminuzione dei costi di trasporto (legata all’abbattimento dei tempi di percorrenza) poteva rendere talora assai più conveniente il pagamento di una moderata gabella nei confronti dell’aggiramento dei punti di controllo attraverso lunghe e disagevoli «vie di frodo». Intorno alla metà dell’800 la Romagna toscana, soprattutto nel suo settore collinare, risultava quindi attraversata da una rete di strade rotabili piuttosto ampia e fortemente gerarchizzata, capace di attrarre su determinate direttrici consistenti flussi di traffico. Ma restava il perdurante isolamento del settore più orientale, con le due valli del Bidente e del Savio ancora prive di carrozzabili per la Consigli BAGNI DI MARE FINE OTTOCENTO I primi stabilimenti di bagni si affacciano sulle spiagge di Rimini e Riccione è già famosa, ma le precauzioni raccomandate ai bagnanti dai medici sono infinite e tali da scoraggiare anche i più spericolati. Dice il dottor Cerbone Squarci nella sua “Guida per i bagni di mare” « Si faccia il bagno due ore dopo la colazione, e quattro almeno dopo il pranzo. Non entrare nell’acqua a poco a poco, che è dannoso, ma franco ed in un tempo: chi vuol prima raffreddarsi fa male. Non stare nell’acqua più di mezz’ora: assai meno se senti dei brividi o malessere. E nemmeno, dopo il bagno, starai nudo a tremare: tosto asciugato, ti vestirai. Chi ha visto passare molte belle stagioni, o soffre di palpitazione, o d’asma, di vertigini, di sussurro agli orecchi, di convulsioni, od è stato apoplettico, ovvero è affaticato molto o di sudor freddo coperto, non faccia bagni freddi.» Toscana, nonostante le replicate richieste da parte delle popolazioni locali. Nel 1870 vennero finalmente avviati i lavori per la rotabile congiungente Ponte a Poppi con Bagno di Romagna, terminata nel 1882; la strada detta «dei Mandrioli» trovò il suo naturale proseguo verso Cesena con la costruzione a partire dal 1881 della San Piero in Bagno-Sarsina, inaugurata nel 1899. Nel 1900 fu avviata la costruzione della «Tebro-Romagnola», destinata a unire Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano attraverso Verghereto, fino ad allora rimasta priva di strade rotabili. I lavori, interrottisi a causa del primo conflitto mondiale, terminarono soltanto nel 1932. Per quanto riguarda la valle del Bidente, bisognò aspettare gli anni 1930 per vedere costruita la rotabile transappenninica per Stia e il Casentino attraverso il Passo della Calla. Intorno al 1960 infine venne ultimata la rotabile per la valle del Rabbi (e Premilcuore), che valica l’Appennino alla Colla dei Tre Faggi Sulle nuove strade, nel 1910, fanno la loro comparsa le prime autocorriere La CCXI Tornata è per: Domenica 11 giugno 2006, alle ore 10,00 a Cervia, presso il Centro Congressi del Club Hotel Dante, Lungomare G. Deledda angolo Viale Milazzo. Ci troviamo per la più tradizionale delle nostre tornate: la cerimonia di consegna degli attestati di gran merito “VINO DEL TRIBUNO” edizione 2006 alle Aziende vitivinicole di Romagna. La tornata dedicata ai Vini del Tribuno, ci offre anche l’occasione per arricchire le nostre riflessioni sulla Romagna dei Vini, ascoltando due Tribuni che, dal loro osservatorio particolarmente privilegiato, avranno di certo cose degne da raccontare: Dr. Reggi,Tribuno vicario, Presidente Ente Tutela Vini, sul tema: “Romagna terra ottima anche per il vino” Dr. Giordano Zinzani , Tribuno, Presidente Assoenologi sezione Romagna sul tema: “Come si è modificata nel tempo la produzione dei vini Romagnoli” La mattinata prevede anche l’incapparellatura dei nuovi Tribuni: Dr.Stefano Cerni residente a S.Giovanni in Marignano, funzionario della Amministrazione Provinciale di Rimini (3’corte) Ing.Remo Franchini, libero professionista di Imola (1’corte) Dr. Marco Gardini di Savignano sul Rubicone, libero professionista (1’ corte) Perito Industriale Mauro Morri di Rimini, assessore provinciale di Rimini(1’corte) Dott.Fernando Santucci di Rimini, cardiologo (1’ corte). Vi prego, inoltre, di esprimere il vostro parere sulla chiamata nel Tribunato, dei Signori: Luana Babini di Cesena, imprenditrice orchestra musicale (1’ corte) Dott. Arturo Menghi Sartorio imprenditore di Rimini (3’ corte) Dott. Nicola Milandri di Forlì, imprenditore agenzia di assicurazione (3’ corte) Dott.Leonardo Sacchetta di Rimini , funzionario Comunità Montana (2’ corte) Ing.Andrea Tabanelli , di Brisighella, dirigente aziendale (2’ corte) Come sempre, è graditissima la presenza dei Vostri famigliari e amici. Certo di incontrarvi numerosi, Vi porgo il più cordiale dei saluti. Sen. Lorenzo Cappelli I° Tribuno Prego intervenire con le insegne tribunizie. LA RIVIERA ADRIATICA Dal walzer ai balli nord e sudamericani Sul finire del 1800, la mania del ballo toccò il suo punto più alto; negli ambienti dell’alta borghesia ed aristocrazia, primi a far proprie le mode mitteleuropee, iniziò allora ad esaurirsi la novità di danze come polche e mazurche, ma rimase il culto per il valzer viennese, che pure andò ben presto trasformandosi. Sui periodici “balneari” del periodo emerge tale disaffezione per il ballo. Le testimonianze raccolte sono sintomatiche dell’esaurimento di una fase nelle abitudini mondane che porterà in breve tempo a rivoluzionari cambiamenti nelle danze di societa. Nasce il bisogno di rinnovare repertori ed abitudini che possano di nuovo entusiasmare gli animi di un pubblico sempre più esigente. Il ballo non scomparve. Ciò che sparì dalle sale più raffinate che si affacciavano sulla spiaggia romagnola furono “i soliti balli popolari”. Fu le fin fleur della società (come ostentavano chiamarla i cronisti) a disdegnare per primo le danze considerate “campestri”. Nello stesso tempo vi fu chi organizzò feste da ballo per le allegre comitive domenicali, provenienti dalla campagna, che sempre più numerose affollavano le spiagge. Carlo Brighi, da tutta la Romagna conosciuto col soprannome di Zaclén, ebbe l’iniziativa di impiantare a Bellaria un tendone, illuminato di sera con lampade ad acetilene, sotto al quale un’orchestrina, la sua, eseguiva i balli ormai sempre più popolari: il valzer, la mazurca, la polca, qualche manfrina e la sempre più rara quadriglia. Una preziosa foto-cartolina del 1902 ritrae il “Capannone Brighi”, chiamato anche sulla stampa locale “Festival Brighi”, sotto al quale si organizzavano feste da ballo e commedie. È possibile quindi affermare che furono i primissimi anni di questo secolo a sancire il passaggio dagli ambienti dell’alta società a quelli più popolari di quella musica che andrà a costituire le fondamenta di un genere chiamato caparbiamente “Folck romagnolo”. C’è ancora chi ritiene che il valzer sia nato nelle aie romagnole anziché giungervi dopo che le sale da ballo della Riviera e quelle cittadine si riempirono di ritmi americani. Per fugare ogni sospetto di partigianeria valgano queste affermazioni apparse su un gazzettino riminese. Oggi la polka è confinata in qualche cantuccio del carnet; molti carnets, elegantissimi, pretenziosissimi, la escludono affatto; ed essa esula dalle sale, e se ne va, con gli ultimi balli dei nostri nonni, con le ultime danze dei tempi in cui il ballo era una ginnastica piacevole e un divertimento dei giovani, che sapevano «vivere». Ma se diserta le sale, essa sa prendere la sua rivincita in campagna, dove il moto, l’aria, la gaiezza s’impongono. E tutti i bostons e tutti i Lancieri del mondo non valgono una piccola e briosa polka, bal- lata spensieratamente al chiaro di luna, sull’aia, mentre un organino ripete con la sua voce stridente, un vecchio refrain di una vecchia operetta . La stagione estiva, all’alba del xx secolo, era già considerata ed organizzata come una redditizia attività economica basata sul binomio salute e divertimento. Le “solite danze” nel salone dello Stabilimento bagni di Cattolica, inaugurato con balli e fuochi artificiali, davano l’opportunità ad instancabili giovanotti di stringere tra le braccia simpatiche e graziose signorine.. Le feste da ballo a Viserba erano organizzate al Ristorante Stella d’Italia, ogni martedì, giovedì e sabato di tutta la stagione balneare. A Riccione si ballava nell’elegante sala della pensione Amati e nel Salone Trombi di Rimini, la più organizzata spiaggia romagnola di inizio Novecento si stampava il programma delle feste da ballo all’esordio di ogni stagione; si ballava nelle sale riservate dell’H6tel des Bains ricco di eleganti velluti, ma criticato per gli orribili divani della sala da ballo. Le feste erano quasi sempre a tema ed i templi riminesi più attivi dove si consumavano i piaceri del ballo erano le sfarzose sale del Kursaal, il Pavillon-Lido e la grande sala dell’H6tel Hungaria.. Nell’estate del 1909 i balli erano già completamente cambiati. Da quel momento, nelle sale più alla moda si potevano incontrare solo balli nord e sud-americani: il valzer Boston, il two step, l’one step il Cake-walke ed altri ancora. Ad eseguirli per primi furono alcuni maestri di ballo che si esibivano nelle feste serali e tenevano frequentatissimi corsi in orario diurno, pubblicizzati a più riprese su Il Gazzettino azzurro di Rimini. Tutt’altro che destinato a morire, il ballo rivivrà una nuova stagione di successo essendo una grande occasione per incontrarsi, per flirtare e, se esclusi, per disperarsi. Tutto ciò che non veniva dalle Americhe era oggetto di nostalgia o di semplice curiosità. Vi fu chi rimpianse il passato chiedendosi perché le mode cambiassero ~ e chi introdusse le czardas ungheresi e le tarantelle napoletane come fossero bizzarrie folcloristiche. Resistettero, come testimoni di un’epoca passata, i balli cotillon eseguiti quale pretesto per giochi ed offerta di doni. Per il trionfo dei parrucchieri non mancava in ogni stagione il gran ballo Costumé en téte, dove si premiavano le più ammirate acconciature. Negli anni 1910 il luogo sacro del piacere riminese aveva già cambiato nome: lasciato quello ordinario di Casino dei Bagni, aveva assunto quello più esterofilo di Kursaal, da alcuni considerato nome ostrogoto. Nelle sale, non più affollate come un tempo, si 7 becillità della moda e a sviare la corrente pecorile dello snobismo. Monotonia di arie romantiche, tra il lampeggio delle occhiate e dei pugnali spagnoli di De Musset, di Hugo, Gautier. Industrializzazione di Boudelaire, Fleurs du mal ondeggianti nelle taverne di Jean Lorrain, per voyeurs alla Huysmans e per pervertiti alla Oscar Wilde. Ultimi sforzi maniaci di un romanticismo sentimentale decadente e paralitico verso la Donna Fatale di cartapesta. Goffaggine dei tango inglesi e tedeschi, desideri e spasimi meccanizzati da ossa e da fracs che non possono esternare la loro sensibilità. Plagio dei tango parigini e italiani, coppie-molluschi, felinità selvaggia della razza argentina stupidamente addomesticata, morfinizzata, incipriata.» «Possedere una donna, non è strofinarsi contro di essa. Barbaro! Un ginocchio fra le cosce? Eh via! Barbaro! Ebbene, sì, siamo barbari! Abbasso il tango e i suoi cadenzati deliqui. Tango, rullio e beccheggio di velieri che hanno gettato l’ancora negli antifondi del cretinismo. Tango, rullio e beccheggio di velieri inzuppati di tenerezza e di stupidità lunare. Tango, tango, beccheggio da far vomitare. Tango, lenti e pazienti funerali del sesso morto! Oh! Non si tratta certo di religione, di morale, nè di pudore! Queste tre parole non hanno senso per noi! Noi gridiamo abbasso il tango in nome della salute, della forza, della volontà e della virilità.» 8 ballava un valzer più chic, più languido e voluttuoso, chiamato Boston. La mazurca era anch’essa eseguita e ballata con un ritmo lento ed un carattere malinconico, assai diversa da quella conosciuta oggi. Un’alternativa ai balli lenti fu il Cake-wake, la danza dei neri d’America. Era considerato audace perché la dama doveva alzare pericolosamente la gamba, cosa che segnò la breve fortuna del ballo. Arrivato in Europa a cavaliere tra i due secoli, il Cake-wake cadde velocemente in disuso, ma la sua importanza fu notevole in quanto introdusse il ritmo sincopato nelle danze, origine di altre grandi novità. Un nuovo ballo con andamento veloce si affacciò sull’Adriatico e il nome ne rivela la lontana origine: il two steep, il quale poco dopo lasciò il campo all’one steep. Tornò la voglia di ballare e le sale si animarono attorno ad alcuni efficienti direttori che appresero l’arte ed i benefici economici dell’intrattenimento balneare. A Viserba le danze del Circolo dei Bagnanti erano dirette dal valente maestro Ughi, altre volte dal signor Actia. Il signor Arturo Grossi era l’anima dell’Hòtel des Bains di Riccione e la musica era sotto la guida dell’instancabile maestro Luigi Mignatti. A Rimini le eleganti feste all’H6tel Hungaria, di proprietà dei coniugi Müller, erano sotto la direzione dello stimato cavalier Alfredo Amicucci, mentre al Grand Hòtel i balli di beneficenza avevano una direzione tutta femminile e blasonata. C’era però anche chi si improvvisava organizzatore ottenendo risultati mediocri, come accadde per il Gran Ballo Olandese all’H6tel Lido di Riccione. La preparazione era richiesta anche nelle danze ed ecco allora che comparvero ballerini e maestri di ballo professionisti. A Rimini, nell’estate del 1914, fu il tenente Adolfo Strocca, maestro dell’Accademia di Ballo di Torino, a presentare le ultime mode provenienti dalle Americhe: il Triple Boston, la Maxixe brasiliana e, novità delle novità, il tango argentino~ La fortuna di quest’ultimo sta nelle sue forme e movimenti misurati. Il fior fiore della società rifiutò tutto ciò che era grottesco o che richiedeva movimenti esagerati come lanciare le braccia o alzare le gambe. I passi scivolati presero il posto dell’antico girare o dell’affettato ballo sulle punte dei piedi. Il tango, ripulito dagli iniziali movimenti troppo aperti, rappresentò la sensualità e la riscoperta del corpo. Fu il trionfo, sebbene non mancasse chi, per partito preso o per una nuova ventata moralistica, si scagliò apertamente contro i “veleni rammollenti” del tango. «Abbasso il tango » gridò F. T. Marinetti dalle pagine de Il Gazzettino azzurro del 1914. «Questo dondolio epidemico si diffonde a poco a poco nel mondo intero e minaccia di imputridire tutte le razze, gelatinizzandole. Perciò noi ci vediamo ancora una volta costretti a scagliarci contro l’im- Altri associarono l’insegnamento e l’esecuzione del tango con un vecchio ballo popolare: la furlana La ragione dell’accoppiata tra i due balli, così storicamente lontani è presto spiegata. «[Rimini, agosto 1914]. Note di vita mondana. La Furlana. Pio X, per debellare il diabolico trionfante tango, ha rivolto alle danzatrici e ai danzatori del mondo cattolico un consiglio e una raccomandazione perché sia fatta risorgere — in sostituzione del tango argentino — la furlana. La furlana è una danza che si balla sopra un tempo 6/8 — lo stesso della tarantella che nacque a Venezia al principio del XIX secolo; mentre a grado a grado morivano la pavana, la gavotta e il minuetto, classiche ed aristocratiche danze, le quali avevano tenuto il campo durante il secolo XVIII. Evidentemente dame e cavalieri erano stanchi dei molti inchini, delle parrucche, dei passi lenti, dei sorrisi forzati e accolsero con gioia la nuova danza liberatrice: più semplice, più movimentata. In ogni modo il passaggio da un ballo all’altro non poteva essere rapidissimo; e la furlana stentò i suoi primi passi; dovette lottare lungamente contro i balli che voleva e che poté infine detronizzare. Ma per facilitare il suo successo conservò alcuni dei passi più graziosi e caratteristici delle vecchie danze: troviamo, infatti, nella furlana alcune figure che ricordano da vicino il minuetto (piccole promenades, changement de piace, ecc.) mentre altri passi, altre figure sembrano gli ... antenati della modernissima maxixe brasilienne. A poco a poco la furlana si popolarizzò e perdette alcune caratteristiche movenze per acquistarne altre; ma quando rientrò dopo il 1821 nei saloni veneziani riapparve nella sua compostezza primiera e sconfisse definitivamente il minuetto. Fu più tardi, alla sua volta, sconfitta dal valzer saltato, dal valzer a tre, che giunse da Vienna e da Berlino e che cedette più tardi il posto al boston, al valzer a sei, che impera tuttora malgrado tutti gli one step, i turchey trot, i tango, e gli altri balli dell’orso e del pesce di recentissima importazione Al termine della Grande Guerra, i nuovi discepoli di Tersicore si trovarono a cimentarsi con le difficoltà del fox-trot, erede di gran parte dei balli nord americani e figlio della musica sincopata di impronta jazz . Anche le polche, le mazurche ed i valzer, allontanate dalle sale da ballo più alla moda, vennero condizionate dal jazz. Affermazione che può lasciare perplessi, ma è facilmente comprensibile se si pensa alla rivoluzionata strumentazione delle piccole orchestre locali chiamate ad eseguire contemporaneamente il repertorio d’Oltreoceano ed i balli ormai considerati “tipici romagnoli”. Esse si rinnovarono affiancando la batteria (chiamata per lungo tempo “il jazz” ), il saxofono ed il banjo agli strumenti tipici dell’orchestrina da ballo come gli archi ed il clarinetto in Do. L’influenza del jazz sulla musica da ballo romagnola merita lo sforzo di altre ricerche. Franco Dell’Amore LA SARTA SIGNORA VIRGINIA Premessa Molti anni fa mi capitò di trovare a Bologna, in Piazzola, un grosso album in pelle di quelli che solitamente contengono fotografie che sono l’oggetto delle mie ricerche di collezionista. Rimasi molto male quando, apertolo,vi trovai lettere e bigliettini relativi ad un carteggio, ma quando, leggendo a caso qualche lettera, capii di cosa si trattava, rimossi la delusione. Acquistato l’album lo studiai in maniera approfondita tanto da trarne alcuni saggi sulla storia economica della moda e del costume. Era il carteggio, avvenuto durante alcuni decenni, di una sarta bolognese, molto famosa alla fine dell’Ottocento. Se anche la corrispondenza, per sua natura, non si riferisce a tutta la clientela della sarta ma solo a quella parte che non abitava a Bologna, é certamente rappresentativo del costume di un’epoca. Per vostra curiosità aggiungo che ella abitava a Bologna in via Lame al n° 46. Per i lettori di questa rivista riporto qualche stralcio di lettere ed alcuni commenti che ritengo possano interessare. «Macerata, 15 agosto 1905. Il giorno 13 le inviai il saldo del mio dare... lo stesso giorno le scrissi facendole notare come l’abito fosse mal confezionato. La prego di non calcolare quelle frasi per le seguenti ragioni. Qui a Macerata pochissime vestono bene non solo, ma la moda viene dopo qualche anno. Appena io vidi l’abito bianco non le nascondo la mia sorpresa poiché costì non ve ne sono uguali. Ed appena misurato [indossato?] mi sembrò invero ridicolo. Cosa vuole io confesso la mia poca esperienza e bisogna che mi rimetta agli altri voleri. Mia sorella, reduce da Milano, mi ha fatto vedere i suoi vestiti e mi ha convinto che tutto andava bene ed anzi m’ha gridato, meravigliandosi del poco mio gusto. Creda buona signora, che un vestito che ancora qui non si vede (al)la moda, produce un grande effetto. Appena osservai gli abiti di mia sorella e gli abiti della Marchesa Ritzer nostra vecchia conoscenza, ed appena appresi la moda delle altre città mi convinsi del grande errore...». Così una delle tante lettere diligentemente raccolte in un bell’album con ricca rilegatura in cuoio che porta impresso sul piatto: “Virginia Notari Fattorini -Corrispondenza - Bologna”. La raccolta si riferisce ad un periodo che va dall’ultimo decennio dell’ottocento al primo decennio del novecento. Ovviamente, in un album di corrispondenza, le lettere parlano esclusivamente di rapporti con le clienti che non risiedono a Bologna, dove era ubicata la sartoria e pertanto non può mostrare quelli con tutta l’altra clientela locale. Altre osservazioni di ordine generale si possono fare sulla fascia sociale, certamente alta, della clientela, come l’album stesso evidenzia e sull’area territoriale che è prevalentemente marchigiana e ferrarese con alcune eccezioni, chiaramente dovute a trasferimenti per lavoro del coniuge. Infatti dalle lettere si rileva che non sono poche le clienti mogli o figlie di funzionari dello Stato, di militari e di ingegneri dediti alla costruzione delle ferrovie che mantengono i rapporti con la nostra sarta anche nelle nuove residenze. Vi è anche una clientela acquisita esclusivamente tramite corrispondenza, che non ha mai visitato l’atelier ed incontrato personalmente la sarta bolognese, ma che ad essa si è rivolta attraverso una trafila di referenze di parenti ed amiche. «…Ho bisogno dell’opera sua. Ho visto da molto tempo i suoi lavori alle R. di Macerata e a Matilde C. mia conoscente e qui alla signora V. Perciò vorrei pregarla di mettere anche me nel numero delle sue clienti. Io vivo a Modena, come vede siamo vicine....» «Macerata... Se viene ad Ancona per la stagione balneare verrei per il piacere di fare la sua conoscenza personale…» «Migliarino... sono stata contentissima (del vestito). Noi qui andiamo vestiti alla buona con abiti andanti, di poco costo....» Appare poi singolare la capacità della sarta di confezionare abiti attraverso il solo invio per posta di misure o modelli. «Ferrara... siccome quest’anno le sottane usano corte, ho messo un filo nella lettera che sarebbe la lunghezza giusta dell’abito». «...la camicetta e la blusa dell’abito mi vanno un po’ strette. Quindi per l’abito nuovo la prego di allargare il giro della vita di un mezzo centimetro e il giro del petto di un centimetro buono.» Come si legge la cliente è molto prudente nel proporre aggiustamenti! Una volta consolidate clienti, esse richiedono anche modifiche non derivanti dalla moda, ma da altre ragioni: «…le invio due metri di stoffa per farmi una giacca... sono incinta, la prego di farmela molto comoda davanti....la prego di servirmi con la solita premura e col solito capriccio...». E infine quando si parla di cappellini: «Il cappellino deve essere di forma che stia bene su tutti i vestiti e stia fermo in testa…. …il cappello non è adatto ad una signora vecchia.., ella lo vorrebbe senza velo lungo dietro, di un modello che calzasse in testa ossia in forma di “cappotta” poi con nastri per legarlo.» Ma col passare degli anni e a causa delle frequenti maternità le richieste investono motivazioni estetiche: «... nella mia giacca nera si ricordi di mettere gli ossicini nella vita...» e quando l’intervento deve essere più incisivo: «…sia tanto gentile da mandarmi una fascia elastica per intorno al corpo della grandezza di centimetri 80 e più alta che sia possibile... …Mi rimetto sempre a lei per la foggia purché sia sempre di quelle che “sveltiscono” la persona...» Sono singolari i rapporti economici con molteplici richieste di sconto e lamentele per il prezzo ritenuto troppo alto. Quasi sempre il rilievo è poi mitigato da complimenti per il lavoro eseguito (la fattura) al fine di non offendere la sarta e perdere le sue rinomate prestazioni: «…rifaccia bene i suoi conti e vedrà che può rimanere soddisfatta.. Macerata 1897...ho ricevuto la mantella della quale, nell’insieme, sono contenta perché mi piace, mi sta bene. Non sono punto soddisfatta del prezzo. Convengo che qualche cosa doveva crescere perché è più lunga, ma nel suo conto l’aumento è veramente troppo forte. Spero che quando pagherò combineremo secondo il solito e che Ella vorrà farmi un forte ribasso...» La sarta è invitata non solo a presentare “liste non esose” (ovviamente dal punto di vista della clientela) ma anche eque nei confronti delle parenti ed amiche che notoriamente fanno parte della stessa clientela e che sono poi avvezze a parlare tra loro, in particolare di vestiti. «...ma ho trovato il conto estremamente caro, anche perché ho potuto paragonare ciò che lei fa spendere a noi, ai conti che lei manda a mia sorella e alle mie amiche. Le vesti nere, per esempio, sono addirittura favolosamente care. Voglio sperare che mi farà un grosso calo… ...per le fatture delle mie nipoti cerchi non si distacchino molto da quelle che fa per me, siamo in un piccolo paese...» Le richieste per dilazioni nei pagamenti sono frequenti e le ragioni o scuse tra le più varie, anche se il rinvio nel tempo è modesto e per noi irrilevante, abituati come siamo a comportamenti commerciali più disinvolti. ottobre 1896 «...la prego concedermi un po’ di tempo (per pagare) perché saprà che ho comprato dell’uva e non potrei mandarle il suo saldo che ai 7 o 8 di novembre...” Ma a volte il problema o il ritardo è più grave ed è necessario l’intervento del marito avvocato che scrive in prima persona: 1896 «Le spedisco un vaglia della Banca d’Italia per £. 395 a saldo del vostro conto di £. 405. La differenza di £.10 rappresenta la diminuzione fatta su alcuni prezzi trovati troppo alti..» «Domando scusa per il ritardo al pagamento causato dalla trascuratezza di mia moglie nella consegna del conto.» Se riportiamo l’ammontare di quel conto al valore attuale della moneta, esso sarebbe oggi stimato in alcuni milioni di lire o migliaia di €. Una trascuratezza pelosa quella della signora e quindi spiegabile l’imbarazzo del marito anche perché si capisce chiaramente che ella, fino a quando le è stato possibile, l’ha tenuto all’oscuro della notevole spesa. Egli allora teneva sì autorevolmente il potere e i cordoni della borsa, ma tuttavia doveva poi scomodarsi e rimediare al salasso economico una volta che questo era avvenuto. Gian Franco Fontana 9 FRANCESCO VERLICCHI Decano dei pittori ravennati 10 L’artista al centro dell’attenzione di questo numero della nostra rivista è il decano dei grandi pittori di Romagna che ha segnato con la sua forte personalità l’atmosfera degli ambienti pittorici del Ravennate. Venuto alla luce a Fusignano l’8 maggio del 1915, Francesco Verlicchi, per gli intimi Chicco, era nato artista fin nelle midolla, essendo egli attratto non solo dalle arti figurative, ma pure dalla musica. La sua prima aspirazione, infatti, avrebbe dovuto fargli abbracciare la professione di musicista, anzi Francesco Verlicchi in un recente di pianista. Ma le difficoltà ritratto a matita di Odette Gelosi economiche della famiglia - il padre, imbianchino, riusciva a mala pena ad assicurare condizioni di vita appena accettabili a sua moglie e ai suoi quattro figli - infransero il sogno del piccolo Francesco che dovette seguire le orme del padre e pitturare pareti, contribuendo così a racimolare qualche soldo in più per consentire al gruppo familiare di sbarcare il lunario. Ma, per fortuna, la sorte volle che, in quella zona di ricchi proprietari terrieri, venisse creata, proprio a Fusignano, la Scuola di Arti e Mestieri, diretta, su nomina del Comune, dal noto pittore lughese Giulio Avveduti. Il giovane Verlicchi seguì le lezioni con alacre lena, scoprendo, insospettate in sé, doti segniche inequivocabili e uno specifico interesse per la figura. Egli seguì pure i corsi serali di Vistoli e Montesano. Dal 1928 al 1940 divenne il discepolo prediletto di Avveduti, dapprima come allievo, poi come garzone, impegnato quale suo aiutante nel restauro dei dipinti della Chiesa di San Giacomo Maggiore di Lugo. Tali erano le qualità di riproduzione grafica di Verlicchi che il suo maestro gli consigliò di lasciare la sua Fusignano e di aprire uno studio di pittore a Ravenna, specializzandosi nei ritratti nei quali egli eccelleva e che, in quel periodo, consentivano un discreto guadagno. Dal 1945, dopo la seconda guerra mondiale, egli diede inizio ad una fervida attività espositiva e la sua fama ormai consolidata gli valse un posto d’insegnante ( subentrò pure a Giulio Avveduti alla direzione della Scuola di Arti e Mestieri di Fusignano). Nel 1958 vinse il concorso per l’insegnamento quale docente di disegno dal vero presso l’Istituto d’Arte per il Mosaico di Ravenna appena costituito. Fu la perfezione dei suoi ritratti a convincere i membri della giuria della predisposizione a trasmettere le sue conoscenze tecniche quale docente. Il suo compito nel panorama curriculare d’insegnamento rivestiva una particolare importanza, giacché le sue discipline d’insegnamento, disegno e composizione oggettiva, costituivano la base di tutto il programma. Per ventitré anni Francesco Verlicchi trasmise la sua esperienza a schiere di studenti, esercitando parallelamente un’intensa attività pittorica ed espositiva, per poi ritirarsi in pensione, beneficiando di una legge che gli riconobbe otto anni per aver combattuto in guerra. Da allora l’artista fusignanese si è totalmente dedicato all’arte, confermando la sua fama di grande pittore che, insieme agli amici Folli, Ruffini, Varoli, animava negli anni Settanta la vita artistica del Ravennate. L’esistenza di Verlicchi non si è mai discostata idealmente dalle parche consuetudini del vivere rurale. Pur curioso e idealmente avido di conoscere, egli non si è spostato sovente, e ha sopperito all’assenza di viaggi facendo entrare in casa sua il mondo dell’arte mediante pubblicazioni artistiche che gli procuravano le librerie Tarantola e Feltrinelli. Tuttavia un soggiorno lontano dalla sua Fusignano fu determinante per la sua evoluzione artistica: egli approfittò al massimo di un viaggio a Parigi nel 1950, quando, dopo aver vinto il Premio Marina di Ravenna, ebbe occasione di usufruire delle modalità stabilite dal Ministero degli scambi con l’estero, che gli permisero di trascorrere tre mesi a Parigi. La sua esperienza nella capitale francese si rivelò esplosiva quando, in visita nella palazzina del Jeu de Paume a sinistra dell’ingresso dei giardini delle Tuileries, egli venne a contatto con Corot, Degas, Manet, Monet, Renoir, Sisley, Van Gogh. Allora il tonalismo intimista della visione morandiana fu ad un tratto travolto dagli esiti della visione “en plein air” e dalle modificazioni cromatiche degli impressionisti. Fino allora abituato al linguaggio dei nostri macchiaioli in cui le ombre appaiono scure, Verlicchi fu affascinato dal quel nuovo concetto di dare un colore alle ombre, il che determinò nel pittore italiano una radicale trasformazione della sua tavolozza, da quel momento volta a determinare vibrazioni del colore. Anche la frequentazione del Musée d’Art Moderne gli fece scoprire l’atmosfera insieme frivola e malinconica delle tele di Toulouse-Lautrec e le opere dei grandi dell’arte fino all’informale, facendogli intuire il valore della libertà assoluta concessa dall’espressionismo per ingigantire l’espressività creativa. In particolare fu piacevolmente colpito dalle creazioni dei Fauves in cui egli scopriva il colore caldo della vita rappresentata in un’intensa armonia fra luce, calore e colore. Il Maestro di Fusignano confessa l’importanza dei suoi contatti parigini per la sua tecnica esecutiva, mentre minimizza l’influenza del mosaico ravennate che non ha contribuito a rivelargli il gioco del colore. Per Verlicchi, “nella pittura ci vuole colore e poesia”. Attento osservatore, egli coglie sempre dal vero l’oggetto pittorico con un’evidente preferenza per la figura che esce dal suo pennello con la massima espressività, in un’originale verità sempre ammantata di un alone impalpabile di finezza psicologica, abilmente determinata da un soffuso cromatismo. Eccelso ritrattista, ottimo disegnatore attento ad una composizione equilibrata, il pittore dà libero sfogo alla sua ironia cimentandosi pure in brillanti e riuscite caricature di persone del suo ambiente, non trascurando di sorridere di se stesso. Le sue nature morte si vestono della poesia del suo sentire, una poesia semplice, tenue, trascritta dalla delicatezza cromica della sua tavolozza. In tutte le sue opere egli rende l’impressione mediante fremiti coloristici legati alla distribuzione più o meno densa delle pennellate. Segno e colore si completano, rafforzandosi ed imprimendo al quadro la forza suggestiva di dolcezza, di sogno o di bonario graffio ironico. Ed è tuttora bello vedere ancora all’opera il Maestro, con quella ombrosa eppur dolce determinazione a continuare a vivere con il pennello in mano, perché per lui dipingere è esistere. Odette Gelosi Natura Morta PESTE E CANNIBALISMO IN ROMAGNA Verso la metà del sec. XIV accadde un fatto spaventoso che doveva tenere per anni l’Europa sotto lo spettro della morte e in seguito quello, non molto migliore, della fame. Fin dal 1333 la peste aveva fatto la sua apparizione sulle rive del Mar Nero, per poi dilagare in tutta l’Asia e passare anche in Africa con una violenza tale che molte regioni rimanevano semi spopolate. Un mite ottobre intiepidiva la Sicilia quando vennero ad attraccare nel porto di Messina 12 galere veneziane provenienti dall’Oriente. Era il 1347 e a bordo avevano la peste. Fu l’inizio di uno sterminio senza pari. Dalla Sicilia l’epidemia prese a risalire con una impressionante rapidità tutta quanta la penisola e a riempirne le città e le campagne di lutti. Gli astrologi avanzarono l’ipotesi che la causa di questo guaio fosse da attribuirsi alla congiunzione di Saturno, Giove e Marte avvenuta nel 1345, però si era generalmente propensi a credere che dei vapori malefici fossero scaturiti dalla terra, avessero contagiato le messi e i frutti, i fiumi e i pozzi per poi diffondersi nell’aria e inquinarla senza rimedio. In precedenza si erano avute molte epidemie, però avevano sempre investito zone limitate, imperversando sopra una città, o tutt’al più sopra una regione. Mai avevano avuta una simile estensione. Chi veniva colto dalla malattia polmonare moriva in tre giorni, chi sotto forma di bubboni in cinque. In ogni città, in ogni villaggio, sotto ogni bandiera, la reazione era una sola: terrore folle per ciò che di spaventoso c’era realmente nell’epidemia e per quello che la superstizione vi aggiungeva in un secolo in cui l’ignoranza imperante inibiva ogni senso critico, lasciando libero il campo alle credenze e alle dicerie più assurde. Si vedeva la magia dovunque in una grande confusione d’idee, in cui il diavolo del Cristianesimo si univa ai demoni e alle forze Stampa tedesca che rappresenta un festino con carne umana, sec. XV malefiche del paganesimo, che ancora non erano del tutto scomparse dalla mente dell’uomo medievale. A Roma, nel sesto secolo, era stato riaperto il Santuario di Dioniso a furor di popolo ! Questa prima ondata di peste durò per quattro anni consecutivi; in seguito ebbe delle riprese sempre ugualmente terribili, anche se meno diffuse. Vi perse la vita la Laura del Petrarca e, stando al Villani, nel 1358 a Firenze morirono circa 100.000 persone. Come immediata conseguenza la morte indurì i cuori sconvolgendone i sentimenti e allentandone a volte anche i vincoli affettivi più tenaci. Perfino qualche madre si scostava atterrita dal capezzale del figlio colpito dalla pestilenza nella certezza di non potergli essere di alcun aiuto e più ancora nel timore, divenuto ormai simile alla follia, di venirne contagiata. E i cadaveri che spesso s’incontravano abbandonati lungo le strade non facevano che acuire il disperato senso di orrore dell’uomo indifeso, preda di qualcosa che andava al di là della sua ragione. I medici, avvolti in vesti lunghe e ampie che li ricoprivano tutti e con una spugna imbevuta d’aceto perennemente contro il naso, s’aggiravano per le città a prescrivere purganti e salassi e la Teriaca, che si diceva buona per qualsiasi malattia perché era composta da un numero così grande di sostanze (originariamente 154) che ogni malanno poteva scegliersi quella che faceva al caso suo. Intanto si bruciavano cumuli d’incenso e di camomilla. In uno slancio di penitenza comparvero nelle vie le lunghe file dei flagellanti: uomini e donne, scarmigliati e seminudi, che si percuotevano fino a ridursi grondanti di sangue. Ma gli uomini continuavano a morire in tutta Europa e i loro corpi li seppellivano accatastati in fosse comuni. Gli scongiuri non servivano, le benedizioni neppure, allora cominciò a farsi strada nelle menti confuse e spaventate l’idea dell’esistenza di una intesa diabolica e che doveva esserci qualcuno che, d’accordo con le forze del male e magari per procurare anime per il diavolo, s’industriava a far sì che il morbo dilagasse. In tempi recenti la colpa di un simile flagello é stato attribuito in buona parte ai topi, che vivono nelle fogne, cioè tra i rifiuti dove si sviluppano microbi e virus e anche alle pulci, che nel Medioevo non mancavano certo. Ma l’uomo del .Medioevo non pensava di attribuire a loro la colpa dell’estendersi della pandemia. Secondo la sua abitudine mentale rivolgeva piuttosto il pensiero alla magia e alla perversità umana. San Tommaso d’Aquino e Sant’Agostino avevano detto: «… Omnia quae visibiliter fiunt in hoc mundo, possunt fieri per daemones» e nella gran massa ignorante tali parole non avevano fatto che confermare un convincimento già saldo, per cui in ogni avvenimento che andasse al di là del consueto si vedeva un intervento magico. Un pazzo, un paralitico, una meteora erano fatti extraterreni, che esulavano dalla comprensione comune e che di conseguenza potevano benissimo rientrare fra le manifestazioni demoniache. Naturalmente c’era chi sapeva approfittare di tali superstizioni. In Francia una donna, che era soggetta a crisi di epilessia, fu processata come strega e truffatrice nello stesso tempo. Il processo significava tortura e la disgraziata confessò di aver approfittato della sua particolare condizione di epilettica per procurarsi di che vivere. Ci si convinse che vi fossero delle persone che, immuni per una concessione fatta dal diavolo, si divertissero a raccogliere i vapori maligni che la terra sprigionava da qualche parte per buttarli nei pozzi, nei rivi, nelle cisterne, insomma dovunque esistesse acqua potabile e che tutta l’umanità fosse destinata a perire. L’idea di ricercare i colpevoli venne dapprima sussurrata, poi dichiarata a gran voce, in breve finì col divenire una necessità incombente e l’uomo diede una caccia spietata all’uomo. All’epidemia di peste si può dire che vi si aggiungesse una epidemia psichica. Ma chi si doveva cercare? Non era difficile nello stato di tensione terrorizzata che era andato formandosi e nell’oscurità dell’ignoranza trovare un volto ai colpevoli. Bastavano un antico odio, il ricordo di un gesto o di una parola sospetti, la taccia di 11 Stampa germanica antiebraica con ebrei che sezionano un corpo umano, sec. XV 12 comunicare col demonio o di appartenere a una razza o a una religione che non fossero le dominanti per scatenare gli istinti più crudeli. Era difficile che in una famiglia nessun membro fosse stato colpito dalla peste, ma se per caso c’era, subito sopra di quella si appuntavano i sospetti. E la risposta veniva da sé: «sono in combutta col diavolo». E quei poveretti erano spacciati. Così alla lunga fila delle vittime della peste si aggiunse quella dei massacrati dall’uomo. La prima città in cui avvennero queste uccisioni fu Avignone, che, sotto l’incubo della morte, venne pervasa da un’assurda sete di vendetta. In modo particolare si presero di mira gli ebrei e questa specie di sommossa espiatoria diede luogo a un vero massacro. Da Avignone, lo stesso sistema fu adottato da parecchie altre città e in Germania prese l’aspetto di un violento movimento antisemita. Ma l’epidemia continuò a imperversare finché rimasero solo quelli diventati immuni senza distinzione di credo. Si calcolò che in Europa ci fossero stati circa 25 milioni di morti, cifra paurosamente alta quando si pensi che la popolazione totale era stimata attorno ai 100 milioni. Passata la grande pandemia, la popolazione di molte città risultò dimezzata e molti villaggi rimasero spopolati, i campi abbandonati. Le classi più ricche erano quelle che avevano resistito meglio alla furia dell’epidemia, perché avevano avuto modo di rifugiarsi in luoghi isolati, di nutrirsi meglio e di evitare, per quanto possibile, il contagio; invece il popolo minuto aveva subito il colpo più forte. Nel 1314 erano stati segnalati casi di persone che, spinte dalla carestia, avevano mangiato carne d’uomo. Ora la peste faceva che quegli episodi si ripetessero. Ma non erano casi nuovi e isolati. Nei secoli precedenti era stato ripetutamente riferito che qualche commerciante, che per la necessità del suo lavoro percorreva da solo un bosco, non fosse giunto a destinazione e che neppure il suo corpo fosse stato più rinvenuto. Una simile sorte era pure toccata a qualche famiglia di girovaghi e di saltimbanchi, gente che di continuo si spostava e la cui assenza difficilmente si notava se non dopo parecchio tempo. Era risaputo che in periodi di carestia bande di assassini si specializzavano in questa macabra macelleria. E in genere chi si recava in tali periodi al mercato era tanto felice di potersi procurare un po’ di carne che non stava a sofisticare sul colore o sulla forma. Questo si potrebbe chiamare un genere di cannibalismo senza colpa perché inconscio, ma non era così per quelle madri che si cuocevano i loro piccoli appena nati. Ed era successo anche questo. Non si poteva più parlare di magia, la fame trasformava l’uomo stesso in un demone ripugnante. Se nel tardo Medioevo, quando l’uomo era vagamente più progredito, la peste e la fame potevano portare a così terribili estremi quali il cannibalismo e il massacro per superstizione, si può immaginare quale doveva essere la mentalità degli uomini delle classi sociali più basse nel primo Medioevo, quando saccheggi e incendi, fame e peste accompagnavano le marce degli eserciti barbarici. Durante quelle invasioni la vita economica rimase paralizzata. Le strade erano pressoché impraticabili e per di più infestate da gruppi di soldati dispersi e da briganti. Nessuno pensava più a mantenere efficienti gli argini dei fiumi. Le attività artigianali locali erano andate distrutte. Di molti villaggi non rimaneva che un cumulo di macerie annerite per l’incendio. In questo ambiente desolato si aggiravano esseri che la fame rendeva simili ai lupi.. Procopio da Cesarea, testimonio oculare, ci racconta come i Toscani macinassero ghiande per farne pane e come tale cibo provocasse loro la morte. Allora essi cercavano d’interpretare nell’erba i segni del demone del vento, di comprendere le ammonizioni delle stelle, d’individuare il diavolo che era sceso tra loro e, se talora un conoscente, avventuratosi nel bosco non ne usciva più, si parlava dei lupi mannari che vi si erano celati. E Procopio aggiunge: «…vi furono taluni che, sotto le violenze della fame, mangiaronsi l’un l’altro...». «In una campagna non molto lontana da Rimini c’era un villaggio, nel quale, dopo una epidemia e la conseguente carestia, erano rimaste superstiti solo due donne. Non si sa come riuscissero a sopravvivere. Di tanto in tanto passava di là qualche viandante che, stanco, chiedeva loro ospitalità. Esse gliela accordavano di buon grado, invitandolo a pernottare nella loro capanna. Sennonché quell’ospite era destinato a non uscire mai più dal villaggio, perché nella notte le due donne lo colpivano nel sonno e lo uccidevano per destinarlo al loro sostentamento. Col passare del tempo di viandanti ne erano stati ospitati e regolarmente mangiati 17, quando giunse il diciottesimo. Anch’egli chiese ospitalità e anche a lui fu gentilmente accordata, ma, o ch’egli si fosse accorto di qualche poco convincente maneggio o che avesse il sonno leggero, fatto sta che si svegliò proprio nel momento in cui le donne si accingevano a ucciderlo e balzato loro addosso, ne conobbe tutta la storia e ambedue le uccise ». a cura di Aurora Romanini Ferraresi Processione di “flagellanti”, sec. XIV E TRATÔR Siamo nel 1938, Mario ed Vizenz, assieme al padre ai fratelli e a tre cugini, uniscono tutti i risparmi di una vita per comprare un trattore; “un Landini”a testa calda con una potenza di 45 cavalli, col patto siglato da una stretta di mano, di usarlo per i lavori necessari a due poderi vicini e se possibile per conto terzi. Mario aveva ottenuto da poco e con una certa fatica la patente “per trattrice con motore endotermico”. Detto oggi, non fa nessun effetto, ma al tempo si contavano sulle dita di una mano in quel piccolo comune nelle vicinanze di Faenza. Quando andava al bar “Vittoria” dove si svolgevano le contrattazioni, e dove i sensali seduti generalmente ad un tavolo d’angolo aprivano i loro portafogli a fisarmonica “ed vachetta” cioè di cuoio grezzo e regolavano gli acquisti, le vendite e le riscossioni, ricevevano spesso delle pacche sulle spalle e l’offerta del vermut o del caffè corretto “al mattino” Un vicino di casa, dopo che bevuto il vermut se ne era andato, disse che l’offerta del bere era per tenerselo buono, perché “un sa mai, lô e guida e trator.” Il giorno della consegna del trattore, si presentarono tutti in bicicletta al Consorzio Agrario di Faenza, consorzio che aveva provveduto, come rappresentante, oltre alle pratiche e al pagamento, al trasporto dalla stazione, dove era arrivato la sera prima, al piazzale antistante il consorzio stesso. Ed ora, eccolo: Verniciato di grigio azzurro con le ruote rosse troneggiare (è il caso di dirlo) davanti a tutti, che radunatisi attorno lo ammiravano. Mario con lo stomaco stretto stretto dall’apprensione, si accinse allora, sotto la guida del meccanico del consorzio e con il libretto di uso e manutenzione in mano, ad eseguire le manovre per la messa in moto. Per prima cosa il rifornimento di nafta, poi il riempimento di acqua nel radiatore, poi il riempimento con benzina della “leopila” in dotazione, la sua messa in pressione e l’accensione. Questo aggeggio serviva con la sua fiamma a dardo di colore azzurrognolo messa per terra sotto la testata dell’unico cilindro del trattore “ un due tempi di 4200 cm3 per portare al calor rosso una parte della medesima; cosi facendo, quando il pistone metteva in pressione l’aria e arrivava il carburante, questi esplodeva e così sempre di seguito rimanendo rossa all’infinito. Dopo una buona mezz’ora, giudicato il riscaldamento della testata sufficiente, in due, uno di qua e uno di là, afferrati i due grossi volani, li fecero girare. Uno sbuffo di fumo azzurrognolo uscì dal grande e caratteristico tubo di scarico, poi uno scoppio, poi un altro; lentamente i volani raggiunsero i 700 giri, la velocità massima. Poi Mario si sedette sul sedile di ferro traforato sorretto da una balestra: “sembrava una grande ramina”, ridusse i giri, innestò la marcia, allentò il freno a mano e con uno scatto il trattore si mise in movimento. Il rumore era a dir poco assordante; oltre agli scoppi del motore un rumore di ferraglia accompagnava la sua marcia, seguita dal codazzo del parentado in bicicletta. Nel pomeriggio già stava arando nel campo. Il solco tracciato dall’aratro non era proprio dritto, ma tant’è c’è un inizio per tutto. Però Mario aveva un pensiero nascosto, un tarlo nel cervello che non lo lasciava in pace; aveva saputo che in città, vi era un meccanico che sapeva modificare la pompa di iniezione della nafta, e dare perciò più potenza al motore. Un giorno, con la scusa di comprare due latte d’olio lubrificante, lo andò a trovare. Presto si accordarono, il meccanico gli garantiva cinque cavalli in più e avrebbe fatto il lavoro sull’aia. Detto fatto, dopo pochi giorni arrivò in bicicletta, tirò fuori da una sporta fatta di foglia di frumento intrecciata e infilata nel manubrio i ferri del mestiere, e in poco tempo divenne un trattore truccato. Poi un giorno di mercato si presentò al solito bar dove sapeva che vi avrebbe trovato diciamo un collega che guidava lo stesso tipi di trattore Col fare più innocente di questo mondo, per caso, si trovò al banco proprio mentre quello sorseggiava il suo vermut: «Allora come va» attaccò Mario «il Landini?»« Benissimo» rispose l’altro, « l’altro ieri ho arato il podere “dla Martlozza”, e sono andato a fondo con l’aratro ben 40 centimetri» «Bè» disse Mario «ma io lavoro sempre con il mio a 50 centimetri.» «Non è possibile “un’gna fa”» «Sé che u’ia fa» «No» «Sé» «Scumitegna una zéna» «Ai stagh.» Al pomeriggio nel campo prescelto tutto il bar era presente; arrivò Mario con trattore e aratro. Fu controllato e trovato normale, iniziò l’aratura. Il solco era oltre i 50 centimetri di profondità. La sorpresa fu totale e alla fine dell’aratura fu evidente a tutti che la scommessa era vinta. Naturalmente Mario si guardò bene dal dire qualcosa sul trucco e anche il meccanico stette zitto, perché, per il suo silenzio, aveva patteggiato due capponi per tre Natali. Durante una trebbiatura una “azdora” dopo aver fritto almeno otto padellate di patate, vide che il grasso di maiale con cui friggeva non era più buono, e decise di buttarlo. Il marito scherzando disse che poteva essere usato come carburante per il trattore. Mario non fece una piega, prese la padella (bella grande e con tre dita di grasso fuso) e versò il tutto nel serbatoio del Landini. Sembrò che il ritmo di funzionamento migliorasse, solamente si sparse per l’aia un forte odore di fritto. In una calda notte estiva Mario col suo trattore faceva funzionare una pompa per irrigazione vicino al Rio Salato: la notte era calda e stellata e, dopo aver fatto rifornimento Mario, non avendo nulla da fare, si era seduto su di un tronco tagliato, tutto era tranquillo; il battito del motore era regolare, si rilassò e decise di fumarsi una sigaretta. Nel momento che accese il fiammifero, una fiamma azzurrognola dai contorni rossastri lunga quasi un braccio gli lambì la faccia.. Impaurito si alzò di scatto, ma la fiamma lo seguì, fece un passo indietro, ma vi era il tronco e cadde all’indietro; la fiamma lo seguì mentre cadeva per un attimo, poi sparì. Mario rimase sdraiato per un poco cercando di capire cosa diavolo fosse successo. Finalmente si alzò con molta circospezione e con le gambe un po’ molli si diresse verso il trattore vi salì sopra e facendosi forza riaccese un altro fiammifero, questa volta però non successe niente . Un poco rassicurato restò sul trattore fin verso le sei del mattino, ora in cui gli veniva dato il cambio.«Tè una faza come s t’aves vest e geval» gli disse Tugnì dl’a ca et ciotta appena lo vide. Mario gli raccontò per filo e per segno ciò che le era capitato. Tugnì si mise a ridere e gli spiegò che lungo l’argine del rio, vi erano dei cosiddetti “ Buldur” (vulcanetti nel terreno che emettono fango e gas metano e che specialmente in estate possono incendiarsi. Tempo dopo, un giorno mentre arava un podere in quel di Brisighella, l’aratro si impuntò contro una vena di roccia non visibile: Il trattore alzò le ruote anteriori come un cavallo imbizzarrito; il perno di collegamento trattore aratro si ruppe e il trattore ricadde con Mario attaccato spasmodicamente al volante. Si risolse così, bene, una situazione molto pericolosa. Quello era un trattore con l’anima, guidarlo tutto il giorno, causa le forti vibrazioni, era come fare all’amore tutto il giorno con la moglie “senza però e gost” Quel l’era un trator, miga quei d’incö!. Pier Giorgio Casadio Prati 13 MUSSOLINI ANARCHICO 14 Il 14 marzo del 1912 un muratore anarchico, certo Antonio d’Allo stesso a prendere la licenza elementare. ba, attentò alla vita di Vittorio Emanuele III. Poi i genitori lo fecero accettare al collegio laico Carducci di Il re si salvò e nel pomeriggio i deputati di ogni corrente politica Forlimpopoli: dopo un anno l’espulsione. Vi era entrato portando salirono al Quirinale per felicitarsi dello scampato pericolo: tra con sé il coltello a serramanico che soltanto anni più tardi avrebbe gli altri sfilarono davanti al sovrano e gli strinsero la mano gli lasciato per la pistola. onorevoli Bissolati, Bonomi e Cabrini, socialisti. Questi tre erano Gli è che facendosi giovanotto Mussolini prese a rivestire la pronoti per il loro buon senso, per la loro politica conciliante e compria istintiva violenza di fiocchi culturali, di letture filosofiche che pirono l’atto gentile in piena tranquillità. Fu il giorno successivo, lo orientarono verso una ancor vaga politica rivoluzionaria. sfogliando un giornale romagnolo intitolato La lotta di classe, che Fanatico della Rivoluzione francese, dall’ultimo banco dov’era, seppero come il gesto era stato tanto poco apprezzato dall’ala rivospediva proclami rivoluzionari ai compagni chiamandoli «cittaluzionaria del Partito da minacciare la loro espulsione. «Una solledini». Scherzava, ma quando si accorse che il fornaio del collegio cita espulsione!» -così scriveva il direttore de La lotta di classe- e metteva crusca nel pane combinò sul serio una mezza rivoluzione proseguiva tempestando i tre onorevoli di autentiche insolenze. collegiale. Leonida Bissolati, tre mesi più tardi, al Congresso del Partito soFinché una mattina, quando aveva diciassette anni, se ne arrivò a cialista tenuto a Reggio Emilia poté finalmente vedere in faccia scuola sfoderando di sotto il cappotto una grande cravatta nera e a l’audace giornalista. chi gliene chiese il motivo rispose: « Io? io Era un giovanotto di non ancora trent’anni, dagli occhi rotondi sono anarchico individualista ». e strabuzzati, la barba indecoCosì i suoi professori cominrosamente lunga e una giacca ciarono a capire perché nei nera stretta fino all’inverosuoi temi erano citati con tanta simile: «alla tribuna Benito passione Roberto Ardigò e Max Mussolini» disse l’annunciaStirner, filosofi fra i prediletti tore. dagli anarchici. Un quarto d’ora più tardi La smania di apparire, di rifiuLeonida Bissolati si vide puntare ogni imposizione, tutti eletare contro il dito e ripensò a menti che facevano di Mussolini malincuore il disgraziato giorun anarchico per natura, lo porno in cui aveva visitato il re tavano a deformare le proprie scampato all’attentato. vicende. « Voi, Bissolati » lo assaliva Gli anarchici di un tempo erano Mussolini «avete tentato di sicuri che per trascinare i popoli giustificare il vostro gesto di bisognasse farsi conoscere renomaggio al re per l’attentato dersi sempre presenti, menare dell’anarchico d’Alba. La scandalo nella morta gora del vostra andata al Quirinale vi regime borghese. ha posto sotto l’accusa del Mussolini raccolse d’istinto Partito... Ditemi, Bissolati, questa loro eredità. Dal moquante volte siete stato a renmento in cui uscì dal collegio di dere omaggio a un muratore Forlimpopoli fece tesoro di ogni caduto da un’impalcatura? vicenda privata o addirittura Quante volte ad un birrocciaio intima, e molte ne inventò, pur travolto dal proprio carro? di lasciare una scia dovunque Quante volte ad un minatore passava, una scia che facesse colpito da un sasso? Ebbene? rabbrividire i buoni borghesi. Che cosa è un attentato al re, se Cominciò assai presto, quando non un infortunio sul lavoro? » ancora faceva la comunione a Bissolati non era preparato Pasqua: entrò nel confessionale ad un attacco così logico. Si con l’anima quasi candida e lì aspettava che Mussolini, come per li inventò una serie di pecal solito, si compromettesse cati abominevoli da spifferare al con un elogio degli anarchici confessore. attentatori, ma Mussolini queIl gioco di apparir cattivo e sta volta fu più prudente. Ai ribelle ad ogni consuetudine vertici del Partito socialista, Ritratto di Benito Mussolini al tempo della sua permanenza in Svizzera gli riusciva ancor meglio con quel giorno del luglio 1912 ci le sue innamorate: queste anzi fu così un cambio della guardia assai significativo: si ritraevano i furono le prime persone sulle quali saggiò anche la sua smania socialisti accorsi a stringer la mano al re il giorno dell’attentato e autoritaria. saliva alla ribalta quel Mussolini che due anni prima aveva scritto Avvenne che partisse per la Svizzera in cerca di fortuna. degli attentatori anarchici: « Pazzo un Angiolillo? (uccisore del Fortuna non ne ebbe molta, in Svizzera, ma in compenso poté inministro spagnuolo Canovas del Castilo). Pazzo un Bresci? (ucserire per la prima volta questi suoi furori nella vita politica. cisore di Umberto I). Pazza una Sofia Perovskaja? Ah, no. Eroi, Era l’autunno del 1902: Mussolini diciannovenne, senza una lira, quasi sempre eroi, ma pazzi quasi mai. » partì per Chiasso, passò il confine, si diresse a Losanna e cominciò Mussolini fu anarchico assai prima di sentire questa parola. ad arrangiarsi con lezioni e traduzioni; ma in questo periodo il suo Da ragazzetto detestava la obbedienza e i compagni obbedienti antico odio generico per i compagni ossequienti e bravi a scuola, e devoti. Non tollerava di inginocchiarsi in chiesa e scappava di la sua antica smania di prevalere si tradussero in odio feroce conmano alla madre quando lei andava a messa. Poi si arrampicava su tro i ricchi. di un albero traboccante il muricciolo dell’oratorio e bersagliava a Fu questo odio inconsulto verso i benestanti a dischiudergli sufiondate i vetri della chiesa, il prete e i ragazzi che giocavano. bito la simpatia dei gruppi rivoluzionari svizzeri: tre settimane Iscritto quasi di forza al collegio dei salesiani di Faenza accumulò non erano trascorse dal suo arrivo, che suoi articoli apparvero sui tanto precoce odio contro maestri e compagni diligenti che alla giornaletti rivoluzionari delle più estreme tendenze. Prima che prima occasione spaccò un calamaio sulla testa dell’insegnante e finisse il 1902 Mussolini ottenne il segretariato dell’Associazione piantò un temperino nella pancia di un compagno. Espulso riuscì fra muratori e manovali di Losanna, col beneficio di far colazione Mussolini alla sua seconda espulsione dalla Svizzera gratis al caffè Boch, privilegio non indifferente in quegli ambienti di scarso credito. A metà del 1903 i carpentieri del cantone di Berna, un settore sindacale che non lo riguardava, entrarono in agitazione. Mussolini fece un discorso ai muratori: egli propose uno sciopero generale di solidarietà, e predicò l’uso immediato dei mezzi violenti. La polizia svizzera, nonostante la lunga abitudine con i rivoluzionari, tese le orecchie, acchiappò Benito e lo rispedì in Italia dopo averlo tenuto in prigione per dodici giorni. Ma da Chiasso Mussolini passò a Como e di lì di nuovo in Svizzera. In quel tempo si era dato alle letture politiche, o meglio a certe letture politiche che erano gli stessi testi sui quali si fondavano gli anarchici e i sindacalisti rivoluzionari: fra questi testi c’era qualcosa del Sorel e l’idea dello sciopero generale e della violenza intesa come morale era proprio sua. Da questo momento Mussolini non abbandonò più il Sorel e qualche anno più tardi, nel 1908, fu tra gli entusiasti estimatori e divulgatori del libro di Sorel: Considerazioni sulla violenza nel quale si leggeva: «Alla violenza il socialismo deve gli alti valori morali, coi quali porge la salvezza al mondo moderno». Gli anarchici si erano staccati dai socialisti, ed erano arretrati sulla scena politica proprio perché i socialisti avevano mostrato di preferire la tribuna parlamentare alla rivoluzione violenta: ma ora che certi iscritti al Partito socialista come questo giovane Mussolini volevano la violenza, non era il caso di tender dì nuovo loro la mano? In effetti il gruppo anarchico Réveil, che operava a Ginevra, entrò subito in contatto con Mussolini e gli affidò la traduzione e la presentazione ai lettori di uno dei testi più dinamitardi dell’anarchismo: le Paroles d’un revolté di Kropotkin. Mussolini lesse, tradusse e si entusiasmò a quella prosa letteraria. Ritenne molte di quelle idee e le espose in cento articoli. Inoltre divenne amico di un grosso esponente dell’anarchia locale, certo Bertoni e in breve si diffuse la voce che Mussolini era anarchico. Anarchico nei pensieri, negli atteggiamenti, nei fatti: questo fu anche il giudizio di una donna ch’egli incontrò a Ginevra nel marzo del 1904, donna che ebbe molta importanza nella sua vita, la profuga russa Angelica Balabanoff. Questa Balabanoff in un suo libro su Mussolini si affannò anzi a precisare che di socialista Mussolini non aveva proprio niente, attratto com’era verso l’anarchia, l’anticlericalismo e l’antimilitarismo sfegatati: comunque seguì l’amante per molti anni, partecipò al suo trionfo su Leonida Bissolati, fu con lui alla direzione dell’Avanti!, lo abbandonò quando Mussolini volse al fascismo ed alla fine intitolò un libro di memorie Il traditore Mussolini. La Balabanoff fu testimone del modo con il quale Mussolini cercò di «liberare» sé e i suoi seguaci dalla «superstizione» di Dio e della religione. Accadde a Losanna, nel 1904, alla casa del popolo dove il pastore evangelico Tagliatela teneva una conferenza. Mussolini si alzò in piedi e chiese la parola. Domandò intorno se qualcuno gli prestava un cronometro, quando ne trovò uno fece scattare la lancetta dei secondi e lo sospese per la catenella bene in vista davanti a sé. Poi disse ai presenti: «Signori, dò cinque minuti di tempo a Dio per fulminarmi; se non mi punisce in questo tempo vuol dire che non esiste». E rimase così ad aspettare il fulmine, mentre all’interno perfino i compagni più ardenti mormoravano imbarazzati. Il medesimo episodio di Losanna si ripeté poi, nel 1907, nell’Alta Carnia. Ancora a Losanna, durante una conferenza nella quale Emilio Vandervelde sosteneva la libertà di religione anche per i socialisti, Benito Mussolini si alzò in piedi per sostenere l’assurdità di un socialismo religioso. Ormai egli era noto per colui che aveva concluso la prefazione del suo libretto Dio non esiste con le parole: «Fedeli, l’Anticristo è nato». A dare maggior credito alla nomea di anarchico di Mussolini venne dall’Italia nel 1903 una condanna, contro di lui, per diserzione dal servizio militare. Come al solito ansioso di estendere a dottrina politica i propri casi particolari Mussolini reagì alla condanna inserendo nei propri articoli una violentissima vena antimilitarista. Scrisse parole di fuoco contro «le divise dai colori chiassosi, i petti irti di croci, di medaglie, di decorazioni e simili chincaglierie», si accanì contro le parate reali scalpitanti di cavalli addobbati e contro i codazzi di ministri «che passano accecando il pubblico». Ed è curioso ricordare che Benito Mussolini, in questi primi scritti antimilitaristi, si esprimeva quasi con le stesse parole a suo tempo usate dall’anarchico Passanante, infelice attentatore alla vita di Umberto I. In Svizzera insomma la fama di un Mussolini anarchico si allargò al punto, che lo stesso Mussolini, per tema di guai maggiori, si decise a sconfessarla. Questo avvenne nell’aprile del 1904 quando la polizia svizzera lo arrestò per la seconda volta e minacciò di rispedirlo in Italia dove lo attendeva la condanna per diserzione. Mussolini non poteva certo chiedere aiuto ai compagni anarchici, 15 16 in questo caso, così si volse ad un socialista, il consigliere Wyss, e gli scrisse: «Tutti vi diranno che io sono anarchico. Nulla di più falso, compagno... Sono stato quaranta giorni a Ginevra ed ho partecipato pochissimo alla vita politica. Quasi tutto il tempo ho frequentato la biblioteca. Adesso me ne vado a Losanna, all’Università, e spero di restarvi tranquillo...». Ma tant’è, anche se frequentava la biblioteca, le sue letture ed i suoi lavori lo spingevano sempre più verso l’anarchia. Con l’aiuto della Balabanoff tradusse un opuscolo del Kautsky; poi intervenne nel problema morale traducendo e diffondendo un libretto di Malthus sulla regolamentazione delle nascite, e intitolò la traduzione Meno figli, meno schiavi. Ma soprattutto, con il Sorel, con Nietzsche, con Stirner, con Kropoktin, ebbe importanza nella sua preparazione culturale-politica il Blanqui. Blanqui aveva gettato il seme del socialismo rivoluzionario sostenendo che la rivoluzione doveva essere preparata e condotta da pochi iniziati ed anche Michele Bakunin si era richiamato a questa teoria. Mussolini la raccolse, se ne entusiasmò e non la lasciò più. Così, quando in seguito ad amnistia Mussolini poté tornare in Italia, sia pur pagando lo scotto di una lunga ferma militare, portò con sé non solo un’affermata nomea di anarchico. ma un bagaglio di idee e di nozioni che aspettavano solo di potersi tramutare in azione. Tornò dunque in Italia e compì il servizio militare, poi insegnò qua e là, ma il tempo non relegò nel dimenticatoio la sua attività svizzera. Così quando fu di nuovo a Forlì e fondò il settimanale La lotta di classe gli anarchici capirono che Mussolini era pur sempre un prezioso alleato. Gli perdonarono di aver compiuto il servizio militare. Trascorsa la «ferma» militare Mussolini aveva ancora accentuato il tono antimilitarista dei propri scritti, sconfinando nell’antipatriottismo. Qualche anno più tardi, nel 1913, fece un discorso che avrebbe allargato il cuore a Bakunin e ai vecchi anarchici che erano sempre stati insidiati nella loro lotta libertaria dal fascino sulle folle di Garibaldi e Mazzini. Si trattava di commemorare la Comune di Parigi, la famosa rivoluzione anarchico-comunista che nel 1871 aveva acceso tante speranze nel cuore di Bakunin: Mussolini dopo un attacco contro ogni forma sorpassata di patriottismo borghese rammentò in che modo Giuseppe Mazzini aveva combattuto la Comune e concluse dicendo che « anche Garibaldi e Mazzini vanno relegati in soffitta tra il vecchio ciarpame del Risorgimento». Per gli anarchici, comunque, Benito Mussolini era già l’uomo del domani o, come lo chiamavano, il loro «pensoso apostolo». Forse furono proprio gli anarchici i primi a parlare di uno «stile mussoliniano», lo fecero riferendosi ad uno dei loro grandi, lo spagnolo Ferrer. Benito Mussolini non entrò in contatto diretto con l’anarchico spagnolo, ma quando questi fu preso e fucilato, Mussolini, che si trovava a Forlì, sentì il dovere di intervenire. Fece un comizio di protesta ed aizzò la folla al punto che una masnada corse al palazzo vescovile armata di bastoni e di pietre, e poiché non riuscì a linciare il Vescovo se la prese con una colonna votiva della Madonna. Effettivamente in quegli anni intorno al 1910 il popolo era molto facile al subbuglio. E di lì a poco, certo pensando a Mussolini, un vecchio anarchico dal cuore giovanile, scriveva quasi rispondendogli: « Ora, finalmente pare che i rivoluzionari trovino che sia tempo di parlare chiaramente di rivoluzione e di insurrezione e di presentare lo sciopero generale definitivo non più come un sostituto dell’ insurrezione, ma come un mezzo per tirare in piazza le masse, per provocare l’insurrezione e facilitarne il successo» Scriveva così un anarchico poco meno che redivivo, un uomo la cui mitica vecchiezza fa impressione confrontata alla cruenta gioventù di Mussolini: era Errico Malatesta, il fedelissimo di Bakunin, il compagno di Carlo Cafiero, il venerando capo della Banda del Matese. Benito Mussolini consentiva in pieno con le sue parole, fin dal tempo della Svizzera, allora, quando propose uno « sciopero generale » con l’impiego dei « mezzi violenti ». Nel settembre del 1911 Mussolini si comportò in modo tale da far battere davvero con speranza il cuore del vecchio Malatesta che dall’esilio di Londra lo spiava. Si profilava la guerra italo-turca e Mussolini non si appagò di dare sfogo al proprio furente antimilitarismo con articoli di giornale. Ne scrisse naturalmente, e di terribili, nei quali dichiarò che la propria lotta era «intesa a demolire l’esercito» e che la bandiera nazionale, italiana «è uno straccio da piantare sul letame»; ma volle anche agire. Fece un discorso memorabile al popolo di Forlì: se la prese con tutti coloro che erano venuti al comizio con le mani penzoloni anziché bene armati, e nel pandemonio che nacque Benito Mussolini esortò a tagliare il telegrafo, a metter pali di traverso sulle rotaie perché i soldati non potessero partire. Prese un gruppo di fedelissime andò a svellere le rotaie della tramvia Forli-Meldola. Mussolini conosceva il proprio fascino e quando fu arrestato pronunciò frasi memorabili come « Se mi assolvete mi fate piacere, se mi condannate mi fate onore ». Fu condannato e uscì di prigione all’inizio di quel 1912 nel quale, come abbiamo visto, avrebbe attaccato a fondo i socialisti legalitari che si erano felicitati con il re per essere scampato all’attentato d’Alba. E nel 1912 Mussolini diede un’altra stretta di mano all’anarchia. Un anarchico molto noto, Paolo Valera, aveva fondato a Milano un giornale intitolato La folla: Mussolini volle subito collaborare al giornale anarchico. Intanto, da Londra, Malatesta spiava gli avvenimenti. Di giorno in giorno nuove speranze lo nutrivano: questo Mussolini che se ne infischiava di ogni patteggiamento, che voleva la rivoluzione, che sullo sciopero generale la pensava come lui, questo Mussolini che aveva gli anarchici tra gli amici prediletti, era una bella soddisfazione per colui che aveva sempre lasciato l’Italia con una sconfitta alle spalle e tanta amarezza nel cuore. Alla fine del 1912 Mussolini prese la direzione dell’Avanti! e l’Avanti!, vale a dire il più letto quotidiano popolare, lasciò cadere ogni atteggiamento legalitario: tutti i giorni dalla prima pagina Mussolini ribadiva l’idea dello sciopero generale e della rivoluzione e di giorno in giorno la folla si muoveva di più. Con la settimana rossa, che fu 1’ultima esplosione di anarchia in Italia, anche i rapporti stretti fra Benito Mussolini e l’anarchia cessarono. La guerra mondiale urgeva, ormai. Eppure, per lo meno, una simpatia anarchica da parte di Mussolini si protrasse nel tempo. Nel 1919, già alle soglie del fascismo, dopo il «tradimento» mussoliniano a favore del nazionalismo, Benito Mussolini salutò con un articolo plaudente l’ultimo ritorno di Errico Malatesta in Italia, e parlando di Max Stirner, il filosofo dell’anarchia, il suo primo amore intellettuale, disse: « Perché Stirner non sarebbe più di moda? ». Una domanda timida, dubbiosa, quasi nostalgica. Ma l’esperienza anarchica di Mussolini giovò anche agli anarchici: Malatesta, che per Benito Mussolini aveva avuto quasi un amore senile, chiese soltanto di poter vivere tanto da veder cadere il fascismo. Gian Franco Vené E’ zoch-periodico di attività culturali fondato nel 2002 da D. Franchini e G.F. Fontana Giugno 2006, numero 21 Autorizzazione del Tribunale di Bologna n.° 6718 Direttore : Daniele Franchini Direttore responsabile : Gian Franco Fontana Redazione: Santerno Edizioni sas di Gian Franco Fontana e C. Via IV novembre, 7 40026 Imola BO E mail : [email protected] Fax 0542.35629 Stampa: Offset Ragazzini & C. - Faenza - 0546 28230 Questa pubblicazione è edita con i contributi dei soci del Tribunato e della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. In questo numero scritti di: Giuseppe Carrello, Pier Giorgio Casadio Prati, Franco Dell’Amore, Francesco Donati, Gian Franco Fontana, Odette Gelosi, Aurora Romanini Ferraresi, Gian Franco Vené Le fotografie sono dell’archivio Gian Franco Fontana ©2006 Spedizione in Abbonamento Postale D. L.353/2003 conv. L.27-02-2004 n°46 art. 1 comma 1 DCB Bologna
Scaricare