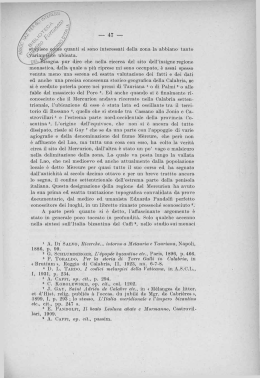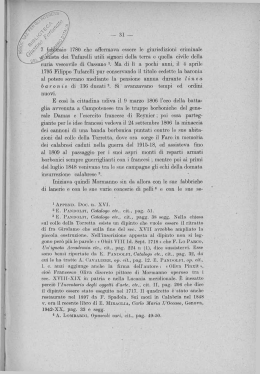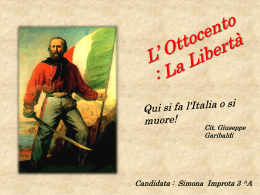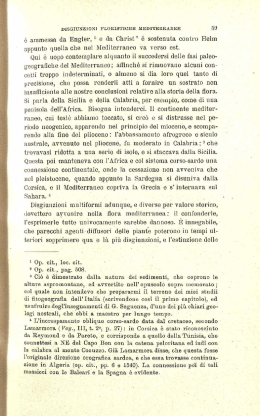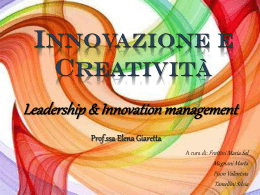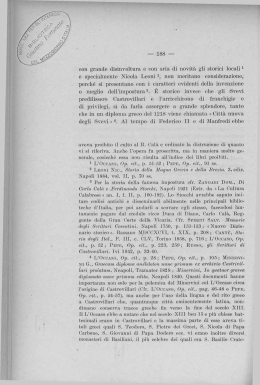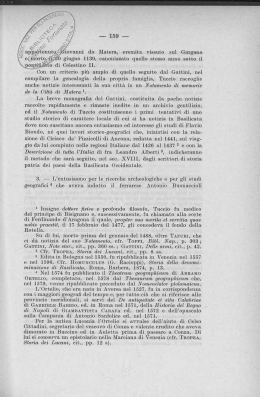XXXVI. I DIRITTI DELLE PERSONE DEBOLI di Paolo Cendon SOMMARIO: 36.1. Contrasti e interrogativi. — 36.2. Pregiudizi, linguaggio, terminologia legislativa. — 36.3. Mistero. — 36.4. Categorie. — 36.5. Essere, fare. — 36.6. Beni e diritti nella Costituzione italiana. — 36.7. Combinazioni individuali. — 36.8. Nozione di soggetto debole. — 36.9. Singolare e plurale. — 36.10. Contagiosità, nuovo diritto, progetto continuo. — 36.11. Quotidianità. — 36.12. Prerogative dei soggetti deboli. — 36.13. Abbandono, responsabilità. — 36.14. Debolologia. — 36.15. Oltre il diritto. — 36.16. Strumenti di protezione. — 36.17. Pubblico e privato. — 36.18. Razionalizzazione. 36.1. Contrasti e interrogativi. Poche materie come quella dei soggetti deboli si presentano ai nostri occhi così ricche di segni incerti, contraddittori. Basta confrontare in un qualsiasi quotidiano i titoli delle pagine iniziali (o di quelle culturali, economiche, scientifiche, ecc.) con gli articoli di cronaca nera o cittadina. Di là richiami alla morale, dichiarazioni internazionali, leggi quadro, moniti del papa; di qua notizie circa neonati abbandonati nei cassonetti, famiglie alluvionate senza indennizzo, incesti, sequestri. Da un lato carte, difensori civici, piani di recupero, convegni, annunci di interventi regionali (1); dall’altro cronache di esuli annegati, maltrattamenti, momenti di razzismo, suicidi di adolescenti, miserie nascoste (2). Due livelli di materiali che, apparentemente, non comunicano affatto tra di loro. E più gli anni passano (giornali come Il Piccolo, a Trieste, ripubblicano ogni tanto copie fotostatiche di proprie pagine di mezzo secolo fa) più si ha l’impressione che le distanze — fra teoria e prassi, fra realtà giornaliera e sogni — vengano moltiplicandosi. Di chi la colpa se tanti auspici e inviti beneaugurali rimangono, in concreto, lettera morta? Vari — sulla carta — i motivi da considerare. Fattori di ordine economico, medico, tecnologico; ragioni scolastiche, religiose, farmacologiche, urbanistiche. Si potrebbe continuare a lungo. Un punto risulta subito chiaro però, e attiene alle responsabilità di natura culturale, metodologica (3). Per gli addetti (o non addetti) ai lavori c’è soltanto l’imbarazzo della scelta. Vizi propri di ciascuna disciplina, e difetti di impostazione più generali. Provincialismi, fughe in avanti, astruserie. Eccessi di separatezza tra le varie branche, esibizioni anticonformistiche, gusto smodato per le ideologie. Disinformazioni, parole d’ordine massimalistiche, manie di complotti, estremismi ricostruttivi. Scarsezza di comunicazione fra 2110 PAOLO CENDON XXXVI, 36.2. psicologhese, medical-legalese, economichese, bioetichese, antipsichiatrese. Difficile non chiedersi se ombre del genere potranno mai venir fugate, in che modo occorra operare a tal fine. Ma più ampiamente: un linguaggio comune fra i vari approcci è mai pensabile, sarebbe opportuno tecnicamente? Quanto vasta e ramificata si presenta la galassia antropologica in esame, chi effettivamente deve considerarsi « debole » chi sempre, chi mai, chi ogni tanto? 36.2. Pregiudizi, linguaggio, terminologia legislativa. Una spia importante è costituita dall’atteggiamento che sogliono assumere, parlando della propria condizione, tanti fra gli appartenenti alle fasce in oggetto. Soprattutto donne, epilettici, omosessuali, anziani (4), ma anche alcolisti, vittime di calamità naturali, ipovedenti, handicappati fisici in genere (5). Non è raro che alla domanda « Debole o non debole? » — riferita a un individuo singolo o una certa nicchia di persone — venga offerta dall’interpellato una risposta radicalmente negativa (« Non debole »). Espressa alle volte con toni di sdegno o di risentimento. Orgoglio di minoranze incomprese, complessi di inferiorità/ superiorità? Riserve quanto al valore di un’« ammucchiata » in cui le peculiarità dei singoli gruppi correrebbero il rischio di sbiadire? Fastidio per quel tanto di compassione, o di irrisione, che sarebbe implicito nel ricorso stesso a locuzioni come « debole », « debilitato », « debolezza »? Rispondere non è facile, dipende anche dalle categorie e dai soggetti. Si tratta comunque di reazioni abbastanza sintomatiche perché ci si debba, in via preliminare, porre il problema della convenienza o meno dell’utilizzo di espressioni simili — nonché del modo più indolore per sostituirle. Particolarmente indicativi — sottolineiamo — gli spunti che può fornire, sotto il profilo terminologico, uno spoglio della legislazione italiana. Nelle scelte lessicali che i nostri parlamenti sono venuti compiendo, durante l’ultimo periodo, non è difficile cogliere riflessi più o meno vivi di decenni di labelism. Da un XXXVI, 36.3. I DIRITTI DELLE PERSONE DEBOLI 2111 testo normativo all’altro (sul piano nazionale, ma anche regionale) si assiste in effetti a continue variazioni linguistiche; rincorse dei vocaboli meno stigmatizzanti, ricerche affannose della locuzione politicamente più corretta. Facile constatare, ad esempio, un crescente declino delle espressioni con carichi semantico-letterari negativi, di quelle più manichee o perentorie (« pazzi », « cretini », « minorati », « ciechi », « sordi », « handicappati »). Facile accorgersi del ricorso sempre più frequente — via via che il tempo passa — ai motti anglicizzanti (6), alle litoti, alle endiadi tratte dal lessico tecnico, alle costruzioni più anodine ed eufemistiche (« portatori di handicap », « svantaggiati », « cittadini con epilessia », « audiolesi », « disabili », « non normodotati », « utenti »). Resistono le espressioni più neutre, chiuse in qualche contesto tecnico, le parole meno facilmente sostituibili: « Infermi di mente » (7), « Invalidi », « Malati », « Incapaci »... e così via. 36.3. Mistero. La realtà dei deboli — quella di tanti barboni, dei drogati, dei bambini di nessuno, degli anziani della quarta età, dei fuggitivi del terzo mondo (8)? Qualcosa di sostanzialmente ignoto all’esterno. I comparti disciplinari deputati ad occuparsene — pedagogia, economia, sociologia, urbanistica, diritto, pediatria? Universi spesso all’oscuro delle faglie del loro oggetto (a parte le notizie più sensazionali, quelle assurte all’onore della cronaca). Le disavventure affidate a questa provincia del sapere? Storie quasi sempre incolori, fenomeni con scarse capacità di audience, sparpagliati in mille segmenti di degrado e sfortuna (9). Coltri di silenzio, porte chiuse: buio sulle minitransazioni spontanee degli operatori, sulle modalità spesso bizzarre di sopravvivenza. Indifferenza ufficiale per gli scippi senza nome, per le vite solitarie, per gli sperperi clandestini, per i figli o i congiunti menomati o difficili. Irrilevanza burocratica dei cani senza collare, dei fanciulli astigmatici o un po’ sordi, degli ospiti di tante corsie, dei nuovi baraccati. Ogni tanto la complicità degli stessi protagonisti a non far 2112 PAOLO CENDON XXXVI, 36.4. trapelare nulla. La vergogna per la propria impotenza o eccezionalità, rigurgiti di fierezza; insondabilità delle sfumature, sequestri casalinghi, panni sporchi lavati il più possibile in famiglia (10) — cose di cui si saprà poco, che esisteranno esclusivamente per chi le ha vissute. 36.4. Categorie. Alla domanda « Quali categorie possono considerarsi deboli? », la risposta — per lo studioso di scienze sociali — non è sempre facile. Della correttezza di tale qualifica non si dubita quasi mai per i bambini (11): soprattutto per i neonati prematuri, per gli orfani ancora in istituto, per i concepiti (12), per i minori maltrattati. Oppure con riferimento ai portatori di handicap, ai malati gravi (13), agli infermi psichici, agli epilettici. Nei confronti di altri gruppi la conclusione appare meno sicura. Ad esempio, rispetto ai tossicodipendenti o agli alcolisti (14): che valore attribuire alla circostanza che sono gli stessi « molestanti », qui, la causa immediata del loro disagio? Oppure i detenuti nelle carceri: un riferimento al corpo o alla mente (quale origine o terminale dell’imbarazzo esistenziale) non avrebbe per essi significato apprezzabile: vorrà dire che fra le chiavi del discorso occorre assumere anche quelle di natura muraria, segregativa? E gli extracomunitari, i rifugiati politici, i rom (15)? Non si tratta in effetti di malati, né di esseri rinchiusi in una struttura segregativa, né di incapaci legali o naturali. E gli appartenenti ai culti acattolici? Oppure le minoranze in quanto tali — linguistiche, religiose (16), etniche, razziali (17)? Gli adolescenti: creature inquiete, né grandi né piccole, che non sanno né di carne né di pesce (18); non si tratta però del simbolo stesso della gaiezza, della fioritura? Le donne: anche quelle che hanno più di sei mesi e meno di novant’anni? o soltanto quelle che aspettano un bambino (19)? o quelle esposte a violenze (20)? o invece le donne che lavorano (madri con turni eccessivi, in ambienti insalubri, a contatto di materie pericolose) (21)? o quelle che non lavorano affatto — perché licenziate, XXXVI, 36.5. I DIRITTI DELLE PERSONE DEBOLI 2113 analfabete, cassintegrate (22)? I disoccupati in generale; ma allora anche gli homeless — o forse soprattutto loro (23)? Gli ex detenuti, i meridionali, i poveri nel loro insieme, i consumatori (24), i pedoni, i risparmiatori. E i ciclisti? Forse no. I lavoratori subordinati in quanto tali? Neanche, probabilmente (25). Gli animali magari (quelli selvatici, quelli più rari, quelli commestibili) (26), i conviventi more uxorio (27), le piante in via di estinzione. I transessuali (28). Gli italiani all’estero, gli emigranti che tornano in paria. I frati, le suore? No, verosimilmente. I nani, i giganti? Nemmeno. Gli spettatori televisivi (29), le prostitute (30), i cittadini oggetto di informazioni computerizzate (31), gli studenti, le vittime di « Internet », i soldati di leva (32), i fumatori? 36.5. Essere, fare. È plausibile che una fra le vie maestre per rinnovare la « cultura debolologica » — come battaglia contro i pregiudizi correnti, ma anche per un’attenuazione degli steccati fra i vari gruppi — sia rappresentata dalla progressiva rinuncia a impostazioni o fantasmi di tipo ontologico-lombrosiano (33). Un traguardo tanto più raggiungibile, va sottolineato, quanto più venga accrescendosi nell’interprete di oggi l’impegno a fondare la nozione di debolezza sul terreno prettamente esistenzial-relazionale. Il che in concreto significa: a) sempre meno una fotografia delle varie « menomazioni » — di tipo anatomico, genetico, sensoriale, estetico, neurologico, sessuale, anagrafico, ecc. — che valgono a costituire qualcuno come intimamente sottodotato, mostruoso, anormale, deviante, ecc.; b) sempre più — guardando al reticolato amministrativo del territorio — uno spoglio dei « luoghi » esteriori di inserimento o di inveramento il cui accesso risulti ostacolato (per coloro che vorrebbero o potrebbero fruirne) da ritardi statutari, da barriere, da insufficienze applicative, vuoti nel distretto socialsanitario, cattivo uso delle leggi (34). Non tanto insomma un’attenzione all’essere (i deboli) mor- 2114 PAOLO CENDON XXXVI, 36.6. fologicamente diversi dagli altri. Piuttosto, la consapevolezza del (dover certi individui) fare giorno per giorno cose diverse dai loro simili: un inventario, cioè, dei tramiti mondano-territoriali la cui attivazione o il cui miglior funzionamento varrebbero a ridurre — di fatto — le distanze fra la « secolarità » dei cosiddetti soggetti forti e quella, rispettivamente, dei soggetti deboli. 36.6. Beni e diritti nella Costituzione italiana. Da questo punto di vista, utili indicazioni possono trarsi dall’elenco che i primi 45 articoli dalla Costituzione italiana effettuano di una serie di diritti-doveri dei cittadini (35). Particolare attenzione meritano i riferimenti a: — diritti inviolabili della persona, globalmente considerati (artt. 2, 3); — lavoro (artt. 1, 4, 35, 36); — libertà personale (art. 13); — domicilio, privacy, segretezza (artt. 14, 15); — libera circolazione (art. 16); — riunione, associazione (artt. 17, 18), sindacato (art. 39); — minoranze linguistiche (art. 6); — religione (artt. 8, 19, 20); — libertà di espressione (art. 21); — diritti civili (art. 22); — difesa nel processo (artt. 24, 25); — famiglia (artt. 29, 30); — maternità, infanzia (artt. 31, 37); — salute (art. 32); — arte, scienza (art. 33), scuola (art. 34); — assistenza per inabilità, per infortunio, per malattia, per vecchiaia, per disoccupazione (art. 38); — iniziativa economica (art. 41); — proprietà, risparmio (artt. 42-47). È palese attraverso quante chiavi differenti la sintesi (del pieno godimento) di queste varie libertà e posizioni potrebbe compiersi: lungo filoni riconducibili, via via, alla nozione di « forza », di « salute », di « normalità », di « soddisfazione », di XXXVI, 36.7. I DIRITTI DELLE PERSONE DEBOLI 2115 « efficienza », ecc. Quale che sia l’angolatura preferibile, due essenzialmente — per la ricomposizione dei momenti indicati — appaiono i fili da evidenziare: a) l’idea di relazionalità/fecondità; le indicazioni, cioè, circa la centralità della persona umana rispetto all’ambiente circostante; la prospettazione dell’« avere » individuale come un « tendere verso », come investimento spontaneo di energie, come un « operare per »; la « felicità » (lemma pur estraneo, formalmente, alla nostra Carta fondamentale) quale tramite rapportabile — non solo dal punto di vista etimologico — ai motivi della fecondità, della fertilità, del venir oltre la linea di galleggiamento, della florealità, del rigoglio partecipativo; l’esistenza umana presentata quale pienezza di contatti, come ricerca di agganci, di occasioni di dialogo; b) il tratto della visione policentrica: ossia il riferimento alla vita dell’uomo come a una trama destinata a svolgersi non già nel chiuso di un’unica stanza, bensì lungo più versanti distinti: ciascuno — via via — improntato a registri di carattere personale o familiare, oneroso o gratuito, religioso o laico, pubblico o privato, egoistico o altruistico, patrimoniale o spirituale, debitorio o creditorio, serio o faceto, individuale o associativo, ecc. 36.7. Combinazioni individuali. Dal piano normativo-generale (elenco dei beni e dei diritti, così come elencati sulla carta, in maniera uguale per tutti) si tratta di passare, allora, al vissuto storico e geografico dei singoli individui: chiarendo quando e in che misura occorra parlare effettivamente di debolezza. Una volta accertati, in effetti, i termini della specifica « combinazione esistenziale » di ciascun essere, non resterà che misurare poi la distanza fra ciò che fa (può fare): a) una persona in difficoltà la quale risulti, in tutto o in parte, abbandonata a se stessa; b) un soggetto — toccato da identiche occasioni di disagio e portatore di analoghe ragioni interattive — che si veda invece adeguatamente sostenuto nei suoi progetti. 2116 PAOLO CENDON XXXVI, 36.8. Insomma, non tanto il raffronto, condotto in astratto, tra la squadra dei « forti » da un lato e quella dei « deboli » dall’altro — tra ciò che una persona svantaggiata o in crisi fa attualmente, e ciò che essa faceva prima che nella sua casella biografica irrompessero i fattori che l’hanno funestata, sconvolta; quanto, piuttosto, una messa a paragone fra ciò che un individuo fragile si vede costretto contingentemente a fare (o a non fare), e ciò che avverrebbe invece nell’organizzazione delle sue giornate qualora fossero vivi intorno a lui i supporti — assistenziali, civilistici, comunitari, ospedalieri, scolastici, ecc. — capaci di neutralizzare, in tutto o in parte, i risvolti preclusivi di quelle manchevolezze. 36.8. Nozione di soggetto debole. Si può concludere allora che esistono non tanto soggetti deboli (dal di dentro), ma sempre e solamente soggetti « indeboliti » (dal di fuori) (36). Non sarà debole ad esempio — non necessariamente — il bambino orfano, esposto a insidie, extraeuropeo, albino, con ritardi di apprendimento. Piuttosto il minore privo di una figura adulta di riferimento, istituzionalizzato sconsideratamente, ignorato dalle strutture educative (37); quello in credito di affetto, senza dentista, privo di telefoni a portata di mano, dimenticato dai presidi sanitari (38), mancante di qualcuno in grado di registrarne i sogni, le domande (39). Malattie di mente? Di nuovo a contare — più che « l’interno » — sarà « l’esterno » delle cose. Indebolito potrà dirsi l’oligofrenico che i familiari sequestrino in casa, quello obeso per pigrizia, improduttivo suo malgrado, con gli occhiali da miope mentre gli servirebbero da presbite. Cesserà di esserlo (sarà meno debole) il giorno in cui gli assistenti sociali, scopertane l’esistenza fisica, avranno provveduto a rivedere il suo dosaggio di psicofarmaci, a ritoccare certi appuntamenti, inserendolo in una comunità di lavoro, facendogli nominare un curatore premuroso, procurandogli una pensioncina di invalidità (40). Ricomparirebbe (la debolezza) il giorno in cui egli si trovasse — per ipotesi — interdetto senza necessità, dismesso dalla cooperativa sociale, sottratto ai luoghi del tempo libero, boicot- XXXVI, 36.9. I DIRITTI DELLE PERSONE DEBOLI 2117 tato nei legami sentimentali; minacciato qua e là nella sua riservatezza, ostacolato nelle possibilità di igiene, scoraggiato nella coltivazione di qualche hobby, affidato a un tutore (magari onesto ma troppo) austero e spilorcio. E così di seguito. Non sarà fragile lo spastico, il sordomuto, il paraplegico che si veda accudito da una rete di terminali capaci di valorizzare, al meglio, ciò che il soggetto è in grado di affermare e di compiere (41). Non lo sarà la donna incinta, toccata magari da piccoli o grandi disagi psicosomatici che il consultorio di quartiere sappia però tamponare (sino al momento del parto, o anche nei mesi successivi) con scrupolo e competenza. Non sarà debole l’eroinomane accolto entro un centro di recupero deciso a prendersi, continuativamente, cura di lui (42). Né l’omosessuale che venga messo dal sistema in condizione di « sposarsi », di optare per un regime di comunione dei beni, di non dover testimoniare in un processo penale contro il suo compagno (43). Né il detenuto ospite di una prigione con celle adeguate, servizi di biblioteca, bagni puliti, contatti periodici (possibilità di tenerezze incluse) col mondo esterno; quello incoraggiato a organizzare concerti rock nel carcere, a laurearsi, ad allevare uccellini (44). 36.9. Singolare e plurale. Con l’enfatizzazione del momento amministrativo-esistenziale, anche la risposta al quesito « singolare/plurale » diventa (riguardo ai soggetti deboli) meno ardua. In effetti: se la seconda cifra (« plurale ») può sempre adempiere per il legislatore o per l’amministratore pubblico funzioni preziose di catalogazione/ orientamento, sarà il primo predicato a candidarsi come segno davvero eponimico della categoria. I motivi di ciò sono più d’uno. Non si tratta soltanto della considerazione che la curvatura sintetica appare indispensabile — politicamente — per il progetto di una cultura davvero « universale », in tema di soggetti deboli (45). Ancor più conterà il rilievo circa la molteplicità dei riferimenti tecnici (dal collocamento obbligatorio agli assegni di 2118 PAOLO CENDON XXXVI, 36.10. mantenimento, dal day hospital alle misure di protezione civilistica, dai presidi territoriali al Leitmotiv della ricerca del consenso (46), dal sistema dei diritti soggettivi all’assistenza domiciliare, ecc.) che si prestano a valere — a seconda delle circostanze — per più di una categoria di svantaggiati (47). 36.10. Contagiosità, nuovo diritto, progetto continuo. Di qui anche la possibilità di fare della « contagiosità delle riforme » un vero e proprio vessillo della materia; e ciò sotto i vari punti di vista che assumeranno, volta a volta, rilievo: a) improponibilità, all’interno di una certa categoria di disagiati, di ritocchi normativi — per questo o quel filamento disciplinare — che non siano destinati, prima o poi, ad imporre la riscrittura o la rifinitura di altri versanti giuridici relativi a quella medesima categoria; per cui sarebbe impossibile (poniamo, riguardo agli infermi di mente) intervenire innovativamente sul terreno dell’interdizione o inabilitazione senza dover mettere allo studio, ad un certo punto, la correzione di ulteriori spicchi istituzionali: matrimonio dell’incapace, filiazione, attività contrattuale, successione mortis causa, lavoro, responsabilità civile, ecc. (48); b) impensabilità — in secondo luogo — di miglioramenti (nello statuto di questo o quel sottogruppo di svantaggiati) che non siano tali da influenzare presto o tardi lo statuto peculiare di altri sottogruppi di deboli; per cui sarebbe difficile, ad esempio, introdurre a beneficio degli anziani nuove modalità di salvaguardia civilistica o socialsanitaria (teledrin, provvidenze di accompagnamento, curatele personalizzate, ecc.) senza dover pensare di estendere le stesse misure, ad un certo momento, a questa o quella fascia di malati, di soggetti a rischio, di « minori grandi », di handicappati (49). E sempre entro cornici di tipo sintetico — arieggianti la categoria unitaria dei deboli — andrà prospettata, via via, la discussione intorno ai restanti profili della materia: 1) giuridificazione: come estendersi progressivo dell’interesse (o delle conquiste) dell’ordinamento a tratti dell’esperienza XXXVI, 36.10. I DIRITTI DELLE PERSONE DEBOLI 2119 umana — bisogni, malesseri, aspirazioni, inettitudini, sordità, appartenenze, contraccolpi, spaesamenti — estranei, sino a quell’istante, al gioco del « giuridicamente rilevante » (50); 2) interdisciplinarità: come destino delle lande in questione a non essere analizzabili, compiutamente, se non attraverso una miscela di saperi distinti (lungo assemblaggi scientifici più o meno diversi, a seconda dell’oggetto specifico di studio) (51); 3) nuovi interventi legislativi: non solo quelli concepiti per più insiemi di soggetti fragili (momento d’inizio della vita, eutanasia (52), unioni coniugali di fatto, associazioni non profit, banche dati); anche quelli rivolti a fasce circoscritte di individui (diritti dei gay e delle lesbiche, sterilizzazione forzata, procreazione assistita, ecc.); 4) il motivo delle nuove Carte endocategoriali, dei Tribunali per la difesa di certi gruppi, delle Dichiarazioni spontanee di diritti, dei Codici e Cataloghi deontologici, dei Manifesti, degli Statuti (53), ecc.; 5) controllo e progetto continuo: come necessità di verifiche incessanti — città per città, provincia per provincia — circa la funzionalità momentanea di ogni braccio assistenziale, soprattutto della pubblica amministrazione; nella consapevolezza che in nessun ambito della vita organizzata vi è un pericolo altrettanto forte che situazioni di (notorio) splendore amministrativo e operativo possano, da un giorno all’altro, cominciare a perdere colpi, a entrare surrettiziamente in crisi: con uffici man mano anchilosati da tensioni interne (psicologiche, politiche, strategiche), sempre meno incisivi negli interventi, frustrati in qualche fantasia di riassetto, ridotti a gusci sostanzialmente vuoti, ecc. (54); 6) tutela esecutiva: come esigenza di ampliare gli spazi entro cui è pensabile — da parte di un privato o di qualche ente esponenziale dei soggetti deboli o di altre figure interessate — un’azione giudiziale (davanti alla magistratura ordinaria, o amministrativa) volta ad ottenere la condanna della pubblica amministrazione, inadempiente rispetto all’impegno di insediare questo o quel servizio, all’esecuzione forzata dell’opera in questione (55); 7) immagini massmediali: come opportunità per lo stu- 2120 PAOLO CENDON XXXVI, 36.11. dioso di verificare quali siano le « immagini » della debolezza che vengono emergendo — via via — in rapporto alle varie tipologie di persone svantaggiate, secondo questa o quell’epoca storica, con riguardo all’uno o all’altro comparto geografico (del nostro Paese o del mondo), in relazione a questo o quel settore culturale e artistico o ai singoli mezzi di comunicazione di massa — letteratura, arti figurative, teatro, cinema, giornali, televisione, pubblicità commerciale, musica, universo informatico, ecc. (56); 8) nuovo linguaggio: come impegno a favorire la nascita progressiva di un nuovo linguaggio, da utilizzarsi per la trattazione dei problemi relativi ai soggetti deboli — un impegno le cui direttrici sembrano ravvisabili, fin d’ora, nella crescente rinuncia a locuzioni burocratiche, a termini inutilmente stigmatizzanti, a formule invecchiate, a fraseggi pomposi, a squarci amatoriali o improvvisati, a ghirlande sintattiche dettate dal mero gusto di intrecciare, fra loro, una serie di subordinate. 36.11. Quotidianità. Il mondo effettivo dei soggetti deboli; la ripetitività spicciola, alimentare dei gesti, le presenze e conferme di ogni giorno: casa, famiglia, lavoro, posta, shopping, telefono. I viaggi, il libretto di banca, la visita specialistica, il treno, l’idraulico. I beni che si comprano, che si affittano, gli oggetti che si vendono, che si rompono; le sostanze che tutti noi beviamo, che mangiamo, gli oggetti smarriti, gli arnesi che danneggiamo senza volerlo. I cibi che fanno bene alla salute, quelli che nuocciono alla pelle o alla linea. Il ristorante, il mare un po’ inquinato, il canone televisivo; il carrozziere, il pedicure, il « gratta e vinci », i venditori ambulanti, l’assicurazione contro gli incendi, il parroco. Il parco-giochi — per i bambini — i fumetti vecchi e nuovi (57), una maestra comprensiva, la nutella, il no alle saracinesche inutili. L’obbligo di andare a letto presto, la certezza di non essere soli, le giostre (58). Progetti, rimbrotti leggeri, minigruppi di lavoro, coccole (59). Il diritto come insieme di tutto ciò che è anonimo, indispensabile (60). Un prontuario delle cose pratiche che sono uguali (61) XXXVI, 36.12. I DIRITTI DELLE PERSONE DEBOLI 2121 per chiunque, di cui ognuno ha bisogno allo stesso modo (il « nomos panton basileus » di Pindaro) — e accanto ad esse la lista delle opportunità di cui il debole, lui solo, avrà bisogno per realizzare se stesso (62). 36.12. Prerogative dei soggetti deboli. Il tratto più significativo, per un soggetto debole? Occorrerà cercarlo nella nozione stessa dei « diritti » che lo riguardano (63). Ci si trova dinanzi, in effetti, a prerogative alquanto dissimili rispetto all’intelaiatura dei « diritti soggettivi » più consueti — situazioni di stampo liberista, che hanno trovato suggello nella rivoluzione francese, e consacrazione formale nel Codice Napoleone; moduli pensati per esseri forti, imperniantisi sul postulato di un titolare autosufficiente, sul dogma di alcuni santuari individuali da non violare: con al centro l’obbligo (per qualunque terzo) di non varcare il cerchio magico, di non accostarsi senza permesso a quel focolare. I soggetti deboli? Non che le prerogative di stampo classico — quelle patrimoniali (proprietà, usufrutto, servitù, abitazione, ecc.) o quelle personali (nome, immagine, onore, riservatezza, ecc.) — non abbiano per essi alcun significato. Anzi è spesso vero il contrario: e la circostanza che il titolare possa non essere, talvolta, in condizione di esercitare questa o quella facoltà (64), sarà un motivo in più per dover cercare in che modo una pienezza di esercizio appaia qui — di fatto — reintegrabile. Nessun dubbio, però, che i momenti più significativi (per il circuito esistenziale di un diverso) assumano frequentemente altre valenze (65). Diritto, allora, ad un’abitazione sicura, ad inserimenti lavorativi decorosi, ad ambienti salubri, ad un asilo-nido non proprio all’altro capo della città. Diritto alla cura (medicine, infermieri, ospedali, informazioni adeguate, tempi ragionevoli) (66), ad un sistema scolastico efficiente (67), ai trasporti particolari, alla pulizia del corpo, a una sorveglianza rigorosa quando ci si può fare del male. Diritto a una buona morte (68). Posizioni giuridiche che non presuppongono, come si vede, 2122 PAOLO CENDON XXXVI, 36.13. la destrezza di titolari organizzati, che non temono indiscrezioni o sconfinamenti dei terzi. Loro cardine sarà che vi sia, casomai, la benefica intromissione di qualcuno: la controparte è prevalentemente di natura pubblicistica, la trasgressione (per gli obbligati) diventa un « non aver fatto », un « non voler fare » (69). Il sistema dei rimedi per la violazione dei doveri (mancata ottemperanza, inerzia decisionale) resta in larga misura da inventare, tecnicamente. L’essenza più profonda? Il dovere, di qualcuno o di qualcosa, di visitare in modo sistematico il « debole »: informandosi circa le sue urgenze, cambiandogli i pannolini, provvedendo a far lavare i suoi indumenti, asciugandogli la saliva, facendogli la puntura di antibiotico. E così di seguito: impegno a cucinare per chi non può farlo, a occupare il posto avanti nel tandem (quello dietro è per chi non vede), ad usare i quattrini del beneficiario per comprare capi di abbigliamento, a leggergli le storie in un libro, a tagliargli i capelli e a pettinarlo (70) — in vista, perché no?, di un’instillazione nell’interessato del gusto a provvedere lui stesso a soddisfare parte, tante o poche, di quelle necessità (71). 36.13. Abbandono, responsabilità. L’essenza del malessere, per buona parte dei deboli? L’isolamento, l’ostracismo: il « non farcela » da soli a gestire le cose, l’emarginazione da qualsiasi ruolo, gli sguardi compassionevoli, l’esclusione da feste e confidenze di sorta. Spesso la mancanza di una famiglia, comunque la difficoltà (o l’impossibilità o la riluttanza) per i congiunti a prendere le redini della situazione. La messa al bando silenziosa, il distacco, nelle varie forme che può assumere: la commiserazione, il rifiuto (plateale o impercettibile) di un malato (72); l’abbandono di un « incapace », lasciato da solo nel suo appartamento, al freddo, senza nessuno che suoni mai al campanello. I mille modi per voltare le spalle a un bambino. Fisicamente, davanti alla Tv, logisticamente, durante le vacanze, affettivamente (73). Nei regali, apposta o senza accorgersene, delegando XXXVI, 36.14. I DIRITTI DELLE PERSONE DEBOLI 2123 ogni cosa all’altro genitore, o ai nonni. Sanitariamente, culturalmente, igienicamente. L’abbandono di un animale al suo destino; l’abbandono di uno scolaretto difficile (estroso, insonnolito, balbuziente, antipatico, insignificante). L’incuria verso un pentito della mafia, verso un’équipe di volontari, verso una colonia estiva, verso un palazzo antico. L’indifferenza per una famiglia a rischio, in seguito alla contrazione nell’organico degli assistenti sociali. La noncuranza per un coniuge senza mezzi, per un reparto ospedaliero, per un sieropositivo, per una comunità alloggio, per un ex detenuto. E al di fuori, per il diritto oggettivo? La tutela esecutiva come realtà destinata a incerarsi un po’ al contrario: assai poco sul piano di una distruzione di cose fatte senza titolo, assai più su quella di una somma di provvidenze quotidiane da attivare — un nido sotto casa, una rampa, un’insegnante di sostegno, un giardino pubblico, un trasporto scolastico (74). La responsabilità, anch’essa, come sanzione non già per quanto è stato compiuto (prepotentemente, sbadatamente), bensì — soprattutto — in relazione ai danni che derivano da altrettante omissioni (75); che coincidono con un’assenza sistematica di iniziative, di gesti necessari, che derivano dalla mancanza di centri, di maniglie, di quel che avrebbe dovuto esserci, da un vuoto tutt’intorno (76). 36.14. Debolologia. L’indagine sul mondo dei deboli, il taglio scientifico per procedervi? Più semplice, ancora una volta, sarà dire che cosa non si debba fare, domandare. Un punto appare certo: ad annunciarsi incongrua è ogni metodologia che non riesca ad andar oltre l’apparenza, al di là del mero studio a tavolino (77). Non basterà fermarsi qui — in effetti — alla constatazione di un gioco delle parti astrattamente rispettato, recitato. Si tratta di andare alla scoperta delle esigenze fattuali, sopravvivenziali, più o meno dichiarate e avvertibili: istanze a metà tra fisiologia e socialità, sospese tra nutrizione quotidiana e pomeriggi rieducativi, fra denaro e non denaro (78). 2124 PAOLO CENDON XXXVI, 36.15. Pazienza, tempo e curiosità, per chi scruta. Gambe, viaggi e ronzii ai bordi dei padiglioni, più che non testa o erudizione. Interviste (anche selvagge) agli addetti ai lavori, visite improvvisate alle giunture meno illustri, chiacchiere senza ragione; il documentarsi senza documenti formali. Cogliere il vissuto nascosto, la sorgività e le utopie della law in action — specialmente come somma di ciò che si subisce (da chi è indifeso), che viene inflitto all’ombra, senza sosta; e assai meno, qui, come insieme di comandi agiti, spesi al meglio da qualcuno in grado di farlo (79). L’essere umano quale entità orizzontale — non di rado (anche una creatura in boccio) piagnucolosa, incattivita. Scoprire il circondario per com’è fatto: vedere in che modo è articolata quella determinata Scuola di specializzazione (80), censire i posti letto nelle cliniche private. Controllare l’impegno degli assessori comunali, dell’ufficio per l’abolizione delle barriere architettoniche (81); misurare le circolari ministeriali sul collocamento dei malati psichici. Verificare i bilanci USL, il grado di affollamento delle celle, occuparsi delle commissioni per le pensioni di invalidità, degli orari degli infermieri (82), del gratuito patrocinio, dell’immondizia, del pagamento delle rette negli ospizi, del volume degli investimenti regionali per il volontariato e le cooperative sociali (83). 36.15. Oltre il diritto. L’oltre (rapporti con l’esterno a parte) anche nelle relazioni del giurista-politico con se stesso — con i vari retroscena del suo mestiere. Le leggi che si scrivono sui deboli: come mai tanta retorica nelle proclamazioni iniziali (84), quel timbro spesso profetico, il legislatore oracolare dei primi articoli? Difficile non pensare a un’assise di eletti che (ancor più che fare propaganda politica, o sollevare cortine fumogene) puntano a salvarsi l’anima (85). L’oltre riferito — poi — ai criteri di lavoro che ci si assegna, al fatto stesso di aver scelto di occuparsi di temi simili. Il diritto dei deboli come « training autoanalitico », come sentiero inatteso attraverso cui chi studia potrà scoprire (domanda dopo do- XXXVI, 36.16. I DIRITTI DELLE PERSONE DEBOLI 2125 manda) in che modo è strutturato lui per primo, anima e corpo. Com’è fatto « dentro », innanzitutto. I profili della causalità: il collegamento fra determinati accadimenti e il prodursi di un danno psichico, la scoperta dei presupposti storici di un tentativo di suicidio (86). Il male: stupri, mutilazioni segrete (87), sequestri di persona, e poi violenze private, minacce, cattiverie e incurie nel quadro delle istituzioni « cattive ». Da dove certi eventi negativi sono derivati, come gli input esterni si sono avvitati. I disturbi mentali: come siamo fatti dentro, l’« oltre » certe evidenze recuperato in una narrazione prosastica, nelle catene dell’ordinamento. E com’è fatta la vita che circonda lo studioso, poi. La parabola del « danno biologico », ad esempio (88) il mondo dell’illecito quale laboratorio dialettico o maieutica di ciò che si è, che si insegue, l’importanza di godere delle cose quando sono intatte, ci appartengono (89). E, in generale, la registrazione di tutto quanto nella quotidianità dei deboli manca; una spia che ricorda all’interprete quel che lui stesso (nella veste di creatura ufficialmente forte) possiede ancora. L’indagine su questi campi quale mezzo per fare del bene all’esterno, per far stare meno peggio qualcuno. Ma anche come specchio per esorcizzare il male, per non dimenticare la propria fortuna. 36.16. Strumenti di protezione. Nell’infinita varietà delle sfumature, la condizione prevalente di chi è fragile è fondamentalmente questa: persone che non stanno abbastanza bene da potersela « cavare » da soli, in tutti quanti i frangenti — e che non stanno tanto male da abbisognare di qualcuno o qualcosa che ne rimpiazzi la voce interamente, definitivamente. Quali le traiettorie da evitare? Niente falsarighe di tipo rigido, in primo luogo (90); no a pacchetti espropriativi concepiti o disposti una volta per sempre. No a eccessi di protezione, a privilegi ingiustificati e irritanti (91). Piuttosto modulazioni flessibili, imperniate sull’idea della piena corrispondenza fra misure vicarie da adottare e necessità specifiche (idiosincratiche, irripe- 2126 PAOLO CENDON XXXVI, 36.17. tibili) di « quel » certo destinatario. Con margini ablativi della capacità limitati allo stretto necessario (92). No a gabbie uguali per tutti, che omogeneizzino chiunque vi venga accolto, no ad onnipotenze o ad eccessi di discrezionalità di autorità — pubbliche o private. Il soccorso legale quale procedimento fluente, sempre revocabile, anche dietro istanza del beneficiario (93). Ognuno con la propria storia, ognuno diverso anche per la legge, con i propri scudi difensivi (94). Le provvidenze assistenziali come abito su misura: che via via alcuni « esperti » (il giudice, i familiari, il medico, gli operatori dei servizi, i periti) ritaglieranno in maniera corale sulla sagoma di « quel » sofferente; dopo averlo interpellato pazientemente, tante volte quante occorre. Senza possibilità di scimmiottature o fotocopie rispetto a moduli, legali o giudiziali, già prefigurati per altri fratelli di sventura — chissà quali, chissà dove (95). 36.17. Pubblico e privato. E la fisionomia statutaria per la figura del curatore, dell’« amministratore di sostegno »? Neanche queste risposte appaiono facili: ma bisognerà essere consapevoli — se non altro — della molteplicità delle situazioni da fronteggiare. Talvolta può accadere che, accanto all’interessato, vivano persone perfettamente idonee a ricoprire quell’ufficio: coniuge, figli, parenti e affini, amici, compagni e colleghi di lavoro. In altri casi la realtà può essere diversa. I familiari non ci sono, o se esistono sono lontani, o se sono vicini non hanno buoni rapporti con l’assistito. Amici e colleghi possono mancare, o non riscuotere la fiducia del beneficiario, o non disporre delle qualità professionali per svolgere quei compiti. Che fare allora? Le questioni sono più d’una (96). Avrà senso immaginare che l’amministratore di sostegno debba — ad esempio — essere visto come vera e propria figura professionale? Con albi specifici, scuole apposite, piccole o grandi retribuzioni, carriere? Quanto di diritto, quanto di socialità, quanto di psicologia nel suo bagaglio formativo? Giovani alle prime armi, già sapienti, con buoni muscoli, XXXVI, 36.18. I DIRITTI DELLE PERSONE DEBOLI 2127 capaci di ascoltare, all’occorrenza di persuadere? Oppure pensionati laboriosi, disponibili, abili narratori di storie, con un bel carattere? E il denaro per compensarli: stanziamenti pubblici, fondi tratti dal le pensioni stesse dei deboli? Un po’ dell’uno e un po’ dell’altro? Oppure tutto gratis? Anche gli assistenti sociali in quel ruolo — e cosa pensare però delle resistenze tradizionali (proprio degli operatori) rispetto a una soluzione del genere? 36.18. Razionalizzazione. Merita sottolineare — infine — l’opportunità che il sistema di « protezioni sostitutive morbide » a favore dei soggetti deboli non venga imperniato, esclusivamente, sull’attività personale di un curatore. Più d’uno allora i passaggi che rilevano: a) l’abbassamento (rispetto ai parametri dell’interdizione) della quota di disagio sufficiente a far scattare la messa in opera del provvedimento giudiziale costituisce di per sé un fattore tale da determinare, potenzialmente, un alto fabbisogno sociale di figure del genere; b) la via d’uscita dovrebbe essere, di conseguenza, quella che veda un singolo curatore chiamato a gestire, contemporaneamente, le sorti di una pluralità più o meno vasta di persone deboli; c) di qui la necessità di modelli organizzativi che sollevino il gestore stesso da una parte delle sue incombenze tecniche — liberando la sua agenda, in sostanza, da tutti gli adempimenti che non siano tali da richiedere istruttorie e auscultazioni individuali, presso i vari assistiti. C’è da chiedersi, allora, se istanze siffatte non potrebbero venir soddisfatte mediante un paradigma più complesso: verosimilmente, con l’insediamento — a livello di comprensorio socioassistenziale (USL, comune, provincia) — di un apposito Centro servizi computerizzati per i soggetti deboli: chiamato a svolgere, a beneficio degli utenti, le varie funzioni di tipo burocratizzatoperiodico. Si andrebbe, in definitiva, verso un assetto di tipo bipolare: 2128 PAOLO CENDON XXXVI, 36.18. 1) al Centro servizi verrebbe rimessa la cura dei momenti (della vita di un debole) più strettamente meccanico-patrimoniali: riscossione di stipendi e pensioni, pagamenti dell’affitto, spese di condominio, rate di qualsiasi genere, bollette, pendenze bancarie e assicurative, stipendi e contributi alla colf, alla fisioterapista, all’infermiera, assegni alimentari, oblazioni amministrative, abbonamenti, canoni, imposte, ecc.; 2) all’amministratore di sostegno resterebbe, nel quadro dei poteri conferitigli dal giudice tutelare, il compimento di tutti gli atti « personalizzati » — quelli incardinati sulla necessità di una previa consultazione del beneficiario: mediazioni sociali, contatti medici, pubbliche relazioni, vendite e locazioni, assemblee condominiali, acquisto di indumenti, beni voluttuari, spettacoli, viaggi, regali, libri, elettrodomestici, antiquariato, e così via. NOTE (1) Una sintesi efficace in G. Alpa, I nuovi mondi e i diritti della persona, in G. Visintini (a cura di), Il diritto dei nuovi mondi, Padova, 1994, pp. 501-5. (2) Per quanto concerne i nuovi poveri, si veda ad esempio v. M. Caferra, Diritti della persona e Stato sociale. Il diritto dei servizi socio sanitari, Bologna, 1987, pp. 8 sec. In merito alla disciplina privatistica degli alimenti, per tutti, T. A. Auletta, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984, oppure M. Dogliotti, Doveri familiari e obbligazioni alimentari, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1994. (3) Qualche rilievo d’insieme in J. Ruesch e G. Bateson, Communication. The Social Matrix of Psychiatry, New York, 1968 (trad. it. La matrice sociale della psichiatria, Bologna, 1976). (4) Sui problemi degli anziani, ad esempio, A. Ardigò, Anziani. Il difficile ruolo sociale, in « Il progetto », 1988, pp. 5 sgg., oppure P. Mariotti, G. Misaraki e R. Rizzi, I diritti dei malati, Milano, 1993, p. 27 ss. Un ricco ventaglio anche in P. Stanzione (a cura di), Anziani e tutele giuridiche, Napoli, 1991 (dove si segnalano i saggi dello stesso curatore, di M. Dogliotti e di P. Perlingieri). Qualche cenno nel contributo di S. Bolognini, in L. Lombardi Vallauri (a cura di), Il meritevole di tutela, Milano, 1990, p. 921 sgg. più recentemente F. Marinelli, La tutela civile dei soggetti deboli, in Giustizia civile, II (1994), p. 166. Significative le testimonianze nel volume a cura della Comunità di Sant’Egidio, L’età più lunga. Anziani: dall’abbandono dalla solidarietà, Milano, 1991. (5) Per un esame analitico della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si vedano i commenti raccolti da P. Cendon (a cura di), Handicap e diritto. Legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e di diritti delle persone handicappate, Torino, 1997. Più succintamente Mariotti, Misaraki e Rizzi, I diritti dei malati, cit., p. 43 s. Oppure C. Scorretti (a cura di) Il mio piede sinistro. Giornate di studio sulla Legge quadro sull’handicap, Belluno, 1995; S. Nocera, Handicappati: la nuova cittadinanza. Commento alla legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, Torino 1995. (6) Soluzioni del genere mostrano di andare incontro, talvolta, a obiezioni di tipo puristico: cfr. ad esempio G. Roehrssen, Gli handicappati nella Costituzione, Roma s.d., pp. 467 sgg. (“Non credo di dovermi soffermare sulla definizione del concerto di handicappato: consentitemi di dire XXXVI I DIRITTI DELLE PERSONE DEBOLI 2129 soltanto, come italiano, che pur senza fare nazionalismi di alcun genere e pur rendendomi conto di una indubbia internazionalità del concetto stesso che comporta talune conseguenze, la parola non mi piace per un eccessivo sapore straniero e per un sostanziale allontanamento del vocabolo dalla nostra lingua. Possibile che la nostra ricca e bella lingua non possieda un vocabolo idoneo ad esprimere il concetto e che si debba ricorrere ad un quasi prestito? »). (7) Sulle problematiche civilistiche relative a questi ultimi si vedano, per tutti, P. Petrelli e A. Ansaldo, in T. Randini, M. Agazzi e A. Verde (a cura di), La tutela giuridica del sofferente psichico. Stato attuale e prospettive di riforma, Milano, 1993, pp. 17 sgg. Assai ricco il volume di A. Venchiarutti, La protezione civilistica dell’incapace, Milano, 1995. Utile anche la ricostruzione di G. Lisella, Interdizione « giudiziale » e tutela della persona. Gli effetti dell’incapacità legale, Napoli, 1984. Un quadro sintetico in P. Lorefice, L’amministrazione dei beni degli incapaci, Padova, 1996; oppure G. Ponti e I. Merzagora, Psichiatria e giustizia, Milano, 1993, pp. 137 sgg.; L. Lenti (a cura di), Interdizione e inabilitazione a tutela delle persone portatrici di handicap, Torino, 1993, e già Aa.Vv., Infermità di mente e diritti civili. Il caso di Imola: la sostanza e la forma del diritto e della cura, Forlì, 1987. Con particolare ampiezza il centinaio di relazioni accolte in P. Cendon (a cura di), Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti della trasformazione, Napoli, 1988, pp. 359 sgg. Un taglio attento al diritto comparato in G. Autorino Stanzione, Infermità mentale e tutela del disabile negli ordinamenti francese e spagnolo, Napoli, 1990. Oppure (con un largo spettro di riferimenti geografici) J. Espinoza Espinoza, Tutela giuridica dei soggetti deboli: il risveglio dai sogni dogmatici dei giuristi, in Rivista critica del diritto privato, 1993, pp. 427 sgg. Sui profili laburistici, interessante il repertorio fornito da M. Orione, in Bandini, Lagazzi e Verde (a cura di), La tutela giuridica del sofferente psichico, cit., pp. 169 sgg. (nello stesso volume, con riguardo alle questioni penalistiche, si vedano le indagini di R. Arata e L. Scorza Azzarà, pp. 263 sgg., nonché i materiali commentati da L. Fioravanti, pp. 389 sgg.). Circa l’evoluzione della nozione privatistica di capacità cfr., in generale, G. Alpa, Status o capacità. La costruzione giuridica delle differenze individuali, Roma-Bari 1993, pp. 63 sgg. Qualche rilievo a proposito degli infermi di mente in A. Falzea, in P. Cendon (a cura di), Infermità di mente e responsabilità civile, Padova, 1988, pp. 17 sgg. Si veda ancora (soprattutto in considerazione della disciplina stabilita per i Tso nella legge 180/78) G. Visintini, La nuova disciplina sui trattamenti sanitari obbligatori per malattie mentali. Riflessi sulla nozione di incapacità di intendere e volere, in Rivista critica del diritto privato, 1984, pp. 817 sgg. Con ampiezza P. Rescigno, Situazione e status nell’esperienza del diritto, in Rivista di diritto civile, n. 1 (1973), pp. 209 sgg.; Id., Capacità di diritto privato e discriminazioni dei soggetti, ibid. (1988), pp. 787 sgg. A proposito dei minori, per tutti, F. Busnelli, Capacità ed incapacità di agire del minore, in « Diritto di famiglia e delle persone », 1982, pp. 54 sgg.; M. Dogliotti, L’autonomia dei minori o le incertezze della Corte costituzionale, in Giurisprudenza italiana, IV (1991), pp. 209 sgg.; A. Scarpa, Legislazione e giurisprudenza per gli interessi dei minori (riflessioni della dottrina sulla « capacità di agire »), in Diritto e giurisprudenza, n. 1 (1992), pp. 324 sgg. Oppure i fascicoli sin qui apparsi della rivista « Minori giustizia ». (8) In merito a questi ultimi si rinvia a R. Magni, Immigrati. La legge infuria lo Stato manca, in Il progetto, 1988, pp. 23 sgg.; cfr. anche D. Petrosino, Immigrati. Forme di razzismo in Italia, ibid., pp. 29 sgg. (9) Per qualche osservazione L. Bellanova, Commento agli artt. 7, 9-10, 35 (1997), in Cendon (a cura di), Handicap o diritto, cit., p. 123 (« ... la visione che ha il legislatore è parziale, angolare: dal mondo del diritto è bandito l’uomo e se ne accolgono solo singole azioni ed omissioni; episodi di vita staccati dalla propria unicità genetica e perciò irrimediabilmente dispersi in una logica (quella economica e giuridica) cui non appartengono se non di riflesso, in seconda battuta »). (10) Circa le violenze arrecate nell’ambito della famiglia, si rinvia a S. Patti, Minori. La violenza in famiglia, in Il progetto, 1988, pp. 15 sgg.; oppure P. Dusi, Minori. Crescita di un fenomeno, ibid., pp. 19 sgg. Sull’handicap di un congiunto come elemento destinato a influenzare la vita dei restanti membri della famiglia, cfr., d’altro canto, Bellanova, Commento agli artt. 7, 9-10, 35 cit., pp. 68 sgg., 112 (« ... porre al centro dell’attenzione la famiglia — come nucleo fondamentale della comunità locale — significa che il sostegno di rete (formale ed informale) deve 2130 PAOLO CENDON XXXVI essere organizzato in funzione delle sue esigenze; senza, per ciò solo, pretendere di risolvere la problematica sociale in un pacchetto di misure funzionali al recupero di una anacronistica esclusività assistenziale della famiglia »). (11) Basterà qui un rinvio a Mariotti, Misaraki e Rizzi, I diritti dei malati, cit., pp. 73 sgg. (12) Assai ricco — ultimamente — il dibattito circa la procreazione artificiale e in merito al cosiddetto « statuto dell’embrione »: per tutti Lenti (a cura di), Interdizione o inabilitazione, cit., e Id.., La procreazione artificiale. Genoma della persona e attribuzione della paternità, Padova 1993; S. Rodotà, Repertorio di fine secolo, Roma-Bari, 1992, pp. 210 sgg. Oppure R. Clarizia, Procreazione artificiale e tutela del minore, Milano, 1988; A. Eser, Status dell’embrione umano da un punto di vista giuridico, in Politica del diritto, 1989, pp. 417 sgg.; M. Mori, Fecondazione artificiale. Gli esperimenti in vitro, in Il progetto, 1988, pp. 53 sgg.; F. Bimbi, Fecondazione artificiale. Bioetica come sapere separato, ibid, pp. 59 sgg.; G. Alpa e G. Ferrando, in P. Cendon (a cura di), I bambini e i loro diritti, Bologna, 1991, pp. 167 sgg.; M. Calogero, La procreazione artificiale. Una ricognizione dei problemi, Milano, 1989; F. Pizzini, Costi e benefici per le donne: aspetti del dibattito internazionale, in Politica del diritto, 1992, pp. 137 sgg.; G.M. Armone, Procreazione assistita e trattamento degli embrioni umani. Prospettive di regolamentazione, in Rivista critica del diritto privato, 1995, pp. 331 sgg.; G. Ferrando, Proposte e progotti di legge per la procreazione assistita?, in « Politica del diritto » 1996, pp. 30 sgg. Da ultimo F.D. Busnelli, Quali regole per la procreazione assistita?, in Rivista di diritto civile, n. 1 (1996), pp. 571 sgg.; E. Capobianco, Nascituro e responsabilità civile, in Rassegna di diritto civile, 1997, pp. 50 sgg. Per un’analisi sul campo, L. Parolari, La coppia sterile: analisi su quattromila casi di un centro universitario di sterilità, in Politica del diritto, 1992, pp. 129 sgg. Un panorama comparatistico in G. Ferrando (a cura di), La procreazione artificiale tra etica e diritto, Padova 1989. Circa i profili tecnici, è sufficiente un rinvio a G. Scarselli, G. Ricci e F. Barciulli, in P. Cendon (a cura di), Il bambino e le cose. Diritti e doveri dei minori nella società dei consumi, Milano, 1993, pp. 99 sgg. (13) Efficace il quadro d’insieme offerto da Maritti, Misaraki e Rizzi, I diritti dei malati, cit. (14) Alla cura e al reinserimento di questi ultimi è dedicato il decreto ministeriale 3 agosto 1993 (in Gazzetta ufficiale, 15 gennaio, n. 11). (15) Sugli zingari si vedano ad esempio i rilievi di R. Granapei e A. Scarpellini, Zingari. Le parole per dirlo, in Il progetto, 1988, pp. 33 sgg. Con riguardo alla legge-quadro sull’handicap, e ai rischi di discriminazione nel trattamento dei disabili stranieri, cfr. Bellanova, Commento agli artt. 7, 9-10, 24 cit., cit., p. 106. In generale, U. Mattei, Ai confini della Terra Promessa. Immigrazione, povertà, razzismo ed i limiti del diritto, in G. Visintini (a cura di), Il diritto dei nuovi mondi, Padova, 1994, pp. 367 sgg. Una tavola di utili riferimenti in M. Luciani, Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L’esperienza italiana, in Rivista critica del diritto privato, 1992, pp. 203 sgg. Si vedano pure le considerazioni di F. Cerrone, Identità civica e diritti degli stranieri, in Politica del diritto, 1955, pp. 441 sgg. (16) Si veda, da ultimo, il numero monografico di Politica del diritto a cura di F. Margiotta Broglio, Libertà religiosa e rapporti Stato. Confessioni nella prospettica di revisione della Costituzione, 1996, pp. 3 sgg. (ove saggi di G. Long, S. Lariccia, S. Berlingò, C. Cardia, F. Finocchiaro, G. Casuscelli, S. Ferrari, F. Onida, A. Mattioni, G. Sacerdoti, R. Botta e N. Colaianni). (17) Qualche osservazione in Rescigno, Capacità di diritto privato, cit., pp. 795 sgg. (18) Pochi temi sono assurti altrettanto rapidamente alla cronaca ufficiale, durante gli ultimi anni. Fra i tanti contributi, C. Francescutti, in Aa.Vv., I dieci anni della 180, Pordenone, 1988, pp. 177 sgg.; G. Dosi, in A. Papisca (a cura di), Nel nome dei bambini, Milano, 1990, p. 71. In precedenza (soprattutto sul fenomeno della delinquenza giovanile) i saggi raccolti in C. Serra (a cura di), Psicologia e giustizia. Questioni di psicologia giuridica, Milano, 1980, pp. 229 sgg. Più succintamente D. Scatolero in R. Villa (a cura di), La violenza interpretata, Bologna, 1979, pp. 91 sgg. Circa il ricovero psichiatrico dei minorenni, si vedano le considerazioni di L. Gandolfo, in K. Graziosi, E. Rebecchi e Spinedi (a cura di), Psichiatria senza manicomi. Atti del convegno Europeo suoltosi a Bologna il 20-22 ottobre 1988, Bologna, 1991, p. 747. A proposito dei « ragazzi della mafia », assai precise le indicazioni in P. Occhiogrosso (a cura di), Ragazzi della mafia. Storie di criminalità — con testi minorili, voci dal carcere, le reazioni e i sentimenti, i ruoli e le proposte, XXXVI I DIRITTI DELLE PERSONE DEBOLI 2131 Milano, 1993. Per il diritto privato, cfr. l’analisi di F. Giardina, La condizione giuridica del minore, Napoli, 1984; più di recente, C. Palmeri, Diritti senza poteri. La condizione giuridica dei minori, Napoli, 1994; significativa la ricostruzione di M. Perucci, Bambini e adolescenti di fronte alla legge, Ancona, 1994. (19) Circa i diritti della donna nei processi penali di aborto, si rimanda a C.F. Grosso, Diritti della donna nei processi penali di aborto, in Politica del diritto, 1990, pp. 297 sgg. (20) Per un’analisi della violenza sessuale nella storia, sono interessanti i contributi raccolti in A. Corbin (a cura di), La violenza sessuale nella storia, Roma-Bari, 1992. (21) Per tutti, Alpa, Status e capacità, cit., p. 157. (22) Sulla complessità dei ruoli familiari affidati alla donna (anche a rischio di disagio mentale) si vedano le osservazioni di Elvira Reale, in Cendon (a cura di), Un altro diritto per il malato di mente, cit., pp. 719 sgg. In generale, Rodotà, Repertorio di fine secolo, cit., pp. 77 sgg. (23) Rimandiamo in proposito all’analisi di A. Tosi, Immigrati e senza casa. I problemi, i progetti, le politiche, Milano, 1993. Sui « diritti delle donne » sono istruttive — in generale — le note di M.V. Ballestrero, I « diritti delle donne » (note in margine a un dibattito su diritti umani e Comunità Europea), in Politica del diritto, 1990, pp. 123 sgg. (24) Uno spoglio completo in G. Alpa, Il diritto dei consumatori, Roma-Bari, 1995. Più sinteticamente Armone, La salute collettivi dei consumatori, cit., pp. 107 sgg. Riguardo ai problemi accennati nel testo, di recente E. Eichenhofer, L’utilizzazione del diritto privato per scopi di politica sociale, in Rivista di diritto civile, n. 1 (1997) p. 206. (25) Sul collocamento obbligatorio si veda il panorama offerto da M.G. Breda e F. Santanera, Handicap: oltre la legge quadro. Riflessioni e proposte, Torino, 1995, pp. 121 sgg.; per un attento esame dei profili del lavoro subordinato nell’ambito della legge 104/1992, F. Nisticò, in Cendon (a cura di), Handicap e diritto, cit., pp. 282 sgg. Con riguardo al lavoro del malato di mente, si veda la tavola rotonda in Cendon (a cura di), Un altro diritto per il malato di mente, cit., pp. 299 sgg. Istruttivo in generale, il percorso tracciato da C. Lepri e E. Montobbio, Lavoro e fasce deboli. Strategie e metodi per l’inserimento lavorativo di persone con difficoltà cliniche o sociali, Milano, 1993. Sui problemi della salute in fabbrica — soprattutto in ordine ai riflessi di ordine psichico — sempre attuale l’indagine di P. Sivadon e R. Amiel, Psicopatologia del lavoro, Roma, 1974. (26) Si veda da ultimo il sintetico panorama di S. Castiglione, Povere bestie. I diritti degli animali, Venezia, 1997. Oppure il saggio di C. Parenti, in Lombardi Vallauri (a cura di), Il meritevole di tutela, cit., pp. 713 sgg. Qualche accenno in Rescigno, Capacità di diritto privato, cit., p 794. Sul rapporto fra bambini e animali, assai felici le considerazioni di P. Zatti, Gli animali, in Cendon (a cura di), Il bambino e le cose, cit., pp. 46 sgg. Quanto agli animali d’affezione, cfr. Marinelli, La tutela civile dei soggetti deboli, cit., pp. 156-57. (27) Per un recente riesame della famiglia di fatto, ad esempio, F. D’Angeli La tutela delle convivenze senza matrimonio, Torino, 1995; oppure M. Bernardini, La convivenza fuori del matrimonio, tra contratto e relazione sentimentale, Padova, 1992; B. Bile, La famiglia di fatto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Rivista di diritto civile, n. 2 (1996), pp. 641 sgg. (28) Un bilancio degli orientamenti giurisprudenziali, da ultimo, in M. Coco, L. 14 aprile 1982, n. 164, sul transessualismo: panorama della giurisprudenza, om Rassegna di diritto civile, 1996, pp. 583 sgg. (29) Si esamini la raccolta di contributi in Aa.Vv., Da sudditi a cittadini. Gli utenti della TV, Milano, 1997 (dove spicca, tra gli altri, il lavoro di R. Salvicchi sui mass media e i disabili; indicativi, in questo volume, anche gli scritti di F. Maineri, G. Cocco, A. M. Natale, M. Colla e M. D’Amato, a proposito della TV e dei bambini). (30) Non senza accenti polemici, Bellanova, Commento agli artt. 7, 9-10, 35, cit., p. 123 (« La soluzione della eguaglianza è data dalla creazione di spazi per i diversi, dove ciascuno sia eguale all’altro nella diversità. Follia, prostituzione e delitto costituiscono una minaccia per la società, ragion per cui vanno rimossi: se la fobia ha in sè i germi della ribellione, nel suo capovolgere le regole della logica su cui qualsiasi società è costruita, la prostituzione, invece, può minare la famiglia »). 2132 PAOLO CENDON XXXVI (31) Rodotà, Repertorio di fine secolo, cit., pp. 237 sgg. (32) Sul suicidio di militari (visto come fonte di possibile responsabilità, a carico dell’Amministrazione statale) cfr. P. Cendon e L. Gaudino, Colpa vostra se mi uccido. Il suicidio e la responsabilità, Venezia, 1996, pp. 71 sgg. Quanto alla sindacalizzazione delle forze armate, M. Greco, Le forze armate: verso il sindacato?, in Politica del diritto, 1996, pp. 331 sgg. (33) Si vedano altresì F. Cafaggi e O. Galloni, Disciplina e tutela delle situazioni soggettive afferenti agli handicappati, in Rivista critica di diritto privato, 1986, pp. 155 sgg. (34) Sempre attuali i contributi raccolti in F. Basaglia (a cura di), L’istituzione negata, Torino, 1968. (35) Per un rapido inquadramento, V. Caferra, Diritti della persona e Stato sociale, cit., pp. 3 sgg. (36) Qualehe osservazione in E. Hanau, Handicap, in Digesto quarto — Discipline pubblicistiche, VIII (1993), p. 69. (37) Sull’inserimento scolastico dei minori handicappati, M. Santerini, Giustizia in educazione. Svantaggio scolastico e strategie educative, Brescia, 1990; S. Nocera, Gli accordi di programma per l’integrazione scolastica e sociale dellle persone con handicap, Milano, 1994; M. Antonione Casale, P. Peila Castellani e F. Saggio, Il bambino handicappato e la scuola, Torino, 1991; G. Moretti, Educare il bambino disabile, Brescia, 1992; Breda e Santanera, Handicap, cit., pp. 102 sgg. Da ultimo Bellanova, Commento agli artt. 7, 9-10, 35, cit., pp. 130 sgg.; E. Pellecchia e M.G. Armone, in Cendon (a cura di), Handicap e diritto, cit., pp. 144 sgg.; L. Simonetti, Commento agli artt. 13-14 (1997), ibid., p. 197. (38) Concisamente A. Zucchetti, I servizi sanitari, Milano, 1995, p. 313. Quanto ai diritti del bambino ospedalizzato, cfr. J. Seilleur-Pazard, The Child, the Parents and their Nurse, Paris, 1985 (trad. it. I diritti del bambino ospedalizzato, Firenze, 1990). Fra i contributi leggibili in Cendon (a cura di), I bambini e i loro diritti, cit., cfr. soprattutto quelli relativi alle malattie infantili (P. Brovedani, G. Esposito e F. Panizon, pp. 261 sgg.), ai problemi del consenso (R. Depiero, pp. 287 sgg.), all’handicap (F. Cafaggi, pp. 323 sgg.). (39) Fra i tanti materiali, si veda il fascicolo Il bambino in affidamento familiare e i suoi legami (con interventi di O. Greco, C. Foti, R. Celegato, D. Ghezzi, M. Orsini, A. Ianniello, P. Vercellone, A. Montobbio, A. Verde N. Toffali, D. Esposito, F. Paino Ferrara, C. Castellani, M. Bouehard, L. Pepino) nella rivista Minori giustizia, n. 2 (1996). Più concisamente J. Korczak, Il diritto del bambino al rispetto, Milano, 1994; S. Rossi, Affidamento familiare: un primo bilancio, in Politica del diritto, 1989, pp. 701 sgg.; G. Dosi, in Papisca (a cura di), Nel nome dei bambini, cit., pp. 67 sgg. Per un inquadramento di carattere storico E. Recchi, I bambini nella storia, Roma-Bari, 1994. Circa la comunicazione con i bambini, sono istruttivi i materiali offerti da C. Vezzi e L. Luison (a cura di), Comunicare con i bambini, Roma, 1989. Quanto ai nodi dell’abuso e del maltrattamento, si veda ad esempio E. Caffo, in Papisca (a cura di), Nel nome dei bambini, cit., pp. 83 sgg.; oppure A.G. Luzzatto, L. Soranzio e R. Zoldan, in Cendon (a cura di), I bambini e i loro diritti, cit., pp. 351 sgg. Sui « bambini che denunciano », sono utili le osservazioni di F. Prina e quelle di P. Covini, entrambi in G. Maggioni e C. Baraldi (a cura di), Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell’infanzia, Urbino, 1997, pp. 177 sgg. e 387 sgg. Riguardo all’adozione dei minori, con vari punti di vista, M. Dogliotti, Affidamento e adozione, in Trattato di diritto civile e commerciale, cit.; F. Uccella, Il minore tra affidamento familiare e adozione, Roma, 1984; nonché i contributi di P. Brovedani, I. D’Eliso, T. Vergerio e L. Grasso in Cendon, (a cura di), I bambini e i loro diritti, cit., pp. 103 sgg. Per qualche rilievo, F. Cosentino, Le frontiere mobili dell’adozione: interessi del minore, politiche del diritto, prospettive di riforma (a proposito di un recente libro pubblicato negli Stati Uniti), in Rivista critica del diritto privato, 1995, pp. 495 sgg. Da ultimo P. Morozzo della Rocca, Adozione « plena, minus plena » e tutela delle radici del minore, ibid., 1996, pp. 683 sgg.; E. Urso, L’adozione dei minori nella prospettica di una riforma, ibid., pp. 711 sgg. Sull’istituto dell’affidamento, ad esempio, P. Perlingieri e A. Procida Mirabelli, L’affidamento del minore nella esegesi e disciplina, Napoli, 1984, e per una ricerca sul campo, F. Mazzucchelli (a cura di), Percorsi assistenziali e affido familiare, Milano, 1993 (dove saggi di F. Ichino Pellizzi, F. Mazzucchelli Pagani, G. Dente Zanna, F. Roncari Colombo). Interessante lo specchio compara- XXXVI I DIRITTI DELLE PERSONE DEBOLI 2133 tistico offerto da A. Procida Mirabelli di Lauro, Le adozioni dei minori nei sistemi italiano e francse, Napoli, 1988; e già M.C. Ebene Corelli, Le adozioni. Prospettive d’una riforma ed esperienze giuridiche europee, Padova, 1981. In merito all’affidamento dei minori nelle separazioni giudiziali, si vedano i materiali forniti da A. Dell’Antonio e D. Vincenti Amato, L’affidamento dei minori nelle separazioni giudiziali, Milano, 1992; significativo anche il panorama di T. Bandini e A. Verde, in Cendon (a cura di), Un altro diritto per il malato di mente, cit., pp. 651 sgg. Riguardo alle convenzioni internazionali in tema di minori, cfr. la recente sintesi di M.E. Quadrato, Il minore tra interessi e diritti, Bari, 1995; oppure M.R. Saulle, in Cendon (a cura di), Ul bambino e le cose, cit., pp. 56 sgg., insieme allo spoglio di G. Conetti, in Cendon (a cura di), I baambini e i loro diritti, cit., pp. 33 sgg. Riferimenti preziosi nel volume di Papisca (a cura di), Nel nome dei bambini, cit. (in particolare l’analisi di M. Mascia, pp. 95 sgg.); nonché Aa.Vv., I diritti del bambino. Riflessioni educative e proposte didattiche, Roma, 1990. (40) Si vedano, per tutti, i contributi presentati in Aa.Vv., Atti del convegno « Solidarietà sociale nella riabilitazione in psichiatria », Milano, 1991. Il riferimento fondamentale in materia resta (beninteso) il volume coordinato da Basaglia (a cura di), L’istituzione negata, cit. Significativo, di recente, il quadro in Aa.Vv., Dalla psichiatria alla salute mentale. Scienza, politica, liberazione dell’uomo, Roma, s.d.; oppure gli atti di cui al volume Graziosi, Rebecchi e Spinedi, (a cura di), Psichiatria senza manicomi, cit. (41) Sui rischi di una politica indifferente alle iniziative di risocializzazione, a favore dei soggetti deboli, cfr. S. Rodotà, Intervento, in Aa.Vv., La prevenzione degli handicaps e i diritti civili degli handicappati. Atti del Congresso scientifico internazionale tenuto a Roma, 27 maggio 1978, 1° giugno 1978, Roma, 1979, p. 479 (« Non trascuro l’importanza degli interventi di sostegno e, in generale, dell’assunzione da parte delle strutture pubbliche di impegni più ampi e qualificati: la logica assistenziale, tuttavia, porta con sè anche quella della separazione. E ciò può voler dire che, proprio con l’argomento della necessità di ampliare gli interventi di sostegno, si potrebbe giungere a creare (o ad ampliare) veri e propri ghetti di handicappati. Ora questa non è soltanto una logica confliggente con quella dei diritti civili (dal momento che approda a nuove ipotesi di discriminazione), ma contrasta pure con i principi costituzionali »). (42) Basterà qui un rinvio al percorso tracciato da R. De Angelis (a cura di), La diversità domata. Cultura della droga, integrazione e controllo nei servizi per tossicodipendenti, Roma, 1987. (43) In proposito, F. Omero, I diritti degli omosessuali, Venezia, 1996. (44) Sull’assistenza penitenziaria e postpenitenziaria, cit., ad esempio, Caferra, Diritti della persona e Stato sociale cit., pp. 268 sgg. Sempre utile, in generale, la lettura dei saggi (di L. Stortoni, E. Loi, N. Mazzacuva, M. Pavarini, E. Carletti, A. Gamberini, M. Virgilio, V. Grevi), in F. Bricola (a cura di), Il carcere « riformato », Bologna, 1977. Al carcere come luogo di produzione di violenza è dedicato lo scritto di N. Franco, in Villa (a cura di), La violenza interpretata, cit., pp. 133 sgg. (interessanti, qui, anche le considerazioni di U. Fornari, Compendio di psichiatria forense, Torino, 1984, pp. 121 sgg.). Per una testimonianza, A. Bozzi, Il detenuto scomodo (Manuale del carcere), Milano, 1972. Un quadro d’insieme in A. Cassese, Umano-disumano. Commissariati e prigioni nell’Europa di oggi, Roma-Bari, 1994. Fondamentale sempre E. Goffman, Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, New York, 1961 (trad. it. Asylums. Le istituzioni totali. La condizione sociale dei malati di mente e di altri internati, Torino, 1968). Circa l’attività della magistratura di sorveglianza, utili indicazioni negli scritti (di G. Ponti, S. Corsaro, P. Pirani e altri) leggibili in Serra (a cura di), Psicologia e giustizia, cit., pp. 139 sgg. Con riguardo agli ospedali psichiatrici giudiziari, A. Manacorda (a cura di), Folli e reclusi. Una ricerca sugli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari italiani, Perugia, 1988; Aa.Vv., Legislazione sanitaria e status del malato di mente. XI Congresso internazionale di legge e psichiatria, Firenze 18 marzo 1985, Firenze, 1985, pp. 79 sgg. Per notizie di carattere storico sul carcere, si rinvia a D. Melossi e M. Pavarini, Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario (XVI-XIX secolo), Bologna, 1977; E. Fassone, La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria, Bologna, 1980. (45) Si veda anche l’impostazione di Roehrssen, Gli handicappati nella Costituzione, cit., p. 468. (46) La letteratura sul consenso nei trattamenti sanitari è enorme: basterà qui un rinvio a 2134 PAOLO CENDON XXXVI Caferra, Diritti della persona e Stato sociale, pp. 85 sgg.; Rodotà, Repertorio di fine secolo, cit., p. 225; oppure A. Santosuosso, Situazioni giuridiche critiche nel rapporto medico-paziente: una ricostruzione giuridica, in Politica del diritto, 1990, pp. 181 sgg. Con riferimento al consenso nella sperimentazione sull’uomo, G. Ferrando, La sperimentazione sull’uomo, ibid., 1995, pp. 485 sgg. In generale S. Viciani, L’autodeterminazione « informata » del soggetto e gli interessi rilevanti (a proposito dell’informazione sul trattamento sanitario), in Rassegna di diritto civile, 1996, pp. 272 sgg. Sul diritto all’informazione per quanto concerne i soggetti handicappati, Bellanova, Commento agli artt. 7, 9-10, 24, 35 cit., p. 77. (47) Si vedano, in Cendon (a cura di), Un altro diritto per il malato di mente, cit., i contributi di M.G. Giannichedda (pp. 235 sgg.), di R. Ariatti, G. Ferrari e A. Fioritti (pp. 149 sgg.), nonché i rilievi di B. Norcio e V. Pastore (pp. 255 sgg.). (48) Assai preciso il quadro offerto da Venchiarutti, La protezione civilistica dell’incapace, cit.; oppure Aa.Vv., Diritto e psichiatria. Tutela giuridica del malato di mente e del disabile psichico. Carenze normative e proposte innovative, Milano, 1993. La legislazione relativa agli infermi di mente in Europa è analizzata in C. Louzoun (a cura di), Législation de santé mentale en Europe. La documentation francaise, Paris 1990; oppure Aa.Vv., Legislazione sanitaria e status del malato di mente, cit., pp. 11 sgg. Sulla perizia psichiatrica si veda (per i profili di ordine medico-sociale) M. G. Giannichedda e F. Ongaro Basaglia (a cura di), Psichiatria, tossicodipendenza, perizia. Ricerche su forme di tutela diritti, modelli di servizio, Milano, 1987. Un taglio attento alle questioni medico-legali in Fornari, Compendio di psichiatria forense, cit., pp. 3 sgg.; oppure Ponti e Merzagora, Psichiatria e giustizia, cit., pp. 17 sgg. Cfr. inoltre Aa.Vv., Legislazione sanitaria e status del malato di mente, cit., pp. 173 sgg.; M. Novello, in Cendon (a cura di), Un altro diritto per il malato di mente, cit., pp. 391 sgg. (49) Frequenti, poi, le sottolineature circa l’influenza tra riforme messe volta a volta in cantiere — riguardo ai vari istituti o gruppi di soggetti deboli — presso l’uno e l’altro Stato europeo. In particolare, quanto agli aspetti della legislazione manicomiale, cfr. la tavola rotonda in Cendon (a cura di), Un altro diritto per il malato di mente, cit., pp. 903 sgg. (dove interventi di F. Ongaro Basaglia, F. Fortini, F. Rotelli e S. Rodotà). Sui motivi peculiari della tutela del consumatore — nell’ottica delle influenze fra i singoli Paesi — si veda l’indagine comparatistica di N. Scannicchio, Consumatori e conclusione dei contratti a distanza tra ordinamenti nazionali, direttive comunitarie e diritto comparato, in Rivista critica del diritto privati, 1994, pp. 3 sgg. (50) Qualche riferimento in Alpa, Status e capacità, cit., pp. 41 sgg. Sui temi della giuridificazione con riguardo all’universo del diritto minorile, si vedano le considerazioni di M.R. Ferrarese, Giuridificazione e diritto minorile, in Politica del diritto, 1990, pp. 59 sgg. (51) Utili indicazioni in G. Maggioni (a cura di), Scienze sociali e diritto. Temi, tendenze e connessioni, Urbino, 1995. Si veda anche — a proposito della famiglia — il lavoro coordinato dello stesso G. Maggioni (a cura di), Come il diritto tratta le famiglie, Urbino, 1996. Quanto ai bambini, si rinvia ai saggi raccolti in Cendon (a cura di), Il bambino e le cose cit. Sui nodi della bioetica la letteratura è ormai vastissima. Un contributo di rilievo, fra i tanti, è quello di R.M. Knoppers, L’integrità del patrimonio genetico: diritto soggettivo o diritto dell’umanità?, in Politica del diritto, 1990, pp. 341 sgg.; oppure C. Ventimiglia, La bioetica problemi di definizione del campo e sue prospettive, ibid, 1992, pp. 115 sgg.; Kaufmann, Etica, cit., pp. 71 sgg.; E. D’Agostino, Gli interventi sulla genetica umana nella prospettiva della filosofia del diritto, in Rivista di diritto civile, n. 1 (1987), pp. 21 sgg.; A: Liserre, Il problema della regola nella ingegneria genetica, ibid. (1992), pp. 181 sgg.; nonché F. Bouquet, in Cendon (a cura di), Infermità di mente, cit., pp. 91 sgg. (in questo volume, riguardo alle manipolazioni genetiche, si segnala il contributo di M. Giacca e A. Falaschi, pp. 75 sgg., oltre alle puntualizzazioni di P.G. Monateri, pp. 81 sgg.). Di recente, P. Zaini, Verso un diritto per la bioetica: risorse e limiti del discorso giuridico, in Rivista di diritto civile, n. 1 (1995), pp. 43 sgg. (52) Per qualche rilievo, v. Zambrano, Eutanasia, diritto alla vita e dignità del paziente, in Rassegna di diritto civile, 1991, pp. 851 sgg. (53) Si vedano le osservazioni di E. Pellecchia e M. G. Armone, in Cendon (a cura di), XXXVI I DIRITTI DELLE PERSONE DEBOLI 2135 Handicap e diritto, cit., pp. 154 sgg. Sull’ipotesi di uno « Statuto dei diritti dei minori », si rinvia a M. Corsale, in Maggioni e Baraldi (a cura di), Cittadinanza dei bambini, cit., pp. 335 sgg. (54) Cfr. ad esempio F. Misticó, Commento agli artt. 17-22 (1997), in Cendon (a cura di), Handicap e diritto, cit., 1997, p. 288 (« ... la storia degli strumenti legislativi e degli interventi giurisprudenziali (sollecitati dalla laconicità e frammentarietà dei testi normativi) è quella di una coutinua frizione fra esigenze di economicità dell’impresa ed esigenze di tutela in favore delle fasce più deboli, fra l’esigenza del datore di lavoro di organizzarsi e dimensionarsi secondo le sue convenienze ed esigenza degli individui, affetti da una minorazione, di fruire di canali privilegiati per l’accesso al lavoro e per il mantenimosto di lavoro. Ma è anche la storia di una continua frizione fra assistenza e assistenzialismo, abusi e storture, e di una inadeguata gestione burocratica di tutto il sistema, al punto che la patologia applicativa torna oggi a mettere in discussione gli stessi principi informatori... »). (55) I termini essenziali della questione sono ben esposti da Caferra, Diritti della persona e Stato sociale, cit., pp. 33 sgg. Attenta pure l’analisi di Cafaggi e Galloni, Disciplina, cit., pp. 178 sgg. Con particolare riguardo all’inserimento scolastico dei bambini con gravi handicap, E. Pellecchia e G.M. Armone, in Cendon (a cura di), Handicap e diritto, cit., pp. 161 sgg.; Simonetti, Commento agli artt. 13-14, cit., pp. 197 sgg. In generale, Rodotà, Repertorio di fine secolo, cit., p. 24. Di taglio pubblicistico il rendiconto di A. Baldassarre, Diritti inviolabili, in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XI, Roma, 1989, p. 38. Da ultimo Bellanova, Commento agli artt. 7, 9-10, 35, cit., p. 76. (56) Riguardo alla malattia di mente, si veda — in particolare — la tavola rotonda (con interventi di G. Scabia, E. Roppo e R. Pardolesi) in Cendon (a cura di), Un altro diritto per il malato di mente, cit., pp. 525 sgg. (57) Cfr., sui fumetti, le considerazioni di E. Marigonda e A. Rezzara, in Cendon (a cura di), Il bambino e le cose, cit., pp. 212 sgg. (58) Con riguardo ai giocattoli, in generale, cit., il saggio di A. Rezzara, in Cendon (a cura di), Il bambino e le cose, cit., pp. 205 sgg. Sulla pubblicità che fa « male ai bambini », si vedano le argute osservazioni di R. Coco, La pubblicità che fa « male » ai bambini, in Rivista critica del diritto privato, 1996, pp. 693 sgg. (59) In merito alla sessualità dei bambini — anche dal punto di vista del diritto — si vedano (con tagli diversi) le osservazioni di P. Zanier e quelle di R. Lanzillo, in Cendon (a cura di), I bambini e i loro diritti, cit., rispettivamente alle pp 137 sgg. e 143 sgg. (60) Sul diritto privato come luogo in cui « meglio e più profondamente si può cogliere la possibilità di una concreta ed effettiva tutela dei soggetti cosiddetti deboli », cfr. Marinelli, La tutela civile dei soggetti deboli, cit., p. 155. (61) In generale Roehrssen, Gli handicappati nella Costituzione, cit., p. 468 (il quale sottolinea che « ciascuno di noi deve dimenticare le differenze che possono esistere con altri consimili, deve nella vita quotidiana, in qualsiasi manifestazione, grande e piccola, di questa vita, guardare agli handicappati come a soggetti che ci sono in tutto simili, non far pesare in nessun modo e per nessuna ragione la loro inferiorità, fisica o, peggio ancora, intellettuale. Vorrei dire che si tratta senza meno di una norma di comportamento, di una regola etica e, quindi, maggiormente impegnativa »). (62) Cfr. E. Pellecchia, in Cendon (a cura di), Handicap e diritto, cit., p. 269 (« ... il vero nodo teorico — di particolare interesse per il giurista — consiste, infatti, non tanto nel dare una risposta ‘diversa’ ai ‘diversi’, quanto nell’elaborare un’idea di eguaglianza che tenga conto della differenza senza negarla, ma anche senza necessità di stigmatizzarla »). (63) Si vedano i rilievi di Baldassarre, Diritti sociali, cit., pp. 6 sgg. (64) Cfr. F.D. Busnelli, Diritti umani e civiltà giuridica. Riflessioni di un civilista, in Rassegna di diritto civile, 1991, pp. 243 sgg. e 249. (65) In generale, M. Luciani, Sui diritti sociali, in R. Romboli (a cura di), La tutela dei diritti fondamentali davanti alla Corte costituzionale, Torino, 1994, pp. 81 sgg.; S. Panunzio, Il cittadino handicappato psichico nel quadro costituzionale, in Rassegna di diritto civile, 1986, pp. 361 sgg. Per 2136 PAOLO CENDON XXXVI qualche considerazione, da ultimo, Eichenhofer, L’utilizzazione del diritto privato, cit., pp. 193 sgg. (66) Ancora attuali i passaggi di molti contributi in F.D. Busnelli e U. Breccia (a cura di), Tutela della salute e diritto privato, Milano, 1976. Di recente, un ricco panorama in Mariotti, Misaraki e Rizzi, I diritti dei malati, cit. Si vedano anche gli scritti raccolti in Aa.Vv., I dieci anni della 180, cit. Sul diritto alla cura dell’handicappato, Bellanova, Commento agli artt. 7, 9-10, 35, cit., pp. 62 sgg. Quanto alla responsabilità del medico, con ampiezza, cfr., M. Barni e A. Santosuosso (a cura di), Medicina e diritto. Prospettive e responsabilità della professione medica oggi, Milano, 1955. A proposito dei servizi sanitari, un utile specchio riassuntivo in Zucchetti, I servizi sanitari, cit. Per un confronto fra gli orientamenti legislativi delle nostre regioni — in materia di tutela dei diritti del malato — A. Musumeci, Gli orientamenti legislativi regionali in materia di tutela dei diritti del malato, in Politica del diritto, 1990, pp. 329 sgg. (67) Assai ampia l’analisi di F. Ruscello, L’istruzione tra scuola e famiglia. Tecniche di tutela della persona, Napoli, 1992. Cfr. pure Carfaggi e Galloni, Disciplina, cit., p. 168. (68) Qualche osservazione in Mariotti, Misaraki e Rizzi, I diritti dei malati, cit., pp. 225 sgg. Si veda altresì il rendiconto di G. Orrù, in Lombardi Vallauri (a cura di), Il meritevole di tutela, cit., pp. 947 sgg. Circa le questioni giuridiche legate alla tutela del cadavere, cfr. la recente indagine di U. Nannini, Valori della persona e definizione legale di morte, Padova, 1996. In generale, sul corpo « giuridificato », S. Rodotà, Ipotesi sul corpo « giuridificato », in Rivista critica del diritto privato, 1994, pp. 467 sgg. (69) Cfr. soprattutto le considerazioni di Cafaggi e Galloni, Disciplina, cit., pp. 159 sgg. In generale Roehrssen, Gli handicappati nella Costituzione, cit., p. 469 (e ibid., p. 474, rilievi sull’opportunità di controllare che differenze di sensibilità legislativa, fra le varie regioni, non si traducano in diversità eccessive nel trattamento di disabili dello stesso tipo; sul punto, di recente, Bellanova, Commento agli artt. 7, 9-10, 35, cit., p. 72). (70) Circa il « diritto alla bellezza », si veda a saggio di I.A. Goffredo, in Lombardi Vallauri (a cura di), Il meritevole di tutela, cit., pp. 435 sgg. (71) Particolarmente attuali le pagine di P. Zatti, in Cendon (a cura di), Un altro diritto per il malato di mente, cit., pp. 107 sgg. (ad esempio, p. 120: « Il diritto del malato può non essere quello al libero svolgimento della personalità, ma dov’essere quello al massimo svolgimento della personalità. Egli ha diritto a essere assistito in modo da non dimenticare i suoi diritti »). Sulle insufficienze di una linea che vede i soggetti deboli come « oggetto » degli interventi normativi — e sulla necessità di una valorizzazione per i momenti creativi e partecipativi delle persone in difficoltà — cfr. Rodotà, Intervento, cit., pp. 489-90 (« Sembra evidente che l’intervento legislativo debba essere orientato in modo da cancellare le caratteristiche assistenziali, a vantaggio di quelle dell’inserimento pieno nella comunità. Questo può avvenire solo a patto di non considerare l’handicappato come ‘oggetto’ degli interventi, che è poi la caratteristica vera della logica assistenziale: e, per far ciò è necessario, ad esempio, che la gestione di specifiche strutture di servizio sia affidata nel modo più largo possibile agli stessi interessati. Solo così può essere superata l’ottica che impone di vedere in taluni servizi il simbolo stesso di una condizione separata, dal momento che l’impegno diretto nella gestione porta almeno ad impadronirsi dei nessi che legano lo specifico servizio all’insieme delle strutture pubbliche, rendendo così partecipi di una comune impresa di gestione della ‘cosa pubblica’ »). (72) Cfr. Le considerazioni di Santosuosso, Situazioni giuridiche critiche nel rapporto medico-paziente, cit., pp. 181, sgg. (73) In merito ai problemi dell’incesto, si veda per tutti D.E. Russell, The Secret Trauma. Incest in the Lives ol Girls and Women, New York, 1986. (74) Fra i nostri giudici, con vari accenti, Pret. Roma, 4 giugno 1980, in Giustizia civile, I (1980), pp. 1990 sgg.; Tar Abruzzo, 3 ottobre 1984, in Foro amministrativo, 1985, p. 260; Pret. Milano, ord. 21 agosto 1984 e ord. 12 ottobre 1984, in Foro italiano, I (1985), pp. 1865 sgg.; Trib. minorenni, 23 febbraio 1984, in Rassegna di diritto civile, 1986, p. 221. Per un attento riesame della questione, di recente, A. Venchiarutti, Commento agli artt. 1-5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (1997), in Cendon, (a cura di), Handicap e diritto, cit., pp. 14 sgg. Significativa, da ultimo, XXXVI I DIRITTI DELLE PERSONE DEBOLI 2137 l’ord. 23 maggio 1997 del Tribunde di Roma, in cui — dopo essersi rilevato che i carrelli elevatori per le carrozzelle dei disabili motori, quali utilizzati attualmente nelle stazioni italiane, non hanno dimensioni tali da consentire l’accesso a treni come l’Etr 450 (Pendolino), le cui porte sono più strette di quelle normali — si è stabilito che la s.p.a. Ferrovie dello Stato debba provvedere a modificare tali carrelli nelle principali stazioni ferroviarie del nostro Paese. (75) Sempre utile — circa la responsabilità pende degli operatori psichiatrici — la lettura dei contributi (di F. Bricola, G. Fiandaca, A. Manacorda, N. Mazzacuva, G.B. Traverso e M. Portigliatti Barbos) raccolti da A. Manacorda (a cura di), Tutela della salute mentale e responsabilità penale degli operatori, Perugia, 1989. Per i profili di responsabilità civile, si rinvia alle analisi coordinate da Cendon (a cura di), Infermità di mente, cit. Lucidamente G. Cattaneo, in Cendon (a cura di), Un altro diritto per il malato di mente, cit., pp. 217 sgg. (76) Per una riflessione sul suicidio — soprattutto nella prospettiva di un possibile risarcimento del danno (da far gravare sulle cosiddette istituzioni « cattive ») — cfr. ampiamente L. Gaudino, Condotte autolesive e risarcimento del danno, Milano, 1995; oppure Cendon e Gaudino, Colpa vostra se mi uccido, cit. Più in breve Mariotti, Misaraki e Rissi, I diritti dei malati, cit., p. 133. Significativo pure il contributo di L. Ravizza, in Villa (a cura di), La violenza interpretata, cit., pp. 79 sgg. In generale R. Marra, Suicidio, diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale, Napoli, 1987. Quanto all’inflizione di disturbi mentali ad opera di un terzo, cfr. — sempre nell’ottica di una possibile tutela risarcitoria per la vittima — P. Cendon e G. Citarella, Anime folli. Disagio psichico, danno e riparazione, Venezia, 1997. (77) Sui rischi del formalismo — anche in sede di metodologia degli interventi — si veda per tutti Rodotà, Intervento, cit., p. 478 (« Non basta proclamare che tutti sono eguali davanti alla legge (anche se questa affermazione costituisce un indispensabile punto di partenza): bisogna far sì che questa eguaglianza da formale diventi sostanziale. Per ciò il tradizionale diritto eguale non è più sufficiente: occorre un diritto diseguale, nel senso di discipline giuridiche che, riconoscendo nei fatti la situazione di disparità in cui si trovano gruppi di cittadini, introducano strumenti specificamente diretti al superamento di tali discriminazioni »). (78) Cfr. P. Zatti, Infermità di mente e diritti fondamentali della persona, (1988), in Cendon (a cura di), Un altro diritto per il malato di mente, cit., p. 109 (« Potrei uscire, s’intende dandone notizia, dal reparto? Sarebbero le porte chiuse o aperte? Avrei con me i miei documenti, i miei vestiti, le mie scarpe? Potrei tenere le mie cose sottochiave, al riparo dagli altri pazienti e dal personale? Potrei chiudermi nel bagno? Dovrei forse sottostare a ispezioni, o vivere sotto l’occhio vigile di un osservatore umano o elettronico? Potrebbe succedermi d’essere ripreso, a mia insaputa o senza il mio consenso, in foto o film magari a scopo didattico o scientifico? Potrei ricevere, chiusa, la mia corrispondenza, e se scrivessi, sarebbe segreto almeno il contenuto dei miei messaggi? Ci sarebbe un telefono, laggiù, e lo potrei usare? Potrei farmi portare giornali e libri a mia scelta? E se avessi una radio, la potrei ascoltare? Potrei ricevere visite, e potrei star solo quando lo volessi? E poi: sarei in grado di rifiutare un farmaco o un trattamento? Potrebbe qualcuno toccarmi senza che io lo volessi, prendermi, portarmi a forza qui o là, spogliarmi o rivestirmi senza che io possa ribellarmi? Deciderei con voi qualcosa, o sarei solo suddito delle vostre decisioni? Potrei far venire il mio medico, e sarebbe ascoltato? Se non riusciste a curarmi, potrei cambiare, cercare altri medici e altri reparti? Che verità mi direste sul mio stato, e che cosa sarei in grado di capire? Se tutto fosse o sembrasse inutile, mi tratterreste soltanto per qualche ragione di sicurezza? Provereste davvero a guarirmi, o vi limitereste a custodirmi? »). (79) Cfr. ancora Zatti, Infermità di mente, cit., p. 119 (« Intendo dire, per essere concreto, che il diritto all’integrità fisica non andrà concepito come il diritto a non essere toccati, iniettati o nutriti senza consenso. Certo, anche questo, finché possibile alla luce di quel famoso ‘purché’ della necessità terapeutica; ma il diritto all’integrità fisica va concepito anche come diritto a essere puliti, cambiati, ben vestiti, pettinati, di piacevole aspetto, di gradevole odore; come il diritto ad essere mantenuti nella capacità di aver cura di sì, ad essere convinti ed aiutati a farlo e infine, se necessario e compatibile con le possibilità terapeutiche, condotti o costretti a farlo. Il diritto all’informazione non va concepito solo come il diritto a poter vedere la televisione o a leggere il giornale ricevuto o raccattato, ma come il diritto ad avere gli strumenti per informarsi e ad essere 2138 PAOLO CENDON XXXVI sollecitato a mantenersi informato, a conservare, nei modi possibili del rispetto alla malattia, la curiosità e l’interesse per gli avvenimenti del mondo. Il diritto alla corrispondenza non significa diritto a ricevere le lettere dei parenti, e a riceverle chiuse, e a spedire lettere a chi si voglia; significa diritto a che i rapporti epistolari siano mantenuti incoraggiati e sollecitati, da parte del paziente, dei suoi familiari, degli amici di un tempo; significa, se necessario, diritto allo scrivano. Il diritto alla intimità e alla riservatezza significa non solo diritto a non essere violato senza causa nel riserbo, nel pudore, nella piccola signoria sugli oggetti personali, ma diritto ad essere sollecitato al pudore e al riserbo, diritto ad essere convinto, aiutato, se mai costretto a mantenere comportamenti di pudore e di riserbo »). (80) Sulla formazione degli assistenti sociali, è sufficiente un rimando agli scritti raccolti da S. Giraldo e E. Riefolo (a cura di), Il servizio sociale: esperienza e costruzione del sapere, Milano, 1996. Istruttive altresì (a proposito degli operatori dei servizi pubblici chiamati a lavorare con i tossicodipendenti) le indicazioni fornite da R.C. Gatti, Lavoratore con i tossicodipendenti. Manuale per gli operatori del servizio pubblico, Milano, 1993. Con riguardo agli infermieri psichiatrici, vedi gli scritti presentati in Graziosi, Rebecchi e Spinedi, Psichiatria senza manicomi, cit., pp. 627 sgg. (81) I riferimenti essenziali sono leggibili in Breda e Santanera, Handicap, cit., pp. 148 sgg.; oppure M. Gorgoni, Commento agli artt. 23-28, in Cendon, (a cura di), Handicap e diritto, cit., pp. 332 sgg. Sull’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, cfr. la legge 9 gennaio 1989, n. 13. (82) Qualche dato in Aa.Vv., I dieci anni della 180, cit. (83) Su queste ultime, si vedano i dati forniti da A. Mattioni, E. Codini, A. Colombo e A. Fossati (a cura di), Le leggi della solidarietà. Commento coordinato della legge sul volontariato e sulle cooperative sociali, Milano, 1993. In generale O. De Leonardi, D. Mauri e F. Rotelli, L’impresa sociale, Milano, 1994. Qualche rilievo in Breda e Santanera, Handicap, cit., pp. 191 sgg. Interessanti ari che i saggi (di D. Gasparrini Pianesi, G. Canavesi, D. Lucarini Ortolani, M. Seri) raccolti in P. Olivelli (a cura di), La disciplina giuridica del volontariato e delle cooperative sociali, Ancona 1995. Sul volontariato, in particolare, il testo di v. Italia, Il volontariato. Organizzazioni, statuti e convenzioni, Milano 1992. Per i profili civilistici, istruttivi i contributi (fra cui quelli di M. Basile, A. Fusaro, G. Marasà, P. Rescigno, P. Schlesinger, M. Stalteri, A. Zoppini) raccolti in G. Ponzanelli (a cura di), Gli enti « non profit » in Italia. Associazioni, fondazioni, volontariato, trust, fondi pensione, Padova, 1994. Un commento della legge 266/1991, in A. Panico e A. Picciotto, La legge quadro sul volontariato. L. 11 agosto 1991, n. 266, Napoli, 1992. Cfr. pure F. Angeloni, Liberalità e solidarietà. Contributo allo studio del volontariato, Padova, 1994. Da ultimo, G. Ponzanelli, Quali regole giuridiche per il terzo settore?, in Rivista di diritto civile, n. 2 (1996), pp. 313 sgg. Sulle ragioni generali devo Stato sociale, succintamente, v. M. Caferra, La giusta disuguaglianza. Dalla nomenclatura alla nuova Repubblica, Roma-Bari, 1994, pp. 153 sgg. (84) Cfr. Zatti, Verso un diritto per la bioetica, cit., p. 45. (85) Qualche rilievo in Bellanova, Commento agli artt. 7, 9-10, 35, cit., p. 104 (« A questi interrogativi il legislatore del 1992 non ha risposto; e — per nulla imbarazzato — è riuscito a far convivere scaglie normative palesemente conflittuali tra loro. Indicativa, peraltro, l’inflazione di principi e di finalità in questa legge: si sa che i principi nulla costano di per sé. Ma quando, poi, ha dovuto — perché non poteva altrimenti — confrontarsi con problemi organizzativi ed operativi, lo spirito umanitario si è attenuato, condizionato dalle ferree leggi dell’economia, dalla paura di compromettere — in caso di ritocchi dei libri contabili delle pubbliche amministrazioni — il sostegno di quei cittadini che, effettivamente, producono tra l’altro un sostegno politico consistente). (86) È sufficiente un rimando alla bibliografia fornita da Gaudino, Condotte autolesive, cit. (87) Sulle mutilazioni sessuali, indicativi i dati offerti da E. Cirillo, Una violenza in più: la salute delle donne e le mutilazioni sessuali, in Politica del diritto, 1992, pp. 149 sgg.; nonché U. Khalif Mohamed, Una pratica millenaria: conoscerla per sconfiggerla, ibid., pp. 153 sgg. Quanto alla sterilizzazione, si veda M. Paradiso, La sterilizzazione umana tra problemi giuridici e presupposti antropologici, in Rivista di diritto civile, n. 1 (1992), pp. 505 sgg. (88) La letteratura in proposito è pressoché sterminata. Una sintesi accurata degli XXXVI I DIRITTI DELLE PERSONE DEBOLI 2139 orientamenti giurisprudenziali in Italia è offerta da M. Franzoni, Il danno alla persona, Milano, 1995. (89) Si vedano, sotto il profilo non patrimoniale, le considerazioni di P. Ziviz, Alla scoperta del danno esistenziale, in Aa.Vv., Scritti in onore di Rodolfo Sacco, II, Milano, 1994, pp. 1996 sgg. (90) Espinoza Espinoza, Tutela giuridica dei soggetti deboli, cit., pp. 425 sgg. (91) Un esempio istruttivo è quello della disciplina fornita — per i contratti posti in essere dall’incapace naturale — dall’art. 428 cod. civ. In effetti, una volta che la malafede di cui al comma 2 di questa norma venga intesa come le nostre Corti hanno spesso ripetuto, quale riconoscimento puro e semplice dello stato di incapacità (e non già quale approfittamento, ad opera del partner dell’infermo psichico), e una volta poi che si individui nella malafede la condizione sufficiente per l’impugnabilità del contratto (anche qui secondo una ricostruzione rispettosa della lettera della norma, e prevalente pure nella giurisprudenza), il risultato cui si approda è certamente quello di un’ampiezza notevole nelle possibilità di impugnativa, ma è pure quello di una grande insicurezza tendenziale (presso il partner dell’infermo) circa la solidità e definitività dello scambio contrattuale che è stato concluso. Ove il patto sia economicamente equilibrato, o addirittura vantaggioso per l’infermo, c’è da immaginare che difficilmente l’incapace deciderà successivamente di impugnarlo, ma è pur sempre una previsione destinata a muoversi su un terreno di fatto; d’altro canto, fino a che punto il partner può davvero sentirsi tranquillo che la propria controparte, che egli sa essere disturbata psichicamente, obbedirà per l’avvenire ai suggerimenti della convenienza e della logica? Di qui — in conclusione — il pericolo che in non poche situazioni l’incapace naturale, una volta che il partner l’abbia riconosciuto come tale, si veda rifiutato a priori l’accesso al contratto ». Sotto un profilo più ampio, si vedano, le considerazioni di Eechenhofer, L’utilizzazione del diritto privato, cit., p. 211, il quale sottolinea che « il diritto privato utilizzato a scopi di politica sociale a causa del suo carattere di privilegio può recare svantaggi a coloro alla cui protezione mira », e rileva poi, a titolo di esempio, che « una tutela completa della maternità o degli handicappati che sia completamente a carico del datore di lavoro, diminuisce le possibilità di mercato di quei soggetti protetti. Infatti la loro controparte contrattuale non vorrà correre il pericolo di essere più obbligato di altri verso la parte contrattuale ‘debole’. Il carattere di privilegio del diritto privato utilizzato a scopi di politica sociale comporta quindi per il soggetto protetto, in ultima analisi, uno svantaggio ». (92) Si veda il numero monografico La tutela giudiziaria dei soggetti deboli (con interventi di G. Calcagno, M. Guida, M. Brienza, E. Ceccarelli, P. Prat, A. Scarpulla, A. Vaccaro, L. Petrone, G. Marcazzan, M. Dellacasa, I. Cesari, M.G. Ruggiano, G. Ausli, D. Sciré, V. Loffredo, L. Lenti, L. Del Conte e altri), in Minori giustizia, n. 4 (1993). (93) Un efficace bilancio di questi ultimi anni in E. Amato, Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno. Incertezze legislative, itinerari giurisprudenziali e proposte della dottrina, in Rivista critica del diritto privato, 1993, pp. 101 sgg. (94) Cfr. ampiamente M.R. Marella, L’integrazione sociale delle persone sociali fra normalità e differenza. (In margine all’art. 8 della legge-quadro sull’handicap), ibid., 1994, pp. 183 sgg. (95) Per un’accurata sintesi, si veda la monografia di Venchiarutti, La protezione civilistica dell’incapace, cit. (96) Sul significato di community care, e sulla necessità di un’integrazione fra reti formali e informali di sostegno, cfr. i rilievi di Bellanova, Commento agli artt. 7, 9-10, 35, cit., pp. 112 sgg. (« La nuova frontiera sociale è data dall’abbandono dell’alternativa Stato/mercato, entro la quale si frantumava l’esistenza, per un sistema complesso, fatto di interrelazioni tra operatori, la cui forza di incidenza dovrà essere rapportata alla misura di coordinamento che si potrà creare fra i servizi di coordinamento e quelli offerti dal mercato, dal cosiddetto terzo settore (per esempio, il volontariato) e dalla famiglia con le sue reti informali »).
Scarica