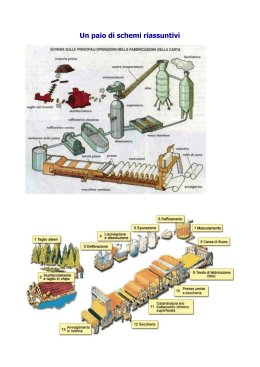Rablon e altre storie Alessandro Marenco Editoriale “Le Stelle”, Cengio (SV) Natale 2010 2 Ho messo insieme queste storie e l’ho stampate per fare un regalo ad un amico, un pensiero augurale per le feste e per i giorni a venire. Non sono riuscito a fare in tempo. L’ho stampato lo stesso, sotto l’ala protettiva de “Le Stelle”, lo spazio nel quale ci siamo conosciuti e abbiamo condiviso alcune cose. Naturalmente a Davide. 11 dicembre 2010 3 4 Metafora in forma di dedica Il contadino s’interessa del bosco. La sua casa è sul confine: alle spalle gli alberi aggrappati alla costiera del colle, davanti a sé i campi, l’orto e più in basso il fiume. Il contadino sulla porta ogni mattina guarda i suoi campi, poi volge lo sguardo a sud per scorgere una certa nuvola che gli indica il tempo che farà, infine comincia il suo incessante lavoro, con calma e metodo. Talvolta sale nel bosco, non lo fa mai come passatempo, ma sempre con un motivo preciso. Taglia la legna per scaldarsi, prepara le fascine, taglia altra legna per avere pali da costruzione, taglia ancora altra legna da portare in segheria e farne tavole, da cui un amico falegname trarrà una madia, un tavolo, una credenza. Nella stagione propizia raccoglie funghi, in quella adatta caccia la selvaggina. Più raramente raccoglie le fragole selvatiche, i mirtilli, un paio di piccole aspre ciliegie. Con il bosco ci vive, gli serve e gli è comodo. Per questo, come tutti i contadini, abita il bosco. Lo ripaga visitandolo con occhio critico, mantenendo pulito un sentiero, libera una fonte, raccogliendo foglie secche da gettare sotto alle vacche nella stalla. Senza mai depauperare, con senso e misura, nel suo interesse. 5 Il contadino nel bosco guarda le piante ma non vede alberi. Vede la possibilità di mangiare una mela, una prugna, oppure vede un tavolo, o anche una serata al caldo in casa, mentre fuori nevica. Di ogni pianta sa le proprietà, le aspirazioni e le reali possibilità di riuscita. Questo pollone di castagno è proprio inutile: non da pali, troppo storti; non da bruciare, o almeno non quanto la rovere; non da lavoro: è incipollito come tutti i castagni da questo versante. Laggiù c’è una rovere, grande e armoniosa: è cresciuta bene fra la luce e in un pezzo di terra adatta e fornita, sotto i suoi rami è facile trovare funghi dalla testa nera come la notte. Al contadino non verrebbe mai in mente di tagliarla. Mentre ce n’è un’altra poco più su, ancora più grande, che è stata curata, potata e osservata nella crescita, ed è ora di tagliarla e coi rami scaldarsi e il tronco segato in panconi sarà un mobile, o sarà venduto, dipende dall’occasione. Ci sono, sparsi un po’ dappertutto, minuti alberi da frutto, sgraziati e sofferenti, piccini. Soffocati dalla maestà delle altre piante. Nella stagione adatta il contadino li innesta, poi li osserva anno per anno. Non parte da casa apposta per innestare, non è un lavoro abbastanza produttivo da poter essere fatto da solo. Mentre passa vede una pianta che potrebbe essere valida. Appresso ha le tessere, le marze da innesto, perché il lavoro del contadino è essere previdente. Ha il coltellino apposito in tasca, taglia, incide, sbuccia, inalbera, fascia, lega, prosegue. Non fa caso a quante ne fa. Le piante che gli sembrano belle le arricchisce. Poi ripassando, nella cadenza delle stagioni, osserva. L’anno seguente dove ha innestato taglia il ceduo, dando aria alla pianta innestata che ha preso bene. L’anno dopo, o quello dopo ancora, o magari dopo tre, quattro anni, tutte le sue informazioni, le sue conoscenze, la sua esperienza lo premiano: si trova lontano da casa, ha lavorato, cacciato o camminato da diverse ore. Ha fame e sete e quella piantina stenta di cui s’era preso cura ora lo ripaga 6 con una manciata di ciliegie, un paio di prugne, due mele, una pera… E il bello è che si tratta di quel gusto preciso di quella tale qualità di frutta da cui ha preso una tessera, magari una pianta a cui teneva particolarmente. E il bello, ancora, è che quella pianta fruttifera non lo arricchirà mai, e la copiosità dei frutti magari sarà vista dalle generazioni a venire, e infine quei frutti non saranno mai riservati e in esclusiva per un certo clan o per una famiglia o per un gruppo sociale identificato, ma serviranno al viandante, all’assetato e affamato, occasionalmente o strutturalmente. Tutto questo il contadino fa per migliorare il mondo in cui vive. Così è accaduto anche a me, come persona. Sono cresciuto in un boschetto vago, nutrito di buona terra. Sono riuscito a radicare sufficientemente, ma non vedevo abbastanza luce e per trovarla ho cominciato a contorcermi. Davanti a me è comparso un professore. Mi ha valutato, pianta fra le altre piante, vedendoci qualcosa di degno, come a molti altri. Mi ha posto un tutore, legato senza troppi vincoli, perché possa svilupparmi secondo l’estro e la natura. Ha sfrondato gli alberi intorno a me, mostrandomi UNA via, delle diverse possibili. Ha continuato a tenermi d’occhio per molto tempo. Poi ha deciso anche di innestarmi qualcosa di più domestico, che produca frutti un po’ più ricercati e piacevoli, strutturati e utili. Ha ancora aspettato per vedere come si combinasse il tutto, e sono certo di non essere mai stato il solo. Alla fine qualcosa è uscito. Non si tratta di nulla di glorioso, indimenticabile o colossale. Si tratta di un paio di ciliegie poco meno che selvatiche. Ma i merli se ne nutrono e così possono fischiare i loro complicati fraseggi fra i cespugli. Il professore stesso se ne nutre, a volte, quando cammina (il vero professore non passeggia: cammina, proviene da un certo posto ed è destinato in un altro) sulla strada del ritorno e s’accorge d’aver sete e di aver terminato l’acqua nella borraccia. 7 Il professore può camminare nel bosco per ore (magari sta tornando dalla Russia…), senza bisogno di portarsi nulla: ha innestato e curato piante di diversi tipi e ora può allungare una mano e trovare sollievo nel lavoro che ha fatto. Altre piante sono cresciute dritte adatte per lavoro, altre ancora saranno utili da bruciare. Il professore si chiama Davide Montino, ed è a lui che dedico questo piccolissimo, asperrimo frutto. Io albero (fra gli altri) e lui contadino, per continuare. 8 Rablon La produzione era finita per la una dopo mezzanotte. Gli addetti alla sala macchine avevano cominciato a spegnere i servizi, per cui un vago silenzio aveva invaso tutte la sale di lavorazione. Chi aveva finito di lavare e riordinare aveva spento la luce, anche quella rossa, e il corridoio di accesso a questi opifici era più buio del solito. La qualità era stata abbastanza buona per tutta la settimana, non c’erano stati scarti e tutte le produzioni avevano rispettato grossomodo la tabella di marcia appesa in bacheca il venerdì pomeriggio precedente. Il capoturno non avrebbe avuto niente da obbiettare se, dopo aver terminato di lavare e riordinare gli attrezzi, ci fossimo intrattenuti al punto fumo, anche noi ultimi arrivati. Gli anziani erano già tutti ai loro posti: chi in mensa per una frugale colazione, chi rintanato nello spogliatoio a dormicchiare sognando vacche, aratri, legna da tagliare; chi ancora con qualche giornale o libro in mano a cercare un posto adatto per aspettare giorno. Io a quel tempo fumavo molto e mi piaceva starmene al punto fumo con gli anziani, ascoltare i loro discorsi, le loro avventure; mi piaceva aspirare il fumo delle nazionali semplici, delle alfa. Poi l’ora tarda e il silenzio davano un che di magico all’ambiente. Non eravamo più in fabbrica: eravamo intorno a un caminetto, eravamo marinai appena tornati in porto, cacciatori appena rientrati dal bosco. Tale è l’uomo quando sente la 9 voglia di raccontare ed immedesimarsi, e soprattutto credere ciecamente a quello che gli viene narrato. Dopo varie considerazioni sul lavoro o su qualche incidente di produzione, dopo aver parlato della propria campagna o dei propri ricordi c’era sempre qualcuno che tirava fuori la storia di Rablon. In genere cominciava così: «Tè non l’hai conosciuto Rablon, neh?». Ora, io questa storia l’ho sentita almeno una ventina di volte, raccontata da venti persone diverse e approssimativamente coincide. La cosa strana è che non mi sono mai stancato di sentirla, ed ogni volta che partiva l’annuncio rispondevo che no, non l’avevo conosciuto, in quanto giovane, appena entrato e ignaro del duro mondo dei “vecchi” di Ferrania. Rablon, innanzi tutto, è parola del dialetto valbormidese che vale letteralmente “grande oggetto trascinato” (dove rablé vale in dialetto ‘trascinare’) e che significa “spartineve”, ovviamente quel tipo di spartineve antico, costruito in legno e che veniva attaccato e trascinato dalle bestie, come un aratro. Naturalmente non era efficace come uno sgombraneve moderno, ma c’è da dire che funzionava egregiamente per creare un varco in strati di neve alti, e soprattutto non circolando automobili, in quei tempi e in quei posti, era più che sufficiente. Nel suo lasciarsi trascinare il “rablon” ondeggiava sulla sua traiettoria e siccome peso e forza trainante non mancavano succedeva ineluttabilmente che facesse danni a quel che trovava ai lati della sua strada, come oggi ancora succede spesso con gli spazzaneve. A questo potere penetrante e dannoso non per dolo, Rablon doveva il suo soprannome. Ricordiamo, a titolo di curiosità, che esistevano numerosi altri soprannomi: L’Unico, Puntura, Ciccio, Micio, Jack, Pupetto, Verme, Bombardini, Testabianca, Bush, Cinghialista, Sarvò (selvatico), Polifemo, Comune, Minestrina. 10 Anzitutto Rablon era noto per la condizione fisica eccellente. Mangiava e beveva senza problemi di sorta. La leggenda vuole che ponesse regolarmente un secchio di acciaio inox (corredo di produzione) sotto una flangia di collegamento con l’autobotte che scaricava mensilmente l’alcool etilico. La flangia perdeva qualche goccia, la quale finiva nel secchio. Al termine del trasferimento Rablon si presentava a riscuotere quel mezzo bicchiere d’alcool al 94% che si trovava in fondo al secchio. E pare che se lo bevesse direttamente da lì, seduta stante. Si narrava però un episodio ancor più raccapricciante. Rablon aveva una passione sviscerata per il vino. Per una bottiglia avrebbe fatto qualsiasi cosa, questo almeno andava dicendo. Qualcuno prese la palla al balzo e gli offrì un cicchetto, un bicchierino da rosolio, pochi centimetri cubici, di gasolio per autotrazione. Se l’avesse bevuto avrebbe ricevuto in dono una bottiglia di nero. Pare che chi stesse proponendo il patto non abbia fatto in tempo neppure ad alzare ed offrire il cicchetto: Rablon glielo strappò di mano e cacciò giù per la gola, reclamando subito dopo il saldo della scommessa, per cui la bottiglia venne regolarmente pagata. Con questa favolosa aurea Rablon viveva di rendita, era diventato un personaggio, di lui si parlava sottovoce, chi voleva ingraziarselo gli offriva bicchieri di vino, assaggi, degustazioni. Lui accettava. Siamo negli anni Cinquanta. La fabbrica lavorava a pieno regime. Era invalso l’uso di lavorare indossando tuta di cotone, bustina bianca e zoccoli di legno ai piedi. Questi calzari dovevano essere abbastanza alti e semi impermeabili, dato che l’acqua si usava regolarmente per le lavorazioni e per la pulizia degli impianti. Anche gli zoccoli potevano diventare un’occasione di scherzo: a Testabianca, che li abbandonava sempre sull’assito di tavole della sala, in prossimità della scaletta sulla quale sedeva per calzarli, qualcuno li aveva inchiodati saldamente, senza spostarli da come erano stati abbandonati. A Sleppa, che li lasciava sotto 11 il grigliato, erano stati riempiti a fine turno di acido nitrico al 36%. Il giorno dopo li aveva appena sfiorati per indossarli e questi s’erano distrutti come pare facciano certe mummie vecchie di migliaia di anni appena scoperte. A Rablon fu proposto di bere una bottiglia di vino tutta in un colpo, a sorsi, ma tutta assieme. Che problema c’è? Si stupì sdegnato. Si ma, gli dissero, devi berla nel tuo zoccolo. Pronti: la calzatura in mano, la bottiglia nell’altro, vuotò in poche versate tutta la bottiglia, alla salute degli astanti increduli. Porse il “calice” nell’atto di offrire, ai colleghi presenti, ma nessuno ebbe animo di accettare. Sempre di Rablon si narra che fosse particolarmente abile nell’organizzare gli scherzi. Minestrina, per esempio, era assai affascinato dal denaro, per i soldi avrebbe fatto qualsiasi cosa. Rablon gli propose un giochino. Uno sgabello, una banconota e una benda. Il gioco consisteva nel far cadere la banconota posta sullo sgabello, ma lui avrebbe dovuto essere bendato. Se la banconota avesse toccato terra entro un dato tempo, allora Minestrina se la sarebbe intascata. Dopo alcuni tentennamenti e la vista diretta della banconota, la vittima accettò. Si pose sgabello e denaro, si pose la benda. Si diede il via. Minestrina soffiava, ogni tanto chiedeva: a che punto sono? È cascata? C’è ancora? Quasi! Quasi! Forza che ci sei! Tutti lo incitavano. Intanto Rablon si era messo in piedi con le terga all’altezza del getto d’aria, calato brache e mutande e si godeva evidentemente il venticello sulle pudenda. Tutti si trattenevano allo spasimo, ma alla fine qualcuno rise. Minestrina percepì che qualcosa non andava, scostò la benda e naturalmente andò su tutte le furie, scagliando verso Rablon e verso il folto pubblico qualsiasi cosa gli passasse per le mani. 12 Ma una delle avventure più divertenti di Rablon è quella che lui stesso ha raccontato, durante una notte come quella di cui io ho già parlato, ad altri colleghi. Lui era nato contadino, aveva sempre lavorato nel bosco o nei campi. Venne la guerra, e per forza dovette partire. Dopo l’addestramento fu destinato in Africa. Breve: venne catturato dagli inglesi e destinato in un campo di prigionia. Recluso, Rablon pativa la fame atavica dei contadini e dei ventenni. A un certo punto un ufficiale inglese l’aveva avvicinato, s’era complimentato con lui per la sua possanza fisica. Gli aveva chiesto se avesse fame, se era disposto a fare qualcosa per mangiare. «Il lavoro non mi fa paura» pare che abbia risposto. Bene, gli disse l’ufficiale, sai boxare? Si. Pensando: qualunque lavoro sia questo boxare, se non son buono imparo presto. Rablon stesso raccontava che era stato accompagnato in una stanza apposita, invitato a spogliarsi e indossare certi mutandoni. Poi gli avevano fatto calzare un paio di guanti spessi, poi l’avevano accompagnato tra due ali di folla festante, tutti soldati inglesi. Chi lo incoraggiava, chi lo incitava, chi gli batteva le mani sulle spalle. Lo fecero salire su una piattaforma cinta da quattro pali e quattro corde, al centro della folla. Salì sulla piattaforma un inglese pure lui in mutande. Un ufficiale in divisa, nel mezzo della piattaforma, parlò ad entrambi ad un tempo, scandendo bene le parole. Chiese evidentemente conferma all’inglese, l’inglese annuì. La chiese anche a Rablon, che annuì allo stesso modo. Rablon a questo punto cominciava a sospettare qualcosa, ma lui di boxe non ne aveva mai sentito parlare. Certo, sapeva o aveva sentito parlare come minimo di Carnera, ma non aveva mai letto un giornale o visto un cinema. O comunque era una cosa che non l’aveva mai riguardato. Al suono della campana l’inglese si fece sotto minaccioso, dopo aver studiato brevemente il nostro eroe gli scaricò sul volto un diretto potente 13 e inatteso. Rablon andò al tappeto nei primi tre secondi della prima ripresa. Si alzò a fatica, tra i fischi del pubblico. L’ufficiale inglese che faceva da arbitro lo guardò in faccia e gli chiese se stava bene. Si bene. Va bene, gli disse, se vuoi mangiare allora devi picchiare questo qui… Rablon stesso aveva raccontato ai colleghi di lavoro che rialzandosi dal tappeto aveva cominciato a capire lo spirito della boxe. Di non molte cose era sicuro, una di queste era che non avrebbe lasciato modo di farsi picchiare e che forse avrebbe potuto mangiare. Di conseguenza, appena si palesò di fronte l’avversario, senza attendere il “boxe!” dell’arbitro, Rablon diede un pugno, uno di quei pugni senza stile, senza tecnica e senza nome, per capirci uno di quei vagoni di pietrisco a tutta velocità, di quelli destinati a spaccare e frantumare. L’avversario finì al tappeto e venne portato via di peso, completamente tramortito. Ebbe modo di affinare la tecnica e imparare qualche regola. Non diventò mai un campione, ma si tolse la fame. L’ultima immagine che Rablon ha lasciato ai colleghi, e che ha contribuito senz’altro a costruirne una figura leggendaria, corrisponde con il suo ultimo Natale in fabbrica, prima del pensionamento. La notte prima delle ferie natalizie a Rablon venne offerta una bottiglia, al termine del rituale pasto comune in refettorio. Naturalmente il patto prevedeva che l’eroe compisse qualche gesto inusitato. E infatti gli venne richiesto di fare un giretto in bicicletta in mutande nel cortile antistante il reparto. Naturalmente era troppo poco: Rablon inforcò la bicicletta nudo, e pedalò per tutto lo stabilimento (un paio di chilometri) passando anche a trovare e salutare da lontano i guardiani allibiti, fra la neve, poco prima del Natale di un anno ormai lontano. 14 J.S. Bach, piccola fuga in fa min. BWV 578 Sono stato organista. Avrò avuto una decina d’anni quando i miei accolsero la richiesta di avvicinarmi ad una tastiera. L’enzima in cagione del quale un ragazzino di un paesino abbia potuto accostarsi alla musica fu Giuseppe Terni, ferroviere in pensione, scapolo, organista parrocchiale. Longilineo, educato, sobrio. Era una di quelle persone che si sforzava di essere cinico, soprattutto per risultare più simpatico. Tutto questo gli donava, in paese, un’aura borghese, anzi, aristocratica, per cui da tutti era nominato col solo cognome, fatto assai strano per quei tempi e quei luoghi, dove ognuno aveva perlomeno uno stranome. Terni prese in consegna l’aspirante organista, lo fece giocare un po’ con la tastiera elettronica che aveva in casa, poi, stabilito che doveva pur esserci in quel fanciullo una qualche propensione artistica, decise di parlarne con mio padre: si sarebbe potuto iscrivere l’imberbe alla Scuola Diocesana di Musica Sacra di Mondovì. Che ne dite? Terni stesso avrebbe procurato un harmonium per gli esercizi, che tanto lui non usava più; uno di quegli strumenti pesanti e tozzi dal suono di fisarmonica, ma dalla tastiera vasta e morbida. In breve, una volta alla settimana, il pomeriggio dopo la scuola, Terni accompagnava me ed altri due o tre sciagurati in treno a Mondovì, a seguire le austere lezioni di teoria e solfeggio, di brevi esercizi ripetitivi 15 secondo il libretto intitolato “Metodo Bungart”, dal nome del suo autore, che io allora mi figuravo come un prete teutonico severissimo, incartapecorito, essiccato dalla stessa aria che nutriva lo strumento. La scuola aveva da poco trovato una sede presso il vescovado, un palazzo dotato di cortile chiuso a Mondovì Piazza. Una ripida scala al cui sommo vi erano alcune stanze, ognuna delle quali conteneva un mostro elettronico da cinque ottave a due, tre tastiere, con pedaliera e seggiola incastrata nel corpo unico dello strumento. Dopo i primi esercizi, Terni, da spregiudicato qual’era, ci aveva accompagnato a turno in visita e alla prova dell’organo parrocchiale del paese patrio. A Saliceto, nella bella chiesa dalla facciata rinascimentale, si trova ancor oggi (ed io credo in buon ordine) un organo a canne ad un manuale (una tastiera) da cinque ottave, ed una pedaliera da un paio di ottave (se non ricordo male), un Veggezzi-Bossi del 1874. Legno, stagno, piombo, pelle, corda, avorio ed ebano. L’organo a canne è uno strumento buffo. Incute ovviamente timore, per le dimensioni e per il sentimento sacro che infonde con la sua musica. Ma stupisce che da un mostro tanto grande si produca una voce tanto mite ed ascetica. È un po’ come trovarsi di fronte ad un gigante minaccioso con una delicata vocina infantile. È uno dei pochi strumenti che non si possono spostare, in questo è assai aristocratico: se si vuole combinare una partitura per organo e altri strumenti occorre che gli altri, chiunque essi siano, se ne vengano a rendere omaggio al “mostro”. L’organo è soprattutto un meccanismo, una macchina per produrre suoni. In questo differisce da tutti gli altri strumenti: nessuno possiede tanta complessa meccanica, idraulica, acustica, metallurgia, ebanisteria, carpenteria, selleria, falegnameria. È figlio della cornamusa e dell’orologio (in questo è figlio dell’illuminismo: è la razionalità portata in chiesa) è il nonno del computer. Eppure da tanta razionalità possono scaturire suoni 16 raffinatissimi, delicati, flebili e dolci. E non è difficile farlo saltare su di un altro livello: se all’organo viene richiesto di alzare la voce allora gonfia il somiere e apre l’accesso dell’aria ai registri di ripieno, abilita il gioco di terza mano, il “fortissimo”, riempiendo l’aria di rombi e di squilli. Quello di Saliceto era un organo semplice, rigido, dalla catenacciatura ruvida e rumorosa. Ogni tasto esigeva una certa pressione delle dita, ogni nota, prima di essere emessa, faceva risuonare nel silenzio, per un breve attimo, il rumore dei meccanismi che presiedevano all’apertura dell’aria. Era (ed è) uno strumento, per quanto delicato, adatto ad un organista che fino a poco prima avesse legato fascine, sfogliato granoturco, vendemmiato, ammucchiato fieno. L’organo di Saliceto si sentiva chiaramente respirare: un motore elettrico (che aveva sostituito il garzone pompante sulla maniglia per tenere il somiere pieno d’aria) ronzava sommesso. Quando era pieno la valvola di sicurezza scaricava l’aria in eccesso con un debole soffio. Non aveva odori particolari, non aveva misteri: si poteva aprire come si apre l’armadio di casa, per scoprire polvere, tarme, legni incastrati magistralmente, qualche canna ammaccata e resa opaca dal tempo. Prima d’arrivare a sfiorare quella tastiera ce n’erano voluti di solfeggi e di esercizi sull’harmonium, poi un giorno si era giunti all’investitura, all’autorizzazione ufficiale: “Prova”. Così? Semplicemente? E allora si, proviamo a sederci, a dominare quel meccano furibondo e immoto. La seggiola dura, inamovibile, la tastiera d’ebano e avorio vetusta, corta, stretta e dura. I registri sulla destra, a leve di nudo legno. I pedali, i comandi a piede del gioco di terza e del “tutti”, lo specchietto retrovisore in alto, sopra il leggio, per vedere a che punto fosse l’officiante. Tutte novità. Ma tu ora devi suonare, devi dimostrare di aver meritato la fiducia che ti ha portato a sedere là. E allora suoni, timidamente, rispettosamente. E scopri che quell’organo vuole rispetto, 17 si, ma anche decisione. Che bisogna “pistare” in modo deciso, senza complimenti. E ti viene un po’ da ridere, come quando riesci a fare una cosa inaspettata, come quando vai in bici senza rotelle la prima volta. Vorresti provare, vorresti tirare il clarino, la voce umana, il flauto da 8 piedi e quello da 16, vorresti tirare il ripieno, le ottave, ma non puoi. Non è che il primo che arriva fa quel che vuole! È un organo, prima di tutto, e poi siamo in chiesa, vorrai mica fare caciara, così, per vedere che effetto fa? Vuoi tirare i registri? Allora studia, solfeggia, impara, ripassa il Bungart, fatti trascrivere un paio di spartiti da Terni, che in cartoleria comprava anche la carta da musica (s’è mai visto, comprare di quella roba lì…), ed erano bellissimi quegli spartiti disegnati con grafia precisa, sottile e sobria, proprio come lui. E poi una volta alla settimana a Mondovì, durante l’anno scolastico, al pomeriggio, si andava in sede, presso i parroci docenti. Seri e dediti alla loro missione, concedevano pochissimo alla chiacchiera, alla perdita di tempo. Un – due – tre – quatr. Una lagna mostruosa. Però ogni tanto un esercizio ti faceva intravedere quello che avresti potuto cavare dall’organo: un accordo, una melodia nuova, come un dito che premeva sul plesso solare, che ti ricordava qualcosa che però non ricordavi, come un odore, un gusto buono, che però non sapevi dove pescare. La scuola era frequentata da una manciata di alunni di tutti i livelli, le età e provenienti dai quattro cantoni della diocesi di Mondovì. C’era chi si trovava ai primi passi, come me; c’era chi strimpellava approssimativamente, c’era chi stava per decidersi ad entrare al conservatorio. C’erano persino delle fanciulle. Cinguettavano per conto loro, salutavano educatamente e poi scomparivano dietro un quaderno, il bavero, le loro stesse mani. Poi era arrivata Luisa. Solida quattordicenne integralmente sviluppata. E tutti i coetanei furono cotti irreversibilmente. 18 Dopo la scuola Terni ci portava al bar del Moro, in cima a via Sant’Agostino dove servivano una sontuosa cioccolata con panna, autentica novità. Si stava al tavolino commentando strumenti, citando episodi, valutando spartiti, giocando insomma ad esser consumati musicisti. Vicino c’era Comino, nota e lussuriosa pasticceria. Non lasciammo mai Mondovì senza far balzare alle stelle la glicemia. E così, di settimana in settimana, di prova in prova, pure io fui giudicato idoneo per suonare durante la messa. Durante la comunione cavai da quei tasti un adagio dello stesso Bungart. Arrivai in fondo sudato, ma felice. Intanto a Mondovì si parlava del saggio annuale. Si trattava di andare una sera di fine corso, a giugno, a suonare una serie di brani all’organo del Santuario della Madonna di Vicoforte. Cosa può voler dire ciò per un imberbe appassionato? Vuol dire cuore alle tempie. La gioia per arrivare ad uno strumento e un luogo tanto grandi contrastava duramente con l’emozione di dover suonare davanti a un pubblico sconosciuto, lontano da casa, in piena luce e piena evidenza. Chi non avesse mai visto il Santuario della Madonna di Vicoforte sappia che stiamo parlando della cupola ellittica più grande d’Europa. Il tempio è a croce greca, l’altare maggiore si trova di fronte all’ingresso principale, al centro della pianta, centrale alla cupola. Una specie di panteon molto più recente. L’organo si trova a destra dell’altare, perfettamente visibile dalla gente seduta. E poi c’è lo spazio, lo spazio vuoto dell’enorme chiesa. Dal palco dell’organista si vedono perfettamente gli angeli del baldacchino sopra l’immagine della Madonna, al centro della chiesa. Il marmo è lavorato in modo tanto magistrale da sembrare quasi trasparente, brillante di luce propria. E l’organo? Lo strumento è un Veggezzi – Bossi, per cui uno si tranquillizza, si dice: conosco… come un vero intenditore. Questo è due tastiere di cinque ottave, una raggiera di pedali che tiene tutto il posto 19 possibile, pulsanti, leve e una moltitudine di pomoli che equivale ad una moltitudine di registri. I tasti bianchi, pulitissimi, nuovi, erano tasti da signori: morbidi, felpati, silenziosissimi. Qui si capiva lo spirito dell’organaro che aveva costruito lo strumento, qui si apprezzava la differenza tra un organo da contadini e un organo da gentiluomini, guantati, affettati, esangui di musica e sospiri, forse di brodini sorbiti all’ombra del seminario. Ma a Saliceto non c’era che un brevissimo ritardo tra la discesa del tasto e l’ascolto del suono. Qui il ritardo era letteralmente spaventoso: l’organaro aveva realizzato la tastiera praticamente sotto la bancata delle canne, per cui il suono che arrivava all’organista era principalmente l’eco della cupola, oltre ad un fisiologico ritardo dello strumento. Si preme un tasto e non accade nulla. Per un attimo lunghissimo. Poi l’aria della cupola vibra delicatissimamente, senza infastidire e facendosi ascoltare perfettamente, come se ogni fedele presente avesse un suo personale organo che suona solo per lui. E poi c’è luce, piena luce. A Saliceto si stava nella penombra, alle spalle dei fedeli. Qui si sta di fianco, basta girare un poco l’occhio per vederli. E poi ci sono le vertigini, perché la panchetta dell’organista è pochi centimetri più bassa della balaustra, per cui ci si sente esposti in tutto quel vuoto luminoso e odoroso d’incenso e di cera. E per il resto c’era la musica, tanta musica. La musica delle prove del saggio, che iniziarono presto. Due o tre volte, a turno, al pomeriggio. Salire, aspettare, sedersi, scegliere i registri, suonare, lasciare il posto. Ma non ci eravamo dimenticati di avere la nostra età. Per cui alcuni temerari (e segnatamente il sottoscritto) si attardarono nella perlustrazione dei cunicoli posteriori allo strumento. Chi aveva costruito il santuario doveva saperla lunga: aveva lasciato ad arte dei passaggi che attraversavano tutti i possenti muraglioni della base, in modo che fosse possibile controllare la 20 staticità della struttura. Lo spazio ottenuto dai passaggi era tale per cui in una parte dei camminamenti era stato realizzato il museo del santuario. Dal palco dell’organo si raggiungeva prima di tutto la cassa lignea esterna dello strumento. In una sala ingombra di calcinacci, con una modesta finestra semiaperta, sul vetusto legno si potevano leggere le firme dei mille organisti passati di là. Poi si continuava il percorso verso l’alto, di sala in sala, di cunicolo in cunicolo, fino a giungere di fronte a una porta sbarrata che conduceva verosimilmente all’aperto, sulla cupola. Fu un’emozione indimenticabile camminare nel ventre di un santuario, sapendo di fare cosa illecita ovvero non autorizzata, con il sottofondo continuo e netto dell’organo. Gli altri alunni provavano, ognuno il suo piccolo esercizio, come il mio. Poi provavano gli alunni più bravi, e la musica cominciava a rapire, senza sapere che si trattasse di questo o quell’autore, avevamo scoperto di avere dei gusti, di cominciare a provare piacere nell’ascoltare. Negli altri giorni di prove eravamo riusciti ad abbinare la musica all’autore. Corelli! Haendel! Zipoli! E poi, distinto e implacabile, il maestro di cappella Giovanni Sebastiano Bach, com’era scritto italianizzando sullo spartito d’anteguerra. Non sono un critico musicale, però una cosa su Bach devo dirla: il suo mistero (per quanto mi riguarda) consta nella capacità di comporre musica quadrata, spaccata con l’accetta e mai grossolana. Eppure per quanto quadrata la musica di Bach può essere angelica, sublime, dolcissima. E questa dolcezza non sta tanto nelle varie interpretazioni, nelle esitazioni o certezze dell’esecutore, ma piuttosto nella precisione millimetrica della riproduzione. È in qualche modo l’unico autore classico che con un tempo in quattro quarti ti fa venire voglia di battere, manco fosse uno swing. Avete presente l’ “Aria sulla quarta corda”? Parlo della leggendaria sigla televisiva di tutti i programmi di Piero Angela. Musica dolcissima, ma perfettamente scandita. Anzi: più è scandita e più è lei, è 21 dolce, serena, quieta. Paradossale se si pensa che scandire il tempo vuol dire mettere in agitazione, produrre ansia. Al santuario eseguiva una fuga di Bach un giovane promettente, destinato al conservatorio ed alla carriera musicale. Il nome dell'allievo non me lo ricordo più, neanche la faccia. Il pezzo era per la precisione una “piccola fuga” in sol minore, opera BWV 578. Io non ero (e non sono) in grado neppure di leggere lo spartito di questo brano. Per un organista degno del nome non credo sia un pezzo particolarmente difficile, ma impegnativo si. Sia per la complessità strutturale che le fughe in genere hanno, sia per l’arduo compito che in più punti viene lasciato ai pedali. La fuga è un modulo musicale proprio del XVII secolo e specialmente dell’organo. Si tratta di annunciare una breve melodia, più accattivante possibile, in modo che sia identificabile, in modo che il cervello se la ricordi facilmente. Al termine del tema (così si chiama questa melodia iniziale) parte una prima risposta, la stessa melodia suonata ad intervallo diverso (come dire più bassa o più alta), poi ci sono varie fasi, vari sviluppi. Ogni tanto, in modo inaspettato, saltano di nuovo fuori quelle note, quella musichetta che uno si ricorda facilmente, incastonata in un oceano in tempesta di temi e altre melodie che si inseguono intrecciandosi. La stessa melodia verrà ripresa dai pedali, cercando le frequenze più basse. Poi i temi si sviluppano ancora fino a cercare le più strane variazioni, le più impensabili combinazioni fino ad arrivare alle dissonanze, come per dire: acciocché l’uom più oltre non si metta… Così è questa breve e complicata fuga in sol minore, che ci accompagnava durante le nostre perlustrazioni diurne. La memoria selettiva ha cancellato gli altri brani per lasciare tutto il ricordo di quei giorni immersi in quella fuga di Bach. L’ultimo giorno dell’ultima prova Luisa era venuta da me e mi aveva chiesto dove ci andavamo a nascondere tutto il tempo, io e gli altri amici, 22 e se le avessi mostrato anche a lei quel che c’era da vedere. Salimmo verso la schiena dell’organo. Eravamo soli. Bach aveva annunciato i suoi temi che ora si stavano dipanando e complicando. L’aria della fine di giugno portava dentro quella stanzetta l’odore dolcissimo dei tigli fioriti. Il profumo si mescolava con l’odore del legno antico e dell’ossido di piombo. Il sole era radente e infiammava di rame i tetti e i mattoni delle strutture attorno al santuario, ben visibili da quella finestrella. Lei non parlava. Guardava lontano rapita. Io guardavo lei allibito. Bach, Luisa, i tigli, l’organo. Non sapevo da dove cominciare. Non colsi l’attimo: vennero a chiamarci, tornammo sulla terra improvvisamente. Poi ci fu il saggio, una sera seguente. Poi ci furono altre estati e l’organo venne lasciato a chi aveva più passione, estro e volontà di suonarlo. C’è chi ascoltando una fuga di Bach pensa ad una chiesa, pensa a qualcosa di sacro e di profondo, di ascetico e severo. Io no. Soprattutto quando incontro la BWV 578 mi sento trasportato fino alle fredde primavere monregalesi, alle Alpi innevate là in fondo, al Monviso enorme. Vedo distintamente i tetti di Mondovì Piazza e i comignoli fumanti, poi vedo i prati e i campi, i morbidi declivi e i colli attorno al santuario, come volassi, tra pioppeti e salici spogliati. E poi sento quell’odore dei tigli, dell’ossido di piombo e di quel fiore non colto. Due interpretazioni, se volete, della breve fuga di cui abbiamo parlato: Questo è un ragazzo giovane ma molto preciso: http://www.youtube.com/watch?v=4h8fhn7tKCY&feature=related Commette qualche imperfezione, ma complessivamente è piacevole. Salvo che il finale, forse fin troppo ad libitum... Questo è il famoso Ton Koopman, ma sinceramente preferisco il primo. http://www.youtube.com/watch?v=PhRa3REdozw&feature=related 23 Sembra che abbia una fretta dannata. Pare un ciclista sul Pordoi. Ma sarà il caso? Però è interessante vedere il ritardo del suono da quando preme (soprattutto sul pedale) a quando si sente. Un vero virtuoso peraltro. 24 Nero o rosso? Conosco Piero da poco. Ci salutiamo cortesemente ma tra di noi c’è stato un motivo di attrito grave, una di quelle questioni da cui nascono faide famigliari che si trascinano nei secoli: il vino si dice “rosso” o “nero”? Da questo è nata una discussione complessa per cui siamo stati a un dipresso dallo scambiarci i padrini. Poi ognuno, in cuor suo, ha deciso di abbassare i toni. Abbiamo semplicemente smesso di parlarne, ognuno con le sue convinzioni. Non c’è niente di grave nel nome che diamo alle cose. Il linguaggio, le parole che usiamo raccontano la nostra storia, talvolta è una storia che vale la pena d’essere raccontata, altre volte può essere una storia creata, per non dire inventata, della quale potremmo restare ugualmente affascinati. Io non so dove l’amico Piero ha imparato a chiamare il vino nero “rosso”, pare sia stato un corso di sommelier, forse su qualche titolo illustre dell’ampelografia internazionale. Certamente ha visto l’uva scambiar colore, ha pestato terra gessosa e umida, ha visto la prima nebbia della stagione alzarsi dall’Erro, o da Tanaro, o da Belbo e inseguire le cime dei colli ponderosamente. Avrà sentito l’odore del mosto nel ribollir dei tini. Poi, per l’appunto, ha innestato sulla radice del suo ricordo vissuto, la nozione classificatoria, come anni prima suo nonno aveva innestato il dolcetto sulla radice di americana, salvandolo. 25 Bisogna compatirlo: lo ha fatto a fin di bene. Per me il vino dolcetto è impersonificato da mio zio Dovardo, vecchio iracondo ossuto e incartapecorito, ma dritto e preciso come un dardo, suicidatosi qualche anno fa, arrabbiato con la vecchiaia, con i malanni, con la vita stessa. Dovardo viveva in una valle boscata dalla quale altro non si vedeva se non qualche traliccio dell’alta tensione. La casa era stata una cascina con fienile, stabbioli per porci, galline, conigli, ripostigli, depositi. Ora era una casa indipendente. Non più bestie, ma la certezza della pensione a riempire le nevrosi di un contadino non più tale. Ad agosto di ogni anno si ripeteva il rito. Si inforcavano gli occhiali, si cercava il numero segnato sul quaderno, si componeva e si attendeva. Silenzio in tutta la casa. Mascarino il piemontese rispondeva all’altro capo che tutto era buono: vite, tempo e salute. Che l’annata era speciale. Nient’altro. Valeva, questa comunicazione, come termini di contratto non scritto (e neanche detto) e relativa sottoscrizione. Alla fine di settembre (poco prima, poco dopo) Mascarino avrebbe telefonato per dire solo: “La settimana prossima, di giovedì”. Basta. Zio Dovardo dava l’allarme ai due nipoti che l’aiutavano nella preparazione. Io e mio fratello ai posti di combattimento: pulizia, spostamento, riordino. Si mettevano a bagno le vetuste botti. Poi Dovardo faceva uscire da qualche recesso un piccolo martello e un arnese di metallo indispensabili per serrare i cerchi. Sembrava impossibile che quei vecchi legni scuri e laschi, che pisciavano come fontane, potessero serrarsi e ospitare il mosto. Eppure di lì a qualche giorno si compiva il miracolo: il legno si gonfiava e si stagnava. Il mercoledì sacro Dovardo toglieva il tappo alle botti, allagando la corte. Il giorno dopo, la mattina, io e mio fratello ci presentavamo assonati e in ritardo (secondo la tabella di marcia dello zio) per le ultime rifiniture: posizionamento irrevocabile delle 26 botti, posizionamento della pigiadiraspatrice, posizionamento delle conche di plastica, della carriola, del mestolo con la preziosissima fiala di vetro per misurare lo zucchero. Poi cominciavamo ad aspettare. Era una giornata così, si sapeva, era normale. C’era quasi sempre il sole, ma l’aria presagiva l’autunno. Se era venuta la pioggia nella ventina di giorni precedente allora lo zio avrebbe preparato un cesto di funghi da dare in omaggio ai portatori dell’uva. Mia zia, la moglie di Dovardo, dislocava più di un quintale, e indossava solo scarpe da tennis: le uniche che non le procurassero dolori. Ma non bastava, e allora, ancor nuove, quelle scarpette venivano ritagliate in corrispondenza dei punti dolenti. Forse per via dei piedi era intrattabile anche lei, e poi era indaffarata per tutto quel giorno: doveva preparare la marenda. Io non so se avessero chiamato quella cosa marenda per scherzo, oppure per giustificare l’orario, non propriamente adatto alla cena, certamente tardi per il pranzo. In ogni caso non prima delle 18 arrivava Mascarino su un camionicino, alla guida del quale c’era un muratore che, appena finito il lavoro in cantiere, era andato a caricare l’uva e l’aveva portata fin qui, conscio soprattutto della famosa marenda. Mascarino scendeva senza salutare, guardava il carico e si stupiva, non si capacitava, si meravigliava, scrollava la testa, parlava fra sé. Poi allungava due dita ossute e staccava un acino, lo suggeva. Non mutava espressione. Ogni anno la stessa sceneggiata per convincerci (se mai l’avessimo guardato) che sicuramente ci avrebbe rimesso, che una merce così poteva venderla a ben altro prezzo, che uva così non se ne trova da nessuna parte. Dovardo e Mascarino si vedevano una volta all’anno, ma non si salutavano. “È bella?” Dovardo lo chiedeva a noi, come dire: “Tanto non mi fido di quello che dici tu, io ascolto solo i miei nipoti”. E noi nipoti ci guardavamo, assaggiavamo timidi, un acino, due. Poi sputavamo 27 sonoramente i semi per terra. “È dolce che attacca!” cioè “attacca in gola”, tanto è lo zucchero che le mucose s’appiccicano tra loro, come accade alle dita inzaccherate dal mosto. Gli uomini potevano entrare in casa, salutati dalla padrona: Mascarino, il muratore e poi mio zio che aveva tenuto la tenda sulla porta col braccio, invitando gli ospiti ad entrare nella cucina buia del pianterreno. Dopo tutti entravamo anche noi, ci sedevamo di là, nella grande stanza che un tempo era la stalla, poi è stata il magazzino e adesso è la “sala”, definizione nuovissima e inadatta per descrivere una stanza di cui nessuno sapeva bene la destinazione d’uso, ma che per l’occasione era arredata e apparecchiata per la festa. La marenda cominciava alle 18,15 con salame cotto, crudo, prosciutto. Funghi sott’olio, peperoncini ripieni sott’olio, salsiccia cruda, frittata, formaggio sott’olio e Bonaptit. Poi c’erano le raviole di mia zia, quelle con la carne di cinghiale col sugo di cinghiale. Se dovevano essere servite, diciamo, alle 18, mia zia metteva giù alle 15. Cuoceva, poi scolava e condiva, poi versava in una teglia e gratinava nel forno della stufa finché non fosse arrivato il momento. Il primo strato era in genere polimerizzato, ma sotto, ad una temperatura indicibile, riposavano le raviole. Quelle raviole, quelle che non ce n’era (e non ce n’è) altre. Se la stagione era stata buona c’erano poi i funghi fritti e al verde. Sempre la salsiccia arrostita e le patate al forno croccanti, dorate come un tesoro precolombiano. Niente dolce: è roba da bambini. Vino di diverse annate, di diverse bottiglie, sempre nero. Mai visto vino bianco sulla tavola di mio zio: qui non fa, non usa, il vino bianco si usa solo per mettere i funghi in composta. Io e mio fratello lasciavamo i commensali a tavola e cominciavamo a spostare le ceste di uva, poi cominciavamo a metterne una nella pigiadiraspatrice, poi cominciavamo a buttarla nella botte, poi magari cominciavamo a schiacciarne un’altra. Ci interessava davvero fare il vino, 28 ma eravamo anche giovinotti, e la sera si hanno sempre un sacco di progetti e programmi, per cui i lavori sono belli quando finiscono in tempo per uscire. I commensali aggiustavano i conti, poi uscivano nell’aria scura e ci raggiungevano, stupendosi del fatto che avevamo quasi finito. Le due botti erano ormai piene per tre quarti di mosto. Ora bisognava misurarle. Deputato è sempre stato mio fratello. Nel silenzio si attendeva l’auspicio: venti, o magari anche ventuno. Mascarino non era mai soddisfatto, misurava lui pinzando il gradino di vetro tra l’indice e il pollice, tirandolo su. Ventiquattro, almeno ventitre. Ma tanto tutto era già saldato e chiuso, con reciproca soddisfazione. Né scontrini, né bolle, solo parole. Mascarino salutava tutti e se ne spariva con la sua cassetta di funghi. Dovardo andava in casa, ne tornava col vaso di vetro verde del sale grosso. Elargiva due, tre grosse manciate di sale sul mosto appena schiacciato. Poi riponeva ogni cosa al suo posto. Si coprivano i tini, si chiudeva a chiave la cantina. Sistemavamo infine il poco materiale che ancora stava in giro, facevamo in tempo a sentire la rugiada fresca posarsi su di noi, andavamo ancora una volta in casa a prendere un caffè, a discutere del prezzo un po’ caro (ma l’uva è bella) e poi si sarebbe potuto tornare a casa. L’indomani Dovardo avrebbe cominciato, a partire dalle cinque, cinque e mezza del mattino, a visitare periodicamente il mosto: più tempo impiega a cominciare a bollire, più è dolce, più fa gradi. Dopo un paio di giorni Dovardo scopriva la processione di bollicine salire in superficie, nel giro di qualche ora si poteva sentire il brontolio del mosto in piena ebollizione. Per prima cosa allora ci telefonava, avvisando che era successo quel che doveva succedere: “U bùi” (“Bolle”). Poi dava giù al mosto rimestando con cura il contenuto delle botti. Poi preparava il coperchio e i puntelli, aspettava che tutte le berte fossero tornate a galla e quindi ci appoggiava 29 sopra il coperchio, spingendole sotto il livello del liquido in fermentazione. Per quindici giorni andava e tornava dalla cucina alla cantina. Andavamo qualche volta a vedere, a trovarlo. Ci accompagnava in cantina, ci spostava il telo pesante di juta sopra le botti, potevamo guardare quella laguna nera ribollire quieta, con calma, rilasciando aromi etilici, aspri, dolci. Legno bagnato e stoffa arsa, cantina, aglio, tabacco, formaggio. Ma Dovardo non poteva trovare requie. A tute le ore piombava in cantina preoccupato, teso, nervoso. Valutava il livello nei tini: se fosse stato troppo alto sarebbe improvvisamente uscito a causa del tumulto della fermentazione, strabordando. Allora spillava dal basso dieci, venti, cinquanta litri di mosto che poneva a fermentare in una damigiana pulita. Accostava la finestra se faceva freddo. Apriva, socchiudeva, chiudeva. Con la mano legnosa tastava il fianco della botte se fosse diventato tiepido. Silenzioso compiva tutti questi riti, nel travaglio, nella sofferenza della preoccupazione, della tensione continua, lampadina sempre in tasca, gambali dietro la porta, sacco di juta in scabuggio se fosse venuta la pioggia, ché l’ombrello non si usa. Dopo quindici giorni chiamava nuovamente i nipoti: “È ora, non bolle più” perentorio. Il giorno prima aveva tolto i puntelli, lasciando alle berte il modo di agglomerarsi in superficie. Nel pomeriggio si disponevano le damigiane, poi si cavava la spina dalla botte e da lì cominciava a spandersi l’odore di vino, mentre il getto nero violaceo riempiva la conca sotto il tino. Ogni tanto si poteva mettere il bicchiere sotto il getto, catturarne un poco, poi portarlo in alto e guardare l’inchiostro in contro il sole, certi che nessuna luce avrebbe osato trapassare quel liquido. Dalla conca si passava alle damigiane con un grande mestolo, più recentemente con una pompa elettrica dedicata. Si poteva infine montare il torchio e spremere quello che restava per cavarne ancora una damigiana. 30 Il torchiato, un cilindro compatto di vinacce, semi e pochi graspi, veniva spaccato con l’ascia per la legna, trasportato con la carriola nel letame. Si lavava tutto con acqua. Tutto salvo le botti, che andavano fatte rotolare fino al declivio davanti alla casa, sempre nello stesso posto. Mio zio stesso e non altri, si tuffava nelle botti coricate con una spazzola di saggina, ripulendole attentamente. Poi si potevano ancora far rotolare fin sotto il portico, si sollevavano una sull’altra con la bocca superiore rivolta a sud, in modo che il sole del primo autunno le accarezzasse all’interno dall’alba al mezzodì. Non c’erano cose nuove, tentativi, sperimentazioni, scoperte. C’era solo un continuo ripetersi di riti e consuetudini ben consolidate, apprese dal proprio padre, dal proprio zio, e come l’autorità paterna, mai messa in discussione. Quei saperi e quelle conoscenze facevano il vino di Dovardo, noto in tutta la valle del Rio Merina e Torrente Valla come il miglior dolcetto che si potesse fare. Era scuro, nero ma limpido. Si, nel bicchiere, al fondo, lasciava un velo rosso violaceo, ma conta il colore di un ombra? Nel bicchiere è nero. Da non confondere con il dolcetto che compri al supermercato: buono, perfetto, tutto uguale e senz’altro rosso. Quel vino era figlio di una famiglia, di un rapporto tra zio e nipoti; figlio dell’aria fredda e umida delle colline boscose della Valle Bormida sposata per procura con un fianco di una collina del Mango d’Alba. Quel vino era stato codificato da un linguaggio specifico, utile come l’arnese che mio zio usava per serrare le botti; sacro come ogni linguaggio legato ad un processo, un mestiere, un’arte, un delitto. Il risultato finale poteva anche non essere il miglior vino, ma era il dolcetto di Dovardo, per davvero un vino di tutto rispetto, che si salvava senza cure particolari, senza bisolfiti. Che finiva giustamente per la cottura del coniglio, per marinare il cinghiale, per accompagnare tutto il pasto dal salame fino alla torta secca da immergere e ripescare dal gotto ubriaca fradicia. 31 Come posso io chiamare oggi il dolcetto “vino rosso”? Devo sforzarmi, non devo pensarci, non devo farci caso… Il dolcetto, l’unico che conosco, è una storia, non un vino. È una questione di famiglia che ha un sacco di aromi e di affetti, che son disposto a incrociare con mille altre vedute, ma mai, mai permetterei a un vero esperto di vini di corrompere con attribuzioni di colore improprie. Tanto più che il nero non è un colore, ma l’assenza di luce: tutta un’altra storia. E se mio zio fosse ancora qui si intrometterebbe iroso, bestemmiando, per dire che rosso o nero, l’importante è che sia buono. 32 La sposa del bandito Arrivò prima lui. Disarmato, ripulito, vestito di chiaro. Con certi baffetti ben pareggiati e i capelli lustri aderenti al cranio. La camicia bianca con l’ampio colletto sopra il bavero della giacca, la sigaretta fra le labbra. Era un ragazzino con arie da uomo, ma chi non lo era a quel tempo? Era presto, lo sapevano. Andarono all’osteria poco lontano, a bere un bicchiere, lui e il testimone: un compagno dello stesso distaccamento, non proprio elegante come lo sposo, ma almeno ripulito e disarmato, come don Eugenio aveva richiesto. Più a valle avevano disposto due pattuglie ai lati della carrozzabile. A monte un paio di vedette. Si poteva stare quasi tranquilli, per quel giorno. Era finita l’estate. A guardare la valle ai piedi del paese sembrava di metter l’occhio dentro un mirino di precisione per guardare il mare. Il fianco sinistro della valle era quello esposto bene, quello in cui gli uomini avevano messo olivi, disposto muri, cresciuto verdure. Il fianco destro era coperto di boschi. Gli uomini guardavano il mare e pensavano che sarebbe stato meglio sposarsi con calma, con una bella cerimonia, un buon pranzo, gli amici, la fisa, i balli sotto la pergola. Avrebbero potuto cantare “Bandiera Rossa” e poi “L’internazionale” e poi ridere e fare scherzi allo sposo. Avrebbero bevuto ancora un bicchiere e pizzicato il culo a quella ragazza alta, e magari ci avrebbero fatto l’amore, la sera, prima di andare a dormire. 33 “Arrivano, sono loro” aveva detto lo sposo ridestando il testimone dal suo sogno. Erano diverse matrone accaldate per la salita. Al centro, diritta come una candela, c’era la sposa. Nessuno vestito di bianco, nessun velo: non bisognava dare nell’occhio. Lo sposo gettò via la sigaretta, si avvicinò, salutò per prima la prossima suocera, poi le signore parenti convenute, per ultima, sfiorandole la mano, la sposa. Il testimone fece cenni col capo, restò serio, a far capire che non intendeva abbassare la guardia. Sulla porta della chiesa la sposa mise un velo bianco, le convenute estrassero dalle borse fazzoletti grandi e scuri, tutte si coprirono il capo, poi si segnarono con la croce, baciandosi infine l’indice incurvato a gancio. Gli uomini entrarono rispettosi, ma senza segnarsi, da bravi compagni. Il prevosto era già vestito e pronto. Accese due candele, pregò sottovoce, sibilando frasi latine rivolto al crocefisso. Le convenute talvolta rispondevano contrite. Si dissero di si, si scambiarono anelli metallici, firmarono gli sposi, firmarono i testimoni. Uscirono a braccetto i due giovani. Insieme non arrivavano a cinquant’anni ed erano pronti a ricevere il bambino che lei aveva scoperto di portare. Quando lei gliel’aveva detto lui non aveva parlato. Lei aveva cominciato a preoccuparsi. Lui aveva concluso che in qualche modo si sarebbe fatto, che una soluzione l’avrebbe trovata, di non preoccuparsi. Come sarebbe, pensò lei, non preoccuparmi? Manco lavorasse in ferrovia, pensò lei. Il bandito comunista, fa, altro che l’operaio, l’impiegato, al limite nella milizia, guarda… No, il bandito e per di più comunista. Come dirlo in casa? Aspetto un bambino. Ah! E lui chi è, disgraziata? Ma, niente, una persona per bene, un impiegato del catasto che abita da solo in una casa di proprietà, e ha pure l’automobile. E invece no. È uno che abita in un 34 bosco, in un seccatoio da castagne, ma solo quando va tutto bene, perché se no abita anche in una capanna di frasche. Mangia quando capita, dorme dove può, non ha un soldo bucato in tasca. Ma ha una buona mira, mi hanno detto, e le scarpe buone, che non si stanca di camminare, perché ha un torace grande e i muscoli duri che li puoi contare. Ed ha sempre un buon odore, di bosco, di foglie, di fumo. E mi piace quando i capelli si scompigliano e gli scende una frangia sugli occhi. Ma queste cose in famiglia non le puoi dire. Va bene che sono comunisti anche loro, che non ammetterebbero mai la figlia sposata a uno della milizia, ma di qui a farsi mettere incinte da un bandito, sia pure un patriota… Ma la sposa aveva organizzato tutto: l’aveva detto in famiglia solo quando lui le aveva detto di essere pronto a sposarla, davanti al prete, coi testimoni, tutto regolare. Il padre della sposa si era messo a piangere. Non protestava, non ce l’aveva con nessuno, singhiozzava come lei non l’aveva mai visto fare. Ma perché piangi? Perché c’è la guerra, e mia figlia si sposa e io non posso neanche vederla sposare, e farà un figlio tra i soldati, e crescerà nella polvere da sparo, col pane razionato, col padre che scavalca le montagne. E io ho aspettato vent’anni per vederti così. Ma perché? Per lo sposo fu tutto più semplice. Il padre e la madre erano lontani cinquecento chilometri e una guerra fa. Chiese una settimana di licenza al comando brigata per motivi matrimoniali. Dovette ripetere più volte la stessa domanda ed ogni volta gli rispondevano con un sorrisino complice: e bravo, l’hai combinata eh? E adesso te ne vai una settimana a spasso con la mogliettina… E bravo. Il commissario politico volle sapere se la sposa era o meno di comprovata fede politica comunista. Lui gli disse di si, certo, che sicuro non lo era, ma lo sarebbe diventata. E dove vi sposate? In chiesa, da don Eugenio. Ma bravi! E che razza di comunisti siete che per sposarvi andate in chiesa? 35 Non saprei, disse lui, per un matrimonio uno va in chiesa, dove vuoi che vada? Giusto, rispose il compagno commissario. Qualche volta poi ti spiego anche questa, ma non è il momento. Vai, vai pure dal prevosto e portagli anche i miei saluti. Diglielo che io sono un democratico, che ci sarà posto anche per lui dopo la vittoria, ma che però dovrà mantenersi da solo, mica coi soldi dei lavoratori. Ad ogni buon conto lui non riferì i saluti. Fu grato a don Eugenio che aveva fatto tutto presto e bene, non l’aveva detto per davvero a nessuno. E poi, quando il testimone aveva fatto il gesto per offrire qualcosa (e sarebbe stato strano veder uscire da quelle tasche più di un soldo) don Eugenio l’aveva fermato, dicendo che quell’offerta sarebbe servita di più alla sua causa che alla chiesa, in quel momento. Don Eugenio era un compagno, conclusero, o forse poco ci mancava. Uscirono dalla chiesa e restarono per un attimo abbacinati dal sole che intanto s’era alzato nel cielo terso. Il testimone andò al parapetto del sagrato, guardò verso il fondovalle, poi guardò lo sposo facendo segno di si, che è tutto a posto. I due sposi, fianco a fianco, discesero le scale. Un bicchiere, all’osteria, un dito di vino. Ma tutti mentre bevevano si guardavano intorno, preoccupati. La gente del borgo aveva notato il movimento e sicuramente la voce girava: “Don Eugenio ha sposato un bandito!”. Le convenute e la madre salutarono la sposa lacrimando. La suocera raccomandò la figlia al genero, con sguardo severo. Poi lo baciò e gli fece una carezza sulla testa, proprio come a un ragazzino. Lo sposo si sentì di colpo troppo giovane per tutte quelle novità. La sposa abbracciò la madre e le convenute, si salutarono. La madre diede alla sposa una borsa da viaggio, si asciugò le lacrime. Il testimone e i due sposi s’incamminarono verso le cime dell’Appennino, fra i boschi, oltre i boschi, da dove talvolta si vede addirittura la Corsica. 36 Camminavano lenti e decisi. Lei s’era cambiata le scarpe e teneva dietro ai due uomini senza lamentarsi, per far vedere di cos’era capace. Incontrarono le vedette. Continuarono a salire. Oltre un bosco di faggi c’era una radura, un declivio al cui margine si trovava un grosso masso. Si fermarono un poco a respirare, mangiarono una fetta di pane e un pezzo di formaggio. Nessuno aveva niente da dire. Lo sposo ogni tanto sorrideva e lei si sentiva sciogliere. L’amava come solo i ragazzi sanno amare: perdutamente. Prima di sera erano alla cascina dell’amico. Il testimone salutò gli sposi, fece loro gli auguri, e proseguì di buon passo nella penombra. Gli sposi vennero accolti in casa. L’aria fuori era già fredda, in cucina c’era un buon odore di roba da mangiare, calore, vapore, sorrisi e parole gentili. La padrona si prese cura della sposa, le fece togliere la giacca scura, la fece sedere. Avevano apparecchiato la tavola con una tovaglia bianca, due piatti uguali, stoviglie di alpaca, bicchieri, una bottiglia di vino nero, ma buono, un vasetto di vetro con dentro alcuni fiori secchi, ma belli. Gli sposi sorridevano. Mangiarono polenta. Poi si divisero una scatoletta di sardine, lasciando l’olio ai padroni di casa, che gradirono. Poi c’era formaggio, e pane bianco, ma buono. Poi c’era il buio che aveva invaso la stanza e il lume, che serviva a malapena per sapere di esserci ancora. I due sposi stettero ancora un poco a sentire il vecchio che ricordava ricordi lontani, di pesci, di lepri, di bottiglie e di funghi. Poi fu lo sposo a parlare, a dire che loro, con licenza, si sarebbero ritirati. E lei si alzò con lui, docile. E lui sentì di non essere solo, sentì che quella donna lo avrebbe seguito e questo gli dava forza e coraggio. La padrona gli fece chiaro su per le scale, fin nella stanza. Appoggiò il lume, accese una candela, raccomandò di fare attenzione, di consumarla il meno possibile. Diede la buonanotte, gli auguri, e chiuse la porta prima di scendere le scale. 37 Lui e lei restarono un poco in silenzio a guardare altrove. Lei si tolse le scarpe e si massaggiò i piedi indolenziti. Lui si allentò la camicia. Lei cavò dalla borsa una camicia da notte e si mise nell’angolo più scuro della stanza a cambiarsi. Lui non sapeva se avrebbe dovuto guardare o far finta di niente. Si stese sul letto, vestito, le mani dietro la nuca. Lei si mise sotto le coperte, poi gli disse: vieni, da sola ho freddo. Lui si tolse i vestiti, spense la candela e si distese accanto a lei. Nel buio più buio si sfiorarono, si annusarono, si trovarono. Quella notte durò una settimana: altro non c’era. Non contava il pranzo, la cena, le passeggiate, le volte che lui o che lei diedero una mano in casa. Non contava nulla. Contava solo la notte, le notti. Si stringevano nel buio assoluto, si facevano piccoli uno nell’altro, nient’altro esisteva: non guerra, non rastrellamenti, non la fame, la sete, la paura, i pidocchi, la scabbia, la dissenteria, non i lanci degli inglesi e le mine dei tedeschi, non i repubblichini, non i ricognitori sopra le loro teste. Fuori dalla cascina, per quella settimana, le pattuglie s’incrociavano. Tutti sapevano che quella casa di contadini era diventata importante, strategica, qualcuno aveva detto con parola inusuale. Cosa ci fosse dentro, poi, proprio per bene non si sapeva. Ma le pattuglie di ragazzi che camminano il giorno e la notte hanno anche bisogno di qualche mistero per funzionare bene, per fare meglio il loro lavoro. Erano tutti uomini fidati e nessuno avrebbe permesso a chiunque di avvicinarsi troppo a quella casa. E tanto bastava. La settimana finì presto, come finisce una notte di sonno beato. Lei discese a valle, verso la città, verso gli sguardi dei vicini da dietro le stecche delle persiane: “…Ha sposato un bandito, perché era incinta…” e di questo si sentiva fiera, di entrambe le cose: d’aver sposato un bandito e di portare in grembo, come di diceva allora, il frutto della loro passione. 38 Lui tornò al distaccamento. Il comandante lo spedì subito di pattuglia: niente di peggio per lui che restare a gongolare, vittima della nostalgia e dell’amore lontano. E niente di peggio per gli altri del gruppo: non si devono avere riguardi, sposo fresco o no: via, in mezzo alle eriche e alla nebbia bassa sulle cime, ad aspettare che succeda qualcosa. Qualche mese dopo il testimone e lo sposo camminavano soli verso valle. Ognuno la sua piccola missione da compiere: comprare cibo, parlare con informatori, tenere gli occhi aperti. Subito dopo il ponte c’era un’osteria, sarebbe stato naturale fermarsi e bere un bicchiere. Entrarono e scorsero subito un gruppo di militari della San Marco seduti a un tavolo. Il testimone era uno pratico e risoluto, fu rapidissimo ad estrarre la pistola e minacciare i soldati. Tutti alzarono le mani. Lo sposo li disarmò. Si sentiva nell’aria immobile la paura di questi e di quelli, ragazzi consumati, assonnati, affamati d’affetti e di pastasciutta. Un caporale armeggiò sotto il tavolo, il testimone sparò, altri spararono. Lo sposo si accasciò a terra. Il testimone sparò all’impazzata, prese di peso lo sposo e lo trascinò fuori. Mentre i due uscivano altri colpi vennero da fuori. Dalla carne di uomini lacerata dai proiettili uscì copioso sangue e insieme a questo la vita. Lo sposo fu portato in una cascina poco lontana. Venne il medico della brigata a scuotere la testa. Prima di giorno lo sposo morì. Lo sposo si chiamava Vincenzo Pes, aveva 24 anni, militare dell’esercito italiano, del genio, aveva scelto la macchia e l’impegno politico. Morì nel novembre del ’44 per una disattenzione, per una leggerezza, per un atto di spavalderia, come i giovani di tutti i tempi sono costumati. Le memorie dei reduci non ci raccontano come visse la sposa, se crebbe il figlio, se tornò a innamorarsi e sposarsi e a vivere, senza dimenticare quello che era avvenuto, come sarebbe giusto che fosse stato. 39 Il fiume rubato: teatro a Cengio 4 settembre 2009 I manifesti sono stati attaccati per tutta la Valle Bormida. Hanno girato mail con locandine e brani e commenti sullo spettacolo. Hanno persino messo un titolo nella locandina del Secolo XIX in cui si criticava il sindaco di Cengio, Billia, perché non sarebbe stato presente. La serata è fresca, il luogo è piacevole. C’è un gruppo che suona, ma il silenzio sarebbe meglio. Siamo sotto un gazebo ampio, su un palchetto. Non ci sono sedie, sono le 21,00 e la gente comincia ad assieparsi. Comincia la caccia alla sedia: vengono pescate un po’ dappertutto. Mi chiedo: ma perché queste cose si organizzano così male? Mettere sedie o panche o prevedere un sistema… Alle 21,30 si affaccia alla platea, composta da circa 120 persone, un signore anziano che dice (tra l’altro) di essere uno dell’associazione “Asso di cuori” per la quale questa serata è stata possibile. Poi c’è il saluto di una signora della stessa associazione, dice che questa serata è dedicata a tutti coloro che sono morti per causa della fabbrica. Torna il signore anziano e invita al microfono l’assessore regionale all’ambiente. L’assessore ricorda tempi epici, nomi, luoghi… Dice cose da assessore. L’anziano chiude parlando di luoghi comuni, d’epoca, ma pur sempre luoghi comuni: guerra tra poveri, fabbrica della morte, cita Fenoglio… Perdicca comincia a raccontare leggendo la concessione al dinamitificio Barbieri del comune di Cengio. Tutto inizia di qui, dice. 40 Lo spettacolo è diviso in due parti: la prima è la storia per sommi capi dell’espansione di una fabbrica e delle lotte che gli abitanti a valle della fabbrica hanno cercato di fare, perdendole per novant’anni. La seconda è una cronaca appassionata degli ultimi dieci anni delle lotte dei contadini (buoni e piemontesi) contro l’ACNA (cattiva e ligure). Pubblico: 120 persone sono poche. Non ho visto molte facce conosciute, non c’erano striscioni di Consigli di Fabbrica, Consigli Comunali, ALA, associazioni di altro tipo. Mi è parso che fossero presenti alcuni salicetesi che a suo tempo manifestavano per la chiusura. Il pubblico ha seguito con un interesse non comune il racconto: Pedricca sa il fatto suo: recita con trasporto, passione, insiste un po’ troppo su alcune pause ad effetto. Non c’è scenografia: solo un paio di lampade portatili accese e spente a scena aperta dallo stesso attore. Un po’ di musica in sottofondo, qua e là, a sottolineare certi passaggi. Il racconto Bello, emotivamente coinvolgente. Non ha tralasciato quasi nulla, ha citato quasi tutto quello che era possibile citare. Le fonti della storia sono quelle… Poi salta fuori anche il nome di don Billia e del suo giornalino, di Aldo Pastore e del suo primato nel parlare dei rischi alla salute, delle condizioni di fabbrica. Chi ha vissuto quei giorni dalla parte piemontese è felice, commosso, eccitato. Alcuni sono intervenuti a scena aperta per sottolineare: “è vero!”, oppure anticipare la battuta del ministro Donat-Cattin (“Non rompetemi le palle!”) a Bossolasco. La platea dice: io c’ero, ed è la verità. L’attore narra delle manifestazioni di piemontesi che attraversavano il paese di Cengio deserto. Gli operai, presenti nella prima parte del racconto, svaniscono nella seconda. In ogni caso la storia non lascia indifferenti, che è quel che conta. 41 Però… Però se uno è costumato a vedere le cose dall’alto (dalla scaletta che il metodo storico ti offre e ti invita ad usare) non ti basta un racconto ben sceneggiato. Non ti basta perché le questioni sono ancora più complesse, perché la Valle Bormida non è solo “ACNA” da una parte e “I valligiani” dall’altra. Perché oltre al confine Liguria-Piemonte c’era un complesso industriale sviluppato in un secolo in terre poco redditizie: carbone, coke, chimica organica, fertilizzanti, fotografie. Forse 20.000 persone più l’indotto, tutte nella chimica, a livello diverso di rischio e retribuzione, sia chiaro. E allora? E poi gli operai e le famiglie degli operai di Cengio, ma anche di Saliceto non erano affatto serene e rassegnate: liti terribili, musi lunghi e qualche sberla e la famiglia si disfa: i parenti di Cortemilia non ti salutano più. E le botteghe di Cengio (e non solo di Cengio)? E i contadini che non dicevano nulla ma pensavano alla vacca in più nella stalla comprata proprio grazie al turno di notte? Negli anni ’70 a Saliceto irrigavano fagiolane e granoturco dei campi prossimi al fiume e poi vendevano questi fagioli. La ditta Xxxxx di Saliceto ha costruito una florida impresa su questa attività. Nella Bormida marrone e rivoltante nuotavano le “gallinelle d’acqua”, incredibilmente inattaccabili da quelle pestilenze. Noi bimbi andavamo a giocare sulle rive, nelle sabbione alluvionali a fianco della Bormida nera, e c’era un odore penetrante, non buono o cattivo. Sapevi che era cattivo, ma non ti dava fastidio. Così come non dava fastidio quell’odore quando arrivavi subito dopo il passaggio a livello: era “odore di fabbrica”, regolare, come “odore di stalla”. Vuoi lamentarti? Tutto regolare. Poggio e Moro, i due morti del 1976, vengono ricordati dall’attore, viene ricordata la giornata terribile, ma nessuno (forse) si ricorda che gli operai 42 accettavano di scaricare i forni del cloruro d’alluminio a mazzate, perché almeno poi li lasciavano dormire, perché domani c’è un altro lavoro che ti aspetta (siano campi o pavimenti o tinteggiature), perché i soldi non bastano e sprecare il tempo libero è proprio uno spreco… Ed è vero che se si è voluto capire qualcosa dell’incidente dove sono morti Poggio e Moro si è potuto fare proprio con il giornalino di don Billia. Ma è pur vero che il titolo è “Il fiume rubato” e non “La Valle Bormida”, per cui gli autori sono stati coerenti. Il problema è che per contestualizzare una fabbrica, una valle, una lotta, una storia di politici e di politica, di malattie e di pietanze, vacanze, auto nuove e figli che studiano, non basta una storia ben raccontata. E poi infine, la gente non è venuta. Ai giovani non interessa più, ai vecchi fa sentire male, fastidio. A dieci metri dall’attore c’era un gruppo di ragazzi che giocava a beach-volley ridendo e gridando. Perché? Perché questa approssimazione, questo chiasso? Perché non si poteva chiedere loro di non giocare, per stasera? Una cosa Perducca non ha detto: dove si fanno oggi i prodotti che si facevano a Cengio. In India? Nel 1988 avevo chiesto a Manfredi (attivista di Camerana) cosa avesse fatto se fosse riuscito a chiudere l’ACNA, se questa avesse riaperto in India. Lui aveva risposto che sarebbe andato in India a continuare la lotta. E invece oggi produce miele biologico a Camerana. Lui che diceva che non sarebbero bastati cento anni per bonificare la Valle Bormida, ora, vent’anni dopo, vende miele biologico. Chiudere una fabbrica è una sconfitta per tutti. Perché vuol dire che non si possiedono gli strumenti per produrre una certa cosa. Ma se c’è l’esigenza di un prodotto (pardon, un mercato) allora bisogna trovare il modo per farla. Ma non ne siamo in grado, perché l’interesse di un 43 capitale non è soddisfare un bisogno, ma vendere un prodotto. E se questa è la regola principale, le altre vengono di conseguenza. Dove sarà oggi il betanaftolo? Dove l’acido picrico? Dove le labbra gialle? E le automobili che si sono moltiplicate, bruciando idrocarburi e triturando bitume sollevandolo per aria. E i camion? E le innumerevoli betoniere, il loro viavai continuo non è un problema d’ambiente? Eppure ci piace avere lo svincolo, la rotonda, anche la casa o l’appartamento nuovi. E poi penso ancora ai più di mille morti di infortuni che abbiamo in Italia, e penso che ancora c’è qualcosa che non va, se non li sentiamo come un problema, se parliamo sempre d’altro, rispetto a quello che ci dovrebbe interessare. Ultima considerazione: questa serata dimostra che si può fare teatro, che non servono strutture particolari, impianti, scenografie, costumi. Come al solito serve soprattutto avere qualcosa da dire, poi gli spazi, le occasioni si formano con la perseveranza. Teatro non vuol dire obbligatoriamente palcoscenico, sipario, maschere e luci. Basta una piazza, un paio di lampade. Però sono indispensabili tre cose: un attore, una storia e la voglia di raccontarla. 44 Aurelio, Mariuccia, Teresa. Ho accompagnato mia madre e il suo amico Aurelio a trovare mia zia Teresa, la sorella di mia madre. Abita in Supervia, a Dego. Mia madre è la più giovane delle sorelle superstiti, Teresa porta dignitosamente i suoi 94 anni. Aurelio di anni ne ha poco più di ottanta, ma la circolazione e il diabete hanno minato severamente il pensiero, ed è triste vedere un uomo forte e pieno d’iniziativa com’era appassire lentamente, dimenticarsi, restare sempre più di sovente inebetito. Fortunatamente è sempre stata una brava persona e la malattia non l’ha cambiato in questo tratto, almeno per ora. Sorride, è cordiale, saluta con trasporto. Non chiede quasi mai niente. Il lato buffo di Aurelio, suo malgrado, è che nonostante le facoltà mentali limitate riesce perfettamente a sostenere una conversazione con uno sconosciuto: fa caldo, fa freddo, c’è siccità, non si sa più dove andremo a finire, una volta era meglio di oggi. Luoghi comuni, certo, ma che probabilmente si imparano in maniera tanto profonda da restare impressi come le facce dei nostri cari, ancor più: come le informazioni necessarie a respirare o a deglutire. E il bello è che l’occasionale dialogante non si accorge dei limiti del caro amico. Mia madre mi ha raccontato che dall’inizio dell’estate viene a trovarlo Adolfo, un vicino ottuagenario vedovo. Si siedono sotto il portico e chiacchierano e fumano. Mia madre ha provato a sedersi fra loro ed 45 ascoltare i discorsi. Si è stupita di come non parlassero di fatto assolutamente di nulla: discorsi sconclusionati, ognuno parlava per conto suo di un certo argomento accennando brevemente a certi particolari più complessi, l’altro annuiva serio, da esperto. Poi rispondeva con un altro argomento. Eppure passavano delle mezz’ore sfuggendo la canicola. Oggi siamo arrivati nel cortile di mia zia Teresa nel tardo pomeriggio. In un lato della piazza ci sono tre sedie, su due delle quali ci sono delle vecchine all’ombra. Appena ci avvistano una delle due comincia a chiamare per nome: “Giovanni!”. Rispondo che non sono Giovanni. “Giovanni?” “No, signora, non sono Giovanni, sono il nipote di Teresa”. Intanto la vecchina si avvicina. Mia madre la conosce e le dà una voce per salutarla: “Oh Mariuccia! Andiamo bene?” E lei: “Ma chi sei? La moglie di Giovanni?”. Insomma, viene chiarito l’equivoco e chiarito soprattutto che Giovanni (che il Signore lo guardi) non c’entra nulla. Mariuccia e mia madre si salutano, si baciano le guance. Nel frattempo anche Aurelio è sceso ponderosamente dalla macchina. Si guarda un po’ in giro, sorride, avvista Mariuccia. Le si avvicina e le chiede: “E noi non ci salutiamo?”. Da notare che i due non si conoscono, provengono da due paesi, anzi, due vallate diverse. Non c’è neanche una mezza parentela di ennesimo grado di mezzo. Eppure s’abbracciano e si baciano sulle guance, si stringono con trasporto le mani, si sorridono, si chiedono come andiamo e si rispondono che le ossa, l’età, le gambe, le vene… Poi si risalutano di nuovo: è venuta mia madre ad agganciare Aurelio per portarlo via di lì, perché finché Mariuccia sta là mia zia non apre la porta. Non per altro: è che Mariuccia è noiosa, pettegola e anche un po’ bacata, e mia zia non ha tempo da perdere… 46 Ricomposto il paesaggio magicamente mia zia compare nella fessura della porta. È piegata, cadente, vecchia, proprio vecchia, ma conserva un brillìo negli occhi proprio delle bambine sveglie, un po’ birbe, furbe. Ci fa entrare, ci salutiamo baciandoci le guance. Aurelio anche bacia e saluta. Poi si siede sul divano e s’addormenta. Mia zia ci offre caffè, vino, acqua. Poi parte subito con la descrizione dell’orto di quest’anno. Ci sono i pomodori, le melanzane, il prezzemolo. Ha fatto nascere scarola e indivia, sotto un sacco ben bagnato. Ha dell’uva bellissima, le peschette, il fico che suo figlio ha messo a dimora in mezzo al pollaio (ormai vuoto) è stato sarchiato e rinfrescato con nuova terra scura e grassa. Ha strappato per bene le erbacce, ha tolto le piante dei piselli ormai secche. Vedessi che belle zucchine che ho quest’anno. Andiamo a vedere? Non vede l’ora di uscire e mostrarti l’orto, soprattutto di farlo prima che arrivi il figlio, il quale non vorrebbe che la madre scendesse la ripida scaletta che adduce alla terrazza ben seminata e battuta, ordinata come un giardinetto, in cui Teresa passa larga parte del suo tempo. Prima di uscire si mette il mandillo sulla testa, prende il bastone: un palucco di nocciola di grosso diametro e troppo corto: ma a lei va bene così. Ci taglia un poco di insalata, ci regala uno zucchino. Poi torniamo in casa, ha voglia di raccontare il tempo passato, ma senza retorica, senza esagerare. Tutte le sue storie contengono un sorriso, storie di malattie, di fatiche, di paura, ma anche di soluzioni brillanti, dovute al caso, alla fortuna, alla fede. Il potere incombe e Teresa si difende come può. E il potere è indistinguibile: fascista, repubblichino o repubblicano. Ha litigato col generale Farina in persona, per via di un paio di vacche; avrebbe litigato o blandito camicie nere, carabinieri o guardie municipali, per il bene della sua famiglia, della sua “azienda” come oggi chiamerebbero una cascina. 47 Oggi si ricorda di quando, d’estate, il povero Renzo suo marito non poteva dormire per il caldo, e lei aveva sempre freddo. Il figlio s’era da poco sposato e c’era una stanza vuota. Bene: avrebbero dormito separati in modo da non discutere sulla finestra chiusa o aperta. Buonanotte. A quei tempi, ricorda Teresa, non avevamo ancora la corrente. C’era il lume sul comodino e basta. E di sotto, sotto il pavimento di tavole, c’erano le bestie. E quell’anno ce n’era una che doveva “fare”, partorire. C’era da starci attenti: le vacche quando partoriscono vanno aiutate, non le si può lasciare sole in un momento così duro. Si aiuta il vitellino ad uscire legandogli le zampe anteriori e, con l’aiuto di una carrucola, si tira fuori il cucciolo. Il povero Renzo quando dormiva non sentiva niente. Doveva stare attenta lei, alle bestie, alla partoriente. Nel pieno della notte, infatti, Teresa sente un qualche rumore che le fa capire d’essere arrivati al momento del parto. Emozionata, agitata, dimentica di essere a dormire nella stanza del figlio, salta giù dal letto chiamando Renzo, Renzo (il quale non sente) e anziché mettere i piedi sul pavimento finisce a cavallo del comodino, da qui ruzzola verso il muro dove prende una testata. Grida, ma si rimette in piedi nell’oscurità assoluta. Renzo! Renzo! Niente. Fa un passo per andarlo a chiamare ma s’inciampa nel tappeto e finisce con le gambe sotto il letto, graffiandosi e incastrandosi in malo modo. Finalmente arriva Renzo col lume acceso. Cosa c’è? Ti aiuto, ti sei fatta male? Ma vai va’, lascia perdere me che io mi aggiusto. Vai a vedere la vacca piuttosto, che sta per partorire, che l’ho sentita, vai, ma sbrigati! E mentre racconta Teresa sogghigna, sorride, ogni tanto addirittura ride proprio. Da quando i preti hanno tolto la gonna, dice, andiamo sempre peggio. E poi torna ad accennare alla storia che a me piace di più, quella del maestro vagabondo, il maestro Milano, l'antifascista. Dice, sempre sorridendo, che 48 se ci fosse ancora il maestro Milano, ci penserebbero lei stessa e lui a mettere a posto 'Bernasconi' e tutte le sue porcherie... Il tempo è passato, dopo alcuni convenevoli ci alziamo, risvegliamo Aurelio dal suo torpore, rimontiamo in macchina salutando perfino Mariuccia, che si alza e sorride agitando il braccio per aria, e ce ne andiamo da dove siamo venuti. 49 Un viaggio a Eataly Conosco Roby dal tempo della scuola. Adesso lui è quasi famoso, almeno in Piemonte, e non si dimentica degli amici anche nella buona sorte. Adesso è diventato Bertu di Lilu, un figuro dal brutto carattere che suona la chitarra nella “scelta orchestra” dei Trelilu. Uscendo il nuovo CD e presentando questo CD in una sala di Eataly, Berto mi ha invitato come amico (ufficialmente come giornalista) alla presentazione ed alla relativa cena. La storia comincia con un corvo nero, grande come tutti i corvi. Se ne stava appollaiato sul guard-rail della rotonda adiacente al casello dell’autostrada di Mondovì. Hanno costruito un enorme centro commerciale, lo svincolo, le rotonde, i muretti, i canali: tutto nuovo, tutto cemento, asfalto e metallo zincato. Lampioni arancioni e cartelli stradali. Non c’è un pezzo di terra libera a pagarlo, se se c’è è pieno di rumenta, o di praticelli esotici. Il corvo guarda tutto questo e continua a sorprendersi. Scrolla la testa e sorride: pare impossibile uno scempio del genere. Spicca un breve volo e si posa al centro della carreggiata. Cammina ponderoso: è l’unico padrone del luogo. Prima che arrivi un camion è saltato al centro della rotonda e da lì domina. Sta pensando che gli umani sono strani, che suo bisnonno gli raccontava di quando quella pianura era di mais, di grano, di erba medica. Erano tempi durissimi per i corvi, erano mal visti. Poi è cambiato 50 tutto e i campi di mais sono stati confinati. Gli umani preferiscono l’asfalto e il cemento, e le luci arancioni. Ed è meglio anche per i corvi: mai stati meglio, mai prolificato così bene. C’è rumenta dappertutto e quindi c’è da mangiare. Finalmente è arrivato anche Roby e io ho smesso di fare il moralista immerso nella testa di un corvo che cominciava a guardarmi con sospetto. Viaggeremo con Franco, che suona il contrabbasso. Lo strumento necessita di una station-wagon. Poi c’è la chitarra di Roby, tutta l’attrezzatura e il materiale promozionale. In definitiva ci stipiamo dentro, di modo che posso sentirmi per un attimo un vero artista vagante, anche se non faccio parte della compagine. Eataly è un supermercato con carrelli e casse e commesse e luci. C’è di tutto, ma è tutta roba buona, pulita e giusta. È il risultato dell’accoppiamento tra Slow Food e l’Ikea. Le signore bene di Torino (ma anche solo le persone comuni) vagano alla ricerca del prodotto sopraffino, di nicchia, all’antica, originale. Noi abbiamo fretta, e saliamo al piano di sopra, dove ci sarà conferenza stampa e cena. Al piano si sopra c’è la cosa che più mi ha toccato di Eataly: in queste strutture, oggi così lustre, colorate, alla moda, rasserenanti, un tempo lavorava la Carpano, produttrice di liquori e vermuth. I corridoi e alcune sale, alcuni laboratori sono stati lasciati così com’erano, da quando la Carpano è stata liquidata e trasferita a Milano. Ci sono serbatoi di rame, valvole e tubi, caldaie a pressione. Mi colpiscono i particolari: il pavimento di gres, l’impianto elettrico antideflagrante, la vetreria di laboratorio nell’armadio di vetro, esposta a celebrare il passato. Questo posto assomiglia maledettamente alla fabbrica nella quale lavoravo io fino a qualche tempo fa, e che ora sta crollando. 51 La conferenza stampa è divertente: i Lilu sanno intrattenere e scherzare. Ne suonano anche un paio. Chiacchiero con un paio di conoscenze, poi in un attimo è ora di cena. La sala da pranzo è un ampio locale suddiviso da tendaggi. C’è una struttura in carpenteria metallica, una trave a “doppio T” imbullonata, una grande vetrata che mostra le luci di Torino. Io ci sento la memoria della città nebbiosa e industriale degli anni ’60 e ’70. Ora è ristorante: una signorina comì ci fa accomodare agli ampi tavoli tondi. Le signore sfoggiano toelettes, come forse facevano solo nei romanzi romantici per fanciulle di fine ottocento. I signori sono più sbracati, ma sono tutti abilissimi a far roteare i bicchieri sottilissimi. Serata polenta, in onore di un mulino di Cossano Belbo che macina un chicco alla volta facendo piano per non disturbare troppo il seme. Mangiamo polenta e baccalà, polenta e spezzatino, polenta e formaggio, polenta e marmellata, biscotti di polenta. Beviamo spumantino, nebbiolo e moscato. Al mio fianco un distributore di musica, ex imprenditore edile, mi spiega tutto della vita e della morte. È interessante il tipo: basta dirgli un soggetto che lui subito risponde con una delle seguenti possibilità: A) l’ha fatto lui B) l’ha fatto fare C) ne ha seguito la progettazione/costruzione D) conosce benissimo quel tipo lì che lo ha fatto. Inoltre ha una competenza estrema di sociologia (“Vedi qui, in questa sala, ci sono due tipi di persone: quelle della Torino bene e gli altri”. “E come si distinguono?” “Eh, così, si distinguono…”). E come se non bastasse è un raffinato gastronomo ed enologo. Rotea benissimo il bicchiere, fa boccuccia mentre sorbisce quel nebbiolo ordinario, assaggia in punta di forchetta i piatti, illustrandomi tutto. Alla fine mi spiega anche la polenta, cos’è, come si fa. Sono sul punto di dirgli che io la polenta me la faccio, che la porto al mulino a macinare, poi, eroicamente, desisto. 52 Alla mia sinistra c’è una madama quarantenne in gran spolvero. Mostrerebbe un po’ il seno, ma non ne ha. Pallida, quasi esangue. Lei, da buona madre, cucina spesso la pòlenta per i figli, gliela taglia a cubetti e la condisce col pomodoro e i piccoli la mangiano, convinti che sia pasta. “Ah, e quanti anni anno i bimbi?” (le chiedo). Dodici e undici. Ma come, penso, non riconoscono la polenta dalla pasta? In quella famiglia ha problemi la madre o hanno problemi i figli. In ogni caso non riesco a immaginarmela ai fornelli. A fare la spesa si, a scegliere questo e quello perché fa più bene, ma a cucinare no. Anche perché cucinare è rendere edibile una cosa che non lo sarebbe (o lo sarebbe con difficoltà) e invece questa madama cucina scegliendo, disponendo, impiattando, guarnendo; una cucina di gerundi che finisce per dare una immagine fantastica del mondo ai bambini. Un altro signore dice che non sopporta i ceci: sanno troppo di mare. Me lo faccio ripetere, ma è proprio così: sanno di mare. Sto per ridere, sto per chiedergli se si sente bene. Poi mi taccio: sono pur sempre ospite. Quindi educazione, misura. Registro tutto e taccio. Ho visto che i commensali hanno pagato 40 euro per questa cena che mi è stata gentilmente offerta. Devo dire che il baccalà era buonissimo, come pure lo spezzatino (che ora ci si ostina a chiamare “bocconcini”), ma quaranta euro mi sembra una cifra sproporzionata, fatto salvo per il servizio: tanti camerieri, tanto gentili, tanto rapidi. I Trelilu hanno suonato, sono stati applauditi. Gli ho dato una mano con gli strumenti e siamo tornati verso casa. Per la mezzanotte ero di nuovo nel parcheggio vicino al casello di Mondovì. L’aria fresca di novembre mi ha schiarito la testa, ripensavo a quel che ho visto e quel che vedo ora: qui, fino a vent’anni fa, c’erano campi di granturco, patate, fagioli. Poi c’erano i prati, la soia e non so cos’altro. C’era un canale per l’irrigazione dei campi. Non c’erano prodotti tradizionali, si mangiavano solo cose da 53 supermercato. La polenta la si trovava come anonima fettina, negli antipasti, supporto a qualche goccia di sugo, fra vol-au-vent e i sorbetti al limone. Ora che abbiamo cominciato a cementificare e asfaltare i campi più belli, ora che copriamo i canali d’irrigazione con strutture prefabbricate, ora che abbiamo demolito un sistema sociale produttivo e un ecosistema ricco di animali diversi, abbiamo aperto alla rumenta e ospitiamo serenamente ratti, corvi e mosche, ora scopriamo il territorio. Mio nonno, mio padre, hanno dovuto mangiare polenta per forza per tanto tempo. Poi le cose sono cambiate e hanno potuto scegliere di mangiare anche qualcos’altro. Adesso celebriamo la condizione in cui non si poteva scegliere come fosse una cosa bella e giusta. E intanto, gli stessi che sorbiscono, commentano, gustano, sono gli stessi danarosi signori che esigono uno svincolo autostradale o lo costruiscono, o lo amministrano. Il corvo non c’era più. Chissà dove sarà andato a dormire il re indiscusso della terra che gli uomini abbandonarono. 54 Prima di leggere questo appunto dovreste guardare il filmato al link sottostante, dura solo pochi minuti. http://www.youtube.com/watch?v=-WtdMwjmRd8 Premessa Scrivo quando mi emoziono: m’arrabbio, mi diverto, mi incanto. Se provo un’emozione devo cercare di metterla per iscritto, di trasferirla in parole, possibilmente comprensibili. Poi mi piace condividere le parole con alcuni amici, alcuni conoscenti, magari anche con persone sconosciute, e attendere un commento, una critica, un’opinione. Ecco perché questo scritto. Il disperato Lui ha i capelli ben impomatati, brillanti. Ha una faccia cordiale, ampia, serena. Si trova in una sala da ballo, o una osteria, dove c’è gente di diversa estrazione. Sono tutti appoggiati in qualche modo a qualcosa, spesso hanno sguardi verso il basso, come chi, affranto per un lungo viaggio, non ha trovato quel che cercava e si sente nuovamente al principio della stessa salita. 55 C’è anche un uomo in divisa, un marinaio forse. Ci sono varie signorine che sai spregiudicate, forse sguaiate, indurite da una vita da tanghèra, stanche di promesse e di odor di coppale. Eppure vinte anche loro dalla canzone che l’uomo canta. C’è lei, presumibilmente in una stanza vicina, che ascolta trasognata. Trasale, si emoziona fino alle lacrime, fino a sorridere quando il cantante parla della sua bocca mendace, dei suoi occhi stregati. Come mai emoziona tanto una canzone, una vicenda racchiusa in un paio di minuti, un titolo neppure facile da comprendere (“Cuesta abajo” cioè: “Ridiscendo nel mio girare”)? Cosa c’è di condivisibile in questa storia? Io almeno non sono mai stato marinaio, non sono mai stato in Sud America, non sono mai stato in una posada frequentata da marinai disperati e donne leggere. Sono stato disperato, questo si, per amore. Come penso succeda a tutti appena superata la dozzina d’anni. Forse quelli a cui può piacere questa canzone, questa storia, questo filmato, sono coloro i quali ricordano bene la disperazione sconfinata che solo un adolescente può provare. Di fatto, a pensarci bene, solo a sedici anni ci si sente distrutti per amore, ci si può sentire senza speranza, bruciati, finiti. Seduti su una panchina solitaria, considerando la solitudine, la perdita di tutte le opportunità e le occasioni, destinato ineluttabilmente ad una vita raminga, solitaria e disperata. Salvo poi, dopo soli cinque minuti, naturalissimamente, ridacchiare con altri amici, tornare a innamorarsi, giocare e fare tutte quelle cose che competono all’età di mezzo: né bambini, né adulti, che molti dicono essere bellissima e sulla qual cosa io avrei qualche dubbio. Ma la verità è che indulgere su quel tipo di disperazione è divertente: in realtà è bellissimo interpretare la parte del disperato, ancorché giovane, aitante, manco povero. Che gusto c’è ad essere uno “normale”, con le sue sfighe regolari, le sue fortune, la sua serenità acquisita in tasca. Meglio 56 rappresentare un vissuto da naufrago, da esule inseguito, da legionario, da pirata o almeno da imprenditore ricercato, piuttosto che da grigio impiegato regolare. “…Per cui bello di fama e di sventura baciò la sua petrosa Itaca, Ulisse” scrisse un poeta. Aveva capito: la bellezza (soprattutto per gli uomini) è una questione di vissuto. Chi si salva dal gorgo si purifica e rinasce alla vita ristorato nel fisico, a patto che però sia un po’ sfigato, che si sia salvato per un pelo, ma abbia perso tutto, o quasi tutto. Gli rimanga la disperazione. Lui (il nostro cantante) non lo sa, ma mentre canta Lei si strugge. È preda della malinconia, della nostalgia, del dispiacere delle cose perdute, del tempo passato che nunca volverà. Altra cosa che può far piacere: lui, disperato, canta la sua disperazione. Lei ne soffre, perché si rende conto solo allora, solo in quel momento realizza di aver perso ogni bene, e ne piange silenziosa fino a sorriderne vinta da una dolcezza profonda. Lei (occorre dirlo) non è che sia il massimo della bellezza. Ma è giusto: come farebbe una “super donna”, una attuale velina (per dire) sana come una rovere e giovane come l’aglio, a rappresentare tutta questa disperazione? Ci vuole una donna esile, un po’ affaticata, in odor di tubercolosi, con lo sguardo un po’ triste e ansioso di ricevere cure, affetto, amor (che va usato solo nella forma tronca). Si tratta anche qui di un tipo di retorica, di ricostruzione scenica di una serie di sentimenti umani. Ma siamo lontani dalla retorica cara al potere. Siamo lontani anche dalla retorica dei buoni sentimenti regolari, di molte canzoni popolari anche italiane, dove il cuore e la mamma aspettano il ritorno. No. Qui ci sono partenze, ci sono persone che lasciano altre persone, ci sono struggimenti infiniti causati da incomprensioni tragiche durante le quali gli uomini perdono “pezzi di cuore” ad ogni svolta. 57 Eppure le storie funzionano proprio su questa base: non c’è film, non c’è storia d’amore antica, vecchia o recente, che si occupi dell’amore “dopo”. L’amore è quello che non si riesce a completare, ed è così sotto tutti i cieli. Basta vedere i vecchi film indiani, anche senza capirci una parola. La trama è sempre la stessa: lui è un bell’uomo coi baffi, conosce casualmente lei, prosperosa signorina benestante dagli occhi neri, col terzo occhio ben disegnato in mezzo alla fronte. Si amano senza conoscersi, si amano di lontano, solo guardandosi. A un certo punto accade il misfatto: viaggio, guerra, alluvione, dischi volanti… Insomma, il casus belli che allontana i due. Traversie separate, sofferenze indicibili, perdita di ogni speranza di ritrovarla (lo) viva (vivo), per poi arrivare al giorno fatidico in cui i due si incontrano e, scomparse tutte le cause che ostavano, convolano a giusta unione. Da quel giorno in avanti non c’è più niente da raccontare, fine. La stessa trama dei Promessi Sposi, le stesse trame dell’italico melodramma per cui un qualche letterato aveva riassunto tutte le trame possibili con: “Il baritono vuol portarsi a letto il soprano, ma il tenore non vuole”. Tutte le storie devono passare per la disperazione, ecco la realtà. Per questo a sedici anni si può (o si deve, addirittura?) essere disperati, perché così ci si può stupire di quanto non lo fossimo stati. Perché ricordare il tempo passato che non torna più è struggente, ma serve anche a riprendere il fardello in spalla e a ripartire. Questa storia di disperazione “utile” ha una radice profonda nell’America del Sud evidentemente perché si attaglia bene all’animo degli emigranti. Lavoriamo, commerciamo, spostiamo mandrie tutto il giorno, conduciamo navi e battelli, peschiamo, fondiamo vetro, macelliamo bestie e le inscatoliamo, conduciamo fazendas, fondiamo banche, facciamo girare moneta sonante. Ma la sera, quando anche il sole si ritira, ci appoggiamo 58 pensierosi al bancone, disperati. Siamo venuti qui per ritornare, ma non abbiamo più un posto dove tornare. Siamo innamorati di donne che non ci amano, oppure che forse ci amano, ma che oramai abbiamo perduto. Lasciateci rappresentare questa stanchezza, questa dolce disperazione, questa nostalgia di casa, di Italia, questa malinconia di un’altra rappresentazione che sappiamo benissimo non esistere. E questo ci strugge ancor più: siamo disperati a causa di qualcosa che non esiste. E lo sappiamo. Vent’anni fa è tornata a Giusvalla una signora che aveva lasciato il suo paese nel 1950 per l’Uruguay. Era ospite di parenti, aveva una stanza e molto tempo libero. Camminava tutto il giorno da una casa all’altra, da una cascina all’altra, fra boschi, sentieri, strade. Poi tornava al cimitero. Piangeva tutto il giorno. Diceva: “Non ci avevo pensato. Sono passati trent’anni, non c’è più quasi niente che assomiglia al paese che avevo lasciato: gli alberi crescono, i fossi si interrano, le strade cambiano. Le persone invecchiano e poi muoiono. E le cascine sono tutte deserte e sfondate, e io me le ricordavo piene di gente, e speravo di tornare, salutare, sedermi e raccontare. E invece non c’è più nessuno: sono tutti al camposanto. E io a chi racconto tutto quello che ho visto?”. È tornata in America per l’ultima volta, convinta che ormai il suo Paese fosse quello. Il cantante, lo avrete letto, è Carlos Gardel, morto negli anni trenta in un incendio aereo. Il testo della canzone, tradotto in italiano (traduzione trovata sul web) è il seguente: se ho trascinato per questo mondo la vergogna di essere stato ed il dolore di non essere ora, sotto la falda del cappello quante volte coperta 59 una lacrima spuntava senza che la potessi trattenere. se ho vagato per le strade come uno che il destino ha cercato di distruggere; se fui debole, se fui cieco, voglio solo far comprendere il valore che rappresenta il coraggio di amare. era per me la vita intera, come un sole di primavera, la mia speranza e la mia passione. sapevo che nel mondo non ci stava tutta questa umile allegria del mio povero cuore. e adesso, ridiscendo nel mio girare, le illusioni passate oramai non le posso sradicare sogno il passato che rimpiango, il vecchio tempo che piango e che mai più ritornerà ... per seguire le sue orme ho bevuto instancabilmente nel mio bicchiere di dolore; ma nessuno comprendeva che se io davo tutto, ad ogni svolta lasciavo pezzi di cuore... 60 ed ora, triste nella caduta, solitario e oramai vinto, io mi voglio confessare; se quella bocca mentiva l'amore che mi offriva per quegli occhi stregati io avrei dato sempre più... 61 Metodologia e approccio tematico nelle problematiche di ricerca storica sul territorio. Ho registrato la mia vecchia zia con una videocamera. Ha novantadue anni, tutto sommato è un po’ noiosa. Ti sistemo io, ho pensato, hai sempre qualcosa da raccontarmi e io non ho mai tempo di starti a sentire. Ah si? E allora dài… Videocamera accesa su inquadratura fissa, microfono, tutto a posto. E la zia parla, racconta, ripercorre fatiche, profumi, cibi. Imita facce, voci. Quando le faccio una domanda studia il pavimento, a volte si succhia il labbro. Povera piccola potentissima zia, dalle mani consunte quanto i tuoi vestiti, i capelli scarmigliati e grigi, bocca senza denti ma occhi vispi e, diresti, birbanti. Racconta tranquilla ma se la vai a cercare la trovi. Le chiedo cos’era il fascismo. Allarga gli occhi e dice che per loro, allora, era una cosa come un gioco, che li facevano vestire bene, che li portavano in gita, che gli dava i quaderni. Poi fa una piccola pausa ed esclama: “Poi ci hanno detto che è tutta una schifezza, una dittatura”. E in quegli occhi leggo: “Lo so quello che è giusto dire del fascismo, cosa ti credi?”. Poi parla del maestro Milano, un vagabondo, uno di quelli che passava e dormiva dove capitava e mangiava quel che gli davano. Insegnava ai bambini a leggere e scrivere, alla sera anche ai grandi, era tenuto in grande considerazione, rispetto, quasi timore. Aveva scritto a 62 Donna Rachele per via di una famiglia povera, aveva scritto a Mussolini per far costruire una scuola. Era l’interprete con il potere, anzi, il Potere. È una storia che mi incuriosisce. Inizio a parlarne con tutti: amici, parenti, gente che conosco appena. Davide, che se ne intende di certe questioni di scuola e maestri, dice di insistere, che non è una ricerca d’archivio, la mia, basata su dati certi, ma più che altro sulla traccia nella memoria che un maestro (sia pur vagante) ha lasciato. Mia zia dice che è stato sepolto nel cimitero della Ferriera di Montenotte. Non è difficile andare a vedere, il cimitero è piccolissimo, fra i boschi, abbarbicato a mezza costa, per non rubare spazio ai campi (allora) coltivati. Vado, ma non c’è nessuno con quel nome, nessuna croce ignota, niente di particolare. È ancora viva la signora Paola, che gestiva l’osteria. Accetta di vedermi. Abita al piano di sopra rispetto alla vecchia locanda. Sta sulla sedia a rotelle, sola con un badante sudamericano con il quale non va molto d’accordo. Certo che si ricorda del maestro Milano: passava da una casa ad un'altra, insegnava a leggere a scrivere a tutti, grandi e bambini. Ho una fotografia, dice, ma devo cercarla. E intanto, aperto il baule dei ricordi, saltano fuori vicende di madri, fratelli, mariti. Di cene luculliane, di cacciatori, di funghi. Di nevicate epiche, di ladri, puttane, preti, soldati. Faccio fatica a lasciarla. Dopo qualche giorno telefona uno, dice che ha saputo che cerco notizie del maestro Milano. Lui non l’ha conosciuto ma forse conosce qualcuno che l’ha conosciuto. Si farà risentire. Dopo qualche giorno richiama, dice che il suo amico anziano è in ospedale, se sopravvive potrà raccontarmi tutto lui, intanto di annotarmi che Milano non era il suo nome. Si chiamava Sacchi Luigi ed è morto nel fienile della cascina Bandita, nei boschi di Montenotte. È settembre, sono a casa e non ho nulla di più urgente da fare. In più ho un paio di scarponi nuovi che non ho ancora provato. Bene, andiamo a visitare la Bandita, perché anche solo un nome così merita una visita. 63 Dalla Ferriera di Montenotte si prende la stradina asfaltata verso Dego, appena superate le vecchie scuole, prima del fiume, si prende a sinistra, su sterrato. All’inizio della strada ci sono numerosi cartelli: “Divieto d’accesso”, “Vietato entrare”, “Proprietà Privata”. La cosa m’inquieta: sono al cospetto del deposito di Paperon de Paperoni? Da cosa avrà mai da proteggersi il padrone di casa con questi cartelli. Tuttavia la strada non è sbarrata, anzi: è larga e piena di ghiaia portata apposta. La strada sale abbastanza ripida fra i faggi. C’è silenzio, il silenzio del bosco, pieno di scricchiolii, fruscii e versi di uccelli. Al termine della salita si intravede la luce, dev’esserci una radura. Infatti c’è un prato da qualche anno non più falciato. L’erba lunga e secca sembra i capelli di un vecchio spettinato. Poco più oltre c’è un prato verde, ben falciato. Al margine alcune piante da frutto. Proprio sulla strada un pero, sotto, in mezzo alla via, decine di piccole pere gialle. Le conosco, non so come si chiamano ma le conosco. Sono pere dolcissime vagamente allappanti, sugose che se uno non sta attento si inzacchera. Nessun frutto è schiacciato, quindi da stamattina o ieri sera nessuno è salito su in macchina. Forse ci vanno alla domenica, forse sono villeggianti. Comunque non ne colgo nessuna, non so ancora chi è il padrone. Proseguo e sfilo sotto una vecchia cascina abbandonata, cintata, con alcuni cartelli minacciosi intorno. Proseguo sempre più inquieto. Penso che il padrone, qui, dev’essere uno un po’ aggressivo, magari ha qualche cane libero, più cattivo di lui… Cerco un bastone e lo uso per appoggiarmi, ma intanto penso che se un cane m’aggredisce vedrò di vendere cara la pelle. Salgo ancora, ho il fiatone perché non sono abituato a camminare. Al termine di una nuova rampa trovo un’altra radura. Ci sono prati falciati, mucchi di foglie di faggio secche, ortensie fiorite vigorose. Dev’esserci molta acqua da queste parti: le ortensie vogliono 64 bere sempre. Poco più avanti c’è la casa e altri cartelli “attenti al cane”. Non so che fare… Proseguo: ormai sono qui, al massimo mi cacciano. Mi faccio avanti e noto il camino che fuma. A questa stagione? Fuma? I casi sono due: o saponificano abitualmente i curiosi di passaggio o ci abita persona anziana e sola, che non sa come passare il tempo. Sono nella corte. Il terribile cane, un segugio preoccupatissimo, si è rifugiato subito nella sua cuccia ricavata da un castagno cavo. Provo a chiamare, a fischiare. Silenzio. Poi qualcuno risponde. Spunta sulla porta un uomo, avrà passato la cinquantina da un po’. Capelli biondicci arruffati, pancia tonda, camicia vissuta. Gli dico che cerco la Bandita, se sa dirmi dov’è. Si, è nel mio, dice, su da quella strada. Vieni in casa. E mi fa entrare, subito. Mi precede verso una cucina piccola e sicuramente rimasta tal quale al momento in cui morirono i vecchi: gli anni ’70. Fòrmica, tovaglia di plasticone a fioroni. La stufa accesa. Gli spiego per sommi capi del maestro Milano. No, non ne sa niente del maestro. Lui lavorava a Vado, s’è sposato e poi è andato a stare a Pontinvrea. Sua moglie sta là. Ma lui nel chiasso non ci sta volentieri (A Pontinvrea c’è chiasso?!) e allora sta qui. Fa un po’ di legna, va un po’ a caccia, fa un po’ d’orto. Ma solo un po’ perché tanto è vecchio e non è che ci sia tanto da fare… La pensione mi basta e allora perché cercarsi altre grane? Mi offre da bere, il caffè. Ringrazio ma ho fretta. Proseguo verso la Bandita, se mi indica la strada. Si, è di là. Adesso vengo anch’io col trattore. Mi incammino, tanto ci vediamo là. Attraverso ancora un prato e poi di nuovo nel bosco. Ai bordi della strada sono sbocciati fiori che non conosco, ogni tanto affiora l’acqua formando piccole zone fangose. Intorno ci sono faggi e faggi, non molto grandi, ma diffusi. Al sommo la vasca dell’acquedotto che gorgoglia. La strada prosegue a mezza costa in una tagliata dell’anno scorso. Ci sono tutti i cespugli nuovi e si può vedere la cresta della cima. Alla fine compare la 65 Bandita, una cascina grossa, possente, squadrata come una caserma. Bianca di calce. Due seccatoi, diversi stabbioli, un fienile. Dietro la casa alcuni bei prati quasi in piano. Davanti un panorama che spazia dai boschi della vallata di fronte fino ai salienti della provincia d’Alessandria. Leggo sulla cartina 765 m s.l.m. Qui l’inverno deve essere bestiale. Romba il trattore e arriva anche il padrone. Si ferma e spegne davanti a me, per dirmi che ora neve non ne viene più. Quando veniva arrivava fino alle finestre del piano di sopra. Sotto la cucina la stalla, davanti alla stalla la concimaia, davanti alla concimaia l’orto. Tutto abbandonato ma mantenuto. Era la casa dei suoi di sua moglie. Mia suocera è morta di parto, mi dice, e così sono rimasti soli. Quando il padre è venuto vecchio sono andati a stare a Pontinvrea. Io anche, che sono della cascina lì sotto. Vedo il fienile, quattro pilastri e una manciata di tavole. Qui ha dormito il Maestro Milano. Qui ci è morto. Niente, ovviamente, lo ricorda. Non so perché sono venuto qui, ma mi faceva piacere toccare con mano qualcosa di raccontato. Nel fienile ci sono alcuni fascetti di legna ben fatti, ordinati, tutti della stessa misura. Gli dico che è un bel lavoro. Lo fa per le pizzerie, la comprano volentieri così. Ma lui non ne ha voglia, non ha testa, è un traffico. Non rende. Lo guardo. È un uomo stanco dentro. Non ha più niente da fare qui. È il guardiano e il sacerdote degli antichi possedimenti di famiglia, ma si è dimenticato anche il perché si trova qui. Posiziona cartelli e catene, chiude con lucchetti e serrature, ma nessuno lo va mai a trovare. Cambia tegole, ripara grondaie, taglia i rovi, ma non sa perché. Prova a fare un po’ d’orto, ma i pomodori seccano, le patate son brutte, le zucche patiscono la sete. Dilata gli occhi azzurrissimi, balbetta. Non è abituato a parlare con nessuno. Qui è solo silenzio, gazze che s’inseguono, qualche cinghiale. Sì, dice, si potrebbe fare un agriturismo, ti darebbero anche dei soldi. Ma non ho testa, ho un età che oramai… Così lo lascio nella sua trincea, a fare la guardia a una cosa che nessuno assale, 66 mi ricorda quei vecchi soldati giapponesi dimenticati su un isola deserta e mai più ritrovati, ma fedeli alla consegna e al loro imperatore. Scendo con tutta la solitudine e la tristezza di quell’uomo. Penso al maestro Milano, ai suoi passi, alla sua stanchezza fra questa gente. Passo di nuovo sotto quel pero, ora so anche di chi è e non credo che abbia niente in contrario se me ne prendo una manciata, sotto la pianta, mentre cammino. Scelgo le più integre. Sono profumate e madide, dolcissime, con la buccia dura di un giallo carico. Il maestro Milan le avrà mangiate pure lui, in un giorno di fine estate come questo, e si sarà detto fortunato per quella volta, per aver trovato gente disposta a regalargli un paio di pere. Più in basso mi fermo a sciacquare le mani appiccicaticce per via della frutta matura. Il ruscello è scarso d’acqua ma è freddissimo, emana un profumo marcato, umido, di terra e di foglie marce che ricordo bene, che per un lampo mi riporta ai ruscelli delle cacce e pesche instancabili da bambino. Scendo a valle e mi viene in mente che potrei portare una foto a quel tale che mi ha contattato. Si chiama Alberto e ha dei camion. Non è difficile. Chiedo e trovo al primo colpo. Una casa linda, bianca, una villa, coperta di fiori, di cotto, di muretti. Gente così ci tiene alla casa, magari dice: niente estranei, niente rompiscatole… Ma ormai son qua e provo. Non c’è campanello, non c’è cancello. Prima di entrare chiamo, fischio. Risponde e si affaccia una signora. Sorride, scende, mi apre. “Venga in casa!” Prima di tutto entrare, come quell’altro lassù, poi parlare. Perché non sta bene far parlare uno in mezzo alla strada. È magra ed energica, è stata una bella donna assai corteggiata. Ora non molti passano di qui, non vedeva l’ora di scambiare quattro chiacchiere, di offrire una bibita. La casa linda, immacolata, i muri glabri. Qualche foto di funghi. Sorride, la signora, non ha conosciuto il maestro Milan, non è del paese, è di fuori, di Pareto. E poi dipana vicende sue, di sua madre che ormai non c’è più, dei figli, dei cognati e vicini. Loro, gli uomini, oggi 67 sono in Piemonte per vedere un lavoro. Come sempre, dice sottotraccia, loro in giro e io a casa da sola, ad accudire l’orto. Che una volta si era in 15 per famiglia e adesso siamo in tre. Però ospitiamo amici magari alla domenica e capita di fare tavolate di più di 15 persone, altroché. Le lascio la foto, la darà al marito, quando torna. La saluto sorridendo. Belle persone, penso. Lavorano, se la godono meglio che possono, sorridono. E penso all’immagine che ci dà della realtà la televisione, una realtà di delitti, corruzione, truffe e rapine per un verso e per un altro veline, palestre, salute, seni e bicipiti, record e raglan. E questa gente dove sta? Chi ne parla di quelli che ti ospitano senza chiederti niente e se possono ti aiutano? E non ti chiedono nulla: vieni in casa, ti dicono, perché hanno rispetto. Il maestro Milan, prima di lui i disertori napoleonici o della prima guerra, i partigiani poi, sono vissuti anni e anni fra queste colline proprio perché c’era questa gente. Non è retorica, non è un sogno di anarchia teorica. È semplice convenienza per l’uomo animale gregario, parente fra parenti, viaggiatore, anzi viandante fra viandanti. Come nelle favole: ti avvicini ad una casa perché un camino fuma. Chiedi permesso, un pezzo di pane, un po’ d’acqua e da dormire nel fienile. In cambio aggiusti una sedia, provi a guarire una bestia, insegni a leggere, leggi, insegni a scrivere, scrivi per conto di altri al duce o al presidente della repubblica. Tutto questo non dovrebbe essere una notizia, una novella. Tutto dovrebbe essere normale, è che ci hanno disabituati all’umanità. 68 L'edificio frutto del tempo Camminare è salutare e piacevole. Non solo in un bosco o in montagna, anzi: per meglio esercitare il proprio senso critico bisognerebbe alternare luoghi selvaggi (per quanto sia possibile trovarne) a luoghi fortemente segnati dall’uomo, sia nel passato, sia attualmente vissuti. Di Cairo Montenotte mi ha da sempre colpito la profonda spaccatura, la divisione netta tra passato e presente (con alcune incursioni di quest’ultimo a danno del passato). Ha un centro storico che oggi diciamo “bello” poiché caratteristico: viuzze strette e irregolari, negozietti, alcuni portici, il selciato. Di fatto non ci sono edifici di particolare pregio, monumenti o chiese. È un borgo a pianta irregolarmente ortogonale, con la sua bella via centrale che collega la porta di accesso superiore a quella inferiore. I portici mettono in comunicazione la via maestra con la stradina della muta chiesa, senza facciata, ma dall’importante campanile. Il primo elemento di modernità è forse rappresentato dalla piazza, che s’è formata tra il borgo e quelle che erano le scuole. Da qui in avanti troviamo le case presuntuose di “Cairo nuovo”, e cioè le casette degli impiegati, degli emancipati dai nuovi impianti industriali, sviluppatesi soprattutto a partire dal dopoguerra. Non prive di una propria personalità, talvolta declinate nella versione di “palazzina” a più appartamenti, talvolta case bifamigliari, con annesso orto e cancello per consentire l’accesso dell’auto, finalmente. 69 Più recenti sono i palazzacci, alti e sgraziati, costruiti dove si poteva e non dove si voleva. In quel momento abitare là voleva dire “essere” di quell’ambito: impiegato, tecnico, amministrativo. Man mano che ci si allontana da quella zona e si procede verso il fiume e verso Cortemilia i palazzacci peggiorano: sempre più accatastati, sempre meno parcheggi o aree verdi, sempre più grandi occasioni per i costruttori. Il processo prosegue fino ad arrivare a Cairo Due, complesso residenziale senza negozi, senza servizi, cementificato e brutto, di una bruttezza semplice, di chi ha voluto farlo brutto, di chi non aveva manco l’intenzione di edificare una peculiarità, e gli è scappata una bruttura. All’altro lato del centro storico spiccano i palazzi più alti. Uno in particolar modo, che si trova di fronte alla casa comunale, è terribile. Volendo, per l’appunto, realizzare qualcosa di inedito, il progettista ha ideato un edificio in cemento, con portici, vetrate, pilastri. Solo che i pilastri sono piccini, diresti gracili. Il cemento non è stato realizzato a regola d’arte e segna pesantemente sulle giunture, mentre la muffa nera macchia la facciata, l’alluminio dei serramenti è di un bel rosso vivo che rimarca pesantemente le linee squilibrate e goffe di un catafalco pesante e ingombrante. Le vetrate, difficili e onerose da pulire, rimangono per anni vistosamente sporche. Dirimpetto, in via Colla, c’è un altro condominio, un tempo sede del cinema Cristallo. Nove piani di cemento. Muto anch’egli. Non ha altro da dire se non il rivendicare di essere figlio degli anni Sessanta e Settanta, quando l’emergenza era fare abitazioni, belle o brutte, ma farne tante. Perché si vendevano, perché si poteva, perché nessuno avrebbe protestato, perché ci sembrava bello un palazzaccio del genere, desiderabile, forse. Così ne hanno costruito altri quattro o cinque. A guardar bene, però, si percepisce pure il “seme” di questi palazzacci: fra un condominio e l’altro si sono misteriosamente salvate due case, peculiari, caratteristiche, eppure quasi invisibili. La prima è quasi nascosta 70 da un distributore di carburante (che solo per questo andrebbe spostato), la seconda poco più avanti, fra altri due palazzi enormi. Quella dietro al distributore è stata costruita (io credo) negli anni Trenta, è cubica ed armonica nelle sue proporzioni generali. Le finestre, le porte, sono ricamate da modanature in rilievo chiare. Ci sono pochissimi spigoli vivi, i particolari sono tutti arrotondati, come anche i balconi. Questo edificio mi parla dei criteri costruttivi amati nel ventennio, credo si dicano “razionalisti”, e mi sovviene un altro piccolo gioiello: il dopolavoro di Ferrania, abbandonato e prossimo alla rovina. Sono stato dentro questa casa un po’ di tempo fa. La porta di ogni appartamento si apriva su un vestibolo in cui la persona di servizio vi avrebbe fatto attendere. Una cortina pesante avrà forse separato questo locale dal salottino. Mentre le altre stanze avevano ognuna la sua porta. A terra il pavimento in graniglia di marmo, con decori continui che si inseguivano in tutte le stanze. L’altro edificio, mi ha detto un cairese con un certo orgoglio, è “Il più vecchio di Cairo”. Questa affermazione merita d’essere approfondita. Si tratta certamente si una piccola svista: tutto il centro storico esisteva perlomeno nel medioevo, quindi gli edifici costruiti fuori dalle mura, in genere, sono più recenti. Ma è curioso che il cairese sappia e noti, in cuor suo, il valore di quel palazzo (sia pur moderno), rispetto agli osceni palazzacci che ha hai due lati. Ma al cairese mancano parametri, informazioni, forse addirittura le parole per designare quel palazzo. Allora ne parla nell’unico modo che si usa per dire bene di una cosa di cui non si sa perché abbia in sé del buono: l’antichità. Le cose antiche sono buone, questo palazzo è buono, per dirlo in modo rapido (e non troppo dissimile dalla realtà, visto che gli altri palazzi sono contemporanei) questo palazzo è antico, anzi, il più antico. 71 In ogni caso si tratta anche qui di un cubo, proporzionato e solido. Un ampio portale prefigura la possibilità di entrare con carri e quindi probabilmente l’esistenza (almeno in antico) di un cortile interno. Non ha fronzoli, non ha decori. È una “macchina per abitare” e si fa notare per sobrietà. Ripensavo, guardandolo, a quello che ho sentito dire da Pasolini mentre guardava Sabaudia: quanto abbiamo riso, noi intellettuali, sull’architettura di regime. Eppure oggi ci rendiamo conto che il fascismo, nonostante tutto, non è riuscito a permeare come avrebbe voluto, non è riuscito a corrompere usi, consuetudini, tradizioni, espressioni e infine neanche estetica e paesaggio. Breve: quello che non è riuscito a fare il fascismo lo ha realizzato il sistema di potere e produzione insediatosi e sviluppatosi a partire dagli anni Cinquanta, giunto oggi alla convergenza tra mercato e partito. Il famoso benessere, gestito quasi solo per fini di profitto economico, ha continuato a produrre piccoli (e grandi) mostri. Per guardare come si sono evolute le condizioni dei miei paesi mi sposto ora a Carcare. Quando ho comprato la casa in cui abito, il declivio che si trovava sopra questa si chiamava con il bellissimo nome di Niprati. Ed in effetti si trattava di una costiera esposta a sud, ricca di acqua, che albergava ampi pascoli, prati appunto. Il foraggio, come noto, non serve quasi più a nessuno, ma le costiere esposte a sud no, anzi, servono moltissimo. Se avessi potuto avrei costruito anch’io la mia casa su quel declivio. Ma forse no: mi piacciono le case vecchie, e i declivi che diventano tempestati di ville mi sanno di volgare opulenza. È comunque interessante camminare in questa zona. Il piano regolatore ha previsto una corretta suddivisione degli spazi, strade asfaltate, lampioni, tombini… C’è tutto. Più in basso ci sono alcune ville più antiche: i primitivi padroni ci tenevano a far vedere di che pasta… Cancellate, ringhiere in ferro battuto, giardini, parchi addirittura. Ce n’è una, più recente, squisitamente 72 anni Settanta, molto elaborata e con inserti in legno sulla facciata, come ne ho viste solo su alcune riviste di quell’epoca, e forse neanche in Italia. Si lascia guardare da un parco sobrio, adiacente alla strada. Poco più in alto ci sono le ville degli anni Ottanta e Novanta: tuje o altra siepe adatta parano quasi completamente la vista. Non ti deve interessare chi/cosa c’è là dietro. E forse al proprietario non interessa il mondo che c’è oltre la tuja. Il mondo è brutto? E io mi costruisco l’isola che mi piace, con le mie regole, il mio spazio vitale. Ogni tanto esco per portare fuori l’immondizia, fare urinare il cane, scrollare un tappeto. Ecco: il mondo è la mia personale pattumiera. Più oltre ci sono le ville moderne. Tetti poco spioventi, abbaini, porticati. Praticelli, piante dai nomi impronunciabili disposte da architetti imprescindibili, recinzioni in acciaio inox, legna segata finta (o inutile), sentierini di pietre che adducono alla casa, viottolo in porfido verso il garage, davanti al quale risplende un grosso camion a forma di auto che mi dicono chiamarsi SUV. C’è almeno un cane, che abbaia a gravi latrati, minaccioso. La casa è in vista, splendida e tronfia, si mostra in tutta la sua volgarissima opulenza. La casa è oggi la vetrina delle nostre ambizioni. Ma allo stesso tempo deve essere blindata, inavvicinabile. È una perla in mezzo al letame, una venere (truccata da baldracca) distesa su una pezza di seta rossa, fra lerciume e orrore. Non ci si deve avvicinare, non ci si può avvicinare. Gli “altri” sono dannosi per definizione, per cui vanno tenuti a distanza. Possono guardare, questo si. Possono desiderare, anzi devono desiderare tutto questo. E tutto questo non deve essere frutto del proprio gusto, delle proprie opinioni, scelte, esperienze fatte in vita, ma espressione diretta di uno studio di architettura, di estetica del vivere, secondo le più moderne (e aliene) opinioni degli specialisti del mercato. Del mercato, appunto. 73 Mi pare di poter entrare in quelle case, di vedere, a volo di mosca, mobili di design, vasi di vetro enormi contenenti rami secchi, alluminio, pelle, cristallo. Non una piccola particola di polvere. Profumo di patchouli e di ambra grigia. La scala di legno, curvato, esotico. I quadri inesplicabili, ma certamente di gran gusto. Le cornici d’argento, la televisione, i libri di brunovespa, i libri d’arte e di foto. Il gelo di quelle stanze. La cucina tecnologica, con la pasta in vista nei barattoli di vetro, e l’impastatrice (“Ma non ho mai tempo di usarla…” direbbe la padrona di casa, forte dei suoi cotonati e dei suoi centimetri di tacco). E poi, su una mensolina, un vasetto, un piatto dipinto, o magari un acquerello incorniciato, che rappresenta un piccolo borgo, un arco, un camino che fuma. La stradina, l’alberello, la vecchina che fila sulla porta, un vaso di gerani, il basilico sul balcone, i panni stesi, i fiori di campo. E potremmo chiedere alla padrona cosa rappresenta quel quadro, e lei potrebbe dirci che le piaceva, che le sarebbe piaciuto vivere in un posto così, che lei da bambina ci abitava. È vero, sarebbe bello vivere in una borgata, dove si esce e si chiacchiera, magari si litiga anche un po’, dove nessuno si fa mai i fatti suoi, dove se hai un problema perlomeno hai qualcuno a cui raccontarlo. Dove puoi dimenticarti dei bambini fuori. Ci sono ancora quelle borgate: sono case minute, timide, un po’ deboli, tanto che si devono sostenere una con l’altra. Chi le ha costruite non pensava di dover dimostrare niente a nessuno, se non la dignità di esser capace a fornire alla sua famiglia quello che serviva. Non c’erano SUV da parcheggiare. Non c’erano piante esotiche e praticelli da non calpestare. La vita era tutt’altro che facile, si mangiava male e sempre la stessa cosa. Ma non ci piaceva quel modo di vivere, ed ora che potremmo avere quelle borgate linde, ben isolate e riscaldate, con luce, acqua, rete wireless, illuminazione pubblica, adesso non ci piacciono più. Vogliamo la villa esagerata, che si veda, volgare come una persona fuori luogo che non s’accorge d’esserlo. 74 25 aprile 2010 Caro amico fascista Oggi posso pure chiamarti amico: i tempi sono cambiati rispetto all’ultima guerra, e tu non sei una persona propriamente cattiva. Penso anzi che tu sia un esibizionista, un provocatore, e per questo ti dichiari fascista, anche senza sapere bene che cos’è il fascismo. E qui sei in buona compagnia, dato che ci sono milioni di persone che aderiscono fervidamente ad un’idea (fino alla morte – propria o di altri compresa – ) senza sapere di cosa si tratta. Io mi sono iscritto all’ANPI, e di questo tu puoi pure ridere. Anzi, il fatto che tu ne rida mi rende quasi contento della scelta che ho fatto: vuol dire che sono sulla buona strada. Come sai io faccio fatica a prendere una tessera, persino quella di una biblioteca. Puoi immaginare quindi con che stato d’animo ho dato i miei dati e ricevuto il cartoncino. I partigiani sono dei guerrieri. E io sono la cosa più lontana da un guerriero che si possa immaginare. Non sono virile, volitivo, autoritario. Non sono marziale, coriaceo, massiccio. Non sono neppure categorico. Non sono quasi mai certo. Le poche certezze che ho me le tengo strette: ho paura che si consumino, che si logorino. Le rimugino e scopro ogni volta che nella loro essenza potrei trovare la forza di fare qualche sacrificio per il bene di altri. Questo mi fortifica. Allora perché mi sono iscritto all’ANPI? Non lo sapevo. Si, certo, la deriva populistica e semiautoritaria dell’attuale governo m’inquieta. 75 Sicuramente sono finiti i tempi della compartecipazione, della politica come cosa nobile. Questo è il tempo della brevissima memoria ogni giorno più breve, e questo ha contribuito alla spinta verso una piccolissima testimonianza che mi sentivo di poter dare. Ma perché? No, dai, per davvero… Dimmi perché l’ANPI. L’ho scoperto ieri sera, quando sono stato ad un convegno per la ricorrenza del 25 aprile. In una sala si sono ritrovate circa cinquanta persone. La serata era organizzata dall’ANPI. C’erano giovani, anziani, operai, scrittori di storie partigiane, aspiranti politici, curiosi. Irma ha fatto gli onori di casa. Ha una voce netta e precisa, dice cose funzionali, esatte. Va al sodo. Senza enfasi, senza violenza. Ha gli occhi sereni e il sorriso ampio, amichevole. Poi ha parlato Emanuela, profumata ancora del lauro accademico. Precisa e affilata. Sa quello che dice e sa fare il suo mestiere: ha raccontato i fatti e alla fine ha chiuso con il suo pensiero. Poi le testimonianze dei reduci (e qui, chiedo scusa, ma per forza maggiore ho dovuto lasciare la sala). Una cosa accumunava gli intervenuti: nessuna delle persone presenti in quella sala portava con sé una molecola d’odio. Nessuna portava con sé una particola di violenza, di desiderio di sopraffazione, di necessità di urlare al balcone dichiarazioni di guerra, di virilità, di categoricità. Alcuni, altrove, per semplificare pongono sullo stesso piano partigiani e fascisti. Non è vero, non c’entra nulla: i fascisti appartengono a un partito politico. I partigiani non appartengono a nessuno (salvo scelte individuali). Dentro ci sono persone, singole persone. Niente di granitico, niente di inossidabile. Nelle adunate che ancora si tengono a Predappio, o in qualche sala semiclandestina dell’urbe, o forse anche in provincia, c’è un pesante rituale fatto di drappi neri, di pugnali e teschi, di croci e simboli tristi. Si parla continuamente di onore, di riscatto, di tradimento. Il sangue è centrale, la morte è coronamento di una vita a passo di corsa. 76 L’italianità un primato, Roma un mito, ed i migliori uomini da ricordare sono tutti d’un pezzo: violenti, autoritari, prevaricatori. Mi pare di ricordare, però, che durante la marcia su Roma, Mussolini fosse pronto a “saltare” in Svizzera. E che dire del prode principe Borghese e delle sue trattative separate con gli americani prima del 25 aprile? Dunque anche pronti a tradire? Alcuni aspetti di questi rituali e di certo patriottismo lo ritroviamo nell’attuale destra, quando celebra le persone decedute o ferite in missioni di guerra all’estero. Persino in civili che muoiono dicendo frasi coraggiose un attimo prima di morire, come nel caso di Quattrocchi. Oggi, questi militari appartengono ad un esercito professionale: vengono preparati e pagati per servire la patria in armi. Sulla forza delle loro idee si innesta una ragionevole convenienza economica. I partigiani di allora, spesso soldati del regio esercito mal pagati, mal vestiti, male armati e mal nutriti, hanno scelto di “andare in montagna” o di restare in prigionia pur di non collaborare. Allora, quale differenza c’è tra i partigiani di ieri e i soldati di oggi? O addirittura nei confronti di Quattrocchi, di cui si può avere tutto il rispetto e la costernazione debita, ma che si è recato in zona di guerra per lavoro e non per precettazione gratuita o per ideale. Infine dai fascisti viene spesso citata la parola onore. È un termine caro ai militari in genere, l’onore, l’orgoglio, sono parole che gonfiano il petto, preparano alla battaglia, fanno tenere alto lo sguardo fisso, dritto negli occhi del nemico. L’onore serve a prevaricare, a superare l’avversario, l’antagonista, contiene l’idea accessoria di superiorità (o di inferiorità dell’avversario). L’antagonista in guerra va abbattuto, sconfitto, distrutto. Allora fuori dalla guerra non si dovrebbe usare l’orgoglio. I partigiani sono affezionati ad altre parole. Termini che richiamano innanzi tutto alla responsabilità individuale (primo passo per la 77 costruzione di una società civile) e al valore di eguale fra eguali, come opportuno, decoroso, stimabile, decente. C’è un senso di sobrietà in questo, non c’è la volontà di prevaricare nessuno, piuttosto di voler testimoniare la propria condizione di individuo tra gli individui, come ricorda la nota epigrafe che io non posso leggere senza sentire un piccolo magone in gola: …questo patto giurato fra uomini liberi che volontari si adunarono per dignità e non per odio decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. A tutto questo ho pensato ieri sera, caro amico. Io non voglio convincere nessuno, ma pensa che tu puoi scegliere di essere o non essere fascista proprio perché hanno vinto gli antifascisti. 78 Stranieri in patria Lavoro precariamente presso l’ufficio anagrafe del Comune di un paese della Val Bormida. Spesso mi capita di ricevere utenti che hanno bisogno di fare la carta d’identità. Ieri mattina è arrivata una ragazza di neanche vent’anni. Bella, sorridente, dai lineamenti orientali. Si trattava di una fanciulla adottata, evidentemente, in tenera età da una coppia del paese, per cui cittadina italiana a tutti gli effetti. La ragazza ha involontariamente deteriorato la vecchia carta, si è presentata allo sportello per avere una carta nuova. Breve: ho istituito la pratica e ritirato la carta vecchia, dandole appuntamento a un paio di giorni. Lei mi ha chiesto: “Ma se mi fermano quali documenti posso mostrare, visto che non ho ancora la patente?”. Ho esitato, non capivo. È difficile che mi fermino per strada, a piedi, e che mi chiedano i documenti. Le ho detto che i carabinieri o la polizia avrebbero potuto telefonare per accertarsi dell’identità, che in un paese è difficile che succeda, e che tutto sommato c’era da aspettare solo due giorni. Lei ha sorriso, gentile e bellissima. Ha fatto si con la testa. Ha salutato e se n’è andata. 79 Solo qualche ora dopo ho capito. Non me ne ero accorto, le cose sono cambiate e ora mi rendo conto di quanto siamo andati avanti (o meglio indietro) sulla strada del pregiudizio. E il pregiudizio è arrivato anche in paese, anche alla periferia dell’impero. La ragazza sa di avere la pelle scura e i lineamenti orientali. Sa che un “bianco” può anche perdere i documenti, è difficile che venga fermato, difficile che abbia problemi. Sa però che per lei è diverso, che una sera ad un posto di blocco potrebbe essere trattata diversamente, e che l’unica cosa che potrebbe salvarla è la dicitura “cittadinanza italiana”. Lei è straniera, e lo ha scritto, inciso sulla faccia, nonostante parli un fluente italiano, nonostante la sua (probabile) religione di appartenenza, sebbene mangi spaghetti, tifi Italia, ascolti i vacui cantanti del momento, mandi sms, giochi con la play, cerchi un lavoro, sogni un grande amore. Questa storia mi ha messo tristezza perché per me ha un significato preciso: la società è peggiorata, almeno sotto questo aspetto, a nessun cittadino italiano, fino ad alcuni anni fa, sarebbe venuto in mente di non poter stare due giorni senza un documento d’identità, per paura di essere fermato, di subire un accertamento, un semplice controllo di documenti. E anche se fosse, cosa dovrebbe temere un cittadino straniero da un accertamento da parte della polizia? Un politico potrebbe dire che è colpa del terrorismo internazionale. Secondo me è colpa della paura che serpeggia, insinuata, tra la gente, la stessa che porta a installare antifurti, portoni blindati, telecamere, pregiudizi. Quanto tempo ci vorrà prima di tornare indietro? 80 DANZA LENTA Hai mai guardato i bambini in un girotondo? O ascoltato il rumore della pioggia quando cade a terra? O seguito mai lo svolazzare irregolare di una farfalla? O osservato il sole allo svanire della notte? Faresti meglio a rallentare. Non danzare così veloce. Il tempo è breve. La musica non durerà. Percorri ogni giorno in volo? Quando dici "Come stai?" ascolti la risposta? Quando la giornata è finita ti stendi sul tuo letto con centinaia di questioni successive che ti passano per la testa? Faresti meglio a rallentare. Non danzare così veloce Il tempo è breve. 81 La musica non durerà. Hai mai detto a tuo figlio, "lo faremo domani?" senza notare nella fretta, il suo dispiacere? Mai perso il contatto, con una buona amicizia che poi finita perché tu non avevi mai avuto tempo di chiamare e dire "Ciao"? Faresti meglio a rallentare. Non danzare così veloce Il tempo è breve. La musica non durerà. Quando corri cosi veloce per giungere da qualche parte ti perdi la metà del piacere di andarci. Quando ti preoccupi e corri tutto il giorno, come un regalo mai aperto . . . gettato via. La vita non è una corsa. Prendila piano. Ascolta la musica. Ho ricevuto questa poesia per posta elettronica. Di per sé mi pare piuttosto banale: non insegna niente di nuovo e non mi suggerisce nessun pensiero. Mi sono informato brevemente ed ho scoperto che tutta la presentazione è una bufala che circola, in diverse versioni, dal 1997. Niente di male, se non fosse che in chiusura gli anonimi autori (poiché ci 82 sono diverse versioni) hanno scritto i veri recapiti di persone esistenti, che dopo la “pubblicazione” di questa presentazione vengono tempestati di chiamate, mail, domande, offerte eccetera, perdendo così un sacco di tempo. Poi mi sono anche fermato a considerare il contenuto della poesia (che, sia detto per completezza d’informazione, non è stata scritta da un’adolescente malata terminale, ma, pare, da uno psicologo americano, ed è visibile a questa pagina web: http://www.davidlweatherford.com/slowdance.html) che mi pare semplicistica, puerile, presuntuosa. Mi sento di rispondere a questa poesia domanda su domanda, perché la trovo, in alcuni punti, imbarazzante. Hai mai guardato i bambini in un girotondo? Se mi capitasse li guarderei. Ma i bambini che vedo, spesso giocano con la playstation, ed è difficilissimo convincerli a mollarla e giocare a qualcos’altro. La cosa interessante è che però se riesci a coinvolgerli poi non guardano più la “play”, ma è molto impegnativo. Poi “guardo” anche altri bambini: faccio parte di un’associazione che mi consente di informarmi sull'Africa e suoi problemi, e di fare qualcosa per i bambini africani. Loro giocano ANCHE al girotondo, nonostante la malaria, il tifo, l'enterite, le infezioni respiratorie, l'aids, la sottoalimentazione, la sottoistruzione. Quindi, caro amico poeta, guardali tu i bambini che fanno girotondo, io ho altro da fare. ascoltato il rumore della pioggia quando cade a terra? Spesso. Mi piace molto quando piove, d'estate. Quando aspetti la pioggia insieme alle verdure dell'orto e i fiumi sono esangui e quasi silenziosi. La pioggia fa chiasso e l'aria si profuma. Ma se la pioggia viene in altre 83 stagioni che non siano estate, se la pioggia viene mentre si lavora all'esterno e non si può smettere, allora non ascolto né l'odore, né il rumore della pioggia. Impreco dentro di me mentre sento l'acqua gelida che scende tra le scapole. Mi è capitato raramente, ma è una bruttissima impressione. Altre volte la pioggia gonfia i fiumi e si porta via tutto e qui c’è poco da stare a sentire… O seguito mai lo svolazzare irregolare di una farfalla? Certo, per chi mi hai preso? Tanto le cavolaie che le falene. A proposito: te che sei un “poeta” vedi un mondo fatto di farfalle, tramonti, bimbi e fanciulle. Sappi che vedi poco: c'è poesia anche dentro una falena, un pipistrello, un vecchio demente, una notte di nebbia... Perché la poesia è umana, non naturale, viene cioè dall'uomo. Se non vedi poesia nella tavola periodica degli elementi, non sei poeta. Se non vedi poesia nel betanaftolo, non sei poeta. O osservato il sole allo svanire della notte? Appunto, come dicevo prima... Faresti meglio a rallentare. Non danzare così veloce. Il tempo è breve. La musica non durerà. Ma non sto correndo, cosa te lo fa pensare? Come ti permetti di sostenere questo quando sei tu che non vedi le cose intorno a te? Sappi che c'è un momento per danzare veloci, uno per danzare lenti. Lo so che “la musica” non durerà: ho perso amici e parenti a cui tenevo molto in un soffio, e tutto è passato. E io faccio del mio meglio per portare avanti di qualche metro il testimone che mi hanno lasciato, cercando di essere sincero, coerente, responsabile. A volte sono anche di corsa, altre volte 84 mi siedo e guardo, altre volte riesco a correre e a guardare. Ne saresti capace? Quando dici "Come stai?" ascolti la risposta? Lo chiedo a pochissime persone, e solo quando sono davvero interessato alla loro salute, oppure voglio sapere da loro come si sentono. Evito di chiederlo come formalità. Lavoro (per ora) ad uno sportello pubblico e non accolgo nessuno dicendo: “Dica?”, ma: “Posso aiutarla?”. Hai mai detto a tuo figlio, "lo faremo domani?" senza notare nella fretta, il suo dispiacere? Non ho figli, l'ho detto ai miei nipoti. La grande non era poi tanto triste. Mi ha detto che le sembravo stanco e che avrei dovuto andare a casa a riposarmi. Mentre se dico al piccolo che non ho tempo vola svelto a inventarsi un gioco autonomamente. È importante dare tempo e spazio ai bambini, ma è altrettanto importante far capire loro che non sempre c’è il tempo per giocare, per raccontare storie. C’è anche il tempo dei doveri quotidiani, come c’è il tempo del riposo o il tempo per stare da soli a non far nulla. Mai perso il contatto, con una buona amicizia che poi finita perché tu non avevi mai avuto tempo di chiamare e dire "Ciao"? Amicizie ne ho perse a migliaia. E sono convinto che succede. Si cambia strada o si cambia carattere. Se ne perdono e se ne trovano. E se dopo cent'anni dovessi ritrovare un amico che ho perso lo vedrei volentieri. Non credo sia possibile mantenere un amicizia per decine d'anni se non si 85 ha niente (o poco) in comune. Le persone, col tempo, si complicano (e faccio finta di non vedere le sgrammaticature...). Faresti meglio a rallentare. Non danzare così veloce Il tempo è breve. La musica non durerà. Comincio a pensare che te porti sfiga. Mi sembri quel tale che (se ricordo bene) teneva l'alloro sul capo del trionfatore nella Roma antica, e che intanto gli sussurrava all'orecchio: ricordati che devi morire! (“Si, mo’ me lo segno” rispondeva memorabilmente Troisi). Ho 44 anni, sono in salute, magari un po' sovrappeso, ma sto bene. Anche gli esami del sangue vanno bene. Ho imparato che i consigli della mamma non vanno ascoltati: maglia di lana, correnti d'aria, stare al sole senza cappello, bere dopo la frutta, fare il bagno così e cosà... tutte precauzioni che contribuiscono a renderci nevrotici della nostra condizione di salute. Stiamo qui a misurare i decimi di millimetro della nostra vita, quando a qualche migliaia di chilometri ci sono persone che vivono bevendo fango, mangiando quel che capita, lavorando ore su ore dormendo poi a terra. Dobbiamo riguadagnare la consapevolezza della fatica, del caldo e del freddo, dell'acqua del rubinetto (e magari pretendere che QUELLA sia buona da bere, non necessariamente comprarla al supermercato). Dobbiamo essere sobri e misurati nei consumi, spendaccioni e munifici con le nostre energie e la nostra capacità di sopportazione e adattamento. Certo che il tempo è breve, e poesie come questa lo erodono, diminuiscono cioè il tempo che abbiamo a disposizione per imparare, ascoltare, guardare, amare ed odiare. Quando corri cosi veloce per giungere da qualche parte 86 ti perdi la metà del piacere di andarci. Quando corro veloce, è perchè devo arrivare in tempo, non per altri motivi. Se posso vado piano. Sto anche fermo, se è il caso. E se ci fosse un sistema di trasporti pubblici che funzionasse, non avrei neppure bisogno di andare in auto. Quando ti preoccupi e corri tutto il giorno, come un regalo mai aperto . . . gettato via. Se mi preoccupo è perché sono dedito a risolvere un problema. Può essere semplice o complesso, ma non si risolve solo pensandoci, o guardando le farfalle... E poi cosa vuol dire “come un regalo mai aperto”? È incomprensibile! La vita non è una corsa. Prendila piano. Ascolta la musica. No, certo, non è una corsa. Non è da prendere “piano” o “forte”, occorre però imparare ad adattarsi alle situazioni, occorre imparare a imparare. È indispensabile mantenere vivo il senso critico, analizzare quel che ci arriva dal mondo e “leggerlo” ponendosi domande. Questo non toglie nulla alla sorda disperazione che dentro ognuno cova, ma contribuisce a farci uomini interi, armati contro i momenti avversi (se non sono troppo duri). Per questo bisogna riempirsi di bellezza e di conoscenza, e soprattutto prima dei venticinque anni, perché dopo è più difficile imparare. Ma il sistema economico che tanti decantano è il responsabile dell'imbarbarimento a cui assistiamo: la bellezza è solo quella suggerita dai media, la conoscenza è un format televisivo. A che ci serve guardare la bellezza delle cose intorno a noi se basta un indumento firmato o 87 un’operazione chirurgica a renderci conformi, e cioè belli? A che ci serve imparare se tutto è su google? Allora, per cominciare, cerchiamo le poesie dei poeti veri, e non quelle degli psicologi nevrotici. Partiamo da un punto fermo e ingrandiamo questa consapevolezza. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina quando su te sola ti pieghi nello specchio. O cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte ha uno sguardo. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo muti. C.P. 88 Un melo, un confine, due case Mio zio si chiamava Edoardo e abitava una casa indipendente, sul fianco di una collina esposta a sud, nel comune di Dego. Viveva con la moglie nella casa che era stata dei suoi genitori, dei suoi nonni, forse ancora dei suoi bisnonni. La cucina aveva, anticamente, una sola porta che conduceva direttamente all’esterno. Il cortile fangoso era limitato da un basso muretto. Sopra il cortile la “lobbia”, ovvero il camminamento coperto ma aperto per raggiungere le camere e porre il granoturco ad asciugare; più in basso rispetto al cortile c’era il pollaio, nel mezzo un grande fico, dal quale nella stagione giusta era facile spiccare alcuni frutti neri e dolcissimi, salendo sul basso muretto. Oltre il fico null’altro si vedeva che colline coperte di boschi. Nudi nell’inverno o coperti di foglie nell’estate; variegati di verdi nuovi e gioiosi in primavera; lussureggianti di calde tonalità d’autunno. Boschi sempre diversi, sempre più estesi, inarrestabili fagocitanti pascoli. Sopra la casa di mio zio c’era la casa di Berto. Stessa età, stessa vita (più o meno). Anche lui con la moglie, anche lui contadino. Ma Berto e mio zio non si parlavano. Io non so dire per quale motivo si fossero tolti il saluto. Forse non se lo ricordavano neppure loro. Si odiavano semplicemente, come se l’odio fosse naturale, come se non fosse anzi possibile far altro che odiarsi a vicenda e quindi, come d’uso da queste parti, si ignoravano signorilmente. 89 Esiste in dialetto un termine per designare questa condizione, questo comportamento che due persone possono tenere reciprocamente, oppure anche adottata da una sola persona nei confronti di un’altra. Questo termine è anek (si dice: “Ha l’anek con Tizio, non si parlano”). Si tratta di togliere dalla percezione del mondo reale quella persona, di non vederla, non considerarla, non parlare a… È di fatto uno dei sistemi più perversi e raffinati per dimostrare odio in maniera estremamente sobria. Non essere “parlati” equivale a sentirsi scartati, ignorati, equivale a non esistere. Nella condizione di non-esistente non c’è possibilità di emendarsi, di salvarsi, di essere perdonati. È una strada senza ritorno verso l’Ade. E tutto senza manifestare idee, proposte, apologie di reato in genere. Non che questa situazione sia poco faticosa: anzi. Basti pensare alla situazione che si crea quando due persone abitano vicine e, praticamente, sole. Si saranno incrociati, mio zio e Berto, decine di volte al giorno e ognuno avrà fatto di tutto non tanto per mostrare disinteresse, ma per non permettere alla presenza stessa dell’altro di cambiare il suo comportamento: tanta aveva da essere l’indifferenza che non si sarebbe potuto prendere in considerazione neanche la possibilità di scansarsi se l’altro fosse caduto al vicino. Sublime, sofisticatissima indifferenza. Se uno dei due avesse avuto bisogno di una mano per reggere una tavola, per piantare un chiodo, se fosse scappato il tappo al tino mentre il mosto fermentava, il malcapitato sarebbe dovuto partire di gran galoppo, alla volta della casa vicina, pur sempre ad un chilometro e in salita, per chiedere aiuto. Le stesse galline avevano percepito la sacralità dei confini: nessuna gallina di Berto fu mai vista razzolare nel cortile di Edoardo e viceversa. Forse gli stessi fili d’erba se ne guardavano bene di invadere la invisibile linea di confine. 90 Perché all’origine della incomunicabilità dei due c’era una questione di confini, sicuramente. Su quei colli, a quel tempo, la terra aveva un valore che andava al di là del prezzo. Possedere la terra voleva dire possedere un diritto: il diritto di seminare, di raccogliere, di passare; e quindi di mangiare, dare mangiare alle proprie bestie, scaldarsi. La terra era la vita e soprattutto era vita da uomini liberi. Il diritto necessita però di regole, di limiti, di accordi scritti e non scritti. Oltre a questo è da ricordare che la terra non è tutta uguale. Abbiamo oggi perso questa percezione, ma la parola “terra” non era neppure pronunciata direttamente. Ci si riferiva semplicemente a: “Un pezzo”, per dire appezzamento. Oppure ancor meglio: “Nel suo di…” per riferirsi più a un diritto che a un oggetto. La stessa costiera, lo stesso campo, che oggi appare corrotto da gaggie e castagni selvatici, era luogo d’elezione per l’aglio, per le prime patate, per le rape o per i piselli. Quella tale costiera andava per il grano e quest’altra era d’uso coltivarla a mais. Quando avvenivano le divisioni si cercava di attribuire ai comparenti appezzamenti adatti per costruirsi una dispensa più completa possibile. Per questo le mappe catastali ancor oggi rappresentano curiosi confini che ignorano spesso i limiti orografici (cime delle colline, ruscelli, scogliere), ma seguono un disegno complesso, che non sappiamo più leggere, e che comprendeva appunto l’idea di fornire a tutti gli eredi la terra necessaria per essere liberi. Da questo discendeva l’importanza per i sacri confini, perché nessuno avesse l’ardire si spostare un terma (cosa quanto mai riprovevole, disdicevole e innominabile, anche solo come accusa), ma anche di contestare un passaggio, una lenzuolata di fieno, un ramo in più o in meno. E spesso si tratta di più d’una di queste cose, che accatastate e tenute da conto da una persona, diventano motivo di livore, di odio appunto. 91 Tra la casa di mio zio Edoardo e la casa di Berto c’era un melo. Un melo non molto grande, per la verità. Un melo che ogni anno produceva la sua modesta quantità di mele botazze. Pochi conoscono questa qualità di mele, io ne ignoravo l’esistenza fino a qualche giorno fa. In realtà oggi conosciamo solo più le mele del supermercato: bellissime, perfette, tutte uguali, gialle o rosse, stark o fuji. Al limite le renette. Eppure esistono ancora bei meli nelle nostre campagne, alberi non grandissimi, spesso inselvatichiti e dimenticati, che nelle annate adatte si caricano di frutti. Spesso si tratta di mele piccole, non abbastanza “belle” da essere commercializzate, o con qualche altro difetto che le rende inadatte alla commercializzazione su vasta scala. Ma è sorprendente, passeggiando, raccoglierne una dalla terra fredda d’autunno, mondarla con un piccolo coltellino a serramanico, ed assaporarla. Scoprire così che esistono tantissime varietà e di conseguenza tantissimi gusti di mela, tante consistenze e tanti usi. Le migliori sono, secondo me, le piccole mele di un albero che possiedo (nel suo dei marenchi, io e mio fratello) a Giusvalla, e di cui non conosco la specie o il nome tradizionale. L’albero è vecchio, l’ha forse piantato mio nonno. Produce piccole mele, non più grandi di una clementina. Il frutto è duro e quindi poco attaccato dai parassiti. Il colore va dal giallo tenue a qualche velata macchia di rosso. La forma è tonda e liscia. La vera sorpresa è il profumo: all’olfatto ricorda indiscutibilmente il vino moscato. È addirittura curioso, e fa sorridere, a pensarci, che una mela sappia di vino dolce. Ma tale è. E spero solo che questa pianta non s’ammali. Ma stavo raccontando delle mele bottazze di Berto: L’albero si trovava quindi sul declivio tra le due case. Non so se per vizio della pianta o della specie in particolare, passato Ognissanti le mele cascavano quasi tutte. Rotolavano, come la loro forma e la nota legge vuole, verso il basso, e cioè nella cunetta della casa di Edoardo. Berto non le avrebbe mai 92 raccolte, così vicino alla casa della persona che ignorava. Edoardo non le raccoglieva: ignorava le mele come il suo legittimo proprietario. Per motivi diversi, e forse perché si sentiva un po’ trascurato il melo aveva praticamente smesso di farne. Certo, Berto avrebbe potuto raccoglierle sull’albero appena passate le tempora, diciamo dopo il giorno di San Matteo, quando, come tutti sanno benissimo, le mele si possono cogliere perché è finito il processo di maturazione sulla pianta; ma disgraziatamente salire sull’albero con la scala equivaleva inevitabilmente a ficcanasare in casa di Edoardo, visto che l’albero era troppo vicino alla casa. Insomma: non c’era soluzione. Le poche mele che Berto mangiava erano quelle che, cadendo, restavano incastrate fra un ciuffo d’erba e una pietra, o rotolando nel cortile a monte, per puro caso. Ma nonostante le mele fossero da entrambi ambite ed apprezzate QUELLE mele andavano perse, sgheiroie, o come si dice in riviera: scentate. Fortunatamente le donne non erano tanto sprovvedute. Quando i due mariti andavano (ognuno per proprio conto) a caccia o nel bosco, loro sortivano guardinghe e prendevano qualche mela nel grembiule, fermandosi a commentare il tempo o il prezzo delle uova. Per le mogli, che portavano lo stesso nome: Pina, non era il caso di far questioni di fronte a quella roba messa lì a marcire, se ne prendevano un paio, intanto chiacchieravano, se le sarebbero fatte cuocere nella stufa. Le avrebbero mangiate anche i rispettivi mariti, che magari sospettavano qualcosa, ma senza un’esplicita informazione (che si guardavano bene di chiedere) non ci sarebbe stata infrazione al reciproco anecco. Anni sono passati. I due vicini sono morti. Ci sono ancora le due case, abitate d’estate, e c’è ancora il melo nel mezzo, che nel frattempo è cresciuto. Si è slanciato verso l’alto alla ricerca di luce e le radici devono aver trovato terra fertile per prosperare. Da anni non lo notava (quasi) più 93 nessuno. Lui forse s’era messo in pensione, o forse non sono stati anni proficui per i meli da quelle parti. Quest’anno, dopo una bella fioritura, ha prodotto una quantità di mele stupefacente. Belle per qualità, consistenza e gusto. Come sempre dopo i Ognissanti si sono in gran parte staccate (ma molte sono ancora sull’albero) e sono rotolate verso la casa di Edoardo, fermandosi nella cunetta, formando un letto verde, lucido e profumato di mela. Io stesso ne ho raccolte una cinquantina di chili. Le brutte, ammaccate, marce, l’ho gettate in basso, a favore di cinghiali o caprioli. Ce ne sono ancora molte sulla pianta. Scenderanno anche loro, con calma, quando sembrerà a loro il caso di scendere. Mentre scaricavo le mele “brutte” a valle pensavo: non siamo abituati neanche a questo. Tutto, ora, è di prima scelta. Nei canestri dei supermercati, negli scaffali, nelle corsie, ci sono solo cose “perfette”. Ma la natura non è così: di ogni frutto (di qualunque frutto) ce ne sono di belli, storti, corrotti da parassiti, bitorzoluti, piccoli, marci, provenienti ad un tempo dalla stessa pianta. Ottimizzando il processo di coltivazione diminuiscono i frutti non “perfetti”, poi, grazie ad una scelta, i frutti che arrivano sul mercato sono divisi tutt’al più per calibro. Quello che ci manca a noi compratori, consumatori, è la nozione della varietà della produzione, del fatto stesso che la natura non produce le mele come quelle della pubblicità, ma anzi quelle mele sono rare, inusuali, sorprendenti. E che non sono più buone solo perché sono belle. Da questa consapevolezza dovrebbe derivare la considerazione che non si possono consumare solo i prodotti “belli”, ma occorre trovare uno spazio anche per le mele (o le patate, le noci, i piselli) che non sono perfetti. Allo stesso modo si può considerare la carne di bovino o di suino: sembrerebbe che le vacche siano costituite principalmente da bistecchine magre, al limite qualche pezzo di bollito magro. E tutto il resto? Dalla testa alle zampe, dalle interiora alla coda, tutto scarto? Possibile? Allora 94 mi viene da fare ancora una considerazione: la cucina tradizionale, o meglio l’occupazione prevalente della cucina casalinga, era trasformare in edibile sostanze che non lo erano o che lo erano con difficoltà, oppure sostanze buone da mangiare ma dalla scarsa conservabilità: lo scarto del signore locale diventava prelibatezza. Persino la grappa, in quanto lavorazione di un prodotto di scarto, farebbe parte di questa famiglia. Da queste considerazioni si potrebbe giungere al consumo della varietà dei prodotti in base alla disponibilità, e non in base all’offerta che viene fatta a livello unicamente commerciale. Si potrebbe infine ricordare che “non è sempre domenica”, non è sempre festa, non possiamo fare festa tutti i giorni. Ma qui scivolo nel moralismo e anche se mi diverto, lascio ad ognuno le conclusioni. Per finire, il melo di Berto, liberato dall’odio che attraversava l’aria tra i due uomini, è tornato alla sua occupazione: produrre mele per chi le raccoglie, alieno a tutte le questioni di proprietà, diritti e confini, perché alla fine, come dice quel mio amico, la natura prevale, silenziosa e paziente. Spetta al passante conservare la sensibilità per certi temi, onde poi raccogliere e consumare le mele abbandonate pensando al bene che ci hanno voluto i nostri ascendenti, tutti compresi nell’odiarsi a vicenda, eppure consapevoli di compiere un atto a nostro favore quando piantavano, innestavano e curavano un melo. 95
Scarica