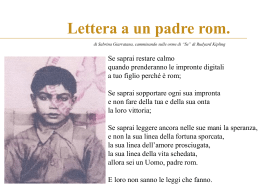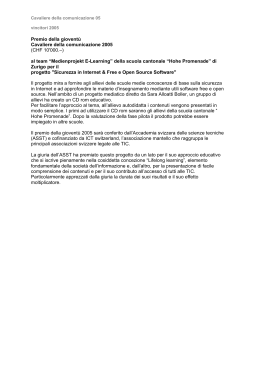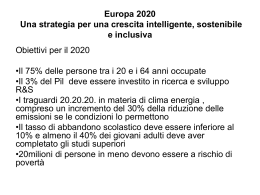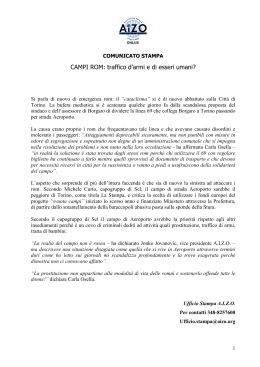6,00 EURO - TARIFFA R.O.C.: POSTE ITALIANE SPA - SPED. IN ABB. POST. D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/04 N.46) ART.1 COMMA 1, DCB Rom fuori campo MARZO 2015 3 CONFRONTI 3/MARZO 2015 WWW.CONFRONTI.NET Anno XLII, numero 3 Confronti, mensile di fede, politica, vita quotidiana, è proprietà della cooperativa di lettori Com Nuovi Tempi, rappresentata dal Consiglio di Amministrazione: Nicoletta Cocretoli, Ernesto Flavio Ghizzoni (presidente), Daniela Mazzarella, Piera Rella, Stefania Sarallo (vicepresidente). Le immagini Rom fuori campo • Andrea Sabbadini, copertina Rom: solo un numero civico • Rocco Luigi Mangiavillano, 3 Gli editoriali «Europeizzare» di più l’immigrazione • Roberto Zaccaria, 4 Uscire dalla gabbia d’acciaio europea • Tonino Perna, 5 Libertà religiosa in cerca di legge • Marco Ventura, 6 Direttore Claudio Paravati Caporedattore Mostafa El Ayoubi I servizi In redazione Luca Baratto, Antonio Delrio, Franca Di Lecce, Filippo Gentiloni, Adriano Gizzi, Giuliano Ligabue, Michele Lipori, Rocco Luigi Mangiavillano, Anna Maria Marlia, Daniela Mazzarella, Carmelo Russo, Luigi Sandri, Stefania Sarallo, Lia Tagliacozzo, Stefano Toppi. Collaborano a Confronti Stefano Allievi, Massimo Aprile, Giovanni Avena, Vittorio Bellavite, Daniele Benini, Dora Bognandi, Maria Bonafede, Giorgio Bouchard, Stefano Cavallotto, Giancarla Codrignani, Gaëlle Courtens, Biagio De Giovanni, Ottavio Di Grazia, Jayendranatha Franco Di Maria, Piero Di Nepi, Monica Di Pietro, Piera Egidi, Mahmoud Salem Elsheikh, Giulio Ercolessi, Maria Angela Falà, Giovanni Franzoni, Pupa Garribba, Daniele Garrone, Francesco Gentiloni, Gian Mario Gillio, Svamini Hamsananda Giri, Giorgio Gomel, Laura Grassi, Bruna Iacopino, Domenico Jervolino, Maria Cristina Laurenzi, Giacoma Limentani, Franca Long, Maria Immacolata Macioti, Anna Maffei, Fiammetta Mariani, Dafne Marzoli, Domenico Maselli, Cristina Mattiello, Lidia Menapace, Adnane Mokrani, Paolo Naso, Luca Maria Negro, Silvana Nitti, Enzo Nucci, Paolo Odello, Enzo Pace, Gianluca Polverari, Pier Giorgio Rauzi (direttore responsabile), Josè Ramos Regidor, Paolo Ricca, Carlo Rubini, Andrea Sabbadini, Brunetto Salvarani, Iacopo Scaramuzzi, Daniele Solvi, Francesca Spedicato, Valdo Spini, Patrizia Toss, Gianna Urizio, Roberto Vacca, Cristina Zanazzo, Luca Zevi. Abbonamenti, diffusione e pubblicità Nicoletta Cocretoli Amministrazione Gioia Guarna Programmi Michele Lipori, Stefania Sarallo Redazione tecnica e grafica Daniela Mazzarella Publicazione registrata presso il Tribunale di Roma il 12/03/73, n. 15012 e il 7/01/75, n.15476. ROC n. 6551. Hanno collaborato a questo numero: G. Battaglia, A. Bruno, M. Felici, S.M. Fiammelli, M. Iannucci, D. Losurdo, E. Marzo, R. Mazzoli, T. Perna, D. Salkànovic, L.Savarino, C. Stasolla, M. Ventura, R. Zaccaria. Medio Oriente Società Etica Ebraismo Armeni Laicità Chiesa cattolica Cultura La favola della «lotta al terrorismo» • Mostafa El Ayoubi, 7 E l’apprendista stregone Occidente «creò» l’Isis • (int. a) D. Losurdo, 9 I razzismi «costruiti dall’alto» • Roberto Mazzoli, 12 I campi: una vergogna tutta italiana • (int. a) Stasolla e Salkànovic, 13 I rom? Mandiamoli a casa! • Rocco Luigi Mangiavillano, 16 Obiezione di coscienza: quali confini? • Luca Savarino, 17 La legge 194 ha fatto dimezzare gli aborti • (int. a) Adriana Bruno, 19 Una stella di David arcobaleno • Daniela Mazzarella, 21 Ebreo e omosessuale: identità non in contrasto • (int. a) M. Fiammelli, 22 A cento anni dal genocidio • Maria Immacolata Macioti, 24 Il papa e i nanetti litigiosi • Paolo Naso, 26 Se manca la leva, nulla si risolleva • Enzo Marzo, 27 Perché Francesco entusiasma e turba • Luigi Sandri, 29 I rom e le identità «cucite addosso» • Gino Battaglia, 31 Le notizie Ambiente Diritti umani Immigrazione Società Media Medio Oriente Pluralismo Ecumenismo Economia Eutanasia Polveri e ozono fuori controllo: la denuncia di Legambiente, 33 La Giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili, 33 La comunità marocchina in Italia conta mezzo milione di persone, 33 Quando gli immigrati siamo noi. E non ci vogliono più, 34 Una cooperativa di giovani nel rione Sanità di Napoli, 34 La classifica di Reporters sans frontières sulla libertà di stampa, 34 Un convegno a Roma con lo storico israeliano Ilan Pappé, 35 «Dai culti ammessi alla libertà religiosa», 35 Lo scontro tra Egitto ed Etiopia sulla diga sul Nilo Azzurro, 36 Libby Lane è la prima donna-vescovo della Chiesa d’Inghilterra, 36 Prosegue la raccolta firme contro il Ttip, 37 «Liberi fino alla fine»: la campagna sull’eutanasia legale, 37 Le rubriche Diario africano In genere Note dal margine Osservatorio sulle fedi Cibo e religioni Spigolature d’Europa Opinione Libro Segnalazioni In Sud Sudan è ormai catastrofe umanitaria • Enzo Nucci, 38 Uno sforzo verso un femminismo musulmano • Stefania Sarallo, 39 Gli spazi della tradizione • Giovanni Franzoni, 40 Non nominate il nome di Dio invano! • Antonio Delrio, 41 Alimentazione halal: i precetti dell’islam • Marisa Iannucci, 42 La vie en rose di Marine Le Pen • Adriano Gizzi, 43 Scuola: sbagliare meglio • Giuliano Ligabue, 44 Le donne che si parlano in silenzio • Marcella Felici, 45 46 RISERVATO AGLI ABBONATI: chi fosse interessato a ricevere, oltre alla copia cartacea della rivista, anche una mail con Confronti in formato pdf può scriverci a [email protected] 2 LE IMMAGINI ROM: SOLO UN NUMERO CIVICO L’accesso alla casa è il primo segnale di «normalizzazione» sociale e un diritto per tutti. Le foto che illustrano il numero sono di Rocco Luigi Mangiavillano e riprendono alcuni momenti di «Europa Spa - Strumenti di partecipazione attiva nell’Europa del XXI secolo», promosso dalla Commissione europea e attuato in Italia da Eurobic Toscana Sud, in partnership con Provincia di Roma e Cilap Eapn Italia. Il cantiere «presa di parola dei rom» è stato curato da Coop. Ermes insieme ai rappresentanti rom di alcuni insediamenti di Roma. 3 GLI EDITORIALI «Europeizzare» di più l’immigrazione Roberto Zaccaria a «contabilizzazione» degli arrivi via mare, in Italia nel 2014, è stata drammatica: oltre 850 sbarchi, oltre 170mila persone, in gran parte rifugiati, approdate sulle nostre coste, oltre 3.000 morti o dispersi. Tutto questo nonostante uno sforzo straordinario, vorrei dire eroico, delle nostre forze militari e civili, nonostante Mare nostrum e nonostante il grande impegno economico del nostro paese. Tutto questo dopo la tragedia di Lampedusa dell’ottobre del 2013, che aveva colpito l’opinione pubblica italiana ed internazionale in maniera devastante. Ricordiamo ancora le parole durissime di papa Francesco, ricordiamo le meste visite dei governanti italiani ed europei e ricordiamo i solenni impegni di solidarietà di quei giorni. In termini politici si è cercato innanzitutto di predisporre in Italia, con il concorso dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, un piano di accoglienza e di solidarietà straordinario. Si è cercato di sostenere questo sforzo con un piano di risorse finanziarie maggiori e si sono potenziate anche le strutture per il vaglio delle domande di asilo. Naturalmente nella consapevolezza che tutti questi sforzi continuano ad essere insufficienti di fronte alla crescita esponenziale del fenomeno migratorio. In termini politici si è agito anche verso l’Europa per ottenere un maggior coinvolgimento nelle operazioni in mare e per rivedere il «sistema Dublino» che sostanzialmente obbliga gli stati di arrivo ad esaurire al loro interno le procedure di asilo e di accoglienza dei rifugiati. L’esatto contrario di quel principio di solidarietà europea che ispira la lettera e lo spirito dei principi dell’Unione. Il risultato su questo piano è stato decisamente modesto. L’operazione Mare nostrum è stata sostituita da Triton (sostanzialmente nel perimetro di Frontex), caratterizzata da mezzi e da regole di ingaggio decisamente insufficienti. Di riformare Dublino (attraverso la predisposizione di quote proporzionali di accoglienza tra i vari paesi) nessuno in Europa parla seriamente. L Ancora tragedie a largo delle nostre coste. L’operazione Triton ha sostituito Mare nostrum, ma come ampiamente prevedibile si è rivelata del tutto inadeguata e la solidarietà europea è mancata di nuovo: il peso maggiore degli sforzi ricade ancora sull’Italia. Nessuno infatti parla di rivedere il «sistema Dublino», magari predisponendo quote proporzionali di accoglienza tra i vari paesi. Zaccaria è professore di Diritto costituzionale all’Università di Firenze. 4 L’inizio del 2015 si è subito caratterizzato con dati ancora più preoccupanti. La situazione internazionale, dopo gli eventi drammatici di Parigi e di altre capitali europee, ha messo in primo piano gravissimi problemi di sicurezza; le vicende della Libia, con l’acuirsi dell’instabilità politica, dell’avanzata delle truppe dell’Isis, della partenza del nostro ambasciatore, hanno reso drammatica la situazione in quel paese. Gli attraversamenti via mare, nonostante le condizioni avverse del periodo invernale, sono ripresi ad un ritmo quasi raddoppiato rispetto a quello dell’anno precedente e purtroppo si sono verificate nuove tragedie nelle acque di Lampedusa. Molti sono stati i morti e in alcuni casi drammaticamente per assideramento quando le persone già si trovavano sui mezzi di salvataggio. Moltissimi i dispersi. Si è dato inizio ad una contabilità di proporzioni ancora più gravi rispetto al passato. L’operazione Triton ha rivelato, come si sapeva o si poteva prevedere, la sua assoluta inadeguatezza. La solidarietà europea è parsa lontana dal delinearsi ed ancora una volta il peso maggiore degli sforzi ha finito con il ricadere sul nostro paese. Naturalmente di fronte ad una situazione obiettivamente drammatica, non mancano le operazioni spregiudicate di ulteriore drammatizzazione. Risulta più che mai facile mescolare impropriamente i termini immigrazione e terrorismo, suscitando allarmi crescenti nel paese e nella comunità internazionale. Proprio questo è il momento invece di usare la maggiore razionalità possibile. Bande criminali e forse anche frange di terrorismo speculano a monte sul traffico collegato ai viaggi dei rifugiati e dei migranti. Per questo la comunità internazionale e l’Europa devono cercare paesi e luoghi di accesso protetto ovunque sia possibile, in Africa, nel Medio oriente, vicino alle aree di crisi, per evitare fin dall’inizio questi viaggi verso la morte. Se e quando questi disperati si imbarcassero per attraversare il Mediterraneo è indispensabile con mezzi navali adeguati: salvarli, identificarli, arrestare i trafficanti e requisire o distruggere i natanti. Tutte queste misure, anche se costose, sono essenziali per coniugare insieme accoglienza, solidarietà e sicurezza. Una volta che queste persone siano approdate in un qualunque paese europeo di primo ingresso, devono esse- GLI EDITORIALI re rigorosamente identificate, dal punto di vista personale e del loro fabbisogno sanitario, curate, assistite in termini di prima accoglienza. Deve essere valutata l’esistenza dei presupposti per rimanere e poi le presenze debbono essere ripartite tra i vari paesi, tenendo conto della situazione personale e dei possibili ricongiungimenti, secondo un fondamentale ed elementare principio di solidarietà. Solo se l’Europa sarà in grado di gestire con una visione d’insieme tutti questi passaggi il problema potrà essere governato nel quadro di un sistema comune. E solo allora potremo dire di esserci incamminati sulla strada giusta. Uscire dalla gabbia d’acciaio europea Tonino Perna a vittoria di Syriza alle elezioni politiche in Grecia ha aperto una finestra nella triste politica dell’austerity che imperversa da quando è scoppiata la crisi finanziaria. La trattativa/negoziazione di Tsipras e Varoufakis (il ministro delle Finanze) con i vertici di Bruxelles andrà avanti per mesi e non sappiamo come finirà. Quello che sappiamo è che per la prima volta un piccolo paese della Ue, con appena il 2% del Pil della Comunità, è riuscito ad alzare la testa ed a mettere in discussione l’ideologia dei mercati finanziari e la religione del debito come colpa che i cittadini devono scontare, anche se non sono loro i responsabili del processo di indebitamento. Come sappiamo, i diktat della troika (Commissione europea, Banca centrale europea e Fondo monetario internazionale) hanno impoverito brutalmente la società greca come mai era successo in tempo di pace. Non per caso si è parlato di «guerra economica» che insieme a quelle che sono state definite «guerre umanitarie» hanno costituito le due nefaste coordinate dentro le quali la classe politica dominante ha pensato di costruire l’Unione europea negli ultimi decenni. A cui va aggiunta la terza coordinata che è emersa chiaramente negli ultimi tempi: la guerra ai migranti. Con questi tre assi la burocrazia e la classe politica dominante nella Ue hanno L «I diktat della troika hanno impoverito brutalmente la società greca come mai era successo in tempo di pace. Non per caso si è parlato di “guerra economica” che insieme a quelle che sono state definite “guerre umanitarie” hanno costituito le due nefaste coordinate dentro le quali la classe politica dominante ha pensato di costruire l’Unione europea negli ultimi decenni». Economista e sociologo, Perna è docente di Sociologia economica alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Messina. 5 di fatto eretto, in nome della «sicurezza finanziaria» una grande gabbia d’acciaio (fabbricato nella Ruhr) che ci sta stritolando. Dopo la caduta del muro di Berlino l’Ue avrebbe potuto portare avanti una politica di pace e disarmo, mettendo in discussione la stessa sopravvivenza della Nato, che aveva perso la sua ragione sociale con la scomparsa del «pericolo rosso». Ed invece abbiamo continuato ad essere succubi delle strategie militari Usa, seguendo la superpotenza nelle «guerre umanitarie», all’insegna dell’esportazione della nostra democrazia, facendoci complici dei danni gravissimi che abbiamo prodotto in Somalia, Iraq, Afghanistan, Libia (per citare i casi più eclatanti). Ed oggi siamo succubi dell’espansione della Nato sotto le porte di Mosca, che ha portato alla guerra in Ucraina ed alle sanzioni alla Russia che colpiscono soprattutto la nostra economia. In breve: abbiamo perso l’occasione storica per allargare l’Unione europea ed includere la Federazione Russa, creando un grande mercato interno, paragonabile a quello della Cina o dell’India. Allo stesso tempo, abbiamo chiuso le porte e le finestre al Mediterraneo, impedendo al momento opportuno (inizi del secolo) che la Turchia entrasse nell’Unione europea, costruendo un ponte culturale importante col mondo islamico, prima che questo paese cadesse nelle mani di un governo islamico che sta sotterrando la sua tradizione laica. Infine, abbiamo intrapreso una vigliacca «guerra ai migranti», guerra non dichiarata che produce ugualmente decine di migliaia di morti. In breve: ci siamo chiusi in una gabbia pensando di essere autosufficienti. Una scelta miope e suicida che ci porterà all’implosione se non cambiamo registro. Come uscirne? Il popolo greco scegliendo Syriza ci ha indicato una finestra che ci potrebbe permettere di respirare nel breve periodo, che potrebbe allentare la morsa della guerra economica che sta colpendo in tutta la Ue le fasce deboli della popolazione e lo stesso ceto medio. Ma, non basta. Occorre allo stesso tempo rompere con la strategia militare Usa e rivendicare un ruolo di pace per la Ue, un nuovo rapporto con i popoli del Mediterraneo e dell’est europeo. A partire dalla irrisolta, tragica, questione della Palestina. Così come rispetto all’inarrestabile flusso di migranti dalla sponda sud del Mediterraneo, spesso frutto di guerre che noi GLI EDITORIALI abbiamo sostenuto o volutamente ignorato, deve essere avviato un reale e fruttuoso processo di cooperazione con tutti i paesi della sponda sud e sud-est del Mediterraneo, non dimenticando che è un «mare di mezzo» tra terre che per millenni hanno intrecciato le loro storie, culture, economie. La gabbia d’acciaio va spezzata, nel nostro interesse e di quello dell’intera umanità. Libertà religiosa in cerca di una legge Marco Ventura ono maturi i tempi perché il Parlamento abroghi le norme sui culti ammessi del 1929-1930 e le sostituisca con disposizioni adatte al nuovo contesto. Convergono in proposito gli attori intervenuti al convegno tenutosi presso il Senato il 17 e 18 febbraio 2015. Le Chiese evangeliche in Italia hanno promosso l’iniziativa. Si battono da lunga data per una legge sulla libertà religiosa. Sono un interlocutore autorevole del governo e delle forze politiche. Hanno una leadership morale tra le confessioni e comunità religiose diverse dalla cattolica. Nel convegno al Senato, la Federazione delle chiese evangeliche ha rinnovato il suo appello per norme sulla libertà religiosa adeguate ai nuovi bisogni. La Chiesa cattolica è apparsa pronta a dialogare. Già la presenza al convegno del segretario generale della Conferenza episcopale italiana, una storica prima volta, ha rappresentato un segno di grande valore. Le parole di monsignor Galantino hanno dato corpo al segno. Davanti a «situazioni consolidate» come la legislazione sui culti ammessi, ha affermato il vescovo, è difficile «rivedere i nostri atteggiamenti». Ma necessario: in giro c’è ancora «troppa pigrizia intellettuale». Fedele a Francesco, la Chiesa cattolica è «Chiesa in uscita», che «gioca d’anticipo»; anzitutto «su se stessa». Inevitabile la conseguenza sulla libertà religiosa. Per il segretario generale, l’impostazione «sospettosa e avara» della legislazione sui culti ammessi «va superata». Servono norme ispirate alla «corretta laicità» quale definita dalla Corte costituzionale, all’eguaglianza nella libertà, ai valori del pluralismo. Monsignor S Molti gli interventi al convegno che si è svolto al Senato il 17 e 18 febbraio sul tema «Dai culti ammessi alla libertà religiosa». La Fcei, promotrice dell’incontro, ha rinnovato il suo appello per norme sulla libertà religiosa adeguate ai nuovi bisogni e la Chiesa cattolica è apparsa pronta a dialogare. Ventura è docente di Diritto delle religioni e Diritto canonico nelle Università di Lovanio e Siena. 6 Galantino ha espresso il timore dei vescovi cattolici per «amnesie» e «strabismi», per una laicità «monista, alla francese», per una legge che incoraggi «movimenti pseudo-religiosi e sette», il «livellamento al basso» e l’«omogeneizzazione verso l’alto». Nondimeno la Chiesa cattolica è capace «di confrontarsi su tutto», ed è pronta ad «approfondire insieme un intervento legislativo», ha aggiunto il vescovo, convinto che questo tempo sia «propizio per cercare insieme». È un contributo incoraggiante perché aggredisce il nemico peggiore di questi anni: l’inerzia, l’immobilismo. L’intervento del presidente del Senato ha portato l’avallo dell’attore statale alla convergenza tra attori confessionali. Grasso ha auspicato la «rapida e necessaria revisione della legge del 1929». Ha invitato a «garantire a pieno i principi costituzionali», «in modo pragmatico e realistico», mediante una risposta legislativa alle «sfide poste dal pluralismo religioso e culturale» che sostenga lo «sviluppo della società italiana ed europea». Il lavoro per una nuova legge, ha concluso il presidente Grasso, è oltre che una «battaglia politica», un «impegno culturale», e addirittura «un dovere etico per il nostro Paese». Alla convergenza registratasi al convegno va ora data sostanza. È forte la responsabilità degli attori religiosi. Dalle associazioni dei musulmani e dai vescovi cattolici, in particolare, si attendono passi coraggiosi. La sfida è non meno delicata in casa dell’attore statale. Il governo deve assumersi la sua responsabilità. Sul piano politico, certo. Ma anche su quello tecnico. Le sue articolazioni con competenze in materia di politica religiosa dovranno coordinarsi o quanto meno non ostacolarsi. La sede decisiva, tuttavia, resta il Parlamento. Proprio perché così significativa sul piano simbolico e pratico, una legge sulla libertà religiosa è possibile solo se si sa dare risposta alle remore degli eletti e alle inquietudini degli elettori. Pezzi cospicui del paese hanno paura dell’immigrazione e dell’islam. Esistono forze politiche determinate a trarne vantaggio. Lo dimostra la sciagurata legge anti moschea della Regione Lombardia. Nelle ragioni, nei principi, nel testo, nel percorso parlamentare, la legge sulla libertà religiosa dovrà convincere eletti ed elettori. Può nascere, la legge, solo se è risposta democratica alla realtà del paese. MEDIO ORIENTE La favola della «lotta al terrorismo» Mostafa El Ayoubi È ormai evidente – anche agli ottimisti più irriducibili – che le speranze suscitate in tutto il mondo dalle cosiddette primavere arabe sono rimaste del tutto disattese. Piuttosto, oggi assistiamo a una rigogliosa «primavera jihadista», che spiana la strada alla realizzazione del progetto statunitense di egemonia sul Medio Oriente. l mondo arabo continua a non trovare pace. Il linguaggio delle armi, con tutto ciò che comporta in termini di ingenti perdite di vite umane, di instabilità politica, sociale ed economica, è quello che la fa da padrone in Paesi come l’Iraq, la Siria e la Libia. La repressione è il sistema più consono ai regimi che «governano» Paesi come il Bahrein e l’Egitto. E lo Yemen – da tanti anni oggetto di operazioni militari americane mediante i droni, lontano dai riflettori dei media – versa oggi nel caos totale: dopo decenni di sottomissione al regime saudita, Sana’a è passata in mano ai ribelli houthi, sciiti, vicini all’Iran. A contribuire al permanere e al peggioramento della già grave situazione di instabilità in queste nazioni, sono i regimi arabi settari del Golfo: Arabia Saudita, Qatar e anche Emirati Arabi; Paesi sotto dittatura assoluta, che oltre a perpetrare una forte repressione, all’occorrenza privano i loro oppositori del titolo di cittadinanza! Un oppositore al regime saudita rischia di perdere la sua cittadinanza con tutto ciò che ne consegue: perdita di beni, di diritti ecc. Queste arcaiche monarchie del petrodollaro hanno contribuito in maniera decisiva al dilagare del terrorismo, la cui massima espressione oggi è il famigerato Isis, organizzazione derivante da Al-Qaeda. Quattro anni fa si evocava una «primavera araba»; si parlava di vento di libertà e democrazia che avrebbe interessato l’intero mondo arabo. Chi ha coniato e diffuso questa novella, oggi non osa più menzionarla. È stata una favola per addormentare le coscienze dell’opinione pubblica, per orchestrare dei cambi di regimi non funzionali agli interessi delle grandi potenze mondiali (alcuni che non lo sono più come l’Egitto, altri che non lo sono mai stati come in Libia e in Siria). I 7 L’espressione forse più azzeccata oggi in questa fase buia della storia del mondo araboislamico è «primavera jihadista». Per i jihadisti è una «primavera», un successo, perché oggi occupano parte della Siria, dell’Iraq e della Libia, Paesi una volta governati da regimi laici (non democratici ovviamente, ma d’altronde è un problema che riguarda l’intero mondo arabo). Ma quanto durerà questo successo dei jihadisti? Il tempo necessario per consentire loro di portare a termine la distruzione totale dell’apparato dello Stato, delle sue infrastrutture e del sistema economico produttivo in questi Paesi. In Libia l’operazione è giunta al termine. Affidando questo compito ai jihadisti, gli Usa (con la partecipazione dei loro alleati) sperano di poter appropriarsi della sovranità di quei Paesi. Per il governo americano, i jihadisti sono un efficace strumento per l’attuazione di un piano che consente di trasformare il Medio Oriente in un «protettorato americano» (come afferma Losurdo; vedi la sua intervista a pagina 9) mediante una «guerra per procura». Questa regione è strategica per il gas, il petrolio, l’acqua. E controllarla significa frenare l’espansione geopolitica e geo-economica di potenze regionali come l’Iran e mondiali come la Cina e la Russia (le quali a loro volta mirano a promuovere i propri interessi). Il marasma in cui vive oggi il mondo arabo ha poco a che fare con le questioni dei diritti umani e della democrazia; quello che è in gioco sono gli interessi geostrategici. Il repubblicano Henry Kissinger, segretario di Stato americano tra 1973 e il 1977, disse una volta: «Se noi dobbiamo scegliere tra i nostri interessi e la democrazia, sceglieremo sempre i nostri interessi». Per la cronaca, Kissinger ebbe un ruolo determinante nel colpo di Stato in Cile che condusse al potere il sanguinario regime di Pinochet. La strategia moderna per promuovere e consolidare i propri interessi nel Medio Oriente è la «guerra per procura» per destabilizzare i regimi non allineati. Questo compito è stato «appaltato» ai regimi oscurantisti del Golfo in primo luogo. I jihadisti di Al- i servizi marzo 2015 confronti MEDIO ORIENTE Qaeda/Isis non sono altro che la manovalanza alla quale è stata affidata l’esecuzione materiale di questa strategia, di cui gli operai del terrorismo (kamikaze, ecc) non sono nemmeno al corrente! È ormai un mantra – ma è sempre importante ripeterlo – quello di ricordare che AlQaeda (da cui è nato l’Isis) è una creazione dei servizi segreti americani (assieme ai talebani, all’epoca della guerra in Afghanistan). E a metterla in piedi, finanziarla e farla crescere sono stati uomini della famiglia reale saudita, tra i quali il principe Bandar Bin Sultan, ex ambasciatore saudita in Usa ed ex capo dei servizi segreti. Nel 2002 una commissione del Senato americano co-presieduta dal senatore Bob Graham ha prodotto un rapporto sugli attentati dell’11 settembre. Per «ragioni di Stato» il rapporto è stato tenuto segreto da Bush e mantenuto tale da Obama. Questo rapporto parla dell’implicazione dell’Arabia Saudita nella tragedia dell’11 settembre. Il senatore Graham pubblicò nel 2008 un libro intitolato «Intelligence matters» in cui parla di un capitolo di 28 pagine del suddetto rapporto, nel quale viene accertato che l’operazione condotta da 19 terroristi (di cui 15 di nazionalità saudita) è stata finanziata principalmente dall’Arabia Saudita, un alleato di prim’ordine della Casa Bianca. Perché i media continuano a sottacere questo fatto importante? Il regno saudita insieme a quello del Qatar (nonostante le apparenti divergenze politiche tra queste due monarchie) hanno inondato il mondo arabo e una parte dell’Africa subsahariana di jihadisti tafkiristi indottrinati con l’ideologia salafita, la quale predica una visione distorta della religione islamica. Eppure questi Paesi partecipano oggi al bombardamento dei territori iracheni e siriani con l’intento di combattere l’Isis. Com’è possibile combattere il terrorismo al fianco di chi lo crea e lo finanzia? Paradossale! Se è vero che lo si vuole combattere allora bisogna iniziare dall’Arabia Saudita. In realtà con la storiella della «lotta al terrorismo» gli Usa manipolano l’opinione pubblica internazionale costringendola ad accettare provvedimenti drastici: uso necessario della guerra, restrizioni di diritti individuali e collettivi in nome della sicurezza. L’Isis dilaga oggi in Libia. Questo Paese è stato distrutto dalla Nato e a chiedere l’intervento militare con una risoluzione all’Onu, nel marzo 2011, è stata la Lega araba sotto controllo dei sauditi. A Derna, il Califfato ha Il regno saudita insieme a quello del Qatar (nonostante le apparenti divergenze politiche tra queste due monarchie) hanno inondato il mondo arabo e una parte dell’Africa subsahariana di jihadisti tafkiristi indottrinati con l’ideologia salafita, la quale predica una visione distorta della religione islamica. Eppure questi Paesi partecipano oggi al bombardamento dei territori iracheni e siriani con l’intento di combattere l’Isis. Com’è possibile combattere il terrorismo al fianco di chi lo crea e lo finanzia? 8 già stabilito un suo emirato, a 300 chilometri dalle coste italiane e a 200 chilometri dalle frontiere con l’Egitto. Anche in Libia l’Isis sgozza e commette attentati mortali. Davanti a questa «nuova» minaccia si torna a parlare di un nuovo intervento militare in Libia. A metà dicembre scorso, in occasione di un summit franco-africano, il presidente del Ciad, Idriss Déby Itno, ha affermato che «la risoluzione della crisi in Libia è in mano alla Nato». E in seguito agli attacchi terroristici a Parigi, nel gennaio scorso, il presidente Hollande ha fatto intendere che sia necessario un altro intervento militare in Libia. In questo gioco è entrato ormai anche il regime egiziano di Al Sisi che, dopo lo sgozzamento di massa a danno di 21 dei suoi cittadini copti, ha replicato con raid aerei contro postazioni dei jihadisti in Libia. L’Egitto, che ha sognato quattro anni fa la libertà e la democrazia, è oggi sotto tutela dell’Arabia Saudita. A metà febbraio, Al-Sisi ha firmato con la Francia un contratto per l’acquisto di armi. Il costo dell’operazione è di 5,2 miliardi, tutto a carico dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi. Hollande ha definito l’operazione come necessaria per la sicurezza dell’Egitto e del Medio Oriente. È un ottimo affare per la Francia, in questa fase di crisi economica, e per la sua multinazionale Dassault Aviation: 24 cacciabombardieri Rafale venduti al regime del Cairo. Dassault ha tutto l’interesse a convincere la gente che la guerra è necessaria e lo fa ormai da anni attraverso Le Figaro, giornale di sua proprietà, uno dei più venduti in Francia (a proposito di libertà d’informazione!). Di recente, in una visita a Parigi, Al-Sisi ha esortato l’Europa ad intervenire militarmente in Libia. In Egitto, dopo un periodo flash di prove generali per l’avvio della democrazia, il colpo di Stato del 3 luglio 2013 ha riportato la lancetta della storia al periodo pre-rivoluzione del 25 gennaio 2011 caratterizzato dalla violenza e dalla repressione. Da quando è arrivato Al-Sisi al potere la situazione dei diritti umani è peggiorata. Lo afferma Amnesty international, che parla di una «repressione senza precedenti negli ultimi 30 anni»: 1500 condanne a morte e 45mila oppositori incarcerati... Il governo francese tutto ciò lo sa, ma evidentemente vale anche per esso la massima di Henry Kissinger di cui sopra, che del resto è il motto cardine di tutte le potenze (neo)coloniali. i servizi marzo 2015 confronti MEDIO ORIENTE E l’apprendista stregone Occidente «creò» l’Isis Diversi paesi arabi sono oggi disastrati e distrutti. Quali sono le cause della gravissima crisi in cui vivono paesi come la Libia, la Siria e l’Iraq? A partire da quello che era stato strombazzato come l’anno di grazia, il 1989, sono stati investiti dalla guerra Panama, l’Iraq, la Jugoslavia, la Libia, la Siria... L’epicentro di questi conflitti è costituito dal Medio Oriente, dove l’Occidente assicura di voler apportare civiltà, democrazia, pace. Dopo centinaia di migliaia di morti, milioni di feriti e milioni di profughi, la realtà è sotto gli occhi di tutti. Non si tratta solo delle terribili devastazioni materiali. In occasione della prima e della seconda guerra del Golfo (1991 e 2003) gli sciiti iracheni furono chiamati alla rivolta contro i sunniti guidati da Saddam Hussein; successivamente, con lo sguardo rivolto all’Iran sciita e ai suoi possibili alleati, sono stati i sunniti a essere sollecitati a prendere le armi contro gli sciiti in Iraq e soprattutto in Siria. Ai giorni nostri, dopo essere stati incoraggiati in Siria, gli spietati guerrieri sunniti del Califfato sono combattuti in Iraq e soprattutto nel Kurdistan secessionista. In tutto il Medio Oriente, nella lotta contro i regimi laici scaturiti dalle rivoluzioni anticoloniali (che hanno fatto seguito alla Seconda guerra mondiale) e contro i movimenti di liberazione nazionale collocati su posizioni laiche, l’Occidente ha fatto appello alla religione e al fondamentalismo religioso: così in Iraq, Libia, Siria, Palestina, dove Israele a suo tempo appoggiò Hamas contro l’Olp di Arafat. Impressionante è la scia di distruzione e di morte: paesi come l’Iraq, la Libia, la Siria rischiano di cessare di esistere come Stati nazionali unitari e indipendenti, mentre priva ormai di qualsiasi credibilità è la fondazione di uno Stato nazionale palestinese, il cui territorio diviene sempre più esiguo e sempre più frammentato. C’è di peggio. In Medio Oriente divampa la guerra civile tra laici e religiosi, nell’ambito del mondo religioso tra islamici e cristiani, nell’ambito dell’islam tra sunniti e sciiti. In conseguenza di tutto ciò, l’Iraq e la Siria vedono una parte del loro ter- Domenico Losurdo «In tutto il Medio Oriente, nella lotta contro i regimi laici scaturiti dalle rivoluzioni anticoloniali (che hanno fatto seguito alla Seconda guerra mondiale) e contro i movimenti di liberazione nazionale collocati su posizioni laiche, l’Occidente ha fatto appello alla religione e al fondamentalismo religioso: così in Iraq, Libia, Siria, Palestina, dove Israele a suo tempo appoggiò Hamas contro l’Olp di Arafat». Filosofo e storico, Losurso ha insegnato Filosofia della storia all’Università di Urbino. 9 ritorio occupato da forze qaediste, almeno inizialmente finanziate e armate dall’Arabia Saudita (da sempre alleata con l’Occidente), e il cui comportamento può suscitare solo orrore. È vero che i jihadisti si sono moltiplicati a dismisura in questi ultimi anni, soprattutto a partire dalla cosiddetta Primavera araba? «Primavera araba» è un’espressione chiaramente ideologica. Se si vuol fare riferimento all’irruzione della democrazia nel Medio Oriente, occorrerebbe prendere le mosse in realtà dal 1979, e cioè dalla rivoluzione che in Iran (un paese islamico ma non arabo) ha posto fine alla spietata dittatura di una dinastia appoggiata dall’Occidente, col rovesciamento a opera degli Usa e della Gran Bretagna, nel 1953, del governo democratico di Mossadeq. Nonostante viva sotto la minaccia costante di un attacco statunitense (assieme ai suoi alleati, ndr), l’Iran, con la sua vivace dialettica politica, è indubbiamente ben più democratico di paesi quali la Libia o l’Egitto, dove avrebbe avuto luogo la «Primavera araba». Se invece ci si vuole concentrare esclusivamente sul mondo arabo, bisognerebbe prendere le mosse dal 1991. A partire dalla prima guerra del Golfo, l’Occidente si è impegnato ad aggredire o a destabilizzare i paesi (l’Iraq, la Libia, la Siria) che bene o male avevano alle spalle una rivoluzione anticoloniale e antifeudale (più complesso è il caso dell’Egitto). Nello scatenare l’attacco, gli Usa e i loro alleati europei si sono avvalsi dell’appoggio di paesi come l’Arabia Saudita, che non hanno mai conosciuto una rivoluzione anticoloniale e antifeudale, e di bande armate fondamentaliste che da ultimo hanno assunto la configurazione dell’Isis. Chi sono veramente e come sono riusciti ad avere tutta questa forza militare che oggi preoccupa l’Occidente? Gli Stati Uniti hanno condotto la guerra per procura prima contro la Libia di Gheddafi e poi contro la Siria di Assad, finanziando e armando quella che oggi è l’Isis. Abbiamo così un mostro che l’apprendista stregone occidentale ha creato ma non riesce più a controllare. È da aggiungere che la distruzione materiale e spirituale e la balcanizzazione inflitte al Medio Oriente realizzano le condizioni favorevoli per l’emergere e il diffondersi della nostalgia per un Califfato al tempo i servizi marzo 2015 confronti MEDIO ORIENTE stesso miticamente trasfigurato e distorto in senso selvaggiamente fondamentalista. Esiste un nesso geopolitico tra le guerre che devastano il Medio Oriente e gli attentati di Parigi? Non si può comprendere il barbaro attentato di Parigi ignorando la carica di frustrazione e di risentimento che colpisce il mondo arabo e islamico. Nella stessa Francia gli arabi e gli islamici si sentono discriminati: sul piano sociale sono reclusi nei segmenti inferiori del mercato del lavoro e segregati in banlieues spesso fatiscenti. Mentre la loro religione e la loro identità religiosa (e indirettamente nazionale) può incessantemente essere derisa e vilipesa, allorché essi reagiscono, sia pure maldestramente alla maniera del comico Dieudonné, ecco che dilegua la conclamata libertà di parola. Vale la pena di ricordare quello che già alcuni anni prima dell’11 settembre 2001 scriveva un illustre politologo statunitense di orientamento conservatore (Samuel Huntington): ai giorni nostri, «in Europa occidentale, l’antisemitismo verso gli ebrei è stato in larga parte soppiantato dall’antisemitismo verso gli arabi». Certo, gli assassini dell’Isis colpiscono gli ebrei, assieme ai cristiani e agli sciiti, ma in Europa occidentale sono solo l’islam e i suoi seguaci a essere oggetto di un pregiudizio di massa, che talvolta investe anche l’alta cultura. «Non si può comprendere il barbaro attentato di Parigi ignorando la carica di frustrazione e di risentimento che colpisce il mondo arabo e islamico, e non solo a causa delle guerre dall’Occidente scatenate contro di esso e dell’interminabile martirio del popolo palestinese. Nella stessa Francia gli arabi e gli islamici si sentono discriminati: sul piano sociale sono reclusi nei segmenti inferiori del mercato del lavoro e segregati in banlieues spesso fatiscenti». È possibile individuare delle «colpe» occidentali e/o musulmane in questi attentati? È bene tener ferma una distinzione: i musulmani o islamici sono i seguaci di una religione, l’Occidente è una realtà geopolitica. Se si vuole analizzare il ruolo della religione, bisognerebbe procedere a una comparatistica delle «colpe» o responsabilità delle tre grandi religioni monoteistiche presenti in Medio Oriente: islam, ebraismo, cristianesimo. Non credo che la prima se la cavi peggio delle altre due. Come ho spiegato in un mio libro (Il linguaggio dell’Impero, Laterza), criticando dura- 10 mente Oriana Fallaci, se gli antisemiti e i giudeofobi amavano mettere sul banco degli imputati Jahvé, oggi invece su quel banco gli islamofobi trascinano Allah. Pressoché immutato è rimasto il capo d’imputazione: ieri il Dio dell’ebraismo, oggi quello dell’islam è considerato l’ispiratore del fanatismo, dell’intolleranza, dell’odio teologico. È preferibile concentrarsi sulla geopolitica. Alcuni anni fa, Huntington, in un celebre libro (Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine internazionale) tracciava un eloquente bilancio dello scontro tra Occidente e mondo arabo-islamico: «Il Dipartimento della Difesa statunitense riferisce che nel quindicennio 1980-1995 gli Stati Uniti sono stati impegnati in diciassette operazioni militari in Medio Oriente, tutte dirette contro Stati musulmani. Non esiste un ruolino lontanamente paragonabile di operazioni militari statunitensi contro la popolazione di qualunque altra civiltà». In ogni caso, sempre secondo Huntington, il quadro strategico della regione ha subito radicali mutamenti: «La posta in gio- i servizi marzo 2015 confronti MEDIO ORIENTE co [della prima guerra del Golfo] era stabilire se il grosso delle maggiori riserve petrolifere del mondo sarebbe stato controllato dai governi sauditi e dagli emirati – la cui sicurezza era affidata alla potenza militare occidentale – oppure da regimi indipendenti antioccidentali in grado e forse decisi a utilizzare l’arma del petrolio contro l’Occidente»; fortunatamente, ora il Golfo Persico è «diventato un lago americano». Senonché, questo progetto incontra una resistenza inaspettata e crescente ed è chiaramente destinato al fallimento. Esiste un nesso tra la crisi in Siria e quella in Ucraina? Intanto, conviene notare una contraddizione così clamorosa da essere persino divertente. In Ucraina, sorvolando sul colpo di Stato da essi organizzato e riconosciuto come tale da autorevoli analisti (ad esempio Sergio Romano), gli Usa denunciano le interferenze della Russia; al tempo stesso, in modo aperto e dichiarato, Obama dà disposizioni perché sia armato e addestrato un esercito di ribelli chiamato a rovesciare in Siria il governo di al-Assad. Il primo nesso che balza agli occhi è questo: nonostante che non si stanchino di agitare la bandiera dell’universalismo, l’Occidente e il suo paese-guida si rivelano incapaci di enunciare norme e regole che siano vincolanti per tutti. Anche il secondo nesso è sufficientemente chiaro: il colpo di Stato in Ucraina si proponeva in definitiva di inglobarla nella Nato, in modo da far avanzare l’accerchiamento della Russia; la guerra per procura contro la Siria è parte integrante del tentativo (cui ho già accennato) di imporre in Medio Oriente il protettorato americano, al fine anche di rendere possibile il «pivot» in direzione dell’Asia e contro la Cina. Si tratta di due aspetti di un unico piano: prima che si accentui il loro declino, gli Usa tentano di perpetuare la loro egemonia mondiale, avvalendosi della loro permanente superiorità militare al fine di estendere e rafforzare il controllo sulle aree geopoliticamente decisive del pianeta. Quali sono le conseguenze di queste crisi sull’Europa? In conseguenza del formidabile sviluppo economico e tecnologico della Cina e dell’ascesa dei paesi emergenti, volge ormai al termine l’«era colombiana», il mezzo millennio di «Prima che si accentui il loro declino, gli Usa tentano di perpetuare la loro egemonia mondiale, avvalendosi della loro permanente superiorità militare al fine di estendere e rafforzare il controllo sulle aree geopoliticamente decisive del pianeta». 11 storia che, a partire dalla scoperta-conquista dell’America, ha visto l’Occidente assoggettare, schiavizzare e decimare la restante umanità. Nel mondo che si sta affermando non c’è più posto per il monopolio della tecnologia detenuto dall’Occidente e per la sua incontrastata egemonia mondiale; rapporti di eguaglianza tendono ad affermarsi tra le varie nazioni e tra le varie civiltà. È il risultato della rivoluzione anticoloniale mondiale che si è sviluppata a partire dall’ottobre 1917. Saprà accettare l’Occidente la fine dell’«era colombiana»? Avendo alle loro spalle una tradizione in cui è fortemente presente il mito della «nazione eletta da Dio» ovvero (in termini appena più laici) dell’unica «nazione indispensabile», gli Usa incontrano particolari difficoltà ad adattarsi alla nuova situazione. Disgraziatamente, fiancheggiando Washington nelle sue sciagurate avventure imperiali, l’Europa ha dato prova di sconfortante subalternità e in tal modo ha visto accentuarsi il suo declino. Essa potrà contenere e risolvere la sua crisi, al tempo stesso economica e politica, solo se saprà stabilire un nuovo rapporto con i paesi emergenti e rompere in modo radicale con il suo passato coloniale e neocoloniale. intervista a cura di Carmelo Russo SOCIETA’ I razzismi «costruiti dall’alto» Roberto Mazzoli L’immagine fornita dai media sui rom è spesso negativa. Molti sono convinti che esista una differenza di carattere culturale che rende incompatibile la convivenza sociale. Ma il razzismo contro i rom fa comodo alle classi dirigenti che, spostando l’attenzione su di loro, possono così «incanalare» la rabbia e la frustrazione della società. l razzismo contro i rom è una prassi di discriminazione sociale fondata su stereotipi e pregiudizi antichi e particolarmente persistenti. Esso è alimentato da cognizioni non basate sull’esperienza, come tutti gli stereotipi e i pregiudizi, ma accolte «per sentito dire». Se si domanda ad un razzista di giustificare le ragioni che lo portano a discriminare una qualche categoria intera di persone (rom, ebrei, islamici, rumeni eccetera), avremo sempre a che fare con risposte inconsistenti sul piano razionale, poiché non esistono motivazioni sufficienti, poiché non si può «giudicare senza conoscere». Anche i razzisti più acculturati, posti di fronte al quesito, ad esempio: «Come fai a dire che tutti i rom sono disonesti?», saranno costretti ad arrampicarsi concettualmente su una presunta differenza di carattere culturale che rende incompatibile la convivenza, se ritengono esagerato spingersi fino ad un razzismo di carattere biologico, scientificamente ancora più impresentabile. Il punto centrale di ogni razzismo sta qua, nell’«evitamento della ragione». Ed è da qua che bisogna partire per sconfiggerlo. Il razzismo contro i rom è, di conseguenza, una delle numerose forme di espletamento della violenza sociale intergruppi, una delle modalità attraverso le quali si strutturano le relazioni tra gruppi di maggioranza e gruppi di minoranza: le maggioranze, per rafforzare la coesione al proprio interno, al fine di mantenere e consolidare il potere in mano alla propria classe dirigente, identificano una minoranza verso la quale depositare una porzione di frustrazione del corpo sociale, alimentando dall’alto sentimenti discriminatori già circolanti fra la popolazione; in questo modo si effettua uno sposta- I Mazzoli è psicologo sociale e ricercatore. 12 mento dell’attenzione dalle responsabilità che si dovrebbero attribuire alle istituzioni per il cattivo funzionamento della convivenza sociale. Questo vale sempre e, tanto più, durante le fasi storiche di crisi economica. Nella sostanza non è diverso né più grave di qualsiasi altra forma di razzismo, ma si caratterizza per il suo apparire, insieme con il razzismo contro gli ebrei, quello più ampiamente legittimato socialmente. È riscontrabile in moltissimi ambienti culturali, a volte anche in quelli che ne dovrebbero essere immuni. Perché? Poiché è molto antico e quindi radicato: gli «zingari» sono i discendenti di Caino il fratricida, sono i fabbri che forgiarono i chiodi con i quali Gesù fu crocifisso, sono i nomadi misteriosi, impostori e furbi, dediti alla magia e al raggiro. Perché se in passato erano la letteratura ed il teatro ad alimentarne la sinistra e affascinante fama, insieme con infiniti procedimenti legislativi atti all’esclusione, oggi, in Italia, è la stragrande maggioranza dei mezzi di informazione a fornire dei rom una immagine parziale e insufficiente, quando non esclusivamente negativa. Nel nostro paese, inoltre, non esiste il riconoscimento dello status di minoranza per i rom e, molto peggio, un numero consistente di persone è costretto a vivere in condizioni sub-umane negli insediamenti istituzionali definiti «campi nomadi». Luoghi de-umanizzanti, veri e propri ghetti dove i diritti fondamentali sono spesso ostacolati o addirittura negati, sempre più relegati alla periferia delle città, lontani dai servizi fondamentali, dove il degrado è condizione quotidiana. Dove l’umanità resiste, ma deve affrontare enormi ostacoli, dove piccoli boss spregiudicati possono costruirsi imperi personali, basati sullo sfruttamento della disillusione delle giovani generazioni. Dove le istituzioni falliscono, per incapacità o per dolo, e fanno arricchire amministratori e faccendieri sulla pelle dei rom. La povertà fa paura, la sporcizia fa schifo, e le persone che ci vivono dentro finiscono per non essere più esseri umani come gli al- i servizi marzo 2015 confronti SOCIETA’ tri, diventano inferiori, perdono lo status di umanità per acquisire una forma intermedia animale/umana. E di conseguenza possono essere tutti relegati ai margini, espulsi, lasciati fuori, imprigionati e, perché no, bruciati dal fuoco purificatore del fascismo contemporaneo. È necessario attivare dispositivi educativi, culturali, mediatici progettati per «decostruire» gli stereotipi, facilitando la conoscenza delle specificità della cultura rom che i rom stessi sceglieranno, lasciando che siano essi stessi ad autorappresentarsi nelle forme e nelle modalità che riterranno più opportune. Chiudere i campi istituzionali e realizzare l’estensione dei diritti fondamentali di tutte le donne e gli uomini rom, in particolare. Lottare ogni giorno perché la consapevolezza della costruzione sociale dall’alto dei razzismi cresca nell’animo e nella mente della popolazione intera, in generale. Oltre il pessimismo della ragione e l’ottimismo della volontà ci può essere il realismo dell’indignazione. I campi: una vergogna tutta italiana Carlo Stasolla Abbiamo intervistato due rappresentanti dell’Associazione 21 luglio, un’organizzazione non profit che si occupa da cinque anni delle comunità rom e sinte in Italia. Cosa fa la vostra associazione? L’Associazione 21 luglio nasce per la tutela e la promozione dei diritti delle comunità rom e sinte in italia con un focus rivolto soprattutto all’infanzia. Il 21 luglio ricorda infatti la data di alcuni anni fa, quando una bambina è stata sottratta ai suoi genitori da una decisione degli organi istituzionali. È un’associazione indipendente, non fa ricorso a finanziamenti pubblici. È composta da rom e da sinti e da non-rom e non-sinti, che lavorano insieme. Non eroga servizi all’interno degli insediamenti ma cerca piuttosto, a partire dai diritti umani, di promuovere l’inclusione dei rom in Italia. Sempre più frequenti gli episodi di razzismo, tra i quali cartelli appesi per le città: che fenomeno è? Abbiamo un osservatorio che monitora più di 140 testate giornalistiche in Italia. Il fenomeno dell’antiziganismo è molto forte e si amplifica nei media. Gli stereotipi e i pregiudizi producono politiche discriminatorie e le politiche discriminatorie a loro volta generano stereotipi e pregiudizi: è un cane che si morde la coda. Tutto ciò malgrado i rom in Italia rappresentino lo 0,23% della popolazione: finiscono paradossalmente per diventare il problema nazionale, come si è dimostrato nell’emergenza rom attuata dal governo italiano tra il 2008 e il 2011. Stasolla è presidente e socio fondatore dell’Associazione 21 luglio. 13 Parliamo di alcuni luoghi comuni: i rom sono tutti nomadi. Negli anni Ottanta alcune amministrazioni di centro-sinistra prendendo un abbaglio culturale hanno sostenuto che i rom sono nomadi, riferendosi a quelli appena arrivati dalla exJugoslavia, quindi incapaci di vivere in abitazioni civili. In realtà i dati sono altri. Nella storia rom e sinti sono stati sì nomadi o per antica tradizione di attività lavorativa oppure per scappare da conflitti e persecuzioni. Persecuzioni che sono nate all’inizio dell’età moderna, sono passate dal Porrajmos e continuano oggi con gli sgomberi forzati dai campi. Il Ministero del lavoro nel 2011 ha rilevato come solo il 3% dei rom in Italia sia effetti- i servizi marzo 2015 confronti SOCIETA’ vamente nomade. E in Italia, a fronte di 35 mila rom che vivono nei campi, ce ne sono 140mila che vivono in abitazioni convenzionali. In altri paesi, come nella vicina Spagna, vivono 800mila rom, e vivono tutti in abitazioni convenzionali e i campi non esistono. I campi sono un prodotto di politiche nazionali e locali tipicamente italiane, tanto che l’Italia è chiamata «il Paese dei campi». Attorno ai campi si è inoltre generato un ingente indotto economico di un associazionismo che eroga servizi. I campi di fatto sono dei ghetti etnici dove i diritti vengono sospesi. E i 140mila che abitano in case convenzionali? C’è un mimetismo dovuto al fatto che il rom o il sinto che vive in una casa ha oggi paura di dichiararsi tale, per paura di divenire discriminato, e di conseguenza perdere il lavoro e la casa. Nel nostro Paese ci sono delle enclave che vanno da Rovigo, a Terni al sud Italia dove vivono intere comunità rom anche molto numerose, migliaia di individui. Per esempio all’università di Roma ci sono 10 studenti rom che nessuno sa che sono rom. La testimonianza di Dzemila Salkànovic, che vive a Roma da 28 anni ed è sposata con un «gagè», ossia un non-rom: a volte – spiega – si incontrano i pregiudizi da entrambe le parti. L’importanza del ruolo che può giocare la scuola. Religiosamente come si suddividono i rom e i sinti in Italia? I rom storicamente si adattano alla cultura in cui si trovano. Sono molto permeabili. Anche dal punto di vista religioso troviamo tutte le espressioni religiose: musulmani, protestanti, cattolici etc. In uno stesso insediamento si trovano le religioni mischiate senza conflitto alcuno. Dzemila Salkànovic La ricchezza culturale della famiglia «mista» E che i rom non portano i figli a scuola? È estremamente residuale e riguarda le famiglie rom che vivono un estremo disagio, soprattutto abitativo, come accade in qualsiasi popolo. Dove ci sono condizioni minime per una vita dignitosa i dati dimostrano che la cultura trova piena espressione, e quindi la dimensione scolastica ed educativa assume un valore per la comunità e si verifica meno evasione scolastica. I rom hanno una lingua comune? La lingua è il romanés, lingua sanscrita. Il 3035% delle parole sono sanscrite, quindi c’è una base comune di comprensione. Ci sono poi all’interno i vari dialetti che corrispondono ai diversi gruppi. La minoranza linguistica rom non è riconosciuta come tale dalla legge del 1999 che istituisce 12 minoranze linguisticoculturali. Dopo sardi e friulani quella rom è la terza in Italia, ma la Lega Nord si oppose al riconoscimento. Neanche la minoranza in termini culturali è riconosciuta. Per questo l’Associazione 21 luglio sostiene la proposta di legge presentata l’anno scorso per il riconoscimento della minoranza linguistica e culturale rom e sinta, che è una cultura e una lingua millenaria, e quindi, come qualsiasi cultura, una ricchezza per il nostro Paese. Cosa è urgente fare? Chiudere i campi: una vergogna tutta italiana. Ce lo dice l’Europa con i suoi commissari così come i comitati delle Nazioni Unite. Bisogna riconvertire le ingenti risorse stanziate per mantenere il sistema campi in percorsi di inclusione. È fattibile, ci vuole la volontà politica. La sua vita? Sono nata in Montenegro, a Nikšić. Ho vissuto fino ai 3 anni lì, dove avevamo una casa, quando la famiglia ha deciso di spostarsi e siamo venuti in Italia, prima nel nord, poi nel sud. Abbiamo girato molto per l’Italia. Siamo a Roma da 28 anni. Ora dove vive? Da molti anni, alla prima possibilità, io e mio marito abbiamo smesso di abitare nei campi, e ci siamo trasferiti in casa. Ho preso la cittadinanza italiana. È una fantasia che i rom vogliono vivere girovaghi per i campi. In Montenegro avevamo una casa: appena c’è un’opportunità il rom esce dal campo e va in casa. Salkànovic è mediatrice culturale; lavora con l’associazione 21 luglio e si occupa nello specifico di attività con i bambini e le mamme nelle scuole e nei campi rom. 14 Con i bambini e la scuola? Ho sempre creduto nella necessità di avere una buona formazione, quindi ho iscritto da subito i miei bambini all’asilo e a scuola. Gli operatori sociali ci hanno aiutato con l’iscrizione, e subito dopo era diventato impossibile per noi mamme accompagnare e seguire i nostri figli a scuola, parlando direttamente con le maestre. Spesso accade che i mediatori, che di per sé fanno un lavoro straordinario, e sono bravissimi, finiscono per essere gli unici soggetti in gioco. Così i genitori non crescono e non possono veramente occuparsi dei propri figli. Io credo molto in una mediazione che crei il sostegno i servizi marzo 2015 confronti SOCIETA’ per le persone, di modo che poi siano esse stesse a occuparsi in prima persona delle cose, tra cui la scuola e i propri figli; è quello che facciamo adesso noi come mediatori. Come è oggi la situazione dei campi? Sono peggiorati. Sono diventati «mega campi», che io non esito a chiamare lager. Si sta ammassati, senza spazio, in situazioni di forte indigenza; e per andare a trovare mia madre nel campo ho bisogno del permesso comunale. È diventato un vero e proprio campo blindato. Ed è aumentato di molto il sentimento di razzismo nei confronti dei rom. Ha una famiglia «mista», rom e non-rom. Sì, la nostra famiglia è mista. Abbiamo vissuto nei campi i primi anni come testimonianza, sia per i gagè (non-rom) che per i rom, del fatto che una famiglia mista è una cosa possibile. Le famiglie miste sono molto rare, e di solito tagliano i contatti con entrambe le famiglie di appartenenza. Credo che questo sia un errore. Una famiglia mista deve prendere da entrambe le culture le cose belle, per arricchirsi ancora di più! Nella sua vita ha temuto per la sua sicurezza, ha avuto paura della gente? Quando dovevo girare e vivevo nei campi, vivevo sempre una situazione precaria. Non si sapeva quanto si poteva stare, giorni, mesi... Ho visto le baracche bruciare in un attimo: prendono fuoco subito. Ho avuto paura della gente. Noi andavamo in giro in gruppo per difenderci. Una volta una ragazza rom è stata violentata e nessuno è intervenuto. Altri episodi di maltrattamento sono accaduti a me in prima persona e ai miei familiari, senza che nessuno ci soccorresse. Ora ho la mia casa, il mio lavoro: mi sento parte della società. Quali pregiudizi avete incontrato? I pregiudizi dei gagé sono gli stessi che hanno i rom: «i gagè imbrogliano, rubano, non sono generosi, ingannano e non sanno cos’è la solidarietà etc». Ho lavorato per 13 anni dentro un centro d’accoglienza per rifugiati. Tra migliaia di persone che ho incontrato, non ho conosciuto un popolo buono o un popolo cattivo: ho trovato persone, esseri umani, con difficoltà, furbizie etc. Non c’è un popolo buono e un popolo cattivo. La situazione è migliore per i giovani di oggi? Oggi paradossalmente è peggio: i giovani stanno chiusi nei campi, e non sanno stare nella città, con la gente. Ho portato giovani di 16-17 anni, di Roma, che non avevano mai visto la stazione dei treni. Vivono isolati, hanno paura di uscire dai campi, hanno paura dei posti affollati. Vedono solo il pulmino per andare a scuola e tornano a casa. Non hanno momenti di condivisione, non c’è contatto reale con le persone di fuori. Come miglioriamo la situazione? Penso che anche noi rom dobbiamo darci da fare. Gli attivisti sono il futuro. Servono naturalmente anche politiche diverse su lavoro e casa, non esclusive ma finalmente inclusive. Per realizzare tutto ciò serve la scuola: è l’unico modo. Devo conoscere i miei diritti e i miei doveri, e come fare per viverli. Per fortuna in Italia ancora resiste la scuola. Come definisci la tua identità? Mi penso prima di tutto rom, e italiana. E sono anche Jugoslava. E sono molto felice di essere rom, italiana e jugoslava. interviste a cura di Claudio Paravati 15 marzo 2015 i servizi confronti SOCIETA’ I rom? Mandiamoli a casa! Sarebbe ora! Mandiamoli a casa. Ma una casa vera, però. Fatta di calce e mattoni veri, non disegnati sulle lamiere di un container. Con la luce, l’acqua, pure quella calda, il gas e perfino il riscaldamento con i termosifoni, così da non morir di freddo o per i veleni di una maledetta stufa difettosa, killer, nelle cronache di tante notti gelide finite in tragedia. I fuochi dei copertoni, meglio di no. Non sono una buona alternativa. Mandiamoli in una casa vera con il bagno e una vera cucina, con una camera da letto, veri mobili, qualche fiore colorato che si affaccia ad un balcone e una vera cameretta per i bambini, con i giocattoli sparsi nel solito «perfetto» disordine. I bambini, si sa, sono sempre bambini! Mandiamoli a casa, per Dio! Ma una casa in una palazzina vera che si trovi in una vera via o piazza, con un numero civico vero. Un cap e una cassetta per la posta con i nomi scritti sopra, anche a penna, quelli veri. Il riconoscimento dell’identità, oltre che con una carta, con fotografia appiccicata sopra, passa anche da qui. Nuovi vicini da incontrare sul pianerottolo, la mattina presto, mentre tengono per mano la mano dei figli, infiocchettati come bonbons nei loro grembiuli, con tanto di cartella e cestino con la merenda, pronti per la scuola. Scendere insieme qualche piano in ascensore, anziché calarsi dalle grondaie, e via fuori dal portone ciascuno per andare incontro alla sua giornata. Home sweet home! Ma non mandiamoli solamente a casa. Loro, non aspettano altro. Mandiamoli anche a scuola, a studiare. Pensa se a giugno, prima delle vacanze, stiamo ringraziando una maestra, rom, proprio lei, quella che ha seguito nostro figlio cosi bene... come fosse stato il suo! Allora, mandiamoli anche al lavoro, mandiamoli a prendere un metrò, naso contro naso, o su un autobus, magari a guidarlo. Perché no?! Ma si, mandiamoli anche al supermercato. Dentro stavolta, a fare la spesa. Potremmo incontrarli tra gli scaffali oppure anche alla cassa a chiederci il conto per i nostri acquisti. Paghiamo e con un sorriso prendiamo il resto, lo scontrino e... grazie e arrivederci. Normale! Rocco Luigi Mangiavillano «Ma non mandiamoli solamente a casa. Loro, non aspettano altro. Mandiamoli anche a scuola, a studiare. Pensa se a giugno, prima delle vacanze, stiamo ringraziando una maestra, rom, proprio lei, quella che ha seguito nostro figlio cosi bene... come fosse stato il suo! Allora, mandiamoli anche al lavoro, mandiamoli a prendere un metrò, naso contro naso, o su un autobus, magari a guidarlo. Perché no?! Ma si, mandiamoli anche al supermercato. Dentro stavolta, a fare la spesa». 16 Mandiamoli all’ospedale, a curarsi come tutti, per scoprire che si ammalano come noi e come noi soffrono se si ha male da qualche parte e piangono, proprio come noi, se un nostro caro non se la sta cavando niente affatto bene. Il mal di denti, si sa, non guarda in faccia proprio nessuno e quelli d’oro, di denti, non possono farci proprio nulla. E nel tempo libero? Mandiamoli a teatro, in libreria, al museo o in giro per la città, in pieno centro, a fare shopping... «Ehi tu, ehi signore, sir, sir… ti è caduto questo», al turista che smarrito ma felice lo ringrazia in quasi tutte le lingue del mondo mentre ripone in tasca, stavolta con molta attenzione, ciò che aveva smarrito un minuto prima. E pensare... Mandiamoli a ballare a sentire un concerto. Certo la musica ce l’hanno proprio nel sangue, le danze poi...! Mandiamoli al cinema a vedere un film o anche a farlo. Per la parte dei cattivi, imbroglioni e furfanti di ogni risma, sono i figuranti più richiesti. Per le scene di degrado, poi, non ne parliamo! Ma è proprio quando bisogna «girare» un genocidio, allora si che l’interpretazione del ruolo raggiunge il livello più alto. Il pubblico si commuove, si stringe, qualcuno piange. Per morire sono gli attori più bravi del mondo. Beh, allora mandiamoli anche in piazza, a manifestare e protestare anche, ogni qualvolta c’è qualcosa che in questo mondo proprio non va. Tutte le volte che c’è bisogno di far sentire la propria voce. E se li mandassimo anche a votare? Sì, alcuni già ci vanno... anche alle primarie. Allora possono esprimere le loro opinioni politiche, organizzarsi come parte sociale, darsi rappresentanza mettendosi d’accordo tra loro e partecipare alla vita pubblica, contribuire agli interessi della collettività, proporre miglioramenti sociali e tutelare i beni comuni. Costruire con gli altri un mondo da abitare insieme, uomini e donne, ricco di tutte le differenze possibili. Scegliere liberamente, per chi ci crede, ciascuno il proprio Dio da pregare. A questo punto solo un dubbio. Se a furia di volerli mandare continuamente a casa, senza specificare quale, i rom sono diventati nomadi per colpa nostra? Ps: l’articolo racconta le mille voci che ho incontrato nei campi e insediamenti rom della Capitale. ETICA Obiezione di coscienza: quali confini? Luca Savarino L’obiezione di coscienza è uno strumento senz’altro legittimo, nato per garantire i diritti individuali di fronte alla forza dello Stato. Occorre però ragionare seriamente sui suoi limiti politici, affinché non finisca per portare vantaggi personali all’obiettore sottraendo diritti all’individuo. egli ultimi cinquant’anni l’ambito di applicazione dell’istituto giuridico dell’obiezione di coscienza si è progressivamente allargato. Dall’obiezione di coscienza al servizio militare si è passati a discutere di un’obiezione di coscienza sanitaria. L’estensione della questione al campo della bioetica è stata interpretata da alcuni come una perdita di significato del concetto e della pratica dell’obiezione di coscienza che, nata per sottrarre l’individuo al dispotismo della disciplina statale in ambito militare e sanitario, avrebbe finito per sottrarre diritti all’individuo. «Il buon medico non obietta», recita lo slogan di una recente campagna di sensibilizzazione contro l’obiezione di coscienza in ambito sanitario, alludendo al fatto che l’eventuale obiezione dell’individuo medico violerebbe i diritti di un altro individuo, il suo paziente. Questioni di principio si saldano a problemi pratici. Iniziamo dalle prime. Va innanzitutto ricordata la differenza tra obiezione di coscienza e disobbedienza civile. Quest’ultima è una forma di lotta pacifica, utilizzata per offrire un’alternativa non violenta ai resistenti di un governo autoritario poco incline all’ascolto democratico. Il fine della disobbedienza civile è pubblico e politico: cambiare la legge contestata o rovesciare il governo. L’individuo che sceglie di aderirvi è disposto a incorrere nella sanzione prevista dalla legge. Diverso è il fine dell’obiezione di coscienza, che vuole tutelare uno spazio di libertà individuale per le minoranze: non si tratta dunque di cambiare la legge, ma di garantirla, salvaguardando sia il rispetto della coscienza individuale sia il rispetto della legge stessa. Dal punto di vista giuridico, dunque, l’obiezione di coscienza è diversa dalla disob- N Savarino è docente di Filosofia politica presso l’Università del Piemonte Orientale. 17 bedienza civile, perché non rappresenta uno strumento di lotta politica e di resistenza organizzata contro una legge approvata democraticamente, ma costituisce uno dei cardini di un sistema politico liberale, in cui accanto al principio democratico della partecipazione di tutti alle scelte per tutti vincolanti viene posto il principio della garanzia e sicurezza della libertà individuale, principio che non abolisce il primo ma che lo limita nella sua portata. Personalmente sono convinto che, da un punto di vista teorico, il principio giuridico dell’obiezione di coscienza non debba essere messo in discussione. Ritengo estremistica la tesi secondo cui il diritto all’obiezione di coscienza dovrebbe essere negato a coloro che liberamente scelgono una determinata professione. Da un punto di vista cristiano, e protestante, l’obiezione di coscienza è uno strumento non solo legittimo, ma indispensabile per il buon funzionamento di una società democratica e pluralista. Il protestantesimo è una delle radici storiche dell’idea della libertà di coscienza, il cui primato etico è stato costantemente riaffermato nel corso del XX secolo dalle Chiese riformate. Occorre specificare tuttavia come tale principio debba venire inteso in senso cristiano: la coscienza si sottrae alla legge degli uomini nella misura in cui essa non rappresenta lo spazio dell’arbitrio individuale, ma il luogo in cui il messaggio di Dio interpella l’essere umano e in cui quest’ultimo assume responsabilmente, nei confronti di Dio, il tessuto di relazioni che lo costituiscono. L’autonomia della coscienza si coniuga con l’idea della responsabilità della scelta di fede. La dimensione politica della responsabilità deriva dal fatto che essa non si esercita solo di fronte a Dio, ma anche di fronte agli altri uomini, concretizzandosi nell’attenzione rivolta ai loro diritti, all’esercizio della loro autonomia e alla giustizia sociale. Per questo motivo, è necessario ragionare seriamente sui limiti politici dell’esercizio dell’obiezione di coscienza. In Italia, il clima inflattivo della sua applicazione in ambito sa- i servizi marzo 2015 confronti ETICA nitario può ingenerare confusione e dissolverne il valore morale. In primo luogo, dovrebbe essere chiaro che il valore morale della testimonianza viene meno qualora dell’obiezione di coscienza venga fatto un uso strumentale. La rivendicazione della libertà di coscienza non può ridursi a difesa di interessi particolari. Fuor di metafora, è opportuno ricordare che, a differenza di quanto potrebbe verificarsi in questo momento in Italia, la pratica dell’obiezione non dovrebbe portare vantaggi personali all’obiettore: l’appello alla coscienza non può essere un pretesto o un espediente per migliorare la propria carriera professionale. Inoltre, all’interno di un sistema liberale l’obiezione di coscienza non dovrebbe diventare uno strumento per mettere in pericolo i diritti dei cittadini, come avverrebbe, sempre nel peculiare contesto italiano, nel caso in cui la diffusione dell’istituto dell’obiezione di coscienza all’interruzione volontaria della gravidanza mettesse a rischio il diritto delle donne di abortire. All’interno di un sistema liberale l’obiezione di coscienza non dovrebbe diventare uno strumento per mettere in pericolo i diritti dei cittadini, come avverrebbe, sempre nel peculiare contesto italiano, nel caso in cui la diffusione dell’istituto dell’obiezione di coscienza all’interruzione volontaria della gravidanza mettesse a rischio il diritto delle donne di abortire. 18 Un primo limite all’esercizio dell’obiezione di coscienza è dunque il diritto di altri. Se il legittimo esercizio della moralità individuale consente di disattivare un servizio di utilità pubblica o nega il diritto soggettivo alla salute si apre un conflitto che deve essere regolamentato. Un secondo limite possibile potrebbe essere la distinzione tra azioni e omissioni. Il significato etico di tale distinzione può essere discutibile, ma continua a conservare una sua utilità su alcune questioni come il fine vita. Penso per esempio alla distinzione tra l’interruzione (o non attivazione) di un trattamento e l’eutanasia. Qualora venisse approvata una legge che legalizzi l’eutanasia o il suicidio assistito, un medico obiettore non potrebbe imporre alcun trattamento indesiderato a un paziente che vi si opponga o rifiutare di sospendere un trattamento; ma, allo stesso tempo, dovrebbe potersi rifiutare di provocare attivamente il decesso del paziente. i servizi marzo 2015 confronti ETICA La legge 194 ha fatto dimezzare gli aborti Intervistiamo Adriana Bruno, ginecologa che lavora nei consultori familiari dal 1983, prima in provincia di Viterbo, poi a Roma (ad Ostia). Si occupa inoltre di screening per la prevenzione del tumore al collo dell’utero. Come si avvicinano le donne per l’interruzione di gravidanza? Arrivano al mattino con il loro test in mano e l’aria un poco smarrita. Sanno che potranno ricevere da noi il certificato o le indicazioni per poter interrompere la gravidanza. Spesso non si aspettano di trovare un’accoglienza che non sia solo un certificato ma una presa in carico della loro situazione emotiva e della loro salute come per esempio fare un pap test, se non l’hanno fatto mai, e le basi per la futura contraccezione. Sia nei consultori che negli ospedali che effettuano le interruzioni le donne possono applicare gratuitamente lo iud (la «spirale»). Quindi dopo continuano ad usare i nostri servizi, se si sono trovate bene. Da molti spesso i consultori vengono visti come luoghi della morte anziché luoghi della vita. Invece seguiamo più gravidanze che interruzioni di gravidanza; facciamo corsi di preparazione al parto, di baby massage, lavoro con adolescenti e sensibilizzazione alla contraccezione. Tutte cose che della vita hanno sacro rispetto. Adriana Bruno In meno di quarant’anni, le interruzioni di gravidanza in Italia sono passate da 200mila a meno di 100mila l’anno. Sono però aumentati, negli ultimi anni, gli aborti clandestini, anche a causa dell’altissimo tasso di medici obiettori. Spesso si ignora che tra i compiti principali di un consultorio c’è tutto un lavoro di sostegno, di preparazione al parto e di sensibilizzazione alla contraccezione. Quante donne si sono rivolte a voi nel 2014? Italiane, 103 sopra i 25 anni, 31 sotto i 25 anni, e 7 minori. Tra le straniere, 74 sopra i 25 anni e 24 sotto. Sono più le italiane che le straniere. Ho tolto quelle che sono venute per un’interruzione di gravidanza e hanno poi deciso di continuare la gestazione. Sono diminuite globalmente le interruzioni volontarie in Italia. All’inizio della legge c’erano 200mila interruzioni di gravidanza l’anno, oggi siamo a neanche 100mila. Come avviene questo ripensamento? Tramite colloqui? Il consultorio accoglie la donna; riusciamo a fare colloqui non solo con il ginecologo, ma anche con l’assistente sociale e con lo psicologo, in modo da accogliere tutta la proble- 19 matica, che può essere psicologica ed emotiva. Negli ultimi due anni è emerso in maniera forte il motivo economico. Ci sono casi di donne che hanno cercato una gravidanza ma hanno poi perso il lavoro, e non si sentono più in grado di proseguire. Oppure per contratti non rinnovati all’ultimo momento. Grazie a questa azione e all’accettazione della contraccezione osserviamo che negli anni sono diminuite le recidive, ovvero le donne che tornano dopo pochi mesi a chiedere nuovamente un’interruzione di gravidanza. Non sono sparite, ma sono fortemente diminuite. Perché? Da una parte è diminuito il tasso di fertilità e un po’ si ricorre maggiormente alla contraccezione e alla pillola del giorno dopo. C’è anche chi fa notare però che sono aumentati gli aborti clandestini, per l’obiezione di coscienza dei medici. Ovvero? Com’è la situazione? Una signora siciliana con tre figli voleva interrompere la gravidanza. Non trovando nessun posto in Sicilia per farlo si è messa in contatto con l’associazione «Vita di donna» della collega Lisa Canitano, che fa un lavoro di sostegno mettendo in rete consultori e ospedali per dare la possibilità di trovare un posto in cui essere accolte e accompagnate all’interruzione di gravidanza (e anche per la pillola del giorno dopo). Nessun posto in Sicilia è stato trovato, quindi l’associazione l’ha aiutata economicamente per il biglietto del treno. Arrivata a Roma sono andata a prenderla personalmente in stazione, ha dormito da me, l’ho portata poi in ospedale dove finalmente ha ricevuto attenzione e l’atto medico. Teoricamente ogni ospedale dovrebbe garantire l’interruzione di gravidanza, ma così non è. Ci sono intere Asl dove non si può fare l’interruzione di gravidanza. Un esempio emblematico è la vicenda del Policlinico Umberto I di Roma: è stato il primo reparto dove si sono fatte le interruzioni di gravidanza a Roma, grazie ad un’occupazione fatta dalle donne del quartiere San Lorenzo e di altre parti di Roma. Lo si chiamava in gergo «il repartino». Io ci ho lavorato come volontaria. C’erano cinque ginecologi ed uno psicologo assunti dalla struttura, pagati. Oggi il reparto è chiuso. Un reparto che era il punto di riferimento per Roma, e che aveva una rilevante storia sociale e politica per la città. i servizi marzo 2015 confronti ETICA L’obiezione di coscienza serve per permettere al medico di fare carriera? Il mondo si è molto laicizzato. Secondo me semplicemente non importa più niente della questione, l’interruzione di gravidanza è vissuta come una «rogna». Molti colleghi che la facevano ora non la fanno più perché trovano più gratificanti altre cose. Come è la situazione con le donne straniere? C’è stato un cambiamento. Per esempio la prima immigrazione ucraina e rumena aveva sulle spalle 12-20-25 aborti fatti in casa. Avevano un senso della vita in utero molto labile. Molte rumene arrivate in Italia hanno cominciato a seguire la Chiesa ortodossa. La fede ritrovata è stata molto condizionante. Ora il numero di aborti è molto minore; spesso sono persone che decidono infine di continuare la gravidanza. Per il mondo musulmano non è una scelta facile. Viene affrontata sempre con molta sofferenza, pur non essendo vietato dall’islam. Ci sono però varie interpretazioni e vari modi di vivere la fede e molto dipende anche da chi è l’imam di riferimento. «Assistiamo alla morte della spinta propulsiva che ha portato alla legge 194 e alla creazione dei consultori. La colpa è di questo Stato, che non lavora sulle lunghe distanze e mette sempre in discussione ciò che si è già scelto anche con referendum (vedi il referendum sull’acqua) e anche delle donne. La generazione venuta dopo si è trovata con dei servizi e dei diritti e non ha più pensato che bisognasse lottare per consolidarli». Il diritto non è dunque garantito? Certo che no. Alcuni numeri dell’obiezione di coscienza relativi al 2012: Basilicata 89,4%, Lazio 81,9%, Campania 81,8%, Lombardia 63,6 %, Toscana 55,6 %. In pratica dappertutto si va da più della metà, a quasi la totalità. Cosa servirebbe oggi? Nuove persone giovani e preparate sia in ospedale che sul territorio. Invece stanno chiudendo i consultori. Chi va in pensione non viene rimpiazzato. Gli infermieri vengono tolti e assegnati agli ospedali. Per cui andiamo morendo. Ci sarebbe invece bisogno di persone giovani, che ricomincino con il desiderio di accogliere le donne, di confrontarsi con altri operatori dell’équipe (parola che va dissolvendosi), con l’obiettivo di aiutarle nella scelta fra proseguire l’esperienza di maternità o interromperla in quel momento non adatto per loro. Quindi la politica al riguardo non fa prefigurare niente di buono... Assistiamo alla morte della spinta propulsiva che ha portato alla legge 194 e alla creazione dei consultori. La colpa è di questo Stato, che non lavora sulle lunghe distanze e mette sempre in discussione ciò che si è già scelto anche con referendum (vedi il referendum sull’acqua) e anche delle donne. La generazione venuta dopo si è trovata con dei servizi e dei diritti e non ha più pensato che bisognasse lottare per consolidarli. È stato dato come uno stato di fatto. Invece questa legge, grazie al tranello dell’obiezione di coscienza, è stata svuotata da dentro e poche persone scelgono di far sentire la propria voce, raccogliere firme e mandarle alle direzioni delle Asl per far valere un proprio diritto; direi anzi che si accettano supinamente peggioramenti e logoramenti dei diritti. Dove finiremo quindi, in questa direzione? Col tasso di obiezione che c’è, dove si andrà? Chi certificherà per l’interruzione di gravidanza? Solo il privato! Ci sarà la privatizzazione come unica strada. Io fra tre anni andrò in pensione, così come le mie colleghe, e non ci sono nuove assunzioni. Ci dovrebbe essere un consultorio ogni 25mila abitanti. Il distretto sanitario di Ostia conta 250mila abitanti, e solo due consultori. intervista a cura di Claudio Paravati 20 EBRAISMO Una stella di David arcobaleno Daniela Mazzarella Come su molte altre questioni, anche rispetto al tema dell’omosessualità le varie correnti dell’ebraismo esprimono posizioni differenziate: dalle più tradizionali alle più aperte alle novità della società contemporanea. Di ebraismo e omosessualità si è discusso a Roma in un convegno organizzato dalla comunità riformata Beth Hillel. fine gennaio si è svolto a Roma il convegno «Gli ebrei e l’omossessualità», organizzato da Beth Hillel Roma («la più giovane comunità ebraica nella città dove c’è la più vecchia comunità d’Europa», come ha detto all’apertura dei lavori la sua presidente, Franca Coen). Il pomeriggio di studi si è aperto con gli interventi del rabbino della comunità Fabian Sborovsky e di Shmuel Sermoneta-Gertel (insegnante di tefillà); entrambi hanno affrontato l’aspetto teologico dell’argomento, soffermandosi soprattutto sulla lettura e sull’interpretazione di Levitico 18:22 e Levitico 20:13, che sono gli unici due versetti della Torah in cui si nomina l’omosessualità. Rav Sborovsky ha ricordato come l’ebraismo non sia monolitico ma ricco e frastagliato. Un conto sono le comunità ebraiche ortodosse, un altro quelle conservative che negli ultimi anni hanno addirittura ordinato rabbini gay. L’ultima grande corrente è quella dell’ebraismo riformato, che è la più numerosa nel mondo ed è totalmente aperta rispetto alla questione omosessualità. Nelle scuole rabbiniche riformate in Usa è obbligatorio un corso contro l’omofobia. Shmuel Sermoneta-Gertel ha puntualizzato il fatto che, su una quarantina di precetti, solo due siano riconducibili alla sessualità e che molti dei precetti si riferiscano alla sfera privata. Le differenti interpretazioni dei versetti del Levitico vanno lette alla luce delle varie correnti esegetiche che esistono all’interno del mondo ebraico. A loro ha fatto seguito un intervento video di Barry Schneider (professore emerito alla School of Psychology, University of Ottawa) che ha descritto i profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi anni e ha precisato che, anche in un’interpretazione più letterale della Torah, A 21 bisognerebbe sempre ricordare che, oltre e prima dell’omosessualità, è vietato l’adulterio. Un approccio più personale ha caratterizzato la relazione di Tommaso Giartosio (scrittore e conduttore radiofonico) dal titolo «Omosessualità ed ebraismo, dallo stigma al linguaggio», in cui si è parlato del bisogno e della ricerca di identità, tema centrale nell’ebraismo. La psicoterapeuta e scrittice Anna Segre si è soffermata sulla parola «orgoglio», specificando come, di fronte a una richiesta di omologazione, l’orgoglio permetta di ribellarsi. L’orgoglio, così importante per la comunità gay, è anche parte fondamentale dell’identità ebraica. Lo psicologo e psicoterapeuta Nicola Nardelli ha poi tenuto un intervento sull’aspetto medico-psicologico della questione, ribadendo che l’omosessualità non è una malattia e illustrando i cambiamenti vissuti dalla comunità scientifica negli ultimi decenni con il passaggio da una situazione ricca di pregiudizi a una in cui l’aspetto patologico viene ricercato, al contrario, nell’omofobia. A seguire, Pamela Harris (docente di Diritto alla John Cabot University di Roma) ci ha parlato del trattamento giuridico riservato agli omosessuali in Israele, che ha fatto molte riforme negli ultimi anni tanto da diventare uno degli stati con minor discriminazione al mondo. Una delle ultime novità è l’estensione ai coniugi gay della Legge del ritorno (che permette ad ogni ebreo di andare a vivere in Israele con la propria famiglia). Ha concluso il convegno Serafino Marco Fiammelli (luogotenente dell’Esercito italiano e cofondatore di Beth Hillel Roma), che ha parlato della situazione dei gay all’interno delle forze armate israeliane, dove non è stato mai formalmente vietato l’accesso agli omosessuali, anche se in passato questi venivano molto spesso riformati. Attualmente però la situazione è molto diversa: l’esercito israeliano riconosce le coppie omosessuali anche ai fini pensionistici e nel dicembre 2014 sono state introdotte delle regole per facilitare l’arruolamento dei transgender. i servizi marzo 2015 confronti EBRAISMO Ebreo e omosessuale: identità non in contrasto Lei è un socio fondatore di Beth Hillel Roma e delegato per le questioni Lgbt. Come nasce l’idea di questa giornata di studio sul rapporto tra ebraismo e omosessualità? L’idea nasce perché ho sempre notato una similitudine nella situazione storica e sociale degli ebrei e degli omosessuali. L’odio verso di loro ha radici lontane, a differenza di quello verso altri gruppi etnici che è più recente. Gli ebrei omosessuali racchiudono in un’unica personalità due identità caratterizzate dall’ostinazione ad autoaffermarsi come gruppo sociale. La «dura cervice» accomuna gli ebrei e gli omosessuali. Un’altra similitudine è la capacità di fare gruppo per fronteggiare l’odio e per garantire a tutti la possibilità di vivere liberamente la propria identità. Le associazioni Lgbt, come le comunità ebraiche nel mondo, sono organizzazioni molto forti e hanno un peso notevole nelle società in cui vivono, anche quando numericamente molto deboli. Le due entità dovrebbero imparare a condividere e supportarsi reciprocamente nelle battaglie di ognuno, perché spesso hanno lo stesso fine. Chi ha visto recentemente il film Pride sa perfettamente a cosa mi riferisco. Gli omosessuali già in giovanissima età percepiscono l’odio che arriva dalla società: non ne capiscono la ragione, vivono un dramma nella più totale solitudine. A differenza dei giovani ebrei, che hanno nella famiglia un punto di riferimento e di protezione, per gli omosessuali il coming out in famiglia è spesso uno dei momenti più devastanti: spesso ci vogliono anni perché i rapporti ritornino alla normalità. Le associazioni rispondono a molte telefonate di giovanissimi che hanno seri problemi a relazionarsi con la loro famiglia a causa della propria omosessualità, problemi che diventano subito di natura psicologica anche seria, come è emerso dal convegno. L’ebraismo ortodosso prende molto seriamente quanto scritto nel Levitico: «non ti coricherai con un uomo così come con una donna». Le scritture sono sacre per definizione e nessuno può cambiarle. Quello che Serafino Marco Fiammelli «Le scritture sono sacre per definizione e nessuno può cambiarle. Quello che si potrebbe cambiare è l’interpretazione. Dovrebbe essere possibile alla persona ebrea e omosessuale di vivere una vita serena senza dover rinunciare a una parte della propria identità. Non c’è nulla di sbagliato nell’essere omosessuale». si potrebbe cambiare, come ci hanno spiegato i nostri conferenzieri, è l’interpretazione. Questo era quello che volevo emergesse dal convegno. Il risultato dal punto di vista didattico è stato straordinario, grazie al livello di preparazione dei relatori. Dovrebbe essere possibile alla persona ebrea e omosessuale di vivere una vita serena senza dover rinunciare a una parte della propria identità. Non c’è nulla di sbagliato nell’essere omosessuale, ognuno di noi nasce secondo un disegno divino. È anche un luogotenente dell’esercito italiano e nella sua relazione al convegno ci ha parlato della situazione dei gay nell’esercito israeliano. Qual è la realtà nel nostro Paese? Le Forze armate italiane vivono e operano nell’alveo della Carta costituzionale e delle leggi dello Stato, nulla potrebbero decidere autonomamente al proprio interno. In 34 anni di servizio attivo non ho mai assistito a nessun grave atto di omofobia. Prima del 2000, anno in cui il servizio di leva è stato sospeso, c’era sempre lo sfottò nei confronti del ragazzo effeminato, come di altre «categorie», poi, con l’avvento del servizio militare professionale, molto è cambiato, assieme alla sensibilità per tutto ciò che attiene alla sfera personale dell’individuo, che nei giovani è molto diversa. L’arruolamento delle donne ha fatto la sua parte, mettendo i maschietti nella condizione di doversi confrontare quotidianamente con la diversità di genere in un processo molto rapido e naturale. Io personalmente godo dell’affetto dei colleghi, dei superiori e degli amici: nessuna discriminazione mai ricevuta; un mio ex comandante mi dice sempre: «Speriamo che approvino in fretta le unioni civili, perché vorrei venire al suo matrimonio». Esiste una rete italiana di ebrei omosessuali? E internazionale? No, non esiste, mentre ne esistono da oltre 45 anni in Nord Europa, nel Nord e Sud America e in Israele. Teniamo ben presente che l’ebraismo riformato in Italia è nato circa 15 anni fa, con un ritardo di oltre un secolo rispetto al resto del mondo occidentale, quindi abbiamo molta strada da fare, e non solo per quanto riguarda le questioni Lgbt. In Italia mancano le condizioni di emancipazione sociale, culturale e sopratutto politica. 22 i servizi marzo 2015 confronti EBRAISMO Sappiamo che in Europa esistono vari gruppi di omosessuali caratterizzati dalla loro appartenenza religiosa. È possibile pensare a un percorso comune e di dialogo interreligioso sul tema? Ci sono già organizzazioni religiose di gay e lesbiche cristiani – «Nuova proposta» è una di queste – che oltre a organizzare attività di tipo religioso affiancano e supportano organizzazioni Lgbt per eventi più specifici relativi alla tutela dei diritti degli omosessuali. Anche qui gli omosessuali hanno necessità di creare delle zone franche e sicure per esprimersi senza timore di minacce, minacce che potrebbero arrivare anche dall’interno della propria comunità. L’importanza di queste associazioni è fondamentale. Beth Hillel Roma considera il dialogo tra le religioni uno dei suoi impegni e obiettivi e la nostra presidente Franca Coen è molto attiva nell’organizzazione Religions for peace. Alcune delle nostre attività vengono svolte con il coinvolgimento di questa associazione. Per rispondere alla sua domanda: sì, i gruppi di gay religiosi possono lavorare insieme per un percorso comune e un lavoro «ecumenico». «Si può essere discriminati in quanto gay, in quanto ebrei e per entrambe le cose, ma si può anche essere discriminati dagli ebrei perché gay e dai gay perché ebrei; in questo secondo caso spesso perché si identifica l’ebreo con Israele. Insomma un bel casino, ma questa è la realtà; ci si abitua, si impara a difendersi, a reagire, a convivere e combattere quando necessario». quando ci ha spiegato i passi da compiere per arrivare alla conversione e cosa ci veniva richiesto, ci è apparso evidente che la nostra omosessualità sarebbe stato un ostacolo. Ci siamo rivolti quindi alla comunità riformata di Milano Lev Chadash, visto che a Roma non c’era nessuna entità ebraica non ortodossa. Il rabbino di Lev Chadash ci ha accolti nella comunità e dopo circa un anno ci ha accettato come studenti per la conversione, dicendoci che per lui il fatto che fossimo gay non era un impedimento, ma il fatto che fossimo una coppia stabile era per lui una garanzia: come nucleo familiare convivente avremmo potuto vivere una vita ebraica in una casa ebraica. E così fu e il 4 giugno del 2012, davanti al tribunale rabbinico del Mouvement juif libéral de France (Mjlf ) di Parigi, abbiamo sostenuto l’«esame» decisivo per la conversione, poi il bagno rituale, e qualche tempo prima la circoncisione. Come omosessuale ed ebreo, appartiene a una doppia minoranza. Come vive questa situazione? Si può essere discriminati in quanto gay, in quanto ebrei e per entrambe le cose, ma si può anche essere discriminati dagli ebrei perché gay e dai gay perché ebrei; in questo secondo caso spesso perché si identifica l’ebreo con Israele. Insomma un bel casino, ma questa è la realtà; ci si abitua, si impara a difendersi, a reagire, a convivere e combattere quando necessario. Ci sono comunità ebraiche ortodosse «gay friendly»? Questa è una bella domanda, alla quale ovviamente non posso rispondere; bisognerebbe chiederlo a loro, anche perché dovremmo prima definire bene il termine gay friendly. Tecnicamente non credo, se intendiamo per gay friendly piena accettazione. Se lo intendiamo come accettazione di uno stato di fatto, ma senza ufficializzare né «legalizzare» l’omosessualità, allora forse. Quando pensa che cambieranno le cose? Anche qui gli ebrei e gli omosessuali si incontrano sulla stessa via, credo ci sia bisogno di una legge contro il negazionismo e che ci sia bisogno di una legge contro l’omofobia. La storia ci insegna che spesso l’umanità ha bisogno di essere educata al rispetto dell’altro. Lei si è convertito all’ebraismo. Si è avvicinato da subito a una realtà di ebraismo riformato come quella di Beth Hillel Roma o ha tentato prima con le strutture ortodosse? Quando insieme al mio compagno abbiamo deciso che il nostro interesse per l’ebraismo e Israele – che ci aveva già indotto da un paio di anni a studiare l’ebraico moderno, a studiare la storia degli ebrei e del sionismo, a leggere letteratura e saggistica ebraica e a fare viaggi in Israele – era arrivato al punto in cui esigeva un salto di qualità, ci siamo rivolti a una comunità ortodossa, il cui rabbino ci ha ricevuto con molta cordialità, ci ha chiesto di noi e ci ha raccontato di loro. Poi, intervista a cura di Daniela Mazzarella 23 ARMENI Maria Immacolata Macioti A cento anni dal genocidio Nel 1915 vengono sospese le garanzie fondamentali nei confronti degli armeni e imposta una politica panislamica per rafforzare l’identità musulmana. A distanza di cento anni, grazie alla documentazione e agli studi usciti nel frattempo, la negazione del genocidio da parte del governo turco diventa sempre meno credibile. il 1915 quando gli armeni che da tempo vivono in Turchia, e che hanno subito tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 dure persecuzioni sotto ‘Abd al-Hamid, ritengono di poter sperare in un miglioramento della situazione. Ma il sovrano, è noto, non ha simpatia per gli armeni. Ha tentato una politica di accordi con la Germania e con il Giappone per frenare la decadenza della Turchia. Teme la Russia, che cerca sbocchi sul mare, da cui verrà sconfitto tra il 1877 e il ’78: e dovrà riconoscere l’indipendenza di Serbia, Romania e Montenegro. Il Trattato di Berlino dà in teoria una certa autonomia agli armeni, sotto l’altrettanto teorica sorveglianza delle potenze europee. Ma il sovrano sospende le garanzie fondamentali, impone una politica panislamica per rafforzare l’identità musulmana. Gli armeni sono una presenza fastidiosa, contraddittoria. Semmai il sovrano darà spazio a curdi e circassi, a ceceni e albanesi, anche utilizzandoli in chiave anticristiana. Gli armeni avvertono il pericolo crescente, si hanno agitazioni. Nasce nel 1881 la società segreta dei Protettori della patria. Nasce, nel 1890, a Tbilisi, la Federazione rivoluzionaria armena, Dashnaksutiun, vicina al socialismo. Le riforme però non arrivano. Anzi, tra il 1894 e il 1896 saranno arrestati vescovi e notabili armeni, si avranno attentati contro il patriarca. Ed ecco il conflitto di Sasun: tre villaggi rifiutano di pagare ancora le tasse già pagate agli esattori curdi, la cittadina si ribella. Interverrà la Quarta armata: i morti saranno un migliaio; uno schema che si ripete, documentato da varie relazioni consolari. Si parla di villaggi incendiati, chiese rase al suolo, conversioni forzate, deportazioni. Nel 1895 è prevista una manifestazione del par- E’ La professoressa Macioti è coordinatrice della Sezione di Sociologia della religione dell’Associazione italiana di sociologia e coordinatrice de «La Critica sociologica». 24 tito Hntchak per la richiesta di diritti civili: si avrà una sanguinosa repressione. Seguirà il caso di Zeythun, o Zeytún (1895-1896), rea di resistere persino all’esercito. La cittadina pagherà duramente, nel 1915, le sue capacità di resistenza. Intanto si verificano fatti importanti nello scenario internazionale: nel giugno 1896 Theodor Herzl propone alla Turchia il consolidamento del debito da parte ebraica in cambio della cessione della Palestina o di uno stato autonomo sotto sovranità ottomana. Il sovrano chiede che gli ebrei intervengano presso la stampa europea perché la questione armena sia vista in un’ottica più favorevole alla Turchia. In agosto, gli armeni si impadroniscono a scopo dimostrativo della banca ottomana di Costantinopoli. Distribuiscono volantini in cui si chiedono riforme e si auspica un Alto Commissario per l’Armenia, di nomina europea. Richieste che non avranno seguito, mentre si avrà il massacro della città di Egin: da cui l’appellativo di bloody sultan ad ‘Abd al-Hamid, cui si imputano circa 200mila morti armeni. Sarebbero di più, senza gli ammonimenti delle potenze europee. Intanto si ha un forte ravvicinamento con la Germania guglielmina: si ipotizzano investimenti e progetti Germania-Turchia. Le speranze armene si concentrano sui Giovani turchi, sul Comitato unione e progresso (Cup): e siamo al 1907. La Turchia si avvia a perdere un terzo del proprio territorio, mentre all’interno urgono problemi finanziari. Tra i Giovani turchi prende spazio l’ala radicale e nazionalista. Nel 1909 viene deposto il vecchio sovrano responsabile di tante stragi armene, sale al trono Mehemet V. Il potere è in mano ai Giovani turchi, che vogliono la modernizzazione del paese. Gli armeni non fanno a tempo a rallegrarsi della deposizione del «sovrano rosso» che si ha l’assedio di Adana (aprile 1909). La città si difende: moriranno circa 25mila armeni. Negli anni successivi la Turchia continua a perdere territori, è coinvolta in devastanti guerre balcaniche. Gli armeni confidano nei Giovani turchi, alle elezioni del 16 aprile i servizi marzo 2015 confronti ARMENI 1912 votano la lista del Cup. La Conferenza di Londra per la risoluzione della situazione post balcanica verrà subita da una Turchia che si sente estremamente penalizzata e che continua a perdere spazio. Finché il 23 gennaio 1913 si ha un colpo di Stato dei «Giovani turchi»: i capi sono Talaat (Tal’at), Enver e Cemal (Gamāl). Il Trattato di Londra del 30 maggio 1913 vede la Grecia occupare la Macedonia meridionale e Creta, la Serbia ottenere il Kosovo e la Macedonia settentrionale; il Montenegro, parte dell’Albania; per la Turchia, esiti tragici: si radicalizza il suo distacco dall’Intesa, l’accostamento agli imperi centrali. La Germania sarà sempre più presente nel paese, addestrerà lo stesso esercito. Ormai in Turchia sono al potere i militari, che non intendono cedere sulle previste riforme per gli armeni. Che liberano Edirne: e brilla la stella del vincitore Enver Pascià, mentre nazionalismo e islamismo si rafforzano a vicenda. È il 1914: la Turchia inizia la mobilitazione, anche se larga parte della popolazione è alla fame. La Germania occupa Liegi, Namur. Avanza verso Parigi, chiude i Dardanelli, isola la Russia rispetto agli alleati. In novembre si ha la dichiarazione di guerra turca contro gli infedeli, nemici da combattere: Inghilterra, Francia, Russia. Obiettivo: turchizzare l’impero. E matura la tragedia di Van, dove si avranno fucilazioni di armeni, richieste esose di uomini e denaro. Donne vengono catturate, la città è assediata. Si difende per cinque settimane. All’arrivo dei russi, i morti armeni sono circa 55mila. Il 1915 si apre, per la Turchia, con la deportazione dei greci, derubati e perseguitati, ma non uccisi. Vengono disarmati gli armeni: verranno declassati, affamati, torturati. Fatti a pezzi, arsi vivi. Tra gennaio e febbraio gli alleati attaccano i Dardanelli, la Serbia respinge gli austriaci: si teme la dissoluzione dell’impero turco. Ma i Dardanelli resistono, gli Alleati si ritirano. La Russia è isolata, senza rifornimenti. Il 24 aprile 1915 (la data ricorda oggi il genocidio) vengono arrestati 2.345 intellettuali e politici armeni, laici e religiosi, a Costantinopoli. Passa intanto una legge temporanea di deportazione: donne e bambini armeni saranno costretti ad abbandonare i loro paesi, a fare lunghe, estenuanti marce nel deserto dell’Anatolia. Subiranno ruberie e violenze lungo il percorso, da bande curde. Molti moriranno lungo la via. I sopravvissuti saranno eliminati o finiranno in campi di Il 24 aprile 1915 (la data ricorda oggi il genocidio) vengono arrestati 2.345 intellettuali e politici armeni, laici e religiosi, a Costantinopoli. Passa intanto una legge temporanea di deportazione: donne e bambini armeni saranno costretti ad abbandonare i loro paesi, a fare lunghe, estenuanti marce nel deserto dell’Anatolia. Subiranno ruberie e violenze lungo il percorso, da bande curde. Molti moriranno lungo la via. I sopravvissuti saranno eliminati o finiranno in campi di concentramento. 25 concentramento. Bambini sono uccisi davanti alle madri, uomini massacrati davanti alle mogli. Con crudeltà e disprezzo: greci e armeni sono considerati porci o cibo per porci. Si sa di ferri di cavallo attaccati a piedi maschili, di gente rifugiatasi in chiesa, cui viene dato fuoco. Gli armeni sono odiati perché hanno commerci fiorenti – mentre i turchi sono poveri – e perché cristiani. Invano il pastore Lepsius, l’ambasciatore americano Morgenthau e altri cercano di intervenire. Invano lettere allarmanti partono dai consolati delle potenze europee a prospettare l’ipotesi di un tentativo di sterminio degli armeni; dai religiosi, che scrivono ai superiori. Ci sono, all’inizio, fraintendimenti: da parte cattolica si ipotizza una persecuzione ai soli armeni cattolici (pochi, rispetto alla Chiesa armena). Altri prestano fede, inizialmente, all’ipotesi di trasferimenti a scopo di protezione. Ma la realtà si impone: gli armeni sono sterminati brutalmente. Donne muoiono per strada porgendo i bambini a qualche turco: cresceranno allevati nella fede islamica. Molti, finiranno negli harem. Fotografie vengono scattate da Armin T. Wegner: documenti, fonti storiche indiscutibili, ché non è stato ancora inventato il digitale. Lo stesso Wegner scrive dal deserto di Deir es Zor, subito, lettere agli amici, a sua madre. Pubblicherà poi La via senza ritorno. Un martirio in lettere. Saranno soprattutto le sue foto e il romanzo di Franz Werfel, autore de I quaranta giorni del Mussa Dagh, a tenere desto il ricordo del genocidio, in Europa. Oggi, a distanza di cento anni dai tragici fatti di allora, restano il dolore di una popolazione, la negazione del genocidio da parte del governo turco. Però molti sono gli studi usciti nel frattempo su questi accadimenti, sia da parte di studiosi armeni che da parte di non armeni; tra i più significativi, 4 volumi a cura del gesuita Georges-Henri Ruyssen su La questione armena (per ora, dal 1894 al 1925), con documenti dell’Archivio segreto vaticano e dell’Archivio della Congregazione per le Chiese orientali. Vi sono documenti familiari, narrazioni, film: sarebbe ormai impossibile stendere su queste tragiche vicende, come pure si è tentato, uno spesso velo di silenzio. LAICITA’ Il papa e i nanetti litigiosi Paolo Naso Un’indagine su «Gli italiani e lo Stato», condotta dall’istituto di ricerca Demos & Pi, conferma la progressiva perdita di fiducia nei confronti della politica e delle istituzioni: sfiducia, disincanto e rassegnazione sembrano essere i sentimenti dominanti. In netta controtendenza papa Francesco, benvisto da 9 italiani su 10. « n paese spaesato. Senza riferimenti. Frustrato dai problemi economici, dall’inefficienza e dalla corruzione politica. Affaticato. E senza troppe illusioni nel futuro». È questa l’Italia disegnata dalla XVII indagine su «Gli italiani e lo Stato», condotta da Demos e pubblicata su la Repubblica il 28 dicembre scorso con un commento del sociologo Ilvo Diamanti. Rispetto al 2010 la credibilità dello Stato, dei partiti e del Parlamento è dimezzata; la fiducia nei Comuni e nelle Regioni è calata di oltre 10 punti percentuali. Non se la cava l’Unione europea, vista con favore da un modesto 27% degli italiani: 22 punti meno del 2010 e 5 meno dell’anno precedente. Tutto questo induce una vera e propria «stanchezza democratica»: tramontato l’astro grillino, non sembrano esserci né Renzi né Salvini né tanto meno Berlusconi a rincuorare gli italiani e a restituire loro un po’ di fiducia. Tutti gli indici di partecipazione politica e sociale sono in declino: cala la fiducia anche nei sindacati, quasi 6 persone su 10 diffidano degli «altri». In generale. In questa palude di rassegnazione e disincanto, l’unico zampillo fresco sembra provenire da papa Francesco. C’è una sola figura che oggi disponga di grande credito – dice il survey – ed abita in una foresteria in Vaticano, apprezzato da 9 italiani su 10. Quasi un plebiscito. «La sua grandissima popolarità (che, peraltro, è “personalizzata” e non si estende alla Chiesa) – commentano gli analisti di Demos – potrebbe suggerire che, ormai, non c’è speranza. E non ci resta che affidarci alla provvidenza divina». Solo un papa ci salverà? È questo il destino dell’Italia che, a questo punto, ci appare assai meno secolarizzata di come per decenni l’ab- U 26 biamo conosciuta e descritta? A questo dovranno rassegnarsi laici e laicisti, agnostici e anticlericali, non cattolici e diversamente credenti di ogni tipo? Il papato – neanche il cattolicesimo – come «religione civile degli italiani», come pilastro della tenuta etica e democratica del Paese? In apparenza questo sembra essere il messaggio forte e chiaro dell’indagine. Ma forse è una lettura troppo frettolosa del dato. Papa Francesco si sta mostrando un pastore vicino alla gente, che parla come il nonno o lo zio saggio che ognuno vorrebbe. Anche quando parla di teologia e cita la Bibbia lo fa senza quell’accento dogmatico e curiale che nei decenni ha allontanato milioni di italiani dalla pratica religiosa e dal rapporto con la Chiesa. Persino dal balcone di Piazza San Pietro, questo papa venuto da lontano parla di cose concrete come l’educazione dei bambini, la cura degli anziani, lo stipendio che non basta ad arrivare a fine mese. E lo fa con accenti dubbiosi ed umili, quasi a precisare che la sua è solo un’opinione che vale quanto altre. Tutto questo non piace – non può piacere – ai guardiani dell’ortodossia e della sacralità ma piace alla gente. Si parva licet... con Diana Spencer abbiamo conosciuto una «principessa del popolo», con Bergoglio incontriamo un «papa del popolo», più amato quando parla con la gente che quando presiede un Concistoro. Bergoglio piace e dà fiducia perché riempie un vuoto di autorevolezza morale che la politica, le istituzioni, la cultura non riescono a colmare. Da protestante la mia preoccupazione non è nel ruolo di moral authority che il papa va assumendo, ma piuttosto nella débâcle civile che ha azzerato la credibilità di altre figure e di altre istituzioni. Il papa fa il suo mestiere di pastore di anime, e Francesco lo fa meglio di altri. Non è questo il problema. Il problema – non religioso, democratico! – è che egli giganteggi solitario in una scena in cui amministratori della cosa pubblica e funzionari dello Stato, generali e magistrati, intellettuali e opinion makers appaiano dei nanetti privi di autorevolezza. i servizi marzo 2015 confronti LAICITA’ Questo fa male alla democrazia e, personalmente, credo faccia anche male alla Chiesa cattolica, che potrebbe fraintendere e immaginare che gli italiani le abbiano restituito quel ruolo centrale nella vita pubblica che i processi di secolarizzazione le avevano sottratto. In realtà così non è. Tutte le indagini sociologiche di questi anni ci dicono che gli italiani vivono una religiosità propria, libera, opzionale e persino sincretica. Amano i presepi ma sono insofferenti alle restrizioni etiche, si dicono cattolici ma adottano la spiritualità orientale, iscrivono i figli all’ora di religione confessionale e approvano i registri per le coppie di fatto. In nessun modo, insomma, la popolarità del papa sembra suggerire che gli italiani siano tornati all’ovile parrocchiale, che resta sempre più vuoto e spoglio, o che si vadano uniformando alla morale della Chiesa di maggioranza. La popolarità e l’autorevolezza morale del papa dice che gli italiani sentono il bisogno di un riferimento alto, che non riduce tutto a polemica politica o a contabilità degli affari. Secolarizzati ma con un’anima, potremmo dire, che li spinge ancora a levare gli occhi verso il cielo alla ricerca di una speranza e di una visione che vada oltre la miseria delle tristi contese politiche di ogni giorno. Per molti è la post-secolarizzazione, una nuova attitudine che non cancella quella precedente ma si sovrappone e si confonde con essa, come un nuovo strato di sabbia mosso dal vento. Vecchio e nuovo, singolare (la Chiesa) e plurale (le religioni), secolare e post-secolare. Di nuovo, da credente e da protestante, non me ne preoccupo ed anzi sento la freschezza di una nuova ventata sulla scena religiosa nazionale. Qualcosa si muove, e in un paese statico come l’Italia è un bel segnale. Da cittadino, lamento che uno spazio pubblico affollato da nanetti litigiosi consegna il paese ai peggiori populismi e alle peggiori demagogie. E non ci sarà papa che potrà salvarci. Se manca la leva, nulla si risolleva Enzo Marzo «Per un periodo storico lungo ma ovviamente non calcolabile, l’Italia è destinata a un degrado senza ritorno. Perché non solo nella classe politica ma nei ceti intellettuali, in chi forma l’opinione pubblica, tra i manager e gli imprenditori, tra i burocrati, la fanno da padroni, nel migliore dei casi, l’afasia e lo smarrimento del proprio ruolo; nella normalità generalizzata, l’incompetenza e la corruzione morale e materiale». Enzo Marzo è direttore di «Critica liberale» e presidente della Fondazione Critica liberale. 27 Le cifre sono sempre importanti perché della realtà danno una fotografia. Ma la realtà italiana, davanti agli occhi di tutti, ha aspetti così eclatanti che la demagogia non riesce più a mascherarla. Gli opinion leader vigliaccamente non hanno il coraggio di trarre le conclusioni, che sono crude: il nostro paese è entrato da tempo in una crisi irreversibile. Che differenza corre tra «gravissima» e «irreversibile»? Nel Novecento due paesi, gli Stati Uniti e la Germania sprofondarono in una crisi «gravissima». Con sistemi politici opposti, in una mezza dozzina di anni non solo la superarono ma arrivarono a porsi al vertice delle potenze mondiali. Come fu possibile? Perché possedevano una classe dirigente e alcuni valori. L’Italia, nelle classifiche mondiali su tutti i campi, giace agli ultimi posti, ampiamente superata da paesi che appena venti anni fa consideravamo spocchiosamente «sottosviluppati». Per un periodo storico lungo ma ovviamente non calcolabile, l’Italia è destinata a un degrado senza ritorno. Perché non solo nella classe politica ma nei ceti intellettuali, in chi forma l’opinione pubblica, tra i manager e gli imprenditori, tra i burocrati, la fanno da padroni, nel migliore dei casi, l’afasia e lo smarrimento del proprio ruolo; nella normalità generalizzata, l’incompetenza e la corruzione morale e materiale. Se manca la leva, nulla si risolleva. Fa disperare non la crisi, ma l’assenza delle forze che possano rimediarvi. Si dice: ma anche la Chiesa cattolica era precipitata in un disfacimento che sembrava irreversibile. Eppure il nuovo papa... È mia convinzione che neppure questo papa, così simpatico, così apparentemente diverso da quelli che lo hanno preceduto, possa molto. Certo, è amato da 9 italiani su 10. Certo, la Chiesa cattolica ha avuto pur sempre la saggezza di affidarsi a un homo novus, lontano dalla fogna romana e nutrito nel brodo di cultura del migliore populismo peronista. L’immagine superficiale è infatti cambiata rapidamente. Un gesuita aveva detto, prima di morire, che il cattolicesimo era indietro di alcuni se- i servizi marzo 2015 confronti SOCIETA’ coli, un altro gesuita cerca di porvi rimedio rincorrendo la modernità con un po’ di buon senso. Intendiamoci, è già qualcosa. Aver cambiato gli uomini in alcuni posti chiave è rilevante per la vita interna della Chiesa. Ma molto meno se si tiene presente il ritardo della Chiesa cattolica nei confronti del mondo esterno. E questo non può essere affrontato solo da qualche dichiarazione eccentrica e buonista. Il vero ostacolo insormontabile è nella stessa struttura totalitaria della Chiesa. Le vere «riforme» non sono mai ottriate. E persino i cauti mutamenti dall’alto operati da Francesco per ora si sono infranti contro la muraglia cinese dell’essenza del cattolicesimo. Prima di Natale il papa si è conquistato qualche bel titolo sui giornali con le sue accuse davvero graffianti contro i cardinali. Parole. Come fa un osservatore non cieco, né sordo, a non pensare che quei cardinali così maltrattati pubblicamente sono stati nominati personalmente dal papa e perlopiù scelti da un papa che lo stesso Francesco proclama santo? «La contraddizion nol consente». La modernità è ben altro, si fonda sul concetto di riforma, che è rivoluzione strutturale, è critica del totalitarismo e del principio gerarchico piramidale. Invece Francesco, proprio perché immobile in campo teologico, non riesce a fare un vero passo avanti in alcun altro campo. Anche lì dove apparentemente dovrebbe essere facile. Aspettiamo invano che una diocesi prenda per la collottola un prete pedofilo e lo consegni all’autorità civile, invece di sottrarglielo. O che il Vaticano smetta di pretendere per sé privilegi economici e di ruolo. Più passa il tempo e più le riforme di Francesco – mi scuso per il paragone – appariranno aria fritta e «politica degli annunci» come quelle di colui che governa l’Italia e che Scalfari definisce «il narciso di provincia e bullo di quartiere». E allora saranno molti i delusi. Non lo saranno coloro che non si aspettavano molto e apprezzano il papa per quello che può fare e fa: restituire al cattolicesimo un po’ di decenza e offrirsi come surrogato «paterno» a chi non sopporta il vuoto esistente oggi nello spazio pubblico. Nulla di più. Né ci si può attendere di più dal cesarismo populista, due pilastri, il primo sempiterno nella Chiesa cattolica e il secondo che negli ultimi decenni ha avuto declinazioni differenti ma traguardi simili. Francesco forse ascolta di più il «cerchio magico» di cui si è circondato, forse tiene maggiormente presenti gli interessi delle periferiche chiese locali, «appare» più pluralistico, anche se la sua «rivoluzione» è tutta incentrata sul «suo» messaggio. Incanta, sì, i laici superficiali, ma proprio sui contenuti che più dovrebbero interessar loro, ovvero sui rapporti tra Stato e Chiesa e sul ruolo pubblico o privato delle confessioni religiose, il Vaticano è fermo alla più retrograda politica dei concordati e dei privilegi. 28 Anche Giovanni Paolo II aveva introiettato il valore della «religione come spettacolo», anch’egli era un grande attore amato da 9 italiani su 10, il che non gli ha impedito di far sprofondare la Chiesa. Francesco forse ascolta di più il «cerchio magico» di cui si è circondato, forse tiene maggiormente presenti gli interessi delle periferiche chiese locali, «appare» più pluralistico, anche se la sua «rivoluzione» è tutta incentrata sul «suo» messaggio. Incanta, sì, i laici superficiali, ma proprio sui contenuti che più dovrebbero interessar loro, ovvero sui rapporti tra Stato e Chiesa e sul ruolo pubblico o privato delle confessioni religiose, il Vaticano è fermo alla più retrograda politica dei concordati e dei privilegi. Forse nelle ultime settimane può essere cominciata la fine della «luna di miele» per il papa. Quello che è stato da tantissimi percepito come il primo grave «scivolone» di Francesco, mi riferisco all’agghiacciante frase sul «pugno in faccia» a chi non rispetta la Chiesa anche solo a parole, costituisce in effetti una svolta. Quella sua dichiarazione va letta con attenzione. Prima di tutto risponde perfettamente alla classica retorica gesuitica che consiste nell’inserire nella medesima frase due concetti contrari, in modo da renderla ambigua e disponibile a citazioni opposte. Da una parte, la rivendicazione della non violenza; dall’altra, «il pugno», solo quantitativamente differente dai colpi di kalashnikov sparati dai fanatici islamici a Parigi pochissimi giorni prima. Il papa, prima, fa sopire il polverone delle emozioni e dell’orgoglio laico europeo; poi, mostra di stare dalla parte di chi è contrario alla paressia, fino alla violenza. Con cinismo Francesco testimonia per una religione violenta o potenzialmente violenta. Al «Je suis Charlie» contrappone un «Io sono Breivik». Mentre tutta la cultura europea riflette in modo multiforme su quanto è avvenuto, la frase di Francesco, anche con una nuance di volgarità, dimostra che la gerarchia cattolica non ha, né intende cercare, una risposta agli inquietanti interrogativi di molti credenti di fronte a due questioni che gravano sulle religioni da millenni, il rapporto col Male e con la Violenza. CHIESA CATTOLICA Perché Francesco entusiasma e turba Luigi Sandri Con le sue scelte, a due anni dall’elezione il vescovo di Roma entusiasma molti cattolici, ma ne turba altri. Una parte della Curia è con lui, ma un’altra gli si oppone, in ciò sostenuta dagli orfani di Ratzinger. Alta sarà la sfida al prossimo Sinodo, e non indolore la questione dell’ammissione all’Eucaristia delle/dei divorziati e risposati. l giro di boa del secondo anno di servizio episcopale sulle rive del Tevere che Francesco ha iniziato il 13 marzo 2013, si delineano sempre più i tratti caratteristici del suo ministero, le novità apportate, le criticità insuperate, le sfide emergenti e le speranze possibili. E le reazioni del corpo vivo della Chiesa cattolica ad un vescovo di Roma «arrivato quasi dalla fine del mondo». A Il programma, ammirato e/o contestato, di Bergoglio «La strada della Chiesa, dal Concilio di Gerusalemme in poi, è sempre quella di Gesù: della misericordia e dell’integrazione. Questo non vuol dire sottovalutare i pericoli o fare entrare i lupi nel gregge, ma accogliere il figlio prodigo pentito; sanare con determinazione e coraggio le ferite del peccato; rimboccarsi le maniche e non rimanere a guardare passivamente la sofferenza del mondo. La strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno; di effondere la misericordia di Dio a tutte le persone che la chiedono con cuore sincero; la strada della Chiesa è proprio quella di uscire dal proprio recinto per andare a cercare i lontani nelle “periferie” essenziali dell’esistenza; quella di adottare integralmente la logica di Dio (Luca 5,31-32)». Così, Francesco, il 15 febbraio, ai nuovi venti porporati (da lui creati il giorno prima), riassumendo il suo programma episcopale romano, più diffusamente spiegato nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium (24/11/2013). Un programma che entusiasma e, insieme turba, la Chiesa romana: non tanto per le parole in sé – innocue, se inattuate – ma perché Francesco da subito ha comin- 29 ciato a inverarle. Perciò, mentre grande è stata (è) la gioia di moltissimi cattolici per il suo ministero e magistero, sentito come profumo di Vangelo, altrettanto profondo è stato (è) il disagio di altri, soprattutto se ecclesiastici o apologeti di professione sulla cresta dell’onda sotto i pontificati di Wojtyla e di Ratzinger, i quali, adesso, vistisi messi in discussione i loro radicatissimi schemi interpretativi, sono spiazzati e – oh meraviglia! – scoprono il sapore dei distinguo e del dissenso dal papa. Che cresca, anche a Roma, e proprio a Roma, una sorda opposizione all’orizzonte tratteggiato e alla prassi incarnata da Francesco lo ha ammesso lui stesso – indirettamente ma con sferzante chiarezza – quando, il 22 dicembre 2014, ricevendo gli alti dirigenti della Curia per gli auguri natalizi, senza tanti fronzoli ha elencato le «quindici malattie curiali», tra le quali: «1. La malattia del sentirsi “immortale”, “immune” o addirittura “indispensabile”; 3. La malattia dell’”impietrimento” mentale e spirituale; 6. La malattia dell’“Alzheimer spirituale”; 7. La malattia della rivalità e della vanagloria; 8. La malattia della schizofrenia esistenziale; 10. La malattia di divinizzare i capi; 12. La malattia della faccia funerea; 15. La malattia del profitto mondano, degli esibizionismi». Già i semplici titoli, pur senza riportare le sapide spiegazioni di Bergoglio, danno il tono del suo pensiero e il senso della sua sfida. Se un papa fa una tale analisi – che, così cruda, non ha precedenti in bocca ad un pontefice – è evidente che egli constata un’insopportabile distonia tra la sua visione e quella della Curia. Gruppo variegato, questo, di oltre duemila persone, nel quale una parte è toto corde con lui, a iniziare dal segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin; ma una parte notevole gli è contro, e una terza si barcamena, frenando, per quel che può, le attese del papa. Questa «lontananza» lambisce anche il Collegio cardinalizio ove, in un settore significativo, a livello di Curia ma non solo, cresce l’insofferenza verso Francesco – né potrebbero occultare questo dato i resoconti ufficiali che parlano quasi di un idillio tra papa e porporati nel «plenum» cardinali- marzo 2015 i servizi confronti CHIESA CATTOLICA zio del 12-13 febbraio. Ed è a questo livello, forse, che si trovano i riferimenti (o i suggeritori?) di Vittorio Messori che, il 24 dicembre – due giorni dopo il discorso papale – con impeccabile stile curiale (che colpisce mentre fa finta di lodare) sulla prima pagina del Corriere della sera critica Francesco, per la sua «imprevedibilità... che turba la tranquillità del cattolico medio, abituato a fare a meno di pensare in proprio, quanto a fede e costumi, ed esortato a limitarsi a “seguire il papa”». Uscito la vigilia di Natale, quell’articolo ha suscitato larga eco; lo meritava? Intanto, ci appare davvero pretenzioso uno scrittore che si auto-elegge quasi a rappresentante del «cattolico medio». Si tratterà, forse, di cattolici della bassa Bresciana (zona ove vive, mi dicono, lo scrittore), ma non certo di quelli «medi» del Brasile, o delle Filippine, entusiasti di Bergoglio. Dunque, solo una visione provinciale poteva suggerire quel linkage, anche se volatili sono sempre gli applausi delle folle. Ad ogni modo, il suo attacco è apparso davvero sopra le righe a diversi gruppi e personalità (in Italia comunità varie e cenacoli, e il movimento Noi siamo Chiesa; in Brasile il teologo della liberazione Leonardo Boff ) per cui, polemizzando con lui, gli hanno risposto con appelli di sostegno a Francesco. Ma, forse, invece che al dito, bisognava (bisogna) guardare alla luna. E la luna è quel blocco di prelati, orfani di Ratzinger, rafforzati da lefebvriani ad honorem e da «laici devoti», che si stanno organizzando per contrastare frontalmente, e pubblicamente, scelte dirimenti del nuovo vescovo di Roma. Se, a proposito di certi temi – l’Eucaristia a persone divorziate e risposate, il giudizio etico sulle unioni omosessuali e sulla convivenza prematrimoniale – l’Assemblea episcopale di ottobre proporrà di cambiare la pastorale corrente, lasciando però immutati i princìpi dottrinali, questa scelta sarebbe debole, e forse indifendibile. Occorrerebbe riproporre anche dimenticate premesse dottrinali, perché la «nuova» pastorale regga. La partita del Sinodo, diviso tra due princìpi L’appuntamento per la battaglia dei «lunari» – guidata da cardinali: in prima fila Ludwig Gerhard Müller, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, e dagli altri quattro che con lui nell’ottobre scorso hanno firmato il volume Perseverare nella verità di Cristo; li fiancheggiano Angelo Scola, arcivescovo di Milano; Camillo Ruini, per tre mandati da Wojtyla nominato presidente della Cei; Francis George, ex arcivescovo di Chicago – sarà il Sinodo dei vescovi di ottobre, dedicato alla famiglia, e secondo round di analoga Assemblea (questa «straordinaria», quella «generale») svoltasi nell’ottobre scorso (vedi Confronti 11/2014). Il nodo cruciale che divide(rà) i pro e i contro-Bergoglio è il come coniugare verità e carità, diritto e mi- 30 sericordia, dottrina e pastorale su temi quali l’ammissione all’Eucaristia di persone divorziate e risposate, il giudizio morale sulle unioni omosessuali, le convivenze pre-matrimoniali. Limitiamoci, qui, al primo argomento: su di esso il Sinodo 2014 si è spaccato tra favorevoli e contrari. I contro sostenevano che il sì avrebbe violato il mandato di Gesù («L’uomo non divida ciò che Dio ha unito»); secondo i pro, invece, già nelle Scritture, oltre che nella prassi storica delle Chiese, vi sono eccezioni al principio. A proposito: ribadire, come fanno Francesco ed i vescovi del sì, che si intende cambiare la pastorale ma lasciando immutato il principio (la «dottrina»), apre un cortocircuito, e i no rimarranno imbattibili – chi, potrebbe, infatti, sciogliere da un comandamento di Cristo? Bisognerebbe invece imboccare una via più stretta, ma più sicura, affermando due princìpi: 1/ l’indissolubilità della coppia è un alto ideale proposto da Gesù, e chi la rompe si assume una grave responsabilità; 2/ il Signore («Il sabato è fatto per l’uomo, e non l’uomo per il sabato») non intende schiacciare nessuno sotto la sua colpa, ma incoraggia a riprendere il cammino. E così da sempre, rispetto a quel problema, agiscono le Chiese ortodosse e, pur partendo da altre prospettive, quelle della Riforma. Del resto, mentre ribadisce con fermezza il comandamento «Non uccidere», e condanna l’assassinio, la stessa Chiesa romana ammette all’Eucaristia l’omicida che si pente, e che in nessun caso può risuscitare le sue vittime. Inevitabile è la croce che inchioda Francesco: ritenuto «deviante» da quelli del no ove ammettesse all’Eucaristia persone divorziate e risposate; considerato improvvido da quelli del sì ove infine ribadisse l’esclusione dalla comunione. Proclamare un solo principio dottrinale, ignorandone un altro, ed asserire che si cambia solo la pastorale, è una scorciatoia che, infine, porta ad un vicolo cieco. Con buona pace dei «lunari», bisognerà pure un giorno ammettere che, grazie a Dio, una Chiesa smemorata, da secoli dimentica dell’Evangelo (il principio!) della misericordia, ora, ravveduta, se ne ricorda. Può fare questo passo una Chiesa che, dopo aver per tanto tempo negato il principio della libertà religiosa, al Concilio Vaticano II ha avuto l’ardire di riconoscerlo. Ma fu una battaglia – teologica – asperrima. E oggi, come allora, Lefebvre incombe. CULTURA I rom e le identità «cucite addosso» Gino Battaglia Molto si è scritto sulla Shoah, ma sul Porrajmos – lo sterminio di circa mezzo milione di rom e sinti nei campi nazisti – quasi nulla. Mancano soprattutto le fonti dirette. Il protagonista del romanzo di Gino Battaglia «La fortuna di Dragutin», per quanto grande sia il dramma a cui è sopravvissuto, non ha parole. « a fortuna di Dragutin» è il titolo dell’ultimo libro di Gino Battaglia, viaggiatore e studioso che a lungo ha lavorato sui temi della marginalità sociale e del dialogo tra le religioni e le culture. Il romanzo è uno spaccato di vita rom nel campo dove vive la famiglia di Dragutin, sopravvissuto allo sterminio nazista da piccolo, e ora anziano che vede attorno a sé la vita e le storie cambiare. Sul libro e sul tema, Confronti lo ha intervistato. Già direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Cei, monsignor Battaglia ha passato molti anni a contatto con i rom, lavorando alla scolarizzazione dei bambini con la Comunità di Sant’Egidio. L La fortuna di Dragutin. Dragutin per tutto il libro si chiede se la sua sia davvero una «fortuna». Riflette sulla durezza della vita e teme i cambiamenti in atto. Che ne è di questa sua fortuna? Dragutin è sopravvissuto a un episodio dello sterminio degli zingari, il Porrajmos, quando era molto piccolo. Ora è uno dei pochi anziani (l’attesa di vita nei campi rom è molto bassa). Dunque è doppiamente un sopravvissuto. Questa sembra la sua fortuna. Dragutin confronta la sua fama di fortunato con la sua condizione e le vicende della sua famiglia, che vive un momento di trasformazione in mezzo a noi gagé. Il presente prefigura infatti il fallimento dei suoi progetti e delle sue speranze. Davvero, allora, che ne è della sua fortuna? Ma il protagonista del romanzo non è solo il paradigma della condizione di un certo gruppo umano. Dragutin, dicevo, è un sopravvissuto, ma chi di noi non lo è? Sopravvissuto a vicende anche casuali, alla morte dell’amico o del genitore, al tempo che passa. Qual è il significato di questa sopravvivenza? Dragutin è un sopravvissuto che non ha parole. Non solo perché è rom. Ma anche questo è un aspetto drammatico della condizio- 31 ne dei rom: c’è una sterminata letteratura sulla Shoah, sul Porrajmos quasi nulla, e quasi nulla di fonte rom, di fonte diretta. Soprattutto, il sopravvissuto alla Shoah, per tanti motivi, diventa testimone, diventa profeta. Dragutin, per quanto grande sia il dramma a cui è sopravvissuto (lo sterminio di mezzo milione di rom e sinti) non ha parole. Come forse ognuno di noi. Solo una domanda: se questa sopravvivenza non sia un privilegio ingiustificabile pagato con la sfortuna degli altri. Dragutin, appunto, incarna il suo essere sopravvissuto, unico della sua famiglia all’eccidio. Eppure la sua storia gliela ricordano, gliela raccontano gli altri. Hai creato nel libro un contrasto tra ricordo personale e storia raccontata. Quante storie vivono nel libro, e che rapporto hanno tra loro? Quello dei rom è un popolo che vive anche di storie. Abituati a pensare a loro come problema sociale, trascuriamo tanti altri aspetti. Ho passato molti anni in mezzo a loro lavorando alla scolarizzazione dei bambini con la Comunità di Sant’Egidio. È stato un modo per entrare nelle kampine e nelle baracche, per incontrare e ascoltare. Ascoltare soprattutto. Non diversamente da noi, ma con mezzi più poveri, i rom cercano di capirci qualcosa in questo mondo complicato. Il libro è anche il tentativo di far risuonare il flusso di coscienza che coinvolge questo piccolo popolo, il gusto di chiacchierare, il racconto che si snoda tra stupore e rabbia, tra amarezza e comicità. Allora, è vero, il libro contiene in realtà tante storie, come rivoli di quella corrente, molte di queste raccontate, per così dire, non da me ma dai personaggi. Non manca la riflessione teologica tra i personaggi. Capitolo centrale è quello della festa, per la santa protettrice, il momento della benedizione e della «vita». Quale rapporto tra festa, Dio e la vita futura? Si tratta in realtà di una tradizione balcanica, quella della festa di famiglia, la Krsna Slava, che però i rom di religione cristiano-or- i servizi marzo 2015 confronti CULTURA todossa hanno fatto propria. In una vita religiosa povera di manifestazioni esteriori, è un momento centrale. Si carica anche di significati sociali: è il giorno della convocazione di tutte le relazioni attorno a quella famiglia e anche il coagulo delle tensioni e delle prospettive. Ma è anche il momento della centralità di Dio e quindi delle domande sulla vita, sulla morte, sul futuro, sulla fortuna. Per questo è tanto più doloroso per Dragutin avvertire le crepe nella tenuta della sua famiglia. La festa è anche il perpetuarsi attraverso le generazioni di un legame con l’Oltre, con l’Eterno. Per questo la festa è l’occasione, come dicevo, per le domande, che sono un altro aspetto del libro, in cui ci ritroviamo, noi e i rom, così vicini. Ulteriore elemento di fondo del libro è il contrasto tra generazioni. Quelle giovani lottano contro le tradizioni per «fare a modo loro». È segno di speranza o di peggioramento? Nel mondo contemporaneo, ogni generazione, in ogni contesto sociale e culturale, ha con la precedente un rapporto complesso. Ogni generazione compie un pezzo di strada in più. Ma per andare dove? Questo è il punto. Noi stessi ci troviamo a dubitare ormai di un’idea del progresso inarrestabile dell’umanità verso il meglio. Per i giovani rom il presente è particolarmente frustrante: è una terra di nessuno, un’attesa quasi senza oggetto, né integrazione né possibilità di essere se stessi. In una società che sembra accettare tutte le diversità, le trasgressioni, i rom sono diversi ma non sono accettati. I giovani finiscono per essere in conflitto con il loro ambiente oltre che con il nostro. Qui c’è anche la nostra responsabilità collettiva e la responsabilità della politica. Forse non è questa la sede per parlare di questi problemi, che pure il romanzo evoca. Dico solo che un popolo di giovani e di bambini potrebbe cambiare molto, attraverso la scuola, attraverso un serio avviamento al lavoro. Stiamo parlando di 70-80mila persone nei campi italiani, di cui la metà sono minori. Chiusa la parentesi, mi pare che si profilino nel mondo dei rom aspettative e speranze, incarnate soprattutto dai giovani, di maggiore inserimento, soprattutto di superamento di quelle contraddizioni del loro mondo, che non è facile affrontare seriamente finché la situazione è così polarizzata e ostile nei loro confronti. Se i giovani rom non trovano nella nostra società «Per i giovani rom il presente è particolarmente frustrante: è una terra di nessuno, un’attesa quasi senza oggetto, né integrazione né possibilità di essere se stessi. In una società che sembra accettare tutte le diversità, le trasgressioni, i rom sono diversi ma non sono accettati. I giovani finiscono per essere in conflitto con il loro ambiente oltre che con il nostro. Qui c’è anche la nostra responsabilità collettiva e la responsabilità della politica». una sponda al loro desiderio di una vita meno precaria (vogliamo dire più normale?), sarà sempre impossibile per loro essere, appunto, normali. Perché è importante per lei aver scritto un libro sui rom? Quello dei rom in mezzo a noi è un tema sul quale non si riesce a ragionare con la testa lucida. Mi ha sempre colpito come il tema fosse assente anche dall’orizzonte della sinistra, se si esclude qualche eccezione, e come le prassi delle diverse amministrazioni fossero sempre le stesse: campi sosta (ma sono nomadi davvero, i rom?) e sgomberi. Nient’altro. Per le chiese è diverso, mi pare. Ma anche qui si tratta di esperienze di punta. Potrebbe contribuire la letteratura a suggerire un punto di vista diverso? Potrebbe cioè la finzione (perché di questo si tratta) dire qualcosa di umano su coloro di cui non si riesce a dire altro che male? Io non pretendo di dire chi sono davvero i rom, oltre il pregiudizio, oltre le nostre rappresentazioni, buone o cattive che siano. Oltre le loro rappresentazioni. Un racconto dice una cosa, alcune cose, dell’oggetto di cui parla. Questa cosa è vera, come è vera una fotografia, che coglie un’espressione, un momento particolare, un taglio di luce. La verità poi è fatta di tante verità, anche in contraddizione tra loro, ma che non debbono essere considerate come contrapposte ma semmai complementari. La realtà è sempre complessa. So bene che nei campi c’è altro, oltre quello che ho raccontato, e c’è anche altro che io non so. Ma ho cercato solo di raccontare quello che appare quando ci si trova tra i rom, fuori dai ruoli definiti di zingari e gagé. Insomma, il contrario della verità è la menzogna non la finzione. La finzione non è invece un modo per dire una verità che altrimenti non si può dire? D’altra parte, ciascuno costruisce la sua identità: cioè ogni individuo si crea dei personaggi, di cui riveste i panni a seconda delle circostanze. Ovvero glieli cuciono addosso gli altri. È il problema dei rom in mezzo a noi. È il problema di Dragutin: sono gli altri a dirgli chi è. Dragutin, il fortunato. Dragutin, il furbo... Alla fine, la maschera rivela, non nasconde, qualcosa della persona: i suoi dolori e le sue passioni. intervista a cura di Claudio Paravati 32 marzo 2015 • le notizie n o t i z i e AMBIENTE Polveri e ozono fuori controllo in Italia: la denuncia di Legambiente nel rapporto «Mal’aria 2015». Legambiente chiede un piano urgente di intervento per la riduzione dell’inquinamento nei capoluoghi italiani, lo ha fatto in occasione della presentazione dei dati sull’inquinamento atmosferico «Mal’aria 2015». Si registra un miglioramento dell’inquinamento atmosferico nelle nostre città e una riduzione nelle emissioni di alcuni inquinanti negli ultimi anni, ma i livelli di esposizione dei cittadini rimangono ben oltre le soglie consentite. La cattiva qualità dell’aria nelle aree urbane è alla base di una procedura d’infrazione relativa alla mancata applicazione della direttiva 2008/50/CE aperta nel luglio scorso. La direttiva attua una revisione della legislazione europea con lo scopo di ridurre l’inquinamento per limitare gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente. L’Italia era già stata condannata tre anni fa per il superamento di PM10 (tutte le particelle che hanno un diametro uguale o inferiore a 10 micron) per il periodo 20062007 in 55 diverse zone ed agglomerati italiani; di queste, 13 continuano a superare costantemente i limiti per il PM10 anche nel periodo 2008-2012 e si ritrovano di nuovo sotto indagine insieme ad altre 6 nuove zone. Gli impatti dell’inquinamento atmosferico si trasformano in morti premature e costi sanitari, a conferma di questo la recente decisione dello Iarc (l’Agenzia DIRITTI UMANI internazionale di ricerca sul cancro) di inserire l’esposizione all’inquinamento dell’aria, e in particolare ad elevati livelli di particolato atmosferico, come cancerogeno di gruppo 1. Nella classifica diffusa troviamo nell’ordine Frosinone, Alessandria, Vicenza e Torino. Degli 88 capoluoghi monitorati quelli che hanno registrato superamenti del limite (35 giorni) sono stati il 37%: Frosinone lo supera di tre volte, Alessandria di due volte e mezza, Benevento, Vicenza, Torino, Lodi e Cremona sono oltre il doppio dei giorni consentiti. In Veneto la situazione più preoccupante per il PM10 (il 92% delle centraline supera il limite, esclusa Belluno), segue la Lombardia (68%), il Piemonte (50%), la Campania (44%). In Europa, secondo i dati «Rapporto sulla qualità dell’aria 2014» redatto dell’Agenzia europea per l’ambiente, il nostro è il Paese con il più alto numero di morti premature dovute all’inquinamento da ozono: con circa 3.400 vittime all’anno (dato relativo al 2011) precede la Germania, la Francia e la Spagna. «È quanto mai evidente – ha dichiarato il responsabile scientifico di Legambiente Giorgio Zampetti – la necessità di un urgente e decisivo piano di intervento che vada finalmente ad incidere sulle politiche relative alle fonti di inquinamento più volte annunciato ma ancora mai attivato a livello nazionale. Le cause si conoscono e le soluzioni ci sono, occorrono la volontà politica e gli strumenti per metterle in campo». Cristina Zanazzo Celebrata la Giornata contro le mutilazioni genitali femminili: sono130 milioni, nel mondo, le bambine e le donne vittime di questa pratica. Le mutilazioni genitali femminili (Mgf) violano i diritti umani e minacciano la salute e il benessere di circa 3 milioni di ragazze ogni anno. Sono più di 130 milioni le bambine e le donne mutilate, soprattutto in Africa e Medio Oriente dove la pratica è più diffusa. I dati sono stati resi noti in occasione della Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili, il 6 febbraio, da Unicef, Unfpa, Confederation of midwives e International federation of gynecology and obstetrics. Queste organizzazioni hanno chiesto per le Mgf tolleranza zero, e la mobilitazione degli operatori sanitari. Proprio loro sono stati identificati come i soggetti che possono accelerare il processo di abbandono di questa pratica, grazie al rapporto di fiducia che instaurano con le pazienti, ma soprattutto perché conoscono le conseguenze e le complicazioni che le Mgf provocano (talvolta sono anche causa di morte) e le terribili conseguenze del trauma subito nelle giovani donne. Preoccupa la tendenza, in numerosi paesi, alla «medicalizzazione» delle Mgf. Tre quarti degli interventi vengono effettuati da operatori sanitari, contravvenendo al precetto fondamentale della disciplina medica: non procurare del male. Per sostenere gli operatori sanitari, le organizzazioni promo- 33 trici si impegnano a fornire il proprio appoggio a tutte le iniziative tese a fornire le competenze e le informazioni di cui essi hanno bisogno per accelerare l’abbandono delle Mgf e per curare le complicazioni causate da questa pratica. Il Parlamento europeo stima che nell’Ue siano 500mila le donne che convivono con la Mgf e 180mila coloro che rischiano annualmente di esserne sottoposte. Per questo motivo l’Aidos (Associazione italiana donne per lo sviluppo) insieme al Gruppo di lavoro parlamentare «Salute globale e diritti delle donne» ha richiamato l’attenzione sulla necessità di gestire il fenomeno con risorse economiche, infatti è dal 2012 che la legge sulla prevenzione e sul divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile non viene rifinanziata. Una legge che – come ha spiegato Pia Locatelli, coordinatrice del Gruppo e di Aidos – prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro l’anno per attività di prevenzione e formazione nel nostro paese. Cristina Zanazzo IMMIGRAZIONE La comunità marocchina in Italia conta oggi 500mila persone, presenti soprattutto nel nord del paese. Seconda per numero, dopo quella rumena, è però al primo posto per numero di imprenditori stranieri presenti nel nostro Paese. Con più di mezzo milione di presenze, i marocchini costituiscono in Italia la seconda comunità di immigrati più numerosa dopo la rome- marzo 2015 • le notizie na. Dalle sole 1.001 unità del 1981, si è passati alle 407.097 del 2011, concentrate maggiormente nelle regioni del Nord: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. Al primo posto tra gli imprenditori stranieri, più del 70% delle imprese marocchine, fiorite soprattutto tra il 1998 e il 2002, si occupa di commercio. Seguono l’edilizia, il settore manufatturiero, i trasporti e i servizi professionali. L’Italia ha iniziato ad essere meta di immigrazione a partire dagli anni ‘70, data la legislazione più flessibile, i redditi più elevati e le maggiori possibilità di lavoro rispetto agli altri paesi europei. I primi marocchini arrivati, provenienti dalle campagne e spinti dalle disgrazie causate dalla siccità e dai debiti nel proprio paese, senza delle vere qualifiche, svolsero le attività di venditori ambulanti, lavavetri e braccianti. Negli anni ‘80 invece l’immigrazione inizia ad interessare anche le città. Gli artigiani e i disoccupati delle fabbriche e delle miniere di fosfati, di età più giovane rispetto ai loro predecessori, si sono inseriti non solo nell’agricoltura ma anche nella piccola edilizia, nell’industria e ovunque ci fosse bisogno di manodopera. Questa fase di consolidamento ha visto l’arrivo anche di alcuni studenti universitari. Gli anni ‘90 rappresentano la fase del ricongiungimento familiare, con l’arrivo delle donne e dei bambini. Dal 2000, nonostante la sempre crescente tendenza all’insediamento stabile (tramite, ad esempio, l’acquisto di beni immobili), si sta vivendo un momento più problematico causato non solo dalla crisi economica, a cui gli stranieri sono più soggetti, ma anche dall’atteggiamento restio degli italiani ad accettare la presenza permanente dei migranti. necessariamente svizzeri ma anche stranieri che vivono stabilmente in Ticino. È una questione innanzitutto di equilibrio (...) ma anche di trasparenza: il negozio o l’azienda espone il logo e si assume il rischio, il cliente può fare la sua scelta. Non sta avvenendo la stessa cosa in Italia con i prodotti doc o la concorrenza sleale dei cinesi?». La volontà elvetica di porre un tetto all’arrivo di immigrati e lavoratori stranieri, stabilito dal referendum di un anno fa contro la libera circolazione in vigore con l’Ue, è anche al centro degli incontri tra i presidenti della Confederazione elvetica e della Commissione europea, perché si scontra con i trattati internazionali firmati a Bruxelles. Monica Di Pietro La comunità marocchina in Italia è comunque attiva e prospera e i ricongiungimenti, i matrimoni e le richieste di cittadinanza indicano la propensione ad una crescita ulteriore. Come tutti gli stranieri, i marocchini dovrebbero essere considerati una risorsa, e il loro inserimento nella società italiana può produrre degli effetti ancor più positivi di quanto fatto fin’ora; in particolar modo per quanto riguarda i giovani delle seconde generazioni, che sentono di avere una doppia appartenenza culturale e che hanno dato vita a nuove identità originali. Monica Di Pietro Quando gli immigrati siamo noi (e non ci vogliono più). Un paese della Svizzera «italiana» ha lanciato una campagna per scoraggiare l’assunzione di lavoratori provenienti dall’Italia. SOCIETÀ Claro, un comune svizzero di 2.700 anime vicino Bellinzona (Canton Ticino), a circa 60 chilometri dal confine italiano, ha avviato una campagna per incoraggiare, da parte delle aziende, l’assunzione di personale residente in Svizzera a scapito dei dipendenti provenienti dall’Italia. Tali imprese, riunite in una sorta di «white list», avranno anche un logo da esporre con la scritta «noi impieghiamo personale residente». «Da quando il numero dei frontalieri è esploso, sono nate storture nel mercato del lavoro», ha affermato il sindaco Keller. Nell’ultimo decennio infatti il mercato del lavoro in Canton Ticino si sta trasformando. Nel 2014 sono più di 60mila i pendolari italiani che varcano la frontiera, che accettano un salario più basso degli elvetici del 15-20% e che occupano un quarto dei posti di lavoro. «L’appello è ad assumere residenti, che non significa Nel rione Sanità di Napoli, una cooperativa di giovani si occupa con impegno e passione di numerose attività culturali. Il Rione Sanità a Napoli non gode di buona fama, anche se si chiama così perché anticamente era più «salubre» rispetto alla città bassa, lungo il porto. Oggi però nel Rione Sanità si sta sviluppando un’esperienza condotta da un gruppo di giovani che ha già cambiato i connotati di questa zona di Napoli. Si tratta della cooperativa che gestisce la Casa del Monacone, un piccolo B&B che ha provveduto a ristrutturare all’interno del convento annesso alla Basilica di Santa Maria della Salute. Inoltre, sempre questo stesso gruppo è impegnato nelle visite delle Catacombe di San Gaudioso e di San Gennaro; gli accompagnatori spiegano che hanno anche collaborato nel lavoro di ripristino degli spazi sotterranei, inagibili dopo molti an- 34 ni di abbandono; oggi con precisione e competenza spiegano ai visitatori la storia di questi antichi luoghi della città. Sono tutti giovani che provengono dallo stesso Rione Sanità e svolgono questo lavoro con impegno e passione, consapevoli delle ricadute che si potranno avere per uno sviluppo futuro sia del rione che di tutta la zona limitrofa, e anche sull’immagine di Napoli. Buon lavoro ragazzi! Anna Maria Marlia MEDIA La classifica di Reporters sans frontières sulla libertà di stampa in 180 paesi del mondo vede l’Italia precipitare al 73° posto. Come ogni anno, la Classifica mondiale della libertà di stampa di Reporters sans frontières vede al vertice i paesi del nord Europa. Si conferma in testa – per la quinta volta consecutiva – la Finlandia, seguita quest’anno da Norvegia, Danimarca e Olanda. L’anno scorso l’Olanda era seconda, seguita da Norvegia e Lussemburgo. Spostamenti non eclatanti, quindi, ma nella «top ten» sono da registrare il balzo in avanti del Canada (dal 18° all’8° posto) e della Giamaica (dal 17° al 9°), ma anche le clamorose retrocessioni dell’Islanda (dall’8° al 21°), del Liechtenstein (dal 6° al 27°) e di Andorra, dal 5° al 32°. Per quanto riguarda il nostro paese, precipitiamo dal già non molto onorevole 49° posto ad un ancor più drammatico 73° posto: una perdita di ben 24 punti. Quando al governo c’era Berlusconi, i media – quelli non direttamente dipendenti dal presidente del Consiglio – tendevano a enfatizzare molto i risultati negativi dell’Italia nelle classifiche sulla libertà di stampa, mentre il record negativo di quest’anno sembra marzo 2015 • le notizie non aver fatto molto scalpore: se ne è parlato, certo, ma meno rispetto al passato. Chiudono la classifica gli stessi stati dell’anno scorso: Cina, Siria, Turkmenistan, Corea del Nord ed Eritrea. Come sottolinea Reporters sans frontières, l’intensità degli attentati alla libertà dell’informazione nel mondo ha subito un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente e la responsabilità di questo aumento è soprattutto dell’Europa. A livello mondiale, la causa principale del peggioramento è l’aumento dei conflitti: i mass media diventano obiettivi strategici e vengono utilizzati per la propaganda o ridotti al silenzio, secondo i casi. Molti regimi poi, per censurare le critiche, utilizzano la scusa della protezione del sacro. In quasi la metà dei paesi, infatti, il reato di blasfemia mette seriamente in pericolo la libertà d’informazione e diventa un ulteriore strumento – accanto a quello di «attentato alla sicurezza nazionale», concetto estendibile a piacimento da chi detiene il potere – per intimidire i giornalisti. I due stati più intransigenti in materia di blasfemia sono l’Iran (al 173° posto della classifica) e l’Arabia Saudita (al 164°). Altro problema messo in evidenza da Reporters sans frontières è la difficoltà crescente nel dare copertura informativa alle manifestazioni: si sono infatti intensificate le violenze nei confronti dei giornalisti che hanno il compito di seguirle: insulti, minacce e aggressioni si verificano in molti paesi. In alcuni casi i giornalisti sono solo «vittime collaterali» di scontri fra manifestanti e forze dell’ordine, ma a volte sono presi a bersaglio direttamente dagli uni o dagli altri. Questo è accaduto, per esempio, in Turchia (al 149° posto della classifica), in Ucraina (al 129°), in Egitto etnica della Palestina (pubblicato in Italia da Fazi, nel 2008). Secondo lo storico, ben prima della spartizione della Palestina del Mandato britannico, decisa dalle Nazioni Unite nel 1947, e della nascita di Israele nel ’48, David Ben Gurion – che diverrà poi presidente del suo paese – già aveva programmato in modo sistematico un piano di «pulizia etnica» a danno degli arabi. All’origine di Israele, ha sottolineato Pappé, vi è l’idea di un singolare colonialismo che ha portato gli ebrei provenienti dal di fuori a sentirsi autorizzati a sloggiare i palestinesi abitanti da secoli in quella terra, per insediarsi al loro posto. Venendo poi all’attualità, lo storico ha sostenuto che una equa soluzione del conflitto israelopalestinese – che garantisca Israele ma anche la Palestina – avrebbe enormi e positive conseguenze. In merito, in un’intervista a il manifesto (18 febbraio) ha precisato: «Se il conflitto israelo-palestinese venisse risolto in modo giusto, il Medio Oriente cambierebbe faccia. L’occupazione della Palestina è una delle principali giustificazioni per chi ha simpatie islamiste [per l’Isis], perché è il simbolo del doppio standard che l’Occidente applica a chi viola i diritti umani fondamentali». Ovadia, da parte sua, ha energicamente protestato contro chi ha impedito a Pappé di parlare all’università di Roma-Tre, e rilevato che la censura avvenuta (contro la quale ha proposto di informare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella) «non serve a nessuno». Molto più utile (dato che le tesi dello storico sono contestate da altri storici) sarebbe stato, e sarebbe – ha concluso – un aperto confronto tra opinioni anche frontalmente diverse. L. S. (158°) e nello Yemen (168°), ma anche in Thailandia (134°), dove alcuni giornalisti sono stati aggrediti dalla folla che li considerava troppo filo-governativi. Michele Lipori MEDIO ORIENTE La presenza ad un convegno di Ilan Pappé (storico israeliano non conformista), e poi di Moni Ovadia, è stata probabilmente la motivazione che ha spinto il rettore dell’università di Roma-Tre a negare una sala, prima concessa. Il convegno si è svolto dunque in altra sede. Le tesi sul sionismo e sul conflitto israelo-palestinese, emerse nel dibattito. Un convegno all’università di Roma-Tre, che prevedeva la partecipazione – tra altri oratori – di due ebrei scomodi per chi sostiene le tesi del governo israeliano sul sionismo e sulla questione palestinese, non ha più potuto tenersi nel luogo previsto, ed è stato costretto, all’ultimo momento, a trovare un’altra sistemazione. Le due personalità scomode erano Ilan Pappé – storico israeliano, molto inviso all’establishment del suo paese, un tempo docente all’università di Haifa ed ora in Gran Bretagna – e Moni Ovadia. Lunedì 16 febbraio, aprendo al Centro congressi di via dei Frentani l’incontro dedicato a «Europa e Medio Oriente oltre gli identitarismi», gli organizzatori hanno espresso il «sospetto» che a spingere il rettore dell’università romana a negare il permesso, prima concesso, siano state pressioni dell’ambasciata israeliana e della dirigenza della comunità ebraica romana. Dopo altri interventi – tra essi quello dell’ex vicepresidente del Parlamento europeo, Luisa Morgantini – ha preso la parola Pappé che, nella sostanza, ha ripreso le tesi del suo libro La pulizia 35 PLURALISMO Al Senato un convegno sul tema «Dai culti ammessi alla libertà religiosa». Ribadita l’importanza dell’approvazione di una legge in materia. Il 16 e 17 febbraio scorso si è tenuto al Senato il convegno «Dai culti ammessi alla libertà religiosa», dedicato al giurista Gianni Long e promosso dalla Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei) in collaborazione con la Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato (Ccers). Nella prima sessione, «Il ruolo e i diritti delle comunità di fede nella società laica», Silvio Ferrari, Alberto Melloni, Biagio De Giovanni e Paolo Naso hanno evidenziato come il nuovo pluralismo religioso che caratterizza l’Italia renda non più rimandabile una nuova legge sulla libertà religiosa. La sessione del 17 si è aperta con «Le politiche degli Stati europei in materia di libertà religiosa. Specificità e percorsi comuni». Roberto Mazzola ha presentato un quadro della situazione europea, mentre Michel Heining, dell’Università di Göttingen, si è soffermato sul modello tedesco e Miguel Rodriguez Blanco, dell’Università di Alcalà, su quello spagnolo. Marco Ventura, Sara Domianello e Francesco Margiotta Broglio hanno risposto positivamente alla domanda: «Un diritto europeo delle religioni?». Nel suo saluto anche il presidente del Senato Pietro Grasso ha ribadito la necessità di una nuova legge che superi la legislazione dei «culti ammessi» del 192930. Poi, dopo l’intervento di Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, sul tema «Pluralismo e libertà religiosa in Italia. Il contributo della Chiesa cattolica», Ti- marzo 2015 • le notizie ziano Rimoldi e Alberto Fossati si sono soffermati su alcune criticità della libertà religiosa in Italia, soprattutto in relazione all’edilizia per il culto e all’attività dei ministri di culto. Infine Alessandro Ferrari e Roberto Zaccaria hanno illustrato i progressi dell’elaborazione curata da un gruppo di giuristi di un testo di una proposta di legge in materia di libertà religiosa. La tavola rotonda «Una legge per la libertà religiosa? Quale? Quando?» presieduta da Valdo Spini, con esponenti politici – Lucio Malan (Forza Italia), Andrea Mazziotti (Scelta civica), Alberto Airola (M5s) e Micaela Campana (Pd) – ha chiuso il convegno, auspicando che si arrivi quanto prima a questa legge. Antonio Delrio ECUMENISMO Il patriarcato copto d’Alessandria d’Egitto e quello etiopico, che hanno rafforzato i loro rapporti, un tempo turbolenti, intendono mediare tra il governo del Cairo e quello di Addis Abeba a proposito di una diga sul Nilo Azzurro, in Etiopia, che al-Sisi non tollera, e che potrebbe dunque innescare uno scontro armato. Dall’ecumenismo alla mediazione per la pace. Si potrebbe forse sintetizzare così il senso della visita che il patriarca della Chiesa ortodossa Tehawedo d’Etiopia, l’abuna Mathias, ha compiuto a metà gennaio al patriarca copto d’Alessandria, e residente al Cairo, Tawadros II. L’incontro è stato cordiale e, a quanto pare, foriero di ulteriori e rafforzati rapporti tra le due Chiese. Il che non era scontato: infatti, la Chiesa etiope è «figlia» di quella d’Alessandria, che si vanta di essere stata fondata dall’apostolo Marco; per tali motivi, fino a metà Novecento la parola decisiva be un enorme potenziale idroelettrico (seimila megawatt). Ma l’Egitto – governato fino al luglio 2013 da Muhammed Morsi, e poi da Abdel-Fattah al-Sisi – riteneva, e ritiene, di non poter perdere «nemmeno una goccia» del 95% delle acque del Nilo che attualmente sfrutta. È in tale complicato contesto economico, giuridico e geopolitico che i due patriarchi copti hanno offerto i loro buoni uffici per una «mediazione» – certamente inusuale – tra Il Cairo ed Addis Abeba. Dirà il tempo se essa andrà a buon fine, e se le minacce di una possibile «guerra per il Nilo» svaniranno. Luigi Sandri per l’elezione dell’abuna era del patriarca alessandrino. Questa situazione era però diventata sempre meno tollerabile per la Chiesa etiopica che, infine, nel 1959 ha ottenuto l’autocefalia. Ma, a parte le questioni ecclesiali da essi ora affrontate, con un dialogo costruttivo, i due patriarchi hanno riflettuto su un problema geopolitico che, direttamente, non tocca affatto le due Chiese, e tuttavia molto ha a che fare con la pace dei loro popoli: le conseguenze di un contestato sbarramento, in Etiopia, del Nilo Azzurro. Il governo di Addis Abeba ha infatti deciso la costruzione di una gigantesca diga, affidando l’impresa all’italiana Salini Costruttori, che ha iniziato i lavori nel maggio del 2013; una volta terminata, essa sarebbe la più grande diga dell’Africa. L’Egitto però teme che il previsto sbarramento gli tolga una parte del limo, essenziale per le coltivazioni egiziane, e risorse idriche indispensabili: quelle che da millenni assicurano la fertilità delle terre confinanti con il fiume. Perciò, al fine di evitare quella che ritengono una catastrofe, ambienti militari egiziani hanno minacciato perfino di bombardare la diga. Nove sono i paesi rivieraschi del Nilo, le cui sorgenti, dei diversi rami, si addentrano molto nell’Africa, lambendo l’Equatore; ma i principali «beneficiari» del fiume sono l’Etiopia, il Sudan e l’Egitto. La spartizione delle acque nilotiche è legata, in parte, ad accordi stipulati quando molti di quei paesi erano possedimenti coloniali, in particolare inglesi. Recenti tentativi di aggiornare quei patti non hanno soddisfatto le divergenti rivendicazioni; da parte sua l’Etiopia ritiene decisiva, per la sua economia, la costruzione della «Grande Diga della rinascita» che le garantireb- Libby Lane è la prima donna-vescovo della Chiesa d’Inghilterra, ordinata in gennaio. L’evento, per quanto atteso, ha provocato qualche contestazione da parte di chi ritiene contraria alla Bibbia quella scelta, alla quale però la grande maggioranza degli anglicani è favorevole. Il gelo della Chiesa cattolica romana. Dopo anni di dibattiti assai accalorati, infine il Sinodo generale della Chiesa d’Inghilterra nel luglio 2014 aveva approvato in linea di principio la possibilità della donnavescovo, e la decisione, diventata potenzialmente operativa a novembre, è stata infine attuata il 26 gennaio: l’arcivescovo di York, John Sentamu, ha ordinato vescovo di Stockport la pastora Libby Lane, sposata. Durante la solenne cerimonia nella cattedrale affollata, Paul Williamson – un esponente della minoranza anglicana ostile alla donna-vescovo – ha gridato: «La Bibbia vieta questa scelta!». La contestazione ha creato un certo trambusto, ma poi la cerimonia è proseguita tranquillamente. Dopo che da qualche decennio era ammessa la donna-pastora, alcune «province» – Chiese nazionali angli- 36 cane, in comunione con il primate, l’arcivescovo di Canterbury – decisero di ammettere la donna-vescovo: si iniziò nel 1989 negli Stati Uniti, seguirono poi Canada, Australia e altre. Nella Chiesa d’Inghilterra le prime donne-pastore si ebbero nel 1994; e, prima di arrivare alla donna-vescovo sono trascorsi due decenni, carichi di polemiche. Una minoranza di anglicani inglesi – vescovi, clero e laici – si sono opposti all’ipotesi, ritenendola contraria alla Bibbia; e ancor più hanno contrastato le unioni omosessuali, anch’esse ammesse da molte Chiese anglicane del Nord. Opponendosi alle due «novità», primati delle Chiese anglicane africane (in Kenya, Uganda, Nigeria...), e alcuni piccoli gruppi nordamericani, si sono posti di fatto in stato di scisma, rispetto a Canterbury. Una parte di questi fedeli – circa cinquemila, nell’insieme – hanno addirittura abbandonato la Chiesamadre, passando al cattolicesimo; per accoglierli, papa Ratzinger nel 2009 ha creato degli appositi ordinariati personali (specie di diocesi, attualmente tre: negli Usa, in Gran Bretagna e in Australia). Una decisione che ha lasciato assai perplesso il mondo ecumenico. Il Vaticano non ha ufficialmente commentato l’ordinazione di Libby Lane, ma essa, che apre un cammino irreversibile (al momento, la Chiesa d’Inghilterra ha 7.798 pastori, di cui 1.781 donne; si prevede che, in proporzione, identico sarà tra qualche anno il rapporto nell’episcopato, oggi composto da 101 uomini e una donna), mette in grande imbarazzo la Chiesa romana, la cui dottrina ufficiale, ribadita da Paolo VI e, con più durezza, da papa Wojtyla, è assolutamente contraria all’ordinazione sacerdotale (ed episcopale) delle donne. Luigi Sandri marzo 2015 • le notizie ECONOMIA Partita anche in Italia la campagna di raccolta firme contro il Trattato transatlantico tra Unione europea e Stati Uniti. Obiettivo: 50mila firme entro il 18 aprile. Il Trattato transatlantico tra Unione europea e Stati Uniti (Ttip) prevede l’apertura della più grande area di libero scambio mai conosciuta prima e a giudizio degli oppositori finirebbe per sottomettere regole e leggi agli interessi delle grandi imprese. Il negoziato è stato portato avanti nella discrezione più assoluta, finché finalmente i movimenti e le associazioni che si battono per un’economia più equa sono riuscite ad attirare l’attenzione dell’opinione pubblica – in realtà, almeno per il momento, solo della parte più sensibile a questi temi – su un trattato che rischia di rimettere in discussione standard e normative ambientali e sociali viste spesso come «impedimenti tecnici al libero commercio». Investimenti e commercio avranno la precedenza sull’interesse pubblico e i parlamenti non avranno la possibilità di opporsi. «Il meccanismo proposto è un pericolosissimo precedente – sottolinea Marco Bersani, di Attac e tra i promotori della Campagna Stop Ttip Italia – che rischia di indebolire ulteriormente i poteri pubblici davanti alle pretese delle lobby economiche». Per Monica Di Sisto, di Fairwatch, «il Ttip rischia di essere un ulteriore grimaldello che può disarticolare le filiere produttive dell’agricoltura familiare, piccola e media, liberalizzando un mercato come quello agroalimentare dove le aziende più legate al territorio e alla qualità chiudono una dopo l’altra, sembrano non avere vie d’uscita». La raccolta di firme a livello europeo ha raggiunto ormai il milione e mezzo di adesioni. Una prima parte è già stata consegnata al presidente della Commissione europea Juncker. L’obiettivo è arrivare a due milioni entro ottobre. Per quanto ri- guarda l’Italia, si punta a raccogliere 50mila firme entro il 18 aprile. A mobilitarsi sono più di 140 organizzazioni e una quarantina tra comitati e contatti locali nei vari territori. Per firmare la petizione online: https://stopttip.org/firma/. In alternativa, si può firmare e far firmare la petizione cartacea scaricando i moduli per la raccolta firme dal sito della campagna alla sezione «materiali» (http://stop-ttip-italia.net/i-materiali/) ed inviarli compilati all’associazione A Sud (piazzale del Giardino Zoologico, 2 00197 Roma). Per ulteriori informazioni: [email protected]. Michele Lipori EUTANASIA «Liberi fino alla fine»: i promotori della campagna per l’eutanasia legale tornano a chiedere al Parlamento di discutere la legge di iniziativa popolare su rifiuto dei trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia. «Ammalarsi fa parte della vita. Come guarire, morire, nascere, invecchiare, amare. Le buone leggi servono alla vita: per impedire che siano altri a decidere per noi, in nome di Stati o religioni; per garantire libertà e responsabilità alle nostre scelte, drammatiche e felici. Fino alla fine». Con queste parole, i promotori della campagna per l’eutanasia legale chiedono che il Parlamento discuta la legge di iniziativa popolare su rifiuto dei trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia che giace alla Camera dal settembre 2013 con le firme di oltre 67mila cittadini. Ne aveva scritto su queste pagine (vedi Confronti luglioagosto 2014) Mina Welby, vedova di Piergiorgio Welby, il cui caso alla fine del 2006 aveva fatto molto discutere. Gravemente ammalato, chiedeva che le sue cure fossero 37 interrotte e scrisse una lettera all’allora presidente della Repubblica Napolitano, il quale rispose auspicando che «il Parlamento avvii un confronto di idee il più possibile pacato e approfondito sulle scelte di fine vita». Sul sito www.eutanasiale gale.it sono state raccolte altre 100mila adesioni all’iniziativa: #LiberiFinoAllaFine è l’hashtag della campagna su Twitter. A febbraio Marco Cappato, promotore della campagna e tesoriere dell’associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, è tornato a rivolgersi ai deputati delle Commissioni Giustizia e Affari sociali per chiedere ai propri presidenti di inserire all’Ordine del giorno la proposta di legge di iniziativa popolare. «Malgrado l’articolo 71 della Costituzione preveda che “il popolo esercita l’iniziativa delle leggi”, quel documento non è mai stato messo in discussione. Neanche in Commissione», ricorda Cappato, che nella sua lettera cita le parole di Napolitano: «Il solo atteggiamento ingiustificabile sarebbe il silenzio, la sospensione o l’elusione di ogni responsabile chiarimento». A sostegno della campagna, numerosi malati, medici, infermieri e personalità della cultura e della politica hanno rivolto ai parlamentari il video-appello «Il Parlamento si faccia vivo», per chiedere la discussione della proposta di legge. La legge prevede che «ogni cittadino può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale e/o terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente». Si richiede solo che il paziente sia maggiorenne, sia capace di intendere e di volere e manifesti la volontà in modo inequivocabile. Michele Lipori marzo 2015 le rubriche confronti DIARIO AFRICANO Enzo Nucci Quando, nel luglio 2011, il Sud Sudan ottenne l’indipendenza dal Sudan, le storiche rivalità tra le etnie dinka (a cui appartiene il presidente Salva Kiir) e nuer (dell’ex vicepresidente Riek Machar) sembravano accantonate. Ma nel dicembre 2013 sono ripresi gli scontri e da allora ogni speranza di tregua viene subito disattesa. Le Nazioni Unite hanno lanciato un appello per aiutare i sud sudanesi minacciati da carestia e guerra, che in breve tempo potrebbero diventare quattro milioni: un terzo della popolazione complessiva. In Sud Sudan è ormai catastrofe umanitaria a quando, nel dicembre 2013, in Sud Sudan si è riacceso il conflitto armato, hanno sottoscritto ben sette accordi di cessate il fuoco, tutti puntualmente violati nelle ore successive alla loro entrata in vigore. Il presidente Salva Kiir e l’ex vicepresidente Riek Machar ci hanno insegnato che cosa significa «scrivere intese sull’acqua e cementarle sulla sabbia». L’ultima in ordine di tempo è del primo febbraio. Ma dopo 9 giorni gli uomini di Riek Machar hanno bombardato le postazioni governative nella città petrolifera di Bentiu, dove 53mila civili sono ospitati in un campo profughi delle Nazioni Unite. È forte l’impressione che le strette di mano tra i due contendenti dopo la firma delle tregue siano solo delle «photo opportunity» per la stampa internazionale. Quello siglato prima dell’ultima violazione era l’ennesimo «accordo non accordo», perché ancora una volta le parti hanno evitato accuratamente di affrontare la questione cruciale, ovvero la divisione del potere. Nel documento si parlava genericamente di creare le condizioni per un governo di transizione, che sono solo beneauguranti promesse. L’Igad (l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo composta dai paesi del Corno d’Africa) in veste di mediatrice aveva avanzato la candidatura di Riek Machar a primo vicepresidente, ipotesi bocciata sonoramente da James Wani Igga, vicepresidente in carica. Intanto il presidente Salva Kiir non ha fermato la macchina elettorale. Alle urne si andrà a maggio, anche se sarà difficile organizzare in poco tempo questo appuntamento senza il controllo del territorio necessario a garantire incolumità e partecipazione dei votanti. Ma in ogni caso sarà una consultazione monca: l’opposizione già urla alla illegittimità. Il presidente spinge sull’acceleratore appellandosi alla Costituzione ed alla partecipazione democratica, ma in realtà sta conducendo una operazione di restyling per cancellare i massacri di civili (compiuti da entrambi gli schieramenti) e la chiamata in soccorso dell’esercito ugandese e dei gruppi ribelli suda- D 38 nesi. Purtroppo hanno ripreso l’attività anche numerose milizie armate locali che agiscono alternativamente a favore dei due fronti, ma sono difficilmente controllabili. In veste di mediatori sono scesi in campo anche l’odiato Sudan (contro cui è stata condotta una guerra durata quasi 50 anni per ottenere l’indipendenza) e la Cina, ambedue mossi dall’obiettivo di difendere i rispettivi interessi petroliferi. Risultati nulli. Come recita un antico proverbio africano, «quando due elefanti combattono, a soffrire sono i fili d’erba». Nel caso specifico la popolazione civile. Le cifre dell’emergenza umanitaria sono da brividi, al pari di Siria e Repubblica Centrafricana. Le Nazioni Unite hanno lanciato un appello per raccogliere un miliardo e mezzo di euro per gli aiuti da destinare agli oltre due milioni e mezzo di sud sudanesi minacciati da carestia e guerra. Ma nel 2015 saranno 4 milioni le persone non più autosufficienti dal punto di vista alimentare, ovvero un terzo della popolazione complessiva. Siamo di fronte alla catastrofe umanitaria. Quando il 9 luglio 2011 la neonata nazione (a larga maggioranza cristiana e animista) ottenne l’indipendenza dal Sudan islamico, le speranze di un futuro di pace dopo mezzo secolo di conflitto animarono la comunità internazionale che fece grandi investimenti anche per la presenza di significative riserve petrolifere. Le storiche rivalità tra le etnie dinka (a cui appartiene il presidente) e nuer (di cui l’ex vicepresidente è espressione) sembravano accantonate, almeno momentaneamente. Alcuni analisti hanno evidenziato come il numero di vittime di questa guerra intestina al Sud Sudan sia stato di gran lunga superiore a quello registratosi nel conflitto con il Sudan musulmano. Un elemento che avrebbe dovuto mettere in guardia dall’evoluzione della situazione. Dinka, in maggioranza dediti all’agricoltura, contro nuer, pastori, in guerra per acqua e campi. Oggi sembra un binomio impossibile da coniugare insieme. La pace in Sud Sudan appare lontanissima. marzo 2015 le rubriche confronti IN GENERE Stefania Sarallo Un incontro alla Casa internazionale delle donne per discutere del libro «Femminismi musulmani. Un incontro sul Gender jihad», curato da Marisa Iannucci, Ada Assirelli, Marina Mannucci e Maria Paola Patuelli. Per «Gender jihad» si intende quello sforzo messo in atto da sempre più donne musulmane per avvicinarsi al senso di giustizia prescritto dal Corano: uno sforzo per la difesa dei diritti delle donne e per il raggiungimento di una emancipazione di genere. Uno sforzo verso un femminismo musulmano iccolo esempio di quello che le autrici definiscono «relazione in presenza», il libro Femminismi musulmani. Un incontro sul Gender jihad (Fernandel editore), è il frutto di una serie di seminari sui temi di genere che hanno avuto luogo a Ravenna nel 2013; incontri associativi che, oltre al merito di coniugare «pensiero e progettazione», hanno anche reso possibile l’impresa di condurre sotto l’unico comune denominatore chiamato «femminismo» donne (ma anche un uomo!) provenienti da ambiti molto diversi. Italiane e marocchine, musulmane e cattoliche, laiche e agnostiche hanno intrapreso un percorso teso al reciproco riconoscimento, i cui frutti – non propriamente scontati – confluiscono in questo libretto ricco di spunti di riflessione che si dipanano in molteplici direzioni di approfondimento senza voler tracciare un unico cammino di azione. Una riflessione comune intorno a questo testo, come quella che ha avuto luogo il 30 gennaio a Roma, alla Casa internazionale delle donne, non può prescindere da un’analisi del significato attribuito e attribuibile al termine «jihad» che, baldanzoso e – agli occhi dei meno avvezzi alla tematica – «provocatorio», appare nel sottotitolo. Il jihad, come ha inteso subito spiegare Marisa Iannucci, studiosa del mondo islamico nonché curatrice del libro insieme a Ada Assirelli, Marina Mannucci e Maria Paola Patuelli, indica lo «sforzo», l’«impegno» – dell’anima, dell’intelletto o del corpo – per giungere a un obiettivo. Nel mondo arabo vi si ricorre, a diverso titolo, per intendere tanto la lotta dell’individuo che tende al raggiungimento di una conoscenza più matura del sé, quanto l’impegno profuso in un ambito mondano circoscritto o il combattimento in senso stretto; ma, soprattutto, il jihad rappresenta quel continuo stato di sforzo interiore, teso alla comprensione del volere divino e alla sua corretta applicazione, cui dovrebbe ambire ciascun buon musulmano. Quando si ricorre all’espressione «Gender jihad» si intende quello sforzo per la difesa dei diritti P 39 delle donne e per il raggiungimento di una emancipazione di genere che, sulla scia delle opere della teologa Amina Wadud, parte proprio da una nuova esegesi del testo in chiave femminista, l’unica in grado di mettere in discussione le interpretazioni patriarcali prevalenti. L’ampio spettro di significati che vengono conferiti alla parola all’interno del contesto originario arabo e islamico mostra tutta la limitatezza di una traduzione che ne fa in Occidente semplicemente una «guerra santa». Come ha sottolineato l’antropologa Anna Maria Rivera, «un libro come questo è oggi quantomeno opportuno. È un piccolo argine al dilagare dell’islamofobia e a tutte le retoriche che ruotano intorno allo scontro di civiltà. Mostra tutta la ricchezza dell’islam e il fatto che sia compatibile con la liberazione dal patriarcato». Il recupero e l’analisi del termine jihad, quindi, è fondamentale perché proprio il jihad rappresenta lo strumento di cui l’islam può avvalersi per liberarsi dai pregiudizi e dai molteplici «appiattimenti» che subisce all’interno della nostra società. Jihad, ad esempio, può significare per le seconde generazioni di donne musulmane in Occidente ricollocarsi all’interno della loro tradizione facendosi promotrici di una sua visione «diversa» che risponda alle loro esigenze specifiche di giovani musulmane protagoniste di una mediazione tra culture. La questione è stata sollevata da Renata Pepicelli, esperta di islam: «Dove stanno andando le nuove generazioni di donne che “fanno” femminismo pur non riconoscendosi in nessuna delle categorie di femminismo esistenti? Oggi ci sarebbe bisogno di uno “sforzo” maggiore soprattutto da parte delle seconde generazioni in Occidente, troppo chiuse dentro storie individuali. C’è bisogno che ci propongano una visione che non sia solo testimonianza, per ricostruire insieme le categorie del femminismo». Ci auguriamo di poter assistere quanto prima all’emergere di nuove proposte e che diventino esse stesse l’oggetto di una riflessione condivisa e a più mani. marzo 2015 le rubriche confronti NOTE DAL MARGINE Giovanni Franzoni La questione dell’autorità della Tradizione, sottoposta alle Scritture, ha posto in antichità e ancora pone, dal Concilio Vaticano II ad oggi, diversi problemi. Le conseguenze di un approccio storico-critico alle tradizioni. Un piccolo consiglio, ripreso dai «luoghi teologici» del teologo spagnolo cinquecentesco Melchior Cano. Gli spazi della tradizione ella prima sessione del Concilio Vaticano II fu calda la discussione sulle fonti della rivelazione; la commissione aveva preparato un testo in cui le fonti della rivelazione erano due – la Sacra Scrittura e la Tradizione – ma questa impostazione fu fortemente criticata soprattutto dai vescovi del nord Europa sensibili alla teologia protestante. E, finalmente, la costituzione Dei Verbum parla di un’unica divina fonte della Rivelazione, dalla quale sgorgano la Sacra Scrittura e, alla sua luce, la Tradizione, il cui ruolo l’ala conservatrice del Concilio riuscì peraltro a sottolineare fortemente. Poi, negli anni post-conciliari la funzione equilibratrice della Tradizione, insieme al magistero papale ed episcopale, è stata ulteriormente ribadita, ed è diventata prassi un’interpretazione cauta, monca e limitata dei generi letterari usati nelle Scritture. Recentemente si è fatto sempre più strada il metodo storico-critico nello studio delle Sacre Scritture e anche in opere non canoniche, come la Didaché, venerate per la loro antichità. Il rigore di questo metodo ha costretto gli esegeti a constatare che fra i primi scritti canonici, come per esempio le Lettere di Paolo – ai Tessalonicesi, ai Corinzi, ai Romani, ai Filippesi – e gli Evangeli databili tra gli anni Settanta e Novanta e al Vangelo di Giovanni, collocabile nei primi anni del II secolo, si sono formate delle tradizioni e delle memorie assai diverse della predicazione di Gesù e della rappresentazione della sua famiglia, di Maria e dei suoi fratelli, ma tutte rispettabili. Di conseguenza, se alcune tradizioni sono da considerare eliminabili in seguito ad una lettura storico-critica, non si può negare che abbiano comunque un loro valore, utile per la fedele sequela di Gesù. Quanto poi alle ulteriori tradizioni, anch’esse diversificate, che hanno nutrito il cammino delle Chiese durante i secoli, bisognerà cercare di distinguere ciò che nasce da una verace ricerca dell’Evangelo e ciò che deriva da falsificazioni attuate per interessi N 40 politici o di gestione autoritaria del potere. Purtroppo talora le Chiese hanno soffocato – considerandole aberranti, eretiche o scismatiche – voci che, invece, potevano e dovevano arricchire i cammini di fede. Mi sembra perciò utile ricordare la distinzione dei luoghi teologici – passibile naturalmente di diversa formulazione – proposti alla fine del Cinquecento dal teologo spagnolo Melchior Cano: «Il primo luogo è l’autorità della Sacra Scrittura che contiene i libri canonici. Il secondo è l’autorità della tradizione di Cristo e quella degli Apostoli, le quali, anche se non furono scritte sono arrivate fino a noi come da udito a udito, in modo che con tutta verità si possono chiamare come oracoli di viva voce. Il terzo è l’autorità della Chiesa cattolica [intendendo con essa la “Grande Chiesa” durata fino allo scisma reciproco del 1054 tra Oriente e Occidente]. Il quarto è l’autorità dei Concili, in modo speciale i Concili generali, nei quali risiede l’autorità della Chiesa cattolica. Il quinto è l’autorità della Chiesa romana, che per privilegio divino è e si chiama apostolica. Il sesto è l’autorità dei santi padri. Il settimo è l’autorità dei teologi scolastici, [legati all’insegnamento di Tommaso d’Aquino]... L’ottavo è la ragione naturale, molto conosciuta in tutte le scienze che si studiano attraverso la luce naturale. Il nono è l’autorità dei filosofi che seguono come guida la natura. Tra questi senza dubbio si trovano i giuristi (giureconsulti dell’autorità civile), i quali professano anche la vera filosofia. Il decimo e ultimo è l’autorità della storia umana, tanto quella scritta dagli autori degni di credito come quella trasmessa di generazione in generazione, non superstiziosamente o come racconti di vecchiette, ma in modo serio e coerente». Questa ricerca di percorsi, diversi ma compatibili, potrebbe calmare nella Chiesa romana i turbamenti sorti, a quanto si constata, fra i cattolici tradizionalisti turbati dalle innovazioni nella prassi pastorale introdotte da papa Francesco. marzo 2015 le rubriche confronti OSSERVATORIO SULLE FEDI Antonio Delrio Nel corso della storia uomini e istituzioni si sono arrogati il diritto di parlare e agire «in nome di Dio» e le religioni di considerare sante le guerre combattute «in nome di Dio». L’attuale connubio fra nome di Dio e violenza non ha nulla di nuovo rispetto ai passati modelli di guerra santa se non che i portatori di questa estrema violenza «in nome di Dio» siano terroristi. In ogni caso non possiamo che considerare colpevoli anche di violare la parola «non nominare il nome di Dio invano» coloro che uccidono esseri umani con la pretesa di agire e di farlo «in nome di Dio». Non nominate il nome di Dio invano! i fronte ai recenti episodi di terrorismo, di brutali uccisioni e finanche di guerre, perpetrati «in nome di Dio», sia credenti che non, non possiamo non interrogarci – anche nel rinnovato interesse per il decalogo, le dieci parole o comandamenti – se non ci si trovi di fronte a una blasfema pretesa e ad una palese violazione della parola «Non nominare il nome di Dio invano». Il nome di Dio a cui si fa riferimento nella Bibbia è il Tetragramma – JHWH, che compare più di 6.000 volte nell’Antico Testamento a partire da Genesi 2,4 – e nel significato della terza parola è incluso il divieto dell’uso superstizioso di questo nome, come pure la bestemmia, il falso giuramento e la strumentalizzazione del nome di Dio, ad esempio utilizzandolo quale legittimazione del potere umano. Eppure, nel corso della storia, uomini e istituzioni si sono arrogati il diritto di parlare e agire «in nome di Dio». Guerre e paci, giuramenti e rivoluzioni, fondazioni e rifondazioni: tutto si è spesso preteso di fare «in nome di Dio», comprese le reciproche strumentalizzazioni fra istituzioni politiche ed ecclesiastiche, e le ipocrite alleanze fra potere politico e religioso, fino al punto di vedere re e governanti dirsi «cristianissimi» e papi definire i dittatori «uomini della provvidenza». Ma che anche il cristianesimo abbia conosciuto la guerra santa non può negarsi: in ambito cristiano-cattolico «santa» non è stata considerata solo la guerra ordinata direttamente da Dio – come quella veterotestamentaria – ma anche quella proclamata dalle autorità ecclesiastiche in nome di Dio contro gli eretici, considerati bestemmiatori che usano il nome di Dio per mentire. Nella lotta contro gli eretici è stato arruolato pure il potere politico e così il nome di Dio è stato utilizzato come bandiera di verità e di autorità sia dalla Chiesa che dallo Stato; e questo anche in ambito protestante, come ha dimostrato anche il rogo di Serveto nella Ginevra di Calvino. Poi, all’inizio dell’era moderna, la guerra santa interna – la guerra «in nome di Dio» – si è trasformata nelle guerre civili di D 41 religione: le stragi e le violenze che, sempre «in nome di Dio», hanno insanguinato per ben più di un secolo l’Europa cristiana. Benché l’epoca moderna abbia tentato di neutralizzare questo tipo di guerra attraverso l’interiorizzazione della religione e la trasformazione politica della sovranità dello Stato, la crociata è rimasta un modello di guerra, e il nome di Dio è stato utilizzato come bandiera per legittimare e giustificare molte altre guerre: da quelle europee contro i turchi alla guerra civile spagnola. L’attuale connubio fra nome di Dio e violenza non ha quindi nulla di nuovo rispetto ai passati modelli di guerra santa. Le novità sono forse la frequenza con cui il nome di Dio viene associato alla violenza, il carattere estremo di questa violenza e il fatto che i portatori di questa violenza «in nome di Dio» siano terroristi. Agli occhi del terrorista tutti i nemici sono dichiarati «ingiusti» e perciò colpevoli, nessuno è innocente. Il nome di Dio contrapposto al nome di Satana serve perciò a fornire una giustificazione religiosa dell’azione terroristica, e serve a tradurre e amplificare le istanze e le questioni materiali che la motivano: il riscatto da un’umiliazione radicale che toglie il senso alla vita è possibile solo reinterpretando questa esperienza negativa in chiave religiosa fornendo un nuovo senso anche alla morte, trasformandola così da sconfitta davanti a un potere soverchiante in martirio. L’uso del nome di Dio serve insomma a terrorizzare i nemici e ad assicurare a se stessi che il corso della storia non è nelle mani degli oppressori, che è possibile un’altra lettura delle cose del mondo, e che la punizione e l’uccisione dei nemici non è altro che la realizzazione, ora, del giudizio di Dio nella guerra universale contro il Male. In ogni caso, benché la questione abbia risposte diverse e opposte a seconda dei punti di vista, non possiamo che considerare colpevoli anche di violare la parola «non nominare il nome di Dio invano» coloro che uccidono esseri umani con la pretesa di agire e di farlo «in nome di Dio». marzo 2015 le rubriche confronti CIBO E RELIGIONI Marisa Iannucci Halal (lecito) è qualsiasi cosa o azione consentita secondo la legge islamica. Il termine designa non solo cibo e bevande ma anche tutti gli aspetti della vita quotidiana, che la Shari’a divide in cinque categorie: obbligatorio, raccomandato, lecito, riprovevole e proibito; esse definiscono la moralità dell’agire umano nell’islam. In generale vale il principio che è lecito tutto ciò che non è proibito dalla Shari’a. La macellazione rituale tiene conto del rapporto tra uomo e animale sacralizzandone l’uccisione, e dando ad essa un carattere solenne e non ordinario e banale. Alimentazione halal: i precetti dell’islam nche i precetti alimentari si inseriscono in comportamenti e in uno stile di vita che regolano le azioni e le relazioni del credente rispetto a se stesso, agli altri esseri umani e al resto del creato (mu’amalat). Insieme agli atti di culto (‘ibadat, che attengono al rapporto tra uomo e Dio) costituiscono la pratica religiosa del musulmano. I versetti del Corano in cui vengono menzionati gli alimenti sono molti, e sono il riferimento – insieme agli hadith del Profeta Muhammad – su cui si è sviluppata la giurisprudenza e la tradizione relativa all’alimentazione halal. Tra tutti citiamo la Sura II:173: «In verità, vi sono state vietate le bestie morte, il sangue, la carne di porco e quella su cui sia stato invocato altro nome, che quello di Iddio. E chi vi sarà costretto, senza desiderio o intenzione, non farà peccato. Iddio è perdonatore, misericordioso». Il Corano ha introdotto il divieto delle carni suine e delle altre carni se non macellate ritualmente, da cui si è sviluppato un quadro più complesso di prescrizioni alimentari note come halal in parte simili alla tradizione ebraica del khasher, derivata dalla Torah. La macellazione rituale infatti interessa entrambe le religioni, e il Corano ha stabilito per i musulmani la liceità delle carni macellate dalla Gente del Libro (cristiani ed ebrei) purché coerenti con le norme religiose (Corano, V:5: «Oggi vi sono permesse le cose buone e vi è lecito anche il cibo di coloro ai quali è stata data la Scrittura, e il vostro cibo è lecito a loro (...)». L’operazione è accompagnata da benedizioni e invocazioni nel nome di Dio, e in particolare dalla frase Bismillah, Allahu akbar (nel nome di Iddio, Iddio è grande). La macellazione rituale non mira solo a eliminare il sangue dalla carne, ma riporta l’attenzione sull’importante aspetto della legittimità dell’uccisione di un animale ai fini dell’alimentazione umana. Nella società industriale la macellazione – come l’allevamento – è stata spersonalizzata e organizzata secondo procedure dettate da esigenze di tipo economico e produttivo. La macellazione rituale tiene conto del rapporto tra uomo A 42 e animale sacralizzandone l’uccisione, e dando ad essa un carattere solenne e non ordinario e banale come avviene nelle catene industriali, ove si perde la consapevolezza del gesto che dà la morte ad un essere vivente, seppure al solo scopo di cibarsene. Il precetto ha quindi anche lo scopo di ricordare all’essere umano che egli non dispone arbitrariamente degli animali ma se ne può servire all’interno di un orizzonte di senso che ha come riferimento Dio e la sua Legge. Nel versetto citato e in altri è ricordata la condizione di chi, trovandosi nell’impossibilità di assolvere il precetto, debba nutrirsi diversamente. È il caso dei musulmani che, vivendo in paesi a maggioranza non islamica, si trovino ricoverati in ospedale o in stato di detenzione. Sura XVI:115: «(...) Quanto a colui che vi sia costretto senza essere né ribelle, né trasgressore, in verità Iddio è perdonatore, misericordioso». Un altro divieto alimentare è quello relativo al vino, nella Shari’a esteso a tutte le sostanze inebrianti a base di alcool e non, comprese le droghe. In generale qualsiasi sostanza che ottunde e toglie lucidità, e danneggia il corpo provocando malattie è illecita. Il divieto del vino, gradualmente introdotto dal Corano, vi si trova in forma definitiva in V:90-91: «In verità col vino e il gioco d'azzardo, Satana vuole seminare inimicizia e odio tra di voi e allontanarvi dal Ricordo di Iddio e dall’orazione. Ve ne asterrete? I prodotti haram (illeciti, come il maiale o l’alcool) non possono essere prodotti, acquistati o venduti e donati, né trasportati o serviti. Secondo la giurisprudenza islamica il cibo per essere halal, oltre a non essere tra quelli proibiti, deve essere acquistato in maniera legale (non attraverso il furto o la frode). Inoltre vi è un altro aspetto legato al cibo che è il generale divieto dell’eccesso (sia nel praticare il digiuno che nel cibarsi troppo), riconducibile al principio islamico della wasatiyya (moderazione). In Corano VII:31 leggiamo: «O Figli di Adamo, abbigliatevi prima di ogni orazione. Mangiate e bevete, ma senza eccessi, ché Iddio non ama chi eccede». marzo 2015 le rubriche confronti SPIGOLATURE D’EUROPA Adriano Gizzi Il 22 e 29 marzo la Francia affronta un importante voto amministrativo e il clima di solidarietà nazionale che si era creato dopo gli attentati di Parigi è ormai alle spalle. Dopo un momento di difficoltà, il Front national sembra aver recuperato lo slancio che lo aveva portato ad essere il primo partito alle europee dell’anno scorso e pare intenzionato a ripetere il successo anche in questa tornata elettorale. La vie en rose di Marine Le Pen opo gli attentati terroristici di Parigi, erano in molti a temere un’ulteriore impennata del Front national in Francia. In realtà la sua leader ha giocato piuttosto male le proprie carte, proponendo maldestramente un referendum sulla pena di morte. La ghigliottina è stata abolita nel 1981 dal presidente Mitterrand che, appena eletto, ha avuto il coraggio di andare contro l’opinione della maggioranza dei francesi. Oggi prevalgono di misura i contrari, anche se nell’elettorato del Fn la situazione è ben diversa. Ma la strategia che Marine Le Pen persegue con successo da quattro anni consiste nel far dimenticare di essere figlia di Jean-Marie, per poter conquistare così l’elettorato più moderato: una scelta «identitaria», da estrema destra, senz’altro non giova alla causa. E infatti il clima da «union sacrée» seguito agli attentati – ben sfruttato dal presidente Hollande per recuperare un po’ di consensi – ha prodotto l’esclusione del Front national dalla grande manifestazione dell’11 gennaio, dove si è vista tutta la classe politica francese repubblicana, dai post-gollisti ai comunisti, sfilare compatta in nome della libertà di espressione e contro il terrorismo. Il concetto di «fronte repubblicano» somiglia a quello che in Italia, per decenni, è stato il cosiddetto «arco costituzionale» in contrapposizione al Movimento sociale italiano. Quel partito non solo non aveva votato la Costituzione (infatti il 2 giugno del ’46, quando assieme al referendum su monarchia o repubblica si votò per l’Assemblea costituente, il Msi non era ancora stato fondato), ma per molti era «anti-costituzionale», poiché di fatto violava la XII disposizione finale della Costituzione (che vieta la riorganizzazione, «sotto qualsiasi forma», del partito fascista) e la legge Scelba del ’52, che ne dava attuazione introducendo il reato di «apologia del fascismo». Ciononostante, i tentativi di mettere fuorilegge il Msi sono sempre falliti e quel partito ha attraversato indenne tutta la prima repubblica, sfiorando addirittura i tre milioni di voti nelle elezioni del 1972. D 43 In Francia la situazione è diversa, perché il Front national è stato isolato e demonizzato da tutti i partiti francesi per decenni. Questo però gli ha fruttato elettoralmente: molti lo considerano l’unica vera alternativa alla «consorteria destra-sinistra». Quando alle presidenziali del 2002 il fiasco del candidato socialista Jospin porta al ballottaggio Jean-Marie Le Pen, la Francia si mobilita in un sussulto repubblicano che vede milioni di persone in piazza. Nel ballottaggio le sinistre – senza esitazione – danno indicazione di voto per Chirac, che viene rieletto con l’82%. Oggi però tutto è cambiato: nelle elezioni europee Marine Le Pen ha fatto diventare il Fn primo partito (con il 25%) e secondo un sondaggio Tns Sofres un terzo dei francesi ne condivide le opinioni. Ma soprattutto la strategia del «fronte repubblicano» sembra ormai affossata per la defezione di gran parte del partito di centro-destra, l’Ump. Molti elettori di sinistra preferiscono ancora andare a votare per un candidato dell’Ump pur di non far vincere un candidato del Front national. Ma l’elettorato dell’Ump invece non solo non va a votare per il candidato socialista in funzione anti-Fn, ma in molti casi vota direttamente quello del Fn. Lo confermano le analisi dei flussi elettorali: l’8 febbraio, nelle elezioni suppletive in una circoscrizione del Doubs dove il candidato dell’Ump non era riuscito ad accedere al secondo turno, la metà dell’elettorato Ump ha riversato i propri voti sulla candidata del Fn, che alla fine ha perso solo per un soffio. Un quarto degli elettori Ump ha seguito la linea del leader Sarkozy (quella del «né Fn né Ps») e un altro quarto la linea del fronte repubblicano, sostenuta ancora dall’ex premier Alain Juppé (che si appresta a contendere a Sarkozy la candidatura Ump alle presidenziali del 2017) e dalla numero due del partito, Nathalie Kosciusko-Morizet. Il 22 e 29 marzo si vota per elezioni dipartimentali e, data la grande confusione sotto il cielo politico francese, la situazione è eccellente per il Front national di Marine Le Pen. marzo 2015 le rubriche confronti OPINIONE Giuliano Ligabue Nel primo anniversario del governo Renzi, il 22 gennaio, si è tenuto un evento nazionale sul tema della scuola organizzato dal Pd, con la partecipazione del presidente del Consiglio e della ministra dell’Istruzione Stefania Giannini. Il messaggio che con questo appuntamento il governo intendeva lanciare è semplice: l’Italia sta cambiando perché è la scuola che sta cambiando. Ma è davvero così? Scuola: sbagliare meglio o scorso 3 febbraio, davanti al Parlamento, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato al Paese che garantire la Costituzione significa, prima di ogni altra cosa, «garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi in una scuola moderna, in ambienti sicuri». Scuola moderna e sicura. Venti giorni dopo, a Roma, la ministra dell’Istruzione pubblica, Stefania Giannini, e il capo del governo, Matteo Renzi, si trovavano insieme all’evento nazionale con cui il Partito democratico – partito di governo, a un anno esatto dalla sua investitura (22 febbraio) – intendeva proclamare ai quattro venti che l’Italia stava cambiando perché è la scuola che sta cambiando. Ma l’evento non andava molto più in là d’una kermesse, con qualche richiamo di «azzurro»: video e slides, musichette, giovanili e informali presentatori; ai due lati, giovanissimi orchestrali dell’Accademia di Santa Cecilia. E, in tre ore, un fiume di interventi in un mare di parole. Non una riga di quel documento, che tutti ci si attendeva e su cui si voleva ragionare e valutare, tutti. Solo l’annuncio del premier che avremmo avuto «un doppio atto normativo in settimana» (a fine febbraio, quindi). Ma cosa ci si aspettava? Certamente qualcosa di più puntuale, un qualche contenuto più concreto che non fosse l’elencazione di titoli e capitoli – gli stessi – delle 130 pagine de «La buona scuola». Così sulla sicurezza delle scuole non è stato del tutto rasserenante sentirsi dire che sono stati «aperti» 7.700 cantieri su 43.220 edifici scolastici, che una nuova fonte di finanziamento potrà forse essere l’utilizzo del 5xmille, che bisognerà far uscire i Comuni dal patto di stabilità. Ma è soprattutto sulla scuola moderna – «la scuola dal ‘900 al terzo millennio», secondo l’enfasi della Giannini – che ci si doveva dire di più: come formare i docenti e promuoverli a motore di cambiamento; quale organico funzionale e come attuarlo; i criteri, ma anche e soprattutto i limiti, del finanziamento dei privati. Non va sottaciuto che in alcuni interventi hanno trovato una giusta sottoli- L 44 neatura argomenti come l’assunzione dei docenti («dal prossimo anno solo per concorso», Davide Faraone), la fine del precariato, l’autonomia scolastica, il merito e la valutazione dei docenti, l’immissione di nuove discipline, la dispersione scolastica, l’inclusione e l’integrazione, l’educazione alla legalità. E, quasi sopra gli altri, due argomenti: l’alternanza scuola/lavoro nelle scuole superiori, per formare la persona più che per formare al lavoro; la scuola digitale, come nuovo ambiente e nuova organizzazione della didattica. Ma sempre e solo argomenti enunciati e in termini già noti, o poco più. Poi, il problema dei tempi. Gli atti legislativi «saranno licenziati tutti entro settembre», dice Renzi. Ed è un altro rinvio. E perché il cambiamento sia concluso? Otto anni, dice la Giannini, ragionando così: «Per realizzare l’autostrada del sole, abbiamo impiegato quattro anni. Per un’impresa come questa, ne occorreranno almeno il doppio». Non è risultato ben chiaro ai presenti il perché di un’autostrada, come termine di paragone. Qualcosa di più ha saputo comunicare Luigi Berlinguer – l’ottantatreenne, d’una spanna più giovane dei compagni rottamatori – sulla volontà di cambiare («Ho il cuore aperto alla speranza») questa nostra «scuola senz’arte né parte», logocentrica e frustrante, in direzione d’una scuola in cui stiano insieme modernità, fatica e piacere. Un applauso fragoroso, per minuti. Neppure le contestazioni sono mancate, gridate in faccia a Renzi da docenti delusi e rabbiosi. La risposta è arrivata sulla voce, altrettanto robusta e categorica: la democrazia non è soltanto ascoltare, parlare e discutere; la democrazia è poter contare, quindi potere alla fine decidere. Va detto che, verso la fine dei suoi 45 minuti di intervento, Renzi ha usato il termine «tentativo», riferendosi alla messa in campo della sua riforma della scuola. Anzi, quasi a mettere le mani avanti, scherzosamente, ha citato il Gianni Rodari del «sbagliando, si inventa». E sia, signor premier e signora ministra, purché si cerchi di sbagliare meglio. marzo 2015 le rubriche LIBRO Gianni Manghetti «Lacrime asciutte» Cantagalli 2014 192 pagine, 14 euro Marcella Felici I protagonisti di questo racconto sono le famiglie più povere di un paese della Toscana nel difficile periodo del dopoguerra. Il duro lavoro e le fatiche quotidiane per tirare avanti sono ovviamente centrali nella vita dei personaggi. Ma lo sguardo attento dell’autore si concentra sulle donne e sul loro modo di stare al mondo, di guardare alla realtà, di comunicare i sentimenti anche con gli sguardi e i silenzi. confronti Le donne che si parlano in silenzio « acrime asciutte» racconta di un paese della Toscana, tra la prima e la fine della seconda guerra mondiale, e delle donne della sua comunità. Una narrazione che, per la condizione sociale dei protagonisti – gli abitanti dei «Casalini», i più miseri del paese – assume un innegabile valore documentario ed è la testimonianza di un mondo che la modernizzazione degli anni Cinquanta ha poi spazzato via, nel bene e nel male. Molti gli elementi significativi: la battaglia continua per il sostentamento della famiglia, con gli uomini «a portare a casa» e le donne «a mettere insieme pranzo e cena», sempre responsabili in prima persona di quello che si troverà nel piatto; i mestieri antichi come lo stagnaro e lo spaccapietre, con l’emergere di una coscienza di classe nei primi, pochi operai; le disgrazie e le malattie, sempre senza rimedio, sempre devastanti per l’intero nucleo familiare. Tutto questo nella cornice della «grande» storia: il referendum del giugno 1946 e il voto alle donne; la riforma agraria e l’Ente maremma; le nuove industrie e il piano Fanfani per la casa. Tutte occasioni dall’impatto imprevedibile, più perturbante che risolutivo. Fin qui il libro come documento. Il testo è, però, molto altro. Nella prima pagina si presenta il narratore: è uno dei bambini di allora, uno degli ormai pochi testimoni del faticoso e dolente vivere delle donne dei «Casalini», che sente in modo imperativo il compito di trasformare quelle antiche esistenze in «frammenti vivi», sente il bisogno di farle risorgere nella scrittura La scelta di parlare dal versante femminile, indicata già nel sottotitolo («le donne piangono dentro»), è opzione originaria e costitutiva del testo, non solo perché le donne sono protagoniste – ogni capitolo ha per titolo il nome di una di esse – ma perché è il loro modo di stare al mondo, è la Necessità che le piega, sono le risposte con cui le fanno fronte, che costituiscono il tema continuo della narrazione. La forte motivazione etica a fare memoria si converte, nella scrittura, in uno sguardo d’amore: le impressioni e i ricordi L 45 del bambino alimentano la consapevolezza dello scrittore adulto e gli permettono di rivisitare dal di dentro questo mondo di donne, portando alla luce una molteplicità di piani, la verità di emozioni e momenti. I dolori e la fatica che occupano la loro vita hanno asciugato parole e nascosto lacrime: non c’è spazio per piangere, né per dire e chiedere, perché tutto, delle altre e di sé, è già conosciuto da ognuna di loro. Allora basta anche uno sguardo che sembra vuoto, degli occhi di uno spento colore grigio topo – ma che, a volte, si dice siano stati anche azzurri – per ricordarsi di quante pene è carica da sempre quella vita; o basta chiamarsi solo per nome incontrandosi – saluto, presenza, accettazione di una comunità di pena – per attivare una profonda comunicazione di sentimenti. È proprio su quest’economia di espressione che lavora la scrittura, trovando nel non detto dei silenzi e degli sguardi, in immagini fugaci come «il sorriso più svelto del filo dell’acqua», la dimensione espressiva della pietosa complicità che lega la vita e la storia di queste donne. Aver trovato la voce interna, con cui esse hanno imparato ad esprimersi e a vivere la relazione tra loro, è il primo pregio del testo. Accanto a questa lingua del dolore, l’autore dà luce alla capacità delle donne dei Casalini di pensare oltre il dato fermo della realtà. Se per gli uomini ci sono solo i bisogni primari da soddisfare, in esse vive, malgrado tutto, la tensione alla ricerca di condizioni meno degradate, con una qualche aspirazione al bello, non fosse altro che la foto di un attore appesa al muro. La possibilità di immaginare, un atteggiamento desiderante, l’autore li coglie soprattutto nelle giovani donne, le figlie, che anche davanti o dentro una tragedia mantengono guizzi di curiosità per la vita e una sensualità non negata. In questi elementi ci sembra di poter riconoscere l’autentica dimensione letteraria di un testo che con una certa facilità avrebbe potuto scivolare nel cliché di un affettuoso e nostalgico ricordo di tempi e luoghi lontani. le rubriche marzo 2015 confronti SEGNALAZIONI Don Olivo Bolzon Marisa Restello, «Il dono dell’amicizia», Studio editoriale Carlo Silvano, Villorba, Treviso, 2014, 112 pagine, 10 euro. Alessandra Bozzoli, Maria Merelli, Maria Grazia Ruggerini (a cura di), «Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschile contro le donne: modelli culturali di intervento», Ediesse 2013, 448 pagine, 20 euro. Don Olivo Bolzon e Marisa Restello «Il dono dell’amicizia» Bozzoli, Merelli, Ruggerini «Il lato oscuro degli uomini» Potrebbe sembrare generico, il titolo del volumetto; ma esso si illumina nel sottotitolo – «Vita in comune e dono del celibato» – che non è una riflessione, a tavolino, del tema trattato, ma la descrizione di un’esperienza reale. Don Olivo – trevigiano, classe 1932 – da giovane prete, impegnato nel sociale, incontra Marisa, anch’essa dedita alla difesa dei diritti degli operai. Tra i due nasce una profonda consonanza di ideali che si arricchisce di un’amicizia perdurante, che tale rimane, senza mai sfociare, come in teoria sarebbe potuto accadere, in innamoramento e poi in convivenza o matrimonio. Marisa, del resto, è legata alla Fraternità di Charles de Foucauld e Olivo approfondirà i suoi legami con i preti operai francesi, tanto più dopo che, per ordine dei superiori, sarà inviato in Belgio come assistente europeo delle Acli. Poi il vescovo di Treviso lo richiamerà in patria, per mandarlo come parroco a San Floriano, una piccola frazione di Castelfranco Veneto. E Marisa, che già era stata per un certo tempo con lui, andrà anch’essa a vivere nella canonica, dando una mano nelle attività della piccola comunità locale. Non mancano le «male lingue» di qualche fedele, ma infine la gente accetta quella singolare situazione e, anzi, la considera un’alta testimonianza, anche perché la casa parrocchiale è aperta e ospitale per tutti, e soprattutto per gli extracomunitari. Il libro – scritto a quattro mani, parte da Olivo e parte da Marisa, distintamente: così si individua come i due protagonisti hanno vissuto e vivono la loro storia – è ricco di osservazioni, aneddoti, valutazioni che, in controluce, inquadrano la loro esistenza nella più ampia cornice dell’Italia e della Chiesa romana, con le luci e le ombre del post-Concilio. Ma, soprattutto, è testimonianza di una realtà al tempo stesso umile e straordinaria. E inevitabile sorge il desiderio, per chi non conoscesse Marisa ed Olivo, di andarli a trovare. E – lo assicuriamo – sarebbe per loro, e per l’ospite, una gioia straordinaria. Scrive Olivo, in una delle poesie che concludono il volume: «Vagando e vagando / raccogliendo e raccogliendo / senza direzioni, / ma fissi all’orizzonte / abbiamo esplorato oceani / dentro alle nostre vite». Quali sono le possibilità e i modelli di intervento per contrastare la violenza contro le donne? Questo il quesito principale che affronta il volume, raccogliendo saggi di autrici e autori che riportano l’esperienza di centri antiviolenza in Italia e nel mondo, contestualizzando tali esperienze nel differente ambiente legislativo dei paesi presi in considerazione. Oltre a ciò, vengono prese in considerazione riflessioni sullo sbilanciamento dei rapporti fra donne e uomini suggerito e supportato dalla società patriarcale, ma anche modelli di trattamento degli uomini autori di violenza in strutture sia in campo sanitario, sia nel contesto carcerario, sia nell’ambito dei centri di ascolto e consultori per uomini. In appendice, oltre ad una mappatura dei centri per uomini maltrattanti, il volume contiene un’analisi della legge 119 del 2013 in materia di contrasto della violenza di genere. Quel che emerge dal volume è che l’attenzione sulla violenza contro le donne è spesso limitata ad interventi di supporto alle donne oggetto della violenza stessa. La «questione maschile» è rimasta, invece, pressoché inesplorata, eccezion fatta per il progressivo inasprimento delle norme repressive nei confronti degli uomini maltrattanti. Sebbene provvedimenti di questo tipo siano necessari per contrastare il fenomeno e per fornire strumenti di difesa alle donne maltrattate, di fatto, non mettono in discussione i modelli culturali messi in essere dalla società patriarcale. Ciò fa sì che gli uomini maltrattanti vengano percepiti sempre come un’eccezione e non come espressione di un’inquietudine maschile diffusa. Ma, si evince nella lettura del libro, il quadro di intervento sta lentamente modificandosi, focalizzandosi sempre di più sulle responsabilità maschili e sulle possibilità di attuare un cambiamento delle dinamiche interne e di percezione relazionale in coloro che commettono violenza. In questo nuovo quadro, l’uomo che commette violenza, spesso una persona che è stata a sua volta vittima di violenza e che vive ed agisce in uno stato di disagio e sofferenza, deve essere supportato (oltre a dover pagare le conseguenze legali delle proprie azioni) in un percorso che lo aiuti ad uscire definitivamente da una condizione di violenza. Luigi Sandri Michele Lipori 46 CONFRONTI 3/MARZO 2015 abbonamento 2015: 50 euro 80 euro abbonamento sostenitore con in omaggio il dossier «Minareti e dialogo» e inoltre uno dei libri qui sotto P.Naso, A.Passarelli, T.Pispisa (a cura di) Fratelli e sorelle di Jerry Masslo Letizia Tomassone Guy Delisle Figlie di Agar Cronache di Gerusalemme Claudiana Effatà Rizzoli Lizard PROPOSTE DI ABBONAMENTO CUMULATIVO Confronti + Adista 104 euro Confronti + Africa 67 euro Confronti + Cem/Mondialità 67 euro Confronti + Dharma 70 euro Confronti + Esodo 67 euro Confronti + Riforma 109 euro Confronti + Gioventù Evangelica 68 euro Confronti + Lettera Internazionale 73 euro Confronti + Missione Oggi 67 euro Confronti + Mosaico di pace 69 euro Confronti + Qol 57 euro Confronti + Servitium 80 euro Confronti + Tempi di Fraternità 69 euro Confronti + Testimonianze 82 euro Confronti mensile di fede, politica, vita quotidiana Abbonamenti annuale: ordinario 50,00 euro, sostenitore 80,00 euro (con omaggio), estero 80,00 euro. Una copia arretrata 8,00 euro. ABBONAMENTO «UNDER 30» 25,00 EURO. Versamenti su c.c.p. 61288007 intestato a coop. Com Nuovi tempi, via Firenze 38, 00184 Roma; vaglia postale appoggiato sull’ufficio postale di Roma 13; bonifico bancario Iban: IT64Z0558403200000000048990. Per gli abbonamenti è attivo anche il sito www.rivisteonline-arco.net edizioni com nuovi tempi - marzo 2015 - chiusura di redazione: 24 febbraio 2015 Confronti: direzione, amministrazione e redazione: via Firenze 38, 00184 Roma, 06 4820503 (fax 06 4827901); www.confronti.net; [email protected] Fotolito e stampa: Tipocrom - C.S.C. grafica - via A. Meucci 28 - 00012 Guidonia (Roma). Foto di copertina: Andrea Sabbadini (andreasabbadini.photoshelter.com) I dati forniti dagli abbonati vengono utilizzati esclusivamente per l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi. (Legge 675/96) 2015 Associato alla Unione Stampa Periodica Italiana pubblicità per richiedere il dossier, al costo di 5 euro, telefonare allo 064820503 o inviare una mail ad [email protected]
Scarica