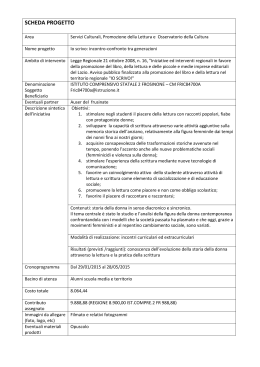L’oggetto del godimento, l’oggetto del piacere∗ Pietro Kobau «Che cosa è che si desidera quando si gode? Che tutto ciò che ci circonda non si occupi che di noi, non pensi che a noi, non abbia cura che di noi. Se gli oggetti che ci servono godono, eccoli per conseguenza occupati ben più di se stessi che di noi e il nostro piacere di conseguenza ne scapita»1 . Questa argomentazione di Sade, volta a giustificare (naturalisticamente e, insieme, moralisticamente) un’economia del dominio finalizzata alla massimizzazione del piacere, appare immediatamente reggersi su due presupposti. Il primo: provare piacere è identico a godere di qualcosa – ciò che appunto fonda un’economia di scambio fra oggetti, parallela rispetto all’economia dei sentimenti che per quelli si provano. Il secondo: provare piacere è l’opposto del provare dolore, vi si contrappone cioè, in ultima analisi, quantitativamente – per cui è possibile giocare uno scambio di dare e avere sensazioni piacevoli e spiacevoli, calcolandone in anticipo il bilancio affettivo. L’argomentazione di Sade è controvertibile secondo strategie diverse. Una di queste, ossia quella che verrà adottata nelle pagine che seguono, sceglie di collocarsi innanzitutto fuori dal piano moralistico (ovvero economico) previsto da Sade, restringendosi a quello naturalistico, che sarà rappresentato in prima istanza dalla filosofia della mente2 . Su questo piano, infatti, spicca in piena evidenza la centralità di un presupposto che pertiene alla psicologia popolare3 , secondo cui il ∗ Questo saggio è stato presentato al convegno La via dell’emozione, organizzato da Maddalena Mazzocut-Mis e Gianfranco Mormino, e svoltosi presso l’Università degli Studi di Milano il 5 maggio 2005. 1 D.A.F. De Sade, La Philosophie dans le Boudoir ou les Instituteurs immoraux (1795), tr. it. di V. Finzi Ghisi, La filosofia nel boudoir, in Id., Opere, a cura di P. Caruso, “Prefazione” di A. Moravia, Mondatori, Milano 1992, pp. 23-237. 2 Aderendo alle indicazioni metodologico-disciplinari avanzate da M. Di Francesco, in Id., Introduzione alla filosofia della mente (1996), Carocci, Roma 20022 , pp. 24-31. 3 Riconoscendo la distinzione tra “psicologia ingenua” e “psicologia popolare” rispettivamente intese come «la capacità, universalmente condivisa dagli esseri umani adulti, di spiegare e prevede- c 2005 ITINERA (http://www.filosofia.unimi.it/itinera) Copyright Il contenuto di queste pagine è protetto dalle leggi sul copyright e dalle disposizioni dei trattati internazionali. Il titolo e i copyright relativi alle pagine sono di proprietà di ITINERA. Le pagine possono essere riprodotte e utilizzate liberamente dagli studenti, dagli istituti di ricerca, scolastici e universitari afferenti ai Ministeri della Pubblica Istruzione e dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per scopi istituzionali, non a fine di lucro. Ogni altro utilizzo o riproduzione (ivi incluse, ma non limitatamente a, le riproduzioni a mezzo stampa, su supporti magnetici o su reti di calcolatori) in toto o in parte è vietato, se non esplicitamente autorizzato per iscritto, a priori, da parte di ITINERA. In ogni caso questa nota di copyright non deve essere rimossa e deve essere riportata anche in utilizzi parziali. ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura piacere e il dolore (sia fisici, sia mentali) vanno intesi come sensazioni collocate agli estremi di un continuo al cui centro si dà “indifferenza”4 . Scelta tale strategia, si tratterà, dunque, di smentire Sade, sostenendo in particolare due tesi. La prima: quelli che chiamiamo propriamente sentimenti (e, innanzitutto, il piacere e il dolore) non possono venire intesi semplicemente nei termini di un “sentire qualcosa”. La seconda: tra quelli che possono venire definiti come i due fenomeni affettivi elementari, cioè il provare piacere e il provare dispiacere, va riconosciuta una dissimmetria – una dissimmetria di ruolo, capace di metterne in questione le illustrazioni tradizionalmente fenomenologiche. L’educazione sentimentale di Drella La filosofia di Andy Warhol è uno strano libro autobiografico. Si presenta come una collezione di aneddoti e aforismi che, presi tutti insieme, non fanno una storia, ma valgono unicamente a illustrare la vita saggia e felice – perché uniformemente piacevole e virtualmente prolungabile all’infinito – di un anaffettivo. Al primo capitolo del libretto, però, con un distacco dagli esiti vagamente comici più che ironici, Warhol racconta davvero una storia; e se non è proprio vera, è almeno più normale del suo seguito. La trama della catastrofe biografica iniziale è questa: un ragazzo che ha dei problemi causati dalla sua eccessiva sensibilità viene guarito con una sola seduta psichiatrica. Il medico, in effetti, non gli prescrive terapie, ma, più radicalmente, smentisce la sua convinzione di avere dei problemi. La vera terapia per rendersi affettivamente impermeabili ai problemi altrui, se mai di terapia si tratta, viene trovata dallo stesso protagonista. Dal momento che sentivo di assorbire i problemi della gente, andai da uno psichiatra nel Greenwich Village e gli raccontai tutto di me. Gli raccontai la storia della mia vita e come non avessi un problema veramente mio e come mi facessi i problemi degli amici, ed egli mi disse che mi avrebbe richiamato per fissare un altro appuntamento per poterci parlare ancora un po’, e da allora non mi ha più richiamato. [. . . ] Di ritorno dallo psichiatra mi fermai da Macy e per la depressione mi comprai il mio primo televisore, un RCA bianco e nero da 19 pollici. Me lo portai a casa [. . . ] ed immediatamente mi scordai di tutto ciò che riguardava lo psichiatra. Tenevo continuamente re il comportamento di se stessi o altrui attribuendo stati mentali» (C. Meini, Psicologia ingenua. Una teoria evolutiva, McGraw-Hill, Milano 2001, p. XI) e un’estensione di tale capacità che includa una qualche «teoria dei caratteri e la comprensione del ruolo della volizione per la formazione e la modificazione delle credenze» (ibid., p. 9), a tale distinzione ne sovrapporremo un’altra. Le considereremo, cioè, come distinte quanto al loro probabile statuto di capacità sviluppata su basi biologiche innate e, rispettivamente, di estensione di tale capacità sviluppata su basi culturali. Inoltre, in ciò che segue, l’uso di “comune” o “corrente” riferito a cognizioni o teorie psicologiche sufficientemente condivise lascerà indeciso il riferirsi all’una o all’altra nei casi dubbi. 4 Cfr. M. Aydede, “An Analysis of Pleasure vis-à-vis Pain”, Philosophy and Phenomenological Research, n. 61, 2000, pp. 537-70. 2 ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura accesa la TV, specialmente mentre la gente mi contava dei suoi problemi che non mi colpivano più, con la televisione accesa. Era una specie di magia.5 Il mago-terapeuta agisce non agendo; è invece Warhol che, trovato il primo espediente per smettere di agire mosso dal proprio disagio, si ritrova facilmente su una strada lungo la quale non avrà più altro desiderio se non quello di perfezionare la sua prima trovata, già risolutiva. Acquistato il suo primo televisore, smette di subire dolorosamente l’intimità altrui; acquistato il suo primo registratore a nastro, allorché cessa ogni sua vita emotiva, è addirittura in grado di sposarsi6 e, come si dice, di campare contento. Al di là di ogni impressione di normalità o bizzarria, ciò che rende comunque plausibile e attraente questa storia – lo si proverà ad argomentare meglio tra poco – è una dissimmetria: mentre la sofferenza iniziale, il disagio, il primo movente biografico subito spento da Warhol, aveva una sorta di oggetto (e forse più di uno), il piacere diffuso e senza perché della sua vita adulta (e poi senile, come attestano i titoli dei capitoli immediatamente successivi al primo) si vuole presentare, e con successo, come privo di causa e di contenuto, e (soprattutto) ingiudicabile. E la dissimmetria che qui ci tocca è duplice: vige tra lo stato di un prima e quello di un poi biografico, disegna cioè una cesura, un’azione e un evento vitale; e vige tra una condizione mentale retta da un’economia di affetti legati ad oggetti che muovono all’azione e una condizione perfettamente liberata da ogni simile economia. Ma al di là della sua persuasività, o meno, e forse contro le sue intenzioni, il Bildungsroman di Warhol presenta due zone d’ombra che vale la pena di chiarire. Si vuol dire, in primo luogo, l’iniziale sofferenza del protagonista, circa la quale si vorrebbe sapere meglio che cosa davvero sentisse, quando pativa nel suo “assorbire i problemi della gente”; e poi il suo finale piacere, o godimento diffuso – che non si sa bene come definire, anche una volta compreso che non si tratta di anedonia mascherata, né (tantomeno) di atarassia. Soffrire Le parole, come si vede, qui non mancano, specie se si chiede soccorso al gergo psichiatrico: ma non è detto che questo aiuti a chiarire le cose. Di più: in linea 5 A. Warhol, The Philosophy of Andy Warhol (From A to B and Back Again) (1975), tr. it. di R. Ponte e F. Ferretti, La filosofia di Andy Warhol, Costa & Nolan, Genova-Milano 1983, p. 26). 6 «Quando ho avuto la mia prima TV, ho smesso di tenerci tanto ad avere rapporti stretti con gli altri. Sono stato ferito tanto, quanto può essere ferito solo chi ci tiene tanto. [. . . ] Cominciò così verso la fine degli anni Cinquanta la mia storia con la televisione, una storia che dura ancora oggi, che ne ho quattro in camera con cui giocare contemporaneamente. Ma non mi sono sposato fino al 1964, quando mi sono preso il primo registratore. [. . . ] L’acquisto del registratore ha posto fine a qualsiasi tipo di vita emotiva potessi avere, ma sono contento che sia andata così. Niente era più un problema, perché l’unico problema poteva essere quello di avere un buon nastro, e quando l’unico problema è un buon nastro, non è più un problema.» (A. Warhol, La filosofia di Andy Warhol, cit., pp. 28-29). 3 ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura generale, ogni indagine lessicografica su termini riferiti a emozioni, sentimenti, affetti, anche ristretta alle principali lingue europee nel loro uso scientifico, registrerà subito la difficoltà di una loro sistemazione, rafforzata facilmente dal dubbio che tale difficoltà non dipenda solo dalla complessità dei fatti linguistici, ma più radicalmente dalla diversità dei campi culturali cui i campi semantici si sovrappongono. Una possibile via d’uscita è quella indicata dai vari suggerimenti a rompere quello che anche qui si presenta come un “circolo ermeneutico”7 affrontando il tema sotteso a parole così problematiche liberi dalla «dipendenza da ogni linguaggio naturale in quanto origine delle ‘intuizioni di senso comune’», ancorando invece l’analisi di tali parole «a concetti umani universali e alla loro ‘grammatica universale’»8 , i quali risulterebbero indagabili utilizzando metodi empirici. Si tratta certo di una soluzione attraente – ma solo finché non si considera quale problematicità affligga proprio i contesti disciplinari che, con buoni motivi, muovono da un’assunzione positiva circa il darsi di universali umani. In particolare, nella filosofia della mente, ossia nella disciplina che qui si intende assumere come polo di riferimento strategico, l’individuazione di simili universali, non potendosi appoggiare per via diretta a metodi empirici, quella che poteva apparire una soluzione rischia di ridiventare un problema. Dunque, se di fronte allo strano caso della sofferenza del giovane Warhol ci si vuole chiedere innanzitutto che genere di cosa sia – al di là delle parole – quel dolore, non rimane che prendere una via intermedia. Ai nostri scopi basterà allora richiamarsi a una elementare (e forse rudimentale) classificazione «ontologica [sic]» sviluppata «sulla base di criteri linguistici [sic]»9 dei fenomeni del sentire10 come è quella offerta da Ricken. Tale classificazione riesce, intanto, a rendere una qualche giustizia alle nostre concezioni psicologiche correnti, distinguendo 7 Cfr. A. Wierzbicka, Emotions across Languages and Cultures. Diversity and Universals, Cambridge University Press, Cambridge-Paris 1999, p. 7. 8 Ibid., p. 35. 9 F. Ricken, “Emotion, Affect”, in H. Burkhardt, B. Smith (a cura di), Handbook of Metaphysics and Ontology, Philosophia, München 1991, vol. I, pp. 237-238. 10 Benché l’articolo di Ricken sia intitolato Emotion, Affect, e benché voglia in primo luogo riferirsi “etimologicamente” alla pathe aristotelica (De an. 403a, 26), si è preferito parlare qui di “sentire” per introdurre un termine italiano ugualmente sovraordinato a quelli che designano i quattro tipi di “affetto” riconosciuti dall’autore. Questo, sia per aderire il più possibile alla lingua italiana corrente, sia considerando che Aristotele, più esattamente, considera pathe tes psyches ogni stato o condizione (exeis) dell’anima (De an. 402a, 9) e, inoltre, ogni moto dell’animo, originato sia dall’anima stessa, sia dal corpo (Eth. Nic. X, 2, 1173b, 9). Il significato di “sentire”, insomma, pare raccogliere abbastanza bene i diversi sensi della pathe aristotelica – senza tuttavia indirizzare in modo affrettato verso un’identificazione tra “passioni” e “stati qualitativi” ovvero “qualia”. (Tale identificazione è tuttavia esplicitamente accettata da alcuni autori: «Credo si possa accettare questo punto di vista. La domanda di Nagel [. . . ]: Cosa si prova a essere un pipistrello?, sempre che se ne ammetta la sensatezza, andrebbe interpretata come: Cosa si patisce a essere un pipistrello?» (S. Gozzano, “Ipotesi sulla metafisica delle passioni”, in T. Magri (a cura di), Filosofia ed emozioni, Feltrinelli, Milano 1999, p. 16). La domanda cui si fa riferimento, che ammette varie traduzioni in italiano, è il celebre titolo di T. Nagel, “What Is It Like to Be a Bat?”, Philosophical Review, n. 88, 1974, pp. 435-450, tr. it. “Com’è essere un pipistrello?”, in A. De Palma, G. Pareti (a cura di), Mente e corpo. Dai dilemmi della filosofia alle ipotesi della neuroscienza, Bollati Boringhieri, Milano 2004, pp. 164-180). 4 ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura all’interno di una classe comune le seguenti quattro entità mentali: “percezioni (perceptions)”, dove il sentire sarebbe riferito a un contenuto conoscitivo11 ; “sensazioni (sensations) in senso stretto”, come sarebbero ad es. i dolori, che a differenza delle percezioni non avrebbero un proprio oggetto; “sentimenti (feelings) in senso stretto”, che andrebbero intesi come un “sentirsi”, ossia avrebbero come riferimento “oggettuale” peculiare la condizione del senziente-parlante; “emozioni (emotions)”, che a differenza delle sensazioni e dei sentimenti in senso stretto avrebbero un oggetto. Ora, però, se la si mette alla prova e ci si chiede in che modo potrebbe venire classificata la sofferenza di cui parla Warhol – come una sorta di percezione, o sensazione, o sentimento, o emozione –, questa tassonomia mette in luce le proprie debolezze12 . E, in primo luogo, nella sua tendenza a ridurre ogni fatto relativo al sentire al paradigma della percezione (ma su ciò torneremo presto), questa tassonomia, basandosi sul criterio della differenza tra i contenuti ovvero gli oggetti del sentire, presenta una curiosa incapacità di distinguere tra percezioni ed emozioni, che appaiono entrambe “avere” un oggetto. Ora, è certamente vero che alcune teorie delle emozioni le intendono alla stregua di percezioni di peculiari proprietà oggettive13 – ma non si possono ignorare le difficoltà a cui vanno incontro, specie nel loro urtare con le nostre concezioni psicologiche comuni, dove risulta intuitivo che “avere un oggetto” deve significare qualcosa di ben diverso nel caso di una percezione e nel caso di un’emozione14 . Tra le teorie psicologiche che, invece, intendono salvare tale intuizione, van11 Interpretiamo Ricken in tal senso poiché questi parla delle percezioni in quanto riferite o a un loro “oggetto immediato” o a un “oggetto” inteso come riferimento di una “that-clause”. Circa un necessario contenuto conoscitivo ovvero un necessario contenuto proposizionale delle percezioni il dibattito attuale è comunque assai aperto (per una panoramica aggiornata cfr. T. Crane, The Problem of Perception [2005], in SEPh; S. Siegel, The Contents of Perception [2005], in SEPh). Cfr. anche T. Crane, “The origins of qualia”, in T. Crane, S. Patterson (a cura di), The History of the Mind-Body Problem, Routledge, London 2000, pp. 169-195. 12 A parte l’obiezione che sta per venire mossa, e oltre a ciò che si è accennato nella nota precedente, va almeno aggiunto che non è affatto chiaro in quale senso la classificazione “ontologica” proposta da Ricken risulterebbe disegnata “sulla base di criteri linguistici”. Forse, si vuol dire che i criteri grammaticali propri di una lingua naturale dovrebbero fungere da criteri epistemici – come mostra il caso dei “sentimenti in senso stretto”, i quali per l’autore sarebbero caratterizzati in primo luogo dal venire espressi mediante costruzioni riflessivo-avverbiali, come è ad es. per «I feel. . . ». Tralasciamo di dimostrare la facile controvertibilità di una simile impostazione. 13 Non mancano qui referenti storici, né distanti (Shaftesbury, Hutcheson, Hume. . . ), né prossimi (Scheler, Meinong. . . ); per una ripresa contemporanea di tale impostazione cfr. C. Tappolet, “Irrational Emotions”, in D. Weinstock (a cura di), Perspectives on Irrationality, University of Toronto Press, Toronto 2005 (in corso di pubblicazione, URL: http://www.philo.umontreal.ca/ textes/Tappolet_Irrationality.pdf). 14 Per un ampio sviluppo critico di tale opinione, cfr. classicamente J.R.S. Wilson, Emotion and Object, Cambridge University Press, Cambridge 1972; si osservi, ancora, la centralità assunta dal problema dell’individuazione di un oggetto dell’emozione per tutti e cinque gli approcci definitori elencati in C. Calhoun, R.C. Solomon, “What is an Emotion?”, in Idd. (a cura di), Classical Readings in Philosophical Psychology, Oxford University Press, New York-Oxford 1984, p. 8, che (nell’ordine) tendono a trattarla (più o meno riduzionisticamente) come una peculiare sensazione, un evento o processo fisiologico, un tipo di comportamento, un atto di valutazione, un processo cognitivo. 5 ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura no perciò seriamente considerate quelle che prevedono una caratterizzazione delle emozioni come eventi o processi mentali compositi, ossia come costituite almeno da una componente cognitiva (provvista di un correlato oggettuale, ad es. percettivo) e da una componente non cognitiva, rispetto a cui pare affatto problematico individuare un preciso correlato oggettuale. La teoria di Oatley, ad es., prevede per le emozioni il concorso di due distinti momenti o fattori. Il primo è considerato il “nucleo” di ogni emozione e viene definito come «uno stato mentale di preparazione all’azione, oppure un cambiamento nella preparazione»15 di essa; si tratta, cioè, di un atto valutativo riferito a un oggetto che non necessariamente si realizzerebbe a livello conscio. Ancora sottostante a esso, però, viene individuata una “funzione” che Oatley decide di chiamare “tonalità fenomenologica”; ed è tale tonalità affettiva cosciente che ci permette di distinguere fra le nostre diverse emozioni: «Ogni emozione può essere tipicamente sentita come diversa da un’emozione contrastante e diversa dalle non-emozioni. La tristezza è diversa sia dalla felicità sia dal ragionamento deduttivo o dalla sonnolenza»16 . Non è difficile ritrovare tale distinzione in altri modelli psicologici più o meno analoghi, compresi quelli che si premurano di ancorarsi a dati neurofisiologici, tentando così di risolvere meglio il problema di definire la funzione di questa “seconda componente” delle emozioni – sia essa considerata come una “tonalità fenomenologica”, oppure come un “marcatore somatico”17 . In ogni caso, per una filosofia della mente risulta difficile dare conto di simili fenomeni, già sul piano descrittivo, ma eminentemente su quello ontologico, dove emergono innumerevoli impedimenti a trattarli (per usare una terminologia quasi desueta) come rappresentazioni genuine. E, questo, risulta tanto più grave per i modelli che si vorrebbero denominare cartesiano-fenomenologici (denunciando già con questa formula quali ne sarebbero i principali esponenti storici), dove il problema della “seconda componente” delle emozioni finisce per cadere nella più ampia famiglia di problemi riguardanti l’esistenza e lo statuto dei “qualia”, ossia degli aspetti essenzialmente «fenomenici della nostra vita mentale» che risultano «accessibili per introspezio15 K. Oatley, Best Laid Schemes. The Psychology of Emotions (1992), tr. it. di R. Carrera, S. Falchero e M. Monaci, Psicologia ed emozioni, “Introduzione” e cura di V. D’Urso, Il Mulino, Bologna 1997, p. 78. 16 Ibid., pp. 78-79. 17 I tentativi di integrazione della teoria di A.R. Damasio, Descartes’ error: Emotion, reason and the human brain (1994), tr. it. di F. Macaluso, L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, Adelphi, Milano 1995, entro opportune teorie della decisione pongono un forte accento sul fatto che secondo tale teoria peculiari sensazioni fisiche (piacevoli o spiacevoli, innanzitutto) interverrebbero a “marcare” (positivamente o negativamente) le rappresentazioni dei risultati delle nostre azioni (prevedibili o simulabili), intervenendo dunque “dall’esterno” su un processo cognitivo di tipo decisionale altrimenti autonomo, e “sbilanciandolo” in maniera non necessariamente “irrazionale” (cfr. ad es. A. Barnes, P. Thagard, “Emotional Decisions”, in G.W. Cottrell (a cura di), Proceedings of the Eighteenth Annual Conference of the Cognitive Science Society, Erlbaum, Hillsdale (NJ) 1996, pp. 426-429). A ogni modo, se questo è vero, al di là del maggiore dettaglio sul piano cognitivo e neurofisiologico, sembra di trovarsi dinanzi a una riedizione del modello motivazionale del De anima cui si accennerà più sotto – ciò che lascia ancora aperte le questioni metafisiche di cui si vuole qui discorrere. 6 ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura ne»18 . Ancor peggio: una volta riconosciuto il darsi di simili aspetti, i relativi problemi19 riguardano non solo la componente propriamente “affettiva” e non “cognitiva” delle emozioni, ma tutte e quattro le classi di entità mentali in cui per Ricken, come si è visto, si suddivide il sentire, nella misura in cui possono venire disancorati da un correlato extramentale caratterizzabile come un loro oggetto20 . Data tale situazione, allora, si comprende come non avvenga per motivi di “semplice” efficacia retorica che nella filosofia della mente di impostazione analitica si ravvisi un uso quasi sistematico del caso del dolore fisico per trattare i problemi relativi ai “qualia”, ovvero all’“esperienza in prima persona”. Pare intuitivo, infatti, che una volta risolto il dubbio circa la riducibilità a un “quale” del candidato più promettente, ossia le “sensazioni” intese come affatto prive di “oggetto”, la soluzione apparirà più vicina anche per gli altri tipi di sentire classificati da Ricken. (Ed è altrettanto intuitivo che risolvere tale questione sia cruciale per poter mantenere in piedi o, viceversa, per far cadere le concezioni comuni del piacere e del dolore incentrate sulla loro caratterizzazione di sensazioni “contrapposte”). Particolarmente esplicito nel mettere in luce la vera posta in gioco di tali discussioni è Crane21 , quando la individua nella validità, o meno, della “tesi di Brentano” secondo cui tutti e soltanto i fenomeni mentali manifesterebbero il carattere dell’intenzionalità. Tale tesi, infatti, pare ovviamente falsa per coloro che accettano l’esistenza di stati ed eventi mentali non-intenzionali accanto a quelli intenzionali, e i migliori candidati a tale ruolo di controesempio paiono appunto i fenomeni mentali «puramente ‘qualitativi’ – [. . . ] di cui le sensazioni (come sono i dolori) sono gli esempi più comunemente citati», insieme alle «emozioni» e agli «stati d’animo (mood), come l’angoscia (undirected anxiety)»22 . Strategicamente, in ogni caso, è 18 M. Tye, Qualia (1997), in SEPh. Tye precisa efficacemente che, una volta definiti nel modo che si è visto, è difficile negare il darsi di “qualia”; ciò che invece pare necessario (e arduo) chiarire è «quali stati mentali abbiano dei qualia, se i qualia siano qualità intrinseche o estrinseche dei loro portatori, e in che modo i qualia si relazionino con il mondo fisico, sia quello interno, sia quello esterno alla testa»; per tutti questi motivi, inoltre, lo statuto dei “qualia” viene vivacemente discusso per il suo ruolo nella comprensione della natura della coscienza (M. Tye, Qualia [1997], cit.). 20 Tye elenca così gli stati mentali normalmente candidati al possesso di “qualia”: «(1) Esperienze percettive, ad es. le esperienze del vedere un colore rosso, udire forti squilli di tromba, gustare della liquirizia, odorare l’aria marina, maneggiare un brandello di pelliccia. (2) Sensazioni corporee, ad es. avvertire una fitta di dolore, sentire solletico, avere fame, avere mal di stomaco, avere caldo, avere le vertigini. Qui, si pensi anche ad esperienze come quelle che si hanno nell’orgasmo, o nel correre sino a sfiancarsi. (3) Reazioni avvertite, ovvero passioni, ovvero emozioni, ad es. provare piacere, forte desiderio, timore, amore, afflizione, gelosia, rimpianto. (4) Stati d’animo, ad es. sentirsi esaltati, depressi, calmi, annoiati, tesi, miserabili.» (ibid.). 21 T. Crane, “Intentionality as the mark of the mental”, in A. O’Hear (a cura di), Current Issues in Philosophy of Mind, Cambridge University Press, Cambridge 1998, pp. 229-251. 22 Ibid. p. 230. A smentire la tesi di Brentano varrebbero anche i casi dei fenomeni non mentali che esibiscono intenzionalità, come ad es. il fototropismo positivo delle piante (cfr. ibid, pp. 230-231). Ma l’intera posta in gioco è ancora più rilevante: ne va, infatti, di decidere se il contrassegno del mentale sia primariamente quello dell’intenzionalità, oppure quello del carattere cosciente dell’esperienza, com’è ad es. per un autore come Searle (J. Searle, Intentionality, Cambridge University Press, Cambridge 1983, tr. it. di A. Barbieri, Della intenzionalità. Un saggio di filosofia della conoscenza, 19 7 ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura decisivo l’atteggiamento da assumere in tale disputa rispetto a due criteri orientativi fondamentali e strettamente intercorrelati, ossia quello dell’analisi linguistica dei fenomeni in questione e – soprattutto – quello dell’armonizzazione con la nostra psicologia ingenua. In tale prospettiva, Crane apre uno dei suoi scritti più recenti e maturi dedicati al tema che qui interessa fingendo di dovere innanzitutto convertire un neofita della filosofia della mente, il quale opporrebbe resistenza all’idea che anche il dolore “fisico” sia propriamente uno stato mentale, alla stessa stregua, cioè, della «sofferenza mentale (che viene normalmente intesa come una sorta di sofferenza emotiva)»23 . Ai nostri scopi, dell’argomentazione che qui segue importa, più che l’esito favorevole alla tesi dell’esperto, e persino al di là del suo raccogliere implicitamente la sofferenza fisica e quella mentale sotto un unico termine comune, la strategia di fondo. Crane, infatti, contrasta con misura le concezioni del neofita, scommettendo sulla possibilità che queste ultime siano in grado di autocorreggersi, in quanto già conterrebbero le basi di un’accettabile equazione fra coscienza e intenzionalità degli stati mentali, grazie a cui risulta poi possibile descrivere adeguatamente il fenomeno del soffrire24 . Tutto ciò che chiede all’ingenuo è di non confondere Bompiani, Milano 1985), di cui appunto Crane discute qui i controesempi (cfr. Crane, “Intentionality as the mark of the mental”, cit., pp. 250-251). Per una panoramica del dibattito sul rapporto tra fenomeno della coscienza e intenzionalità degli stati mentali, cfr. P. Carruthers, Higher-Order Theories of Consciousness (2001), in SEPh; C. Siewert, Consciousness and Intentionality (2002), in SEPh; W. Lycan, Representational Theories of Consciousness (2004), in SEPh; R. Van Gulick, Consciousness (2004), in SEPh. 23 T. Crane, “The Intentional Structure of Consciousness”, in A. Jokic, Q. Smith (a cura di), Consciousness: New Philosophical Perspectives, Oxford University Press, Oxford-New York 2003, p. 33. 24 Si noti quanto diversamente viene trattata l’opinione psicologica corrente sulla natura del dolore in un saggio di Dennett (D.C. Dennett, Why You Can’t Make a Computer that Feels Pain [1978], tr. it. di L. Colasanti, “Perché non si può costruire un calcolatore che sente dolore”, in Id., Brainstorms. Saggi filosofici sulla mente e la psicologia, Adelphi, Milano 1991, pp. 299-350 e 514-22), dove si afferma che essa conterrebbe due nuclei teorici differenti e inconciliabili – tesi utile, a sua volta, per sostenere che è impossibile costruire un computer capace di simulare (in senso proprio) il dolore. Tale opinione comune sarebbe cioè affetta da un’ambiguità che ricorda da vicino la duplicità delle emozioni già incontrata nel modello di Oatley. Per sostenerlo, fra l’altro, Dennett prende in esame il caso ipotetico di un paziente sottoposto ad anestesia locale dal proprio dentista e poi interrogato sul suo successo. Il paziente, viene osservato, potrebbe rispondere in due maniere diverse: «(1) Il trattamento ha funzionato: il dolore che mi provoca la trapanazione [. . . ] è intenso come sempre, però ora posso sopportarlo meglio. [. . . ] (2) Il trattamento ha funzionato: la trapanazione [. . . ] non mi fa più così male; il dolore è molto meno forte» (ibid., p. 341). Nella prima risposta il paziente si riferirebbe al proprio dolore percepito in senso cognitivo, nella seconda no. Alle due espressioni, dunque, corrisponderebbero due teorie del dolore che Dennett rende rispettivamente esplicite così: «(1) avere dolore non è un mero presentarsi di stimoli, ma una ricezione interpretata, una percezione che è influenzata da molti fattori cognitivi e volitivi precedenti [. . . ] (2) Per chi soffre, nulla è più ‘intuitivo’ dell’idea contraria: c’è ben poco di cognitivo nel dolore: quello che si vuole evitare non è semplicemente una specie indesiderata di percezioni; il dolore è lì, presenza bruta, non analizzabile, indipendente, in aggiunta allo stato di coscienza, o percettivo, o epistemico» (ibid., p. 344). Ma per Dennett non ci sarebbe modo di qualificare l’una come più corretta dell’altra: le nostre concezioni comuni relative a che cosa sia il dolore non formerebbero infatti un sistema coerente, e quindi non saremmo in grado di fornire su tali basi alcuna vera teoria del dolore. Una posizione nettamente 8 ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura l’oggetto dello stato mentale, in quanto intenzionale, con lo stato stesso25 – per poi procedere a una revisione dell’idea di oggetto che fa da sostegno alle opinioni correnti secondo cui le sensazioni (e, paradigmaticamente, quelle di sofferenza) ne sarebbero prive. Tale strategia è sviluppata con il massimo dettaglio in un altro lavoro dello stesso autore, nel passaggio cruciale dove questi si impegna nuovamente a dimostrare il carattere intenzionale del dolore26 . Il cuore delle sue argomentazioni – volte a difendere una versione forte dell’intenzionalismo che escluda la necessità dell’introduzione dei “qualia” per rendere interamente conto del fenomeno della coscienza in maniera compatibile con le nostre concezioni psicologiche correnti – si configura come la negazione della tesi di Searle27 secondo cui «i dolori non sono intenzionali perché non rappresentano nulla al di là di se stessi»28 . Crane attacca infatti questa tesi, per così dire, aggirandola: non tenta cioè di fornire una caratterizzazione in positivo dell’oggetto intenzionale del dolore in quanto oggetto (rispondente, magari, a una concezione popolare di quest’ultimo), bensì fornisce una precisazione del significato di “localizzazione” che, utilizzata nell’analisi del caso problematico del dolore, renderebbe possibile affermare che anche il dolore ha comunque un “oggetto” – nel senso che ogni dolore (anche nel caso limite dell’arto fantasma) deve avere una localizzazione almeno apparente e avvertita29 . La tesi suona curiosamente consonante con la dottrina kantiana secondo cui ogni “oggetto” che può darsi nell’esperienza di un soggetto è sempre un fenomeno esteticamente (ossia spazio-temporalmente) collocato; e su questo ritorneremo. Ora, tuttavia, è più urgente sottolineare come per Crane, più in generale, anche per “i dolori e le altre sensazioni” in quanto stati mentali possano sempre essere distinti, oltre al loro soggetto, un oggetto e un “modo” intenzionali30 – senza dover eliminativistica rispetto al problema dei “qualia” è stata presa di lì a poco in D.C. Dennett, Quining Qualia, tr. it. Quainare i qualia (versione 1985), in A. De Palma, G. Pareti (a cura di), Mente e corpo. Dai dilemmi della filosofia alle ipotesi della neuroscienza, Bollati Boringhieri, Milano 2004, pp. 189-233. 25 «Il dolore è uno stato di coscienza, ovvero un evento nella coscienza e, a prescindere dal fatto che tutti gli stati mentali siano coscienti, o meno, è incontrovertibile che solo le menti, ovvero gli stati mentali, sono coscienti. Ma l’opinione ingenua ci dice forse qualcosa sul concetto di dolore, o sul concetto di mente? Credo di sì. In questo mio scritto fornirò ragioni per pensare che la coscienza sia una forma di intenzionalità, il ‘dirigersi della mente verso i suoi oggetti’. Sosterrò che la coscienza coinvolta nelle sensazioni fisiche come il dolore è costituita dal dirigersi della mente verso la parte o la regione del corpo dove si sente che ha luogo la sensazione [where the sensation feels to be]. Ammesso questo, risulterà meno sorprendente che l’opinione ingenua sul dolore affermi ciò che afferma: la ‘fisicità’ del dolore consegue dal confondere l’oggetto dello stato intenzionale – la parte del corpo in cui viene sentito il dolore – con lo stato del provare dolore.» (T. Crane, “The Intentional Structure of Consciousness”, cit., p. 33). 26 Cfr. T. Crane, Elements of Mind. An Introduction to the Philosophy of Mind (2001), tr. it. di C. Nizzo, Fenomeni mentali. Un’introduzione alla filosofia della mente, R. Cortina, Milano 2003, in particolare pp. 103-150. 27 Cfr. J. Searle, Della intenzionalità, cit. 28 T. Crane, Fenomeni mentali. Un’introduzione alla filosofia della mente, cit., p. 116. 29 Ibid, p. 117. 30 Cfr. ibid., pp. 40-48. Il “modo intenzionale” (formula dichiaratamente ripresa da Searle in Id., 9 ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura concedere alcun ruolo ai “qualia”, richiamandosi in ciò al carattere “trasparente” dell’esperienza in generale31 . Crane, però, non fa dipendere le caratteristiche fenomeniche coscienti di una sensazione dal solo contenuto rappresentazionale del relativo stato mentale. Piuttosto, nella sua “teoria percettiva” della sensazione corporea32 , le fa ugualmente dipendere dal “modo” del sentire33 . Benché centrale nella sua prospettiva, la nozione di “modo intenzionale” patisce tuttavia di una certa vaghezza. E qui il primo problema sarebbe di precisare meglio che cosa si intende per “modo” nel caso del dolore. A questo scopo, Crane procede soprattutto per suggestioni ed esemplificazioni. Ma mentre è relativamente facile suggerire che cosa significhi una differenza di modo intenzionale elencando casi come «la credenza, la speranza», o ancora «il desiderio, il pensiero, l’intenzione, la percezione, l’amore, la paura, il rimpianto, la pietà»34 , risulta più difficile esplicitare e definire esattamente in che cosa consistano in generale tali differenze. In particolare, appoggiarsi sul paradigma offerto dalle differenze tra le modalità sensoriali, come sembra fare Crane, solleva tutta una serie di problemi di lunghissima tradizione filosofica. In tal caso, infatti, compare ad es. il problema (cruciale per la trattazione della sofferenza) dell’impossibilità di individuare un’appropriata modalità sensoriale responsabile di una determinata classe di “percezioni”: e qui non basta suggerire che «mentre alcune proprietà degli oggetti (ad esempio i colori) possono essere colte solo in certi Intentionality, cit.) è detto anche “forma aspettuale” e va inteso come una relazione fra il soggetto e il contenuto del suo stato intenzionale (cfr. ibid.). 31 In una serie di argomentazioni successive a quelle riportate nel precedente capoverso, Crane mira innanzitutto a escludere che, pur in un quadro intenzionalistico, sia necessario ammettere il darsi di “qualia” come proprietà di proprietà che contribuirebbero a caratterizzare una sensazione: «è proprio corretto dire che essere consapevoli di un dolore implica l’essere consapevoli di proprietà di un proprio stato mentale? Il mio dolore alla caviglia sembra aver luogo in una parte di me: sembra che sia la caviglia che mi fa male. Non è che io sia consapevole della collocazione della mia caviglia e (in aggiunta a ciò) senta che tale mia consapevolezza possiede un quale. [. . . ] Piuttosto, la consapevolezza della caviglia sembra essere ipso facto consapevolezza del far male» (ibid., pp. 1245). Così procedendo, Crane sottolinea quindi come la posizione criticata sia perfettamente parallela a quella della teoria intenzionalistica debole della percezione visiva – e sulla base di tale parallelismo la attacca: «Un’obiezione usuale all’idea di qualia della percezione visiva è che quando si presta attenzione alla propria esperienza, “tutto ciò che si trova è il mondo” – per dirla con J.J. Valberg. Se si considera l’essere rosso di un bicchiere di vino, cercando proprietà non intenzionali dell’esperienza, tutto ciò che si trova è un’evidente proprietà del vino: il suo essere rosso. Questo fatto è stato denominato la ‘trasparenza’ dell’esperienza [. . . ]. La mia obiezione alle concezioni intenzionaliste deboli della sensazione è analoga: quando si presta attenzione al proprio dolore, si presta attenzione all’oggetto del proprio dolore, non a caratteristiche dell’esperienza». (ibid., pp. 124-125). 32 Si tratta di una teoria “percettiva” perché «tratta la sensazione corporea come una forma di percezione, la percezione di ciò che avviene nel proprio corpo» (ibid., p. 126). 33 «Prestare attenzione a un dolore significa prestare attenzione alla parte che fa male. Ma non si può farlo senza prestare attenzione al male provato, e il male provato [. . . ] è il modo in cui quella parte o regione del corpo si impone (per così dire) alla nostra attenzione. Dunque, quando siamo consapevoli che la nostra caviglia fa male, siamo consapevoli che fa male a noi stessi. È questa la ragione per cui affermo che, secondo la teoria percettiva, il carattere fenomenico del dolore è dato da due fattori: il contenuto dell’esperienza e il modo intenzionale». (ibid., p. 128) 34 Ibid., p. 46. 10 ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura modi, e perciò non possono comparire nel contenuto di altri modi (non si possono annusare i colori)», altre proprietà «non sono specifiche di certi modi»35 . Tale suggerimento, infatti, può valere per la percezione di proprietà di oggetti la cui caratterizzazione vada oltre la semplice localizzazione: e qui basterà, magari, rifarsi ulteriormente alla veneranda dottrina del sensus communis. Ma la aspecificità con cui si ha a che fare nel caso del dolore (e in particolare nel caso di alcuni dolori fisici) è di tipo diverso: non si tratta di una “semplice” indifferenza rispetto a una modalità sensoriale specifica (come è nel caso classico “colore vs forma”), bensì di una letterale mancanza fenomenica di un senso (fosse pure un sensus communis) a cui riferire una sensazione. Sicché, a meno di introdurre modalità sensoriali ad hoc, occorrerebbe qui fornire una definizione di “modo intenzionale” che abbandonasse il paradigma della differenza tra modalità sensoriali – il che, per il dolore fisico, pare evidentemente problematico. E, se risultasse impossibile, avremmo a che fare con caratteristiche fenomeniche coscienti di una sensazione che sarebbero determinate dal solo contenuto, ovvero mancheremmo di qualificazioni modali adeguate per alcune specie del sentire – caso che sembra verificarsi quando, invece del dolore fisico, tocchi prendere in considerazione il disagio mentale. Lo stato d’animo come arto fantasma Si è già accennato a come l’interpretazione del dolore offerta da Crane aspiri a valere anche nel caso dell’arto fantasma, dove non si ha a che fare con alcun oggetto normalmente inteso, ma dove la localizzazione di ciò che è sentito permetterebbe comunque di parlare di un oggetto percettivo. Ciò non voleva essere indice soltanto del potere descrittivo di questa interpretazione di per se stessa, ma, più in generale, della correttezza della “tesi di Brentano” – la quale, tuttavia, non risulta ancora interamente difesa, anche una volta considerato risolto (nella maniera che si è vista) il caso del dolore fisico. Considerato che al centro del dibattito recente sull’intenzionalità stanno la questione della sua struttura relazionale e quella del suo carattere prospettico36 , rispetto alla prima Crane prende pienamente sul serio l’importanza del problema. In particolare, affronta l’obiezione standard secondo cui mentre «gli stati intenzionali paiono essere relazioni tra chi pensa e gli oggetti dei loro pensieri, questo non può valere in generale, poiché gli stati intenzionali possono essere diretti a cose che non esistono, mentre le relazioni implicano l’esistenza dei loro relati»37 . Rispetto 35 Ibid., p. 126. Cfr. T. Crane, “Intentionality as the mark of the mental”, cit., pp. 423-424. 37 Ibid., p. 244. Cfr. qui la relativa nota 30, dove il problema viene presentato come centrale già per la concezione brentaniana dell’intenzionalità. Cfr. inoltre ibid., pp. 30-40, dove questo è trattato come “il” problema dell’intenzionalità. Di sicuro rilievo per le conseguenze da trarsi nell’ambito dell’estetica è osservare la stretta affinità tra questa problematica e la sottolineatura di Ferraris della “verità” dei sentimenti suscitati dalle opere d’arte, nonché dalle entità fittizie che queste possono rappresentare (M. Ferraris, “L’opera d’arte come fidanzata automatica”, Rivista di estetica (n.s.), n. 26, 2004, pp. 153-170). 36 11 ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura a tale problema generale, Crane riafferma che, alla luce della sua analisi dei casi contrari alla «tesi di Brentano», e innanzitutto di quello del dolore, occorre riaffermare l’inutilità del trattarli come casi di «istanziazione di proprietà monadiche e puramente soggettive», e invece l’opportunità di leggerli come esperienze che comunque «presentano qualcosa – (ad es.) una parte del corpo – come modificata in una certa maniera»38 . In questa loro lettura, dunque, si ha a che fare con «stati di coscienza, e quindi stati apparentemente relazionali»: sarebbero cioè «solo apparentemente relazionali, poiché, alla luce della [mia] teoria percettiva, i fenomeni di arto fantasma (ad es.) sono casi di consapevolezza di una qualità avvertita in una parte del corpo che è solo apparente»39 , in maniera del tutto analoga ai casi di allucinazione percettiva – permettendo così di fare intervenire risolutivamente la nozione di “modo”. Ma se ciò è vero, è possibile accogliere come corretta l’analisi fenomenologica delle emozioni proposta da Sartre40 , poiché anche queste ultime esibirebbero un analogo carattere apparentemente relazionale che chiama in campo la nozione di “modo”: «c’è il soggetto che ha un’esperienza, c’è il mondo (o una cosa nel mondo) che viene esperito e [c’è] il modo particolare di percepire o cogliere (apprehend) il mondo»41 . Per valutare adeguatamente tale suggerimento, occorre ritornare sulla maniera in cui Crane aveva poco prima discusso il caso delle emozioni come preteso esempio contrario alla “teoria di Brentano”. Nel caso di emozioni come “nervosismo, esultanza, angoscia”, infatti, è difficile individuarne un oggetto, come dimostra innanzitutto la difficoltà a nominarlo da parte del soggetto che le prova42 ; né sembra risolutivo il fare coincidere un tale oggetto con la causa di simili stati d’animo43 . Muovendo, allora, dal problema di identificare innanzitutto tali stati affettivi, Crane scarta nuovamente ogni soluzione basata sui “qualia”44 e trova, invece, una via d’uscita in una soluzione intenzionalistica, osservando innanzitutto che una persona (ad es.) angosciata «potrebbe non essere in grado di esprimere a parole per che cosa prova angoscia, ma potrebbe comunque essere in grado di dire come le cose le appaiono nel suo stato»45 . Ciò permette di affermare, riprendendo Sartre, 38 Cfr. T. Crane, “Intentionality as the mark of the mental”, cit., p. 245. Ibid. 40 Cfr. J.-P. Sartre, Esquisse d’une théorie des émotions, Gallimard, Paris 1939. 41 Ibid. 42 Cfr. ibid., p. 238. 43 Cfr. ibid., p. 239. Crane ha qui di mira le teorie secondo cui un fenomeno di tipo affettivo, pur potendosi presentare come non intenzionale a colui che prova il sentimento in questione (cioè come non riferibile ad alcun oggetto a lui adeguatamente noto), può venire comunque sempre interpretato mediante una spiegazione causale. Si pensi al fortunato argomento applicato da Hume al caso dell’orgoglio, cfr. D. Davidson, Hume’s cognitive theory of pride (1976), tr. it. “La teoria cognitiva dell’orgoglio in Hume”, in Id., Azioni ed eventi, il Mulino, Bologna 1992, pp. 365-382; o anche alla nota interpretazione freudiana dell’angoscia. Come una variante limite di tali teorie potrebbe venire considerata quella, radicalmente fisiologistica, di W. James, “What is an Emotion?”, Mind, n. 9, 1884, pp. 188-205 – di cui si ricorda la smentita, su basi ugualmente fisiologiche, già da parte di W. Cannon in Id., Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage, Appleton, New York 1929). 44 Cfr. T. Crane, “Intentionality as the mark of the mental”, cit., pp. 239-241. 45 Ibid., p. 241, corsivo nostro. 39 12 ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura che qui non ne va del cogliere un oggetto (non, almeno, un oggetto “normalmente” inteso e identificato) con cui si intratterrebbe una relazione e, soprattutto, che l’elemento capace di distinguere tra emozioni differenti, e dunque anche tra sentimenti apparentemente privi di oggetto, è il modo in cui «il mondo, e la collocazione del soggetto nel mondo, vengono percepiti o colti (apprehend) nello stato emotivo»46 . Di nuovo, dunque, come nel caso dell’arto fantasma, si ha a che fare con un oggetto intenzionale che non è un oggetto “normale” ma che, tuttavia, almeno appare localizzato – se si vuole, si ha a che fare con un caso limite di localizzazione. E, di nuovo, si fa leva sul ruolo del “modo” del suo apparire per evitare il ricorso ai “qualia” e per consentire una differenziazione tra tipi diversi del sentire cosciente; e, questo, sempre all’interno di una “teoria percettiva”: «nella sensazione viene sentito qualcosa, nell’emozione viene percepito o colto (apprehend) qualcosa – e così via»47 . A questo punto, la teoria del sentire proposta da Crane – per quanto segnata da oscurità, specie nella nozione limite di “localizzazione” impiegata nell’analisi delle emozioni e, più in generale, nella sua nozione di “modo intenzionale” – sembra bene utilizzabile per un’analisi dello strano soffrire del giovane Warhol, e poi dello strano godimento diffuso del Warhol senile. Si sarebbe trattato, in fin dei conti, di un caso umano (se non del tutto normale) perfettamente normalizzabile: Drella avrebbe “percepito” in modo doloroso e poi “piacevole” determinati “oggetti”, ossia “le cose”, ovvero il mondo intero e la propria collocazione in esso. Tuttavia, nemmeno un simile esercizio renderebbe conto dell’intera storia che Warhol ci racconta. Anche se ora saremmo forse meglio indirizzati a dire che cosa e come ha via via sentito il suo protagonista, rimarrebbe da spiegare come mai una volta ci racconta che ha agito in una certa maniera perché sentiva così e così, e un’altra volta che da un certo momento in avanti ha agito provando questo o quello – ossia, rimane da chiarire la cesura biografica, determinata dalla decisiva reazione di Warhol alla seduta psichiatrica, tra un prima e un poi rispettivamente segnati e non più segnati dal soffrire e, infine, da ogni evento propriamente affettivo. Resta, insomma, da spiegare la particolarità del ruolo funzionale che in determinate circostanze viene attribuito o non viene attribuito – al livello della nostra psicologia popolare – al sentire di tipo propriamente affettivo. Da questo punto di vista, benché relativamente povero dal punto di vista dell’analisi fenomenologica rispetto alle argomentazioni di un Crane, un altro aneddoto autobiografico ci porta direttamente al centro del problema. Alcuni anni fa mi trovavo ad assistere a degli esperimenti sul lancio di proiettili. Il mortaio era quasi verticale: la bomba doveva cadere non lontano dal luogo in cui si trovavano gli osservatori che ne stavano rilevando il tempo di ascesa e di caduta. Gli osservatori si compiacevano in tutta tranquillità di seguire la bomba nella sua salita, di rilevare il momento in cui cessava di innalzarsi, di guardarla precipitare; ognuno si curava soltanto di questo oggetto, quando all’improvviso si udì gridare: “Viene su di noi!”. Le idee così 46 47 Ibid., p. 242. Ibid., p. 243. 13 ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura suscitate posero bruscamente fine all’osservazione dell’oggetto: ora ognuno pensava soltanto a se stesso; l’uno correva a dritta, l’altro a manca, cercando di sfuggire al pericolo.48 Questo episodio minimo di vita vissuta, in cui non pare esserci alcun bisogno di nominare i sentimenti provati dagli attori, è riportato da Sulzer a sostegno della propria teoria circa il darsi di due facoltà dell’anima fondamentali e distinte, quella di «rappresentarsi qualcosa [sich etwas vorstellen]» e quella di «sentire [empfinden]». Ciò che qui interessa non è tanto la caratterizzazione – fenomenologica e metafisico-psicologica – degli stati dell’anima cui fanno capo tali facoltà, e in cui quest’ultima rispettivamente conosce «le proprietà delle cose» e si sente «stimolata in maniera piacevole o spiacevole»49 . (Tale caratterizzazione, fra l’altro, potrebbe bene venire riassorbita in un quadro intenzionalistico come è quello di Crane, al solo prezzo di aggiungere al suo elenco di oggetti “non normali”, che già comprendeva gli oggetti “fantasma” e quell’oggetto “totale” che è il “mondo”, anche l’anima che “sente se stessa”.)50 Importa, piuttosto, considerare come per Sulzer l’esercizio dell’attività rappresentativa comporta un’attenzione per le cose conosciute che può accrescersi fino alla totale distrazione rispetto a sé e, soprattutto, non ha alcun ruolo come stimolo all’azione51 . Per contro, nello «stato del sentire», in cui si prova piacere o dispiacere, l’anima ha per oggetto se stessa; e proprio in tale stato hanno luogo quegli «atti involontari dell’anima» tradizionalmente chiamati «passioni»52 i quali sono il vero e unico motore dell’agire. Se si vuole, dunque, neanche di mero sentire si tratta, bensì, più propriamente, di una reazione ad esso che, sola, pare capace di attivare un comportamento. E, se questo è vero, si comincia a intravedere il motivo per cui gli strumenti offerti da una “teoria percettiva” del sentire appaiono insufficienti. Kant e il modello motivazionale Che lo si consideri, o meno, soltanto suggestivo, oppure come portatore di una proposta teorica che merita di venire ascoltata, il modello psicologico di Sulzer 48 J.G. Sulzer, Anmerkungen über den verschiedenen Zustand, worinn sich die Seele bey Ausübung ihrer Hauptvermögen, nämlich des Vermögens, sich etwas vorzustellen und des Vermögens zu empfinden, befindet (1771), tr. it. a cura di P. Kobau, “Note sul diverso stato in cui l’anima si trova nell’esercitare le proprie facoltà principali, ossia quella di rappresentarsi qualcosa e quella di sentire”, Rivista di estetica (n.s.), n. 3, 1996, p. 72. 49 Ibid., p. 67. 50 Per Sulzer, il sentire è del tutto svincolato da un qualsiasi oggetto che propriamente lo causi, anche quando si è propensi a individuare in un oggetto la causa di un sentimento; icasticamente: nello stato del sentire «non sentiamo l’oggetto, bensì noi stessi» (ibid., p. 67). 51 Lo stato del rappresentare, per quanto «favorevole alla ricerca della verità», ha tuttavia per Sulzer «degli inconvenienti peculiari. Finché persiste, siamo incapaci di riflettere su di noi; non ci troviamo stimolati ad alcuna azione che riguardi la nostra persona; l’essere umano diventa un essere astratto che non ha alcun legame con alcuna altra cosa al mondo; ciò che non si lega alla nostra riflessione lo facciamo macchinalmente e senza sapere di farlo; manifestiamo tutti i segni e le caratteristi che tipici dell’ottusità» (ibid., p. 70). 52 Ibid., p. 78. 14 ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura ci interessa in maniera speciale perché aspira a svolgere un ruolo esplicativo del comportamento che non risulta, invece, ugualmente centrale nel modello di tipo cartesiano-fenomenologico fin qui considerato. In quest’ultimo, infatti, appare cruciale la sola considerazione epistemica dell’oggetto dell’esperienza – specie quando tale oggetto viene interpretato alla luce di una “teoria percettiva” à la Crane. Si vuole suggerire, dunque, di considerare la teoria di Sulzer come rappresentativa di una diversa famiglia di modelli psicologici, che potrebbero essere detti motivazionali. Si intende, cioè, etichettare in questa maniera l’insieme dei modelli psicologici di tipo naturalistico entro cui una teoria dell’esperienza, e in particolare la considerazione del fenomeno del sentire, vale innanzitutto a fini esplicativi del comportamento di un organismo53 . Ora, l’avere a che fare con l’uno o con l’altro di questi due modelli è un punto particolarmente delicato per i nostri scopi, giacché i fenomeni mentali del piacere e del dolore reagiscono in modo nettamente diverso a un loro inquadramento nell’uno o nell’altro. Per dimostrarlo, sarebbe tuttavia un’impresa quasi interminabile cercare di mettere alla prova sotto questo profilo una collezione di teorie esemplari etichettate sotto il primo o sotto il secondo titolo. Si cercherà quindi di produrre soltanto un paio di campionature, cominciando con un paio di osservazioni intorno a Kant – autore alle cui spalle Sulzer immediatamente si colloca e che, per altro verso, fornisce un esempio della maniera di trattare il nostro problema che risulterà influente sino a tempi recenti e recentissimi. Per i nostri scopi, importerà allora ricordare essenzialmente come Kant sciolga un doppio equivoco rispetto al significato di “sentire”. Il primo, quello consegnato con maggiore rilievo all’opera critica, è relativo al significato dell’aggettivo “estetico” che normalmente gli si applica e finisce per caratterizzare, all’interno della sfera dell’esperienza, il sentimento propriamente inteso come non conoscitivo e privo, in tal senso, di oggetto. Impostando l’analisi del giudizio estetico, nei paragrafi iniziali della terza Critica Kant ne precisa infatti subito lo statuto soggettivo, rilevando come ogni riferimento delle rappresentazioni può essere oggettivo, perfino quello delle sensazioni [. . . ], escluso solo il riferimento al sentimento del piacere o del dispiacere, con il quale nulla viene designato nell’oggetto, ma nel quale il soggetto sente se stesso secondo il modo in cui è affetto dalla rappresentazione.54 “Oggettivo” e “soggettivo” non si riferiscono qui alle caratteristiche del giudizio (ad es. alla sua possibile validità universale e/o necessaria), bensì proprio al suo tema. Sicché, mentre la prima accezione di questa dicotomia vale piuttosto a di53 Ciò vale anche per il caso limite del comportamento individuato (minimalmente) nella sola espressione delle “emozioni”, come avviene nel celebre studio di Darwin a ciò dedicato. Tale famiglia di modelli, va comunque sottolineato, aspira ad avere un valore intrinseco sul piano psicologico, al di là del sostegno che offre alla prospettiva etica dell’“edonismo normativo” (cfr. A. Moore, Hedonism [2004], in SEPh). 54 I. Kant, Critica della facoltà di giudizio, par. 1. 15 ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura stinguere quelli che al par. 18 dei Prolegomeni sono chiamati “giudizi percettivi”55 dai giudizi di esperienza intesi in senso stretto, la seconda riguarda peculiarmente i giudizi di gusto trattati nella terza Critica in quanto in essi «la rappresentazione viene riferita interamente al soggetto, e cioè al suo sentimento vitale, sotto il nome di sentimento del piacere o del dispiacere»56 . Se si vuole, abbiamo qui a che fare con un’anima che sulzerianamente “sente se stessa”; in ogni caso, questo permette di avanzare la celebre determinazione del carattere “disinteressato” del giudizio estetico, cioè del suo non essere legato «con la rappresentazione dell’esistenza di un oggetto»57 . Questa determinazione (cui paiono fare eco le analisi di Crane), ancora, chiama in gioco la precisazione del carattere del godimento estetico come “compiacimento per il piacevole”: e l’esempio subito addotto chiarisce bene in che senso per Kant si deve parlare di sentimento come sensazione puramente soggettiva: «Il colore verde dei prati compete alla sensazione oggettiva, quale percezione di un oggetto del senso; ma la sua piacevolezza compete alla sensazione soggettiva, con cui non viene rappresentato un oggetto, e cioè al sentimento»58 . Al di là della soluzione terminologica, paiono qui rimanere in sospeso almeno due questioni. La prima: la determinazione negativa del disinteresse proprio del giudizio di gusto coincide davvero interamente con la determinazione positiva della “sensazione soggettiva” incontrata poco sopra, ossia il suo riferimento integrale come rappresentazione al soggetto, ovvero al suo “sentimento vitale”? La seconda: il piacere senza oggetto espresso nel giudizio estetico e, rispettivamente, il godimento sensibile sono due fenomeni mentali radicalmente differenti – e, se sì, sono fra loro anche non comunicanti? Si tratta di questioni che, nel presente contesto, riguardano la legittimità, o meno, di fare rientrare nell’ambito dei giudizi di esperienza i giudizi estetici puri – e che, in ogni caso, portate su un piano psicologico rivelano altre sfaccettature. Dunque, più che la risposta data a tali questioni nella terza Critica, dove il problema di fondo che emerge dopo la prima serie di paragrafi è quello dell’oggettività dei giudizi di gusto (e non quello dell’oggettività del loro tema) 59 , importerà qui un’altra serie di precisazioni kantiane circa il significato del 55 «I giudizi empirici, in quanto hanno una validità oggettiva, sono giudizi di esperienza; ma quelli che sono validi soltanto soggettivamente io li chiamo semplici giudizi percettivi. Questi ultimi non richiedono alcun concetto puro dell’intelletto, ma soltanto la connessione logica delle percezioni in un soggetto pensante.» (Ak IV, p. 298). 56 I. Kant, Critica della facoltà di giudizio, par. 1. 57 Ibid., par. 2. 58 Ibid. 59 Si potrebbe qui individuare uno slittamento nel significato di “esperienza” (ovvero una sua estensione) importato dal compimento del sistema kantiano con la stesura della terza Critica (cfr. I. Kant, “Prefazione”, in Critica della facoltà di giudizio, p. 6, nonché Id., “Introduzione”, in ibid., parr. II e IX) – slittamento o estensione che appaiono ancor più evidenti se, invece del confronto tra la prima e la terza delle Critiche, si istruisce un simile confronto tra i Prolegomeni e la Critica della facoltà di giudizio. Guardando al par. 18 dei Prolegomeni, troviamo infatti che solo nei genuini giudizi di esperienza si ha a che fare con oggetti, essendo questi determinati dal valore universale e necessario dei giudizi che si possono emettere sopra di essi. Al successivo par. 19 Kant precisa inoltre che emettendo un giudizio oggettivo riconosciamo un oggetto «dal valore universale e necessario della connessione fra le percezioni date; e poiché questo è il caso per tutti gli oggetti dei sensi, 16 ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura sentire, che punta alla distinzione strettamente psicologica tra il sentimento (inteso sempre come la facoltà di provare piacere e dispiacere) e la facoltà dell’appetizione. Decidendo a questo punto di seguire il Kant che fornisce le basi specificamente psicologiche della terza Critica60 , troviamo allora innanzitutto che l’aisthesis, già interpretata dai wolffiani come facoltà unitaria, viene tripartita da Kant in una maniera fondamentale – ossia in una maniera che distingue nettamente non solo tra sensazione oggettiva e soggettiva, come si è appena visto, ma anche tra il provare piacere e il tendere a un oggetto come possibile termine del desiderio. Incontriamo così, entro una serie di distinzioni relative alla «facoltà inferiore»61 , la caratterizzazione della «facoltà cognitiva sensibile»62 in quanto prevede l’uso di sensi che si determinano maggiormente in senso oggettivo oppure soggettivo e che, in allora i giudizi di esperienza ricaveranno la loro validità oggettiva non dalla conoscenza immediata dell’oggetto (ciò che è impossibile), bensì soltanto dalla condizione del valore universale dei giudizi empirici: che, come si è già detto, non si fonda mai su condizioni empiriche e in generale sensibili, bensì su un concetto puro dell’intelletto» (Ak IV, pp. 298-299). Ancora: «Tutti i nostri giudizi sono in un primo momento semplici giudizi percettivi: essi valgono soltanto per noi, cioè per noi in quanto singoli soggetti, e soltanto in seguito assegniamo loro una nuova relazione, quella cioè con un oggetto, e vogliamo quindi che [il primo giudizio] debba essere valido per noi sempre, nonché per ogni altro uomo; infatti, quando un giudizio si accorda con un oggetto, tutti i giudizi circa il medesimo oggetto devono anche concordare tra loro, sicché la validità oggettiva del giudizio di esperienza non significa altro se non la sua validità necessaria e universale» (ibid., p. 298). E qui Kant fa cadere il primo di una serie di chiarimenti: «Che la stanza sia calda, lo zucchero dolce, l’assenzio disgustoso, sono giudizi validi soltanto soggettivamente, giacché io non pretendo di doverli ritenere sempre veri e che ogni altro li debba ritenere tali, ma esprimono soltanto una relazione fra due sensazioni per un medesimo soggetto, cioè per me stesso nel mio attuale stato percettivo, e non devono perciò valere anche per l’oggetto: tali giudizi io li chiamo percettivi» (ibid., p. 299). Gli esempi qui invocati presentano tuttavia alcune difficoltà – pienamente inquadrabili solamente in un impianto come sarà quello della terza Critica – di cui pare ben consapevole lo stesso Kant, che precisa in una nota: «Ammetto volentieri che questi esempi non rappresentano giudizi percettivi che potrebbero mai diventare giudizi di esperienza, anche qualora vi si aggiungesse un concetto intellettivo; infatti, si riferiscono soltanto al sentimento, di cui ognuno riconosce il carattere meramente soggettivo e che quindi non può mai venire riferito all’oggetto, e dunque non possono mai diventare oggettivi.» (ibid., p. 299). 60 Giustifichiamo la scelta di riferirci in ciò che segue alla pagine della Metaphysik Pölitz (piuttosto che ad altre trascrizioni di lezioni o alla Antropologia pragmatica) in base a due ordini di considerazioni. Pur oscillandone le datazioni (che comunque la collocano intorno ai primissimi anni Settanta), vi è chiaramente leggibile 1) la ripresa degli argomenti di Sulzer (op. cit.) appena presentati; 2) ugualmente riscontrabile vi è una concomitante e crescente influenza della revisione operata da Meier rispetto alla psicologia empirica di Wolff, sia nell’indebolirne la dottrina della piena riducibilità delle appetizioni e dei sentimenti alle cognizioni (cfr. P. Kobau, “Sentire. Percezione e sentimento”, Rivista di estetica [n.s.], n. 4, 1997, pp. 21-47; id., “Psicologia senza sentimenti: da Wolff a Dennett”, in C. Bazzanella, P. Kobau (a cura di), Passioni, emozioni, affetti, McGraw-Hill, Milano 2002, pp. 37-61), sia nell’assumere come primo oggetto della “patologia” i moti di desiderio e avversione (cfr. già G.F. Meier, Theoretische Lehre von den Gemüthsbewegungen überhaupt, Hemmerde, Halle 1744, par. 17). 61 In sede di psicologia empirica, infatti, per la caratterizzazione complessiva della “facoltà inferiore” in termini di passività di contro alla caratterizzazione di quella “superiore” in termini di attività, troviamo che con questo medesimo criterio sono bipartite tutte e tre le facoltà principali, che operano rispettivamente con «rappresentazioni [Vorstellungen]», «appetiti [Begierden]» e il «sentimento del piacere e dispiacere [Gefühl der Lust und Unlust]» (Psic, p. 55). 62 Ibid., p. 57. 17 ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura quest’ultimo caso (esemplarmente, il gusto e l’olfatto), operano come «sensi del godimento [Genuss]» più che come sensi «informativi»63 . Per contro, la seconda facoltà principale dell’anima non è affatto da caratterizzarsi come cognitiva, poiché ad essa compete di «distinguere le cose secondo il sentimento del piacere e dispiacere, ovvero del gradimento e del disagio»64 . Soprattutto, però, va attentamente considerato come (e in che misura) da entrambe queste facoltà venga distinta la terza facoltà, l’appetitiva, così definita. La facoltà del piacere e dispiacere era il rapporto dell’oggetto con il nostro sentimento dell’agire, ossia della promozione della vita oppure del suo impedimento. Ma in quanto quella del piacere e dispiacere è una facoltà di certe attività e azioni che alla vita siano conformi, in tanto si tratta di un appetire.65 Spicca, qui, l’ulteriore caratterizzazione della seconda facoltà in quanto non “esteticamente disinteressata”, bensì come capacità di giudicare del rapporto fra un oggetto e il fine della “promozione della vita”, o (più precisamente) nei termini di una “concordanza” o «contrasto del principio della vita» con determinate «rappresentazioni o impressioni degli oggetti»66 – e dunque come “sentimento dell’agire”, e non più solo di un “piacere e dispiacere” intesi come ineffettuali. Sicché, l’“appetito attivo”, ossia la «facoltà di agire e omettere di agire secondo il gradimento o il disagio in rapporto all’oggetto in quanto cause della capacità attiva di produrlo»67 , risulta a sua volta determinato come “piacere”, «in quanto è una cagione e un motivo dell’agire per determinare certe rappresentazioni dell’oggetto»68 . Nell’insieme, la caratterizzazione del piacere risulta così duplice: o puro sentimento, o sentimento che diventa appetito e motivo di azione. Alla fine, pare di avere dinanzi non due ulteriori facoltà ugualmente distinte da quella della cognizione69 , bensì una seconda facoltà che nel suo tratto “inferiore” possiede tuttavia un duplice volto, la quale risulta cioè inequivocabilmente passiva in quanto capacità di provare piacere o dispiacere, ma (almeno) reattiva nel suo configurarsi come appetizione indirizzata a “produrre” (innanzitutto rappresentativamente) un “oggetto”. Inesistenza del piacere? Nell’interpretazione kantiana del modello psicologico motivazionale, dunque, il fenomeno del piacere si trova sospeso tra due caratterizzazioni e due attribuzioni a 63 Ibid., p. 59. Ibid., p. 75. Non sembra possibile affermare che il piacere o il dispiacere siano letteralmente privi di oggetto, innanzitutto perché mediante il sentimento noi «sentiamo noi stessi» (Ibid., p. 76), e inoltre perché la «situazione del gradire o sgradire» viene definita come la «rappresentazione soggettiva dell’intera capacità vitale di accogliere o escludere gli oggetti» (Ibid., p. 77). 65 Ibid., p. 84. 66 Ibid., p. 77. 67 Ibid., p. 85. 68 Ibid., p. 84. 69 Che rimane comunque condizione ineliminabile del poter provare piacere e dispiacere, cfr. ibid., pp. 75-76. 64 18 ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura facoltà distinte: puro piacere “estetico”, che non ha bisogno di alcun oggetto “reale” per attuarsi, e piacere come desiderio, impulso all’azione che cerca e attende la realizzazione del proprio oggetto al fine di poterlo godere. Ciò potrebbe non costituire un vero dilemma; tale duplicità potrebbe venire semplicemente riconosciuta come un dato dalla psicologia empirica, cioè dalla disciplina che qui detta i criteri ultimi del riconoscimento, o meno, dei problemi effettivi – se non fosse che tale duplicità del piacere, volta per volta puro sentimento o godimento solo virtuale, ma motore ultimo di ogni azione destinata a promuovere la vita, pare sfuggire a ogni netta determinazione nei termini di “attività vs passività”70 , cioè della dicotomia che sta al cuore delle tassonomie disegnate da questa disciplina71 . E ancora, da un punto di vista motivazionale, occorrerebbe capire quando e in che modo il piacere, da “godimento” in sé conchiuso, assumerebbe il ruolo dinamico di “appetito attivo”. Forse, va riconosciuto che tale ambiguità si situa all’origine di tutti i modelli motivazionali che hanno corso sia nella psicologia popolare, sia nella filosofia e nella psicologia scientifica – ossia, nella prima proposizione di un simile modello da parte di Aristotele72 e, in particolare, nella risoluzione che offre a una (presunta) disputa con Platone circa il dovere individuare in un sentimento negativo oppure nel piacere l’impulso ultimo all’azione73 . Senza poterne delineare per intero la 70 Si veda la polarità riconosciuta da Kant fra i casi in cui «appetiamo anche senza essere attivi, anche senza agire», ossia in cui opera un «appetito inattivo ovvero uno struggimento nostalgico [Sehnsucht]», e quelli in cui opera invece l’appetito propriamente attivo, cioè il «libero arbitrio» – nel che va tuttavia osservato come «[i]n ogni arbitrium giuocano cause impulsive, ‘sensibili oppure intellettuali’» (ibid., p. 85). 71 La “Suddivisione generale delle facoltà spirituali” si apre con un’osservazione empirica che ha in tal senso la forma di un vero aut/aut: «Io mi sento o passivo oppure attivo» (ibid., p. 55). 72 Si vuol dire del De anima, dove, a differenza che nel De motu animalium, è più chiaramente assegnato un qualche ruolo al piacere e al dispiacere nella dottrina del movimento animale (cfr. P. Kobau, “Psicologia senza sentimenti: da Wolff a Dennett”, cit.). In tale contesto, infatti, Aristotele afferma che se ne darebbe una doppia causa, trovata nell’“appetito” (ovvero nella “tendenza” o “desiderio”: orexis, De an. 433a, 9) e nell’immaginazione (intesa come facoltà che prolunga quella dell’aisthesis nell’intelletto inteso come “ragione pratica”; si è in tal senso parlato di una funzione “trans-sensoriale” attribuita da Aristotele alla percezione in campo etico, cfr. W. Welsch, Aisthesis: Grundzüge und Perspektiven der Aristotelischen Sinneslehre, Klett-Cotta, Stuttgart 1987, p. 32) considerata come una “specie di pensiero” (De an. 433a, 10) – due facoltà che, indipendentemente, intendono un oggetto come appetibile e quindi come motore (motore “immobile”, dunque, a differenza del secondo motore dell’organismo, “mobile”, costituito dall’anima che lo appetisce). (Tale duplicità, ribadita in Eth. Nic. III, 3 e VI, 1, inoltre, consente di ammettere il darsi di desideri contrastanti, a seconda cioè che assecondino oppure contrastino la “ragione pratica”, De an. 433a, 31-b, 30.) Fin qui, comunque, non si parla di piacere e dispiacere; ma più sotto, chiedendosi se tutto ciò valga anche per gli animali “imperfetti” che possiedono il solo senso del tatto (De an. 433b, 30-434a, 1), Aristotele risponde argomentando in modo seccamente affermativo che questi animali «necessariamente possiedono anche desiderio» ovvero «appetizione [epithymia]» in quanto in essi sono presenti piacere e dolore (De an. 434a, 2-3; per l’analisi fisiologica secondo cui il corpo umano tende a rifuggire il dolore e a ricercare il piacere, cfr. Eth. Nic. VII, 15), mentre il loro possesso dell’immaginazione appare meno ovvio. (Il termine epithymia va a sostituire orexis anche in De an. 433b5 sgg., dove si colloca l’ulteriore discussione sulla possibile contrarietà delle appetizioni, dovuta in realtà a un conflitto tra appetito e intelletto). 73 La dottrina platonica del piacere come risoluzione di una carenza “dolorosamente” avvertita 19 ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura storia degli effetti, di questa basterà, per i nostri scopi, sottolineare un’unica linea di deriva. Benché la lunga storia del modello motivazionale aristotelico sia stata percorsa da tentazioni riduzionistiche ed eliminativistiche diverse, infatti, quella su cui si vorrebbe attirare l’attenzione è la strategia che ha tentato di cancellare da esso uno dei sentimenti che vi svolgono la funzione di stimolo o motivo all’agire, ossia il piacere. Di questa, l’esempio più chiaro in età moderna si può ravvisare in quello che è stato chiamato l’“edonismo negativo” di Locke74 , che del modello aristotelico riprende la fondamentale bipartizione tra sentire e pensare come motivi concorrenti del deliberare e dell’agire, mentre della concezione platonica riprende e rafforza un’impostazione che si potrebbe dire omeostatica, assegnando poi al “disagio (uneasiness)” il ruolo di vera e unica motivazione affettiva. Ciò è per Locke necessario, una volta presi sul serio quei casi di conflitto tra motivazioni riferite a scopi differenti, dove, a ben guardare, il motivo vincente non potrà mai essere la valutazione di un bene assente, per quanto inteso come maggiormente desiderabile75 . Lo potrà bensì essere la sofferenza attuale per la mancanza di un bene – per quanto riconoscibili siano i limiti, e fin la miseria, di quest’ultimo, come icasticamente dimostra l’esempio dell’alcolista, forzato al bere pur nella consapevolezza delle rovinose conseguenze della sua azione76 . Ricapitolando: che cosa resta, dunque, del modello popolare – indistintamente fenomenologico e motivazionale – secondo cui il piacere e il dolore fisici avrebbero delle controparti mentali, mentre entrambi andrebbero intesi come sensazioni opposte, collocate agli estremi di un unico continuo segnato al centro dall’indifferenza? Se viene sottoposto a un raffinamento di tipo analitico, troviamo innanzitutto che quello che correntemente viene distinto in un sentire affettivo di tipo (Resp. IX), ovvero come percezione di una tale risoluzione (Phil.), a ben vedere non contrasta con la caratterizzazione del piacere fornita da Aristotele nel De anima di cui si è detto nella nota precedente: qui, al piacere e al dolore è certo riconosciuto un ruolo funzionale in quanto legati alla facoltà appetitiva, ma sarebbe vano ricercarne una definizione più dettagliata. Per contro, la caratterizzazione del piacere nei termini di un perfezionamento dell’attività, fornita nell’Etica Nicomachea (X, 4), e di cui si dirà più sotto (su cui cfr. almeno F. Ricken, Der Lustbegriff in der Nikomachischen Ethik des Aristoteles, Vandenhoeck & Roprecht, Göttingen 1976; D. Charles, Aristotle’s Philosophy of Action, Duckworth, London 1984), senz’altro non coincide con la dottrina platonica, ma è difficile sostenere che venga prodotta in tale sede da Aristotele allo scopo di dettagliare un modello psicologico di tipo motivazionale. 74 P. Kraus, “Locke’s negative hedonism”, The Locke Newsletter, n. 15, 1984, pp. 43-63. 75 Cfr. P. Kobau, “Sentire. Percezione e sentimento”, cit., pp. 26-29. 76 “[U]n ubriacone può ben vedere che la sua salute va in malora, che i suoi beni si disperdono; che nella linea di condotta da lui seguita lo attendono il discredito e le malattie, l’indigenza assoluta e persino la perdita della sua amata bevanda; e tuttavia, i ritorni del disagio, quando egli sente la mancanza dei suoi compagni di baldoria, la sete abituale di quei bicchieri alle ore consuete, lo trascinano alla taverna” (J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding [1689, 1692-4, 1700-4]), tr. it. di C. Pellizzi rivista da G. Farina, Saggio sull’intelligenza umana, “Introduzione” di C.A. Viano, Laterza, Roma-Bari 1994, 2.21.35). Si confronti la conclusione (molto meno drammatica, ma del tutto consonante) del dialogo manzoniano dedicato al piacere, dove è fornita un’analisi del significato della formula “sentire un bisogno” svolta relativamente al caso dell’assetato (cfr. A. Manzoni, [Del Piacere], lettera a Rosmini del dicembre 1851, in Id., Tutte le Opere, a cura di A. Chiari e F. Ghisalberti, Mondadori, Milano 1970, vol. II, n. 974). 20 ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura fisico oppure mentale risulta trattabile alla stessa maniera, e cioè come fenomeno integralmente psicologico. Ma se ne vengono distinti i versanti fenomenologico e motivazionale, il presunto continuo piacere-dispiacere appare spezzarsi in due maniere diverse. Sul primo versante, cioè, appaiono buone le speranze di poter trattare i fenomeni del sentire affettivo in termini intenzionalistici, recuperando (come si è visto nel caso di Crane) la tradizione rappresentazionistica. In questa maniera, però, oltre a dover riconoscere la necessità di un abbondante supplemento di indagine, la possibile tassonomia di tali fenomeni non viene affatto indirizzata verso una loro disposizione lungo un continuo come è quello previsto dalla psicologia popolare, e rimane anzi aperta la questione di una loro sistematizzabilità in generale. Sull’altro versante, la situazione appare ancora più problematica. Se il sentire affettivo riveste un ruolo funzionale, cioè, piacere e dispiacere risultano del tutto eterogenei – specie nelle versioni del modello motivazionale che si incentrano radicalmente su una funzione omeostatica. Perché un sistema omeostatico possa svolgere il proprio compito, infatti, gli può essere sufficiente regolarsi su di un unico parametro – e, come si è visto nel caso di Locke, il candidato che potrebbe sostenere da solo77 un tale ruolo nella spiegazione dei comportamenti non determinati dal raziocinio è il sentimento di disagio, platonicamente interpretato come segnale della privazione di qualcosa, rispetto a cui viene dunque imposta forzatamente una sorta di giudizio di desiderabilità a prescindere da ogni valutazione strettamente cognitiva, anche quando intesa come riferita un godimento futuro. Se questo è vero, tuttavia, resta però da trovare una collocazione psicologica per il piacere, una volta riconosciutane la differenza rispetto al disagio sotto il profilo motivazionale – pena il risorgere delle tentazioni a farlo scivolare nello statuto di un “quale”, giacché la sua apparente atopia si accorderà benissimo con la caratterizzazione dei “qualia” come fenomeni psichici privi di ruolo funzionale. Tale rischio, però, può essere evitato, prestando attenzione a un argomento radicalmente deflazionistico di Ryle che inoltre, si suggerisce, può bene risultare compatibile con un modello à la Locke. Nel dibattito sviluppatosi negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso circa la possibilità di qualificare il piacere come una sensazione (e in particolare come una sensazione episodica)78 , Ryle, forte di una teoria sistematica delle emo77 A ben vedere, un tale modello non esclude che il sentimento di piacere possa avere una funzione basilare per un sistema omeostatico il cui scopo sia di mantenere in atto (ma non il determinare) un comportamento. (Sarebbe facile immaginare un’integrazione in tal senso dell’analisi lockeana del caso del beone.) Un tale modello, inoltre, sarebbe compatibile con la definizione “protoavverbialistica” del piacere fornita da Aristotele nell’Etica Nicomachea, di cui si tratterà in conclusione. A ogni modo, rimane da sottolineare come si tratterebbe di due sistemi omeostatici (e di due meccanismi psicologici motivazionali) differenti, regolandosi su obiettivi e su parametri di attivazione ben distinti – ciò che va contro sia la concezione popolare del continuum piacere-dolore, sia contro le teorie psicologiche e neuropsicologiche che paiono assumere in modo ovvio tale concezione (ad es. A.R. Damasio, L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, cit.), integrate (o meno) a loro volta in teorie decisionali di tipo cognitivistico. 78 Tale dibattito si inseriva, a sua volta, nella cornice dei tentativi di fornire un’analisi (riduzionistica, quando non eliminativistica) delle emozioni come “fatti pubblici”, ovvero nei termini di 21 ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura zioni di tipo eliminativistico79 , presentò un’estesa critica di una simile concezione del piacere80 . Oltre a criticare diversi aspetti delle concezioni correnti del piacere come sensazione, però, Ryle svolge anche una critica della concezione del piacere e del dolore come sentimenti omogenei ma contrapposti. (Tra i vari argomenti che si possono avanzare in tal senso, occorrerebbe ad es. prendere atto che il piacere, a differenza del dolore che può talvolta essere inteso come una sensazione somatica, mancherebbe sempre della prima caratteristica che una simile sensazione deve possedere, e cioè avere una localizzazione avvertita81 .) Tuttavia, se per Ryle risulta vietato parlare del piacere come di un sentire in senso proprio (per cui non avrebbe senso nemmeno discorrere di confronti tra piaceri, o di presunti calcoli che ne avrebbero di mira la massimizzazione), non è tuttavia vietato riconoscere che quando parliamo di piacere mettiamo a tema un’esperienza peculiare. Per mettere a fuoco questo punto, Ryle si chiede di che tipo sia «la differenza tra fare una passeggiata e goderla (taking a walk which one enjoys) e fare una passeggiata provando indifferenza»82 . La sua risposta è che il «godimento di una passeggiata non è un effetto concomitante, ad es. passibile di introspezione, del passeggiare, tale che si potrebbero fornire due resoconti [distinti], quello della passeggiata e quello della sua piacevolezza per colui che passeggia»83 . Bisogna, cioè, osservare che affermiamo di provare piacere non quando avvertiamo una speciale sensazione, ma quando ad es. ci atteggiamo attivamente (ad es. prestando una particolare attenzione)84 e non in maniera passiva rispetto a un medesimo comportarsi. Se si vuole, dunque, per Ryle il piacere non esiste in quanto specie del sentire, o come evento del provare qualcosa, ma è una qualità peculiare del nostro interesse per un’attività, ovvero consiste nel modo in cui un’attività, che in altre circostanze o per altri rispetti risulta indifferente, può essere svolta. La soluzione di Ryle apparirà forse sconcertante, ma non tanto perché neghecomportamenti relativi al contesto sociale – tentativi che hanno spesso assunto come base i suggerimenti avanzati in tal senso dal “secondo” Wittgenstein, e di cui è un risultato classico E. Bedford, “Emotion”, Proceedings of the Aristotelian Society, n. 57, 1956, pp. 281-304. 79 Cfr. G. Ryle, The Concept of Mind, Penguin Books, Harmondsworth 1949. 80 Cfr. G. Ryle, “Pleasure”, in Id., Dilemmas, Cambridge University Press, Cambridge 1954, pp. 54-67. 81 Più di recente, anche altri autori (cfr. ad es. M.A. McCloskey, “Pleasure”, Mind, n. 80, 1971, pp. 542-551) hanno negato che del piacere (e pure di quello “fisico”) si possa sempre adeguatamente identificare una localizzazione somatica. 82 G. Ryle, “Pleasure”, cit., p. 135. 83 Ibid., p. 138. 84 Evans, The Subject of Consciousness, Allen & Unwin-Humanities Press, LondonNew York 1970, discute e riprende per esteso la teoria “avverbiale” dell’attenzione esposta contestualmente in G. Ryle, “Pleasure”, cit., pp. 54-67: ciò che diciamo “fare attenzione” non andrebbe cioè considerato come un fatto mentale, ma come un modo (qualificabile come “polimorfico”) di svolgere una qualche attività (che Evans assume essere sempre fisica), ad es. come “fare qualcosa con cura”, o (appunto) “con piacere”. Evans, inoltre, riconosce che almeno in alcuni casi “fare attenzione” implica svolgere un’attività concomitante a un’altra (ad es. “pensare”): ma questo non significherebbe che tale attività “parallela” debba venire interpretata come un’attività sui generis, ossia come la peculiare attività del “fare attenzione” – osservazione che può facilmente venire adattata e ripresa in un’interpretazione “avverbialistica” del piacere. 22 ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura rebbe il darsi di qualcosa che siamo abituati a chiamare piacere (Ryle nega solo la liceità di intendere una tale esperienza come una sensazione atomica), quanto piuttosto perché nega la liceità di interpretare questa esperienza come un evento psichico cui, magari, potrebbe spettare un ruolo genuinamente motivazionale – ad es., di un “appetito attivo” in senso kantiano. E a una simile idea, come si è visto, la psicologia popolare (e non solo) rimane legata. D’altro canto, la proposta critica di Ryle lascia aperti ampi spazi, specie per interpretazioni della sua teoria “avverbiale” del piacere che recuperino gli spunti aristotelici volti a caratterizzare il piacere come qualità o come modo dell’agire85 – già ripresi, in realtà, in alcune teorie psicologiche degli affetti che, pur in un’impostazione funzionalistica, si mostrano consapevoli di abbandonare un modello definibile come motivazionale in senso stretto86 . In ogni caso, pur restando quest’ultima una questione del tutto aperta, ci si è portati con ciò a una buona distanza di sicurezza dal modello psicologico popolare incontrato in Sade – rendendoci, forse, capaci di capire meglio una storia come quella che ci racconta Drella. Avvertenza Per i testi pubblicati in rete viene fornita la data dell’ultima versione. La sigla SEPh sta per N. Zalta (a cura di), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (URL: http://plato. stanford.edu). Le opere di Kant sono citate secondo le Kant’s gesammelte Schriften, a cura della Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften (e prosecutori), BerlinLeipzig 1900 e sgg. (= Ak). Ne sono state utilizzate le seguenti trr. itt.: Lezioni di psicologia, tr. it. di G.A. De Toni, “Introduzione” di L. Mecacci, Laterza, Roma-Bari 1986 (= Psic); Critica della facoltà di giudizio, tr. it. a cura di E. Garroni e H. Hohenegger, Einaudi, Torino 1999. 85 Il fatto che il piacere venga definito da Aristotele sia come l’esercizio senza impedimenti di una facoltà naturale (Eth. Nic. VII) sia come il compimento di un’attività (Eth. Nic. X) ha posto un evidente problema ai suoi interpreti. In questa sede, tuttavia, sarà sufficiente riconoscere il darsi di tale questione, visto che il problema maggiore appare qui quello di conciliare le interpretazioni, rispettivamente, motivazionale (De anima) e “proto-avverbialistica” (Etica Nicomachea) del piacere fornite da Aristotele. 86 K. Oatley, op. cit., pp. 561-563. 23
Scaricare