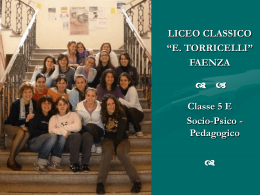Il narratario, nella moderna critica letteraria indica il lettore, non quello reale, che ha letto o che leggerà, ma l’implicito, quello cui si rivolge l’autore. Come scriveva Manzoni nel primo capitolo del suo capolavoro: “Pensino i miei venticinque lettori ch e impressione dovesse fare sull’animo del poveretto, quello che s’è raccontato”. il narratario laboratorio di testi: racconti analisi rapsodie epopee giornale in foglio con editoria elettronica da tavolo direttore responsabile Fabio Trazza www.ilnarratario.info - Premio Nazionale “Verba Volant” 1999 con patrocinio Ministero Pubblica Istruzione - [email protected] anno nono numero nove Da Coquelicot Mafille, corrispondente de il narratario, a tutti i miei venticinque lettori nota per il suo reportage “Una città nel vento”(viii, 20, 30/11/02), giovedì 15 maggio 2003 redazione organizzazione fotocomposizione e stampa in proprio Periodico Quindicinale - Aut. Tribunale Milano 34/95 28.1.1995 - tel/fax 02/6123586 - via Arbe 29 - 20125 Milano GUERRA STRANIERA. MALE DOLCE. GUERRA PREVENTIVA E SICUREZZA INTERNA IN RWANDA: LE LOGICHE POLITICHE DI PAUL KAGAME SULLE CENERI DEL GENOCIDIO RWANDESE Preziose e forse scontate sono apparse le parole pronunciate con dolore dal Papa Giovanni Paolo II e dal segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan mentre la corazzata anglo-americana produceva imperterrita i suoi danni collaterali per liberare l’Iraq. “La guerra irachena” dissero in sintesi “ci porterà a disastri umani incalcolabili”. Per poi ammonire: “Nel mondo imperversano altre guerre e paesi disastrati che non dobbiamo dimenticare”. C’è l’imbarazzo della scelta. Quella che si svolge dal ’98 nella Repubblica Democratica del Congo è una delle tante. E che il Rwanda, coinvolto in questa guerra, possa suscitare un interesse particolare in questi tempi di occupazione unilaterale mediatica, ce ne vuole. Senonché, i gettonatissimi concetti di guerra preventiva e sicurezza interna non sono una prerogativa di Bush. In tempi poco sospetti (ufficialmente tre anni prima dell’11 settembre), l’attuale presidente della Repubblica rwandese Paul Kagame fece di questi concetti i pilastri irremovibili della sua politica nazionale e regionale. Di certo, i fattori che hanno indotto Bush ad intervenire in Iraq e Kagame in territorio congolese non sono di primo acchito relazionabili. C on saggezza, Daniele Scaglione ex presidente di Amnesty International e autore del recentissimo Rwanda: cronache di un massacro evitabile sottolinea l’indecenza con la quale un funzionario occidentale ha tentato di paragonare in termini numerici le vittime del World Trade Center con quelle del genocidio rwandese (se i conti non ingannano, è come se dal 6 aprile al 19 luglio 1994 le Twin Towers fossero crollate tre volte al giorno per 104 mattinate di fila). Ma con tutte le dovute precauzioni, ciò che in qualche maniera accomuna Bush e Kagame sta nel loro modo d’interpretare le paure collettive dei propri connazionali all’indomani di eventi traumatizzanti. Non solo. Entrambi sono sotto torchio mediatico e diplomatico. L’accusa minore: aver provocato una guerra senza il consenso onusiano e dietro la quale si nascondono con fatica interessi precisi che nulla hanno a che fare con una minaccia reale. Tutto questo, quando all’orizzonte si profilano elezioni politiche e il rischio, come già paventato da Amnesty international nel caso di Bush, di vedersi comparire per danni colleterali (o crimini di guerra, fate voi) nel più felice e ragionevole complesso architettonico del XXI secolo: il Tribunale internazionale dell’Aia. Siamo al 25 gennaio 2003, a Zurigo, Renaissance Hotel. Al termine di una giornata convulsa, Nicholas Shalita, direttore dell’informazione dell’ufficio di presidenza rwandese, si avvicina e mi avvisa con tono confidenziale: “Il presidente è pronto”. Dalla hall di questo albergo lussuoso della periferia zurighese, abbandono una cena gargantuesca offerta da uno dei paesi più poveri del mondo, per avviarmi ad intervistare Paul Kagame, uno dei leader africani incontrastati di un’intera regione senza pace (senza se e senza ma), ubicata nel cuore dell’Africa sub-sahariana e “terremotata” dal genocidio rwandese del 1994: l’Africa dei Grandi Laghi. Il passaggio in Svizzera di Kagame non era proprio frutto del caso. In una Congress Halle del Rennaissance Hotel stracolma ha ribadito ad una platea euforica di oltre 400 persone della Diaspora rwandese giunti a Zurigo da mezza Europa le ragioni per le quali partecipò pochi giorni prima al Forum economico di Davos. Ricordare ai potenti del mondo l’anno cruciale che il Rwanda stava per affrontare. “A nove anni del genocidio”, ha avvertito, “le sorti del nostro paese dipendono in parte dall’appoggio politico ed economico della Comunità internazionale”. Nei fatti, entro il 2003, referendum costituzionale ed elezioni legislative e presidenziali dovrebbero chiudere definitivamente i conti con un periodo di transizione iniziato nel ’94 (cioè all’indomani dello sterminio di almeno 800.000 rwandesi Tutsi e Hutu moderati). Uniche certezze: chi assumerà il potere, dovrà proseguire la ricostruzione di un tessuto sociale, economico e politico ancora lacerato dal genocidio, e raccogliere il fardello di un intervento armato in Congo dagli effetti devastanti. Il dubbio: se quell’uomo sarà Paul Kagame? Sul suo conto, si è detto di tutto e il contrario di tutto. C’è chi lo ha paragonato a Giulio Cesare per il modo con cui pose fine ad un genocidio svoltosi a porte chiuse sul piano mediatico; per aver liberato il paese da dittature razziste rwandesi pro-Hutu. C’è chi lo ha soprannominato Afandi peace (cioè il comandante che ha portato la pace). A Zurigo, Yolande Mukagasana, una Primo Levi dei sopravvissuti rwandesi, mi confida come tanti altri il rispetto “per un capo di Stato che in tutti questi anni difficili ha saputo garantire la sicurezza ai quattro angoli di un paese ormai aperto a tutti”. Agli antipodi delle venerazioni per un uomo agli occhi dei più molto riservato, si moltiplicano i rapporti piuttosto severi dei più importanti organismi internazionali per la difesa dei diritti umani. Sono anni ormai che Reporters Sans Frontières lo considera un vero e proprio predatore della libertà di stampa, affiancandolo a illustri personaggi quali Saddam Hussein. A loro volta, Amnesty International e Human Rights Watch non cessano di preoccuparsi per un paese asfissiato da una gestione quasi totalitaristica della res pubblica. “Ma ci vuole molto di più per spaventarlo” sussura Yolande. Ad avvalorare il giudizio della Signora Mukagasana, basterebbe dare un’occhiata al curriculum vitae di Kagame. Un percorso tutto in salita il suo che inizia nel 1960. Non compie 5 anni quando i suoi genitori, commercianti benestanti, vengono cacciati da un regime politico che per i prossimi 30 anni si sarebbe fatto il promotore della rivoluzione sociale (ed etnicizzante) pro-Hutu di cui l’esclusione dei Rwandesi Tutsi ne fu la più diretta conseguenza. Dalla sua città natale di Gitarama scopre l’inferno dei campi profughi ugandesi. Ma un’educazione rigidissima gli spiana la strada degli studi. Nel ’79, l’università è alle porte, ma le discriminazioni anti-rwandesi del regime di Amin Dada sono sempre dietro l’angolo. È la svolta. Ai libri, preferirà sfogare le sue umiliazioni con le armi. Inizia una carriera militare folgorante sotto l’ala del ribelle Museveni (attuale presidente dell’Uganda con cui è in guerra aperta dal ’98 su territorio congolese). Insieme, prendono il potere e lui diventa il numero due dei servizi segreti ugandesi. “È lì”, insiste un incondizionato sostenitore di Kagame presente a Zurigo, “che si è forgiato l’uomo intransigente con se stesso e con gli altri che molti temono”. Di fatto, alcuni soldati sottoposti al suo comando furono fucilati per indisciplina. Da cui, il suo primo soprannome: Ponzio Pilato. Troppo scomodo per Museveni che lo invita a risolvere un problema rimasto per troppo tempo in sospeso: il ritorno dei profughi rwandesi nel loro paese. Da quel momento si aprono nuovi orizzonti che lo conducono ad assumere nel 1990 la guida del Fronte Patriottico Rwandese (FPR, attualmente al potere in Rwanda), un gruppo armato composto da esiliati rwandesi Tutsi e Hutu con base in Uganda. Quattro anni dopo, occupa il Rwanda per fermare genocidiari in piena attività di sterminio “sotto lo sguardo totalmente passivo della Comunità internazionale, ONU in testa, e la complicità della Francia in questo bagno di sangue” (parole sue). Da lì, deve affrontare la gestione di un paese da ricostruire da cima a fondo. Impresa quasi impossibile che lo vede inzialmente al comando della vice-presidenza e del ministero della difesa di un Governo di unità nazionale. Sono i primi assaggi del potere civile, sempre subalterno a quello militare, che lo incorona nell’aprile 2000 Presidente della Repubblica rwandese. Intanto, infuoca i Grandi Laghi africani invadendo il Congo. La causa: dare la caccia ai genocidiari in fuga, che fino al 2000 infiltrano le frontiere rwando-congolesi per destabilizzare il paese. La minaccia sembra reale. Già, perché Congo e Rwanda non sono separati da oceani e deserti, ma da frontiere-colabrodo. Rapidamente, la caccia si trasforma in una guerra stabile che lo stesso Kagame definì —siamo nel ’98— preventiva. È ciò che pervade le menti dei rwandesi, ne costituisce il motivo pricipale: garantire la sicurezza assoluta del paese perché mai più si ripeta un genocidio. Siamo tutti rwandesi Tutsi o Hutu moderati, verrebbe da dire (o più semplicemente rwandesi come preferiscono affermare qui a Zurigo). Ma non tutti la pensano in questi termini. Non più. La società civile congolese nutre ormai da anni un sentimento razzista anti-rwandese e anti-Tutsi. Eppure, i congolesi avevano accolto con fervore nel ’96 l’entrata del ribelle congolese Kabila e delle truppe rwandesi a Kinshasa. A tutti, il neopresidente Kabila prometteva l’inizio di un’era migliore. Per Kagame, la faccenda si riassumeva nell’appoggiare un delinquente (Kabila) a scapito di un moribondo dittatore (Mobutu), colpevole di coprire sul proprio territorio i génocidaires. Per molti, la minaccia dei genocidiari paventata da Kagame si è liquefatta di fronte agli interessi ben più concreti che suscitavano le straordinarie ricchezze minerarie del territorio congolese. Come il petrolio iracheno per gli americani, coltano, uranio, stagno, oro, diamanti e petrolio congolesi hanno fatto gola a tutti. E non solo ai rwandesi. Dal ’98, quattro altri paesi (Angola, Mozambico, Zimbabwe, Uganda), multinazionali di ogni latitudine (belghe, inglesi, statunitensi e sudafricane in testa) e milizie locali di ogni bordo si sono spartiti le straordinarie ricchezze naturali e minerarie dell’ex-Zaire provocando non pochi danni collaterali. Che in termini pratici significa, secondo il Rapporto consegnato a Kofi Annan dal Gruppo di esperti sullo sfruttamento illegale delle risorse naturali nel Congo (16 ottobre 2002), stupri, formazione di bambini-soldati, estorsioni e saccheggi quotidiani, milioni di sfollati e, dulcis in fundo, almeno 3,5 milioni di morti tra agosto ’98 (inizio della guerra) e settembre 2002. « Una guerra straniera », scriveva Montaigne, « è un male ben più dolce che una guerra civile ». Nel caso rwandese, quella congolese è di logoramento lucrativo e poco redditizia sul piano politico. “È un po’ come l’11 settembre con il probabile attacco in Iraq. Genocidio rwandese e guerra in Congo sono strettamente legati” prova a spiegare Chantal Muragwabugabo, una signora rwandese dai modi affabili, che da Milano non ha esitato un istante a raggiungere Zurigo. “Con la sua politica aggressiva” sottolinea con aria un pò rassegnata, “Bush si sta giocando la memoria dell’11 settembre. È un pò la stessa cosa per Kagame con la guerra in Congo. Oggi la memoria del genocidio è rimessa in discussione e si parla già di doppio genocidio. Sarò cinica, ma il bonus morale del genocidio si sta riducendo a vista d’occhio, isolandoci a livello internazionale”. Ma, ancora fragile di fronte ai 30 anni di esilio che il regime prohutuista le ha fatto subire, la signora Muragwabugabo non ha nessun dubbio su chi debba rimarginare le ferite di una società rwandese ancora ossessionata dai fantasmi etnici: “Io sostengo Kagame” assicura disinvolta. “E questo malgrado i suoi errori, perché voi in Occidente” conclude velenosa nei confronti di chi ha chiuso gli occhi di fronte ai massacri del ’94,”non avete la più pallida idea di cosa significhi risollevarsi da un genocidio in un paese povero”. Di certo, per risollevare il Rwanda, non sono bastati i dollari iniettati dalla Comunità internazionale. Così Kigali ha creato una rete elitaria, quasi istituzionalizzata, protesa ad annettere ampi lembi territoriali del Congo Orientale e alla cima della quale gongola il capo di Stato maggiore dell’APR, James Kabarebe, numero due del regime e figliol prodigo di Kagame (il quale –en passant– è pur sempre il capo supremo delle Forze Armate rwandesi). Questo, per lo meno, è la convinzione del Gruppo di esperti, che, tra le sue innumerevoli prove d’accusa contro Kigali, precisa: “le operazioni della rete élitaria nell’est della Repubblica democratica del Congo sono gestite centralmente dall’Ufficio Congo dell’Apr (con base a Kigali, ndr), il quale assicura il legame tra le attività commerciali e militari dell’APR”. Un ufficio che procura nel ’99 l’80% di un budget militare nazionale pari a 400 milioni di $ (cioè il 20% del Prodotto Nazionale Lordo). Anche per questo genere di accuse, ho voluto incontrare a quattr’occhi Kagame. A Zurigo, rimango persuaso d’incontrare un uomo freddo, se non glaciale, arrogante e riservato al contempo. Insomma, così come lo hanno dipinto numerosi giornalisti occidentali, l’identikit del leader militare africano in carenza di buon costume diplomatico. In realtà, scopro un uomo calmo e sereno, più divertito che ironico, alternante risposte evasive e decise puntualizzazioni, senza mai far trapelare riceviamo un’inedita intervista a Paul Kagame di Joshua Massarenti, studente di Storia all’Università degli Studi di Milano. incertezze. Eppure, c’è poco da stare tranquillo per i nemici di statura internazionale che ha accumulato negli ultimi anni. Per primo, il presidente congolese Kabila Junior, insieme al quale la Comunità internazionale ha imposto nel luglio 2002 un accordo di pace —i cosiddetti Accordi di Pretoria— che da un lato prevedeva il rimpatrio in Rwanda degli interahamwe e delle ex-FAR (Forze armate rwandesi), entrambi coinvolti nel genocidio e utilizzati da Kabila per destabilizzare il Rwanda. “Ragion per cui”, sostiene il presidente rwandese, “siamo stati presenti in RDC”. Da parte sua Kigali si era impegnato a ritirare tutte le sue truppe dal territorio congolese entro 45 giorni dalla firma degli accordi. Gli ricordo che il segretario generale dell’ONU denuncia nel suo 12° rapporto sulla RDC –(in data 18 ottobre 2002)– che, dei 23.760 soldati rimpatriati dall’Armata rwandese, quasi 3000 mancavano all’appello, secondo la Missione di Osservazione delle Nazioni Unite in RDC (MONUC). Peggio, il rapporto sostiene che la MONUC ha raccolto “informazioni non confermate secondo le quali l’Armata Patriottica rwandese sarebbe penetrata all’interno del territorio della RDC prima dell’inizio del rimpatrio lasciando importanti quantità di armi oltre che una parte del suo personale all’RCD-Goma”, suo principale alleato in Congo. Alla richiesta di “spiegazioni ufficiali” sul rapporto, Kagame ribatte sicuro: “tutte le nostre truppe si sono ritirate dal Congo”. Per poi contrattaccare. “Piuttosto, il disarmo e il rimpatrio delle ex Far/ Interahamwe sono lungi dall’essersi completati”. Una frecciata indirizzata non solo a Kinshasa, ma anche ai supervisori dell’accordo, cioè la MONUC e il Sudafrica. Sebbene riconosca ai sudafricani “un contributo molto più concreto per risolvere i conflitti della regione”, entrambi “dovrebbero compiere sforzi maggiori nel collaborare con il governo congolese affinché gli impegni di Kinshasa vengano integralmente rispettati”. Ma, a fine gennaio, sui circa 15.000 presunti genocidiari, molti dei quali riciclati nelle Forze Democratiche di Liberazione del Rwanda, solo un migliaio sono rimpatriati. E poco più a fine aprile. Per Kagame, la cosa più grave è che “al di fuori del Rwanda, continuano a ricevere l’appoggio di vari gruppi e governi che hanno interessi a sfruttarli”. Implicito il riferimento al governo congolese, all’Uganda e ai loro bracci armati ribelli. Kinshasa, giunta il 1° aprile scorso a domare faticosissimi accordi per la nascita di un governo nazionale di transizione, aveva assicurato l’espulsione dal Congo dei leaders delle FDLR. Una promessa mai mantenuta e a cui fa riscontro, secondo Kagame, “la continua permanenza dei genocidiari, specialmente a Bunia, Beni [parte orientale, ndr] e altre città dell’entroterra congolese”. Una realtà tutt’ora molto problematica, visto che il presidente Kabila non ha mai ritirato le sue truppe dal Congo orientale, così come previsto dagli accordi di pace. Con l’Uganda, non va certo meglio. Oro, diamanti e petrolio hanno avuto ragione su 20 anni di amicizie tra Museveni e Kagame. Ma se c’è proprio da bisticciare, be’ allora meglio farlo fuori casa. E sempre tramite terzi. Raggiungono l’apice di questa stima reciproca nel ’99 a Kisangani in una guerra sanguinosa in cui prevale l’RDC-Goma, fedele a Kigali. I diamanti sono ormai sotto controllo rwandese. Da allora, a Kampala non ci si dà più pace. La storia più recente sposta il conflitto nell’Ituri, sempre nel Congo orientale, alla frontiera con l’Uganda. Da lì, Museveni avrebbe deciso di far pressione sul Rwanda. E la minaccia secondo Kagame è molto concreta: “sappiamo che gli ugandesi vogliono continuare a crearci problemi, mandando in Congo popolazioni dei campi profughi ugandesi per destabilizzare il nostro paese”. Ma i nemici non si fermano qui. Più giù, nel Sud-Kivu, le milizie Mai-Mai si sono alleate nel 2002 con i Banyamulenge [Tutsi originari del Rwanda, in rottura con l’RCD-Goma, quindi con Kigali], per opporsi a quello che giudicano ormai forze occupazionali. Con l’appoggio di Kabila hanno oggi il controllo delle campagne lasciando le città ad un RCD-Goma in difficoltà su tutti i fronti dal ritiro “ufficiale” delle truppe rwandesi. Eppure Kagame assicura con disinvoltura che “le forze dell’RCDGoma sono in grado di contenere tutti questi gruppi armati”. Fino a voler chiudere frettolosamente la faccenda congolese: “tutta questa instabilità concerne ovviamente il Rwanda, ma non nell’immediato”. Che, per i non addetti di questo risiko africano, significa: “per ora non interverremo militarmente, ma a Kinshasa e Kampala devono stare buoni”. Intanto, ad aprile, la situazione è nettamente peggiorata. Di giornalisti embedded, nemmeno l’ombra mentre lo scontro diretto nell’Ituri tra Uganda e Rwanda è una questione di settimane. Una MONUC impotente si è già messa a contare i morti: un migliaio di civili della comunità Hema, fedele agli ugandesi, sono stati giustiziati il 3 aprile scorso a Drodro (80 km a nord di Bunia, capoluogo dell’Ituri) da rappresentanti della comunità Lendu, sostenuta da Kigali tramite il gruppo ribelle dell’UPC, Union des Patriotes Congolais. “Un’operazione teleguidata dal Rwanda per seminare il terrore”, avrebbe detto un rappresentante Hema. E le accuse incrociate tra Uganda e RDC, da una parte, e Rwanda, dall’altra, sono di nuovo all’ordine del giorno. Ma sulle possibili ripercussioni della crisi congolese in materia di politica interna rwandese, Kagame non ha mai nutrito il minimo dubbio: “Non vedo nulla che possa deviarci dal programma politico che ci siamo prefissati. Nemmeno il Congo”. Per la verità, qualche effetto, la guerra congolese lo ha già prodotto. A nove anni dal genocidio, il periodo di transizione in Rwanda doveva chiudersi in marzo con un referendum costituzionale, seguito entro luglio dalle elezioni presidenziali e legislative. Kagame giustifica invece il rinvio del referendum a maggio, invocando “il tempo necessario per concludere gli ultimi passi della fase preparatoria del referendum” e le elezioni generali entro la fine dell’anno, per colpa “dei mesi di cui i partiti necessitano per potersi organizzare”. Presentato così, la Comunità internazionale non avrebbe nulla da ridire ad un presidente il narratario pagina 2 giovedì 15 maggio 2003 laboratorio di testi: racconti analisi rapsodie epopee che dal 1994 professa un multipartismo reintrodotto nonostante “quanto sia capitato nel nostro paese” e che, nel suo discorso rivolto alla diaspora, ammette: “non tutte le cose in Rwanda vanno per il verso giusto, ma ognuno è libero di tornare nel suo paese e dire ciò che pensa”. Ad un solo patto ammonisce Kagame: “Chiunque può sentirsi Hutu o Tutsi. Ma con la politica, questi sentimenti non hanno nulla a che fare”. Con lo scopo di impedire qualsiasi competizione politica fondata sulla mobilitazione etnica, l’FPR, capeggiato da Kagame, ha imposto dal ’94 una gestione consensuale del potere. Nella pratica, la Costituzione transitoria “vieta ai politici e ai partiti d’intraprendere ogni azione tesa a dividere il paese o a servire i propri interessi a scapito della riconcilizazione del popolo rwandese”. Di sicuro, sintetizza il prezioso rapporto dell’International Crisis Group —ICG, novembre 2002—, “la situazione post–genocidio è davvero eccezionale”, ma ciò non giustifica il fatto che “la stampa, il movimento associativo e i partiti di opposizione vengano ammutoliti, distrutti o cooptati”. A Zurigo, alcuni sostenitori si oppongono a tali asserzioni, sottolineando che ben 8 partiti politici sono presenti nel governo e alle camere. Nulla da ridire nella forma. Ma la sostanza scoperchia angosce che hanno maturato uno sbandamento autoritario del regime. I dati dell’ICG parlano chiaro: —11 prefetti su 12 sono affiliati all’FPR; —7 servizi di sicurezza su 9 appartengono all’FPR; —13 ambasciatori su 15 provengono dai ranghi del partito di Kagame, così come il Procuratore Generale, i capi della Corte di cassazione e della Corte Costituzionale ne sono membri, al pari di 8 direttori di banca –sulle 9 disseminate nel paese– e 25 dirigenti delle 29 più importanti imprese parastatali rwandesi. Nel migliore dei casi, agli oppositori sono rimaste le briciole o l’esilio. Ormai sono un quarantina quelli sparsi per il mondo. Monarchici, combattenti delle Fdlr di Kinshasa, oppositori Hutu moderati e, più di recente, leaders di associazioni di difesa dei sopravissuti del genocidio e membri dell’FPR in fuga da Kigali. Tutti spinti verso un’alleanza disperata quanto surreale. Tra questi oppositori, Faustin Twagiramungu, defenestrato da Kagame nel ’95, allorquando era ministro dell’interno. Da allora vive in Belgio, dove ha annunciato la sua candidatura per le presidenziali. A Zurigo sono stati parecchi ad intuirlo. Quanto a Kagame, ha le idee molto chiare in proposito: “Twagiramungu”, asserisce con parole di circostanza “è un rwandese ed è libero di concorrere a queste elezioni”. Non appena gli evoco che il suo ex alleato non hai mai rinnegato l’ideologia pro-Hutu della Rivoluzione sociale, il suo discorso si fa più affilato: —“Ci saranno in queste elezioni delle linee guida tese ad evitare i pericoli che abbiamo affrontato nel passato. Se qualcuno andrà contro queste regole, allora sarà squalificato. Per quanto riguarda Twagiramungu”–conclude– “le idee cha ha avanzato in passato sono ancora oggi valide. Non credo che una persona possa cambiare di punto in bianco”—. L’ammonimento alle idee che dividono i rwandesi fra Hutu e Tutsi è scontato. Anche per chi, come Twagiramungu, ha sempre riconosciuto il genocidio, ribadendo in una recente intervista rilasciata a Nigrizia che “nel mio partito [l’MDR, ndr] difendo un’ideologia che non ha niente a che vedere con il razzismo”. In realtà, Kagame non può essere impensierito da un Twagiramungu ormai sconnesso dall’elettorato rwandese e la cui candidatura è stata sconfessata dai sei partiti politici che hanno formato nell’ottobre scorso la Concertazione permanente dell’opposizone democratica rwandese (Cpodr), l’ultima ciurma di esiliati alla deriva. Fin troppo facile per lui ironizzare sulla propria candidatura (data per scontata a Kigali come a Zurigo), “che dipenderà da una combinazione tra la decisione del mio partito e la mia coscienza”. Ma una coscienza non del tutto serena dovrebbe suscitargli il caso di Pasteur Bizimungu, l’ex presidente della Repubblica (1994-2000), ormai ridotto al silenzio carcerario dall’aprile 2002. Sulle richieste di una sua immediata scarcerazione invocate da Amnesty International o l’ICG, Kagame si mostra impassibile: “È lui stesso ad aver deciso quello che è, compiendo scelte che lo hanno condotto in prigione”. Tra le poche denunciate da Kagame, “quella di aver sfruttato i sentimenti etnici”. Ma se è vero, spiega il rapporto dell’ICG, che “dietro i suoi discorsi pubblici, l’ex presidente denuncia in privato con molta demagogia l’esclusione degli Hutu dal potere”, è anche vero che “il vero problema si situa sul piano della competizione elettorale”. In tal caso, una sola scelta è stata davvero fatale a Bizimungu: la creazione di un nuovo soggetto politico nel maggio 2001, “per le elezioni presidenziali” sottolinea Kagame, “allorquando sapeva di essere in un periodo di transizione, durante il quale a nessuno era permesso di creare un partito politico. Ha infranto la legge”. Il giudizio non va preso sotto gamba perché cruciale sul piano tecnico- giuridico. Di fatti, Kagame fa un riferimento implicito al periodo di transizione che si dovrebbe chiudere con il referendum e la nascita di una nuova Costituzione. Fin lì nessuna campagna elettorale è autorizzata. Il paese “è ancora a rischio di divisioni” sostiene il regime, riferendosi in realtà alle fratture etniche e regionali che pesano ancora sulla coscienza dei rwandesi. Facendo quattro conti, i partiti avranno pochi mesi a disposizione per conquistare un elettorato rurale —ossia il 90% degli elettori— da sempre indifferente alle contese politiche che riguardano le élites urbane. Il tempo concesso ai partiti somiglia quasi a una provocazione, se penso a come l’incontro con la diaspora si apparenti in realtà ad una vera propria kermesse elettorale dell’FPR. Addirittura la competizione tra i partiti assumerebbe le proporzioni di una farsa, se le rivelazioni di una coppia svizzero-rwandese di Zurigo, fresca di ritorno dal Rwanda, si rivelassero fondate: “Non c’è una città, una collina”, spiega divertito Claudio, “dove l’FPR non abbia organizzato comizi elettorali. E’ presente ovunque, al cospetto degli altri partiti, assolutamente assenti”. In realtà, se tutto appare scontato, i malumori e i rischi sono sempre dietro l’angolo. Non tutti apprezzano la fine di Bizimungu. Alcuni rwandesi Tutsi avrebbero addirittura votato per lui, smentendo in parte il voto etnico automatico. Ma la sentenza di Bizimungu è già stata scritta da Kagame: “il suo futuro dipenderà solo da lui”. In altre parole: la rinuncia ad ambizioni politiche che avrebbero potuto soffiare parecchi voti all’FPR e mettere a rischio il trionfo elettorale di un Kagame in lotta su altri fronti. In primis, quelli giudiziari interni. Di fatti, non si sono ancora placate le angoscie dei sopravissuti in seguito al decreto presidenziale che dal 1 gennaio 2003 ha concesso libertà provvisoria ad oltre 30.000 detenuti sospettati di reati minori durante il genocidio. “Lo si è fatto perché era la cosa giusta da fare” si giustifica n Kagame, impiegando la forma impersonale allorquando la decisione è stata di sua intera responsabilità. “Non potevamo proprio tenere in carcere persone con una pena di anni inferiori a quelli già passati in cella. In molti casi c’è gente che ha trascorso 7 anni in carcere, allorquando la pena ne prevedeva 5. Non potevano rimanere in prigione un minuto in più. E’ una questione di logica!”. Forse una questione elettorale. Per conquistarsi gli elettori Hutu, visto che a Kagame, delle reazioni positive della comunità internazionale su questa questione, non gliene “importa un bel niente!”. Meno logiche appaiono a Carla Del Ponte le difficoltà continue che incontra con Kigali per inchiodare i soldati dell’FPR sospettati di crimini di guerra nel genocidio. In questo caso Kagame si sbarazza facilmente di ogni orpello diplomatico: “Non vedo le basi su cui Carla Del Ponte sta agendo. Penso che debba fare una distinzione tra i perpretatori del genocidio e coloro che hanno fermato il genocidio. Piuttosto” —prosegue quasi irritato— “parliamo del contesto in cui ha lavorato il TPIR ad Arusha rispetto al Rwanda. Il TPIR non ha nessuna scusa! Hanno speso centinaia di milioni di dollari e hanno fatto poco o niente!”. Difficile dargli torto, quando il TPIR procede al ritmo vertiginoso di O,7 condanne all’anno. Dei 73 incarcerati o ricercati dal Tribunale, di fatti solo 7 sono stati condannati. Troppo poco per un Kagame pronto comunque a ribadire che “se fossimo in possesso d’informazioni su casi sospetti dell’FPR, sarebbe il nostro governo a punirli”. Ma c’è chi mira molto più in alto della Del Ponte. Chi, come il giudice antiterrorista francese Bruguières, deve ancora consegnare un dossier spinosissimo che coinvolgerebbe Kagame in prima persona nell’attentato perpretato contro l’ex presidente rwandese Habyarimana alla vigiglia del genocidio. Ma lui, ovviamente, ha sempre negato. Come probabimente si opporrà alla richiesta mossa dal presidente congolese Kabila alla Comunità internazionale e tesa a giudicare l’amministrazione Kagame per crimini di guerra su territorio congolese. E forse, più di ogni altra cosa, sarà la giustizia a segnare il destino di Kagame. Molti, tra coloro che vogliono la sua testa, lo sognano. Come sono in molti ad augurarsi la stessa sorte per G. W. Bush. E, per una strana coincidenza, Washington è stata l’ultima meta occidentale raggiunta da Kagame all’estero. Era il 4 marzo 2003, la vigilia di un primo attacco preventivo in Iraq, e dell’ennesimo in Congo orientale. Con un Consiglio di sicurezza impotente. Entrambi hanno firmato un accordo che prevede l’immunità reciproca per i militari e i cittadini dei due paesi in caso di procedimenti penali davanti alla Corte penale internazionale. E, sempre da Washington, Kagame ha colto al volo l’opportunità di avvalorare la guerra all’Iraq. A modo suo: “Gli stati” —ha assicurato— “si vedono talvolta costretti ad intraprendere azioni militari senza il sostegno dell’ONU. Se abbiamo perso un milione di persone durante il genocidio, è perché il Consiglio di sicurezza ha fallito con il Rwanda”. A ciascuno i suoi traumi. L’11 settembre per gli americani. Il genocidio del ’94 per i rwandesi. Con tutte le insicurezze e le minacce che ne conseguono. A Zurigo, ne erano tutti convinti. Kagame più di ogni altro. (Intervista inedita a Paul Kagame di Joshua Massarenti) il laboratorio di testi racconti analisi rapsodie epopee il arratario periodico quindicinale anno nono numero nove 2003 giovedì quindici maggio narratario www.ilnarratario.info autorizzazione tribunale di Milano 34/95 - 28.1.1995 Lab.A.S. Webmaster Pierpaolo Crudo affidato per la consegna alle poste italiane ❧ A L N I O M E A U P RO alla cortese attenzione dei Visitatori del Sito www.ilnarratario.info Premio Nazionale “Verba Volant” 1999 con patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione Edizione fuori commercio - Vietata la vendita - Proprietà letteraria e artistica ® Distribuzione a cura del «Laboratorio Altiero Spinelli» «Mi si è gelato il sangue... nelle vene sentendo Gad Lerner in televisione constatare: “In effetti, il crocifisso è il simbolo di un perdente”. In effetti un accidente: dipende dalla posta che è in gioco. I simboli vincenti quali sarebbero?» Così scriveva indignata in un articolo Patrizia Valduga su La Repubblica (10.5.03, Milano I). Ma non s’indigni ora che è ascesa agli allori della Scala, con il debutto di Vita, di cui ha scritto il libretto derivandolo da Margaret Edison e facendo apparire tra endecasillabi, ottonari e settenari i suoi amori, Donne e Pascoli. Ha 50 anni, l’età giusta per capire perché La Repubblica le spezzi l’articolo e perché Lerner sia noto soprattutto per la gran devozione al vincente Sofri. Ai miei venticinque lettori dirò che chi si è indignata non è né una Dama di S. Vincenzo né una Suora del Preziosissimo Sangue, ma la poetessa di questi versi: [Sa sedurre la carne la parola] Sa sedurre la carne la parola prepara il gesto, produce destini... E martirio è il verso, è emergenza di sangue che cola e s’aggruma ai confini / del suo inverso sessuato, controverso. [Sa sedurre la carne la parola] Sa anche farsi carne la parola, per i nostri piaceri ultraterreni... Ti onorerò, Gesù, con atti osceni... (Venga il destino e mi prenda alla gola... e lo spirito spiri). (Patrizia Valduga da Medicamenta, 1982) Esemplare unico in edizione elettronica conforme all’edizione cartacea della tiratura della presente edizione: in seicento copie distintamente contrassegnate e raggruppate in quattro serie Bachianas Brasileiras ============================== ========================================== ... ho sospeso il narratario non sapevo né chi né che cosa mi avrebbe regalato la vita potrei sospendere ora e per sempre di raccontare non so cosa e non so a chi —il narratario - lettore implicito— per raccontare cosa so e a chi so quanto devo a chi per primo ha scelto di essere il mio lettore esplicito: mi legge l’anima. A B C D serie « », « », « », « » di centocinquanta esemplari La copia cartacea viene distribuita in edizione filatelica dal «Laboratorio Altiero Spinelli» giornale in foglio con editoria elettronica da tavolo 20125 Milano via Arbe 29 tel./fax 02/6123586 direttore responsabile Fabio Trazza [email protected] ... ... ... ...solo un frammento di musica... ...quasi un frammento di bacio... La voce alta della Bachiana si libra dolce e intensa sulle corde basse e profonde dei violoncelli, le sfiora, le bacia, le anima, ne trasforma il pianto in lamento, lo innalza all’estasi. Vola nell’alto della più alta aquila ridiscendendone in pioggia di baci. Da voce a canto d’amore e, su corde vibranti, un sogno d’alcova. ...presto ricomporremo i frammenti... ...presto ricomporremo i sogni... ...presto rimarrà solo... ...l’essere musica... ...della parola... ...presto... ...piovano i baci... ============================== [ per: Heitor Villa-Lobos, Bachianas Brasileiras No. 5 (1938/1945) per Soprano e otto Violoncelli] ========================================== Ai miei lettori, che hanno espresso il desiderio di sottoscrivere un abbonamento, comunico di voler continuare, per il momento, a mantenere il narratario nel suo attuale stato di prodotto editoriale fuori commercio. Suggerisco loro l’opportunità di voler sostenere il “Laboratorio Altiero Spinelli”, associazione senza fine di lucro impegnata nel campo della formazione, della comunicazione e della diffusione dei valori del volontariato, alla cui nascita ha contribuito proprio il narratario. Tale sostegno rappresenta una ragione in più per ricevere il narratario e avere notizie del “Laboratorio”: Banca di Credito Cooperativo di Sesto S.Giovanni Codice ABI 8865-8 Conto numero 21609/75 intestato a “Laboratorio Altiero Spinelli”
Scaricare