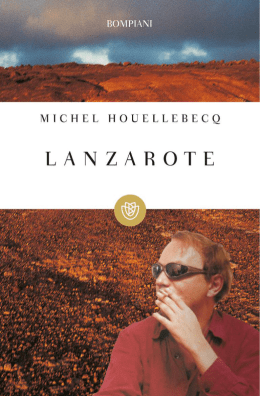Pierluigi Tamanini
un mucchio di parole
Smashwords Edition
Copyright 2013 Pierluigi Tamanini
ISBN 9781310623653
A Gianni Longhi,
se mai è esistito
A volte mi chiedo chi ce l’ha fatto fare
di rinchiuderci
dentro queste quattro mura grigie.
Luigi Alberti
Ho paura.
Giovanni Pietro Longo
Era tutto così semplice.
Zeno Zeni
Quando rinvenni mi ritrovai nudo, disteso su un pavimento freddo. Avevo un forte mal di testa.
Distolsi lo sguardo dal mio corpo: ero in una stanza che non avevo visto prima. Vicino a me c'era
un tavolo in legno massiccio: allungai la mano e mi aggrappai scivolando. Al terzo tentativo riuscii
ad alzarmi in piedi. Notai che al centro del tavolo c'era una scatola da scarpe rossa. La aprii. Dentro
c'era un'altra scatola rossa, poi un'altra, e così via finché nell'ultima scatolina, grande quanto
un'unghia del pollice, trovai un foglio bianco ripiegato più volte. Lo spiegai e iniziai a leggere.
Hai sette anni per uscire vivo...
Trasalii. Dovetti smettere. Tornò il mal di testa. Feci caso alla sedia che stava di fianco al tavolo.
Era anch'essa in legno massiccio. La spostai a fatica e mi sedetti. Poi ripresi a leggere.
Hai sette anni per uscire vivo da qui: dipende solo da te: da ciò che scriverai.
Finiva così, senza aggiungere altro. Rilessi da capo. Non aveva senso. Era uno scherzo di cattivo
gusto. Volevo tornare a casa, alla vita di tutti i giorni. Cercai di stare calmo. Forse era solo un
incubo, presto mi sarei svegliato.
Quando capii che non c'erano alternative, cominciai a scrivere. Era una vita che cercavo invano di
ritagliarmi uno spazio e un tempo per scrivere un romanzo.
UN MUCCHIO DI PAROLE
ai miei: padre, madre, sorella
1
X – L'ampiezza
Persi tutto in un istante: seicentomila euro e famiglia – padre, madre, sorella. A essere sincero non
avvenne in un istante. Mi trovavo nel bar di Vigolo, il paesino in cui ero cresciuto prima di
trasferirmi in città. C’era un’afa insopportabile: stavano tutti in piedi a tifare l’Italia. Gli unici seduti
eravamo io e i miei due migliori amici: Jo a sinistra e Zen a destra. Il mio destino dipendeva da quei
novanta minuti.
Un maxischermo, decine di occhi incollati.
Tre ex-compagni di classe delle elementari – che ormai stentavano a salutarmi – se ne stavano con
la schiena nuda davanti a noi, fischiando e saltando come ventenni, oscurandoci la visione della
partita. Fisici magri, scolpiti dalla fatica: non come noi tre, che sotto la maglietta nascondevamo
pancette flaccide e bianche come mozzarelle.
Birra, bestemmie, fumo di sigaretta. Ci giocavamo il passaggio in finale e io, un paio di mesi prima,
avevo scommesso che l’Italia avrebbe perso.
Anche se da tempo ho smesso di svegliarmi sconvolto da quell’incubo, ancora oggi ricordo ogni
gesto del giorno maledetto in cui decisi di scommettere: mi rivedo ancora lì, immobile, a osservare
l’edificio grigio nel quale sto per entrare. Se sono qui è per dirgli addio, mi dico facendomi forza.
Entro nell’enorme scatola di cemento e mi siedo in sala d’attesa. Mentre aspetto guardo i ricchi
Botero appesi alle pareti scure. Non mi piacciono. Né i quadri né le pareti. Quando è il mio turno mi
chiedo che ci faccio qui? È tardi per ripensarci. Mi alzo e senza rendermene conto mi ritrovo
davanti a uno sportello senza salivazione, inebriato dal sapore tipico dell’inculata.
Esco e m’incammino verso il centro. Nelle tasche – metà nella sinistra, metà nella destra – stringo
ciò che rimane di anni sperperati a lavorare. Ho la bocca impastata. Mi fermo a bere a una fontana,
le mani in tasca. Su un muro grigio c’è una scritta verde. Un aprile fresco e profumato. Mi
domando perché sia ancora lì.
Mentre bevo sorsate di acqua fresca, sento le mani sudare a contatto con le banconote. Non mi
azzardo a muoverle. Smetto di bere e riprendo a camminare, cercando di non pensare a niente.
E se perdo? penso invece. Se perdo me ne andrò a vivere nei boschi: ho sempre desiderato
abbandonare la società e rifugiarmi nella solitudine delle terre estreme.
Mi fermo. Alzo lo sguardo: la luce mi abbaglia: il duomo mi osserva ammonendomi dall’alto.
Adesso o mai più. Spingo la pesante porta con la spalla sinistra e le mani bagnate nelle tasche. Mi
sorprende un ultimo pensiero tanto facile da scacciare che scoppio a ridere. E lei?
La mia ragazza ha due possibilità: o molla tutto e mi segue, oppure, per quanto me ne importa, può
anche andarsene affanculo!
Sono dentro. C’è silenzio. Fa un freddo esagerato. Il sudore che ho addosso diventa di ghiaccio. Ho
un brivido lungo la schiena. Il pavimento è cosparso di fogli accartocciati verdi e azzurri. È sporco
di polvere e terra. C’è odore di pelle magrebina: dei disperati – alcuni in luride canottiere nere, altri
in camicie eleganti con enormi aloni sotto le ascelle – guardano silenziosi schermi fissati ai muri. Li
osservo chiedendomi cosa abbiamo in comune. Poi torno a occuparmi delle mie mani: le sento,
sono ancora lì, in tasca, incollate alle banconote.
In fondo al locale, in un angolo, c’è un vetro nero e lucido. Lo osservo da un po’. Visto dall’alto,
forma, assieme alle pareti, un triangolo isoscele di incredibile perfezione: le pareti sono i cateti, il
vetro l’ipotenusa. È proprio là, dietro a quel vetro, che finiranno tutti i miei risparmi.
Mi avvicino. Solo ora noto che dietro al vetro siede un uomo pelato e grasso con gli occhiali scuri,
la montatura spessa: ha un neo peloso al centro della fronte, quasi fosse un terzo occhio. Anche lui,
come tutti qui dentro, puzza di sudore da far schifo. Mi tremano di nuovo le gambe, quasi cedono.
Mi appoggio allo sportello. Faccio un lungo respiro. Estraggo le mani dalle tasche, una alla volta:
oramai sono un tutt’uno con le banconote. Con lentezza e tremando, apro la mano sinistra.
Appoggio le banconote sulla plastica ruvida e stacco dalla pelle l’ultima rimasta, aiutandomi coi
denti. Ripeto l’operazione con la destra, stavolta aiutandomi con la sinistra libera. Prendo tutte le
banconote e le sistemo ordinatamente di fronte al neo peloso del ciccione, il quale ha un ghigno
incomprensibile.
Qui il sogno finiva, e si trasformava in incubo: mi ritrovavo ogni volta da capo, lì, immobile, al
punto di partenza, di fronte alla banca con le gambe tremanti, e tutto si ripeteva all’infinito nella
stessa identica maniera, finché non mi svegliavo in un lenzuolo allagato di sudore con il cuore che
rimbalzava.
Potevo diventare ricco. Ecco perché era così importante quella partita, quei novanta minuti in cui
ventidue milionari rincorrevano senza sosta una sfera di cuoio – questo almeno sosteneva Zen.
Mentre tutti nel bar incitavano l’Italia gridando a gran voce e sbocciando boccali colmi di birra, noi
tre ce ne stavamo seduti in silenzio al tavolo coi nostri bicchierini e la bottiglia di Marzemino.
Durante l’intervallo Rai Uno ripropose le azioni salienti. Io, incurante del maxischermo, dal vetro
della porta d’ingresso, intravedevo la pioggia sbattere a terra, rimbalzare in aria e dissolversi in
impercettibili goccioline.
«Come va, Luigi?» mi chiese Jo quando l’arbitro fischiò l’inizio del secondo tempo.
«Non sento!» gridai a dieci centimetri dalla sua faccia da secchione.
«Ho detto come va?» mi disse nell’orecchio.
Alzai il pollice della mano destra.
«Sicuro?»
Allora feci segno con le dita che me la stavo facendo sotto.
Jo sorrise.
Mi voltai dall’altra parte. Zen mi dette una pacca sulla spalla e, col suo sguardo da criceto, mi fece
un occhiolino di incoraggiamento proprio mentre la voce del commentatore si faceva grave e nitida,
e la gente del bar si azzittiva. Alzai la testa e guardai il maxischermo giusto in tempo per vedere la
palla insaccarsi a mezza altezza nella rete della porta italiana.
Tutti cominciarono a gridare fuorigioco, arbitro di merda, è una ladrata, non è giusto, calimero
coglione... io, in fondo al locale, con lo sguardo verso il basso, stringevo i pugni sotto il tavolo con
Jo e Zen che mi davano gomitate senza farsi notare. Stavo piegato verso il pavimento cercando di
non sorridere. Non alzai lo sguardo nemmeno per vedere il replay del gol.
L’Italia stava per perdere e io stavo per vincere seicentomila euro.
Potevo licenziarmi, scappare in qualche paradiso tropicale e iniziare a godermi la vita.
Ancora tre quarti d’ora e il destino finalmente mi sorriderà, pensavo in quei momenti.
Y – La profondità
Giovanni, o semplicemente Jo, come lo chiamava Luigi, aveva passato gli anni dell’università
ricurvo sui libri.
Neanche il tempo di festeggiare con gli amici che si ritrovò, a soli due giorni dalla laurea, seduto a
una scrivania qualunque, in un'azienda qualunque, pronto a cominciare la vita che aveva sempre
sognato.
Gli capitò un lavoro di basso profilo, di livello appena mediocre a sentir lui. Eppure Giovanni
andava dicendo alla madre che sapeva quel che faceva. In pochi mesi lo avrebbero shiftato, proprio
così aveva detto, in un posto più adatto al suo indiscusso potenziale. E se anche qualcosa andava
storto, non importava, era giovane e intelligente, avrebbe facilmente cambiato azienda.
Non aveva dubbi: pochi anni e sarebbe entrato nella dirigenza. In fondo, mica voleva diventare
presidente, aspirava semplicemente a una posizione di rilievo, tutto qua. Era arrivato da una porta
laterale per la quale non era richiesta una specializzazione post-diploma, figuriamoci una laurea a
pieni voti come la mia!, aveva detto alla madre. Ma proprio perché partiva dal basso, la sua
cavalcata verso il successo sarebbe stata ancor più esaltante. A breve i suoi superiori gli avrebbero
domandato che ci faceva laggiù in mezzo al tanfo degli sfigati, come lui stesso li chiamava. Lui,
ammiccando, avrebbe risposto qualcosa del tipo Tutto nasce dal basso, signori! A quel punto lo
avrebbero pregato di salire al piano che gli spettava di diritto, quello dei laureati, il piano dei futuri
dirigenti. Una volta al fianco dei propri simili, si fa per dire, si sarebbe fatto strada rapidamente
grazie alle doti relazionali e alla spiccata naturalezza con la quale capiva le cose sempre prima degli
altri.
Nella testa di Giovanni tutto filava nel migliore dei modi. La giovinezza che aveva nel cuore gli
faceva vedere solo rose e fiori. Già si vedeva, di lì a due mesi, prendere l'ascensore per salire dal
quarto al sesto livello. E, una volta al sesto, nulla gli vietava di raggiungere, entro l’anno, il famoso
settimo livello: orario flessibile, paga doppia, mansioni esclusivamente gestionali, viaggi d’affari,
cene di lusso, raffinati corsi d’aggiornamento... Solo lassù, al settimo, avrebbe respirato un'aria pura
e si sarebbe rilassato per sorridere finalmente alla vita.
Aveva tenuto duro per venticinque anni: che gli costava resistere ancora un anno, o al massimo
due?
Ebbene sì, tanto breve immaginava la distanza dall’agognato livello dirigenziale, il nostro caro e
ingenuo Giovanni.
x
A quel tempo avevo trent'anni, una ragazza e un affitto da pagare. Era inverno. Un novembre grigio
come tutti quelli passati a Trento. Mi ero trasferito lì dopo aver trascorso i migliori anni in
provincia, a Vigolo, circondato dalle montagne. La laurea aveva rotto il mio idillio alpino,
facendomi capitolare in città.
Lei doveva ancora rientrare dal lavoro. La casa a quell'ora era strana. Ed era strano per me essere lì
solo di mercoledì pomeriggio, mentre tutto il mondo, fuori, lavorava. (Ricordo di aver pensato,
proprio in quel preciso istante, che meritavo almeno un paio di giorni al mese di malattia: era un
mio diritto: in fondo, nell'animo, stavo male davvero.)
Ero seduto alla scrivania. L'appartamento era buio. Dalla finestra entrava una luce sbiadita.
Osservavo la gente correre di qua e di là, le auto sbuffare in coda ai semafori: tutti intenti a
inseguire un significato che non c'era: un inutile affaccendarsi senza tregua nella mediocrità di un
mondo sempre più grigio, dove anche il sogno più bello e colorato svaniva nel nulla, senza
nemmeno dire addio.
Il mio sogno è vivere senza lavorare.
Di lì a sette mesi iniziavano i mondiali. Non ero un fanatico del calcio, anzi, avevo sempre preferito
un buon libro a una partita in televisione. Era tutta la vita post-lauream che mi sbattevo di qua e di
là per le vie di Trento sperando di trovare un lavoro degno di tale nome. Ero stomacato da quella
routine senza futuro.
Stomacato e incazzato.
Ecco com'ero a quel tempo.
"Se c’è anche solo una possibilità di cambiare le cose, di certo non me la faccio scappare" dicevo a
Zen ogni volta che andavo a trovarlo.
Avevo un obbiettivo: vincere seicentomila euro: un miliardo di vecchie lire – antica moneta in uso a
quell'epoca – era una bella somma per uno che faticava ad arrivare alla fine del mese.
Presi un foglio da terra chiedendomi come ci fosse finito. Le piastrelle del pavimento erano gelide e
coperte da successivi strati di polvere. Mi risollevai a fatica e cercai una penna che ancora
funzionasse.
Da buon ingegnere fallito provai a buttar giù un paio di conti – amo far di calcolo, come diceva
sempre Giovanni ai tempi dell'università. Dunque, vediamo… seicentomila (euro) diviso dodici
(mesi)… fanno cinquantamila (euro/anno)… cinquantamila (euro/anno) diviso mille (euro) –
sperando di non perdere almeno il beneficio di incassare mille euro al mese – fa cinquanta (anni).
Traduco: se avessi continuato a lavorare con quel ritmo senza nessun tipo di spesa – quindi esclusi
cibo, vestiti, cure mediche e, soprattutto, affitto – avrei guadagnato la stessa cifra che mi
prefiguravo di vincere, cioè seicentomila euro, in cinquant'anni. Non potendo vivere di sola aria
provai a considerare anche le spese di base. Queste, per un gran risparmiatore come il sottoscritto,
ammontavano – salvo imprevisti tipo figli o gravi malattie – a circa settecento euro al mese. Ora,
ipotizzando che la vita media sia di circa settantacinque anni, sarei riuscito ad accumulare quei
fottuti soldini novant'anni dopo la mia morte.
È matematico, quindi inconfutabile.
Ma allora perché aspettare una morte certa quando il mio unico desiderio era avere seicentomila
euro in quel preciso istante?
Per questo, sei mesi dopo prosciugai il mio conto in banca e puntai tutto.
Avevo un piano: licenziarmi e fare il giro del mondo cercando un posto dove vivere.
Y
Tutti in paese sapevano della triste storia di Giovanni. Tutti eccetto lui. E nessuno – nemmeno Luigi
e Zeno che lo conoscevano da una vita – osava rivelargli la verità.
La sua storia inizia con un'alba bianca nella notte nera. L’unico punto di riferimento per trovare una
strada sono le ciminiere che feriscono l’orizzonte e sputano di continuo fumo bianco, invisibile.
Qualcuno, presumibilmente una giovane madre di origine russa, durante attimi eterni in cui la neve
e il vento rendono difficile anche il camminare, lascia un fagotto sul ciglio di una strada. La
temperatura è di tre gradi sotto lo zero. La neve cade e comincia a coprirlo, e se continua così in
pochi minuti lo nasconderà.
Dal fagotto escono piagnucolii disperati.
Quel qualcuno non può che essere un qualcuno crudele e sconsiderato, ma non tanto da
abbandonare il fagottino in un posto qualunque.
Nella periferia desolata di San Pietroburgo, in quegli anni, c'era un orfanotrofio. Era stato collocato
in una vecchia fabbrica dismessa. Non era facile tirare avanti. I bambini abbandonati erano molti.
Proprio per questo motivo chi ci lavorava sapeva. Sapeva che era in quelle notti di neve, quando la
visibilità era ridotta a pochi metri, che le giovani madri lasciavano sul ciglio della strada i loro
fagottini, baciandoli per l'ultima volta, suonando il campanello e scappando. C'era sempre una
persona che faceva il turno di notte e aspettava che il campanello suonasse. Il problema era che quel
qualcuno, quella triste notte, indubbiamente afflitto da sensazioni fortissime e contrastanti, non si
era ricordato di suonare.
X
Quando sarò ricco cambierò ragazza. Ne sceglierò una più bella, più magra, senza cellulite. Magari
una modella con due seni prodigiosi e un culo sodo come il cemento.
Di sicuro non sarà l’ultima. Me la scoperò per bene e poi chi s’è visto s’è visto. Non che la reputi
una cosa saggia, ho semplicemente imparato che dopo tre anni (ma nel mio caso già dopo tre mesi)
la monogamia mi sta stretta, incomincia a puzzare di stantio. E non lo dico perché ce l’abbia con il
gentil sesso o lo reputi inferiore – anzi – solo non mi va proprio di svegliarmi ogni mattina con la
stessa cazzo di donna struccata dall’alito cadaverico.
Questo pensavo in quei momenti, mentre l'Italia era sotto 1 a 0 e io avevo in tasca un miliardo di
vecchie lire.
Come sapevo che avrei vinto? Semplice: vivevo come se già avessi vinto. Trovai il trucco – perché
di trucco si tratta – in un libriccino, l'estate precedente ai mondiali di calcio.
Camminavo in direzione dei Giardini Santa Chiara mangiando un'araba con tofu e melanzane. Non
avevo voglia di starmene chiuso in un bar ad aria condizionata con quelle mezze calzette dei
colleghi. Fuori c’era un sole accecante. Terminato il panino mi sfilai la canottiera arancione e mi
sdraiai sul verde osservandomi attorno. Il prato centrale era pieno di studenti della facoltà di Lettere
e Filosofia, chi fumava erba, chi giocava a pallone, chi studiava. Mi venne sete. Mentre, chinato in
avanti con il tronco girato di novanta gradi verso sinistra, bevevo l’acqua gelata della fontana, mi
imbattei con lo sguardo in una ragazza sola su una panchina. Ero miope e non portavo gli occhiali.
Eppure ero certo mi guardasse. Stava a un centinaio di metri. Tornai a sedermi. Aprii il moleskine e,
come ero solito fare, annotai i pensieri. Alzai lo sguardo per controllare se era ancora là. Poi
strappai qualche filo d'erba e l'annusai a lungo prima di lasciarlo volare via per sempre. La campana
della chiesa batteva le quattordici: cinque minuti e me ne sarei dovuto tornare al lavoro. Chiusi il
taccuino e lo infilai nello zaino. Era ancora là. Immobile. Indossai la canottiera arancione. Tre
minuti, il tempo stringeva. Il suo sguardo era ancora fisso su di me. Mi alzai e mi avvicinai. A passi
svelti. Ebbi un dubbio imbarazzante. Accelerai. Il dubbio divenne realtà. Nessuna ragazza.
Maledetta miopia! Era un cartellone incollato al muro qualche metro dietro alla panchina. Feci per
tornarmene da dove ero venuto, sperando nessuno notasse quant’ero stupido, ma mi accorsi che
sulla panchina c’era qualcosa. Un minuscolo libro senza prezzo né editore: un libro sui miracoli:
un'enorme miniera di verità della quale uno come Giovanni non avrebbe saputo che fare, ma che a
me cambiò la vita.
Al lavoro cominciai a leggerlo di nascosto. A casa iniziai a stilare una lista di desideri. Al primo
posto c’era, per chi non l’avesse ancora capito, NON DOVER LAVORARE PER VIVERE. Lo
scrissi in maiuscolo sul foglio bianco. Poi lo convertii in un più semplice VIVERE SENZA
LAVORARE.
"E se tutti la pensassero come te?" mi diceva Jo. "Lo so" rispondevo. "Non ci sarebbero più medici
pronti a guarirti, e forse neanche infermiere affette da burn-out a pulirti il culo quando sei vecchio:
sempre che ci arrivi a diventare vecchio, in questa società dove nessuno vuole invecchiare."
"Lasciamo perdere, Lu." "Tu non capisci, Jo, il cervello è fallace. Soprattutto il tuo!" gli ripetevo
dandogli una sberla sulla guancia. "La mente avrà sempre la tendenza a darti consigli secondo una
logica basata sulla tua estremamente limitata esperienza. Mi spiace dirtelo, ragionare logicamente è
la morte di quella parte di te capace di realizzare miracoli." Lui restava immobile con la faccia
inebetita. "Jo, sveglia!" gli dicevo. "Devi dribblare la ragione: se una cosa non è mai successa finora
– tipo che una figa te la dia – non è detto che mai succederà. D'ora in avanti il tuo obbiettivo
spirituale, vecchio Jo, consisterà nel superare l'attaccamento all’inconscio collettivo."
Perle ai porci.
y
Giovanni andava al lavoro deciso e volenteroso, senza mai tardare. La serietà con cui aveva
affrontato quell’umile occupazione era nota a tutti i colleghi del quarto.
Qualche giorno dopo la sua assunzione, aveva scoperto di avere un amico ai piani alti, per la verità
trattavasi di un lontano parente. Tramite le chiacchiere tra le loro madri, che erano cugine di primo
grado, aveva saputo che ci sarebbe stata una rivoluzione di livelli.
Solitamente non faceva pause in mattinata, ma il giorno seguente alla notizia che gli riferì sua
madre, si concesse un coffee-break, unico istante per poter sperare di dialogare con quelli dei piani
superiori. Scorse da lontano il cugino tra nubi di fumo e odore di caffè. Lo avvicinò timidamente
con lo sguardo verso terra. Il pavimento era ricoperto da decine di calzature nere, splendenti, con la
punta stretta e pronunciata, un po' in su, verso l'alto, come quelle di un marajà. Tra una scarpa e
l'altra, Giovanni vide una moltitudine di sigarette spente calpestate da poco. Si fermò a un paio di
metri dalla schiena del cugino per rassettarsi la cravatta, mettersi a posto il colletto della camicia e
ingerire tre mentine. Una volta dentro la loro nuvola di fumo, finì per tossire e le parole gli uscirono
a stento. Il cugino lo prese per un braccio e lo condusse in un angolo.
“Sono informazioni riservate! Vuoi che lo sappia il mondo intero?”
Giovanni spostò nuovamente lo sguardo verso terra.
Il cugino gettò il bicchierino del caffè e si accese un’altra sigaretta.
Giovanni non reagiva.
“Ascolta" disse prima di buttare per le scale la sigaretta appena accesa. "Non fidarti di nessuno. Qui
sembrano tutti amici, ma appena possono te lo mettono nel culo.”
Poi si guardò in giro sospettoso. “Uomo avvisato mezzo salvato” gli disse dandogli un buffetto sulla
guancia come si fa con i bambini.
Guardò l'orologio in pelle e fece per allontanarsi. “Ah, un'ultima cosa. Io qui dentro non sono tuo
cugino, quindi vedi di non farti più trovare in mezzo alle palle.”
Solo allora i loro sguardi s'incrociarono: l’uno minaccioso, l’altro spaventato.
X
"Come fai a sapere che funzionerà?" mi aveva chiesto Zen quando gli avevo detto che volevo
giocarmi tutto.
Eravamo al bar dell'università di ingegneria dove avevamo studiato per sei lunghi anni e dove ora
lui lavorava. Zen sedeva composto, mentre io in piedi gli parlavo animatamente lanciando braccia
all'aria nella speranza di dare enfasi alle parole.
"Ho cominciato a realizzare desideri, Zen!"
"Sentiamo."
"Ho corso la mezzamaratona di Riva del Garda, in notturna, due minuti sotto al mio record
personale. Ho perso tre chili in una settimana. Sono andato a letto, all'insaputa di chi-tu-sai, con un
gran pezzo di fica che avevo puntato a una festa: tutte cose impossibili, ma che, a forza di pensarci e
di desiderarle intensamente, si sono realizzate!"
Le matricole – quasi tutti ragazzi coi capelli unti – passavano come pecorelle smarrite osservandomi
senza il coraggio di sorridere.
"Secondo me si è trattato semplicemente di essere più convinto in quello che facevi..." disse Zen
guardandosi le mani. "Magari proprio per convincerti che funzionerà."
"Aspetta, non ti ho detto tutto. Il miracolo più incredibile, che qualunque scettico può verificare, è
quello della bacchetta magica. È sufficiente munirsi di un rametto di faggio di piccole dimensioni,
pensare intensamente all'evento desiderato, riaprire gli occhi, agitarlo in aria come a disegnare una
circonferenza, fare un paio di salti a piedi uniti..."
"Ma vaffanculo..." disse sfiorandomi con lo sguardo.
Sorrisi. "Ok, però c'è veramente un piccolo miracolo che ogni patentato può realizzare: quello del
parcheggio."
"Che noia, Luigi. Perché ti sei messo a credere a queste stronzate?"
"Ascolta, malfidente. Al mattino subito dopo aver girato la chiave e udito il motore rombare
debolmente, chiudo gli occhi respirando a pieni polmoni l'aroma nauseante di arbre magique al
pino silvestre e cerco di pensare intensamente alla zona in cui solitamente parcheggio, e di
visualizzare un posto-auto libero. Le volte – la maggior parte a dire il vero – che me ne dimentico,
oppure sono in ritardo e penso che la cosa migliore sia partire in quarta per recuperare il tempo
perso, non trovo mai posto, e perdo diversi minuti prima di trovarne uno, spesso lontano anni-luce
da dove lavoro."
"Coincidenze?"
"Forse, mistico Zen" dissi guardandolo dritto in quegli occhi da criceto. "Può anche darsi che siano
tutte stronzate: ma se l’universo intero ha cospirato in mio favore per dei piccoli desideri senza
senso, non lo farà per il sogno di una vita?"
"Torno a lavorare" disse Zen a quel punto.
Se ne andò scrollando la testa.
Prima di uscire, senza alzare lo sguardo da terra, mi disse: "Vedi di non fare stupidate."
Y
Fu un miracolo che quella mattina con l'arrivo dell'alba smise di nevicare, e che, con le prime luci
dell'aurora, il vento sparì e la temperatura poté salire fin sopra lo zero.
E fu un miracolo che chi consegnava il latte quel giorno decise, senza un apparente motivo, di
alzarsi un'ora prima del solito.
E fu un miracolo anche che, prima di suonare il campanello dell'orfanotrofio, invece di buttare
distrattamente la pesante cassa sopra la neve sul ciglio della strada, come faceva ogni mattina,
l'addetto alla consegna del latte tenne la pesante cassa in equilibrio sull'anca.
Quando l'infermiera uscì, forse per colpa del sole che le abbagliò la vista, andò a sbattere col piede
destro in un ammasso di neve più compatto del previsto.
"Ma..."
Capì subito il dramma in cui era incorsa. Si piegò per scavare nella neve. Raccolse il fagottino. Lo
pulì con una mano e, senza badare all'addetto alla consegna del latte che le stava di fronte a bocca
aperta, corse dentro con il neonato tra le braccia gridando: "Un'ambulanza! Correte a chiamare
un'ambulanza!"
Solo così, per alcune piccole coincidenze favorevoli, il neonato Giovanni, che quelli del centro
chiamavano Piotre, perché si era dimostrato duro a morire, si salvò da una morte certa.
E fu un miracolo che, dopo un paio d'anni passati in misere condizioni nell'orfanotrofio degli orrori,
arrivò una chiamata dall'Italia. E dopo la chiamata due nuovi genitori.
"Prendiamo quello" disse la giovane in minigonna rivolta al marito.
"Piotre?" chiese l'infermiera.
"Sì, lui" risposero entrambi indicandolo. "Quello lì, quello bello."
X
Al ventesimo minuto del secondo tempo, mentre l’Italia faticava a superare la batosta e io sudavo
come un disperato pensando a cosa ne avrei fatto di tutti i soldi che stavo per vincere, entrò al bar
un carabiniere con due grossi baffi grigi e l’uniforme blu bagnata di pioggia. Non mi era nuovo.
Lo riconobbi. Due settimane prima mi aveva fermato per eccesso di velocità mentre andavo a casa
dei miei. Avevo lasciato la ragazza a Trento per starmene qualche giorno al fresco, in mezzo alle
montagne.
«Patente e libretto.»
«Perché?»
«Non se lo faccia ripetere.»
Gli porsi la patente che tenevo nel portafoglio consumato e cercai il libretto senza sapere come
fosse fatto.
«Ecco.»
«Questo non è il libretto, signor Alberti.»
«Ma perché mi ha fermato? Mi ero appena slacciato la cintura come faccio sempre poco prima di
arrivare a destinazione. Mancano solo un centinaio di metri...»
«Sentiamo, e dove abiterebbe? Non l’ho mai vista prima a Vigolo.»
«Sto andando dai miei, a salutarli prima che partano per il mare.»
«Ah, ho capito, allora sei il figlio dell’Alberti...»
«Esatto. E se non mi sbrigo partirà senza che lo possa salutare.»
«Facciamo in fretta. Lei cerchi il libretto e io intanto le faccio la multa.»
«Ma... come? Le ho detto che le cinture le avevo appena tolte!»
«Abbassi la voce. Quando l’ho fermata aveva le cinture slacciate, un fanale rotto e stava andando
agli ottanta.»
«Ah.»
«Sì, e quindi se ha fretta si sbrighi a trovare il libretto e io le farò solo la multa per eccesso di
velocità.»
Guardai lungo la strada asfaltata che scendeva verso l’oratorio arancione dietro il quale c’era la casa
dei miei. Non passavano macchine. C’era un silenzio al quale non ero più abituato. Alzai le spalle.
«Tanto faccio ricorso.»
Il baffone sbottò in una risata che risuonò lenta nell’afa del pomeriggio.
«Faccia come vuole, ma io intanto la multa gliela do più che volentieri.»
«Lo dirò a mio padre.»
«Glielo dirò anch’io appena lo vedo, che ha un figlio maleducato e disonesto» disse. «Dovresti
imparare da tuo padre.»
Ora, nel momento in cui mi stavo giocando tutto, era di nuovo tra le palle.
Tornai a guardare il maxischermo. La partita era ancora sull’1 a 0 e i miei seicentomila euro in
tasca. Avevo già indovinato quattro eventi sui cinque per i quali mi ero giocato ogni centesimo del
mio conto in banca. Mancava soltanto quella stupida partita.
Il carabiniere riapparve alla mia vista. Stava in piedi sulla porta a cinque metri da noi e ci fissava
severo. Tornai ancora al maxischermo, ma lui con un dito mi fece un segno. Tra il frastuono cercai
invano di leggere il suo labiale. Poi distolsi lo sguardo convinto fosse un’allucinazione. Ero troppo
agitato dalla partita per capire. Con la coda dell’occhio lo vidi avvicinarsi al nostro tavolo. Io
fissavo lo schermo, sperando di aver visto male.
«Alberti» disse al mio orecchio, «le devo parlare.»
Lo guardai incredulo. «Adesso?»
«Ora.»
Jo si strinse nelle spalle. Zen sembrava preoccupato.
Il carabiniere si era già dileguato.
«Non preoccupatevi sarà per la multa che gli ho contestato l’altro giorno.»
Mi alzai.
«Torno subito.»
Y
Le giornate passavano veloci. Il lavoro era semplice, non per questo Giovanni lo prendeva
sottogamba. Era deciso a dimostrare il suo valore. Con tutta probabilità, e Giovanni lo sapeva bene,
di lì a pochi giorni lo avrebbero promosso. Se la voce sulla rivoluzione dei livelli era vera,
l’occasione poteva essere buona per innalzarsi direttamente al sesto piano, saltando a piè pari il
quinto, tipicamente occupato da una fauna di neolaureati, o diplomati con esperienza e talento.
Quando Giovanni, come ogni lunedì mattina, si sedette sorridente alla scrivania, trovò una lettera.
La scartò con avidità. Già pensava alle lodi che gli avrebbe tessuto la madre quella sera. Teneva la
lettera con entrambe le mani, i gomiti ben piantati sulla scrivania, quasi volesse rendere il momento
solenne: l'inizio della scalata ai vertici del potere. Uno strano pallore gli invase il volto,
trasformando il sorriso altezzoso in un’angosciosa paresi. La lettera non nominava nessun sesto
livello. Né un quinto. Senza alcuna spiegazione lo si invitava a prendere gli effetti personali e
recarsi al piano inferiore, il terzo. Nemmeno l’ingegner Longo, bensì l’impiegato Giovanni Longo. I
pugni gli tremavano sulla scrivania. Vide in lontananza alcune facce sorridenti. Gli sembrava che
dietro agli armadi qualcuno sghignazzasse. Giovanni si alzò e si diresse verso il bagno. Mentre
richiudeva la porta incrociò lo sguardo di un collega e notò nei suoi occhi una beffarda immagine di
sé. Chiuse a chiave la porta e prese a dare testate contro il muro, mentre un paio di lacrime gli
solcavano il viso ancora giovane e liscio. Si asciugò, uscì dal bagno con passo svelto, raggiunse la
scrivania, raccolse scartoffie, penne e calcolatrice, e se ne andò verso l’androne che portava alle
scale. Ride bene chi ride ultimo pensava, mentre scendendo la scalinata incrociava la gente
sorridente che saliva, ognuno col proprio fagotto, per occupare scrivanie più appetibili, certamente
anche la sua. Senza badare alla puzza acre e allo squallore diffuso che lo circondava, sistemò le sue
cose sul primo banco libero. Era lunedì mattina e si sentiva già esausto. Si sedette e prese la testa tra
le mani. Quando la rilasciò si accorse di avere sete. La bocca gli si era prosciugata. Gli venne il
dubbio di essersi addormentato. L'orologio al polso faceva le undici e quaranta. Senza guardarlo in
faccia, chiese al collega più vicino dove poter bere un bicchier d’acqua. “Rangete!” fu la pronta
risposta. Trovò allora la forza per rialzarsi da questo primo smacco lavorativo, cercò un bagno,
respirò il fetore di fogna che lo invadeva senza farci troppo caso, e bevve dal lavandino un'acqua
tiepida e giallastra. Si rialzò e si guardò allo specchio cercando risposte. Senza trovarne. Uscì e
tornò a sedersi al suo posto attendendo invano che qualcuno gli spiegasse la sua nuova mansione.
Z – L'altezza
Tu.
Tu fai quello che ti dicono di fare. Prendi dei bei voti. Sei gentile.
Sei stato educato al bene.
Tu.
"Prendila in braccio, Zeno!" grida la folla.
Tu sei in imbarazzo, con tutti quegli occhi addosso. Eppure sorridi, prendi tua moglie tra le braccia
e la baci. Anche lei sorride.
Vi arrivano in testa i chicchi di riso. Tutti urlano i vostri nomi. Fanno foto. Saltano.
"Dis-cor-so! Dis-cor-so!"
Tu lo sapevi che sarebbe successo. Sapevi già tutto. Lei ti guarda. Anche lei vuole sentirti parlare.
Il tuo sorriso diventa forzato, di questo sei certo. Speri soltanto che gli altri non se ne accorgano.
Pensi a cosa dire. Almeno alle parole per cominciare.
È una tortura per te questa festa. Sei tu il centro dell'attenzione. Sei tu il genio, tu il modello di
perfezione, tu il mistero che tutti, compresa tua moglie, vorrebbero svelare.
Ma tu non rischi, aspetti. Speri che quelli desistano.
Li guardi, li supplichi con gli occhi.
Sai che non la smetteranno.
Allora decidi di giocarti il tuo asso nella manica.
Ti avvicini all'orecchio di tua moglie e le sussurri un ti amo che è una supplica. Sai che lei ha
capito, ma purtroppo sai anche che tua moglie fingerà di non capire. Anche lei desidera ammirarti.
Anche lei ti vuole mettere a nudo. Vogliono tutti sentire la tua voce.
Le parole non ti vengono. Te ne viene in mente una. Una soltanto. Ma tu la scarti continuamente,
sai che non si accontenterebbero di un semplice grazie. Vogliono di più quelli.
Sarà quasi un minuto che tieni tua moglie tra le braccia, una ventina di secondi che tutti gli invitati
ti guardano gridando: un paio di attimi eterni che sei nel panico.
Vorresti scappare.
E invece no, non è da te scappare. Ricordati che indossi una maschera. Non puoi cambiarla così,
senza preavviso. No, mi dispiace, tu non sei uno che scappa.
O forse sì?
Vorresti gridare un bel vaffanculo, ma non puoi. Non l'hai mai fatto. Non vorrai mica farlo proprio
ora!
Adesso devi smetterla di interrogarti. Fuori il frastuono sta cessando. Ti vogliono ascoltare.
Vogliono ascoltare il tuo silenzio, i tuoi pensieri illuminanti: le parole sacre che la tua mente
produrrà.
Lasci scivolare dolcemente a terra le gambe di tua moglie. La prendi per mano, chiudi gli occhi e
finalmente dici: " ".
Y
Giovanni notò che sua madre era strana. Era strana nonostante lui avesse deciso di non dirle niente.
Aveva preferito rimanere solo con la sua rabbia. Quella notte fece fatica ad addormentarsi. Al terzo
piano non ci voleva stare. Le regole erano diverse dal quarto: niente pause caffè, nessun contatto coi
piani superiori, inflessibilità d’orario: pareva un’altra azienda: non ci si poteva certo sentir parte di
un gruppo più ampio. L’entrata era fissata per tutti alle 7,30; la pausa pranzo dalle 12 alle 12,30;
l’uscita alle 16. Non c’era possibilità alcuna d’incontrare uno dei piani superiori né al mattino, né in
pausa pranzo, né tanto meno al momento di uscire. Come se tra il terzo e il quarto piano ci fosse un
abisso incolmabile. Figuriamoci come dovevano sentirsi quelli del secondo e del primo! Lo
stipendio di Giovanni fu decurtato del venti per cento. Gli fu tolta la calcolatrice, perché poteva
essere utile a qualcuno del quarto. A lui sarebbero bastati carta, penna e un telefono fisso. Lo
stanzone dove erano stipati gli impiegati del terzo era buio e poco aerato, quasi fosse un locale
sotterraneo. Non c’erano finestre. Solo pochi anni prima quella sala era stata adibita a magazzino, e
ancora nessuno si era preso la briga di trovare una soluzione. La luce era artificiale e fioca. Il tanfo
non ne voleva sapere di andarsene.
Giovanni, infuriato per il suo declassamento, il giorno seguente chiese di poter parlare con un
superiore al fine di chiarire la sua situazione, ma nessuno sapeva aiutarlo.
“Voglio parlare col capo. Di qui non mi muovo” insistette Giovanni con la segretaria del quarto.
“Guardi che lei non potrebbe neanche accedere a questo piano: scenda subito” disse l’altra tornando
a leggere il libro in lettere cirilliche che aveva sopra la scrivania.
“Questo lo dice lei. Guardi che io ho una laurea da centodieci e lode.”
“Ah sì?” disse lei pensierosa. “E cosa ci fa giù nel garage?”
“Veramente mi ci avete messo voi in quella stalla. Io una volta lavoravo qui al quarto!” disse
Giovanni alterato.
“Strano” sussurrò la ragazza tra sé e sé. “Ci dev’essere stato un errore... Comunque piacere, io sono
Salomè.”
“Salomè? Ma allora non sei italiana?”
“No, non si sente?” disse rabbuiandosi. “Comunque non mi trovo granché in questo buco di culo.”
“Non hai peli sulla lingua, eh?”
Lei si passò un dito in bocca non capendo. “Capelli sulla lingua?”
“No” disse Giovanni sorridendo. “Intendevo chiederti se detesti il Trentino o l’azienda?”
Lei pareva non voler rispondere.
"Mi piace l'Angi's pub. Lo conosci?"
Giovanni lo odiava quel posto. Era il locale preferito di Luigi. Sorrise, pensando a qualcosa di
carino da dire.
“Ah, a proposito io sono Longo, piacere” disse allungando la mano.
“Longo? Che nome è?”
Giovanni si dette una pacca sulla fronte. “Ops, scusa, che stupido… mi chiamo Giovanni, piacere.”
Salomè non si limitò a stringergli la mano, ma lo baciò su entrambe le guance.
Un signore altissimo e magro in giacca e cravatta li stava osservando.
“Scusate se disturbo” disse. “Che ci fa lei qui, sior? È nuovo?”
“No, a dire il vero, lavoro al piano di sotto. Sono qui per…”
“Torna subito in garage, allora!” disse quello non riuscendo a trattenere un leggero ghigno. “E io
che ti davo del sior... Via! Rapido! Lavorare!”
“Devo urgentemente parlare con un superiore. Ieri mi è arrivata una lettera…”
“Forse non hai capito, te lo ripeto per l'ultima volta: giù di sotto, subito!” gridò facendo l'occhiolino
alla segretaria.
Giovanni non ebbe neanche il tempo si salutarla che si ritrovò a correre in malo modo giù per le
scale. “Se hai qualcosa da dire fai riferimento al tuo responsabile di servizio!” Sentì l'uomo ridere,
sempre più in alto, sempre più lontano.
Mentre se ne stava seduto alla scrivania con gli occhi chiusi, ripensava a quella ragazza. Era stata la
prima in azienda a rivolgergli la parola in modo gentile.
Decise allora di lasciar perdere e si concentrò sul lavoro. Con gioia si accorse di essere molto più
capace dei suoi nuovi colleghi. Quando si trattava di scrivere una lettera importante, veniva subito
interpellato: “ma, Longo, tanto meno va attaccato o staccato?” o ancora “Longo venire puoi qui un
attimo a vedere se scritto giusto ho?” oppure “Longo, ti che t’hai studià, no l’è che te podresi
ciamar ti al me posto? Te sai ben, l’è ‘n cliente straniero, de zo per Roma, sat?”. Giovanni era
felicissimo di essere diventato in poche settimane il punto di riferimento dell'intero piano.
Comprese la ragione del declassamento: era stato spostato al terzo per le innate doti di disponibilità
e umiltà verso il prossimo: il nuovo impiego era un test per misurare le sue doti nel campo della
gestione del personale. La faccenda era talmente evidente che non andavano scomodati i grandi capi
per discuterla. Decise che ce l’avrebbe messa tutta per gestire al meglio il reparto. Avrebbe atteso
che fossero i dirigenti dei piani superiori ad accorgersi di lui. Si mise il cuore in pace e tornò a
cullare la speranza di poter risalire in fretta la gerarchia dell’azienda.
X
«Mi dispiace disturbarla proprio ora, ingegnere, ma...»
La pioggia cadeva fitta e, nonostante fosse luglio, la temperatura non superava i quindici gradi.
Nessuna stella, solo un paio di lampioni e il campanile della chiesa a un centinaio di metri.
«Senta» dissi, «se proprio non le va giù, gliela pago quella cazzo di multa, e spero che poi la
faccenda si possa considerare conclusa. Non mi va di rovinarmi la vita per qualche spicciolo. Ora
però mi lasci tornare dentro. Andrò a pagare già domattina. Va bene? Grazie, arrivederci.»
Feci per tornarmene dentro quando lui mi prese per un braccio.
«Aspetta, Luigi, non è di questo che ti devo parlare.»
«Che c’è?»
«Vieni, sediamoci laggiù, su quella panchina.»
«Ma... non si è accorto che piove che dio la manda?»
«Non ha importanza.»
Ci andammo a sedere su una panchina bagnata sotto il campanile illuminato. Lungo il tragitto il
carabiniere mi aveva tenuta la mano sulla spalla. I cori della gente che incoraggiava l’Italia
arrivavano fin lì. Si sentivano forte. Il carabiniere mi osservava senza parlare, cercando forse le
parole. La campana della chiesa batté le ventidue. Ancora un quarto d’ora e sarei diventato ricco.
Ma c’era questo carabiniere che mi guardava senza fiatare e la cosa cominciava a inquietarmi.
Lo fissai anch’io e in un istante mi fu tutto chiaro: colsi nei suoi occhi lucidi un senso di morte.
Y
“Caro, c’è una lettera per te! Vuoi che te la apra?”
“No, aspetta, mamma! Faccio io!”
Giovanni corse in cucina agitato. Sua madre vestiva un abito di seta azzurra che metteva in risalto
un fisico ancora giovane e prestante. "Lasciare stare le mie cose."
Era un sabato mattina e fuori splendeva un sole africano. I ragazzini in lontananza giocavano a
pallone alzando polvere e poesia. Gli uccelli fischiettavano sugli alberi e le farfalle galleggiavano
nell’etere come mille bolle colorate.
Ma Giovanni era troppo preso dalla lettera per accorgersene.
“Con la seguente… per un impiego a tempo indeterminato di quarto livello presso i nostri uffici di
Padova… di parlarne direttamente con lei nella nostra sede...”
“Giova, non sei felice? Hai trovato il lavoro che tanto aspettavi. Finalmente ti sistemi!” disse la
madre abbracciandolo. I grossi seni premuti contro l’esile petto di Giovanni. “Peccato che mi
lascerai qui tutta sola…”
In silenzio rilesse la lettera scostandosi la madre di dosso.
“Cos’è quella faccia? Non sei contento?” disse lei sorpresa.
“Non credo accetterò, in fondo ho iniziato da poco a lavorare nell’azienda, mi sembra scorretto
andar via senza aver capito quali progetti abbiano per me?”
“Ma se ti hanno addirittura sceso di livello!”
“Si dice abbassato di livello” disse Giovanni alzando la voce. “È una grande società quella per cui
lavoro. Sono partito dal basso, è vero, ma proprio per questo posso aspirare ad arrivare fino in
cima.”
Giovanni sorrise e guardò le montagne stagliarsi lontane all’orizzonte.
“Ma se sei pure a tempo determinato, figlio mio” disse lei corrugando la fronte.
“Ti sbagli, mamma, mi è arrivata giusto ieri una lettera che spiegava la volontà di stabilizzare tutti i
dipendenti entro fine anno.”
“Ah sì? Quindi anche qui a Trento avresti delle garanzie?”
“Certo, è proprio questo che mi fa dire di no alla proposta di Padova. La loro azienda è molto più
piccola e più giovane della nostra. Chi può dire che tra qualche anno non fallisca? Dove lavoro ora
non c’è questo pericolo: abbiamo centinaia di dipendenti e un’esperienza nel settore più che
ventennale.”
“Quindi hai già deciso.”
“Esatto, mamma” disse felice. “Prendi Zeno, guadagna ottocento euro. E Luigi? Lo sai che Luigi
prende ancora meno e lavora più di tutti…”
“Com’è che non si fanno più vedere? Ormai mi ero abituata alla loro presenza.”
“Sì, sì, lo sappiamo, mamma, lo sappiamo!” disse Giovanni in tono brusco. “Tornando a me, è
ancora presto per cambiare. Prima voglio capire a che ruolo posso aspirare nell’azienda. Non mi do
per vinto!”
“Bravo, Giova! Tieni duro. Vedrai che otterrai quello che meriti” disse abbracciandolo col vestito
che le saliva sopra le natiche.
z
piede sinistro rilassato
il piede sinistro si rrilassa
piede sinistro rilassato
rilasssssato
gamba sinistra rilassata
la gamba sinistra si rrilassa
gamba sinistra rilassata
rilasssssata
piede destro rilassato
il piede destro si rrilassa
piede destro rilassato
rilasssssato
gamba destra rilassata
la gamba destra si rrilassa
gamba destra rilassata
rilasssssata
bacino rilassato
il bacino si rilassa
bacino rrilasssato
rrrilasssssato
mano sinistra rilassata
la mano sinistra si rrilassa
mano sinistra rilassata
rilasssssata
braccio sinistro rilassato
il braccio sinistro si rrilassa
braccio sinistro rilassato
rilasssssato
mano destra rilassata
la mano destra si rrilassa
mano destra rilassata
rilasssssata
braccio destro rilassato
il braccio destro si rrilassa
braccio destro rilassato
rilasssssato
colllo schiena rilasssati
bacino rilasssato
spallle braccia rilasssate
piedi gambe rilasssati
tutto il corpo si rrilassa
il corpo è rrilasssato
rrrilasssssaaato
Y
Un giorno, mentre rapido saliva le scale, Giovanni fece una scoperta tanto sciocca quanto tragica: si
accorse che dal piano terra al piano dove lavorava c’erano due rampe di scale. Questo significava
che il terzo livello in realtà era collocato al secondo piano.
A pranzo, come al solito, Giovanni metteva freno al suo affaccendarsi e cercava d’integrarsi coi
colleghi, sperando di carpire informazioni importanti.
“Cos’è? Uno scherzo?”
La tavolata era imbandita. Piatti di affettati frammisti a brocche d’acqua e boccali di vino rosso
stavano al centro della tavolata. Una trentina di dipendenti rilassati e sorridenti erano intenti a
divorare della pasta al ragù che emanava nella stanza un forte odore di carne.
“No, cari i miei Longo, no è scherzi, è verità!” disse uno di quelli, ergendosi in tutta la sua
lunghezza. Era il più grosso. Faceva paura solo a vederlo. "Tu tranquilli, niente per te è cambiati."
“No laora nesun soto” disse un altro.
Tutti presero a sghignazzare animatamente.
“Sentite, ma allora cosa c’è al primo piano?”
“En garage, mona” disse uno. “El garage dela dirigenza, coiòn!”
“E perché allora lo chiamano terzo livello?”
Giù tutti a sbellicarsi ancora.
“Longo, io no so perché chiamano terzi di livelli, fatti è che noi siamo ruote di carri!” disse
dandogli una pacca sulla spalla. “Fatti le ragioni!”
Giovanni ebbe un colpo al cuore. Per un attimo gli mancò il respiro. Buttò giù un tozzo di pane e
bevve un bicchier d’acqua. Un'acqua insolitamente amara.
“Rilassati, goditi, qui hanno mai licenziato nessuno. Mangia beni. Lavora pochi. E alle quattro già
fuori da queste prigioni, senza pensieri! Prendi così, non hai niente da perdere, spassati!”
“Sì, rilassa e diverti te stesso! Troppo non pensare! Il più intelligente di tutti sei, in un’ora fare puoi
quello che in un giorno fare devi.”
“Tu sei il laureati di primi che abbiamo qui giù” disse quello grande e grosso. Quando parlava lui
tutti tacevano. “Inoltre ammiri che più presto ti sposteranno. Qui con noi a lunghi tu non giaci.”
“Speriamo” riuscì a dire Giovanni giocherellando con le briciole. Aveva gli occhi sbarrati e tesi. Gli
altri lo videro in difficoltà e gli riempirono il bicchiere di rosso, pur sapendo che quel vino da poche
lire non gli era mai piaciuto.
“Bevi, dottori Giovanni Pietro Longo! Brindi con noi alle aziende che sfama noi e i nostri famiglie”
disse ancora lo straniero.
“Almeno c'è qualcuno che conosce il mio nome di battesimo” pensò Giovanni abbozzando un tenue
sorriso. Alzò il bicchiere per il brindisi e bevve il vino tutto d’un fiato in una smorfia di dolore.
Suonò la sirena e tutti tornarono in fretta alle proprie occupazioni, o presunte tali.
Decise di telefonare al cugino. Sua madre riuscì a procurargli il numero di cellulare.
"Ciao, sono Giovanni, tuo cugino."
"Tuo cugino un paio di coglioni! Chi cazzo ti ha dato il mio numero?" disse. "Ma non ti hanno
ancora licenziato?"
"Non ancora, però mi hanno messo nel garage."
"Nel garage? Ma che cazzo hai combinato per finire in quella fogna? Laggiù saranno una decina ad
avere un diploma, lo sai? E di quella decina almeno la metà sono immigrati. Te ne sarai accorto,
spero?"
"Sì..."
"E allora che cazzo ci fai laggiù con una laurea in ingegneria da centodieci e lode? Sei tutto
scemo?"
"Non mi ci sono messo io nel garage..."
"Cazzo, ma perché ti hanno messo con gli ex-operai?"
"Ex-operai?"
"Non ci ho mai messo piede per mia fortuna, ma mi hanno detto che laggiù ci mettono gli operai
malandati che non riescono più a lavorare in fabbrica o sui cantieri. Ma che cazzo ci fai nel garage?
Sarai almeno il dirigente, immagino."
"Be', certo, ovvio. Ci mancherebbe" disse Giovanni. "Però ti volevo chiedere se potresti aiutarmi a
tornare almeno al quarto. Sai, non credo sia salutare respirare il fumo di sigaretta e tutto il resto..."
"Capito" disse. "Però quello che mi chiedi è impossibile, ho già i cazzi miei a cui pensare."
"Basterebbe una parolina..."
"Be', allora ci sentiamo, ciao ciao."
"Ciao" disse Giovanni quando suo cugino aveva già riattaccato.
Giovanni quando si guardava allo specchio vedeva un fallito. Non aveva neanche trent’anni e già i
capelli erano radi e brizzolati. La stempiatura avanzava a ritmi vertiginosi. Le spalle, dopo giorni e
notti passati sui libri, si erano incurvate in avanti.
“Forse era meglio se me la prendevo con più calma e me ne andavo anch’io un anno in erasmus
come hanno fatto Zeno e Luigi!” pensava ossessivamente nelle lunghe notti senza dormire. “A cosa
è servito studiare tanto?”
x
«Mi dispiace, Luigi» disse facendosi scappare sulle grandi guance rosse due scie di lacrime.
Ebbi la sensazione di cadere. Mi sentivo mancare, svenire. Senza forze. Come se il mondo stesse
crollando portandomi con sé. Il carabiniere mi abbracciò cercando di sostenermi. Io scoppiai a
piangere in silenzio. Lasciandomi andare. Corpo morto in quelle braccia forti.
A quel punto ci fu un boato. Un grido fortissimo di gioia. Fischi e risa uscivano dal bar, mentre io
chiudevo gli occhi e bagnavo di lacrime calde la camicia azzurra del carabiniere già fradicia di
pioggia.
«Hanno pareggiato» mormorò.
«Già» dissi senza muovermi.
Rimanemmo lì immobili ancora qualche attimo finché lui mi lasciò dicendo: «Arrivano i tuoi
amici.»
Mi presi la testa tra le mani e, sempre a occhi chiusi, la appoggiai sulle ginocchia gocciolando
pioggia e lacrime, cercando di dimenticarmi di tutto e concentrarmi sul solletico che mi
procuravano le gocce scivolando una a una sulla punta del naso.
«C’è stato un incidente sulla Valsugana all’altezza di Borgo Valsugana...» disse in lontananza il
carabiniere distraendomi.
Poi sentii Jo e Zen sedersi sulla panchina e abbracciarmi.
«Meglio spostarsi da qui» disse Zen.
«Non ce la faccio.»
«Su, forza» disse Jo sollevandomi aiutato da Zen. «Ti portiamo a casa.»
Ci incamminammo lentamente, incuranti del diluvio. Davanti al bar si respirava una forte tensione.
Avevo gli occhi puntati verso terra, senza la forza per alzarli. Osservavo i sampietrini lucidi di
pioggia scorrere rapidi sotto il mio sguardo passivo. Avanzavamo a piccoli passi. Senza parlare.
Quando fummo in fondo alla strada, pronti a svoltare verso destra per raggiungere casa dei miei, si
udì una enorme esplosione provenire, non solo dal bar, ma da ogni singola casa. Tutti gridavano
gol, siamo in finale, abbiamo vinto. Le finestre erano aperte e si sentivano urlare i vecchi, gli adulti,
i bambini. Non c’era silenzio quella notte. Non si sentiva nemmeno il rumore della pioggia.
«Ho perso tutto» dissi sotto casa.
Poi sentii Zen sussurrare: «Meglio se dormite da me.»
«Forza» disse Jo spingendomi, «siamo quasi arrivati.»
Y
Giovanni riuscì a fissare un appuntamento con un superiore, ma il giorno del grande incontro si
ritrovò una busta sulla scrivania e si dimenticò totalmente dell'incontro con il superiore. Non aveva
il coraggio di aprirla, così decise di lavorare almeno un'ora. Dopo un'ora si disse di aspettarne
un'altra. E così via, finché suonò la sirena del pranzo. La lesse allora trattenendo il respiro.
...il vicepresidente della società è lieto di annunciarle la sua definitiva assunzione nell’azienda per
l'eternità.
Giovanni prese il foglio dattiloscritto e se lo strinse al cuore. Ce l’aveva fatta, bastava una firma sul
contratto allegato alla lettera e poteva dire addio per sempre al precariato. Pensò a sua madre. Ai
suoi continui incoraggiamenti durante gli anni dell'università. Non vedeva l’ora di tornare a casa per
mostrarle il contratto: era uno dell’azienda: addio crisi!
“Ehi, guarda qui!” disse sorridendo al primo che passava per andare in mensa.
“S’èlo quela roba? I te licenzia?” disse il collega con tono indifferente. “Fame veder, Longo.”
Un altro gli strappò la lettera di mano e la lesse.
“Ragazzi, un attimo di attenzione! Silenzio! Sono felice di annunciarvi che abbiamo un altro
coglione che si è fatto fregare!”
Tutti risero a crepapelle. Giovanni non capiva perché ridevano, e soprattutto perché gli si dava del
coglione.
“Modera i toni, se non vuoi che lo dica al capo!”
“Quale capo?” gli rispose l’altro. E giù tutti a piegarsi in terra dalle risate. “Hai mai visto un capo
qui dentro? Svegliati, Longo. Se vuoi sopravvivere, sbasa le recie!”
Non capiva a cosa erano dovuti quegli sfottò gratuiti e crudeli. Si riprese la lettera e, decidendo che
poteva fare a meno di mangiare con quegli energumeni senza cervello, tornò a lavorare, o finse di
farlo: la sua mente era invasa da pensieri contrastanti: l'animo in pena.
Poco prima delle sedici, Alex, il più amichevole dei colleghi, gli si avvicinò.
“Ti vai di sorseggiare birri fuori dei lavori?”
Giovanni fece un cenno col capo.
Timbrarono il cartellino e uscirono.
Il collega si diresse all'Angi's pub. Giovanni lo seguì.
“Due birri per un favori.”
“Senti, Alex, io non ci capisco più niente..." disse senza guardarlo. "Anzi, a dire il vero io non ci ho
mai capito niente di questa azienda.”
Il viso di Giovanni era attraversato verticalmente da una scia salata.
“Ti comprendo in maniere perfette. Non serve a nulli di piangere. Anch’io sono qui da più di dieci
di anni e sono sempre rimasti ai miei posti fermi. Mai una progressioni, mai un aumenti. Niente di
nulli. Nelle nostre aziende nessuno ti regala niente di nulli, ricordatelo. Meno che tu…”
“A meno che?” disse Giovanni asciugandosi con la mano e cercando per la prima volta gli occhi del
collega.
“A meno che tu non hai spinti di alti. Lo sai come funzionano cosi di affari in grandi società, no?”
disse sputando sul pavimento. “A parti questi, è come essere in posti di pubblici, ma si sgobba un
po’ di più e si hanno meno di diritti.”
“E perché allora te ne resti qui?”
“Che vuoi che faccio di ora mai? Ho quasi quaranta di anni, stranieri e famiglie sulle spalle. Gli
stipendi non è propri di mali. Certo, se ero laureati e giovani come te, me ne vado di corse.”
Alex era enorme, pieno di peli dappertutto. Una pelle ruvida, spessa. Non era né bianco né mulatto,
ma paonazzo come un muro di marmo.
“Ma non c’è la possibilità di crescere all’interno dell’azienda?”
“Proprio non ti vuoi di capire? Qui cose non funzionano con il meritocrazia. Nelle nostre aziende
c’è regimi di mafia, se capisce cose intendo.”
Giovanni appoggiò la fronte sulla birra tremando.
“Ho rifiutato altri posti interessanti nel frattempo.”
“Hai fatto di mali. Di malissimo mali!”
“Ma che ne sapevo io che qui le cose girano a questo modo. Come potevo immaginarlo?”
“Lo so. Vita a volte è grandi fregature” disse sorridendo. “Guardami che dentro non si sta alle fini
tanti mali. Stipendi di garanzia, sudi poco, tredicesime e quattordicesime di sicura garanzia, che
vuoi più dalle vite?”
Giovanni rialzò la testa. Sulla fronte doveva avere il cerchio del boccale, perché Alex, guardandolo,
sghignazzò.
“Cosa faccio ora? Me lo dici?” disse preso dall’agitazione.
“Pure troppi non ho detti tutti?”
“Spara, tanto ormai mi sa che me ne vado da questo posto di merda!” disse fingendosi padrone della
situazione.
“Eh, piani a mettere merde sulle mie di case di seconda.”
“Senza offese, ma ci fosse almeno una cacchio di finestra!” disse Giovanni con lo sguardo fisso sul
muro giallo del locale. “Ma te la immagini tutta la vita là dentro, in quel magazzino stagnante?”
“Già ho fatte di tantissime vite laggiù, cari i miei Longo!”
Alex puntò lo sguardo verso l'uscita.
“Avanti spara, oramai non ho più nulla da perdere” disse Giovanni con voce bassa. “Altre due birre
visto che ci siamo.”
“Due di birri!” gridò Alex al barista. “Ascolti, Longo. Quando tu firmi contratti di tempi non
determinati, come fai tu domani di mattine, per i tre anni di successioni non potrai essere di
spostamenti né di lavori né di livelli.”
“Ma questa è una regola assurda?” disse Giovanni senza togliere gli occhi dal muro. “Mi sono fatto
il sedere sei anni all’università per uscire col massimo dei voti e secondo te ora dovrei farmi tre anni
di gavetta in un magazzino senza finestre in mezzo a una banda di operai sgrammaticati?”
“Longo abbassa tue ali” disse Alex. “Sei esnob contro unici di colleghi tuoi di aiuti.”
“Scusami, non ti volevo offendere, ma domani non credo mi vedrai al lavoro, cerca di capirmi.”
“Credi belli alzare ogni mattini di stesse ore buie e buttare me dentro di magazzini senza finestroni
a lavorare duri e poi uscire con soli già a fare in culi?”
Giovanni sorrise. “Ti chiedo un’altra volta scusa. Amico.”
“Amici paio di palle. Siamo colleghi soli, e non molti da come tu dici.”
Giovanni fece un lungo respiro. Si alzarono.
“Lascia, amice, pago io. Se domani non ci vediamo ti ringrazio per le tue parole. Sei stato l’unico
che si è preso cura di me. Mi hai spiegato com’è difficile sopravvivere a questo mondo. Grazie,
Alex, ti ricorderò per sempre” disse Giovanni mentre pagava le birre.
“Ma vaffanculi, Longo!” disse l’altro andandosene dal bar scuotendo la testa.
Giovanni s’incamminò verso l'auto non riuscendo a capire perché il collega l’aveva mandato a quel
paese. Forse lui non era fatto per dialogare con persone di rango inferiore al suo. Cosa aveva in
comune con gente inebetita dal lavoro e dal televisore? Ne avrebbe parlato con sua madre di tutta
quella faccenda, lei forse avrebbe compreso la situazione e l’avrebbe potuto consigliare.
“Longo, Longo!”
Giovanni udì una voce venire da lontano.
“Longo, aspetti!” Alex gli corse incontro correndo per abbracciarlo. “Addio, Longo. Scusi prima, io
eri incazzati di me. Tu bravi colleghi. Tu bravi ragazzi. Scusi, fai un abbracci a me per un favori. Io
tanti problemi qui perché stranieri. Tu vai via di aziende presto. È posti di merde. Vai via a essere
felici. Credi me.”
“Grazie di cuore” disse Giovanni abbracciandolo a lungo. "Addio, Alex."
“Addii” disse quello voltandosi in fretta e andandosene via.
x
Quando entrai in ufficio e mi sedetti alla scrivania, sullo schermo del portatile intravidi nell'oscurità
un sorriso esagerato. Salvai sulla chiavetta e spensi.
Dopo alcuni minuti i muscoli della mascella, nonostante l'allenamento, si stancarono. Cercai di
rimanere serio. Mi aiutai con le mani. Niente. Ero troppo euforico, allora pensai alla mia ragazza.
Non c’era niente che non andasse in lei. Anzi, le cose andavano talmente bene che ci eravamo
entrambi rilassati. Sempre più fratello e sorella, sempre più amici e meno amanti. Tornavamo a casa
distrutti dal lavoro e ognuno, prima della cena, si rilassava a modo suo. A volte uno dei due si
concedeva un aperitivo con gli amici. Era raro che si uscisse insieme. Stavamo rinchiusi in quelle
tristi mura fino al mattino senza quasi rivolgerci la parola. Il fine settimana lo passavamo
passeggiando, o rimanendo a casa a poltrire, cercando invano di ricaricare le batterie fisiche e
mentali. Averla lasciata è stato necessario e per niente difficile. I soldi dell'eredità non sarebbero
bastati per entrambi. In fondo eravamo legati da un sottile filo di vicendevole sostegno, destinato a
spezzarsi. E comunque adesso era tardi per recriminare.
Attesi i colleghi in un insolito silenzio.
Li scrutai. Uno a uno. Per l’ultima volta. Presto avrei dimenticato i loro volti stanchi e tristi.
Entrò il capo. Osservai il suo rostro agitato e corrugato all’inverosimile. Parlava al cellulare.
Assaporai il suo sadismo. Respirai a pieni polmoni il suo cronico malumore e quel profumo
disgustoso che lo avvolgeva ogni mattina.
“Che cazzo hai da ridere, Luigino?” disse allontanando per un attimo il cellulare.
“Posso?” gli dissi indicando il suo ufficio.
Mi fece cenno di aspettare.
Aspettai.
Appena mi fu concesso di aprir bocca, gli dissi in due secondi quello che in un anno e mezzo non
avevo mai avuto il coraggio di dirgli: "Mi licenzio, signor Testa di Cazzo."
Dopo un lungo silenzio durante il quale io godevo e lui faticava per non prendermi a pugni, questa
fu la frase con la quale mi augurò buone cose: “Vattene pure, figlio di puttana! Sai benissimo che ci
lasci in un mare di merda! Tornatene a casa, fallito del cazzo! La vita non è fatta per chi non ha
voglia di spaccarsi il culo! Checcazzo ridi? Tornerai con la coda tra le gambe a supplicarmi di
riassumerti! La crisi è nell’aria: occhio, Luigino! E ora fuori di qui, pezzente. Vattene!”
Forse si era già scordato della morte dei miei e di mia sorella.
“Con piacere, signor capo, la ringrazio di tutto cuore” dissi abbozzando un inchino. Uscii che il
dolore alla mascella si era fatto insopportabile.
Osservai con lentezza le quattro mura grigie che circondavano lo studio. Salutai i colleghi uno a
uno, anche i più arrivisti: quelli che forse, un lontano giorno di primavera, avrebbero fatto carriera,
quelli che forse un lunedì mattina, avrebbero aperto uno studio, con dei dipendenti pezzenti e falliti.
Uscii dall'edificio senza fretta, con la mascella che mi scoppiava.
y
“Tre anni?” disse la madre appoggiata alla ringhiera del poggiolo senza camicia. “Ma, Giova, è
un’assurdità!”
“Me lo ha detto Alex, l’unico che ha un po’ di cervello lì dentro!" disse andando con lo sguardo alle
montagne lontane. “L’unico che possa considerare un amico.”
“E perché non lo inviti a cena questo Alex?”
"Mamma, caspita, stiamo discutendo del mio futuro!" disse Giovanni. "Puoi smetterla una volta
tanto di pensare a certe cose e concentrarti su di me?"
“Scusami, caro. E quindi tu saresti disposto a rimanere altri tre anni in un bugigattolo senza finestre
a scrivere scartoffie?”
“Dove hai imparato questi termini?”
“Me li ha insegnati Luigi” disse facendogli l'occhiolino.
"Adesso, smettila!"
“Giova, tu sei laureato, sai usare il computer, sei sveglio, intelligente, gentile: io al tuo confronto
sembro ignorante e stupida.”
“Questo lo so, mamma… ma dicono che sta per arrivare la crisi economica e quindi avere un posto
fisso sarebbe una bella garanzia…”
“Allora capirai anche, che dopo tre anni in quel buco uscirai senza ricordarti nemmeno quello che
hai studiato. Ne uscirai instupidito! Non capisco perché sei finito lì dentro con tutte le offerte di
lavoro che ti hanno fatto...”
“Si dice istupidito, mamma.”
"Ah sì?" disse lei.
Giovanni sbuffò e rifletté in silenzio.
“Se la pensi così allora me ne andrò” disse. “Domani cercherò di parlare con un superiore.”
“Cercherò di parlare?”
“Parlerò.”
“Bene, Giova, domani parla coi tuoi superiori e digli che hai altre proposte migliori, pur di non
perderti ti alzeranno subito di livello prima di stabilizzarti. Vieni qui, caro” disse andando ad
abbracciarlo in reggiseno. Lui pianse perdutamente sul suo petto rigoglioso, macchiandole la pelle
profumata e liscia di lacrime chiare.
“Vedrai che nel frattempo riceverò altre proposte ancora migliori delle precedenti. Comunque vada
me ne andrò da quel posto dove non mi considerano che un semplice pezzo di carta.”
Un giorno Giovanni fu chiamato dall'ufficio postale di Vigolo. Si ricordavano bene di lui e di sua
madre nonostante ora vivessero a Trento.
"Senti, non sappiamo che farne della corrispondenza del tuo amico. Non ha nessun parente. Ha
venduto la casa e non ha lasciato altri domicili. Che dobbiamo farne delle lettere che gli arrivano?
Non mi sembra il caso di rimandarle tutte al mittente. Insomma, hai capito..."
"Va bene, nessun problema. Purtroppo non lo sento da un po', ma prima o poi si farà vivo." dissi.
"Mandate tutto a me. Firmerò io le raccomandate a nome suo. Vi lascio il mio indirizzo."
x
Avrei dovuto saperlo che non c'erano più i fancazzisti di una volta. Potevo capire Zen e i suoi
progetti di trasferirsi in Inghilterra, ma perché Jo continuasse a martoriarsi le palle tutti i santi giorni
seduto a una scrivania, per me rimaneva un mistero: non sapeva che da contratto aveva diritto a un
fottutissimo mese di sacrosante ferie?
Aprii un nuovo conto su una banca online. L'altro – quello che avevo sempre avuto presso la Cassa
Rurale di Vigolo – ormai era prosciugato, avevo scommesso tutti i miei risparmi.
Vendetti la casa dei miei e versai il ricavato e quel poco che c'era sul conto corrente dei miei e di
mia sorella, sul mio nuovo conto online.
Il giorno seguente, senza salutare, me ne andai in silenzio da Vigolo, da Trento, dal mio vecchio
lavoro e dalla mia fidanzata, deciso a non tornare.
Mi rassegnai a vagabondare solo come un verme, temendo che viaggiare in solitudine fosse una
noia mortale. In realtà sapevo che non c'entrava la noia, avevo paura di affrontare il mondo, ma ero
convinto che la vita fosse un lungo viaggio in solitaria zaino in spalla verso spazi ignoti, personaggi
bizzarri e assenza di tempi: un pellegrinaggio in stile vagabonding. Sarebbe andato tutto per il verso
giusto se non avessi cominciato a pensare ossessivamente al mio conto in banca.
All'inizio fu un viaggio prolet, come amavo definirlo ai tempi dell’università. Mi cullavo tra le
gente. Ero uno di loro. Osservavo il mondo con gli occhi e con il cuore.
Quando camminavo senza paura per le strade polverose dell’Uzbekistan, lungo l’antica via della
seta, ero un ragazzo felice. Avevo appena ereditato una fortuna. Non avevo ancora perso la voglia
di vagabondare in giro per il mondo. Non mi ero ancora imborghesito. Non avevo ancora gettato la
spugna: me lo sudavo il mio vagabonding. Saranno stati quarantasette gradi in terra uzbeka quando
i miei sandali s’infiammavano a ogni passo, quando una manciata di osh mi bastava per un giorno
intero, quando non importava il perché ma il come. E il come era lentamente.
Ci passai tre settimane a camminare dalle rive di quel che rimaneva del lago d’Aral, con le navi
arenate nel deserto, fino a Samarcanda, in un’ipotetica carovana solitaria. Superai infiniti posti di
blocco, interminabili interrogatori passati a ripetere pa ruski niet, insistenti venditori e scaltri
truffatori, ma era proprio quello il bello del mio vagabondare: camminare sugli ostacoli. Scoprire il
mondo dal basso, strisciando come un verme su terre straniere piene di vita vera, come un nomade,
un pellegrino del mondo. Uno zaino mezzo vuoto, qualche litro d’acqua e voglia d’avventura. Non
serviva altro per vivere.
E i soldi che avevo ereditato?
Si sono fatti sentire poi. Mi hanno sedotto e, presto o tardi, abbandonato.
Resistetti solo qualche settimana.
Non era facile viaggiare in terza classe sul treno per Kabul, in mezzo ai topi e al sudore della gente,
quando con una minuscola carta di credito avrei potuto prenotare l’intera carrozza. Perché mangiare
dagli ambulanti nelle strade del Pakistan, quando avevo i soldi per sedermi a tavola nel migliore
ristorante della città e sorseggiare la bottiglia più pregiata della loro cantina? Chi mi obbligava a
dormire in uno stambugio di Benares che puzzava di piscio, quando avrei potuto permettermi la
stanza di un marajà?
A volte ripenso, con sempre maggior distacco, a quella profezia indiana.
Prima di perdere il senno a Goa, mi ero fatto leggere la mano in un palazzo di Old Delhi. Le pareti
ammuffite palesavano agli occhi il fetore da cui le narici erano invase. Appena comparve, la
vecchia pretese il suo compenso. Le misi cinque rupie in mano. Attraversò la cucina per riporle in
un cassetto. Mi fece sedere e, con un cenno, ebbe le mie mani sul tavolo. Ne prese una, la destra se
ricordo bene, e respinse l’altra. Con un goniometro rudimentale mi disse in un inglese stentato e, vi
assicuro, anche sdentato, “eititri eitifo year”. Ripose lo strumento e riprese a studiare la mano. Più
sorridevo a quanto mi diceva, più si faceva seria. Non avevo mai creduto a quella colossale balla
delle linee della vita, però non volevo offenderla. E poi, pensavo che, se ero lì, un motivo doveva
esserci.
Della mia infanzia sottolineò più volte che avevo spesso un forte mal di testa.
Mi disse che ero appena uscito da una lunga storia d’amore. (Era vero, se d’amore s’era trattato.)
Avevo da poco lasciato un lavoro che non mi piaceva. (Era vero pure questo, e si trattava proprio di
un merdoso e mal retribuito lavoro del cazzo.)
Del mio presente disse che volevo avere tutto sotto controllo.
Poi cominciò a parlare del futuro. Al compimento dei trent’anni, avrei ricominciato a lavorare, ma
non sarebbe durata molto. Se pensava che sarei ritornato a spaccarmi il culo con un altro fottuto
lavoro, si sbagliava di grosso. Era totalmente fuori strada la vecchia. Notò la mia disapprovazione,
ma rimase seria e ferma. A trentatré anni, mollato il lavoro, avrei intrapreso un breve viaggio
trovando quello che cercavo, il mio tesoro. Abbozzai un sorriso. Mi stavo immedesimando in quella
storiella di fantasia. Nemmeno in quel posto avrei raggiunto la pace: a quarant’anni e a
quarantacinque ci sarebbero stati altri grossi cambiamenti, sempre in meglio. Con un sorriso
impercettibile sottolineò che a quarantotto anni avrei raggiunto l’apice della carriera lavorativa,
l’apogeo della creatività, la vetta che avrebbe dato un senso alla mia vita. Non aveva ancora capito,
la povera vecchia, che non avrei lavorato mai più.
Pensai per un attimo ai miei futuri quarantotto anni. Se era vero, avevo ancora molto tempo per
prendere la vita alla leggera, per sbagliare, per non seguire la direzione del gregge ignorante.
Prima di lasciarmi aggiunse che i mesi a seguire sarebbero stati i peggiori della mia vita.
Evidentemente la vecchia era all’oscuro dell'eredità: ero ricco e deciso a spendere al meglio quei
soldi maledetti!
Soltanto tre giorni dopo iniziò il mio declino.
Delle settimane passate a Goa, forse mesi, ricordo soltanto che riuscii a scappare per miracolo
salendo sul primo treno senza biglietto e con lo zaino vuoto.
Quel viaggio solitario attorno al mondo si stava trasformando in un totale insuccesso.
Non riuscivo ad ammetterlo, ma dentro sapevo. La morte dei miei era un trauma che dovevo
superare: non avevo più punti di riferimento: vagavo nel vuoto: brancolavo, punto nero
nell'oscurità.
Y
Il computer in cucina era acceso, sempre pronto a sedurmi. Sembrava un sabato mattina come tanti
altri: a parte il fatto che ero morto dentro: da mesi non ricevevo nuove proposte di lavoro.
Cominciai a navigare scrivendo nel motore di ricerca perdita di senso. Trovai un blog che trattava a
meraviglia l'argomento.
La perdita di senso.
«Cosa ci faccio qui?» è una domanda che in genere arriva improvvisamente, in un giorno come
tanti, magari un lunedì mattina mentre siamo impegnati in un'attività consueta: si prova una
sensazione di estraneità a ciò che stiamo vivendo in quel momento, ma, poiché è sgradevole, la
cacciamo via.
Purtroppo quasi sempre ignoriamo noi stessi e i bisogni della nostra anima: non ci ascoltiamo.
Quando quella sgradevole sensazione si ripresenta, la soffochiamo, magari aumentando le solite
attività di ogni giorno: aggiungiamo strati su strati, maschere su maschere, fino a non capirci più
niente: finché un giorno qualunque esplode di colpo: diventa dal nulla il tutto: un'ossessione senza
fine.
Il non senso si espande allora in noi, dentro corpo-anima-cervello, a macchia d'olio, fino a diventare
un non-senso totalizzante che impregna di sé anche ambiti di vita che invece un senso ce l'hanno. A
quel punto è tardi: il non-senso può portarci a rinascere con una nuova consapevolezza, oppure
all'abisso. Dopo aver nascosto per anni il vero io sotto strati di menzogne, è fondamentale smettere
di cercare le invisibili cause e ascoltare il messaggio della crisi.
Starnutì una seconda volta.
Ma torniamo a quel lunedì mattina: quella sensazione non è altro che una bussola che la natura ci
offre per orientarci verso cambiamenti di vita più in sintonia con ciò che siamo.
Se invece la sopprimiamo con farmaci, alcol, droghe e altri surrogati, ciò che riacquistiamo non è il
vero senso della vita, ma un senso artificiale, un senso menzognero che ci allontana, senza che
nemmeno ce ne accorgiamo, da quello vero.
Starnutì una terza e ultima volta.
La perdita di senso è uno strumento che il cervello utilizza quando vuole impedirci di vivere
qualcosa che ci fa male o che non ci interessa intimamente, ma a cui noi ci sottoponiamo con
ostinazione: troppo lavoro o lavoro che non piace, amori finti o finiti, atmosfere ostili, assenza di
creatività e monotonia.
Jung scrisse: «Diamo al tempo la possibilità di farci da madre». Al cervello va dato il tempo di
ricomporre spontaneamente un nuovo assetto, con la consapevolezza che abbiamo un problema.
Morì da poeta incompreso. E tutto ebbe senso.
PS: PRESIDIO MEDICO. Chi non ha la fortuna di guarire autonomamente, deve richiedere una
psicoterapia breve orientata a capire che cosa ha perso senso.
Lo lessi con interesse. Percepivo una vicinanza tra quanto c'era scritto e la mia anima.
Andai alla home page e capii perché.
I lupi della steppa hanno mille occhi.
Era il suo blog.
Iniziai a piangere.
Non lo avevo più sentito dopo la morte dei suoi. Né una lettera, né un messaggio. Quel blog era
l'unico legame tra di noi.
Pur avendolo sempre saputo, me ne ero reso conto solo allora: mi sentivo in competizione con lui.
Volevo che cadesse. Volevo essere io a trionfare sul lavoro, ad avere la ragazza più bella, a crearmi
una famiglia, ad avere un'automobile più costosa della sua. L'avevo lasciato scappare in mare
aperto. Per questo meritavo di affogare anch'io. E sempre per questo era giusto che mi sentissi un
uomo morto.
Mi asciugai le lacrime.
Cercai altri post. Lessi un po' delle sue poesie, dei suoi racconti, dei suoi pensieri. Solo io sapevo
che quello era il suo blog. Lo sapevo perché Il lupo della steppa – un libro sul suicidio – in gioventù
era stato il suo romanzo preferito, lo sapevo perché un giorno di molti anni prima mi aveva fatto
leggere una poesia intitolata La capra dai mille occhi.
Tra i suoi scritti aveva inserito due trattati di psicologia. Il primo era quello sulla perdita di senso
che ho appena riportato. L'altro era intitolato il senso di perdita. Aveva aggiunto la stessa postilla a
entrambi: SCAVARE DENTRO SÉ È L'ARTE DI SCAVARE DENTRO SÉ.
Il senso di perdita
Il senso di perdita è insito nella psicologia di ogni individuo: in qualche modo è come rinunciare al
se stesso di oggi e scommettere su un futuro se stesso totalmente ipotetico.
Tossì.
La vita avanza e cresce a colpi di distacco.
Tossì ancora, e poi riprese.
La delusione primaria è la più grande. La vita di ogni individuo inizia con un distacco, il primo e
imprescindibile: il distacco dalla madre.
La delusione del distacco dal luogo è forte in tutti noi: il distacco reale dalla terra natia, ancor più se
inconsapevole, è inevitabilmente collegato a un senso di tristezza, poiché, abbandonando i luoghi
familiari, si abbandonano anche le certezze e le sicurezze da essi derivanti.
La delusione della caduta del mito dei genitori comporta un distacco nei loro confronti, che si rivela
necessario per la formazione completa dell’individuo: è il momento di separazione tra la fase
infantile e la fase matura di ogni uomo.
La delusione sociale porta a un distacco e rifiuto della società.
La delusione di una vita senza senso porta al distaccato distacco dalla vita: la morte, anche lei senza
senso.
Io sono.
L’individuazione, quindi, diventa l’unico destino degno della nostra esistenza terrena, che inizia col
distacco che dona la vita e finisce col distacco dalla vita stessa.
Io non sono più.
Senza più tossire né starnutire, morì:
poeta senza voce.
Navigando dentro i meandri di quel blog labirintico, trovai un brano in cui Luigi descriveva una
scena a cui non poteva aver assistito: l'incidente mortale nel quale morirono i suoi: suo padre, sua
madre e sua sorella.
x
Il dopo-Goa non fu meglio. Finii col passare le giornate alzandomi tardi e trascorrere le notti a fare
zapping col telecomando sul letto dell'hotel di turno o a trascinarmi da un locale all'altro,
ingozzandomi di cocktail e stringendo amicizie false e debilitanti.
Questo in qualunque posto fossi. Bangkok, Saigon, Jakarta e via dicendo. Manco ricordo i posti
dove mi ero fermato.
Mesi bui.
Al posto del pranzo facevo colazione.
Nel pomeriggio cercavo di buttare giù qualche idea, di sistemare il diario di viaggio.
Mi ritrovavo sempre in mano un best-seller di qualche genere. Non riuscivo più ad andare oltre, non
mi restava che accontentarmi di passare i pomeriggi a leggere libri inutili o a navigare su internet e
riempire di scemenze il mio blog I lupi della steppa hanno mille occhi.
Da fuori le persone potevano pensare che ero fortunato. Ero ricco e mi godevo la mia fortuna. Mi
credevano felice: sia chi incontravo durante il viaggio, sia chi era rimasto in Italia.
Durante qualche sprazzo di lucidità mi accorgevo che quelli non erano i miei piani.
Poi in un attimo questi brutti pensieri se ne andavano e tornavo nel mio mondo artificiale, senza
passato né futuro.
Ogni tanto ripensavo a lei, a quella ragazza birmana senza nome. Gli abiti lisi e bohemièn,
poeticamente prolet, le gambe sode e lisce, l'odore di sporco, i piedi scalzi, il seno pieno, il viso
abbronzato, gli occhi come feritoie. Seduta al mio fianco, mi guardava. Potevamo essere felici
insieme. Avrei potuto innamorarmi senza alcuna difficoltà. Lei mi avrebbe voluto per ciò che
rappresentavo.
Non ce l’ho fatta. Non ho trovato il coraggio di parlarle, di prenderle la mano e dirle qualsiasi cosa.
Era lì e ora non c’è più.
Io ne avevo troppi e lei troppo pochi. Ed entrambi stavamo lentamente morendo.
La vidi alzarsi un attimo prima, maledetta timidezza, un secondo prima che decidessi di aprir bocca.
Ma era già troppo tardi, lei era salita su quel treno senza ritorno, senza niente, senza soldi, senza
nome, senza sapere dove andare.
In certi momenti avrei voluto chiamare Jo, parlargli, confidarmi, sapere cosa stava facendo, se
aveva fatto carriera: chiedergli un consiglio per uscire dal buco nel quale mi sentivo intrappolato.
Ma alla fine non trovavo il coraggio di telefonargli, e nemmeno di scrivergli: e così stavo lì
immobile sdraiato sul letto a buttare via i secondi, i minuti, le ore, le giornate: la mia vita.
Y
"Papi, perché non ci fermiamo in un bar a Bassano?"
"Sì, dai, rallenta, ***, non correre in questo modo, è pericoloso!"
"Silenzio che devo concentrarmi. Non la voglio vedere in un bar la partita. La voglio vedere a casa,
sul mio divano e sulla mia televisione, senza il casino."
"La fanno su rai uno, possiamo cercare un posto tranquillo, mezzo vuoto. Sono le otto meno dieci e
non siamo neanche a Bassano, non ce la faremo mai."
"Basta parlare, so io cosa bisogna fare."
"Ma, ***, così ci ammazziamo!"
"Figurati, ho la patente da trentacinque anni e non ho mai fatto un incidente. Non sono mica come
mio figlio che si fa infinocchiare per eccesso di velocità a un centinaio di metri da casa! Per di più
dal baffone, il carabiniere più buono di tutta l'Alta Valsugana!"
"Dai, poverino, aveva fretta di vederci, per questo correva."
"Poverino? Cara, mettiti in testa che tuo figlio è uno squinternato di prima categoria. È sempre in
ritardo, si veste come un barbone, non sa tenere in mano un badile... Te lo dico io cosa sono lui e i
suoi simili: un'orda di barbari!"
"Dai, caro, non parlare male del tuo unico figlio!"
"Mamma, per la verità ci sarei anch'io..."
"È diverso, tu sei una femmina. ATTENTO!"
"Tranquilla, non mi schianto prima di vedere la partita."
"Ok, però rallenta."
"Non posso. E comunque lo sai che non ho mai fatto un incidente in vita mia, non come quel cretino
di tuo figlio..."
"Appunto, perché sei sempre andato piano. Non sei abituato a correre in questo modo... Luigi non è
un cretino, ha solo bisogno di trovare la sua strada."
"Silenzio, adesso. Io penso a guidare, voi pensate a fare silenzio."
"Ma, ***, non voglio morire per una stupida partita di calcio!"
"Basta!"
L'auto, una punto blu vecchia di dieci anni, corre indiavolata verso nord-ovest lungo la strada che
collega il mare al Trentino. È da lì che arrivano. Dal mare. Dopo una settimana passata a stare
immobili sotto il sole di giorno e di notte a fare vasche lungo l'unica strada del centro di Jesolo. È
così che ogni buon vigolano passa le ferie estive. A riposare sotto il sole cocente, un sole italiano,
un sole caldo che a Trento non arriva mai. E bisogna andare a prenderselo fin giù al mare,
prenderne il più possibile, caricarselo addosso, sulla pelle secca, e portarlo a Vigolo, ché ci tenga
caldo anche l'inverno.
"Adesso rallenta, mancano venti minuti."
"Perché hai abbassato? Alza!"
Mia madre alza il volume. Mia sorella – che a Dio non ci ha mai creduto – prega che vada tutto
bene, che arrivino a casa sani e salvi: non l'aveva mai visto così indiavolato nostro papà.
"Papi, ho un'amica a Borgo se vuoi, ha una televisione di quelle grandi..."
"Cosa?"
Mia madre abbassa di nuovo il volume.
Mio padre lo alza un po', poi tende l'orecchio a mia sorella guardandola nello specchietto.
"Ho detto che ho un'amica a Borgo che ha una televisione enorme ed è a casa da sola perché i suoi
sono al mare..."
"Ormai siamo arrivati, mancano solo quaranta chilometri."
"Ma, ***, perché non ci fermiamo a Borgo dalla sua amica."
Mio padre alza la radio al massimo e fa segno di fare silenzio con il dito indice della mano destra.
...Maldini, Baresi...
"Cazzo!" grida mio padre.
"Cosa c'è?"
"Sta per iniziare!"
"No, ***, sono le otto e un quarto, non inizia alle otto e mezza?"
Mio padre fa di nuovo segno di tacere e cerca di alzare il volume della radio, che però è già al
massimo. Alle otto e diciassette all'altezza di Borgo Valsugana inizia a piovere di colpo. Gli
altoparlanti faticano, il suono esce distorto e poco comprensibile. Il frastuono della pioggia
torrenziale gareggia con l'autoradio impazzita.
È allora che a centotrenta chilometri orari mentre supera un'altra vettura che procede lenta – lenta
rispetto alla punto blu di mio padre – l'auto s'imbizzarrisce, le ruote cedono, mia sorella grida, mia
madre si mette le mani sugli occhi, la radio manda la pubblicità della mozzarella molisana, mio
padre capisce che l'ha combinata grossa e la punto blu decide che è troppo vecchia per campare
ancora.
Poi diventa tutto rosso: un rosso scuro: quasi nero. Risalta sull'asfalto scolorito da un sole assente,
già fuggito dietro al piz de levec, la grande montagna buia che si staglia a occidente.
E intanto la pioggia cade, continua a cadere sui pezzi di lamiera calda cercando invano di cancellare
le tracce di una tragedia annunciata.
Giovanni lasciò il computer acceso, si alzò, uscì dall'appartamento, una volta tanto senza salutare
sua madre, corse giù dalle scale e cominciò a correre senza meta, spargendo scie di sale nell'aria,
avanti, avanti: avanti senza mai fermarsi.
x
"Ci ho pensato tanto ultimamente" dissi a Li, la puttanella di turno. "È come se il fato avesse voluto
dimostrarmi che da solo non ce la potevo fare. Come se un dio qualunque mi avesse ritenuto troppo
arrogante e indegno, e avesse voluto darmi una lezione."
Lei era nuda, i piccoli seni orizzontali, una sigaretta accesa in mano e due lievi fessure nelle quali
s'intravedevano le pupille marroni.
"Sei bello e ricco, cosa vuoi di più?"
"Evidentemente sono uno di quelli che hanno bisogno di cadere" dissi senza ascoltarla. "Di cadere
per riscoprire quanto sia bello rialzarsi e camminare..."
"Ma dai, su, so io come farti felice..." disse allungando una mano su di me.
"...o semplicemente lasciarsi morire" conclusi prima di lasciarmi rapire nuovamente dall'istinto.
Poi fumai una canna e finalmente trovai il coraggio di telefonare.
"Pronto?"
"Ciao, Zen, pensavo che con il denaro..."
Silenzio.
"Sì, dimmi, Luigi. Continua, ti ascolto. Ti ascoltiamo."
"Pensavo che con il denaro avrei comprato la felicità: ora che ho perso tutto, denaro e felicità, mi
accorgo che la vita è ancora più semplice di come uno se la immagina."
Silenzio.
"Finalmente un discorso da adulto: fai progressi, Luigi."
"Tu non capisci, Zen, l'artificiosità ci inganna continuamente, ci conduce su strade virtuali senza
uscita, ci allontana dal nostro essere, ci confonde lasciandoci in un buio sotterraneo senza amore."
Feci una pausa.
"E la maggior parte di noi nemmeno se ne accorge."
Silenzio.
"Voglio risalire passo dopo passo fino ad arrivare lassù, dove la nebbia avvolge ciò che sarò, lassù
dove sarò finalmente libero dai condizionamenti e dalle cose futili, lassù dove l’utopia diviene
realtà, l’illusione verità: l’energia mentale materia per i nostri sensi."
"Basta fumare, Luigi!" disse Zen ridacchiando al telefono. Sentivo in lontananza anche la risata di
Jo.
"Forse hai ragione tu, in fondo chi se ne frega, probabilmente sono tutte cazzate."
Mentre Zen mi passava Jo pensai: "Un maledetto incidente d'auto: questa è l'unica verità."
"Ciao Lu!"
"Lu tua sorella, coglione!"
"Dai, Lu, non lamentarti sempre. Saremmo noi a doverci lamentare bloccati a casa dalla pioggia di
domenica pomeriggio!"
"Statemi bene" sussurrai, "passo e chiudo."
"Aspetta, non mettere giù..."
"Dai un bacio a tua madre da parte mia!" dissi sforzandomi di ridere.
Appoggiai il telefono sulla scrivania. La ragazza si era addormentata sul letto. Presi una sigaretta
delle sue. Era la prima volta che fingevo di chiamare qualcuno perché mi sentivo il cuore scoppiare
per la solitudine.
"Odio i soldi. Mi hanno rovinato la vita" dissi in italiano, a nessuno.
Mi venne in mente ancora una volta lei, senza nome, i vestiti bucati, i piedi nudi, il viso vissuto, la
pelle spessa e sporca, gli occhi liquidi, feritoie degli abissi, vuoti oceani senza fondo.
Io troppi, lei troppo pochi.
Chissà se ancora viveva su questa terra maledetta? Oppure era morta di stenti in Myanmar,
sorridendo senza nome, mentre io m’ingozzavo di coca e stronzate.
"Ho deciso di cambiare continente" dissi alla puttanella quando si svegliò. "Cambiare aria mi farà
bene, non credi?"
"Sbagli. Rimani qui. Scoperemo tutto il giorno. Io, tu e le mie amiche."
"Lascia perdere, Li. Non mi freghi più. Non mi fregherà più nessuno d'ora in poi."
La guardai negli occhi.
Lei si accese l'ultima sigaretta del pacchetto.
"Vai pure, sai dove trovarmi, quando tornerai piangendo."
y
Quella notte Giovanni piangeva rannicchiato sul poggiolo di casa pensando ai mesi, quasi un anno
ormai, che aveva perso in azienda senza farsi notare da nessuno, mettendosi alla pari con le ultime
ruote di quel carro immobile che era l'azienda a quel tempo.
Trento era tranquilla. Qualche luce, qualche automobile, un passante insonne, qualche gatto in
calore: nulla più.
Gli venne in mente Luigi, che prima di scappare, era finito in un piccolo studio d'ingegneria, dove
doveva sgobbare per tenersi a galla.
“…dobbiamo andarcene, Jo! Scappiamo da questo posto del cazzo! Qui in Italia si vive di merda. Si
lavora tutto il tempo per guadagnarsi da vivere, e poi non ci rimane neanche il tempo per divertirci
con i soldi che abbiamo guadagnato. Sono tutti sotto a un mutuo, che è peggio che stare sotto a un
ponte. Andiamocene!
“Jo, svegliati! Zen dice che appena finisce il dottorato se ne va a fare in culo! Scappa in Inghilterra
o in Germania, lassù hanno stipendi doppi rispetto ai nostri! Dice che in Italia inizia la crisi, che è
meglio scappare. La migliore mente della nostra generazione di sfigati costretta a tirare avanti di
stenti! Che schifo...”
“Aveva ragione” pensava Giovanni mentre si nascondeva sotto le lenzuola per la paura del futuro
incerto che lo attendeva.
Poi i pensieri andavano a Zeno, il migliore ai tempi dell’università. Zeno aveva iniziato il dottorato
e percepiva uno stipendio più basso del suo, senza tredicesima né quattordicesima, e, con tutta
probabilità, lavorava molte più ore rispetto a lui, senza dubbio anche il sabato. Lo si poteva vedere
come un investimento, certo. Ma, considerata l’economia italiana in continua crisi, non era forse
meglio trovarsi un posto fisso che aspettare momenti ancora più bui.
Il giorno successivo gli venne recapitata una lettera raccomandata per Luigi. Giovanni non osò
aprirla. La infilò nel cassetto del comodino e se ne dimenticò.
La settimana successiva però ne arrivò un'altra. E così via, settimana per settimana. Moriva dalla
voglia di sbirciare. Invece no, da amico fedele, firmava le raccomandate della Cassa Rurale di
Vigolo con un ghirigori incomprensibile e le ammonticchiava con cura una sull'altra.
Ne aveva ormai una decina. Tutte uguali.
Un pomeriggio si recò in giacca e cravatta nella banca di Vigolo, ma non riuscì a sapere nulla. E
comunque, di qualunque cosa si trattasse, finché Luigi non si faceva vivo, non avrebbe potuto
riferirglielo.
x
Arrivai a Rio. Un italiano con la pelle scura, gli occhiali neri e il gel in testa mi si avvicinò in
aeroporto e cominciò a parlare a raffica.
"…qui ogni anno."
"Ah" dissi.
"In strada, dopo le ventitré c’è solo l’imbarazzo della scelta. Le ragazze che passeggiano non si
contano. E il prezzo medio di una prestazione è basso: si pagano tra i dieci e i venti euro per un
rapporto orale. Se vuoi di più, ovviamente paghi di più. Però non credere sia molto, da noi non ti
fanno neanche una sega con..."
"Ho capito, grazie. Ciao." Mi allontanai.
"Se vuoi prendiamo un taxi insieme. Ti dicevo, la maggior parte di queste donne proviene dalle
favelas, di conseguenza se il cliente desidera drogarsi vanno anche a recuperare cocaina ed erba."
"Ascoltami bene un secondo" gli dissi. "Ti togli dai coglioni?"
Viaggiai verso nord-est fino ad arrivare in una cittadina di cui preferisco non menzionare il nome.
Da lì, con una bicicletta usata, mi spostai fino a trovare una spiaggia semi-deserta dove, a quanto
dicevano nell'ultimo ostello dove avevo soggiornato, un hippy di nome Art gestiva un campeggio
quasi sempre vuoto.
"Come hai fatto a farti questa vita?" gli chiesi dopo due settimane che stavo lì.
"Sono venuto qui e ho scelto di fare questa vita."
Tornò a guardare l'orizzonte e ad ascoltare l'oceano e le sue onde. Era metà pomeriggio e il sole
batteva sul suo corpo abbronzato senza dargli il minimo fastidio.
"Sì, ma... come ci sei riuscito?"
"Sono venuto qui e ho scelto di fare questa vita" disse. "Anzi, più precisamente ho scelto di fare
questa vita e sono venuto qui."
Non sapevo cosa dire.
Lui scoppiò a ridere senza motivo. I lunghi rasta gli saltellarono dappertutto. Avrà avuto una
cinquantina d'anni. Era alto e tanto magro che aveva pelle da vendere. Teneva in mano, senza
suonarla, una vecchia chitarra classica con il legno tutto rovinato.
"Che ci vuole?" disse. "Quanto pensi che possa costare un terreno qui? Se hai messo via un po' di
soldi, il gioco si fa semplice."
"Come sapevi che avrebbe funzionato?"
Mi guardava con occhi sinceri.
"Non lo sapevo."
"Quindi hai rischiato. Ti sei buttato senza sapere come sarebbe andata a finire..."
"A finire, già."
Mi guardò per mezzo minuto senza parlare.
"Non si può prevedere il futuro. Quindi non ci resta che crederci" disse. Poi aggiunse avvicinandosi
ai miei occhi: "Non ti resta che crederci."
"Mi spaventa vivere in un solo posto tutta la vita" dissi allungando le gambe e infilando i piedi nudi
sotto la sabbia per cercare un po' di frescura.
Art appoggiò la chitarra sulla sabbia calda e prese un barattolo che stava sotto la sedia. Si fece una
canna, la accese, ne fumò metà e me la passò.
"In verità ciò che a quel tempo desideravo con tutto me stesso, era smetterla di tornare a casa e
vomitare lo schifo che ingoiavo in quell’ufficio arrogante e ingrato."
"Esattamente ciò che pensavo io prima di scommettere tutto!"
"Non gridare, amico. Ascolta."
Silenzio.
"A quel tempo una certezza mi consolava: il mondo fisico è un’illusione. Solo se riusciamo a
superare questo scoglio psicologico, possiamo trasformare la nostra energia in ciò che vogliamo:
come se la vita fosse soltanto un interminabile sogno lucido all'interno del quale ognuno di noi tiene
le redini del gioco: vince chi ha più energia mentale. Questa è la ragione per cui, se più persone
"pregano" per lo stesso evento, la probabilità che si realizzi cresce. È vero, l'unione fa la forza, ma
questo vale anche per il male. E il male esiste, esiste per ricordarci cos'è il bene, per farcelo
apprezzare: è un male naturale."
Rimanemmo in silenzio. Cercavo di memorizzare le sue parole.
"Si tratta di un apparente paradosso: dobbiamo dimenticare l’educazione che abbiamo ricevuto. I
limiti non esistono: sono solo una pseudo-barriera mentale. Tutti i record verranno battuti. In noi c’è
un’energia illimitata. In ognuno di noi, dal primo all'ultimo. L’importante è crederci."
Avrei voluto dirgli che la pensavo esattamente come lui, ma preferii tacere.
"Ora starai pensando che non ne ho le prove, che la scienza non lo ha mai dimostrato… cazzate!
Devi crederci! È nell’atto di fede che può cambiare una vita. Credere è la via. Se non credi la tua
vita rimarrà così com’è.
"Io cominciai a credere perché ero disperato: odiavo quella vita insulsa: non avevo niente da
perdere. La paura non serve, amico. Bisogna rischiare, buttarsi, fidarsi dell’istinto. L'energia rende
reale ogni pensiero. È come uno specchio magico: trasforma un’idea in un avvenimento fisico. La
chiave sta nell’atto di fede."
Poi tacque e preparò un altro spinello.
"Tu scrivi, vero?"
Annuii.
"Ecco, la fede di cui parlo è la stessa fede che un lettore dovrebbe avere quando legge il libro di un
autore sconosciuto: per rendere i personaggi reali è necessario crederci e lasciarsi andare.
"Gesù aveva moltiplicato pani e pesci, guarito gli ammalati e resuscitato i morti; Buddha era
rimasto per molte settimane immobile, senza mangiare né bere. Non sono miracoli questi?"
Credo che a quel punto mi scappò un sorriso involontario.
"Sarò anche matto, amico, ma sono convinto che, nella storia dell'umanità, sono esistite persone
così. L’ignoranza di noi gregge ignorante e la crudeltà di chi possiede il potere ci hanno oscurato la
verità. I miracoli esistono, io ne sono un esempio."
Parlava sempre più rapidamente e io continuavo a fumare e riuscivo a stento ad ascoltarlo senza
scoppiare a ridere.
"Lo stramaledetto atto di fede di cui parlo assomiglia al classico atto del religioso: per raggiungere
una consapevolezza superiore dobbiamo fare un passo verso l’ignoto. Ci spaventa la solitudine,
l'allontanarsi da un modo di credere, o non credere, a un altro, nuovo. La totale apertura dà un senso
di perdita. È un percorso d’iniziazione verso una vibrazione interiore di livello più alto: si tratta di
arrivare al do dell’ottava successiva.
"L’energia che prima ti tappava, poi t’invade lentamente, fino a saturare la solitudine. Vi
accorgerete" e qui fece una pausa, "vi accorgerete, voi umani, che i sensi percepiranno un mondo
diverso, malleabile, non sarete più voi a dovervi adattare alla società: sarà la realtà a deformarsi al
vostro desiderio: voi con i vostri pensieri condizionerete il mondo esterno. Einstein ha dimostrato
che tutto ciò che ci circonda (noi, gli oggetti, l’aria, le case) è energia. E-uguale-emme-ci-quadro,
l'energia è direttamente proporzionale alla massa" si fermò nuovamente, "io peso poco, ahimè, tu
però sei davvero un bel po' di energia!"
Art scoppiò a ridere e finalmente potei abbandonarmi e ridere con lui, come soltanto uno che si è
appena fumato troppa cannabis può fare.
"I nostri cinque sensi..."
"Ancora?"
"Ascolta, amico, i nostri cinque sensi non bastano: solo con un livello di consapevolezza superiore
potremo percepire appieno le potenzialità di questa energia."
"Basta, ti prego, non ce la faccio più. Mi scoppia la mascella."
"Ricorda, amico, i pensieri sono più potenti della realtà fisica, perché non sono soggetti ai limiti
della materia."
"Ok, basta, ora fermati, ti prego! Non ce la faccio più, tregua."
Mi guardò storto.
O meglio, lo vidi guardarmi storto.
Non capivo più niente. Terminai il secondo spinello e aspettai che mi passasse la ridarella. Poi mi
feci serio, o almeno ci provai.
"Non sono convinto di rimanere qui."
"Forse è troppo presto" disse lentamente. "Hai bisogno di vedere ancora un po'. Torna quando sarai
certo che è qui che vuoi vivere."
Passai qualche minuto in silenzio a riflettere.
"Eppure questo posto mi piace veramente. Non ho mai amato un posto quanto questo." Le parole mi
uscivano lente e mi sembravano le migliori che avrei mai potuto pronunciare. "Ma il problema è un
altro: e se questo posto non fosse l'unico? E se non fosse il miglior posto in cui vivere?"
"Il problema non è dove, amico. Lo sappiamo entrambi. Ascolta: vai e divertiti."
Notai un ragazzo che stava surfando davanti a noi. Era lontano, eppure lo vedevo bene volteggiare
sulle onde altissime.
"Spero di trovarti qui quando tornerò."
"Non ci contare. Gli specchi prima o poi s'infrangono."
Annuii senza capire a cosa si riferisse.
X
Dal Brasile presi un autobus diretto in Colombia, poi da lì mi spostai in Panama, superai il canale e
sbarcai in Costa Rica, quindi Nicaragua, Honduras, Guatemala e finalmente Messico.
Arrivai in Chiapas e me ne innamorai, ma l'istinto mi portò negli altopiani del nord: dovevo
realizzare un vecchio desiderio giovanile: uno dei miei sogni da adolescente.
Lessi qualcosa su internet:
Pianta utilizzata da un certo numero di artisti, filosofi, psicologi e ricercatori, i quali contribuirono
alla diffusione della mescalina nella cultura psichedelica degli anni sessanta e settanta.
[...]
Nella prima fase della vita è coperto di piccole spine, che vengono progressivamente sostituite da
prolungamenti lanosi. I fiori sono generalmente simili a piccole margherite di color bianco-pallido o
rosaceo.
Nel suo stato naturale raramente affiora dal terreno per più di tre centimetri; la radice della pianta è
interrata e arriva fino a venti. La parte che fuoriesce dal terreno – il famoso 'boton' – è quella che
viene tagliata e consumata fresca o disseccata.
Scoprii che non solo rappresentava una delle droghe allucinogene più popolari tra le popolazioni
indigene, al punto che per gli indios messicani era a tutti gli effetti un Dio, ma che molte tribù lo
utilizzano ancora oggi per divinare il futuro.
Raggiunta la Sierra de Catorce parlai con la gente del posto. Non fu difficile incontrare le persone
giuste ("¿Has leydo a Castañeda, verdad?") che mi condussero da uno sciamano che abitava in uno
dei pueblos fantasmas del deserto alto di Potosi. Rimasi tre settimane con lui notte e giorno
parlando e ascoltando la natura, finché un gelido mattino mi disse: "Adesso sei pronto."
Ci incamminammo nel deserto mentre un asino ci seguiva carico di coperte variopinte, un sacco, un
paio di padelle penzolanti e una tanica d'acqua.
Dopo un giorno di cammino accendemmo un fuoco, lo sciamano cucinò dei fagioli neri e tortillas.
Mangiammo tutto e dormimmo sotto tre strati di coperte. All'alba andammo in cerca del peyote.
Il sole era già alto quando lo incontrammo. Sudavo.
Raccogliemmo ventiquattro botones, dodici a testa. Poi ci spostammo sotto l'ombra di una grossa
pietra bianca e iniziammo a pulirli dalla polvere, dalle spine e dai prolungamenti lanosi.
Finché non disse: "Adesso ascolta."
Silenzio.
"Prendine uno e mangialo."
Il sapore era amaro, ma riuscii a masticarlo e ingoiarlo. E così gli altri undici piccoli cactus.
Poi chiuse gli occhi incavati e tacque per alcuni secondi.
"Adesso puoi dare risposta alle tue domande. Con calma. Abbiamo tutto il tempo che sarà
necessario per ricongiungerti con la tua anima errabonda."
A circa mezz'ora dall'ingestione sopraggiunse la nausea, accompagnata da vertigini, finché vomitai.
Sapevo che sarebbe successo e rimasi tranquillo. Poi mi sentii meglio, ma la bocca mi si riempiva
continuamente di saliva che io seguitavo a sputare. Mi faceva male il collo e provavo lo stesso male
alla mandibola di quando ridevo troppo.
Poi tutto scomparve. Mi ritrovai in paradiso. Lassù, euforico. Mi sembrava di volare. Sentivo ogni
piccolo rumore rimbombare nelle orecchie, la miopia era scomparsa, i colori erano vivi, intensi:
rosso, blu, verde, giallo: nessuna via di mezzo, solo colori sgargianti. Mi concentrai sui sassolini
che vedevo vicino ai piedi. Sembravano spostarsi da soli. Li vedevo rotolare e scontrarsi.
Ero in pace con me stesso. L'energia di prima scomparì ed entrai in uno stato di profonda
contemplazione. Vedevo persone, animali, alberi, muoversi, ballare, parlare. Poi iniziarono le luci
nell'aria e sotto un suono di tamburi. Fino a non capire più. E nella confusione provai una
sovrapposizione tra i vari sensi: ascoltavo con gli occhi, mangiavo con le orecchie, guardavo con la
bocca. Subito dopo mi addormentai.
Qualche ora più tardi ero pronto a parlare.
"Ci sono."
"Cosa hai visto?"
"Ho visto il mondo, l'universo: e quel mondo ero io, e l'universo ero io."
"E poi?"
"Ho visto le anime del mondo prendersi per mano."
"Hai visto te stesso? Sei riuscito a rispondere ai tuoi dubbi?"
"Ho visto il mio corpo intento a costruire una capanna nella giungla."
"Bene. Quella è la tua strada. Seguila."
"In che modo? Dove devo andare? Cosa devo fare?"
Non rispose.
"Grazie, maestro."
x
Mentre decidevo dove passare il resto dei miei giorni, ritrovai nella guida dell’Asia centrale alcuni
fogli scarabocchiati. Erano frasi che avevo scritto a Samarcanda, in Uzbekistan, nei giardini delle
case in cui ero invitato, quando ancora ero ingenuo e spensierato, quando ancora credevo che realtà
e desiderio coincidessero.
L'Uzbekistan per me era mistero, era polvere, erano quarantasette gradi all'ombra – perché al sole
non ci potevi stare. Uno stato sconnesso, violentato dall'armata russa, avvelenato con la vodka,
azzittito con l'alfabeto cirillico. Un crogiolo di facce: cinesi, mongole, mediorientali, russe, europee,
afgane: uzbeke. Una terra cordiale. Un popolo con lacrime agrodolci, con l'orgoglio ferito, con un
senso d'inferiorità verso l'uomo bianco: un popolo con una segreta voglia di rivalsa.
La gente uzbeka è un letto per gli ospiti. La gente uzbeka è un chai per lo straniero. La gente uzbeka
è come vorrei essere.
Ricordo quei giorni come i più belli della mia vita. No, non è una banalità, erano davvero giorni
belli. E con belli intendo avventurosi, vivi, vergini, ricchi. In quei giorni ero riuscito a mettere da
parte la morte dei miei e a tornare ragazzo: un giovane esploratore in cerca di mondi ignoti da
portare alla luce dei pensieri, degli occhi.
Sabato
La noia s’impadronisce presto del viaggiatore che conosce a memoria le sue rotte mutande, proprio
come s’impadronisce del romanziere che è troppo sicuro della sua trama. Un buon viaggiatore non
sa dove andare, non ha programmi. Il suo scopo non è arrivare.
E allora ascoltami un secondo, baby: risvegliati prima che sorga il sole e privo di pensieri cerca la
tua strada. Lascia che la notte ti sorprenda ovunque a casa, e che la luna t’illumini finalmente
l’anima nuda. Non ci sono montagne più alte di queste, né tempi più degni di essere persi di questi.
Domenica
Un lungo viaggio è come una festa senza fine. Non sai cosa ti può accadere, non sai chi incontrerai;
sai solo che alla fine tornerai esattamente al punto di partenza, per vedere il mondo con occhi
diversi.
A volte dobbiamo fuggire nelle terre estreme, nelle solitudini assordanti, nell’assenza di scopi,
nell’incoscienza del pericolo, per bruciare la vita, per saggiare nuove difficoltà, per essere costretti a
sforzarsi nella disperazione, fino a non avere niente da perdere, e sentirsi finalmente vivi. Il viaggio
non è altro che gioia infinita.
Lunedì
Molti spendono soldi in maniera diversa dai loro gusti naturali, e ciò avviene per farsi belli agli
occhi dei loro vicini: a che serve possedere un’automobile nuova o un vestito firmato?
In realtà, chi preferisce sinceramente viaggiare, avere una buona biblioteca o comprare abiti usati,
alla fine sarà molto più rispettato che non se si fosse comportato esattamente come tutti gli altri.
Martedì
Tra il popolo è fin troppo semplice vivere seguendo l’opinione del popolo. In solitudine è fin troppo
semplice vivere seguendo la propria.
Fantasticus autem est, chi, nell’ombelico del mondo, tra arcobaleni dissonanti e schiamazzi d’ogni
colore, conserva col sorriso l’indipendenza della solitudine.
Mercoledì
Quando ci abbandoniamo al sogno di viaggiare, come facevamo da ragazzi, ci accorgiamo che se
non partiamo ora, non lo faremo mai più, e vivremo per sempre ossessionati dai nostri sogni non
realizzati, certi di aver peccato gravemente e senza possibilità di appello contro noi stessi.
E in verità dicono che l’uomo è fatto di desiderio. E come è il suo desiderio, così è la sua fede. E
come è la sua fede, così sono le sue azioni. E come sono le sue azioni, così egli diviene.
Se desiderate viaggiare, viaggiate.
Giovedì
Non voglio mettermi fretta. La fretta è un atteggiamento velenoso della società moderna.
Se vuoi fare qualcosa in fretta, vuol dire che non te ne frega un cazzo, e vuoi passare a qualcosa di
più interessante.
Venerdì
Quanto più s’allarga la nostra conoscenza dei buoni libri, tanto più diviene minuta la cerchia delle
persone con le quali ci piace trascorrere il tempo: chi brucia i libri, presto o tardi arriverà a bruciare
esseri umani.
Sabato
Il mondo del viaggiatore non è quello sciatto e ordinario in cui viviamo, il suo mondo è il viaggio
stesso, un’implicita ricerca dell’anomalo.
Domenica
Pietà e conformismo a quelli che ne vogliono, io sono colui che a forza d’insulti, sprona uomini e
donne gridando: su, alzatevi in piedi, camminate, lottate per le vostre vite!
Ascoltate, siamo qui sulla terra per perder tempo: non permettete a nessuno, neanche al padre
eterno, di dirvi che non è così.
Lunedì
Si dice che quello che tutti cercano sia il senso della vita: mentre viaggio realizzo che ciò che
cerchiamo è semplicemente l’esperienza dell’essere vivi.
Martedì
Andarsene da casa è una specie di regalo.
Quando si arriva tra sconosciuti, ci si stupisce che siano persone per bene: nessuno vi deride o
spettegola su di voi, nessuno invidia i vostri successi, nessuno gode per le vostre sconfitte: dovete
ricominciare da zero, come una specie di redenzione.
Mercoledì
I turisti non sanno di non sapere dove sono stati, i viaggiatori sanno di non sapere dove stanno
andando.
Giovedì
I treni passano senza più tornare.
Li osservate allontanarsi. Vedete la vostra vita avvizzirsi e non fate niente per salvarla, per darle un
senso. Vi nascondete dietro la mediocrità di una società malata.
Vi ci perdete senza reagire, sentendovi ormai troppo vecchi.
E più aspettate, più vi sentite vecchi.
E più vi sentite vecchi,
più siete arrendevoli e in preda alla disperazione.
X
Dopo tre settimane in Messico avevo deciso. Tornai a San Cristobal de la Casas: avrei vissuto il
resto dei miei giorni in Chiapas.
Il passo successivo era capire il modo migliore di investire i cinquecentocinquantacinquemila euro
che mi rimanevano sul conto.
Lasciai l'ostello e affittai un appartamento in centro con la speranza di riuscire a mescolarmi con la
comunità locale. Senza fretta. Sapevo che presto qualcosa sarebbe successo. Quando si viaggia da
soli è così che funziona.
Da sempre ero appassionato alla vicenda degli EZLN guidati dal subcomandante Marcos e della
loro lotta per i diritti del popolo maya. Incontrai Raquel durante la proiezione di un documentario
sulla rivolta zapatista in uno stanzone buio all'interno di un centro culturale.
"Esatto, sono messicana, di Merida. Lavoro per una ONG che si occupa dell'educazione dei bambini
della foresta" mi disse guardandomi con occhi languidi. "Vivo qui da cinque anni."
Non era molto alta, ma aveva lineamenti morbidi e forme generose. La pelle profumata e scura. Il
sorriso intrigante. Le spalle dritte, rotonde alle estremità. Un naso piccolo e un po' schiacciato. Gli
occhi ovali che mi ricordavano vagamente le ragazze dell'est: ma nei suoi vedevo brillare una luce
nuova.
"Ti invidio, io sono sempre rimasto nel Nord Italia, prima in un piccolo paesino, poi in una piccola
città."
"Sono io che dovrei invidiarti, stai girando il mondo da quasi un anno!"
A metà documentario mi invitò ad uscire per fumare una sigaretta. Decidemmo di andare da lei.
Viveva in una antica posada.
"Quanto ti costa un appartamento del genere?" disse mentre camminava nella stanza guardandosi in
giro, quasi fosse la prima volta.
"Non vivo sola. Siamo in cinque. Vieni, ti mostro le camere."
La seguivo senza perdere di vista quel sedere a mandolino che mi faceva impazzire. Portava un paio
di jeans corti, piuttosto chiari, e una camiseta bianca in cui due grossi seni venivano sballottati in
ogni direzione.
"Credi che sarei portato per lavorare in una ONG?"
"Dai, non scherzare, si vede che non hai voglia di lavorare."
Incassai e presi a prendere in mano i libri che trovavo sparsi per la casa.
"Quello è mio, prendilo se vuoi."
"Davvero, grazie."
In realtà non mi interessava granché un saggio sulla psicologia infantile, ma era una maniera di
legarmi a lei e poterla rivedere.
La rividi la notte seguente in un ristorante fuori dal centro. Le pareti azzurre, le sedie rosse, il
pavimento verde. Un piccolo giardino al centro. Lei in un succinto abito da sera color ocra. Il seno
abbronzato che sembrava uscire da un momento all'altro.
"Puoi mangiare tutto quello che vedi a soli cinquanta pesos."
"Perfetto."
Ci sedemmo.
"Che intenzioni hai?"
Trasalii.
"Be', questo dipende anche da te..." dissi cercando di distogliere lo sguardo dalla lunga linea
verticale che formava il suo seno costretto nel vestito.
"No, non hai capito" disse sorridendo, "intendevo dire quanto rimarrai a San Cristobal."
"Per sempre, pensavo. Che dici?"
"Dai, non fare lo stupido. E il tuo viaggio attorno al mondo?"
"In realtà ho trovato ciò che cercavo: un bel posto dove vivere. Ho dei soldi da parte e pensavo di
investirli."
"Non è così economico come credi, sai?"
"Lo so perfettamente. Non è questo il problema."
Tacque per un attimo. Io cercavo nuovamente di sbirciare dentro la scollatura.
"Cosa avresti in mente?"
Tornai a guardarla negli occhi nocciola.
"La mia idea sarebbe quella di gestire un campeggio o qualcosa del genere."
"Visto? Te l'avevo detto che non avevi voglia di lavorare!"
"Non è questo. Ho bisogno di tempo per dedicarmi alla scrittura."
"Sì, dite tutti così voi artisti. E intanto noi ci facciamo il culo..."
Scoppiai in una risata sonora che rimbombò nel locale.
Il nostro terzo incontro avvenne nel mio appartamento. Speravo fosse la volta buona. Quella
ragazza mi piaceva veramente.
"Vuoi qualcosa da bere?"
"No, grazie."
"Acqua?" dissi appoggiandole le mani sulle spalle mentre lei sfogliava una rivista seduta sul divano.
"No, tranquillo, sto bene così."
"Bene, perché era finita. A meno che tu non beva quella del rubinetto."
Sorrise e si alzò. Vestiva attillati pantaloni da ginnastica grigi che le mettevano in risalto i fianchi.
Si girò e mi osservò in silenzio.
"Senti, ti va se mi fermo a dormire?"
"Non c'è problema" dissi mandando giù con difficoltà un sorso di saliva che mi si era formato
istantaneamente in bocca. "Ti cedo il mio letto, io starò bene sul divano."
"Non è necessario."
Girò attorno alla stanza e riconobbe il suo libro. "L'hai terminato?"
"Non ancora... ma preferisco restituirtelo, sto leggendo Pedro Paramo."
"Hai trovato qualcosa?"
"Come dici?"
"Ti sei informato sul costo dei terreni qui a San Cristobal o a San Juan de Chamula?"
"Non ancora. Sono un po' pigro..."
"Senti, io avrei un posto perfetto. Però è lontano da qui."
"A me basta che sia in Chiapas, in una località dove arrivino tanti viaggiatori zaino in spalla."
"Allora è perfetto. Hai mai sentito nominare Palenque e le sue rovine nella giungla?"
"Por supuesto."
"Bene, c'è una zona chiamata El Panchan dove passano centinaia di turisti ogni giorno. E la maggior
parte sono come intendi tu."
"Sì, conosco El Panchan. Quante ore dista da San Cristobal?"
"Saranno circa otto in bus. Ne parte uno ogni sera" disse. "Anche stasera volendo."
"Stasera?"
"Volendo..."
"Be', avevo un'altra idea per stasera..."
"Domani è sabato. Se partiamo stasera potremmo essere di ritorno lunedì mattina, così non avrei
problemi col lavoro."
Passai la notte con lei su un autobus diretto a Palenque. Lei mi tenne stretta la mano per l'intero
tragitto. Anziché dormire, passai le ore osservandole il viso color cioccolata che si faceva chiaro
nell'oscurità ogni volta che i fari di una vettura lo illuminavano.
Arrivammo al mattino. La città non mi fece una bella impressione: la solita cittadina hotelera. Ma
quando poi smontai da un minibus e mi inoltrai con Raquel nella giungla, me ne innamorai. Di
entrambi intendo.
y
Quando una nuvola di fumo gli arrivò in gola Giovanni tossì e alzò la testa.
“Ah, sei tu. Ciao Alex, scusami per ieri, ero fuori di me. Quelle cose non le penso veramente.
Scusami ancora, davvero.”
“Non fa di niente di nulli. Non so cose me ha presi per mandare te ai paesi. Dopo ai pranzi brindisi
a nostre saluti. Prima sono passati dalle tue scrivanie e non vi ho visti, pensavo fossi andati in
definitive.”
“Be', in effetti dopo quello che mi hai detto la mia idea è proprio quella. Ero andato a parlare con i
dirigenti per giocarmi le mie ultime carte, ma…”
“Lasci di perdere, quelli sono tutti granché stronzi! Vai di qui fino a che sei ai tempi!”
“Tu dici? Non mi conviene sentire quello che hanno da dirmi?”
“Tu faresti di te le figure di rompere palle, lasci di perdere! Anche io delle tue età eri da direttori
ogni volte di lunedì, e guarda come sono terminati.”
“Ma qui non c’è nessuno che mi possa mettere in contatto col direttore? Non c’è un ufficio di
competenza?”
“Anche ora non hai compresi? Lasci di perdere! O firmi contratti e torni di lavorare oppure licenzi
te e vai! La secondi delle due, per un favori!”
“Grazie, Alex, se non ci fossi tu…”
x
El Panchan era il posto che avevo sempre cercato. Mancavano l'oceano brasiliano e le sue onde, ma
in compenso c'erano la giungla, le capanne di legno, una comunità di archeologi, un sacco di
viaggiatori provenienti da tutto il mondo, e i bagni della regina nascosti nella foresta.
Affittammo una capanna, ma la usammo soltanto per depositare gli zaini. Il sabato visitammo le
rovine a piedi, distavano soltanto un paio di chilometri. La notte la passammo a fare il bagno
assieme ad altra gente ubriaca all'interno del parco archeologico, nei bagni delle regine maya.
Vederla in costume alla luce della luna mi faceva impazzire. Avrei tanto voluto baciare Raquel e
fare l'amore con lei, ma c'erano troppe persone attorno. Riuscii soltanto ad allungare le mani qua e
là. Stavo scoppiando, ma prima o poi il momento sarebbe arrivato.
La domenica incontrammo un paio di ragazzi che Raquel aveva contattato ancora prima di partire.
Era gente a posto. Fisici magri, pelle appena abbronzata, capelli corti, jeans e camicia. Parlavano
entrambi un ottimo inglese. Dovetti fermarli subito e dire loro che preferivo parlare spagnolo. Mi
mostrarono i documenti, io mostrai il passaporto. Volevo capissero che anch'io facevo sul serio.
"Venite, non è lontano. Possiamo andare a piedi."
Quando vidi il posto e pensai che poteva essere mio, capii che era l'occasione che cercavo da un
anno. Una grande estensione di verde giungla allo stato naturale. L'umidità rendeva l'atmosfera sana
e densa. Piante di specie che non conoscevo creavano una sorta di tenebra. Un ruscello
dall'andamento irregolare scendeva lento accompagnando il canto degli uccelli e delle scimmie
urlatrici in cima agli alberi altissimi.
"Raquel, che ne dici?"
"A me sembra bellissimo, no?"
"Lo è."
"E quanti ettari sarebbero?"
"Quattro chilometri quadrati."
"Non so, mi sembrano troppi. E quanto costerebbero?"
"Seicentomila dollari americani. Prezzo fissato. Niente sconti."
"Impossibile. A me basta un quarto di questo terreno. Cosa me ne faccio di due chilometri per due?"
"Noi vendiamo tutto unito. Altrimenti niente."
"Mi dispiace, ma è davvero troppo."
"Ma la sua fidanzata ci ha confermato che lei dispone di questa cifra."
La guardai. Lei mi fece l'occhiolino.
"Noi abbiamo altri possibili acquirenti interessati. Questa zona è richiestissima da catene di hotel
per gringos americani."
"Un hotel nella giungla a un chilometro dalla una zona archeologica?"
"Sì."
"Che tristezza..." disse Raquel. Io la guardai annuendo.
"Per questo noi desideriamo vendere a gente come lei. Se lei ci assicura che non userà cemento."
"Posso parlarti in privato" dissi a Raquel.
La presi per la mano e la condussi una trentina di metri più in là.
"Perché gli hai detto che eravamo fidanzati?"
"Non l'hai capito? Loro si fidano di te perché stai con me, con una messicana. Non vogliono
vendere a stranieri la terra dei loro antenati."
"Hai ragione, hai avuto un'ottima idea."
"Lo so" disse prima di baciarmi su una guancia. "Senti, se ti sembra troppo lascia perdere. Nessuno
ti obbliga a farlo."
"In realtà quella è esattamente la cifra che mi ero proposto di investire. Inoltre il posto è fantastico.
Mi sembra tutto perfetto."
"Pensaci bene, non prendere decisioni azzardate."
"Lo so che non dovrei, ma anche se mi conosci da poco avrai capito che sono pazzo. Sento dentro di
me che acquistare questo pezzo di giungla è la cosa migliore che mi possa capitare. E viverci
assieme a te..."
"Ma io lavoro a San Cristobal!"
"E non ti piacerebbe venire a vivere qui? Gestire una trentina di capanne e leggere tutto il tempo?"
Lei si avvicinò e mi baciò. Stavolta sulle labbra.
y
I giorni passavano e Giovanni ritrovava la pace che gli era mancata negli ultimi mesi. Gli altri
continuavano a chiedere il suo aiuto e lui era contento di darglielo. Tutto sommato quella vita gli
piaceva e non voleva andarsene proprio ora che cominciava a trovare un equilibrio. In quel periodo,
nonostante si fosse dato da fare a spedire curriculum, non gli arrivò neanche una proposta
lavorativa. Forse la crisi economica era già arrivata, e Giovanni si stava convincendo che doveva
svolgere al meglio la mansione che gli era stata assegnata. Oramai nell’azienda si sentiva a casa.
“Ancora tu sei qui?” disse Alex un giorno passando dalla sua scrivania.
“Eh, sì, alla fine avevi ragione. Ho firmato a tempo indeterminato senza rompere le scatole a
nessuno” disse Giovanni sorridendo all’amico.
“Tu hai firmati?”
“Alla fine non mi trovo poi così male.”
Alex pensò qualche istante prima di aprire bocca. “Tu vedi? Tu hai fatto beni! A te l’avevo detto io,
o lavoravi o te andavi! E te ha scelti lavorare, bravi!” disse accendendosi una sigaretta e sorridendo
di gusto. “Tra tre di anni spostano te ai quarti e puoi fare le carriere tu meriti.”
Una volta a casa, vedendo l'ennesima lettera della Cassa Rurale indirizzata a Luigi, cedette alla
curiosità e l'aprì delicatamente, in modo da poterla poi incollare.
x
Lasciai ai due venditori un acconto di ventimila dollari, firmai i documenti, presi la ricevuta, la
piegai e la riposi con cura nel portafoglio, dopo di che tornai con Raquel a San Cristobal.
Lei venne a stare da me, nel mio appartamento.
Pensavo e ripensavo se quello che stavo facendo era la cosa giusta da fare. Ne discutevo con
chiunque mi capitasse di incontrare. Viaggiatori, gente del posto, albergatori stranieri: tutti erano
convinti che il prezzo era ragionevole e che si trattava di un investimento.
"Se ti stufi lo puoi sempre rivendere. Magari al doppio" mi aveva detto un ricco signore del posto
che avevo conosciuto in un bar. "Puoi trasformare la foresta vergine in un paradiso. Basta
deforestare quel poco che consenta di accedervi. Creare dei sentieri. Costruire qualche capanna.
Fornirle di energia elettrica e acqua. Non serve nient'altro."
Raquel quella settimana uscì ogni mattina e tornò la sera.
"Io vado. Ho deciso. Me ne sto un paio di giorni a El Panchan per respirare l'atmosfera e poi, se la
sensazione è giusta, firmo il contratto di acquisto. Sto impazzendo nell'attesa."
"Quando parti?" disse lei guardandomi dal basso all'alto con occhi da cerbiatta. Attraverso la
scollatura riuscivo a cogliere ogni centimetro di pelle mora.
"Domani sera pensavo. Vieni con me?"
Le appoggiai una mano sulla spalla nuda.
"Stai scherzando? Credi che possa licenziarmi da un giorno all'altro?" disse scrollandosi di dosso la
mia mano.
"Ma ci penserai a raggiungermi?"
"Tempo al tempo" disse togliendosi la maglietta e rimanendo in reggiseno. "Intanto divertiamoci."
y
Passarono alcune settimane nella calma più assoluta, quando Giovanni sentì gridare: “Un brindisi
all’Alex!”
“Sì, al migliore tra di noi brindiamo!” disse uno dal viso olivastro.
“Son siempre i meglio che se van” disse un altro ancor più scuro.
Alex aveva un sorriso raggiante. Aveva tolto il toni da laoro blu e vestiva in abiti borghesi.
“Ma dove te ne vai?” disse Giovanni senza capire. “Hai trovato un altro lavoro?”
Alex, lo si vedeva chiaramente, sperava proprio che Giovanni gli facesse quella domanda.
“No, cari miei belli Longo. Io mi vado ai quarti!” disse Alex con un ghigno in viso. “E lei dottori
Longo rimani qui in garage per tristi resti di tuoi tristi giorni!”
Giovanni non capiva. “Ma come hai fatto?” disse con voce tremante.
“Avresti beni potuti fari anche te! Ogni anni prendono uno per portare su al quarti. Sai no?”
“Sì, ma tu mi avevi detto…”
“Bastavi fare domande, coglioni!”
Giovanni ebbe un colpo al cuore. “Sì, ma tu mi avevi detto che se firmavo a tempo indeterminato
non avrei potuto cambiare di livello per almeno tre anni.”
Tutti scoppiarono a ridere. Guardavano Longo e ridevano come bambini.
“Mai fidare di amici, coglioni!” gli disse Alex felice come non lo era mai stato. “Tieni, coglioni!”
gridò dandogli una sberla su una guancia.
Longo non reagì. Si alzò senza toccare cibo e tornò a sedersi alla sua scrivania. Solo per un attimo,
poi non resistette. Prese la giacca e uscì dall’azienda. Il mondo gli era crollato addosso. Poteva già
essere al quarto. E invece si era fatto infinocchiare dall’unico collega che gli aveva rivolto la parola.
x
Finalmente io e Raquel facemmo l'amore. Nuda era ancora più bella. La sua pelle mulatta, liscia,
splendente mi portò all'estasi. Aver aspettato così tanto rese quella notte ancora più magica.
Balle. È successo solo nei miei sogni. Ho mentito. Non ero ancora riuscito a farmela del tutto. Però
quella notte ci strusciammo per una buona mezzora prima di andare a dormire. Ero cotto a puntino.
Ormai era mia, era cosa fatta.
Al mattino ci salutammo con un lungo bacio. Lei andò al lavoro. Io pagai l'affitto per il resto del
mese. Speravo infatti che poi Raquel mi avrebbe raggiunto nel mio paradiso. Feci i bagagli e presi
l'autobus delle venti.
Arrivai alle cinque del mattino. Il tempo di fare colazione in un bar di Palenque e mi fiondai in un
taxi diretto a El Panchan. Mi sistemai in una capanna del piccolo campeggio. Mi facevano sorridere
quelle dieci capanne ravvicinare rispetto al progetto che avevo in mente per il mio paradiso. Per il
nostro paradiso. Sapevo che alla fine del mese Raquel mi avrebbe raggiunto, per sempre. Nei suoi
occhi, mentre ci baciavamo, avevo visto la luce della passione. Non stava fingendo. Anche lei si era
invaghita di me, anche se non lo voleva ammettere a parole.
"Dove devo firmare?"
L'ufficio era lussuoso e ottimamente arredato: tetro come doveva essere.
"Basta una firma qui e un'altra qui."
"Perfetto" disse l'altro. Al momento della firma io vestivo pantalocini corti e canottiera, loro giacca
e cravatta. Non avevo pensato alla forma per quell'occasione tanto importante.
"Qui ci sono gli atti, signor Alberti" disse il notaio o avvocato, non avevo ben capito, nello studio
del quale stavamo firmando il contratto.
Mi dispiaceva che Raquel non fosse venuta. Era un momento importante anche per lei.
"Bene, è tutto."
Alla fine ero riuscito a strappare un prezzo migliore, seicentocinquantamila dollari. Circa
cinquecentomila euro. I cinquantamila che mi rimanevano sarebbero serviti per costruire la capanne
e tutto il resto.
La settimana seguente rimasi a vivere nella capanna del campeggio di El Panchan, ma cominciai i
lavori di disboscamento. Da solo non sapevo da dove iniziare. Chiamai quindi una ditta locale e gli
spiegai la situazione. Volevo cominciare a creare delle zone pulite collegate da sentieri. Ci
mettemmo al lavoro.
Il giorno lo passavo a lavorare con la squadra di disboscamento, la notte a bere con gli archeologi
che vivevano nel campeggio di El Panchan. Da un po' di giorni Raquel non era raggiungibile. Il suo
cellulare era sempre spento.
Il quinto giorno di lavori, il venerdì, arrivò la polizia.
"Buongiorno."
"Buongiorno" risposi. "Siete venuti a controllare i lavori?"
y
Giovanni, coi pensieri sempre in bilico tra passato e futuro, non aveva smesso di pensare a Salomè,
la ragazza spagnola del quarto. Si ricordò di una conversazione che aveva avuto con Luigi a Trento,
prima che l'amico scomparisse senza farsi più sentire.
“Sei uno scemo. Punto.”
“Sì ma, vedi, nella sfiga ho avuto fortuna. Sono certo che a breve sarò al quarto! Non ci sono dubbi!
Sono nettamente più preparato di tutti quelli del terzo.”
“Non hai capito, te lo ripeto: SEI-U-NO-SCE-MO.”
Si sedettero.
“Tu non capisci! In azienda non ci sono superiori nel mio reparto. Arrivano le commissioni, noi le
portiamo a termine, le consegniamo e la cosa finisce lì. Lo so che è assurdo, ma oramai mi ci sono
abituato.”
“Ma ti rendi conto che non ti hanno nemmeno dato un PC? Sei nel terzo mondo del lavoro, cazzo.
Lavori nella preistoria!”
“Sì, ma a breve tornerò al quarto, o chi lo sa, magari direttamente al quinto. E inoltre sarò a tempo
indeterminato io! Cavoli, mi sento un leone!”
Ordinarono.
“Ma tu sei tutto scemo! Sei confinato in un garage e sei qui a festeggiare. Gli anni passano, Jo.
Passano anche per te. Goditela un po’! Se almeno non vuoi lasciare quella disgrazia di lavoro,
trovati una…”
“C’è una tipa che mi piace. Al quarto.”
Arrivarono le birre. Una chiara, una scura. Cin. Iniziarono a bere.
“Come? Tu che pensi alle donne? Oddio, scommetto che fuori nevica. Avanti, sentiamo!”
“È fantastica. Laureata in lingue moderne: russo e italiano. Carina, simpatica…”
“Ok, ho capito, è un cesso.”
“No! È mora, spagnola, simpatica, magra e con un petto invidiabile, davvero Luigi, un seno
incredibile!”
“Un petto? Un seno? È tuo nonno che ti insegna a parlare? Si chiamano tette, punto. E comunque
non sembra male a quanto dici. E quando te la sei fatta?”
Terminarono le birre.
“Come fatta? Veramente l’ho vista una volta sola, nel suo ufficio...”
“Oddio, non ci sei neanche uscito? Cosa aspetti? Che se ne torni in Spagna?”
Si alzarono e Giovanni si precipitò a pagare.
“Come faccio, Lu, se non posso neanche metterci piede al quarto?”
“Inventati qualcosa! Vai su e ti fai dare il numero. Fine. E non aspettare secoli come al solito. Vuoi
che ci vada io al tuo posto?”
Poi i suoi morirono e lui scappò, ma le sue parole ancora giravano nella testa di Giovanni.
X
"Signor?"
"Sono l'ingegner Luigi Alberti. Piacere."
"Signor Alberti lei è in arresto."
"Cosa?"
"Questo terreno è di proprietà dello Stato del Chiapas, nonché Parco Archeologico Nazionale del
Messico."
"Si sbaglia. Ho qui una fotocopia dei documenti firmati dal notaio."
Quando vidi quell'uomo avvolto in una seria divisa marrone ed enormi scarponi neri ridere e
scrollare la testa, le gambe iniziarono a tremarmi.
"Lei è in arresto."
"Non è possibile."
"In Messico tutto è possibile" disse. "Anche che una persona onesta e ingenua venga truffata. Capita
più spesso di quanto lei pensa."
La polizia provò a risalire al possessore della scheda SIM di Raquel, ma senza successo. L'ufficio
del notaio e il notaio non erano mai esistiti. I due venditori in giacca e cravatta avevano con sé
documenti falsi.
Nessuna Raquel aveva mai lavorato in una ONG che si dedicava ai diritti dei bambini.
L'appartamento in cui mi aveva detto di vivere con altre quattro coinquiline non era mai stato suo.
Era senz'altro una professionista.
Nulla. Non mi rimaneva nulla, se non un orgoglio infinitesimale e un cuore trafitto.
Scontai la pena passando sette giorni – e soprattutto sette notti – in una cella a cercare invano di
dormire, di leggere e di buttare giù qualcosa nel diario. Il carcere però mi ispirò una trama. Mi
sentivo come un pesce intrappolato in una sfera in fondo all'oceano. L'ultima notte scrissi la prima
stesura di quello che poi sarebbe diventato un romanzo breve dal titolo Il pesce illuminato.
Una volta fuori pagai le multe per i danni che avevo procurato al Parco Nazionale. Avevo ancora
poche migliaia di euro.
Avevo fretta di prendere una decisione: dovevo rimanere o scappare nel posto da dove ero
scappato?
Y
"Mamma, vieni."
"Arrivo, caro" disse un paio di secondi prima di entrare nella camera di Giovanni in accappatoio.
Giovanni fece una smorfia.
"Che c'è?"
"Niente..." disse sbuffando. "Devo dirti una cosa. Anzi mostrarti una cosa."
Giovanni le porse la lettera che aveva aperto la settimana precedente.
"Attenta a non rovinarla con quelle mani bagnate."
Mentre lei leggeva, lui senza volerlo osservava ciò che l'accappatoio slacciato non riusciva a
nascondere.
"Ma, Giova, questo è incredibile!" disse alzando le braccia al cielo e mostrando il seno a Giovanni.
X
"Pronto? Jo?"
Silenzio.
"Jo?"
"Chi è? Sei Luigi?"
"Ehi! Vecchiuz! Come va lì a Trento?"
Silenzio.
"Perché te ne sei andato senza salutare?"
"Non lo so... è stato un gesto istintivo..."
"Avresti potuto chiamare in tutto questo tempo, non ti pare?"
"Giusto. Avrei potuto."
Silenzio.
"Senti, Jo, ho combinato un casino."
"Non avevo dubbi."
"No, credimi, stavolta l'ho fatta grossa. Ho perso tutto."
"Intendi i soldi ricavati dalla vendita della casa dei..."
"Sì. Tutti."
"Tutti tutti?"
Silenzio.
"Come cavolo hai fatto?"
Silenzio.
"Cosa cavolo hai comprato?"
"Una fregatura" dissi. "Mi hanno truffato. Non ho più niente. Già tanto se riesco a tornare."
Jo sbuffava.
"Dai che scherzo, stupido! Non ci avrai mica creduto?"
Silenzio.
"Che stronzo! Stavo quasi per crederci, ma sapevo che non eri scemo fino a quel punto."
"E se fosse vero?" dissi. "Rimarresti mio amico? Rimarresti amico di un coglione?"
Silenzio.
"Be', ce l'hai. Eccomi qui."
In quei momenti avrei tanto voluto essere tra le sue braccia incredibilmente pelose, non tutto solo, a
migliaia di chilometri di distanza.
"Lu, vieni a stare da me e mia madre. E non preoccuparti per i soldi, i soldi non sono tutto nella
vita. L'importante è che tu stia bene."
"Jo, ho buttato via una fortuna, come puoi dirmi di non preoccuparmi. Sono un uomo finito."
"Tu vieni qui. Ci penso io a tirarti su."
Stavo per tornare in Trentino: in Trentino dove non avevo né un lavoro, né una casa, né una
ragazza: né una reputazione.
Presi il primo volo economico per Milano, poi il treno fino a Trento. Jo mi aspettava in stazione.
Mi abbracciò, prese il mio zaino e s'incamminò. Non ebbi nemmeno il tempo di sfotterlo un po'.
Non ne avevo voglia. Lo seguii in silenzio. Lungo il viale che dalla stazione portava a casa di Jo, i
noccioli e le betulle erano già fioriti. I bambini saltavano, le mamme gridavano, i vecchi li
osservavano sorridendo in silenzio. Jo camminava rapido senza girarsi, quasi avesse fretta di
arrivare a casa. Portava pantaloni lunghi di un brutto colore tra il grigio e il marrone, calzini bianchi
visibili da lontano a ogni suo passo, scarpe nere opache con la punta leggermente rialzata. Non disse
nulla durante il tragitto. Aprì la porta. Lo seguii.
"Salve, Teresa."
Ero talmente giù che non le toccai nemmeno il sedere come facevo sempre.
"Ciao Messner. Vieni, accomodati sul divano. Jo mi ha già detto tutto. Non devi abbatterti, una
soluzione si trova sempre" disse facendo l'occhiolino a Jo.
Finalmente Jo si decise a parlare.
"Senti, Lu, c'è una cosa che morivo dalla voglia di dirti quando mi hai chiamato al telefono, ma che
davvero non mi sentivo di..."
"Vai avanti, Jo."
Lo vidi illuminarsi.
"Non ho niente da dirti. È sufficiente che tu legga qui."
Mi consegnò una lettera.
"Come mai ce l'hai tu?"
"Non sapevano a chi consegnare la tua corrispondenza, così le poste di Vigolo hanno chiamato me,
eccetera eccetera. Avanti leggi!"
Lessi d'un fiato.
...per dirci come intende investire tale denaro.
Rimasi un minuto immobile. Finché le lacrime non uscirono dai miei occhi.
"Hai vinto, Lu! Ti rendi conto?"
"Ma... com'è possibile?"
"Te lo dico io com'è possibile! Zeno mi ha fatto notare che nelle scommesse multiple spesso pagano
non solo se si indovinano tutti gli eventi, ma anche se c'è un evento non azzeccato. Nel tuo caso ti
hanno pagato i quattro eventi che si sono realizzati."
"Quindi ho vinto anche se l'Italia non ha perso?"
"Esatto. Infatti era data 2 a 1, quindi invece di vincere seicentomila euro, ne hai vinti trecentomila,
che è comunque una fortuna."
"Incredibile. Questo è un miracolo."
"Cosa te ne farai di tutti questi soldi?" disse Teresa.
Tra le lettere che avevo ricevuto ce n'era anche una di Art, il rasta che viveva sulle spiagge del
Brasile.
Caro amico,
il mondo sensoriale non è altro che una percezione della realtà oggettiva (se mai esiste una realtà
oggettiva). Noi possiamo interpretarla e adattarla ai nostri desideri. Finché non ci rendiamo conto
che ciò che vediamo è semplicemente UN modo di vedere, una delle infinite maniere d’interpretare
la verità (e quindi allo stesso tempo verità e illusione), non ci possiamo nemmeno accorgere che
stiamo vivendo in una realtà illusoria. Noi, con la sola forza del pensiero, noi con la nostra infinita
energia mentale e psicologica possiamo modellare il mondo, lasciare che tra noi ed esso fluisca un
amore incondizionato per la vita individuale e universale, come un tutt’uno indivisibile.
L’unica cosa difficile è sapere cosa desiderare, scoprire cosa la nostra anima desidera nel profondo.
Dobbiamo capire dove l’amore, inteso come passione sconfinata, ci vuole portare, e lasciarci
trasportare. È necessario incanalare l’energia verso una direzione di riuscita personale.
Adesso tocca a te prendere il mio posto.
Addio,
stai sereno.
Accartocciai la lettera e la buttai nel cestino ridendo a gran voce. Jo e Teresa mi guardavano senza
capire.
Y
Capitava spesso che Giovanni si recasse in chiesa.
Pregava.
Pregava affinché Dio lo aiutasse.
Gli chiedeva di dargli un aiutino per scalare l'azienda e diventare parte della dirigenza.
Gli chiedeva di fargli incontrare di nuovo Salomè, la segretaria del quarto.
Chiedeva a Dio di vegliare sulla madre e di farla invecchiare in tranquillità, senza troppi grilli per la
testa.
Pregare lo aiutava a pensare. Trascorreva intere serate in ginocchio, di fronte all'altare, a rivedere,
come in un film, l'infanzia felice, o almeno tale la ricordava, che avevano passato lui e la madre a
Vigolo, il paesino di montagna nel quale era cresciuto. Si ricordava i prati verdi, i boschi che
coprivano le colline, la neve perenne sulle vette. I bambini più piccoli che giocavano a rincorrersi
sulle strade sconnesse e quasi deserte. La polvere che si alzava quando lui e i suoi amici correvano
per fare punto a nascondino. Bei tempi andati, pensava Giovanni.
C'era però qualcosa di misterioso nei suoi ricordi, qualcosa di poco chiaro. Riguardava casa sua. Gli
pareva di ricordare un uomo che veniva ogni tanto a trovare lui e la madre. Non era sicuro, gli
sembrava si facesse chiamare “papà”. Era un ricordo sfuocato, poco definito. Si era sempre
vergognato di chiedere alla madre se in quel che riaffiorava in lui, c'era un fondo di verità. Aveva
paura. Lei gli aveva sempre detto che suo padre era morto. Eppure nella sua testa udiva ancora le
grida di quell'uomo, quando lui e lei litigavano. Associava la sua presenza a brutte sensazioni.
Quando arrivava, la casa cominciava a odorare di marcio, di fumo e di vino andato a male. Ma forse
non ricordava bene. Poteva essere un incubo ricorrente, niente a che vedere con la realtà. Si
sforzava di ricordare, ma era passato troppo tempo. Forse l'uomo era un amante della madre che,
per gioco, si faceva chiamare “papà”. E comunque ora Giovanni era grande, il passato è passato.
Ripeteva sempre quest'ultima frase prima di alzarsi, farsi il segno della croce e uscire.
Era un rito.
Serviva a far ordine. Fuori e dentro.
X
Ricomprai la casa dove avevo felicemente passato la mia gioventù in compagnia dei miei genitori e
di mia sorella. Era un vecchio appartamento incastonato in un vecchio caseggiato del centro storico,
ma per me valeva tanto: forse in quel momento era la cosa che valeva più di tutto.
I trecentomila euro vinti non bastarono, dovetti aggiungerne altri venti, indebitandomi.
"In un ufficio non ci voglio tornare" dissi, "manco morto!"
Mi alzai dal divano.
"Se la mia vecchia laurea vale ancora qualcosa, sarà bene spremerla fino a prosciugarla."
"Perché non provi a fare un colloquio in azienda, da me. Magari invece di metterti in un ufficio ti
mandano in giro per il mondo..."
"No, in realtà ho già deciso: farò il lavoro che ho sempre odiato, un lavoro per niente adatto al mio
carattere timido e solitario."
"Timido e solitario?"
Non risposi.
"E da quando? Pensavo avessi superato le tue paure adolescenziali..."
"Non meriti risposta, Jo."
"Sentiamo, cos'hai in mente?"
"Una sfida che, se vincerò, mi aprirà le porte della società e mi libererò per sempre da stupide
paure, dai miei sguardi schivi, dai continui imbarazzi..."
Mi ascoltavo non riconoscendo le mie stesse parole.
"Lo so, Jo, non do l'idea di essere timido, me lo dicono tutti da una vita. Ma ti assicuro che lo sono.
La mia è una timidezza anomala, a due facce: a volte scompare magicamente, altre volte mi
schiaccia, sbattendomi in faccia un'infinità di porte."
"Il solito esagerato..."
"Sarà dura fare il pirla in calzamaglia."
"Il che?"
"Lascia stare, Jo."
"Dì la verità, vuoi fare l'insegnante per avere tempo libero per scrivere, giusto?"
"E l'estate libera per viaggiare" ammisi sorridendo.
La prima supplenza durò poco meno di un mese, dodici ore a settimana per circa
settecentocinquanta euro. Riuscii a saldare una piccola parte del debito e a mangiare quel tanto da
sopravvivere.
"Come va il lavoro?"
"Che ci fa qui?"
"Così... passavo e ho pensato di venire su a salutarti" disse facendomi l'occhiolino.
"Ah..."
"Sì, lo sapevi vero che io e Jo abbiamo un paio di chiavi?"
"Ah, già, me ne ero scordato."
Parlavo a stento perché totalmente catturato da quelle gambe praticamente nude e dal seno che le
usciva prepotente dal canottiera azzurra.
"Come va il lavoro mi hai chiesto?"
"Sì" disse lei sorridendo. "Posso sedermi qui vicino a te?"
"Certo" dissi mentre le facevo spazio sul divano riordinando i fogli sparsi e appoggiandoli per terra.
"Dunque... be', fare il pirla in calzamaglia alle medie è un inferno" dissi, "è come se qualche
terribile virus avesse infettato le nuove generazioni: quei nanetti non sono umani, ma alieni venuti
sulla terra per distruggerla."
Lei sorrideva, ma sapevo bene che non ascoltava una parola di quello che le stavo dicendo.
"Non esiste più il rispetto. La timidezza è scomparsa."
"Non in te, purtroppo o per fortuna" tirò fuori lei, assieme a un gran sorriso ammiccante.
"Esatto..." Poi cercando di non guardarla aggiunsi: "La lealtà, l'onestà, la sincerità non fanno parte
del loro vocabolario. Figuriamoci l'obbedienza. Non sono esseri umani, ma piccoli animali selvatici
impossibili da addomesticare."
"Sono adolescenti, caro" disse lei con occhi di cerbiatto.
"Ai miei tempi certi sentimenti ancora esistevano: possibile che in vent'anni sia tutto cambiato? Più
adolescenti mi trovo di fronte, più mi convinco di vivere in una società malata dove i valori veri
scompaiono a vista d'occhio. Sei d'accordo, Teresa?"
"D'accordissimo" disse lei facendomi l'occhiolino. Io rimasi lì senza più riuscire a guardarla, finché
lei si avvicinò e mi baciò su entrambe le guance dicendomi che purtroppo doveva tornare a casa per
preparare la cena a Jo. L'accompagnai alla porta respirando il suo odore e lei non si dimenticò di
farmi l'occhiolino per la terza volta.
Non chiedetemi perché ero lì, ma fu illuminante ascoltare la predica di un prete-psicologo di origine
indiana.
Chi sono io? Come funziono?
L'omosessualità? Riduzione della capacità di incontrare ciò che è differente da sé.
L'adulto ormai è disgregato, manca di un senso unitario.
Fa tutto senza testa e senza cuore.
Può esistere un'educazione all'affettività?
Infanzia (tutto su di sé) – Adolescenza (paura/stupore/spinta verso l'altro)
corpo importante, contiene tutta la saggezza dell'umano, dice: "non sei fatto per stare solo su te
stesso" (anche messaggio religioso e filosofico – v. Berkeley)
non possiamo noi adulti banalizzare l'innamoramento degli adolescenti
moglie e marito non si bastano a vicenda, serve altro!
È sempre più facile essere disgregati – crisi – anche nell'adulto
gli adolescenti non capiscono i messaggi che gli arrivano, aumenta la pornografia, ne fanno sempre
più uso sia adulti che bambini: auto-gratificazione, ma il corpo in realtà sarebbe fatto per la
relazione con l'altro.
omosessualità alle scuole superiore sta crescendo a dismisura, soprattutto tra le ragazze
ragazzi hanno paura del bello, perché noi adulti abbiamo troppa paura delle conseguenze (metterla
incinta)
Non perdetevi il bello! Cercate di comprendere il bello!
i ragazzi hanno paura a parlare di sé ai genitori, perché questi li stroncherebbero!
Obbiettivo: devono aprirsi, dire come stanno!
Devono andare in cerca di un significato: c'è bisogno di unità e di senso.
Toglierei le considerazioni sugli omosessuali e aggiungerei una domanda sulla quale riflettere: cosa
può creare una sommatoria con x che tende all'infinito di coppie disgregate di genitori a loro volta
disgregati, se non una marea di maligni mostriciattoli?
All’inizio balbettavo. Inciampavo nelle parole e nel palco rialzato che sosteneva la cattedra.
Tremavo davanti a quegli insolenti marmocchi.
Casino totale: schiamazzi, grida, ragazzini che abbaiano.
"Ragazzi! Silenzio!"
"Vaffanculo, prof!"
"Chi è stato!?"
Silenzio. Finalmente silenzio.
"Avanti, fuori il colpevole."
Risatine qua e là.
"Se il colpevole non si fa avanti, do una nota di classe sul registro."
La secchiona: "Dai, prof. Andiamo avanti con la lezione!"
"No. Decido io cosa si fa! Chi è stato a... Chi è stato a insultarmi?"
Risatine ovunque.
"Va bene, l'avete voluto voi. Nota a tutti."
La secchiona: "Non è giusto, prof. Se mi dà una nota per una cosa che non ho fatto, lo dico a mia
madre."
"Dillo pure a tua madre. Non mi interessa. Quel che è giusto è giusto. Vi meritate una nota di
classe."
Sollevazione popolare.
"Ma dai, prof, non può chiudere un occhio?"
"Ma, prof, perché dobbiamo pagare noi per colpa di uno?"
"Prof, non è giusto..."
Eccetera eccetera, fino a tornare al casino di prima. Ovviamente niente nota, la madre della
secchiona è la vicepreside. Sono loro a comandare. Poi arriva l'apoteosi: schiamazzi, grida,
ragazzini che abbaiano, fino al suono del campanello.
Scene come questa si ripetevano in continuazione.
Col tempo imparai. Imparai a farmi rispettare, almeno un po'.
A giugno ci arrivai stravolto: avevo insegnato in sette scuole, di cui due serali. Lo stipendio non
superava mai i mille euro, ma mi bastava per saldare i debiti.
Uscivo poco e quando uscivo non spendevo un soldo. Niente birra, niente vino, niente pizza, niente
sigarette: niente di niente. Uscivo, salutavo qualche amico, discutevo del più e del meno.
"Il tempo sembra essersi fermato per tutti tranne che per me."
"In che senso?" mi rispondeva l'amico di turno.
"Ho perso la famiglia, sono diventato ricco, mi sono licenziato, ho girato il mondo, sono caduto nel
tunnel delle droghe e del sesso, sono scappato in Brasile e ho trovato un rasta che mi ha cambiato la
vita, ho deciso di passare il resto dei miei giorni in Chiapas, sono stato truffato come un pirla, ho
ricomprato casa a quasi il doppio del prezzo a cui l'avevo venduta, ho ricominciato a lavorare: tutto
questo mentre voi avete affondato le radici in Trentino, in una piatta quotidianità."
"Be', adesso ci sei finito anche tu!"
"Lo so. E devo ripartire da zero."
"L'unico è quel tuo amico, il genio."
"Chi? Zeno?"
"Sì, Zeno. Lui sì che ha preso il volo!"
"Ma lui partiva avvantaggiato..." dicevo appoggiandomi un indice sulla fronte. "I geni non contano.
Fanno gara a sé."
"Hai ragione."
"Sai una cosa? Io sono un disilluso. Ho i piedi sottoterra" dicevo. "Tu mi vedi cambiato?"
L'amico di turno rispondeva sempre più o meno alla stessa maniera: "Ti vedo più lento. Non sorridi
più gratuitamente. Si vede che ti porti addosso un fardello..."
"Sarà il peso di tutti gli anni che ho buttato come si butta la spazzatura nei bidoni del secco non
riciclabile."
L'amico di turno rideva inesorabilmente e io continuavo col solito discorso. "Anni che non
torneranno, anni che sembrano aggrapparsi a quelli a venire, per farli affondare anch’essi nella
solitudine."
"E adesso sei pure un poeta."
Durante i mesi dedicati all’insegnamento, passavo i pomeriggi liberi in montagna a leggere o
davanti al computer a scrivere. Luglio e agosto andai in India del Nord, Bhutan e Nepal, lontano dai
bambini indiani che vivevano di stenti nei grandi centri urbani e soprattutto anni-luce dai ragazzini
casinisti delle scuole italiane. Rimasi sempre alle alte quote dove camminavo senza sosta tra una
fotografia e l’altra, passando le notti in tenda o ospitato da qualche famiglia. A cena mangiavo riso
basmati e verdure, durante il giorno assaporavo qualche frutto e bevevo litri di chai.
y
"Ce la fai?"
Io e Zeno ci incontravamo spesso per camminare in montagna. Entrambi eravamo cresciuti, nello
stesso minuscolo paesino circondato da vette innevate.
Vigolo ha mille anime e i contorni ben definiti: a nord c'è la Marzola (1738m s.l.m.), a sud la
Vigolana (2150m s.l.m.), a est il Lago di Caldocazzo, come diceva sempre Luigi, e a ovest Trento.
"Aspettami un secondo, per favore" ripetevo ogni venti passi.
Io arrancavo, Zeno nemmeno sudava.
"Ti va di fare una piccola pausa?" buttavo lì speranzoso quando il sudore cominciava a entrarmi
negli occhi.
Si beveva un po' d'acqua e ci si rilassava.
"Allora, che ne pensi?"
"Riguardo a cosa?"
"Al discorso di prima" dicevo con il respiro ancora affannato. "Non ho forse ragione? A che serve
votare se poi chi fa politica è sempre corrotto? A che serve lavorare come un asino se poi, con la
scusa della crisi, non ci danno né aumenti né livelli? A che serve vivere lavorando se poi ci tocca
comunque morire?"
"Non starai mica pensando al suicidio" diceva Zeno abbozzando un sorriso.
"Non scherzare, è una cosa seria."
Generalmente il discorso – ogni volta identico – a quel punto cadeva.
Zeno amava assaporare il silenzio e i rumori della natura, il vento, l'acqua, il cinguettio degli
uccelli. Se proprio doveva parlare, preferiva argomenti più nobili, quali l'arte, la letteratura, la
fotografia, il cinema.
"Dai, Zeno, rispondimi. A che serve passare la vita dentro un ufficio?"
"Mi sembra di sentire Luigi" mi stuzzicava lui ogni volta.
Sapeva che provavo per Luigi invidia e rabbia, quasi vivessi in eterna competizione con lui,
dovunque fosse finito. Pur amandolo come un fratello, non potevo non considerarlo un perdigiorno:
ne ero certo, prima o poi sarebbe venuto a piangere ai miei piedi, ammettendo che avrebbe dovuto
ascoltarmi, e seguire il mio esempio, ovvero che la vita è sacrificio e costanza, e che nulla ti viene
regalato.
Nonostante ciò, in una ipotetica sfida, consideravo lui il vincitore e io lo sconfitto. Senza capirne
però pienamente la ragione.
"Zeno, se dovessi scegliere di reincarnarti in me o in Luigi, chi sceglieresti?
A quel punto lui rideva, senza più smettere.
Ovviamente Zeno era fuori concorso: lui era superiore alle preoccupazioni dei comuni mortali. Se la
rideva sempre e non diceva mai quello che pensava. Preferiva ascoltare, o, forse per timidezza, non
era in grado di esprimere i propri pensieri, celandosi in un affascinante mistero di apparente
perfezione.
"Siamo in cima!" gridavo ogni volta tutto sudato. "Guarda laggiù, il lago! Guarda che piccola
Vigolo!"
Zeno osservava le montagne all'orizzonte girando lentamente su se stesso; io non smettevo di
osservarlo cercando ossessivamente di carpirne gli alti pensieri profondi.
Poi sbottava – pure lui ripetendosi – con stupide frasi, del tipo: "Hai mai notato che VOGLIO è
l'anagramma di VIGOLO?"
Allora ogni cosa perdeva di senso e non sapevo più cosa pensare.
Z29 agosto
“Sentite” disse Giovanni versandosi del succo d’arancia “ne sta uscendo un personaggio
impotente.”
“È esattamente quello che eri, se capisci ciò che intendo” disse Luigi dando un colpo di bastone al
pavimento e un colpo di tosse in aria.
Il suo stato di salute stava peggiorando di giorno in giorno. Sapevamo che non avrebbe retto
abbastanza per finire il romanzo. Lo sapeva anche lui. Giovanni mi raccontò che lo sentiva scrivere
anche di notte, e che a volte, al mattino, lo trovava addormentato sulla scrivania.
Vederlo disperato, mi faceva stare male. Per questo cominciai a prendere appunti durante i nostri
incontri. Avevo cominciato a scrivere qualcosa di autobiografico, ma mi ero bloccato dopo poche
righe: era più forte di me, non riuscivo ad aprirmi, neanche a me stesso. Mi ero allora divertito a
scrivere un ipotetico dialogo tra Luigi e Giovanni in un pub del centro. Poi avevo ripiegato su
qualcosa di ancor più divertente: mi ero messo nella testa di Salomè e mi ero immaginato la vita che
faceva a Madrid, dopo aver lasciato Giovanni. Ma prima di dare in pasto qualche scritto a quei due
pazzi, avrei rivisto con cura ogni singola parola.
Bastava poco a fare felice Luigi in quel periodo: non dovevamo fare altro che scrivere.
Giovanni era sempre stato una frana nella scrittura. Eppure il suo amore incondizionato per Luigi lo
portava a scrivere pagine che odoravano di verità: lo stile passava inosservato. Giovanni scriveva
con il cuore. In ogni sua parola c'era scritto ti amo.
Stavamo entrambi aiutando il nostro animale morente a realizzare il sogno di una vita: scrivere un
romanzo.
Furono settimane indimenticabili.
“Zen" disse Luigi rivolto a me, per una volta senza sorridere. "Che ne pensi?”
Presi tempo con un cenno della mano.
Il verde del giardino si rifletteva nei nostri occhi stanchi, mentre il sole splendeva alto, in un cielo
senza nuvole. Eravamo felici. Mi sembrava di essere tornato ai tempi dell’università. Ringrazio il
destino di averci riuniti dopo la lunga fatica del vivere.
Ritornai sulla terra: quei due stavano parlando di me. “...un’entità aliena persa nei meandri di una
mente infinita...” Io ascoltavo senza dire niente. E intanto li osservavo. Finché mi accorsi che non
parlavano più.
"A proposito" dissi con decisione per destarli dal torpore pomeridiano nel quale erano finiti.
"Che c'è, Zen?" disse Luigi. "Non si può neanche fare una sacrosanta siesta?"
"Ho pronto il mio prologo?"
I loro sguardi si destarono all'improvviso. Avevo i loro occhi puntati addosso. Iniziai a leggere.
15 agosto
Era Ferragosto. Io e i miei due migliori amici stavamo finalmente per riunirci, questa volta per
sempre: a Vigolo eravamo cresciuti, a Vigolo saremo spirati.
Quando arrivarono, il sole era alto in cielo. Non c’era anima viva in paese. La canicola scoraggiava
anche i più temerari. Nel mio giardino, vicino al torrente, l’aria era fresca: all’ombra delle betulle
dai tronchi bianchi e spelacchiati, la temperatura non superava i trenta gradi.
Vidi Giovanni camminare sull’erba e, dietro di lui, scorsi Luigi che arrancava a fatica col suo
vecchio bastone.
“E così dovrei scrivere un’autobiografia romanzata?” dissi dopo averli abbracciati a lungo e a
lungo ascoltati.
“Esatto, piccolo Zen” disse Luigi.
“Non so se ne sono in grado…”
“Tu che non sei in grado di fare qualcosa?" disse Giovanni. "Ma se sei sempre stato un genio,
Zeno!”
“Basta con questa storia del genio, vi prego.”
“Un motivo ci sarà!” disse Luigi alzando il bastone verso l’alto. "Dammi una goccia di rosso per
cominciare."
Gli riempii il bicchiere.
Rimanemmo in silenzio a lungo. Guardavamo in alto, lontano, in cima alle montagne. Luigi mi
faceva pena. Non potevo abbandonarlo.
“Va bene, avete vinto" dissi. "Scriviamo questo romanzo a sei mani!”
“Sarà un capolavoro!" gridò Luigi. "Tra qualche anno sentirai parlare di noi come il simpatico
trio di vecchietti che ha rivoluzionato la letteratura post-post-moderna!”
Per poco non cadde dalla sedia per l’impeto con cui urlava al cielo la sua gioia. Aveva una voce
rauca e malata.
Non gli restava che qualche mese.
“Secondo te, Lu" disse Giovanni, "perché le nostre vite dovrebbero essere così...”
“Lu tua sorella, coglione!" disse tra l'infuriato e il divertito. "È semplicissimo, Jo. Voglio vedere
chi ha vinto."
Ci fu un attimo di silenzio. Finché Luigi non riprese a parlare.
"Scrivendo di noi vedremo chi ha vissuto meglio.”
“Sì, ma…"
"Cosa c'è ancora, Jo?"
Mi divertiva ascoltarli.
"Cosa abbiamo noi tre di tanto speciale?” disse Giovanni. "Perché qualcuno dovrebbe leggere il
libro?"
“Scommetto che Zen ha già capito...” disse Luigi cercando la nostra attenzione. Si schiarì la voce,
sputò per terra e disse: “Zen rappresenta il ****** buddhista. Tu, piccolo Jo, rappresenti la
******** del ****. Io, ultimo ma non ultimo, l’************ dell’******* corporale!”
Cominciavo a ricordare perché avevo sempre pensato che Luigi fosse *****.
Giovanni non disse nulla, così Luigi proseguì.
“Zen farà Zen" disse dandomi un'occhiata rapida. "Tu farai te stesso, cioè l’******" continuò a
dire impedendo a Giovanni di controbattere. "Io sarò me stesso, ovvero il folle e coraggioso
*********** della ****."
Detto ciò ci mostrò i denti in un ghigno.
“Non mi è chiaro perché dovrei fare io la parte dell’idiota” disse Giovanni.
Mi scappò un sorriso.
“Perché sei stato un idiota per quasi una vita intera" disse Luigi con apparente soddisfazione. "Un
idiota nel concetto dostoevskijano del termine intendo, mi pare ovvio.”
“Non fare il difficile, tanto sai che non l’ho letto…” disse Giovanni. “E forse nemmeno tu...”
“Ascoltami, piccolo Jo, quando dico idiota non intendo dire stupido, dico semplicemente che le
scelte di vita che hai fatto, hanno sempre proteso verso la minimizzazione del rischio.”
"Cioè?" chiese Giovanni.
"Cioè una noia mortale."
“Vaffanculo!" disse Giovanni. "Ti credi sempre il migliore, eh?”
“Dai, Jo, sopportami ancora un po’. Sappiamo tutti che tra qualche giorno abbandonerò questa
triste vita” disse Luigi sorridendo a fatica, mentre con la mano destra dava una pacca sulla spalla
di Giovanni.
Non manifestai la mia gioia, ma devo ammettere che l’idea di Luigi mi piaceva. Se avevo capito
bene, voleva rappresentare la molteplice natura umana tramite tre personaggi, più o meno fittizi, che
**********************.
Era un'idea ambiziosa. Utopica direi. Ad ogni modo sentivo il bisogno di riempire le giornate con
un’attività creativa. Avevo sempre sognato di scrivere un libro. Ero stufo di leggere. L’ultima cosa
che mi andava di fare però, era parlare di me. Forse avrei anche iniziato a scrivere qualcosa, ma di
certo non l’avrei data in pasto a quei due pazzi.
"Allora?"
Rimasero a bocca spalancata.
"Che ne pensate?"
"Vuoi la verità, Zen?"
Annuii.
"Puoi fare meglio."
Rimanemmo in silenzio.
“Ragazzi?" disse Giovanni distogliendomi dai pensieri. "Ho deciso di ricominciare la mia parte da
capo, in prima persona.”
“Te l’avevo detto io..." riuscii a dire.
“Hai ragione, Zen, la prima persona rende meglio” disse Luigi sfiorando col bastone la testa di
Giovanni. "Uomo di poca fede!"
Ridemmo fino a farci mancare il fiato e vedere Luigi piegarsi verso terra. Dopo aver tossito sangue
e catarro, riprese a parlare come niente fosse.
“Scrivere in terza persona è pericoloso perché rischi di dare un giudizio sul personaggio...” disse
Luigi bevendo un mezzo bicchiere di vino e, come faceva sempre, passandolo rapidamente su
lingua e palato per assaporarlo. “C'è anche altro che non mi convince" disse prendendo dei fogli
sparsi su una sedia. "Cito, un attimo che metto gli occhiali, ecco: ...era un sabato mattina e fuori
splendeva un sole africano. I ragazzini in lontananza giocavano a pallone alzando polvere e
poesia. Gli uccelli fischiettavano sugli alberi e le farfalle galleggiavano nell’etere come mille bolle
colorate, ma ti pare?”
“Almeno io ho scritto qualcosa” disse Giovanni voltandosi verso di me. “Che cosa aspetti a metterti
in gioco, Zeno?”
"Ma se ho appena scritto il prologo!"
"Vogliamo qualcosa di tuo, non uno stupido prologo..."
Ero pronto a un simile attacco. Senza dire niente estrassi, controvoglia, dalla vecchia e polverosa
borsa di pelle che prima di me era stata di mio padre, un paio di fogli dattiloscritti. Erano il mio asso
nella manica.
“Devo ancora metterla a posto, è solo un’idea.”
“Avanti, vecchio topo di biblioteca!” disse Luigi battendo col bastone per terra.
“Dunque” dissi tossendo deciso. “A unirli erano stati gli anni dell’università. Anni intensi, anni
felici, anni passati sui libri, ma anche anni di feste e balli che si protraevano per intere nottate."
Senza alzare gli occhi dal foglio sentii Luigi che se la rideva di gusto.
“Si laurearono tutti e tre la stessa settimana. Zeno, manco a dirlo, col massimo dei voti. Luigi con
un mediocre votaccio che sottolineava la sua impazienza di laurearsi. Infine Giovanni, il quale si
laureò con lo stesso punteggio di Zeno, dimostrando che tutte le rinunce e i sacrifici che aveva fatto
durante quegli anni, erano serviti a qualcosa.
“Come la maggior parte delle amicizie anche la loro svanì lentamente, senza dare nell'occhio.
Ormai trentenni, s’incontravano per strada parlando del più e del meno, promettendosi ogni volta di
risentirsi al più presto, ma poi, si sa come vanno certe cose, passavano settimane, mesi, e infine
anni.
“Mai avrebbero immaginato di ritrovarsi tutti e tre, al tramonto della vita.”
Giovanni applaudì.
“Niente male, vecchio Zen" disse Luigi. "D'altra parte, se l'ha scritta un genio...”
Sorrisi compiaciuto e ripresi a osservare il movimento lento di una nuvola lontana, tutta sola nel
cielo oramai settembrino.
“Però perché non inizi a scrivere qualcosa di te" riprese Luigi. "Io ho già scritto più di quarantamila
caratteri spazi inclusi. Giovanni mi sta alle calcagna.
"Mi odi così tanto?” aggiunse con gli occhi di ghiaccio incastonati come diamanti in quel viso
vecchio e consumato.
Non mi andava di rispondere.
Luigi scoppiò a ridere.
Alzai il bicchiere e brindammo al futuro libro.
Bevemmo d'un fiato e facemmo per alzarci.
“Aspettate un secondo, non abbiamo finito” disse Giovanni. “Secondo voi faccio bene a
ricominciare da capo?”
“Jo, quanto ci vuole a riscrivere cambiando la persona da terza a prima?”
“Non è così semplice. Ho bisogno di tempo.”
“Ho un’idea” dissi.
“Ascoltiamo il genietto…” disse Luigi.
“Perché non cambi persona da qui in avanti” dissi guardando in su, com’ero solito fare quando
parlavo alla gente.
“Se lo dice Zeno io eseguo" disse Giovanni alzandosi soddisfatto. "Allora ci vediamo domani, solito
posto solita ora.”
Giovanni si avvicinò a Luigi.
"Ce la fai?”
“Tranquillo, damerino, non schiatto prima di finire il libro” disse sapendo di mentire.
y
Dopo due anni di dubbi e paure, e soprattutto dopo due anni che non la vedeva, Giovanni si decise a
conoscerla.
OPS...
Dopo due anni di dubbi e paure, e soprattutto dopo due anni che non la vedevo, mi decisi a
conoscerla.
Se ancora esisteva.
Se ancora lavorava al quarto.
La ricordavo come fosse passato un minuto: era bella come un angelo: di quei due minuti in cui Dio
mi concesse il privilegio di vederla mi rimaneva una celeste effige.
Non mi andava di precipitarmi furtivamente al quarto e chiederle il numero di cellulare. Mi
umiliava che lei mi vedesse salire dal garage del terzo.
In amore sono sempre stato timido.
Decisi di scriverle una lettera.
Cara Salomè,
è tanto – ben due anni oramai – che volevo comunicarti quello che ho provato, e provo tuttora,
quando ti ho vista la prima volta (e per ora anche l’ultima) al quarto piano. Ti ricordi ancora di me?
Non so che dire, mi vergogno un po’ a confidarti ciò che sento, ma da quando ti ho vista in azienda
la mia vita è cambiata, ha assunto una diversa colorazione. Vedo tutto rosa. Prima ero immerso nel
grigiore più totale.
Nei miei occhi c’è una nuova luce a risplendere verso l’infinito. Non m’importa più di tutto il resto,
del lavoro, degli amici, dei soldi, mi importa solo di conoscerti, di poterti mostrare come sono fatto.
Così che tu possa giudicare la mia persona, e piacendoti chissà.
Ma non mi sembra il caso di dilungarmi oltre. Questo è il mio numero di cellulare 328 610 861...
Chiamami, ci possiamo vedere all'Angi, dopo lavoro, per un caffè... va bene pago io.
Baci,
ing. Giovanni Pietro detto Longo
Non ero per nulla soddisfatto di ciò che avevo scritto, ma mi dissi che avrebbe apprezzato la
spontaneità. Avevo pensato di chiedere un aiuto a Luigi o a Zeno che sapevano scrivere come si
deve, ma Luigi non lo sentivo da mesi – e comunque di lui non mi fidavo –, Zeno certamente non
avrebbe avuto tempo per certe cose, preso com’era dalle sue equazioni di ennesimo grado. Avevo
pensato anche a mia madre, ma questa era una faccenda privata. Mi buttai come il cuore ci
suggerisce di fare nei momenti cruciali delle nostre brevi esistenze.
Ripiegai il foglio e lo introdussi nella piccola busta rosa che avevo comprato nel pomeriggio per
l’occasione. Spensi l’abat-jour e m’infilai nel letto senza chiudere occhio.
Il giorno seguente giunsi alla mia scrivania con qualche minuto di anticipo. Notare che era tutto in
ordine come ogni mattina, mi aiutò a rilassarmi. Sedetti sulla sedia in ferro e dal cassetto con
l'apertura difettosa estrassi una busta grande, v’infilai la letterina rosa con cura esagerata e la
richiusi con colla e saliva. Scrissi c/o Salomè (dolce chica spagnola) - Ufficio di Segreteria e
Rapporti con l’Estero - Piano IV. Mi alzai e la infilai tra le lettere in partenza e tornai alla scrivania
tirando un sospiro di sollievo. Era fatta: non potevo più tornare indietro. Suonò la sirena e in un
minuto arrivarono tutti i colleghi lasciandosi alle spalle lunghe scie di tabacco e sudore.
Z
30 agosto
"Ok, stavolta ho superato me stesso" dissi. "Si tratta di una prefazione da inserire a metà
romanzo..."
"Avanti, leggi" disse Luigi fingendosi scettico.
"Vado?"
"Vai."
"Sicuri?"
"Sicuri."
"Sicuri sicuri?"
"Vaffanculo, Zen. Leggi e taci!"
Iniziai a leggere la mia ultima follia creativa.
POST-PREFAZIONE
di
un narratore pre-postmoderno
Passeggiavo per le antiche vie acciottolate di Vigolo osservando la magnifica ambientazione che mi
circondava: vecchie costruzioni in pietra, tetti sconquassati con le tegole crepate dalle intemperie,
portoni bui che emanavano un'aria fredda e stantia: era come se ogni cosa che desiderassi, mi
comparisse magicamente innanzi. Tutto era pace, assenza, quando mi imbattei in tre anime vive.
C'era un vecchietto che avanzava a stento con un bastone in mano e, se non avesse avuto un perenne
sorriso stampato in volto, lo avrei creduto già morto, da quanto era vecchio. Quello che lo sosteneva
aveva un viso pulito, da bambino, con qualche ruga e un paio di punti neri sul naso; indossava un
abito elegante, aveva la schiena dritta, e mani e braccia indaffarate a sorreggere l'amico d'infanzia.
Il terzo anziano camminava in silenzio, più indietro di almeno un metro, le mani in tasca e la testa
proiettata al cielo, perso nei pensieri, quasi che le vicende terrene non lo interessassero
minimamente.
Quando furono a portata d'orecchio, li sentii discutere di letteratura: volevano scrivere un romanzo,
se avevo capito bene.
Le nostre strade si incrociarono a metà di una vecchia via del centro, talmente stretta da non far
filtrare i raggi diretti del sole. Passai oltre senza essere visto.
Mi girai e presi a seguirli da vicino. Camminavano lenti ma instancabili, come solo gli eroi sanno
fare.
Passarono ore.
Non che mi guardassi in giro, ero troppo concentrato su di loro per badare al resto, ma mi pareva di
aver camminato tutto il pomeriggio lungo quella stessa via.
Decisi di rendermi visibile.
"Salve, lasciate che mi presenti."
Quelli si voltarono.
"Sono un narratore" dissi accennando un inchino.
"Un narratore?" domandò Giovanni, quello elegante.
"Sì, un narratore" risposi.
Mi guardavano perplessi.
"Ho per caso ascoltato la vostra conversazione e..."
Quello col bastone, lo batté forte a terra sui sampietrini. "Ve l'avevo detto di parlare a bassa voce"
disse rivolto agli altri due. Poi, guardandomi, aggiunse: "Quanto vuole, signor Narratore?"
Devo ammettere che Luigi me lo immaginavo più scaltro.
"No, non ha compreso, signore col bastone" dissi. "Lasci che le spieghi in cosa consta il mio lavoro,
se di lavoro possiamo parlare."
Il trio mi guardava curioso. Anche il terzo, che fino a quel punto non aveva abbassato lo sguardo né
aperto bocca, aveva ora gli occhi puntati su di me. Ero certo sapesse già cosa avrei detto.
"Il narratore è colui che narra una storia" ripresi a dire. "E, da quanto ho capito, voi avete una storia
da raccontare, giusto?"
Annuirono.
Li credevo più svegli. Forse avevo sbagliato qualcosa.
Mi schiarii la voce e pronunciai le mie ultime parole: "Ebbene, eccomi qui. Sono pronto a
cominciare. Anzi, a dire il vero, e spero tanto che la cosa non vi molesti, io avrei già cominciato..."
...se non ve ne siete accorti, pensai.
Io mi fermo qui, per ora. Tocca a quei tre darsi da fare!
Non temere, lettore, è gente per bene.
Il narratore
"Vuoi sapere una cosa, Zen?"
"Posso fare di meglio."
"Esatto."
Estrassi un altro paio di fogli dicendo: "Ho già fatto di meglio!"
"No, ci risiamo... un altro mucchio di parole..." disse Luigi.
"Vado?"
"Vai pure, Zeno" disse Giovanni.
"Spero vi piaccia, perché non ho intenzione di scriverne altri. Stavolta mi sono messo nei panni di
un ipotetico curatore..."
"Scusa, fermo, ma è l'inizio del prologo o stai ancora cianciando a vanvera?" disse Luigi.
Attesi che finisse di tossire e iniziai a leggere.
z
PROLOGO del CURATORE
Questo romanzo appartiene al genere dei componimenti misti di realtà e finzione. Personalmente
ritengo che oggigiorno, in un tempo dominato dalla finzione mediatica, la vocazione delle
letteratura sia di superare i confini tra realtà e finzione. Invito quindi il lettore a considerare ogni
singola parola di questo libro, frutto della sua immaginazione, soprattutto quando la narrazione è
riferita a persone e luoghi realmente esistenti.
Qualunque altra interpretazione è da definirsi illusoria: la realtà non è di questo mondo.
Tutto ebbe inizio con la lettura di un vecchio articolo.
(da L'Adigetto del 1/4/19**)
SENSAZIONALE SCOPERTA IN TRENTINO
DIMOSTRATA L'ESISTENZA DI DIO
Lo studente: so che Dio c'è, ma non so ancora chi sia
Trento – Ieri sera l'atteso discorso durante la conferenza stampa presso la Sala
Polifunzionale di via Fersina. Il misterioso fautore della teoria in procinto di sconvolgere il
mondo intero, è uno studente delle medie inferiori di Vigolo.
L'incontro con i giornalisti è durato soltanto pochi minuti. Siamo stati accolti dal dirigente
scolastico, dal sindaco e dal presidente della Provincia Autonoma di Trento, i quali, dopo
le chiacchiere di rito, hanno fatto salire sul palco la mente più brillante di fine millennio.
Sullo sfondo nero un video muto mostrava un uomo intento a correre indefesso su un tapis
roulant. "Ecco a voi, signore e signori..." ha detto il dirigente con enfasi alle 20 e 51. "Zeno
Zeni, un nome orecchiabile, destinato a non farsi mai più dimenticare nei secoli a venire."
Il ragazzino, magro e ingobbito, è entrato con passo svelto per sedersi su una poltrona
rossa posta al centro del palco.
Ecco il breve discorso, tale e quale, del giovanissimo Zeno: "Buonasera. Come tutti i miei
compagni, anch'io sono solito dedicare quotidianamente un paio d'ore ai videogame. (Il
pubblico si rilassa e sorride, probabilmente pensando sia solo uno stupido scherzo.)
Personalmente posseggo ancora un Vic-20, ma alcuni miei amici hanno già il Commodore
64: l'industria informatica rappresenta indubbiamente il futuro degli anni a venire. (Giù tutti
a ridere nuovamente mentre lui continua impassibile.) Sarò breve, a forza di giocare mi è
venuta un'idea: e se fosse tutto un gioco?
"Prima di parlare con papà, ho deciso di eseguire delle ricerche. Ho sfogliato ogni libro
riguardante l'intelligenza artificiale. Purtroppo i testi della biblioteca comunale di Vigolo
sono pochi e datati. Ho chiesto a mia madre di portarmi all'Università degli Studi di Trento
senza darle particolari spiegazioni, temevo mi prendesse per pazzo. (A quel punto il
pubblico scoppia a ridere e i flash impazzano.) Nel reparto INFORMATICA della sede di
Povo-Mesiano ho consultato gli ultimi numeri di alcune riviste americane. Sfogliando il n.
118 di A.I., ho avuto la conferma definitiva dell'esistenza delle basi su cui poggiare la mia
teoria.
"A Seattle negli USA, più o meno nel periodo di Natale del 1977, nacque il primo
videogame... (A questa parola alcuni giornalisti cominciano a ridacchiare a voce
alta.) ...capace di auto-gestirsi. Cercherò di essere più chiaro. Al giorno d'oggi esiste
un'intelligenza artificiale talmente evoluta da poter affermare che i computer, o i robot se
preferite, hanno un cervello.
"Che ha questo a che fare con Dio? Ecco la mia teoria, sviluppata a partire dal libro di
Berkeley SAGGIO DI UNA NUOVA TEORIA DELLA VISIONE del 1709: (In sala alcuni si
alzano scoppiando a ridere rumorosamente. Il ragazzino li osserva serio e aspetta in
silenzio che escano.) se l'uomo è riuscito a creare un gioco virtuale in cui, date delle
regole, i protagonisti del gioco sono in grado di evolversi autonomamente, chi può negare
che anche noi, genere umano, non viviamo all'interno di un videogame creato da un Dio
lontano dai nostri sguardi? (In sala cala il silenzio. Una collega grida: "Sono solo
menzogne! Basta bestemmiare, ragazzino!")
"Sono solo un ragazzino. Frequento ancora la prima media. Non pretendo di aver scoperto
niente. Se anche solo un appartenente al genere umano sarà in grado di contraddirmi,
allora sarò lieto di ammettere che ho torto. Ma se, al contrario, nessuno riuscirà a negare
che quello che dico è vero, allora significherà che Dio esiste: e può staccare la spina da un
momento all'altro. (Tra il pubblico nessuno osa fiatare, a parte la collega di mezza età che
continua a ripetere "Sono solo bestemmie!" e viene condotta fuori.)
"Io e mio padre ci abbiamo pensato a lungo: se un Dio c'è, può ancora esistere un tempo
assoluto e misurabile? Einstein ha dimostrato la relatività del tempo in funzione della
velocità con cui si muove il sistema di riferimento dell'osservatore: ma un minuto per Dio
potrebbe essere un minuto per noi, oppure un secolo, o un nanosecondo: è lui a stabilirlo,
è lui a rallentare o accelerare il nostro tempo, allo stesso modo in cui noi possiamo
rallentare e accelerare a piacimento il tempo del nostro videogame. (A questo punto in
sala si comincia timidamente ad applaudire finché tutti si ritrovano in piedi a battere le
mani all'unico seduto, un ragazzino di undici anni dalle potenzialità infinite.) Non mi
spingerò oltre, ma sarebbe logico a questo punto interrogarsi sul senso della nostra
esistenza. Personalmente ho poca esperienza a tal proposito, preferisco lasciare a voi
grandi l'ingrato compito."
Questo è stato, tale e quale, il discorso del giovane Zeno Zeni dalle 20,52 alle 20,58 di ieri sera: un
piccolo genio che, se sarà validato il senso di ciò che ha proferito, potrebbe rivoluzionare il modo di
pensare dell'intera umanità. Sullo sfondo nero il video muto mostrava ancora lo stesso uomo intento
a correre indefesso su un tapis roulant.
Nemo
Ho letto questo articolo qualche anno fa, dopo che mio padre mi aveva parlato di Zeno. (A
proposito, è ancora troppo presto per cercare di spiegarvi chi sono.) Soltanto alla terza lettura mi è
caduto l'occhio sulla data e ho capito che si trattava di un pesce d'aprile. L'ho stampato e mostrato a
mio padre.
"Se lo lessi? Certo che lo lessi! Lo leggemmo tutti" disse mio padre guardandomi mentre masticava
un pezzo di mollica. "E tutti pensammo a uno scherzo."
"E?"
"Era tutto vero."
"In che senso vero?"
"L'ingegner Zeni, o chi per lui, quando aveva undici anni pronunciò esattamente quelle parole e la
gente lo ascoltò con ammirazione, proprio come riporta l'articolo."
Era una storia troppo strana per lasciarla marcire in qualche remoto angolo di memoria. Mi sono
detto: se a undici anni pensava quelle cose, chissà cos'ha avrà concepito in seguito!
Per questo motivo ho deciso di scrivere un libro su Zeno e sui suoi due migliori amici, Luigi e
Giovanni. In realtà – è bene precisarlo – il libro non l'ho scritto veramente io. Mi sono limitato a
trascrivere quanto quei tre mi dettavano. Ho deciso di suddividere il romanzo in capitoli alternando
i loro punti di vista, dando così il giusto spazio a ognuno. Mi hanno fatto collaborare al loro
progetto proprio per il delicato compito di montaggio super partes. Ma questo adesso non ha
importanza. È tempo che vi presenti gli altri due protagonisti, Luigi e Giovanni.
GIOVANNI
Sono andato nella vecchia scuola elementare di Vigolo e ho trovato nell'archivio il quaderno dei
temi di Giovanni, e questo è decisamente il mio preferito:
Cera tanto tempo fà un bambino cattivo e stupido che voleva vedere comè fatto il mondo. Il suo
nome era Luigino. Era biondo e riccio. era alto così e aveva due occhi di colore azzurro chiaro come
il celo di domenica mattina quando mamma mi porta a fare la colazione nella pasticceria del Signor
Pastina.
Luigino è un bambino cattivo perché mi ruba sempre la merenda. La Michela lo ama solo perché
Luigino altrimenti li e le dà. Luigino è un bambino stupido perché la maestra lo sgrida sempre:
"Luigino, ti comporti propio come uno stupido!" Li e lo dice ogni giorno.
La Michela, anche se non me lo dice, io lo so che lei mi ama. Gli e la detto alla sua mamma che gli
e la detto alla mia che me là detto a me.
Quando Luigino va a vedere comè fatto il mondo io e la Michela ci sposiamo così lui non torna più
e non mi ruba piu la merenda.
LUIGI
Su Luigi invece ho trovato un articolo su un quotidiano nazionale nell'archivio della biblioteca.
(dal Corriere del 11/11/****)
SENSAZIONALE SCIAGURA IN TRENTINO
VIAGGIO DISTRUZIONE
Il professore: se Dio c'era, probabilmente dormiva
Trento – Ieri sera l'atteso arrivo delle salme in piazza Dante. L'intera città è ancora scossa
per la sciagura che ha colpito una scolaresca di povere anime innocenti. Si ipotizza essere
il ghiaccio la vera causa dell'incidente che ha causato la morte di settanta ragazzini di età
compresa tra i dieci e i quattordici anni, e degli adulti che li accompagnavano, autista
compreso.
Luigi Alberti, il professore miracolosamente sopravvissuto al disastro in quanto impossibilitato a
partire a causa di una presunta varicella, non si è fatto finora vedere in pubblico. Ha rilasciato
interviste telefoniche a testate giornalistiche, radio e televisioni. A noi ha fatto sapere, in anteprima
nazionale, che era stato proprio lui a organizzare quello sfortunato viaggio d'istruzione sullo Stelvio.
Durante l'intervista è crollato in un lungo pianto disperato.
Voci maligne, per lo più genitori in cerca di un capro espiatorio che possa alleviare le loro
sofferenze, dicono che in realtà non abbia la varicella, per questo non si sarebbe ancora fatto vedere
in pubblico, dicono sempre le malelingue.
Poco importa se tale grave insinuazione sarà validata o meno: l'ing. Alberti non ha nessuna colpa
diretta per l'incidente: condannare lui non servirà a far tornare in vita le ottanta salme giunte in
Piazza Dante, sotto gli occhi tristi del sommo poeta.
In realtà – me lo ha confessato lui stesso – non fu Zeno a salire sul palco quella sera, ma Luigi,
armato di trucco e parrucco, dopo aver imparato a memoria il discorso.
Non trovando altri articoli riferiti a quel curioso episodio, ho chiesto a mio padre come andò a
finire.
"Pochi giorni dopo qualche filosofo americano disse che erano soltanto un sacco di stronzate..."
Non per me, pensai in silenzio mentre mio padre sghignazzava come una vecchia cornacchia.
Ci tengo a precisare che poiché questa è una storia vera, nessuna ricerca è stata necessaria per
scrivere questo libro. Al di là di quanto possano apparire incredibili gli eventi narrati, tutto ciò che
state per leggere è realmente accaduto: ogni parola corrisponde a verità.
Il curatore
"Non ditemi nulla, lo so, sono pazzo, ma ve l'ho detto, non ne scriverò altri di prologhi, quindi
tenetevi questo!"
"Che incazzato, Zen" disse Luigi col solito sorriso che gli faceva la faccia come un sole
incartapecorito. "Comunque non era male."
"Sì, è vero, Lu, stavolta non era niente male" disse Giovanni serio. "Grande Zeno!"
"Il genio si è finalmente dimostrato tale" disse Luigi alzando il bicchiere di rosso. "Nonostante
rimanga sempre uno sfigato di prima categoria!"
y
In mattinata Salomè avrebbe letto la lettera. Ero teso. Non riuscivo a essere efficiente come al solito
e questo m’indispettiva. Ma il lavoro era passato in secondo piano, ero tutto preso da Salomè e dalla
vecchia immagine sfocata che ne conservavo. Avevo il cellulare a destra della macchina da scrivere,
e continuavo a controllare che non si fosse spento, o che per caso non fosse giunto qualche
messaggio senza che me ne accorgessi, anche se lo ritenevo impossibile.
A pranzo notai che si aggiunsero a quelli del garage alcuni ex, trasvolati al quarto dopo la
rivoluzione dei livelli. Tra di loro c’era anche Alex, che si sedette proprio di fronte a me, rovinando
l’emozione che stavo provando nell’intimo del mio cuore. Cominciai a mangiare fingendo di non
averlo notato.
“Ciao, amico Longo” disse sogghignando. “Non saluti me? Non più di amici?” disse ancora
scoppiando a ridere rumorosamente.
Odiavo il suo fetore, la sua voce cavernicola e, soprattutto, le sue parole sgrammaticate.
“Ciao.”
“Ah, ecco, allora ancora in stati di amici siamo.”
Non risposi sperando che la sceneggiata finisse.
Alex cominciò a battere il coltello sul suo bicchiere di vino rosso maleodorante.
“Attenzioni. Un po’ silenzi. Ragazzi, ascolti uno di attimi.”
“Che hai de dire, Alex, ancora?" disse uno. "Non ti basta essere superato de livello?”
“Sì, mangiare in pace almeno lasciaci!” disse un altro.
“Ragazzi, devi dire di cose importanti. Uno di minuti.”
Estrasse da una tasca un foglietto appallottolato. Lo prese tra le due mani e cominciò a stirarlo per
renderlo leggibile. Tossì e non dovette attendere molto. I conviviali pendevano dalle sue labbra.
“Cara Scialomè…”
Sentii un crampo allo stomaco.
“…è tanti che volevo comuni carte quello che ha provato, e provo tutto ora, quando te ho vista la
prima…”
“Ridammela, stronzo!” gridai. “Pezzo di merda!”
Mi alzai e mi lanciai sopra il tavolo verso di lui per togliergli la lettera dalle mani.
Evidentemente se l’aspettava perché si scansò agilmente lasciandomi steso sulla tavola tra vino
rosso e pasta al ragù.
“Non so che dire, mi vergogna un poco a confidare ti cioè che sento, ma…”
“Alex, dalla a me, la leggo io!” disse uno del quarto strappandogliela di mano. “Ma come cazzo hai
fatto ad arrivare al quarto senza nemmeno saper leggere? Sei un mafioso di merda, Alex! Lasciamo
perdere, dove eravamo arrivati? Dunque... ma da quando ti ho vista in azienda la mia vita è
cambiata, ha assunto una diversa colorazione. Vedo tutto rosa ora. Prima ero immerso nel grigiore
più totale.”
Tutti risero a crepapelle mentre io cercavo di alzarmi invano, due di loro mi si erano seduti sopra.
Una chiazza di ragù mi ostruiva parzialmente la vista.
“Nei miei occhi c’è una nuova luce a risplendere verso l’infinito. Non m’importa più di tutto il
resto, del lavoro, degli amici, dei soldi, mi importa solo di conoscerti, di poterti mostrare come sono
fatto. Così che tu possa giudicare la mia persona, e piacendoti chissà. Ma non mi sembra il caso di
dilungarmi oltre. Questo è il mio numero di cellulare 328 610 861...”
“Sì, Longo” disse uno del terzo “sei uno zero! Sei uno zero!”
Ero immerso nella baldoria quando mi accorsi che dai miei occhi sgorgavano torrenti di lacrime e
ragù.
“Chiamami, ci possiamo vedere dopo lavoro per un caffè, va bene pago io. Baci, ingegner Giovanni
Pietro detto Longo!” gridò il tipo del quarto a pochi centimetri dal mio viso. Il suo alito mi invase e
le goccioline della sua saliva si andarono a mischiare alle mie lacrime. “Detto Longo! Ma se manco
ti tira quell’affarino!”
Non sapevo che dire. Nemmeno che fare. Ero immobilizzato da almeno cinque uomini, tutti più
anziani di me, che mi riempivano le orecchie di sfottò irripetibili.
"Ho trovati lettere in cesti per carte sotto scrivanie di segretarie” disse in piedi sul tavolo
schiacciandomi il viso con la punta metallica dello scarpone. “Lasci di stare donne di piani quarti.
Noi scopiamo loro, loro donne di noi dei quarti, capiti, pezzi di merde?”
Prima di tornarsene al quarto Alex camminò più volte sul mio cranio: lo sentivo scricchiolare a ogni
passo. Speravo si rompesse. Volevo morire.
Chiusi gli occhi e lasciai fuori tutto il resto. La sirena suonò. Gli altri corsero alle loro postazioni.
Rimasi disteso, prono, solo e triste sulla tavola tappezzata di macchie di vino, carne e pomodoro.
Quando raccolsi le forze per alzarmi, mi diressi in bagno, passando dalle cucine. Ero uno straccio.
Mi sanguinava il naso. Una guancia riportava fedelmente la suola della scarpa di Alex e l’altra il
profilo di una forchetta. Il resto erano lacrime, ragù e chiazze di vino rosso. Uscii dal retro, certo di
non tornare.
Z
"Buongiorno, Gianni."
"Giovanni, dottore, Giovanni."
"Si accomodi.
"Mi racconti com'è andata la settimana."
"Dunque... a dire il vero non è successo niente di nuovo. Cioè..."
"Vada avanti."
"Be', in realtà al lavoro procede tutto bene, a casa, con mia madre, va alla grande..."
"Prosegua, Gianni, per favore. Si apra."
"Non so da dove iniziare..."
"È riuscito a rivedere quella ragazza... Salem?"
"Salomè."
"Sì, Salomè, l'ha incontrata?"
"Mi scusi se piango, dottore.
"Sta andando tutto a rotoli. La mia vita è uno schifo."
"Cominci a raccontarmi da quando ci siamo lasciati l'ultima volta. Tenga."
"Grazie.
"Va bene. Mi scusi ancora. Quando sono uscito di qui la settimana scorsa ero pieno di energia. Ho
subito pensato a un mio amico e..."
"Chi? Ze... com'era?"
"No, non Zeno. Si chiama Luigi."
"Lo conosce da molto?"
"Da sempre. Anche lui è originario di Vigolo... Mi scusi se non gliene avevo mai parlato... Non mi
piace parlare di lui. Quando lo faccio finisco sempre col parlare SOLO di lui."
"Ha mai provato a capire il perché?"
"Il perché di cosa?"
"…"
"..."
"Non trova strano che dopo quasi un anno di terapia, lei non mi abbia mai parlato di un suo amico
di vecchia data?"
"Gliel'ho detto. Non mi va di parlare di lui."
"Va bene, prosegua."
"Io e Luigi, prima che scappasse senza avvertire né me né Zeno, siamo andati a bere..."
"Prima che scappasse? Interessante... e dov'è andato?"
"Dottore, stiamo parlando di me, non di lui. E poi scusi, ma se è scappato senza dire nulla come
facevo a sapere dov'era andato?"
"Ma vi avrà chiamati poi, no?"
"Dottore, basta! Parliamo di me."
"Va bene. Mi dica."
"Dunque, le dicevo che due anni fa io e lui siamo andati a bere una birra in un postaccio in centro
ed è stato lui a mettermi in questa situazione."
"Si spieghi."
"Mi ha minacciato."
"Forza, Gianni, è qui da dieci minuti e non mi ha ancora raccontato niente. Ha forse paura? Non la
mangio mica, sa?"
"Mi scusi. Ha ragione. Dunque, Luigi a quel tempo mi disse o ci provi tu o lo faccio io! Mi sentii
schiacciato dalla paura di fallire. Non sarebbe stata la prima volta che parlavo a Luigi di una
ragazza e lui me la soffiava per poi abbandonarla dicendomi comunque quella a letto non vale un
piffero."
"Perché si ostina a considerarlo un amico?"
"Be', perché in fondo ci vogliamo bene."
"A me non sembra."
"Ad ogni modo, dottore, credo che dopo quello che sto per dirle converrà con me che Luigi mi porta
sfortuna."
"Non so cosa mi sta per dire, ma io credo che il suo amico... Gigi..."
"Luigi."
"Sì, Luigi, volesse solo stimolarla ad agire. Non trova?"
"Non lo conosce. Sapeva che mi sarei ficcato in un pasticcio. Non esiste l'impossibile, ripete
sempre. A lui piace spingermi a fare cose di cui non sono capace, per poi ridere alle mie spalle.
Comunque, lasciai perdere. Mi dimenticai di lei. Soltanto qualche giorno fa mi dissi che in fondo
valeva ancora la pena di provare a incontrarla – se ancora lavorava in azienda. Così le scrissi una
lettera e la mattina seguente la spedii con la posta interna. A pranzo però... Si ricorda di Alex?"
"Un suo lontano cugino, se non sbaglio."
"Si sbaglia, dottore. Alex è il collega gigante, quello che non sa parlare italiano, si ricorda? Quello
che è salito di livello al posto mio..."
"Ah, sì, mi pare di ricordare."
"Be', è sceso a pranzo da noi e ha cominciato a leggere a voce alta la mia lettera per Salomè. Tutti
hanno cominciato a ridere a crepapelle, a gridare, a spintonarmi di qua e di là, a insudiciarmi il
volto di ragù e vino, a prendermi per i capelli, a gridarmi insulti che non starò qui a ripetere.
"Dottore, mi sono sentito violentato. Violentato nel cuore. Riesce a capirmi?
"Che c'è, dottore?"
"Niente. Stavo solo..."
"Cos'è quella faccia, dottore?"
"Quale faccia, Gianni?"
"Quel ghigno! Cos'è quel ghigno, dottore?
"Lei sta...
"Lei sta ridendo di me!"
"No, io..."
"Lo sapevo, anche lei è come tutti gli altri!"
"Aspetti! Gianni..."
A quel punto Giovanni era già sulle scale, disperato: e poi via, verso casa, per continuare a piangere
sul grembo caldo della madre.
y
"Mamma, se è per me, di' che non ci sono."
Sentii aprirsi la porta. Evidentemente era un'amica di mia madre. E se ne sarebbe stata in soggiorno
a parlare di gossip, palestra e unghie per il resto del pomeriggio.
Invece all'improvviso la porta della mia stanza si aprì ed entrò lei.
"Ma..."
"Ciao, Giovanni. Al lavoro mi hanno detto che eri malato e così ho pensato..."
Smise di parlare e mi guardò immobile. Gli occhi all'improvviso le si fecero luminosi come giada.
"Adesso ho capito chi sei! Eri venuto su al quarto qualche mese fa, giusto?"
"Un paio d'anni" dissi, "oramai."
"Non ti ricordavo così bello..."
Io non risposi, e probabilmente arrossii.
"Be', dicevo, ho pensato di venire a trovarti. Si no te molesta" disse avvicinandosi. "E adesso che ho
capito chi sei, fa piacere anche a me."
"Certo" dissi deglutendo sonoramente. "Mi fa piacere."
Lei stava in piedi guardandomi senza dire niente. Aveva un'arcata dentale perfetta, che risplendeva
bianca sulla sua pelle scura.
"Scusa" dissi chiudendo il computer e appoggiandolo sul pavimento. "Siediti pure. Scusa se sono
sotto le coperte, ma non sto ancora molto bene."
"A me sembri in gran forma" disse sedendosi e facendomi l'occhiolino. "Avevi la febbre?"
"Sì, un po' d'influenza..."
"Ho saputo, sai?"
"In che senso?"
"So della lettera che mi hai spedito."
"Ah. E chi te l'ha detto?"
"I miei colleghi del quarto. La lettera non l'ho potuta ancora leggere, ma mi hanno detto che l'hai
declamata giù nella mensa del garage, salendo addirittura sul tavolo."
"Sì... più o meno..."
"Perché non sei venuto di persona?"
"Be' sai, per noi del terzo non è così facile salire fin lassù..."
"Dai, non scherzare" disse lei mostrando una perfetta arcata dentale. "Come sei buffo!"
Sorrisi anch'io.
"Ho conosciuto tua madre. È una donna bellissima!" disse con gli occhi enormi puntati sui miei.
"Anche tu comunque non scherzi."
Mi fece di nuovo l'occhiolino.
"Ti vedo un po' giù."
"Sarà la spossatezza."
"Vuoi che ci vediamo un'altra volta?"
"No, rimani ancora se vuoi."
Lei si guardò in giro. Si alzò e puntò dritta alla libreria.
"No, hai letto Il lupo della steppa!"
"Veramente, è di un mio amico..."
"Cosa conta? L'importante è che tu l'abbia letto. È uno dei miei libri preferiti." Poi mi guardò. "Ti è
piaciuto?"
Non sapevo cosa dire. Annuii.
"Lo sapevo" disse, "lo sapevo che io e te eravamo anime gemelle!"
x
Il secondo anno dedicato all'insegnamento fu simile al primo, inutile sprecar tempo a descriverlo.
Cominciai il terzo anno d'insegnamento con un impiego part-time in un istituto professionale, a
circa settanta chilometri da Trento. Non avevo un’auto. A parte questo, il destino non si sentiva
appagato.
A novembre andò su internet un video che mi riprendeva durante una lezione. Penserete che ho
poco a cuore l’educazione dei ragazzi. In classe era la prassi: i ragazzini qualche minuto prima della
ricreazione si preparavano gli spinelli. All’inizio avevo cercato di impedirlo, reputandolo
inammissibile. Mi sbagliavo: gli altri pirla con le loro calzamaglie attillate glielo permettevano.
Prima di giudicarmi quindi dovete immaginare una classe stile Far West, dove i ragazzi erano liberi
di fare qualunque scemenza, e il sottoscritto aveva ben poche armi con cui amministrarla.
Il video che i ragazzi avevano caricato su Facebook (un social network che andava di moda a quei
tempi), mi ritraeva dapprima intento a leggere il giornale, infine a preparami una sigaretta di
tabacco, che a molti moralisti dovette sembrare uno spinello. Non c’erano regole, sfogliare un
quotidiano mentre ai ragazzi era stato assegnato un compito, non aveva niente di sconvolgente.
Rollarmi una cicca nell’attesa della ricreazione era una cosa che facevano anche gli altri professori.
Era l’unico mio misero vizio. Vizio che mi ha cambiato la vita.
La notizia si sparse sulla stampa locale, se ne occuparono addirittura le televisioni di regime. I
ragazzi si facevano le canne in classe e io non potevo rollarmi una cicca di tabacco. Successe tutto
in fretta, tanto che mi ritrovai senza lavoro ancor prima di poter rendermene conto.
Lavoravo ormai nel mondo della scuola da più di due anni. Avevo insegnato diverse materie, dalla
fisica all’educazione tecnica, a circa quattrocento alunni dai dodici ai quarantacinque anni (il
quarantacinquenne era un ex-carcerato dei corsi serali). Cominciavo a trovare ritmi e approcci per
affrontare anche le classi più impervie. Iniziavo a sentirmi a mio agio in cattedra, non mi alzavo più
dal letto col terrore di dover parlare davanti a un pubblico che poteva superare le trenta unità. Ma
una vita, la mia, che sembrava approdare finalmente a un porto sereno, ecco che invece si era
incredibilmente incagliata in mare aperto. Forse il mio destino era un altro, come dicono tutti
quando falliscono in qualcosa in cui erano convinti di far bene.
Mi fu offerta una cattedra annuale in una piccola scuola media di montagna. Sei ore di tecnologia
più dodici di sostegno. Appena arrivato mi sommersero di lavoro extra: dai verbali ai corsi
d'aggiornamento sulla sicurezza, dalla programmazione all'organizzazione di gite e recite
scolastiche. Tra le tante iniziative organizzai anche un viaggio d'istruzione che pochi giorni dopo fu
intitolato dalle testate giornalistiche viaggio distruzione. Sì, senza l'apostrofo. Coinvolsi l'intero
istituto, dai settanta alunni ai nove insegnanti, tra i quali anche il dirigente scolastico. Impiegai
secoli a trovare un pullman a doppia altezza disposto a caricare ottanta persone – delle quali settanta
erano diavoletti – per portarli in cima allo Stelvio.
Era un freddo mattino di novembre. Si presentarono all'appello tutti, nessuna assenza. Tranne la
mia. Varicella.
"Ci siamo tutti? Posso partire?" immagino abbia detto l'autista quel mattino.
"Partiamo" avrà risposto il dirigente scolastico.
I ragazzini, dopo aver gridato per un paio d'ore, si saranno di certo interconnessi con la realtà
virtuale a loro disposizione: mp3, videogames, i-pod nani...
Pranzo in cima allo Stelvio e poi discesa.
Me lo vedo l'autista, lì a frenare come un drago, carico come un mulo... no, non ce la faccio a
raccontarlo, nemmeno a immaginarlo: è tutto troppo triste.
Lo lessi anch'io sul giornale la mattina seguente.
Stelvio: pullman scolastico precipita. Muoiono tutti.
Restai senza parole.
Oltre che senza scuola. E quindi senza lavoro.
Altri quotidiani titolavano:
Viaggio distruzione sullo Stelvio: muore un'intera scuola.
Settantanove morti. La varicella salva un professore.
Trentino-Alto Adige, Stelvio: muoiono settanta ragazzini, otto professori e l'autista.
Molte testate arrivarono addirittura a considerarmi un miracolato. Un miracolato che ha perso
madre, padre e sorella in un incidente automobilistico, e ora otto colleghi e settanta poveri mocciosi,
ai quali, volente o nolente, mi ero pure affezionato. Era una tragedia talmente grave da farmi
sorridere: dimostrava in maniera lampante l'assenza di dio. (Anche se Jo non sarebbe d'accordo.)
Continuai a ridere finché mi ritrovai in bagno a piangere e gridare disperato.
Destino.
Passarono mesi bui. Impalpabili.
Mesi passati a letto con l'insonnia che mi torceva l'anima.
Alla fine mi decisi a riprendere a vivere.
Cominciavo a sentirmi inadatto alla vita terrena. Continuavo a ripetermi che forse era parte di un
disegno a me ignoto.
Cercarsi un altro lavoro, con tutta probabilità un lavoro di merda, alla mia età non era cosa
semplice. Ero un tipo elastico, disponibile, umile, ma non avevo più voglia di sbattermi, di
ricominciare, di fare un’altra volta la gavetta. Avevo altra scelta?
Forse sì, ma avevo ancora voglia di vivere.
Ecco perché, alla fine, mi feci forza e decisi di passare da Giovanni, il buon vecchio Jo. Ci eravamo
persi di vista. In quei tre anni si era sicuramente fatto strada in azienda, come diceva lui, o magari in
un’altra ditta.
x
Lui e Teresa erano scappati dalla vita di paese per entrare nella mondanità cittadina, ma qualcosa in
loro mal celava l'origine provinciale. Con l'età cominciavo a capire che Vigolo, dov'eravamo nati e
cresciuti io, Jo e il vecchio Zen, non era poi tanto male.
Mentre stavo premendo il campanello ne vidi un altro, uno nuovo, un paio di centimetri più su: Ing.
Giovanni Longo - Salomè de la Cruz. Mi tornò alla mente un discorso di molto tempo prima,
quando ancora eravamo freschi di laurea, in cui mi diceva che era perso di una ragazza spagnola che
lavorava con lui. Chissà che non si fosse anche sposato, il bastardo.
“Chi è?”
“Sono io” dissi disinvolto. “Dai, Jo, apri questa fottutissima porta!”
Aprì e salii.
“Chi è?” sentii gridare nel giroscale. “Nooo, ma sei tu, Messner? Fatti abbracciare!” Non ricordo i
dettagli di quel breve dialogo, so solo che sciorinò un’infinità di domande sul mio conto.
“Signora Teresa, mammina, ti fai sempre più bella a quanto vedo” dissi. Devo ammettere che
nonostante avesse superato i cinquanta, quella donna mi faceva ancora girare la testa. Mentre
l’abbracciavo ne approfittai per sentire se aveva ancora il sedere di una volta.
Mi guardò e sorrise. Se solo fosse stata più sana di mente, o, ancora meglio, un minimo più
silenziosa, chissà cosa sarebbe successo tra di noi. Le feci un occhiolino mentre Giovanni mi
trascinava di sopra, nel suo appartamento. Avevo ancora le mani e gli occhi sul culo di sua madre
quando mi accorsi che Jo mi stava parlando.
“…mai più, ok?”
Jo mi guardava con fare serio e minaccioso. Non avevo sentito le sue parole, ma sapevo che si stava
riferendo a sua madre. Annuii e lo abbracciai.
Salimmo.
Mi invase un insopportabile odore chimico di detersivi. Era ancora un maniaco dell'igiene.
“E insomma ti sei fatto uomo, vecchio mio!” dissi guardandomi intorno. “Che cazzo di
appartamento ti sei fatto?”
Splendeva tutto. Sembrava la tipica casa delle pubblicità.
Mi venne in mente il nome inciso sul campanello. Al muro erano appese tre grandi fotografie in
bianco e nero. In una si vedeva uno scorcio di Parigi. In un'altra il viso butterato di una vecchia.
Nella terza un bambino sui tre anni, vestito di stracci, probabilmente scattata in India. Tutte
portavano nell'angolo in basso a destra la firma Salomè. Mi avvicinai alla libreria di acacia e presi
in mano una piccola fotografia con riquadro, riposta su uno scaffale. Non dico che Giovanni fosse
brutto – con una madre del genere era impossibile – ma come fosse riuscito a conquistare una figa
del genere, per me rimaneva un mistero.
“E insomma ti sei sposato, eh, vecchio mio?”
Jo si girò di scatto. Non riuscivo a cogliere nei suoi occhi nessuna espressione prevalente. Forse era
assorto in troppi pensieri. Pareva ebete.
“Pronto? C’è qualcuno in casa?” dissi fingendo di bussargli in testa.
“No, non sono sposato."
Fece una pausa. "Fosse per me l’avrei sposata la prima volta che ci sono uscito.”
“Non avevo dubbi” dissi.
“Voglio sempre tutto e subito. E quando non lo ottengo l'ansia comincia a rodermi dentro.
Cambierò mai, Lu?” disse rattristandosi. “Non so se ne è valsa la pena?"
"In che senso?"
"Studiare duro tutti quegli anni per un lavoro di merda.”
“Ma come? Non hai fatto carriera in azienda?” Sapevo che carriera e azienda erano le sue parole
preferite.
“Luigi, tu non hai idea di tutto quello che ho passato. Sono ancora all’ultimo livello, quello che tutti
chiamano il garage. Ti rendi conto? Oramai non mi aggiorno neanche più, a cosa serve? Ho
disimparato tutto. Nessuno si accorgerà mai delle mie qualità. Gli unici a stimarmi sono i miei
colleghi, ex operai malandati e gentaglia con la licenza media.”
“Mica perché uno non ha studiato deve essere inferiore e stupido, Jo. Chissà che non abbiano
affinato altre virtù che tu non potrai mai avere? La praticità, la manualità, la capacità di fare
gruppo… Magari l'onestà, la semplicità, l'intelligenza nel gestire un rapporto d'amicizia... la felicità
interiore...”
“Luigi, tu non capisci! Sono in mezzo alla feccia dell’azienda!” disse Jo mentre gli occhi gli si
facevano lucidi.
“E con Salomè come va? Sembra proprio una ragazza bellissima!”
Alzò la testa e mi guardò. Sapevo cosa significava quello sguardo. Ti sei scopato mia madre e ora
vuoi scoparti anche la mia ragazza.
Si alzò dalla sedia e mi preparò una tisana al finocchio.
“Jo, sono nella merda” dissi per tirarlo su di morale. “Negli ultimi tempi mi ero dato
all’insegnamento. Lo sapevi, vero?"
Annuì.
"Be', andava tutto bene, guadagnavo poco, ma cercavo di risparmiare e così ho messo via un po’ di
soldi coi quali ho pagato i debiti che avevo accumulato per ricomprare la casa dei miei..." dissi
cercando il suo sguardo. "Scusa se non mi sono mai fatto sentire in questi tempi, lo sai come sono
fatto...”
“Sì, certo" bofonchiò con gli occhi a terra. "Lo sappiamo come sei fatto."
“Ho tirato la cinghia negli ultimi due anni. A volte avrei voluto mollare tutto e abbandonare questa
vita. Ma lavorare coi ragazzi si è rivelato un toccasana. Ho apprezzato nuovamente i ritmi lenti della
vita. Andava bene, finché il destino non ha bussato alla mia porta e mi ha detto: Luigi, questa non è
la tua strada, la vita ti riserva altre emozioni, altri viaggi, altre esperienze, hai già imparato
quanto l’insegnamento ti poteva insegnare, ora va e cercati qualcos’altro per vivere: la vita per te
non è così facile: tu sei speciale..."
Posò sul tavolo le due tazze di tisana bollente e tornò a osservarmi.
“Fui cacciato da due scuole per fatti che non starò a spiegarti, ma per i quali non avevo gravi colpe.
Finii sui giornali e così la mia carriera scolastica credo proprio possa dirsi conclusa." Alzai lo
sguardo. "Ma forse questo già lo sapevi."
Giovanni disse solo: "Chiunque legga un quotidiano o guardi la TV sa cos'è successo."
Non commentai.
"Negli ultimi mesi non ho lavorato. Sono qui per questo.”
Finì di bere la tisana. Si alzò per prendere la teiera. Ancora fumava quando la versò nella sua tazza.
“Ne vuoi dell’altra?”
“Grazie.”
Rimanemmo in silenzio finché non suonò il campanello. Era certamente lei che tornava dal lavoro.
Mentre Jo andava ad aprire mi scompigliai i capelli e la barba, e mi alzai. Mi diressi alla
portafinestra che dava sul poggiolo. Osservai in lontananza le montagne con le cime innevate.
“Ciao cara, fatti baciare. C’è qui un mio vecchio amico dei tempi dell’università” disse con una
voce anomala. “Luigi, questa è Salomè.”
Non dimenticherò mai quel pomeriggio. Non perché avevo potuto toccare con mano un’altra volta il
sedere di Teresa, non perché avevo rivisto Jo dopo anni di separazione, non perché fu grazie a
quella visita che trovai lavoro e realizzai il mio sogno, ma unicamente per lei: quel pomeriggio
Salomè entrò nella mia vita per non uscirne mai più. Gli occhi grandi color cioccolato, i capelli
rasta, il viso abbronzato dai lineamenti perfetti, il collo di velluto avvolto da una pashmina viola dal
sapore indiano, la dolce-vita verdone che evidenziava il seno nudo, i jeans attillati attorno a un
sedere magro e sporgente all'indietro, le clarks grigie come giornate tristi d’inverno.
“Piacere, Luis” dissi con voce impostata. “¿Que tal?”
x
Lei sorrise, appoggiò sul tavolo della cucina il Tolstoj che teneva in mano, e mi baciò sulle guance
alla rovescia, come si fa in Spagna. Rischiai di baciarla sulle labbra.
"Tu sei quello della finta varicella, vero?"
"Sì, esatto" dissi guardando Jo. "Grazie per la bella presentazione, amico."
"Non c'è di che" rispose senza sorridere. "Sono un gran lettore di quotidiani..."
"Sì, ma forse non sai che ho passato dei mesi svegliandomi a ogni ora delle notte, perché non
riuscivo a togliermi dalla testa quell'immagine."
"Quale immagine?" disse lei con occhi innocenti.
"Continuavo a vedere quel cazzo di autobus a doppia altezza che, in una curva a gomito ghiacciata,
scivolava sull'asfalto fino a toccare il guard rail per poi capovolgersi e iniziare a rotolare giù per la
vallata..."
"Dai, non pensarci, basta" disse lei abbracciandomi, "non è colpa tua."
"Sì che è colpa mia" dissi cercando di non piangere. "Sono io che ho insistito perché tutti salissero
in un solo pullman anziché noleggiarne due, come avrebbe fatto chiunque avesse un minimo di
raziocinio."
Tacemmo tutti. Lei continuava a stare al mio fianco con la mano sinistra sul mio braccio destro.
“Poverino" ripeteva, "poverino."
Io ero imbarazzato e allo stesso tempo eccitato.
"Senti, Jo, perché Luigi non si ferma a cena?”
“Anche tu lo chiami Jo?”
“¡Mejor que Giova, como lo llama su puta madre!”
“Lascia perdere mia madre” disse Jo alzando la voce.
“Comunque se disturbo me ne vado. Ero venuto solo per chiederti una cosa, Jo.”
“Non disturbi affatto” disse lei.
“Ho già capito, tranquillo Luigi. Vuoi che ti trovi un lavoro, giusto?”
Annuii sorridendo.
“Vorresti lavorare in azienda?” disse Salomè.
Ogni suono che emetteva mi faceva tremare le ginocchia. Ogni sguardo mi bloccava. Non mi
sentivo così da secoli. Forse da quando avevo visto una homeless senza nome in una stazione
ferroviaria birmana. Come lo era stata lei tanti anni fa, così ora Salomè mi appariva come un angelo
venuto sulla terra per salvarmi dal grigiore.
“Lascia perdere, Luigi, non fa per te” disse Jo prendendo una pentola dalla credenza e riempiendola
d’acqua. “È tremendamente noioso là dentro.”
"Jo, voglio mettere via un gruzzolo e poi scappare dall’Italia. Ne ho piene le scatole! Me ne andrò
in un paese in via di sviluppo.”
“¿Verdaderamente?” scandì lei con lentezza.
Jo mi guardava con occhi maligni. Sapevo cosa stava pensando. Guarda quel pezzo di merda come
si pavoneggia davanti alla futura madre dei miei figli, ecco cosa pensava Jo in quella testa
antiquata. E ce l'aveva certamente anche con lei che faceva l'amicona e mi parlava mezzo in
spagnolo.
“¡Traeme contigo!”
Giovanni divenne pallido, poi rosso, quindi violaceo, fino a sbottare dalla rabbia.
“Basta così per oggi. Si è fatto tardi, Luigi, forse è il caso che ci rivediamo con più calma. Chissà
quante cose avrai da fare a casa.”
“Veramente non ho più una casa, Jo. Dormo in tripla con delle matricole universitarie, in un cesso
di appartamento a centocinquanta euro al mese.”
“Meglio che sotto a un ponte” disse furibondo mentre con gli occhi mi spingeva verso la porta.
“Se non vuoi aiutarmi andrò da Zeno" dissi afferrando la maniglia. "Lui sarà senz’altro più
ospitale.”
“Amico mio, Zeno ti ha preceduto!” gridò fuori sul giroscale facendo rimbombare la voce. “Vive a
Brighton da un paio di anni con Maria e suo figlio!”
“Mi prendi per il culo?”
“Se n'è andato dopo il post-dottorato” disse mentre dietro di lui intravedevo la figura di Salomè che
mi salutava allegramente. Mi scappò un sorriso pensando a quanto erano diversi lei e Jo. Sarebbe
stata certamente meglio con un pazzo come me. Ma, si sa, l’amore è cieco. "Tu invece sei ancora
qui a lamentarti!" disse Jo sbattendo la porta.
La conoscevo da cinque minuti e già speravo che tra loro tutto finisse. Non volevo però che la loro
storia terminasse a causa mia. L’amicizia prima di tutto.
O almeno così credevo di pensarla a quei tempi. Ora seduto su questa sedia vecchia – mai quanto
me –, non so cosa pensare. Scrivo. Cerco di ricordare la mia vita. Le fasi cruciali in cui ho fatto le
scelte che contano. Ammetto però che ne capisco ancor meno di allora. La vita è così strana che
l’unica maniera corretta per trovarci un senso è viverla. Viverla e basta. Scriverla è superfluo.
Stavo chiudendo dietro di me il portone d’ingresso al piano terra, quando guardando in alto rividi la
porta dell’appartamento di Teresa e mi si illuminò un mondo di eccitanti ricordi.
Chiusi il portone. Dall’interno.
Risalii le scale in silenzio.
Sentivo Jo gridare. Urlava parole di rimprovero alla povera Salomè che evidentemente si sorbiva
quella predica senza protestare. Forse era la loro maniera di amarsi. Bussai con dolcezza e mi
ritrovai di fronte una splendida ultracinquantenne in vestaglia.
“È una vita che ti aspetto, Messner" disse chiudendo la porta. "Sapevo che prima o poi saresti
tornato.”
Mi prese la mano sinistra e la portò al suo seno destro. In quel momento sentii riaprirsi dentro me
una gioia da troppo tempo dimenticata. La stessa gioia che prova un bambino a rubare le caramelle
da un cassetto. Le morsi il labbro inferiore mentre con mani ansiose la spogliavo della vestaglia. Mi
allontanai di un paio di passi per ammirarla. Qualche ruga in viso non la rendeva meno sexy. Il seno
abbondante era ancora sodo e pieno di grazia. La pancia era rimasta piccola e sinuosa, le gambe
lunghe e affusolate. Venne verso me, mi spogliò lentamente e s'inginocchiò.
Y
Mi faceva pena vedere Luigi nello stato in cui mi capitò in casa dopo anni che non ci vedevamo.
Il lavoro era sempre lo stesso. Ancora non ero riuscito ad avere nessun riconoscimento. Lavoravo
sodo in mezzo a gente stupida e impreparata, e più m’impegnavo, più i colleghi si facevano beffa di
me. Attendevo con ansia il livello superiore. I colleghi sapevano che me lo meritavo e per questo mi
consideravano diverso e mi emarginavano, nonostante fossi sempre onesto e disponibile con
ognuno di loro.
Ciò che mi teneva a galla era l’amore di Salomè. La mia vita con lei era cambiata. Avevo uno
scopo: renderla felice. Tutto aveva assunto un senso, e la cosa che più volevo al mondo era edificare
(come amo questo termine!) una famiglia con lei. Eravamo entrambi a tempo indeterminato, anche
se i nostri orari ancora non coincidevano. Giù in garage seguivamo orari da fabbrica, si iniziava
presto la mattina per uscire a metà pomeriggio. Questo ci avrebbe imposto l’acquisto di un’altra
auto, ma Salomè trovava sempre un passaggio.
Avrei tanto desiderato un bambino da lei, ma non era mai il momento giusto.
Luigi aveva seguito strade differenti. Fin da piccolo.
Aveva avuto un padre e una sorella. Io no. Sua madre era una donna di paese orgogliosa di esserlo,
non un'aspirante cittadina. Sua madre con l'età era diventata matura sia nel fisico che nell'animo, la
mia rimaneva sempre identica. Sua madre era una donna simpatica, semplice e sincera. La mia
antipatica, sempliciotta e falsa. Non lo dico per auto-commiserarmi. È la verità. Avessi avuto
almeno un maschio in famiglia: un padre col quale confidarmi o un fratello con cui confrontarmi.
Almeno una sorella con cui condividere i momenti felici dell'infanzia. Invece no. Ero cresciuto da
solo. Servito e riverito da una pazza isterica. Però le voglio bene: lei c'è sempre stata, non mi ha mai
abbandonato.
Luigi invece era cresciuto in una famiglia tradizionale. Molti dei suoi amici erano cugini e cugine.
Aveva tanti zii che gli volevano bene. Durante gli anni del liceo aveva avuto sempre la stessa
ragazza, una bionda mozzafiato. All'università al contrario, mentre io studiavo come un mulo, lui
aveva cambiato cinque o sei ragazze. Era fatto così Luigi, fragile e incapace di tenere a freno le
emozioni, a dispetto del suo essere spavaldo. I problemi sono cominciati poi. Dopo la laurea aveva
fatto lo schiavetto in uno studio tecnico di poche unità. Stufo di quella vita, aveva giocato i suoi
risparmi su una partita di calcio: manco gli piaceva il calcio... La cosa incredibile è che aveva
indovinato esattamente il risultato del mondiale successivo. Quando lo feci notare a Zeno, restò in
silenzio un attimo e poi disse: "Luigi è avanti di quattro anni rispetto alla società contemporanea."
Disse proprio così, prima di scoppiare a ridere. Io dall'altra parte della cornetta mi limitai a
sorridere. Era raro che Zeno si lasciasse andare a quel modo.
Al funerale dei genitori e della sorella – me lo ricorderò per sempre – Luigi non versò una lacrima.
C'era tutta Vigolo. L'intero paese era sconvolto. Luigi sembrava indifferente, privo di emozioni,
vuoto. Se dovessi scegliere un colore per descriverlo, sarebbe il bianco. Un bianco etereo, quasi
trasparente. Qualche settimana più tardi, vendette la casa di Vigolo e scomparve.
Passò un anno prima che lo rivedessi.
Poi andò a vivere a Vigolo e, tanto per cambiare, non si fece più vedere né sentire.
Lo rividi in TV. Divenne infatti a suo modo famoso per un paio di curiosi episodi. Quello che lo
rese celebre, fu addirittura un caso nazionale. Venne filmato da uno studente, e poi pubblicato in
rete, mentre si preparava uno spinello in classe. Lui cercò di spiegare che si trattava di una sigaretta,
ma le immagini erano chiare. Fu sospeso per sette anni dal mondo della scuola statale. Perse ogni
ricorso. Fu assunto da una piccola scuola privata e, solo qualche mese dopo si salvò
miracolosamente dalla più grande sciagura del mondo della scuola italiana. Un pullman che
trasportava un'intera scolaresca uscì di strada sullo Stelvio. Morirono tutti. A quanto dissero i
giornali, Luigi era malato. Solo poi si scoprì che si era fatto dare dal medico di famiglia un
certificato di due settimane di malattia per varicella. Quel gesto disonesto gli valse la vita. Perse
però il lavoro e la faccia.
Suonò a casa mia un pomeriggio in cui me ne stavo a casa navigando in internet con la tapparella
abbassata.
x
IL PESCE ILLUMINATO
-MANUALE DI VITA NON VISSUTAdi
Gianni Longhi
SOLITUDINI
come affrontare una nuova vita
Sono qui.
Non so da quanto. Non so come. E non so nemmeno perché.
Vivo.
Questo è tutto.
Ciò che vedo è il blu. Un blu scuro, profondo, quasi cieco.
Acqua è ciò che sono. E se la libertà è potersi muovere dentro vincoli prestabiliti, allora sono libero.
Sì, sono libero di fare tutto quello che voglio. Correre, rallentare, girare, cantare, gridare, volare.
Nel mio mondo posso fare qualsiasi cosa. E il mio mondo è quest’acqua racchiusa in una sfera di
vetro in fondo al mare.
Non ricordo di essere stato in nessun altro posto se non qui, sepolto da un oceano d’acqua, buia e
pesante.
Lo spazio all’interno della sfera di vetro l’ho chiamato il Mio Universo e quello fuori Universo
Infinito.
A volte mi sento leggero come una bolla. Mi sembra di volare, volare in alto verso i confini del
mondo.
Altre volte mi sento oppresso da tutta questa buia azzurrità senza fine. Faccio fatica a muovermi. Mi
passa la voglia di mangiare, di vivere, di scherzare.
Il tempo passa, e io lo trascorro così, pensando, parlando con me stesso, nuotando, osservando
questa montagna d’acqua trasparente e cieca.
Ciò che più mi fa pensare negli ultimi tempi è questo involucro incolore, la Sfera. A volte penso di
essere trasparente anch’io. Di non esistere. Ch’io forse sia la mia mente in movimento, e il mio
corpo questa sfera immobile nella quale sono intrappolato?
Conosco il Mio Universo a memoria. Mi viene naturale identificarmi con esso.
L’idea, o meglio l’ossessione, che mi divora negli ultimi tempi è ch’io non sia solo.
Nella sfera non c’è nessun altro, di questo non dubito. Ma se in qualche luogo lontano ci fosse una
mente rinchiusa anch’essa in un’altra sfera? Perché no? Chi mi vieta di pensare che laggiù qualche
altro Io non possa pensare “Chi mi vieta di pensare che laggiù qualche altro Io non possa pensare
“Chi mi vieta di pensare che laggiù qualche altro Io non possa pensare?”?”?
E se ne esiste uno, perché non due, tre, cento, infiniti? Non mi sembra un’idea tanto folle. O forse lo
è?
Mi sento solo. Questa è la verità. E ho paura di esserlo per sempre.
Qualcosa là fuori c’è. Ne ho le prove. Non me lo sono sognato. Una strana luce filtra nelle acque
lontane. Come se una bolla lontanissima esplodesse. Non so descriverla a parole. È un’esperienza
bellissima. Quando compare mi fermo a guardarla finché non scompare. Io la bolla la chiamo Dio
Sole.
Ho deciso di chiamare Giorno il tempo in cui è presente il Dio Sole e Notte il resto del tempo.
Non è tutto. A volte capita che passino laggiù degli strani esseri allungati. Quasi tutti grigi. Alcuni
sono enormi, fanno paura. Altri sono piccolini. Quelli grandi sembrano vicini, quelli piccoli
lontanissimi. Ce ne sono di varie forme, ma io li chiamo tutti Pesci.
Alcuni si spostano senza neanche muoversi. Come se a portarli fosse una corrente invisibile. In
genere sono i più grandi. Ho deciso di chiamarli Dèi Pesci.
I più piccoli scodinzolano e ogni volta che li vedo non riesco proprio a trattenermi e scoppio a
ridere. Ce ne sono anche di colorati: sono bellissimi! Io li chiamo Pagliacci.
Quelli grigi e allungati ho pensato di chiamarli gli Altri.
Ci sarebbero anche i Fili Verdi, ma quelli mi sa che non sono esseri viventi. Sono solo fili fissati al
fondo dell’oceano che ondeggiano regolari.
E poi ci sono io, che ancora non ho capito che ci faccio qui. Da quando mi ricordo di essere vivo
(prima non ho proprio idea di dove fossi) non ho ancora capito cosa sono. Il mio corpo, che
immagino essere questa sfera di vetro, non si è mai mosso. Non sono come gli altri esseri viventi.
Forse semplicemente non sono un essere vivente. Eppure all’interno del mio corpo la mia mente si
muove eccome! Nuota, corre, canta!
Non sono né vivo come un pesce, né morto come un sasso.
***
Un giorno successe una cosa che mi lasciò senza fiato. Mentre nuotavo nella sfera e provavo nuove
piroette, con la coda dell’occhio destro notai qualcosa. Mi spaventai e presi a nuotare in circolo
come un pazzo per paura che qualcuno mi inseguisse. Correvo da una parte all’altra della sfera
voltandomi all’improvviso per scoprire chi mi stava inseguendo. Fu proprio in uno di questi rapidi
movimenti all’indietro che scoprii chi ero.
Non c’era nessun altro nella sfera. Quello che avevo veduto con la coda dell’occhio ero proprio io!
La mia coda. Il mio corpo.
Mi cadde il mondo addosso. Tutte le congetture sul mio corpo immobile e sulla mia mente libera di
vagare in questo corpo non erano più credibili. Mi girai più volte ad osservare la mia grigia coda e
le sue incantevoli striature rossicce. Mi accorsi che il mio corpo era oblungo, proprio come quello
degli esseri che mi passavano di fronte ogni giorno. Decisi dunque di non chiamarli più gli Altri, ma
semplicemente Compagni.
Ero colmo di gioia, ma allo stesso tempo mi assalivano l’ansia e il terrore di essere diverso. Non
capivo. Perché tutti i Compagni erano liberi e io imprigionato?
Un giorno la risposta che cercavo mi sbatté dritta in faccia. Mentre nuotavo tra le lacrime disperato
e solo come un pesce, una scena raccapricciante mi sconvolse tutto. C’era un Compagno che se la
spassava ancheggiando di qua e di là di fronte alla mia sfera-prigione. Io lo osservavo invidiando la
sua infinita libertà. All’improvviso sbucò dal nulla uno degli Dei. Veloce e silenzioso come solo un
Dio può esserlo, inghiottì in un sol boccone il piccolo ignaro Compagno.
In quel preciso istante mi fu un’altra volta tutto chiaro. Se ero nella sfera era perché qualcuno,
qualche Dio oppure il destino, mi voleva bene. Tanto bene da volermi proteggere.
y
La voce non mi era nuova.
“Dai, sono io, Jo, apri questa stramaledetta porta del cazzo!”
Aprii e lo aspettai a braccia aperte nel vano-scale.
“Chi è?”
“È per me, mamma, lascia stare! Tornatene ai fornelli!” gridai stizzito.
“Ciao, mammina” sentii dire dal piano inferiore.
“Messner! Fatti abbracciare, bel maschione. Guarda che spalle ti sono venute! Ma che fine avevi
fatto? Il Giova non mi dice mai niente di te! Dove sei stato? Hai viaggiato per il mondo? Fai ancora
l'insegnante o sei diventato un ingegnere? O sei disoccupato?”
“Se me ne dai modo forse riesco anche a dirtelo, Teresa” disse abbracciandola con troppo ardore.
Poi si accorse di me.
“Ehi, damerino!”
Lo strinsi tra le braccia. Aveva addosso un odore forte. I capelli erano trascurati e una lunga barba
folta gli copriva gran parte del volto. Portava abiti di seta larghi e sporchi.
“Che combini, fratello?”
“Ma come cazzo parli, Jo?”
"Giova, cerca di esprimerti con un po’ di decenza!” disse mia madre.
Presi Luigi e lo condussi nel mio appartamento al piano superiore ignorando totalmente l’esistenza
di mia madre. Voleva mettere il becco in ogni mia faccenda, e questo non mi andava. E soprattutto
non andava a Salomè.
Mentre parlava Luigi continuava a osservare le foto appese al muro del soggiorno in cui compariva
Salomè. Quel pomeriggio mi dissi più volte “stai attento al tuo amico o finirà per portarti via ciò
che di più caro possiedi”.
Quando Salomè ci raggiunse Luigi non le staccò gli occhi di dosso. Lei, a dire il vero, si faceva
guardare volentieri, ignorandomi totalmente. Decisi di risolvere la cosa spingendo letteralmente
Luigi fuori di casa. Una volta liberatomi di lui feci una scenata di gelosia a Salomè. Le dissi che se
mi amava doveva dimostrarmelo e non supplicare Luigi perché la portasse via dall’Italia.
Non parlammo per il resto della serata. Quando mi coricai ripensai al modo in cui mi ero
comportato e mi vergognai profondamente. Svegliai Salomè e le chiesi scusa. Lei mi abbracciò.
“È colpa mia. Il tuo amico Luis è forte. Dovremmo uscirci assieme qualche volta” disse prima di
ricadere in un sonno profondo.
“Hai ragione” dissi quando lei già dormiva.
Il giorno seguente spedii una lettera al quarto in cui facevo presente la possibilità di proporre un
laureato in mia sostituzione, nel caso in cui la mia presenza fosse ritenuta utile a un livello
superiore. Era la prima lettera di quel genere che spedivo e non sapevo a chi indirizzarla. Scrissi
genericamente All’ufficio personale - IV livello. Avrei allegato il curriculum, se solo Luigi ne
avesse mai redatto uno.
Tornato a casa passai a salutare mia madre come facevo ogni pomeriggio. Notai in lei qualcosa di
diverso. Aveva stampato un sorriso in volto ed era tutta profumata, come se dovesse uscire per un
appuntamento galante. Chi se la piglia una vedova della sua età, pensai malignamente. La baciai e
salii di sopra, nel mio appartamento. Quando verso le sei mi raggiunse Salomè, le raccontai della
lettera.
“Perché non me l’hai detto subito” mi disse animatamente. “Da noi stanno cercando un’altra
persona che possa dialogare con l’America del Sud.”
“Si dice Sudamerica, cara.”
“Se puede decir tambien como lo dije yo!” disse accalorandosi. “Un ingegnere che parla spagnolo e
portoghese sarebbe la persona ideale.”
Volevo aiutarlo, ma non volevo che andasse a lavorare proprio nell’ufficio della mia fidanzata.
“Be', vedremo. E comunque non è che li parli poi tanto bene come dice… Luigi? Ascoltalo la metà
e credigli un quarto!” dissi per screditarlo ai suoi occhi. “Intanto vediamo se rispondono alla
lettera.”
“A proposito, sai chi mi ha dato un passaggio oggi?”
“Un bel maschione?” dissi scherzando.
“Quel tuo vecchio collega sgrammaticato, Alex.”
“Cosa?” gridai. “Che cazzo ti è saltato in testa?”
“Se fai così non ti racconto più niente, Jo.”
“È il bastardo che si è preso la mia promozione, l’ultimo a passare dal terzo al quarto!”
“Fa troppo ridere il modo in cui parla con tutte quelle i. Usa sempre il plurale, hai notati? È troppo
uno spasso starlo ad ascoltare!”
“Uno spasso? Mi dà un fastidio...” dissi sbuffando. “Non credere a una parola di quello che dice
quel pezzo di merda. Quello è uno stronzo fatto e finito. Lascialo perdere!”
“Ma poverino, non sa nemmeno parlare l’italiano, che male vuoi che mi faccia?” disse lei.
“Quel bastardo me ne ha combinate di tutti i colori” dissi stringendo i pugni. “Ricordi la lettera che
ti avevo scritto?”
“Certo, dal terzo al settimo piano parlavano tutti di te!”
“Lui l’aveva accartocciata… lasciamo perdere.” Non volevo rivangare un passato che faticavo a
dimenticare.
“Quella persona così gentile e disponibile? Quel gigante dal cuore buono?”
“Quel pezzo di merda era sceso al terzo e l’aveva letta davanti a tutti.”
“E che male c’è? Ti ha fatto della pubblicità gratuita. E tu, invece di ringraziarlo, lo denigri?”
“Non hai idea di quello che dici. Ti ricordi quando ti dicevo che ero rimasto a casa un mese in
malattia dopo quel fatto?”
Salomè annuì con fare curioso.
“Stavo uno straccio. Ero stato umiliato, i miei sentimenti messi a nudo davanti ai miei colleghi. Non
puoi capire cosa ho passato. Mi volevo licenziare e l’avrei fatto, se mia madre non fosse tornata dal
medico con un certificato di malattia. All’idea di dover tornare a lavorare otto ore al giorno con
certa gente inorridivo.”
“E io passai qui perché ero curiosa di conoscerti. Non mi ricordavo nemmeno chi fossi!”
“Ti assicuro che non ho mai sofferto tanto in vita mia. Non ho mai subito un’umiliazione del
genere. Lascia perdere Alex” dissi guardandola negli occhi. “Promettimelo.”
“Te lo prometto" disse senza cercare i miei, come se quel che ci stavamo dicendo non avesse
importanza.
Alcuni giorni dopo, Luigi finalmente mi spedì il curriculum vitae e una lettera di motivazione, se
tali si potevano definire le due paginette che aveva scritto. Le consegnai a Salomè e, già il mattino
seguente, mi chiamarono al telefono dicendomi che l’ing. Alberti – che non potevano rintracciare in
quanto il suo cellulare risultava sempre spento – doveva presentarsi nel pomeriggio all’ufficio
personale.
Lo rintracciai soltanto a mezzogiorno. Si era appena alzato.
“Non puoi farmi questo. Mi sono sbattuto per trovarti un lavoro e tu mi tiri pacco?”
“Fammici pensare un secondo, baby, che fretta c’è?”
Se lui prendeva il mio posto, avrei avuto il mio migliore amico in azienda e allo stesso tempo la
promozione che aspettavo da anni.
“Forza, Luigi, non puoi dirmi di no!”
“Passo lì verso le quattro.”
“Non farmi fare brutta figura: vestiti decentemente...”
x
Mentre stavo pranzando nudo sul poggiolo di sua madre, Jo chiamò tutto agitato per dirmi che mi
aveva fissato un colloquio in azienda e che avrei dovuto presentarmi già nel pomeriggio. Non mi
andava di mettermi una camicia e mendicare un posto di lavoro, ma non potevo continuare a farmi
mantenere da Teresa. E poi mi serviva il denaro per realizzare il mio sogno.
Salii le scale dell'azienda e al quarto piano mi ritrovai di fronte un angelo coi capelli rasta. In quei
giorni avevo cercato d’immaginarmela più brutta che potevo, ma rivedendola in quello stato di
grazia mi prese un colpo al cuore.
“¿Que haces aqui?” mi disse come se ci conoscessimo da secoli. “Hai sbagliato piano, Jo è giù in
garage” disse col pollice verso e la voce graffiata. "Anzi, a quest'ora sarà già via."
“A dire la verità mi ha chiamato prima per dirmi di un colloquio all’ufficio personale verso le
quattro.”
“Vestito così? Vieni, ti offro un caffè!” disse dopo aver dato un’occhiata all’orologio appeso al
muro.
La seguii. L’ambiente non mi pareva ostile come lo aveva descritto Jo. Ogni scrivania aveva un
computer con lo schermo piatto e un telefono fisso. C’era un’aria pulita e luminosa. La gente
sembrava allegra e socievole.
“Non è male qui” dissi sorridendo.
“Lo stipendio non è granché ma il rapporto coi colleghi è buono. Pensa che il novanta per cento dei
dipendenti è assunto a tempo indeterminato. Non è mai stato licenziato nessuno, per questo si può
lavorare con serenità...”
Mentre parlava non l'ascoltavo, ma la osservavo in tutta la sua bellezza cercando d’incrociare il suo
sguardo.
“Ma perché allora Jo ce l’ha tanto coi colleghi e con l’azienda?”
“Sono due i motivi. Effettivamente giù al terzo non ci sono finestre ed è un covo di ignoranti. Una
volta sono scesa per consegnare delle lettere. Non hanno neanche un computer in tutto il piano e c’è
una puzza di sudore da voltastomaco.”
“Il secondo motivo?”
“Jo è un essere perennemente triste e lamentevole. Se dice asì, no?"
Annuii.
Si avvicinò. Il suo corpo distava da me non più di cinque centimetri, ma lei sembrava non
accorgersene.
"Non lo sopporto più, Luis. Non fa altro che frignare, se dice asì, no? Si sente sottovalutato. Cerca
di farglielo capire tu. Altrimenti sarò costretta a suicidarmi assieme a lui, o a uscire per sempre dalla
sua vita.”
La zona caffè era invasa da fumatori sghignazzanti. Parlavano di calcio, reality-show e politica.
Salomè mi porse il caffè al ginseng e ci appoggiammo coi gomiti sul davanzale di una finestra.
“A che ora stacchi?” dissi guardandola negli occhi nocciola.
“Alle cinque in punto.”
“Ti va una birra all'Angi?”
“Claro, como no!” disse prima di alzare lo sguardo verso me. “A me tremerebbero le gambe.”
“Posso dirtelo in tutta sincerità?” dissi facendomi serio per un attimo. “Sono venuto qui solo per
fare un favore a Jo.”
“Ma non eri alla disperata ricerca di un lavoro?” disse guardandomi con sospetto.
“In questo momento…” Mi fermai non potevo raccontarle che mi facevo mantenere dalla madre del
suo ragazzo. “Ti racconto tutto di fronte a una pinta.”
Mi indicò l’ufficio del personale e ci separammo.
Quando ci rivedemmo, erano le sei e mezza. La stavo aspettando all'Angi's pub, oramai alticcio.
Aspettai che si fosse seduta e, senza dire niente, lessi quanto avevo annotato nell'ultima ora sul
moleskine.
Bussai alla porta alle quattro e dieci.
“Sior?” disse senza alzare lo sguardo un tipo magro in doppio petto con un'evidente cifosi.
“Alberti. Luigi Alberti. Progettista, insegnante, poliglotta…”
“Aspetti un attimo.” Cercò invano tra le sue scartoffie la mia scheda. “Non importa, sior Alberti.
Mi racconti un po’ di lei. Che le piace fare nella vita?” disse guardandomi per la prima volta.
“Viaggiare e parlare con la gente.”
“Tutto qua?”
“Be', è quello che mi piace fare” dissi. “Non disprezzo nemmeno la lettura, se è per questo.”
“Lei non mi piace, Alberti" disse tirando su col naso come un maiale. "Voglio essere franco.
Abbiamo estremo bisogno di un tecnico che parli correntemente portoghese e spagnolo.
Soddisferebbe lei questi requisiti?”
“Sì, soddisferei io questi requisiti.”
Alzai un attimo lo sguardo. Salomè mi guardava. Le si era disegnata sulle labbra l'ombra di un
sorriso inconsapevole. I denti bianchissimi, la birra in mano. L'occhio liquido.
Bevvi un sorso della mia e ripresi a leggere.
...soddisferei io questi requisiti.”
“Guardi, sior Alberti, la smetta di fare il furbo. Lei mi piace sempre meno a ogni parola che esce
dalla sua bocca."
Sorrisi di gusto. Lui sbuffò spazientito.
“Lei mi assicura di avere in suo possesso una laurea in ingegneria?”
Annuii.
“Sa scrivere e parlare in portoghese?”
Annuii gridando “Claire!”
“Fin lì ci arrivano tutti, sior Alberti! È in grado si sostenere un dialogo in portoghese?”
“No problem, sior.”
Forse stavo esagerando. L’incravattato strinse i pugni e digrignò i denti.
Sentivo Salomè ridere. Finii la birra senza alzare lo sguardo dal taccuino. Ero felice che si
divertisse.
“Un’ultima cosa, Alberti: sarebbe disposto a sostenere brevi trasferte in Brasile e Argentina?”
“Gliel’ho detto che adoro viaggiare, no?”
Batté il pugno destro contro la scrivania prima di formulare una frase che non avrebbe mai voluto
dire.
“Va bene, sior ingegner Luigi Alberti. Sosterrà un periodo di prova pagato di tre mesi, superato il
quale verrà assunto a tempo indeterminato in azienda." L'incravattato mi guardò dall'alto in basso
come se avesse appena fatto un atto caritatevole.
Io lo osservai con totale indifferenza, stravaccandomi sulla sedia.
"Accetta, sior Alberti?”
Decisi di farlo contento.
“Potrei sapere a quanto ammonta lo stipendio?”
Solo allora seppi che sapeva sorridere. Sembrava il sorriso di un padre al figliol prodigo.
“Anch’io amo il denaro” disse tutto contento.
“Io ci vivo col denaro.” Non riuscii a tacere.
Finì così il nostro breve idillio.
Mi guardò con lo stesso disprezzo con cui io guardavo il denaro.
Poi scosse la testa a lungo mentre si accendeva un sigaro.
Lui aveva urgente bisogno di me e io del suo fottuto denaro.
Riprese a parlare, con voce triste, come se avesse appena scoperto che la moglie lo tradiva.
“Partirà dal quarto livello, in fascia economica D1. Riceverà uno stipendio iniziale di
millecinquecento euro. In meno di un anno, se si rivelerà particolarmente dotato, passerà al quinto,
fascia EP..." Scandiva le parole lentamente, a malincuore, e io smisi di ascoltarlo. "...le sarà
pagata una cospicua missione tutte le volte che si recherà all’estero."
“Quando si parte?” dissi pensando alle spiagge brasiliane che mi aspettavano.
“Intanto cominciamo col lavoro d’ufficio" disse serio. "Si presenti qui domani alle nove in punto
per la firma del contratto.”
“Non mancherò” dissi alzando con rapidità i tacchi delle infradito, guarda caso brasiliane. Mi
accorsi che le ascelle mi puzzavano e che stavo perdendo i pantaloni. Li tirai su con le mani in
tasca e, prima di chiudere la porta, portai la mano sinistra in alto e, senza girarmi, feci un cenno,
come a salutare un vecchio amico al bar. Sbattei forte la porta mentre il mio futuro capo ancora
parlava. Lasciai fluire una scoreggia che tenevo da un po' e raggiunsi le scale.
Salomè, dopo alcuni secondi di smarrimento, scoppiò a ridere.
"¿Quieres saber una cosa?" Aveva due occhi stupendi. "Sei ancora più pazzo di quello che dice Jo!
È davvero un peccato che non ti abbiano preso. Potevi almeno metterti una camicia invece di
presentarti così..." disse indicando la mia T-shirt azzurra con la scritta rossa SIGANME LAS
BUENAS.
Scoppiai a ridere anch'io mentre ordinavo altre due birre medie.
"Aspetta, non ho finito" dissi prendendoci gusto.
Cercai invano di stare serio e ripresi a parlare.
Mentre scendevo passai da quello che Jo chiama il garage. Avrei fatto di tutto per restituirgli il
favore: dovevo spingerlo al quarto, a costo di portarcelo di peso. All'improvviso mi assalì un tanfo
irrespirabile, come un'enorme scoreggia tossica. Accesi una luce sperando che il gas non
esplodesse. Mi accorsi solo allora che quello non era un ufficio, ma un enorme magazzino freddo e
senza finestre. Le vecchie scrivanie parevano banchi da lavoro. Uscii pensando alla sfortuna che
aveva avuto Jo, e alla mia buona sorte. Il mondo a volte è ingiusto, soprattutto il mondo del lavoro
con i fortunati in amore.
A quel punto scoppiammo di nuovo a ridere, senza sapere perché. Ridemmo fino alle lacrime. Era
la terza volta che ci vedevamo e già mi sembrava di conoscerla da una vita.
"Peccato" disse, "potevamo diventare ottimi colleghi!"
E giù entrambi a ridere ancora, come bambini ignari del mondo.
x
“¡Ahora tienes que contarme todo!” disse sbocciando la guinnes con la mia.
“Tutto tutto?” dissi, pensando si riferisse alla mia relazione tra me e Teresa. Mi vergognavo di
confessarle che andavo a letto con una donna di mezza età.
“Cosa farai ora?” disse invece.
“Eh, purtroppo dovrò lavorare, come fanno tutti...”
"¿Donde?"
Sapevo che una spagnola, per di più ubriaca, poteva impiegare molto a capire. Quindi aspettai.
"Ma... allora ti hanno preso!" disse finalmente.
Rimasi in silenzio con le braccia spalancate. Lei si gettò contro di me rovesciando i bicchieri sul
tavolino e allagandolo. Mi strinse forte, facendomi venire i brividi. Il suo collo liscio e caldo
profumava di giovinezza.
“Dobbiamo festeggiare, collega!" disse facendo segno al barista e continuando a stringermi.
Quando arrivarono altre birre gridò "¡Fondo blanco!”.
Ce ne scolammo tre di seguito.
Rivedevo in lei l'allegria degli spagnoli, con un retrogusto amaro, di difficile definizione, come se si
potesse sprofondare all’infinito in lei, senza mai coglierne pienamente il mistero.
Cercai di dimenticarmi che stavo parlando con un angelo. Le raccontai di me, della morte dei miei,
del mio viaggio, della mia caduta agli inferi. Più bevevo, più ero sincero, più lei diventava sexy. Ci
ritrovammo mano nella mano senza nemmeno accorgercene.
Decisi che era meglio darci un taglio.
Corsi in bagno con l'intento di masturbarmi. Impossibile, troppo ubriaco.
Uscendo mi inondai più volte il viso con dell’acqua ghiacciata.
La trovai a parlare con uno straniero grande e grosso, sulla quarantina. Non avrei saputo dire da
dove venisse. Aveva il fisico e l'accento tipici di un russo e il colore di un indiano pelle rossa.
Usava parole incomprensibili, quasi provenisse da una tribù africana. Rimasi ad ascoltare dietro a
una colonna di legno. Ero affascinato dal suo modo di parlare. E dal magico culo di lei, ovviamente.
"...ora vattene, Alex. Dai, vete!"
“Belle Salomè, dimmi nelle verità che fai di qui e poi io vado. Però basti far di finte io non ti piaci
più. Vieni con me in mie di macchine.”
“Sono con un amico.”
“Chi?”
“Un amico di Giovanni.”
“Un amici di tuo fidanzatini Giovanni detto Little-Longo, esseri più di sfigati dei piani di garage?”
“Dai, Alex, smettila! È solo un po’ pignolo su certe cose, forse un po’ all’antica...”
“Sfigati di prima è! Io non capisci perché tu stai insiemi a lui tanti anni! Lui superdotati forse? Più
di miei?”
“Magari…” disse lei rattristandosi. "Ojalà..."
Alex scoppiò in una risata atroce. “Longo no buoni di scopare agli amori! Ah ah ah! Tu devi di
scopare agli amori con me altre di volte!”
“Taci, estupido!” disse lei voltandosi verso il bagno senza riuscire a vedermi.
L’energumeno alzò lo sguardo nella mia direzione.
“Eccomi” intervenni fingendo di non aver seguito la conversazione. “Piacere, Luigi.”
“Io Alex, uno di colleghi.”
“Allora a domani, collega” dissi.
“Tu nuovi di colleghi domani?”
“Certo, a domani allora, mio colleghi.”
“Tu firme di contratti già fatte?”
“Inizierò domani mattina, e sempre domattina firmerò il contratti di me. A domani, miei colleghi”
dissi sorridendo a Salomè.
“Va beni, a domani. Ti lascio con donne più belle di quarti piani. Lei brave di fare scope degli
amori! Ah ah ah!” disse baciando Salomè sul collo. Quindi se ne andò al bancone a sgolarsi una
birra media con altri compagni di bevute.
“Chi era quel tipo allucinante? Da dove cazzo è saltato fuori?”
“È una lunga historia. Alex è il peggior nemico di Jo e così ogni volta che mi vede ci prova
spudoratamente...”
“Be', io al contrario sono il miglior amico di Jo, ma non per questo non posso provarci con te!” dissi
cercando di sottolineare il tono ironico della frase.
“Con te è un’altra historia” disse ridendo mentre mi guardava dritto negli occhi cercando di scovare
qualcosa. "Potrei anche starci!"
Normalmente avrei continuato quel discorso intrigante, ma si trattava della donna di quello che,
anche se ci eravamo persi di vista, rimaneva il mio migliore amico.
“Posso fidarmi di te, Luis?”
Annuii.
“Sono andata a letto con Alex, il tipo di prima." Mi guardò in silenzio. Era bellissima nel dolcevita
bianco sulla pelle andalusa. "Sei la prima persona a cui lo dico.”
Finsi indifferenza.
“Insuperabile! Mi ha ricordato i tempi in cui facevo sesso con i ragazzi africani di Madrid…” disse
guardando il soffitto. Poi si rabbuiò. “Con Jo le cose non vanno.”
Bevemmo in silenzio le nostre birre fino a svuotare i bicchieri.
“Vuoi che ti legga la mano?”
Notai solo allora che la sua voce tradiva una gran ubriachezza.
“Perché dire no quando posso dire perché no?”
Quando mi toccò la mano provai un brivido.
“Dunque, vediamo. Le linee mi dicono che hai avuto un passato recente molto burrascoso.”
“Grazie, questo lo sapevo.”
“Stai per intraprendere un nuovo lavoro.”
“Ah ah ah” dissi sorridendole. Aveva due occhi grandi e lucenti. Sarà che ero ubriaco, ma era di una
bellezza mai vista. Sentivo mancarmi il respiro. Il cuore riscaldarsi e palpitare.
“Stai conoscendo nuove persone che ti accompagneranno per il resto dei tuoi giorni” disse lei dopo
aver riflettuto a lungo.
“Intendi il tuo collega sgrammaticato o il doppio petto del colloquio di questo pomeriggio?”
“Le linee mi dicono che si tratta di una ragazza” disse guardandomi. “Una ragazza molto bella e
molto intelligente, e anche molto simpatica. Questa ragazza ti seguirà nei tuoi viaggi per tutta la
vita.”
“Dai, smettila, Salomè. Non provocarmi. È già abbastanza difficile.”
“Non ti sto provocando, sono le linee. Se vuoi mi fermo qui, ma è un peccato perché la tua mano mi
sta dicendo tantissime cose importanti del tuo futuro. Avrai tante donne oltre a lei.”
“Basta così. Grazie. La mano me l'ero fatta leggere anche in India, e non mi ha portato troppo
bene!”
Mi guardò come un cucciolo abbandonato.
“Ti accompagno a casa?”
Lei fece una faccia contrariata e ordinò altre due birre scure.
“Lo sai da quanto non faccio l’amore, Luigi?”
“No, e non voglio saperlo.”
“Tre mesi e mezzo.”
Non ci credevo. Quello stronzo di Jo non poteva trattarla così.
“Ci parlo io a Jo, tranquilla. Vedrai come cambieranno le cose d’ora in poi!”
“Jo ha bisogno di uno psicoterapeuta!” disse mentre passava il dito sul boccale. "Non so se il nostro
rapporto si può ancora recuperare."
"Devo dirti una cosa" dissi deciso. Poi mi fermai titubante.
"¿Que pasa?"
"Riguarda Jo e il suo passato" dissi. "Jo e sua madre, a essere precisi."
Lei mi guardò con la faccia obliqua.
"Lasciamo perdere. Non è il momento. Scusami" dissi. "Ordiniamo altre due birre."
Era una cosa che a Vigolo sapevano tutti. Tutti tranne lui. Nei paesi è così, le voci girano. Chi ne
rimane colpito, si ritrova a vivere ignaro all'interno di un Truman Show.
Non volevo coinvolgerla. Forse era meglio che lei e Jo non sapessero la verità.
"Be', me lo dirai un'altra volta" disse sorridendo. “Ti stavo dicendo... io e Jo siamo troppo diversi.”
Rimase in silenzio.
"Invece tu e io siamo almas gemelas."
Il cuore ricominciò a battermi forte. Non mi attraeva solo sessualmente, come mi poteva attizzavate
una come Teresa. Salomè era speciale: amava la letteratura e le montagne, era creativa e adorava
camminare: faceva fotografie bellissime: la volevo conoscere a tutti i costi e svelare il mistero di
quegli occhi tanto sorridenti, quanto profondamente tristi.
Però non così. Non potevo portarla via a Jo.
“Se vi siete messi insieme ci sarà un motivo, no?”
“Vuoi sapere con che tipo di persona mi vedrei ora?”
"No, non dirlo, ti prego" pensai.
“Con uno come Alex. Uno che mi sappia difendere. Uno coi coglioni, pronto a mordere chiunque
mi giri intorno.”
Non mi sembrava un granché quel tipo. Era rozzo e ignorante per quanto muscoloso. Poi lei scoppiò
a ridere e capii che stava scherzando.
“Lo conosci Zeno?” mi disse all’improvviso.
“Certo, io, lui e Jo eravamo inseparabili ai tempi dell’università! Non te l'ha detto Jo che siamo
cresciuti tutti e tre a Vigolo?”
“Lui mi piace veramente. Prima che partisse per l’Inghilterra ci vedevamo spesso. Zeno, sua
moglie, il loro figlioletto, io e Jo. Uscivamo a cena ogni fine settimana. La sua raffinata eleganza
aveva un incredibile fascino su di me. Non l’ho mai detta questa cosa a Jo, non volevo farlo
ingelosire. Ma tra me e Zeno c’era qualcosa di speciale, un amore intellettuale che non trovo
neanche lontanamente in Jo. A volte mi chiedo come possa essere stata innamorata di lui.”
Mi limitai a fare un cenno con la testa e osservarla mentre si sbracciava per ordinare altre birre.
“Io e Jo parlavamo spesso dei tuoi viaggi. Non vedevo l’ora di vederti dal vivo. Mi ero creata una
certa immagine di te… e vedendoti non sono rimasta delusa, anzi. Dicevano che eri ingrassato e ti
drogavi. E invece sei qui forte e sano, e domani inizi un lavoro che farebbe invidia a molti.”
“La fortuna aiuta gli ottimisti!”
“Esattamente quello che dico sempre a Jo: bisogna pensare positivo! Il tuo sorriso perenne, Luis, è
eloquente più di mille parole" disse col bicchiere in mano. "Secondo me anche tu sei una persona
creativa.”
“Be'..." dissi un po' imbarazzato. In quei momenti, nonostante l'ubriachezza, veniva fuori tutta la
mia timidezza. "Forse la cosa che mi viene meglio è scrivere.”
“A me piace moltissimo leggere. Potresti darmi qualche tuo racconto?”
“A dire la verità non scrivo racconti. Se vuoi posso darti la stronzata che ho scritto prima" dissi
mostrandole il taccuino. "In verità ho sempre in testa un romanzo che forse non finirò mai."
"Di che parla?"
"Di un pesce solo come un pesce.”
Nel locale entrarono una decina di clienti mentre Salomè estraeva un flaconcino dalla borsetta
peruviana e spruzzava nell'aria un po' di patchouli.
“Quindi tutto quello che hai scritto fino a oggi finirà nel tuo romanzo?”
Le presi le mani e la fissai negli occhi. Erano color nocciola ma se li vedevi da vicino notavi
un’infinità di striature curiose. Poi rimirai le sue labbra carnose, mancò pochissimo che la baciassi.
“Io devo esprimere i miei sentimenti. E se l’unico modo in cui posso farlo è scrivere, scriverò
finché campo. Inserirò nel romanzo soltanto la centesima parte di ciò che avrò scritto. E ciò che
avrò scritto sarà la centesima parte di quanto avrò vissuto. Quel romanzo sarà l’essenza dell’essenza
di tutta la mia vita.”
Fu allora che pronunciò le parole che non avrebbe mai dovuto pronunciare. “C’è anche un altro
modo per esprimere i propri sentimenti.”
Non sapevo cosa pensare, cosa dire, cosa fare, quando lei mi sfiorò le labbra con le sue. Tutto
l’alcool che avevo bevuto mi impedì di reagire e mi lasciò immobile, cullato da un bacio, un bacio
che durò un istante, un istante senza tempo.
Quando ci separammo eravamo in un’altra dimensione, come se il mondo intero fosse cambiato in
pochi attimi e nulla potesse essere uguale a prima: qualcosa d'immenso si sprigionò dentro al mio
corpo, provai l’estasi dell’infatuazione, sentii un calore invadermi il cuore e la mente e le gambe e
le mani. Rivolsi lo sguardo ai suoi occhi brillanti. Anche lei mi guardava senza parlare.
“Cosa è successo?” dissi molto lentamente.
“Abbiamo entrambi espresso i nostri sentimenti. È inutile nascondersi” disse lei altrettanto
lentamente, “atras de una estupida ipocrisia.”
“Ma noi non…”
Posò il dito indice sulle mie labbra.
“Salomè, io ha visto te tu vuoi beni di nuovi colleghi! Attenzioni o pure a Longo vieni di infarti!”
Fummo risvegliati da quella voce sgradevole, la stessa voce che poco prima avevo trovato degna di
curiosità. Ci riportò per un attimo nel mondo terreno. Ignorammo entrambi le sue parole senza
voltarci. Continuammo a scambiarci sguardi infiniti per spazio e tempo, assai più eloquenti di fiumi
di stupide parole.
Uscimmo dal locale alle nove. Scendeva qualche sporadica goccia di pioggia. Entrambi senza auto,
decidemmo di camminare: lei nelle clarks grigio topo, io nelle infradito verde-oro. L’accompagnai
sotto casa. Non avevo voglia di raccontarle della mia storia con Teresa. Non mi andava di rovinare
quella serata. La osservai richiudere il portone d’ingresso e mi avviai in una direzione qualunque
calpestando chilometri di asfalto bagnato e puzzolente. Quando tornai era buio pesto. Estrassi la
chiave dalla tasca dei jeans e aprii delicatamente. Salii le scale ed entrai da Teresa. La trovai nel
lettone intenta a leggere una rivista patinata.
“Ti aspettavo per cena, Messner.”
“Adoro quando mi chiami così!” dissi mentre mi spogliavo.
“Non dirmi che hai bevuto?”
“È per durare di più, mammina!” dissi sorridendo.
Lei alzò le lenzuola facendomi ammirare quel ben di dio che si portava appresso.
“Eccomi!” dissi mentre la baciavo. E proprio mentre sfioravo quelle labbra rinsecchite e dure, mi
venne in mente Lei. Presi Teresa, la girai finché fu prona, e la penetrai con passione. Chiusi gli
occhi e pensai a Lei la prima volta che l’avevo vista, soltanto tre metri più su. In jeans, coi capelli
rasta e le treccine che le ricadevano sulla pashmina indiana. Ripensai al suo piccolo seno perfetto
racchiuso dalla dolcevita verde scuro che la faceva sembrare una fata silvestre che profumava di
giovinezza. Mentre la osservavo nei miei pensieri, venni con insolito vigore e caddi nel letto esausto
e soddisfatto.
y
Quel giorno rincasai felice sapendo di aver fatto un favore a un amico. Con la crisi che c’era in
Italia a quei tempi, con tutti i licenziamenti e le cassa-integrazioni, se Luigi riusciva a farsi
assumere, c’era da gridare al miracolo. Mi sarebbe stato riconoscente a vita.
Non nascondo che il fatto di poter finalmente salire al quarto piano al fianco di Salomè mi faceva
fibrillare. Avrei potuto vendicarmi di quel porco analfabeta che mi aveva trattato come un cretino e
che ora cercava di insidiarmi anche la donna.
Iniziai a cucinare alle sette inoltrate. Salomè non era ancora tornata. La provai a chiamare al
cellulare, ma non rispondeva. Mangiai verso le nove con la TV accesa. Lasciai apparecchiato il suo
posto nel caso in cui fosse rincasata affamata. Capitava spesso negli ultimi tempi. Io ero fortunato,
in tutti quegli anni nessuno mi aveva mai chiesto di fermarmi un solo minuto di più a lavorare, e se
qualche volta mi ero fermato, lo avevo scelto io di mia sponte.
Mi addormentai davanti al televisore mentre, dopo una mezzora di zapping tra i vari programmi a
quiz, guardavo la mia serie TV preferita. Narrava le vicende di un medico che si era fatto prete, e
amava fare il detective. Non so perché, ma non riuscivo a smettere di seguirla. Quando perdevo una
puntata o mi addormentavo - per l'appunto -, mi sembrava di essermi perso qualcosa d'importante,
di non essere più agganciato al resto del mondo.
Sentii la porta chiudersi. Aprii gli occhi. Fissai l’orologio sul muro. Erano le ventitré suonate.
Salomè barcollando venne a baciarmi con un alito di birra che non le avevo mai sentito addosso
prima di allora.
“Mi hanno obbligata a fermarmi a lavorare fino alle nove. Il capo era così soddisfatto che ci ha
invitati a cena” disse sorridendo come una stupida.
“Perché non mi hai avvertito? Chi c'era a cena? Chi ti ha accompagnata a casa a quest’ora?”
“Ho preso un taxi.”
“Ti sarà costato un occhio della testa! Non potevi prendere un tram, oppure chiamarmi?” dissi con
la voce più antipatica che riuscivo a fare.
“Ho speso sedici euro e cinquanta di taxi però sono stata a cena gratis” disse come niente fosse.
“La prossima volta avvertimi” dissi arrendendomi all’idea che non si poteva ragionare con
un’ubriaca. “Andiamo a dormire?”
“Ho voglia di scopare, Jo!”
“Io no” dissi acido.
Lei non mi degnò di uno sguardo.
La raggiunsi e la presi per un braccio.
“Lo sai amore che ho quel problemino…"
Lei mi guardò con cattiveria.
"Non riesco a baciarti con quell’alito lì!” dissi per vendicarmi di quello sguardo.
“¡Que tonto de mierda!" disse prendendosi il capo tra le mani. "Tampoco bueno de hacerme feliz:
joder tio, no eres un hombre, eres un puto hermano!”
“Brava brava, continua così! Sfottimi! Esci la sera coi tuoi colleghi del quarto, brava! È così sì che
risolverai i problemi?”
“Vete a la mierda, Jo” disse riprendendosi per un attimo dalla sbornia. “Cuando empezeràs a ser
feliz? Carpe diem, carajo!”
Non avevo capito molto. Eppure era chiaro che, qualunque cosa avesse detto, aveva ragione lei. A
quel tempo ero troppo stupido per ammetterlo.
Avevo paura di perderla. Temevo che smettesse di amarmi.
Forse meritavo una donna meno bella, ma che avesse voglia di costruire qualcosa di duraturo:
volevo un figlio e Salomè non ne voleva sapere, volevo sposarmi e per lei era solo uno stupido
capriccio: sopportavo perché l’amavo e non potevo fare a meno dell’amore che provavo per lei.
La raggiunsi a letto.
Erano mesi che dormivamo assieme ogni notte senza mai consumare. L’amavo, ma non avevo
un’erezione degna di tale nome da tempo. Andammo insieme dall'andrologo. I risultati erano chiari:
non avevo nessun problema di tipo fisico, si trattava di impotenza psicologica. "Le cause possono
essere le più svariate" ci spiegò il medico, "la più probabile è lo stress. A volte è il complesso di
inferiorità dentro e fuori la coppia. A volte addirittura il contrario. Non c'è modo di saperlo." Ripeté
più volte che si trattava di una cosa temporanea.
Quella sera ero deciso a provarci. Mi spogliai fino a rimanere completamente nudo. M’infilai nel
letto. Anche lei era nuda. Mi avvicinai fino a respirare il profumo dei suoi capelli. Le appoggiai una
mano sulla spalla. La girai verso di me e mentre la baciavo notai che aveva pianto.
Mi prese forte per le spalle e mi girò. Poi con un balzo mi venne sopra il bacino. Io non ero ancora
pronto. Appena lo notò sbuffò. In me qualcosa non andava.
Decisi di usare una mano. Lei cominciò a dimenarsi con gli occhi chiusi cercando di raggiungere un
orgasmo che aspettava da chissà quanto tempo. Cercai di fare il possibile per renderla felice. I
minuti passavano e lei non si fermava. Avevo un crampo ai muscoli della mano. Soffrivo
terribilmente mentre la osservavo nella penombra fissare il soffitto e dimenarsi come non faceva da
anni.
Non mi dette nemmeno un bacio. Non mi guardò neanche un istante. Rimase con la testa
all’indietro e gli occhi sempre chiusi finché venne.
Venne gridando così forte che, nonostante l'ora tarda, ero certo l’avesse sentita anche mia madre al
piano di sotto.
Ero riuscito finalmente a renderla felice. Un istante.
x
“Eccomi, capo” dissi aprendo la porta senza bussare.
“Ti avevo detto alle nove. Sono quasi le nove e mezza.”
“Eh sì, le nove e mezza. È vero" dissi grattandomi la nuca. "Non c’è la mezzorettina accademica da
queste parti, capo?”
Non rispose.
"Mi sto allenando per i ritmi sudamericani" aggiunsi.
Niente.
“Questo è il contratto" disse dopo un po'. "Dacci un’occhiata veloce e firmalo, che poi
cominciamo.”
Non lo lessi nemmeno e firmai di getto tutte e quattro le copie, tenendone una per me.
“Fatto.”
“Bene, mi piacciono le persone rapide” disse spegnendo il sigaro nel posacenere. “Ora sarai
affiancato da un nostro dipendente che si occupa dei contatti con l’estero. Ti affiancherà il primo
mese, dopo di che sarai pronto per lavorare in autonomia” disse osservando probabilmente i miei
capelli sconnessi. “Quando ti spediremo in Brasile ti voglio un po’ più elegante, ok?”
“No problem, sior” buttai lì senza troppa convinzione. “I’m ready to start!”
L’infiocchettato prese il telefono sbuffando e compose un interno.
“Tutto bene, grazie. Puoi venire qui un attimo?”
Dopo una ventina di secondi, durante i quali avevo osservato gli orrendi quadri alle pareti,
bussarono alla porta.
Era Lei.
Non avevo mai creduto al destino, ma senza volerlo cominciavo a crederci. Aveva una gonna
arancione da contadina, lunga fino alle caviglie. Una dolcevita beige e una collana infinita avvolta
almeno tre volte attorno al collo. Orecchini in ebano di grandi dimensioni. Ai piedi le solite clarks
grigio topo.
“Salve” disse sorridendo.
“Salve, collega” dissi facendole l’occhiolino.
“Lei è Salomè. Dovrai osservarla per otto ore al giorno senza mai perderla di vista. Ok, sior?”
“Più che volentieri, capo.”
L’incravattato scrollò la testa. “Salomè, dagli una regolata. Questo qua ha ancora la testa on
holiday. Ok girl?”
“Nessun problema!” disse. “Sarà un piacere! Possiamo andare?”
“Andate in guerra!” disse ridacchiando forte mentre estraeva l’accendino dal taschino. “Andate in
guerra.”
“È un po’ suonato, no?” dissi mentre camminavamo verso l’ufficio.
“Guarda che adesso è il tuo capo! Attento a quello che dici!”
“Hai ragione, chica! Pausa coffee?” dissi di slancio.
“Meglio se cominciamo a lavorare, sono quasi le dieci e non ho ancora combinato niente.”
“Ti è per caso venuta la giovannite?" dissi prendendola sotto braccio. "Dai vieni, oggi tocca a me
offrire.”
Non mi andava per niente di bere un caffè, né tanto meno di spendere dei soldi, ora che ero
diventato bravo a risparmiarli – salvo l'esosa, ma indimenticabile, nottata precedente.
In quel momento, pur di parlarle, avrei dato un intero stipendio.
“Cos’hai combinato ieri sera poi?”
La domanda mi sorprese.
“Sono tornato nel mio appartamento e ho continuato a bere con gli studenti che ospito” dissi restio.
Non mi andava di mentirle. “La verità è che…”
“Lo so.”
Come faceva a saperlo? “Come fai a saperlo?”
“Lo sospettavo da giorni” disse spiazzandomi. “Da quando sei passato a casa nostra, la mamma di
Jo non ci ha più rotto le scatole, neanche una volta."
Prese il caffè dalla macchinetta e iniziò a mescolare.
“Non ho collegato le due cose finché un giorno Jo, mentre parlavamo di te e Zeno, non si è fatto
scappare una frase del tipo di nuovo colpa di quel figlio di puttana o qualcosa di simile. Capii che
ce l’aveva con te. Null’altro. Ma un pensiero intrigante mi passò nella mente senza più
abbandonarmi."
Sorrisi imbarazzato. Probabilmente grattandomi la nuca come al solito.
"Così ieri sera quando tu mi hai lasciato a casa, mi sono fermata alla finestra del giroscale a
osservare la pioggia che cadeva.”
“Forse dovrei tagliare...” dissi un po’ imbarazzato.
“Perché? Non c’è niente di male. Non devi vergognarti.”
"Non si tratta di intesa intellettuale ovviamente, ma di attrazione sessuale. Quando sarò stufo me ne
tornerò dai miei coinquilini. Nel frattempo ho già subaffittato il mio letto” dissi in tutta sincerità.
“La cosa che mi schifa è l’inganno nei confronti di Jo. Io gli voglio bene, non mi va di ferirlo.”
“Speravo lo ammettessi” disse prendendomi una mano. “Lui ha bisogno di te. Crede in te e ti stima,
anche se non lo dà a vedere. Gli sei mancato.”
In quel mentre passò Alex e ci fece un occhiolino. “Io muti come pesci.”
Lo ignorammo ancora.
“Hai ragione. Vado giù subito.”
“Io cercherò di coprirti al lavoro, ma fai presto. Sono le dieci e mezza. Di questo passo ci
licenziano!” disse lasciandomi la mano.
"Adii, amici di letti di Salomede!" sentii gridarmi alle spalle.
x
Al terzo c’era una forte puzza. Non si respirava.
Da secoli non si poteva fumare nei luoghi di lavoro in Italia, eppure laggiù vedevo decine di
sigarette brillare rosse nella semioscurità. Alcune luci al neon funzionavano, ma l’ambiente era
comunque tetro. Da vicino percepivo l’odore acre di sudore che emanavano quei personaggi sudici
e sdentati.
“Salve, posso sapere dove si trova Giovanni?”
“Chi no ghè nesun Zoani” disse un vecchio mentre era al telefono.
“Impossibile. Lavora qui da parecchi anni.”
“E lù chi élo po'?”
“Sono nuovo, lavoro al quarto” dissi allungando la mano destra, “Luigi Alberti, piacere.”
Il vecchio fece un grugnito e tornò al telefono.
Girai tra i banchi da lavoro senza trovarlo.
“Scusate, non è su questo piano l’ingegner Giovanni Longo?” gridai nel nulla.
“T'hai dit Longo? El dotor?”
Annuii e loro mi indicarono la direzione da seguire. Vidi una scrivania lontana dalle altre, posta
contro un muro perimetrale. Giovanni era intento a battere velocemente le dita sulla macchina da
scrivere.
“Ehi, vecchio Jo” dissi mettendogli una mano su una spalla. “Come butta, fratellino?”
“Che ci fai qui?” disse una volta ripresosi dallo spavento.
“Non te l’ha detto Salomè? Sono stato assunto! Al quarto!” dissi sinceramente contento di lavorare
nel suo stesso palazzo.
La notizia lo sconvolse. Più di quanto immaginavo. Si rabbuiò improvvisamente.
“Tutto bene, Jo?”
“Certo” riuscì a dire. "Certo."
“Ti dovrei dire una cosa… c’è un posto dove bere un caffè?”
“Sto lavorando, non vedi?”
“Ci vorranno dieci minuti.”
“Andiamo in bagno, seguimi” disse alzandosi di scatto.
“In bagno?”
“Quaggiù non sono previste pause e di conseguenza neanche strutture adatte a uno scambio di…”
Lo lasciai parlare in quel gergo grigio e formale.
“Hai voglia di ascoltarmi o me ne devo andare?”
“Facciamo presto, non posso lasciare la scrivania incustodita. Aspetto delle telefonate importanti
stamani.”
"Importanti?" pensai.
Ci chiudemmo nei luridi bagni del garage dove ci avvolse una puzza stomachevole. Mentre
combattevo con un conato di vomito, Jo controllò che il cesso fosse vuoto e parlò.
“Ti hanno messo al quarto?”
“Sì, pensa che storia. A me che non me ne frega niente, che tra un anno me ne vado affanculo, mi
danno un cazzo di lavoro da millecinque, e a te che vorresti solo…”
“Millecinquecento euro?” disse incredulo. Vidi le vene del collo che gli si gonfiavano.
“Sì, ma te l’ho detto, è solo per tirare su un po’ di soldi, non me ne frega un cazzo” dissi alzando le
spalle. “E poi devo superare un periodo di prova di tre mesi...”
Cercò di darsi una calmata, ma era teso e incazzato.
“Formalità. Qui dentro è tutto scartoffie e burocrazia. Non sanno neanche chi siamo noi lavoratori.
Per loro siamo insiemi di numeri, non esistono i meriti del singolo. Siamo solo i dipendenti del
terzo, i dipendenti del quarto, e così via” disse a denti stretti.
Fece un lungo respiro.
“Te lo meriti dopo quello che hai passato, mi riferisco alla droga e al giro di prostituzione nel quale
eri immischiato…”
Parlava per rabbia.
“E la sai la cosa più divertente?” dissi tornando a sorridere, “lavorerò fianco a fianco con Salomè!”
“Che cazzo dici?”
“Nel curriculum che mi hai detto di allegare avevo scritto, tanto per ridere, che sapevo anche il
portoghese. La cosa incredibile è che era praticamente l’unico requisito, oltre alla laurea, che
interessava a quello stronzo del capo” dissi dandogli una pacca sulla spalla.
Jo rimase per un attimo in silenzio. “Sei il-solito-fottuto-ignorante-baciato-dal-destino” scandì
lentamente.
Abbozzò un sorriso.
“È quello che mi ha detto anche Salomè!”
Il sorriso scomparve dal suo volto.
“A proposito” disse facendosi terribilmente serio. “Prova a sfiorarla e ti taglio le palle.”
“Qua la mano, Jo, io non tradisco un amico” dissi dicendo addio a Salomè e ai miei sogni di gloria.
“Finché si tratta di mia madre ci posso anche stare, ma non toccare Salomè, hai capito?”
“Ok ok, stai tranquillo, è tutta tua!” dissi stringendogli ancor più forte la mano e abbracciandolo.
Sono certo che pensava se si fotte mia madre, non si potrà di certo fottere anche la mia ragazza.
“Ora scappo di sopra. Già che ci sono ne approfitto” dissi mentre mi calavo la cerniera dei jeans.
“Ci vediamo stasera?”
Lo osservai mentre estraeva dalla tasca un plico di fogli giallognoli.
"Cos'è quella roba?"
"Niente niente" disse mentre viola in viso li spingeva a fatica di nuovo in fondo alla tasca.
“Vieni da noi a cena" disse quando ebbe finito, "e porta anche mia madre! Io torno al lavoro.”
“A stasera, grazie di tutto, Jo.”
y
Avere visto Alex salire di livello al posto mio, fu un colpo che, anni dopo, non avevo ancora
digerito. Mentre lui e Luigi si stavano pavoneggiando davanti a Salomè su al quarto, io galleggiavo
in un perenne apprendistato, dove però, anziché imparare, disapprendevo quel che avevo imparato
in duri anni di studio: ero un cavallo di razza che trainava l'aratro dei Signori dell'Azienda.
Un giorno, dietro una mattonella del bagno, trovai un manoscritto ricoperto di muffa che mi aprì la
mente sconvolgendomi la vita.
Erano le 9,33 in punto e, come ogni mattina, mi recai a defecare. Al solito, il bagno era lurido. Non
lo pulivano mai. Dei cinque vespasiani a muro ne funzionavano due. A me non importava, non li
usavo. Amavo sedermi – non prima di averlo pulito a sufficienza – sull'unico water dotato di porta,
anche quando dovevo pisciare. Non riuscivo a farla sapendo che chiunque poteva entrare
all'improvviso. In basso, quasi ad altezza terra, c'era una mattonella esattamente uguale alle altre,
ma dal profilo sbeccato. Mi incuriosiva da sempre, ma non ci avevo mai messo mano. Mi veniva da
vomitare al solo pensiero di sfiorare il pavimento. Quel giorno mi armai di carta igienica e provai a
sfilarla. Dietro c'era un manoscritto, anch'esso lercio e umido. Quando riposi al suo posto la
mattonella, da fuori già battevano pugni assordanti.
"Chi è ghe mete sì tant a cagar fòra en stronzo? Set, ti, Zoani?"
"Ho finito, arrivo" dissi accorgendomi di quanto stonasse il mio perfetto italiano in quella sordida
situazione. Mi alzai, infilai con molta fatica il manoscritto in tasca e uscii.
"Ah, ben, eco! No l'è miga tuo 'l cièso, dotor!"
Quel pomeriggio Luigi passò in garage. Oltre a darmi un sacco di dispiaceri a parole, mi sconvolse
con un'immagine che impiegai anni a scacciare: vidi per la prima volta il suo pene mentre lo
estraeva per urinare.
Una volta a casa potei finalmente estrarre dalla tasca il manoscritto. Era impregnato di umidità: lo
asciugai col fon. Trattavasi di un romanzo breve, una settantina di pagine. Non ricordo bene come
iniziasse, ma questo è più o meno il finale:
Dopo una vita, l'apprendista si rende conto che l'azienda continuerà ad affidargli le mansioni che gli
ha sempre affidato. Per i neoassunti è diverso, loro sono sicuramente destinati al lavoro vero, quello
in alto: i ragazzi nuovi diventeranno impiegati, mentre lui, l'eterno apprendista, resterà bloccato
nella sua posizione per un tempo indeterminato, di qui all'eternità. Eppure non li invidia. Per niente.
Certo, invidia la loro posizione, ma non li invidia come persone. Lui è diverso, non è una pecora: è
un pastore di razza. Ma ormai lo sa, la sua condizione è quella di uno pseudo-apprendistato senza
futuro: è in una scuola senza lezioni, senza esami, senza diplomi: si sente in scatola. Hanno fatto di
lui un apprendista permanentemente occupato a non apprendere. Produttivo e generoso. Disponibile
ad assumere qualunque forma gli venga richiesta, e, in quella forma provvisoriamente assunta, è
capace di agire come fosse vera. Non ci crede veramente però, sa che lui non è quella forma. Ma
finge di crederci. La sua natura è ben altra cosa, crede, o pensa di credere, o crede di pensare di
credere: non si ascolta nemmeno più. Non è in grado. Ha paura ad ascoltarsi. L'apprendista si sente
portare lontano dai pensieri, eppure è sempre lì, immobile. A volte gli diventa estremamente
difficile lavorare: corre in bagno e piange: ogni cosa che fa gli pare conclusa in sé, limitata,
spogliata di qualunque senso o logica che lui possa intuire e utilizzare per la propria vita, quella
vera: la vita che non c'è. Nessuna delle cose che fa lo aiuta a vivere nel mondo. Al contrario, tutto,
da quando timbra a quando stimbra, gli sembra sottrazione di tempo e fatica alla vita vera: anche se
nemmeno lui sa dire, in verità, dove sia, questa maledetta vita vera, questo sogno impossibile. Alla
fine decide di smettere di pensare. Finalmente apre gli occhi: è sempre lì, immobile: adesso forse ha
capito, ma nulla è cambiato, nulla.
Questa storia inquadrava magnificamente me e il mio futuro magnifico.
L'autore doveva essere una persona colta e sensibile: qualcuno di grande era passato di lì e aveva
vissuto il mio stesso incubo. Questa scoperta mi faceva sentire, al contempo, orgoglioso e disperato.
Chissà che fine aveva fatto, forse era salpato sulla prima nave di passaggio da Trento, arruolandosi
come mozzo giulivo, verso orizzonti lontani. Una cosa è certa: lui ce l'aveva fatta, era riuscito a
evadere. Se ce l'aveva fatta lui, potevo farcela anch'io, mi dissi a più riprese.
Ero ancora assorto nei pensieri, quando suonò il campanello. Era Salomè. Mi baciò allegramente e
andò a farsi una doccia. Decisi che non avrei confidato a nessuno quel segreto, nemmeno a lei.
Cinque minuti più tardi Salomè mi raggiunse sul divano e mi baciò.
Bussarono alla porta.
“Ciao mamma, fatti baciare.”
“Sì, Giova, abbracciami!”
“Salve, signora Teresa, si accomodi.”
“E Luigi?”
“È andato a prendere un paio di bottiglie.”
Mia madre si accomodò sul divano.
“Ti va un tè, mamma?”
“O preferisce un cioccolatino?”
“Calmi, ragazzi, adesso arriva il nostro Messner con dell’ottimo vino bianco, fresco di cantina.”
Era sempre più bella mia madre. Non invecchiava mai. Passare le mattinate in piscina e i pomeriggi
in palestra le faceva bene. Aveva due gambe da trentenne e le spalle larghe e dritte.
“Eccomi” disse Luigi. “Stappiamo? Bla.”
“Certo, caro, ti stavamo aspettando con ansia.”
Ridemmo tutti. Eravamo una grande famiglia. Un po’ strampalata, lo ammetto, ma pur sempre una
famiglia, a modo nostro.
Non mi piaceva che Luigi prendesse il posto di un padre che non avevo mai avuto: ma in fondo chi
meglio di lui rappresentava una guida spirituale dalla quale attingere, o cercare di attingere, pillole
di saggezza? Avevo ritrovato il mio migliore amico e stavolta nessuno ci poteva separare. Né mia
madre, né tanto meno Salomè.
“Raccontatemi di Zeno. Come mai ha deciso di partire? Bla bla.”
“Luis, ci prendi in giro? Se avessi potuto, me ne sarei già tornata a Madrid!”
Vidi mia madre storcere in naso impercettibilmente. La stessa cosa che, con tutta probabilità, feci
pure io.
“Ah, eres de Madrid? Credevo abitassi a Granada. Bla bla bla.”
“E tu come lo sai, brutto bastardo?” intervenni.
“Sì, maschione mio, come fai a saperlo?” disse mia madre stando al gioco.
“Ragazzi, si dà il caso che io e Salomè si lavori fianco a fianco, anche se io, a dire il vero, non me la
sto lavorando proprio per niente! Bla bla bla bla” disse Luigi cercando di farmi ridere.
“Sì, e il problema è che tu invece di lavorare continui a spostare il discorso sulle nostre feste:
Pamplona, Cadiz, Valencia, Granada… le conosci meglio di me!” disse mettendogli una mano tra i
capelli.
“Che ci devo fare, ragazzi? Non mi è mai piaciuto lavorare! Bla bla bla bla bla.”
Ridemmo ancora tutti. Versai nei calici dell’altro vino.
“Ho abitato a Granada en la casas cuevas fino ai diciott’anni, poi mi sono trasferita a Madrid per
l’università. Che tempi!” disse Salomè alzando gli occhi. “Poi la nostra mitica azienda mi ha
assunta e io, brava stupida, mi sono fatta trasferire qui in Trentino!”
“Hai fatto bene, amore” dissi abbracciandola da dietro, “altrimenti non ci saremmo mai conosciuti!”
La baciai davanti a Luigi e a mia madre, e questo mi diede sicurezza.
“Chi cucina?” disse Salomè.
“Ma sono già le nove!” disse Teresa scuotendo il capo. “Salomè, non sarai mai una mogliettina coi
fiocchi.”
“Ben contenta di non esserlo!” disse lei ridendo. “In Spagna si cena alle undici, signora Teresa.”
“Quando io e Giovanni stavamo ancora in paese, alle sette avevamo già sparecchiato la tavola e
lavato i piatti. Ti ricordi, Giova?”
“Amavo la vita di paese, mamma. Non ho mai capito perché ci siamo trasferiti...”
“Per dimenticare, caro. Per dimenticare” disse mia madre con lentezza.
Calò il silenzio e con esso un certo imbarazzo.
“Dai, oggi cuciniamo io e Luigi!” dissi per rompere il ghiaccio.
“Sì, oggi tocca a noi uomini! Bla bla bla bla bla bla.”
Salomè e mia madre si guardarono e risero sonoramente.
“Esistono anche i telefoni e le pizzerie a domicilio” disse mia madre mentre cercava un’intesa con
Salomè.
“Lasciateci fare, donne di poca fede!” dissi mettendo il braccio sopra le spalle di Luigi.
La serata filò liscia e gioiosa. Avevo fatto finalmente pace col mondo e mi sentivo, una volta tanto,
leggero e spensierato.
Luigi se ne andò poco dopo mia madre, sussurrandomi all'orecchio una frase che, dopo una serata
così, a me suonò sconvolgente: "Odio questa inutile vita borghese del cazzo." Sorrise. Poi mi disse
sottovoce: "Amala. È lei il senso di tutto." Si girò e andò per la sua strada.
Spesso mi viene il dubbio di essermelo sognato. Però i bla bla bla erano reali, di questo sono certo.
Ripensandoci ora che sono trascorsi decenni, in quella frase c'era tutto il suo credo: odiava la mia
vita, il mio lavoro, la mia casa perfetta, l'odore di pulito, la mia pseudo-relazione con Salomè:
l'inutilità di una serata allegra passata a chiacchierare del nulla. Ma, più di tutto, odiava il tempo che
scorreva inesorabile. Questo intendevo qualche riga più su, quando dicevo che i bla bla bla erano
reali: infinitamente più reali di quella intera serata che agli occhi di Luigi dovette essere nient'altro
che una farsa.
x
Le settimane passarono veloci.
Fui confermato in azienda a titolo definitivo.
Mi recai a Rio in missione. Alloggiavo in un hotel a quattro stelle sulla spiaggia, pensione
completa. Svolsi alla bene-meglio il lavoro e rimasi qualche giorno in più a godermi il sole e le
belle donne.
Al ritorno il capo mi accolse nel suo ufficio entusiasta. Come promesso mi alzò di livello. Non
erano passati sei mesi dal colloquio ed ero già al quinto piano con uno stipendio che, grazie alle
trasferte, sfiorava i duemila e cinque, mentre Salomè rimaneva al piano inferiore, e il vecchio Jo giù
nel garage.
Guardarlo in faccia mi imbarazzava. Notavo in lui un malessere dovuto certamente alla mia
presenza. Mi voleva bene come a un fratello, ma la rabbia gli rodeva il fegato. “Tranquillo, Jo, tra
un po’ me ne vado” avrei voluto dirgli. Chissà come l’avrebbe presa?
Nonostante avessi bisogno di denaro per realizzare il mio sogno, decisi di staccarmi da sua madre e
tornare a vivere nel mio appartamento, che negli ultimi tempi avevo affittato in nero per ottocento
euro al mese a un paio di matricole universitarie.
"Non ceni?"
"No, ragazzi, grazie" dissi. "Ma se volete prendete pure gli avanzi di ieri: riso in bianco e verdure."
"Grazie, ma, lo sai, siamo più carnivori."
"Se mi cercate sono in biblio! Ciao!"
"Ciao, Luigi, verremo senz'altro..." dissero ridendo.
A pranzo mi ingozzavo al ristorante dell’azienda senza spendere una lira. Basta birre, basta cinema,
basta pizze con gli amici. Dovevo tenere duro e accumulare i soldi in fretta.
"Non ti trombi nessuna oggi?" disse uno di loro mentre mi mettevo le scarpe. "Se vuoi ti do il
cambio io?"
"Avrei in mente qualcosina per te..."
"No, stronzo, ho capito quale!" disse alzandosi. "Ancora non capisco come ti si drizza con una
così!"
Facevo sesso come un forsennato. Passavo dopo il lavoro da Teresa e il week end andavo con le
studentesse dell’università, belle o brutte che fossero, me le facevo piacere. Spesso mi offrivano la
cena. E, se proprio erano cessi con due gambe, mi bastava chiudere gli occhi e pensare a Salomè e a
quel magnifico culo che si portava appresso.
“Che ne pensi?” dissi a Salomè osservandola da dietro il vetro.
“Il problema non è cosa ne penso io, è cosa ne pensa lui!” disse tenendosi il viso tra le mani e
sbuffando. “Lo sai che non me lo perdonerebbe mai.”
“Non CE lo perdonerebbe mai!” dissi sorridendo.
“Vieni dentro dai.”
Entrai nel suo ufficio che mesi prima era stato anche il mio. “Niente da fare quindi? Lo dico al
capo?”
“Aspetta, vieni qui.” Mi prese le mani e le posò sulle sue guance fredde. Sbuffò ancor più forte. “A
volte vorrei che esistesse la bigamia” disse senza sorridere.
Era ancora attratta da me, e questo mi dava sicurezza. Ero felice. Non solo in quell’istante, anche
negli ultimi tempi. Assaporare un po’ di stanzialità, avere uno stipendio fisso e remunerativo (una
volta tanto!), farmi un viaggetto di lavoro due o tre volte al mese, scopare un po’ qua un po’ là,
cominciava a piacermi.
“Vaffanculo, accetto!”
“Vado su al quinto a dirlo al capo" gridai. "Tu senti quel coglione di Alex, è lui che si occupa delle
missioni all’estero. Non fare caso ai suoi commenti. Ci vediamo da Jo?”
“Aspetta un attimo. Quel gran cazzone l’hanno messo al quinto al reparto logistica?” disse lei.
“Così dicono!”
“Ma se è analfabeta?”
“Quello con due parole li gira e li rigira tutti come vuole!”
“Io di Alex di belli di parlare setti di lingue di capaci!” gridò lei.
“Dai che se ti sente ti ammazza!” dissi guardando fuori dal vetro e pensando a quanto fosse
simpatica. “Dicono che una delle sue mogli una volta gli abbia messo le corna…”
“Ben gli sta a quel porco!” disse lei digrignando i denti.
E poi: “Mogli hai detto?”
“È una lunga storia…”
“E lui come ha reagito?”
“Dicono l’abbia ridotta alla prostituzione” risposi senza più sorridere.
“Ah" disse.
"Così dicono."
"Quell’Alex mi fa paura, Luis!”
“Ma se ci sei andata a letto!"
"Appunto" disse agitata.
La abbracciai.
“E comunque non proprio a letto… veramente stavamo nei bagni del quarto…”
“Complimenti!” le dissi baciandola sui capelli. "E com'è messo?"
"Ne ha da vendere" disse, "e saprei anche a chi..."
Poi sbuffò. Infine sorrise.
“Il problema è che quel coglione mi palpa il culo ogni volta che passa! E tu?”
Lo disse senza lasciare dubbi.
“Lasciamo perdere” dissi sviando la conversazione. “Chi lo dice a Jo? Se lo faccio io mi butta fuori
a calci!”
“Se ne farà una ragione” disse alzando le spalle.
“Magari può venire anche lui in Brasile con noi, no?” dissi senza convinzione. “Si potrebbe
prendere due settimane di ferie.”
“Luis” disse ai miei occhi attenti, “andiamo soli.”
Z1 settembre
“...dovevamo scrivere un romanzo che parlasse della vita, dei viaggi, del lavoro, e invece tu lo stai
facendo diventare un feuilleton” dissi.
Giovanni fece una faccia stranita.
"Intendo un romanzo d'appendice..."
Abbassò allora lo sguardo. Non sopportava di essere considerato ignorante.
"Taci, Zeno, tu non hai ancora detto niente di te, hai solo scritto parodie di me e Luigi o sedute di
meditazione!”
“Hai ragione, però...”
Non sapevo cosa dire.
“Zeno, sai bene anche tu che, purtroppo o per fortuna, le cose sono andate proprio così...” disse
Giovanni. “Sto solo drammatizzando i fatti.”
"La realtà che supera la fantasia" pensai.
“Va benissimo quello che stai scrivendo, Giovanni" dissi. "È avvincente, pieno di dialoghi,
passionale. Il problema è che contagi Luigi. Credo che lui non volesse parlare di certi fatti
spiacevoli che ti riguardavano. Ma quando ha capito che tu non avevi tabù, ha cominciato a andarci
giù di brutto” dissi accorgendomi solo ora di essere in preda ai fumi dell’alcool.
Mi versai un altro bicchierino.
Era l’anniversario del mio divorzio. Non ero triste. La vita solitaria mi era sempre piaciuta. Anzi,
ero contento che Maria si fosse risposata. Parlavamo più ora che in tanti anni di matrimonio.
“E ha fatto bene.”
"Come?" dissi mentre Giovanni me ne versava un altro. “Basta, ti prego, sono già totalmente fuori.”
“Bevi, Zeno, ti fa bene! Lo vedi come sei loquace?”
Rimanemmo in silenzio a riscaldarci al sole delle due.
“Ehi, ragazzini, che state combinando?” gridò Luigi accorrendo in sedia a rotelle. “Non si può
neanche cagare in pace al giorno d’oggi?”
“Scendi dall’automobile e vieni qui” dissi sghignazzando.
“Che ti sei bevuto, Zen? Non ti udivo eloquire con cotal sicurezza dalla presentazione della tesi,
circa mezzo secolo fa!” disse sedendosi a fatica sulla solita sedia. “Visto che bella giornata?”
“Oddio si mette anche a parlare del tempo adesso” dissi versandogli del vino in un bicchiere vuoto.
“Lo sai che eloquire non esiste?"
"E chi se ne importa?" disse. "Ho appena coniato un neologismo, che male c'è?"
Feci un brindisi.
"Al mio matrimonio!"
"Dovresti bere più spesso!" sbottò Luigi scoppiando a tossire sangue.
"Stavo dicendo a Giovanni che state diventando sdolcinati. Il lavoro deve rimanere il tema centrale
del libro: non l’amore o la tua storia di sesso con la sua defunta madre, pace all’anima sua.”
“Guarda che è stato lui a tirarla fuori" disse smettendo per un attimo di tossire. "E tu? Ti decidi a
iniziare la tua autobiografia o continuerai soltanto a prendere appunti?"
“Queste discussioni creative vanno trascritte, se no a che servono?” dissi mentre cercavo di
annotare quanto avevo appena detto. Impossibile. L’alcool mi girava in testa vorticosamente. Decisi
che per quel giorno poteva bastare. “Cerchiamo di tornare sui binari. Tu, Luigi, devi cominciare a
descrivere l’organizzazione della tua fuga, mentre tu, Giovanni, devi parlare della tua rincorsa a
quel benedetto quarto livello. Solo così portiamo avanti la trama: altrimenti crepiamo prima di
finirlo ‘sto romanzo!”
Non avevo più voglia della solita sciava del Brusafèr o meglio The Slave Of Burn-Iron, come la
chiamava Luigi. Appoggiai carta e penna sul tavolo e stappai una bottiglia di rosso, un ottimo
Marzemino d'Isera. Preferivo piangere lacrime superiori.
x
“Che cazzo vuoi che ti dica, Luigi? Andate, fate quel cazzo che volete: cosa conta il mio parere?”
Pausa per ricaricare i polmoni. “Un cazzo! Non conta un emerito cazzo!”
“Non è stata una mia idea” gli dissi asciugandomi il mento con l’avambraccio. “Il capo mi ha detto
di farmi accompagnare da uno del quarto.”
“Appunto, da UNO del quarto, non da UNA, e per di più la fidanzata del tuo migliore amico!” disse
alterandosi. “Sei una merda, Luigi! Sei una merda!”
“Guarda che è un viaggio di lavoro, Jo. Prenditi ferie e vieni con noi, invece di incazzarti.”
“Luigi” disse ignorandomi, “ti ho trovato un lavoro, ti ho permesso di andare a letto con mia madre.
Con cosa mi ripaghi?” Singhiozzò. “Te ne vai quindici giorni con la mia fidanzata in Brasile e
pretendi che sia felice? Sai benissimo che non posso prendermi ferie da una settimana all’altra…”
Lo lasciai sfogare.
“…perché non sei più sincero come una volta?”
Quelle ultime parole mi pesarono per anni sul cuore, anche se finsi di non averle accusate.
“Senti, è un’ottima opportunità per lei. Se otteniamo il finanziamento che abbiamo richiesto, potrei
proporre Salomè per il quinto. È un’opportunità che non può rifiutare.” Lo guardai per un attimo
prima di proseguire. “Se a te una bella ragazza del quarto ti dicesse di andare con lei a Cuba un paio
di settimane e ti dicesse che se accetti probabilmente entreresti a far parte dello staff del quarto,
accetteresti?” Mi fermai ancora per sottolineare la solennità del mio discorso. “Certo che lo faresti.
E allora perché non glielo permetti? Vuoi stroncarle la carriera? Se hai le palle prenditi ‘ste cazzo di
ferie e vieni con noi.”
Erano parole alle quali non credevo nemmeno io.
Ero accecato dall’infatuazione. Mi girai a guardare Salomè seduta sul divano nella posizione del
loto e incrociai il suo sguardo.
“Fuori di qui, pezzo di merda!” sbraitò Jo.
Me ne andai a fottermi sua madre senza neanche salutare. Tra un amplesso e l’altro le spiegai la
faccenda a modo mio.
Anche lei mi sbatté fuori senza pensarci due volte.
Banda di antiquati, sfigati, timorati di Dio! Mi avevano entrambi scaricato.
Camminai nella notte d’asfalto senza rincasare. Le luci gialle dei lampioni mi soffocavano. Entrai
nel primo bar di vecchi e mi scolai tre grappe di fila. Forse aveva osato troppo. Avevano ragione
loro, volevo solo andare a letto con Salomè. Peggio: forse ero innamorato.
Piangevo a causa di un sentimento che non avevo mai provato. E non potevo innamorarmi di quel
sentimento. C’era di mezzo un amico. Avevo sempre odiato l’amore. Anzi, avevo sempre pensato di
odiarlo, ma in realtà non si può odiare l’amore, è più forte della voglia di scappare.
Mi ero innamorato: era ora di scappare prima che diventasse amore.
Z2 settembre
Lo vedevo invecchiare di giorno in giorno. Non sarebbe durato molto. Pensavo a lui non come a un
vino barricato, ma come a un chicco d'uva in decomposizione.
Preso dai sensi di colpa per il pensiero maligno, mi alzai per abbracciarlo. Poi mi risedetti, senza
averlo abbracciato.
“L’altro giorno, Jo, mentre leggevo il tuo manoscritto mi venivano le lacrime.”
“Luigi, ti senti in colpa per avergli fregato la ragazza?” mi scappò di bocca.
“Sono passati quarant’anni, Zen” disse Luigi sfiorandomi con occhi grigi. "E comunque non è
andata così, vero?"
Giovanni annuì. Sembrava volesse prendere la parola.
“Mi fa bene scrivere" disse dopo un po'. "Tutti dovrebbero farlo prima di morire.”
Fece una lunga pausa.
“Decidere di scrivere questo romanzo” disse unendo le mani quasi stesse pregando, "è stata
un'ottima idea. Tornare con la mente a fatti cancellati, mi fa stare meglio. Dà un senso a quello che
è stato. Passo le mattinate da solo a riflettere. Scrivo, leggo, riscrivo e rileggo, riscrivo: provo
emozioni forti. Piango lacrime arretrate. Eppure gioisco per come sono invecchiato. La mia vita è
stata triste per lungo tempo. Eppure quando ho iniziato a scrivere ho capito che faceva tutto parte di
un disegno divino: anche potendo, non cambierei una virgola."
"Limitati a cambiare le virgole alle schifezze che scrivi ogni giorno!" pensai che avrebbe detto
Luigi, se non si fosse appena addormentato.
Sedeva all'ombra delle viti, mentre il sole illuminava il viso mio e di Giovanni. La luce non ci dava
fastidio.
Lo destai con una carezza sui capelli biondi e grigi.
Giovanni proseguì.
“Mi piace passare i pomeriggi con voi due. A parlare, giocare a briscola, guardare la gente da
lontano, vagare per le stradine del paese, fermarsi a riposare: con il solito paesaggio vigolano che è
una vita che non cambia, se non con le stagioni." Fece una pausa. "È così anche la mia vita in
fondo: sempre uguale, sempre la stessa.”
Rimanemmo in silenzio.
“Che stronzo, Jo, mi hai fatto venire gli occhi lucidi” gracchiò Luigi.
"Sei il nostro poeta, Giovanni" dissi.
“Ho semplicemente imparato a mostrare anziché..."
Luigi, glielo si leggeva in faccia, voleva ribattere, ma dalla bocca non gli uscì che un fischio simile
al verso di un asmatico.
Sorrisi in silenzio guardando quei due vecchietti ammaccati, pensando a quante ne avevano passate.
Mi tornò alla mente l’incidente che aveva rubato a Luigi, in una sola volta, sorella e genitori, alla
successiva caduta nelle droghe, alla fuga nelle baracche brasiliane: adesso era lì: un'anima viva in
un corpo morto.
Poi osservai Giovanni. Ripensai al Giovanni sistematicamente umiliato dai colleghi, da Salomè,
dalla madre: dal destino.
Nell'aria c'era un intenso profumo. Mi voltai verso sud: erano le viti di uva fragola, finalmente era
matura.
“Andiamo a farci un giro in paese?” dissi rompendo il silenzio. “Ci arriviamo su al castello, Luigi?”
“Certo, cosa credi?" disse con sfida. "Solo perché mi reggo su due ruote non vuol dire che non
possa batterti!”
“Dai, Giovanni, facciamoci una corsetta!” gridai.
Luigi alzò il dito medio cercando invano di nascondere un sorriso.
“Andiamo!” disse Giovanni incamminandosi attraverso il giardino. “Zeno, posso prenderne un
grappolo.”
"Fai pure” dissi mentre mi giravo per aspettare Luigi. “Forza con quelle braccia rinsecchite, dacci
dentro.”
“Vieni ad aiutarmi invece, Zen dei miei coglioni!” gridò indaffarato a tossire e spingere la sedia a
rotelle.
x
Cara mamma,
lo sai, sono sempre stato timido, fin da piccolo. Ho sempre preferito ascoltare anziché parlare. Ho
passato la giovinezza a sognare di viaggiare, e una volta adulto ho cercato di realizzare questo
sogno. Ricordi? Durante gli anni dell’università sono stato un mese in Marocco e due in Paraguay,
con i soldi tuoi e di papà.
Vi ho ripagati con un sorriso.
Poi ho iniziato a lavorare, e i miei sogni si sono infranti senza ch’io versassi una lacrima, senza che
me ne accorgessi, e questo, ora, mi fa ancora più male.
Con il denaro che guadagnavo i primi tempi riuscivo a stento a pagare l’affitto e a tirare avanti. Non
te l'ho mai detto, ora lo sai. Negli anni ho rinunciato a muovermi, come se mi fossi dimenticato
della possibilità di scoprire nuovi mondi, di incontrare nuova gente, nuovi stimoli, come se
viaggiare fosse un capriccio e non una risorsa, dimenticando che era prima di tutto un dovere verso
se stessi.
A volte ci penso, mamma, e mi dico che viaggiare potrebbe essere il vero scopo della mia vita, la
realizzazione dei miei sogni. Vale la pena di passare undici mesi all’anno davanti a uno stupido
terminale? Forse sì, se poi durante il dodicesimo mese me ne posso scappare da tutto e da tutti con
lo zaino in spalla e la mente sgombra. Il viaggio è anche trascorrere mesi di fibrillazione a
organizzarlo e anni a ricordarlo, con immagini sempre più annebbiate a cariche di sana nostalgia.
Ho deciso: mollo tutto, vado.
Come state lassù in cielo? E la sorellina Elena? Come se la passa?
Beati voi che siete in paradiso! A volte mi chiedo chi ce l’ha fatto fare di rinchiuderci dentro quattro
mura grigie e polverose, dentro automobili automatizzate che puzzano di nuovo o di sudore, dentro
fabbriche metalliche, dentro uffici asettici, dentro scuole logore e fatiscenti: e c’è pure chi va in
chiesa.
Di altre solitudini abbisogniamo.
Non di dio, ma di risposte.
Non di fede cieca, ma di evidente verità.
Non di stronzate, ma di illuminazioni.
Mamma,
ho finalmente deciso.
Mollo tutto. Vado.
Mollo tutto e scappo via.
Quante volte le ho ripetute queste due frasi...
“E a forza di ripeterle sapevo che si sarebbero avverate” avrei detto qualche anno prima.
Ora invece dico “e a forza di ripeterle spero tanto che si avverino”.
C’è una bella differenza. Ha a che fare con la fede, la fede che ho perduto.
Come un risvegliato o come un nuovo nato, devo ricominciare a vivere. Io non sono più quel che
ero, non sono più pecora, non sono più lavoratore, non sono più obbediente: che ci sto a fare qui?
Tutto questo è passato, tutto questo non si trova più sul mio cammino.
Cosa dovrei fare ora che ho saldato i debiti e mi ritrovo al punto di partenza coi miei ventimila euro
in saccoccia? fingere che vada tutto bene come fa il gregge ignorante? accontentarmi di una vita
piena di alti e bassi, senza soddisfazioni ma solo grandi sacrifici?
No, mamma: ho l’energia per riprovarci.
Adesso so chi sono: sono me stesso, un risvegliato, e nient'altro.
Nessuno è solo come me, mamma. Nemmeno tu: hai papà ed Elena a farti compagnia. Io sono solo,
e ho paura.
Non c'è borghese che non appartenga all'ambiente dei borghesi, non c'è manovale che non
appartenga all'ambiente dei manovali: fra i loro pari tutti trovano accoglienza: condividono la vita,
parlano la stessa lingua. Non c'è frate che non sia annoverato tra i suoi colleghi e non viva con loro,
non c'è eremita che non possa trovar ricovero nella società degli eremiti, e anche il più sperduto
solitario della foresta non è uno e solo: anche lui appartiene a una categoria che gli fa dà patria.
Prendi Jo. È diventato dipendente aziendale, e mille dipendenti aziendali sono suoi fratelli, portano
un abito come il suo, condividono la sua fede, parlano il suo linguaggio. Prendi Zen. Zen è
diventato ricercatore universitario, e mille ricercatori universitari sono suoi fratelli, portano una
maschera come la sua, condividono il suo credo, parlano il suo linguaggio.
Ma io, Luigi Alberti, a quale comunità appartengo? Di chi condivido la vita?
Di chi parlo il linguaggio?
Questa confessione, mamma, è l'ultimo brivido del risveglio: la vita post-post-vincita, la vita postmortem: la mia seconda e ultima possibilità.
Se anche stavolta non dovesse funzionare, allora mi accontenterò di una vita grigia e piatta da
comune cittadino, oppure, se mai troverò il coraggio, prenderò una scorciatoia: così staremo di
nuovo tutti e quattro insieme.
Tuo figlio,
Luigino
FINE PRIMA PARTEz
3 settembre
"Luigi, ci sei?"
"Sì, avanti parla, non farti pregare come al solito."
"Avrei scritto un intermezzo da piazzare alla fine della prima parte, riprendendo anche il tuo
romanzo sul pesce..."
"Vai, leggi! Basta cianciare a vanvera, leggi 'sta roba!"
Cominciò a tossire prima soltanto aria, poi saliva e qualche macchia di sangue.
"Ok, vado."
Narratore
Che ti avevo detto, lettore?
È o non è gente per bene?
A me personalmente fanno tenerezza: Luigi e la sua impossibilità di stare, Giovanni e la sua
volontaria reclusione casa-chiesa-azienda, Zeno e la sua incapacità di relazionarsi.
A volte sono stato richiamato verbalmente dall'Autore: vuole che anch'io scriva qualcosa. Sei o non
sei il narratore? continua a ripetere nelle sue missive. Caro Autore, lo farei volentieri, se ne avessi
il tempo. Che ci parli Lei con quei tre: è Lei in fondo che si è imbarcato in questa spedizione.
Sono o non sono il narratore? Allora il mio compito è di narrare, punto. Sai cosa penso? Penso che
gli autori non hanno bisogno di noi. Siamo soltanto delle maschere dietro a cui si celano agli occhi
della gente. L'autore e il personaggio in fondo sono la stessa cosa. Perché allora nascondersi?
Tra non molto rimarrò senza lavoro, ne sono certo. Eppure non sono triste: per il bene dell'arte sono
disposto a dare anche la vita.
Tornando a quei tre, faranno anche tenerezza, ma lavorare con loro sta diventando impegnativo.
A dispetto di quanto uno possa pensare, Zeno è il più indisciplinato. È un individualista. Non gli
interessa portare a termine il romanzo. Si fa scivolare tutto addosso. Ride e guarda in alto, oppure
legge tomi vecchi quanto il mondo. Abbiamo capito, signorino Zeni, che le piace meditare, ma se
ogni tanto si degnasse di contribuire... Ce ne facciamo ben poco dei suoi brani ironici: tiri fuori
qualcosa di suo! Perché grido? Sono certo che in questo momento se ne sta a leggere sulla solita
poltrona in eco-pelle, con quei maledetti tappi nelle orecchie.
Sempre meglio di Luigi: se non continuassi a sedarlo, strariperebbe di qua e di là con aforismi,
poesie, monologhi senza fine, riflessioni senza senso, per non parlare dei suoi pseudo-trattati
psicologici... Non vedo l'ora che il romanzo sia finito: ho bisogno di ferie, dicono che il Brasile sia
così rilassante... La prossima volta sceglierò certamente un romanzo classico, forse un saggio. Io
davvero non le capisco queste cose post-avanguardiste: post-post-modernismo, meta-metaletteratura: dove andremo a finire?
Per fortuna c'è Giovanni a consolarmi. È lui il mio eroe: docile, ubbidiente, preciso; uno stile
semplice, regolare, pacato: una meraviglia per le orecchie. Nei nostri primi incontri percepivo in lui
una certa puzza sotto il naso. Poi ho capito. Si comportava così per immedesimarsi nel suo
personaggio da giovane.
***
Non so come sarà la seconda parte.
Giorni scorsi a casa di Zeno, Luigi mi ha detto di fare le valigie. Una volta capita l'antifona, ho
pensato alle settimane a venire: nuove ambientazioni, nuovi personaggi, nuovi amori: un lavoraccio
senza fine!
"Ma perché ognuno non se ne sta al proprio posto, come il buon Giovanni?" gli ho chiesto.
Ti risparmio, carissimo lettore, gli improperi con i quali Luigi mi ha zittito.
Quindi, d'ora in poi, aspettati un'accelerazione vorticosa verso un finale da leccarsi le dita: sempre
che quello non schiatti prima.
(Giuro che non lo penso davvero, è solo una battuta, non sono cattivo come sembro!)
Be', vediamo come va a finire: speriamo bene.
Ti lascio (sperando non se ne accorga) uno stupido appunto dell'Autore: l'ho trovato ieri sulla sua
scrivania.
Luigi.
Parigi.
Bagigi.
Giovanni.
Anni.
Nanni.
Zeno.
Baleno.
Tungsteno.
Luigi Giovanni Zeno
Parigi Anni Baleno
Bagigi Nanni Tungsteno
Baleno Giovanni Parigi
Luigi Anni Tungsteno
Bagigi Nanni Zeno
(N.d.N.: questa terzina, anche se leggibile, era cancellata)
Luigi Baleno Nanni
Zeno Anni Parigi
Giovanni Tungsteno Bagigi
Che ti avevo detto?
Ah, quasi dimenticavo, Luigi mi ha pregato di farti leggere un estratto di un romanzo breve (anche
se a me, sinceramente, pare più una favola) su cui dice di aver lavorato per tutta la vita. Testuali
parole: qui c'è tutto me stesso: leggerlo equivale a sfogliarmi l'anima.
Se ti piace, posso aggiungere il seguito. Fammi sapere.
CORDONE OMBELICALE
come eliminare un vizio cresciuto fino all’ossessione
Sono passate molte giornate da quella scena spaventosa. Sono turbato.
Ci penso tutto il tempo e ancora non capisco chi mi abbia messo qui dentro.
La notte mi fa paura. Nel buio non si vede che a due o tre sfere di distanza. Solo ombre e notti
interminabili all’orizzonte.
Dopo qualche tempo mi ci sono abituato: dentro la sfera di vetro nessuno mi può fare male.
Se per vera libertà s’intende poter nuotare nell’oceano infinito ed essere inghiottito da un momento
all’altro, allora io mi tengo stretta la mia semilibertà nel mio piccolo universo.
Sono fiero di me stesso. Passo le giornate ad osservare il mondo là fuori. A volte guardo il mio
corpo. Mi sembra che stia cambiando, che stia assumendo una colorazione tutta nuova, verdastra
con qualche venatura violacea. Forse è pure più lungo: mi basta una leggera torsione per vedere la
mia bella coda argentata.
Nella mia sfera a volte mi sento proprio un Dio.
Le ultime giornate, lo ammetto, mi sono un po’ annoiato. Ho fatto un po’ d’ordine in casa. L’ho
pulita e ripulita passandola tutta con le labbra, centimetro per centimetro. Ma mentre rivoltavo ad
uno ad uno i minuscoli sassolini del fondo ho notato un puntino verde, un piccolo germoglio. Gli ho
subito creato dello spazio attorno togliendo le pietruzze che lo soffocavano.
Non c’erano dubbi, era un filo d’erba, sul nascere.
***
Mi prendo cura di lui tutto il giorno. Gli parlo, lo accarezzo con la coda, gli alito sopra la notte per
farlo addormentare. Credo sia stato un regalo del Dio Sole per premiarmi della mia buona condotta:
per farmi compagnia.
La vita col mio piccolo filo d’erba ha un altro sapore. Più ci penso più mi accorgo che faccio tutto
in sua funzione.
Lo sogno spesso la notte. Se mi sveglio all’improvviso da un incubo, rivolgo subito lo sguardo
verso Filo e controllo che sia ancora lì. La prima cosa a cui penso al mattino è verificare il suo stato
di salute. Durante il giorno non faccio altro che prendermi cura di lui. Prima di andare a dormire,
mai mi scordo di dargli il bacio della buona notte. In due la vita è un’altra cosa. Gli voglio bene
come se fosse parte di me.
Le giornate passano e Filo cresce a vista d’occhio. Oramai è lungo quasi quanto me. Gli ho spiegato
le mie teorie sulla vita, sulla sfera, sul Dio Sole e sugli Dei Pesci.
***
Non ho più niente da insegnargli. Siamo grandi uguali, è giusto che ora faccia qualcosa anche lui. In
due ci si deve aiutare a vicenda.
Le chiacchierate che ci facciamo io e Filo… mi basta percepire un suo piccolo ondeggiamento, un
suo su e giù, e capisco esattamente cosa vuole dirmi. Spesso ride con me. Ogni tanto ride di me.
Altre volte sembra non capire. Si può proprio dire che andiamo d’amore e d’accordo.
***
Oggi è un giorno importante: Filo ha sfiorato l’apice della sfera: è così alto che può toccare allo
stesso tempo cima e fondo del mio piccolo mondo. E non sembra volersi fermare.
***
Sono passati dieci giorni e dieci notti da quando Filo ha raggiunto la sommità della sfera. Si sta
propagando a spirale. Se va avanti così la riempirà tutta e non potrò più vedere all’esterno. Vivrò
dentro alla mia sfera di vetro per sempre e Filo mi proteggerà da tutti i pericoli. Nulla potrà
turbarmi o farmi del male. Finalmente avremo solo pace e tranquillità.
Anche Filo la pensa come me e non fa altro che ripetermelo. Dice che andrà tutto bene e che là fuori
è tutto brutto e cattivo.
***
Sono passati altri dieci giorni e qui ora è buio pesto. Comincio ad avere difficoltà a respirare. Filo
mi avvolge tutto col suo odore marcio e stantio. Non so che fare. Occupa tutto lo spazio. L’ho
pregato di fermarsi, di non crescere più. Ho pianto pur di convincerlo a lasciarmi vivere, ma non fa
che ripetermi che andrà tutto bene.
Gli ho detto chiaro e tondo che le cose sono cambiate. Prima lo amavo. Condividevo lo spazio con
lui, gli dedicavo il mio tempo e questo mi gratificava, mi riempiva il cuore di gioia.
Ora mi sta schiacciando, mi imprigiona dentro di sé, nella sua vita statica e monotona. Non trovo
più i miei spazi: manco riusciamo più a guardarci in faccia! Siamo diventati due esseri estranei. Non
abbiamo più niente da spartire. Ognuno pensa solo ad ampliare i propri spazi, a guadagnare quel po’
d’aria in più, quel po’ di libertà.
Quando glielo faccio notare non mi risponde nemmeno.
Mi rimangono due possibilità: o morire con lui o vivere senza di lui. E io mi sento davvero troppo
giovane per morire.
A malincuore mi sono avvicinato al fondo divincolandomi a stento tra le ragnatele del suo verde
corpo. Trovato il punto esatto in cui scompariva dentro la sabbia, ho cominciato a scavare con la
bocca travolta dalla sabbia gelida e dalle mie stesse lacrime calde. Piangevo e scavavo con rabbia.
Volevo che quel momento finisse presto.
Strappai con forza ogni sua amara radice finché anche l’ultima rimasta non fu recisa dai miei piccoli
denti aguzzi, guidati da una forza che non sapevo di avere.
Mi lasciai cadere esausto. Asfissiato dal senso di colpa e disperato.
In pochi giorni Filo se ne andò. Da verde divenne di un giallo raggrinzito. Quindi marrone fino a
sgretolarsi e a posarsi sul fondo come carne morta. Nei giorni successivi lo osservavo mescolarsi
con la sabbia fino a scomparire. Non lo rividi mai più.
RIFLESSIONI
come sopravvivere durante la post-adolescenza
Filo lasciò un gran vuoto dentro me. Con lui al mio fianco tutto mi sembrava bello. Le giornate
filavano lisce, veloci e felici. Si andava sempre d’amore e d’accordo, noi!
Le prime notti dopo la sua morte non riuscivo a chiudere occhio. Riflettevo a lungo, sulle mie
lacrime, sulle mie inquietudini, sulle mie paure di affrontare il mondo da solo.
Poi mi rassegnai ad accettare la vita così com’è. Le cose cambiano continuamente. Nascono e
muoiono. O almeno questo era quello che credevo a quel tempo.
Capii che anch’io prima o poi sarei morto perché pure io continuavo a crescere di giorno in giorno.
Una volta divenuto grande quanto la sfera, la mia fine sarebbe stata segnata.
E la stessa legge doveva essere valida anche fuori. Forse il tempo e lo spazio potevano essere
dilatati di un fattore x o y, ma non ci poteva essere spazio per tutti.
Però un universo dove tutti crescevano all’infinito non aveva senso, prima o poi ogni essere vivente
avrebbe dovuto fare i conti con gli altri, avrebbe inevitabilmente dovuto condividere gli spazi col
prossimo, con l’altro. E poi che vita sarebbe una vita dove tutti crescono all’infinito? Che senso
avrebbe?
Quindi tutto nasce e muore. Ma se tutto nasce e muore, se tutto cambia, se nulla resta uguale, allora
che senso ha che io pensi al passato? Che senso può avere per me Filo ora che non c’è più?
Filo non esiste, non è più qui nella sfera con me, esiste solo nella mia mente. Per quanto ne so posso
anche essermelo sognato. Comunque sia il suo ricordo mi accompagnerà per il resto dei miei giorni,
e delle mie notti.
Io sono vivo e la mia realtà, qui ed ora, sono questa sfera amica dentro la quale vivo, e il mondo là
fuori, o meglio ciò che mi arriva del mondo là fuori.
Digerito tutto ciò, ho smesso di soffrire e mi sono imposto di guardare avanti e affrontare la vita.
Da giorni e giorni aspetto di fronteggiare ciò che il destino mi riserva, ma la mia teoria
sull’impermanenza delle cose non sembra funzionare in questa piccola sfera: è tutto così
maledettamente uguale! Non mi rimane che passare il tempo a riflettere.
Pensando e ripensando mi sono soffermato su di un altro aspetto della mia vita: l’appartenenza al
mondo.
Sono qui protetto da tutto e da tutti in questa ampolla di vetro, eppure anch’io faccio parte del
mondo. Sono parte di quest’enorme massa d’acqua che ci copre tutti, me, gli altri pesci, i
Compagni, i Pagliacci e gli Dei. Il mio ragionamento è semplice: senza di me il mondo sarebbe lo
stesso? La prima volta mi sono detto che sì, senza di me il mondo sarebbe uguale, se sparissi
nessuno se ne accorgerebbe e tutto andrebbe avanti come prima. Ma la risposta cambia se la
domanda la si formula in maniera più precisa: senza di me il mondo sarebbe esattamente lo stesso?
È evidente che no, il mondo non sarebbe esattamente lo stesso se io venissi a mancare! Può
sembrare una sottigliezza, ma per me è di un’importanza fondamentale, esistenziale direi.
Nel mio piccolo anch’io influenzo il mondo. Mi riferisco a Filo, ai Pagliacci che mi gironzolano
attorno ogni giorno, e forse anche al Dio Sole che ogni giorno si degna di illuminare me e tutto
questo eterno abisso. Tale consapevolezza mi ha fatto capire che al mondo ci sono anch’io, che
anch’io ho un ruolo, anche se di comparsa, all’interno della società. Io sono fondamentale per
l’intero mondo, essenziale per l’esistenza dell’universo così come esso mi appare. E di questo non
posso che essere fiero. Sono orgoglioso di esistere.
La morte di Filo mi ha fatto crescere. Ho imparato tante cose che prima non avevo mai neppure
considerato. Ho capito che non mi rimane che pensare. Voglio capire il mondo. Tutto il resto ora è
inutile e futile. D’ora in poi dedicherò tutto me stesso alla ricerca di qualcosa che vada oltre la
semplice apparenza delle cose. Voglio diventare migliore. Studiare le cose che mi circondano.
Trovare quel qualcosa in più, possa esso rappresentare la felicità, la serenità o la verità.
Ancora non so dove, come e cosa cercare, ma sono sicuro che cercando capirò cosa cercare. Anche
se dovessi non trovare mai una risposta, voglio comunque trascorrere la mia vita cercando.
Ho gli occhi chiusi ora. Li terrò così ancora per molto. Voglio vedere il mondo con altri occhi.
Sensazioni contrastanti. Paura e gioia, ansia e pace, noia ed eccitazione.
Sono sulla giusta strada, una via saggia ed avventurosa al tempo stesso.
Dopo lunghe giornate senza aprir occhio, mi sono posto una domanda: devo cercare fuori o dentro
di me? devo usare tutti i sensi a mia disposizione per carpire informazioni oppure astrarmi dal
mondo e contare sulla pura logica dei miei ragionamenti?
Per ora continuo a guardare dentro me stesso. Col pensiero razionale vivrò più saggiamente e saprò
già a priori cosa succede là fuori, oltre la sfera.
Così ho imparato a riflettere sempre su ogni cosa, anche la più insignificante.
Ho appreso, e mi sforzo di affinarle di giorno in giorno, le tecniche di controllo del mio corpo.
Dopo lunghi e disciplinati allenamenti, ho imparato a controllare il respiro e a rallentare il battito
del cuore. È una strana sensazione. Come se riuscissi a fermare il tempo per qualche attimo.
Allo stesso modo ho imparato la complessa pratica del digiuno, scoprendo che per digiunare è
necessario, oltre ad un allenamento fisico, un ottimo controllo della mente.
Ho lavorato molto sui sentimenti. Ho eliminato tutto ciò che mi allontanava dalla serenità.
Cancellare la rabbia è stato il mio primo successo. Tuttora sto cercando di distruggere il desiderio e
l’illusione. Mi blocca la mancata consapevolezza che la mia vita potrà essere migliore senza
desiderare ed illudermi. Non è per niente facile: è una vita che desidero che succeda qualcosa di
nuovo e che mi illudo che la vita non sia tutta qui!
Il segreto credo stia nell’accettare la mia condizione, vista l’impossibilità di cambiarla. Desiderare
qualcos’altro sarebbe ammettere che qui e ora non sto bene.
A volte penso che Filo sia stata solo una visione distorta della mia solitudine. Come una malattia
cresciuta a dismisura dentro di me, che non so con quale forza di volontà sono riuscito a debellare
prima che fosse lei ad uccidermi. Allo stesso tempo il suo ricordo è così vivido da farmi rimangiare
i miei pensieri maligni.
Sto meglio ora che riesco ad eliminare le paure stupide, i desideri ossessionanti, le illusioni fittizie e
le arrabbiature inutili. Cerco di vivere il più sereno possibile, accontentandomi di quel poco che ho.
Amo tutto ciò che è presente nella mia realtà perché so che faccio parte di un mondo e solo amando
universalmente e incondizionatamente ogni piccola cosa, posso riuscire ad amare me stesso.
INNAMORAMENTO
come innamorarsi del solo che si accorge che esisti
Un giorno in cui il Sole (finalmente ho avuto il coraggio di togliere la parola Dio) splendeva come
mai prima, vidi uno dei Pagliacci avvicinarsi alla mia sfera.
Era diverso. Più aggraziato. Scodinzolava con dolcezza risoluta. Pareva curioso. Interessato a me, o
forse alla sfera. Seguitava a girarmi attorno e ad allontanarsi. Dopo una vita di silenzi decisi di
parlare.
«Ciao.»
Non rispose.
«Ciao! Com’è la fuori?!»
Il Pagliaccio doveva aver udito le mie parole perché scattò via, quasi l’avessi aggredito.
«Scusami!» gridai. «Non volevo spaventarti!»
La mia voce risuonava come un fastidioso rimbombo.
Si riavvicinò lentamente. Non gli sembrava vero un pesce imprigionato in un’ampolla di vetro in
fondo all’oceano, eppure lo ero!
«Ehi! guarda che sono di carne e ossa, sono un pesciolino simile a te. Vivo qui da sempre. Tu e un
filo d’erba siete gli unici che si sono accorti che esisto. Il filo poi l’ho dovuto ammazzare, ma
tranquillo, non sono pericoloso!»
Il Pagliaccio si avvicinò titubante.
«Tranquilla vorrai dire!?»
«Come?»
«Tranquilla!!»
«Cioè?»
«Sono una femmina!!!»
Rimasi inebetito non capendo cosa volesse dire con quel termine. Provavo vergogna per la mia
ignoranza.
«Ciao Femmina!»
«Non mi chiamo Femmina, sono una femmina!!!!!»
«Sì sì va bene, ho capito» dissi. «Ti inviterei a bere un po’ d’acqua fresca ma come vedi non mi è
permesso…»
«Mi vorresti dire che non sei mai uscito da lì dentro in tutta la vita?!»
«Mai.»
«Mai?»
«Mai.»
«Mai mai mai?»
«Mai mai mai.»
Rimase di sasso. Aveva un’espressione tra l’incredulo e l’arrabbiato. Sospettava che la prendessi in
giro. Solo dopo un’accurata ispezione all’intera sfera e alla sabbia su cui poggiava, potè convincersi
che dicevo la verità.
Si rilassò.
«E quindi tu saresti nato e cresciuto qui fino ad ora? Senza mai…senza mai essere libero?»
«Ti sbagli. Qui ho la libertà che mi basta per vivere dignitosamente. Nessuno mi vieta di fare quello
che voglio. Nessuno mi costringe. Nessuno mi intimidisce. Con la mente posso spaziare ovunque.
Andare in mondi inventati. Perdermi nei pensieri più vividi. Sognare spazi immensi. Vivere non
una, ma mille vite.»
«Come le bambine che giocano con le bambole?»
«Come cosa!?»
«Le bambine. Quando vivevo in una famiglia di umani ogni pomeriggio le figlie della signora
facevano parlare le loro bambole, le facevano muovere, ballare, piangere. Le spogliavano, le
rivestivano, le pettinavano. Le mandavano a fare la spesa…»
«Petti che?! Aspetta… fare la spesa? Aspetta un attimo! Mi sa che non ho capito un bel niente!»
«Uffi! Sei peggio di un pesce d’acqua dolce!»
«Acqua dolce? Cos’è uno scherzo?»
«Mamma mia, allora è proprio vero che non sei mai uscito da questa sfera! Dovrò spiegarti un bel
po’ di cose.»
«Sì, ti prego, spiegami, aiutami a capire!»
«Ora ci provo… da dove incominciamo?»
Fu così che capii come stavano le cose. Alcune le avevo ipotizzate correttamente coi miei
ragionamenti logici. Altre, la maggior parte a dire il vero, mi sconvolgono tuttora per la loro natura
irrazionale. Enormi costruzioni di pietra grigia che fumano in continuazione, animali della stessa
specie che corrono in ogni dove inveendo gli uni con gli altri, lunghe lingue nere invase da gas
tossici e rumori assordanti, esseri viventi rinchiusi tutto il giorno in stanze tutte uguali davanti ad un
piccolo schermo piatto,…
Libera, così diceva di chiamarsi la pesciolina, non la finiva di raccontare queste ed altre incredibili
assurdità.
Mi raccontò di essere nata in cattività. I pesci la chiamavano così perché era piena di persone
cattive, che tenevano i pesciolini appena nati chiusi in minuscole gabbie.
Mi disse che un giorno una signora l’aveva portata via, in una casa con un grande giardino verde e
profumato, dove a volte si respirava un silenzio fatto di pace. Non era sola. Nell’acquario c’era un
altro pesciolino di nome Jin. Dopo alcuni brevi attimi di timidezza, erano diventati amici per la
pelle. Non facevano che nuotare tutto il giorno tra i riflessi arcobaleno che la luce del sole creava
nell’acqua. Dalla finestra potevano osservare il grande parco della signora ricolmo di fiori rosa e
azzurri, che se al mattino prendevi un bel respiro profondo ne assaporavi anche il profumo, o
almeno questo era quello che lei sosteneva.
Lei e Jin erano cresciuti ridendo e prendendo in giro gli umani. Libera diceva che la razza umana
era la più crudele tra tutti gli animali che aveva visto. E spesso anche la più stupida.
Facevo fatica a credere a quello che diceva. Io nel mio eremo in fondo all’oceano, impermeabile a
qualsiasi dinamica, mi trovavo ad anni luce da quel mondo così ********* e *************.
L’aria, mi spiegò un giorno, sono quelle bolle maleodoranti che si formano nell’acqua quando
abbiamo mal di pancia. Mai e poi mai avrei pensato che potessero esistere esseri viventi, come gli
umani, in grado di vivere tutta la vita in un mondo fatto d’aria.
Libera dopo alcune ore che parlava senza interruzioni finì per raccontarmi un episodio che segnò
per sempre la sua vita e quella del suo amico Jin.
In una calda giornata d’estate la figliuola della signora prese con le mani lei e Jin e li rinchiuse in
una piccola ampolla di vetro, grande più o meno come la mia sfera. Fecero un lungo viaggio in una
profumata ma instabile automobile prima di arrivare esausti alla fattoria della signora con l’acqua
oramai alla gola.
In quel luogo d’altri tempi passarono un periodo piacevole e ricco di novità. A parte un peloso
gattone che li terrorizzava a morte quando si avvicinava, o gli interminabili minuti di apnea quando
la ragazzina li prendeva con le mani e li portava in giro per il campo che stava di fronte alla villa,
passarono giornate beate. La loro amicizia in quel luogo paradisiaco si era saldata fin troppo. In uno
dei tanti momenti d’estasi avevano giurato di stare per sempre insieme, di non separarsi mai per
nulla al mondo. Ancora non sapevano che cosa li aspettava di lì a poco.
Verso la fine dell’estate quando l’acqua nell’ampolla cominciava a farsi un po’ più fresca, furono
caricati nuovamente nell’automobile. Pensavano che sarebbero tornati presto a casa. A rimirare il
geometrico giardino di rose della signora e sullo sfondo i fumi grigi della città. Lei e Jin erano
contenti, indifferenti al mondo esterno, quello che contava era stare insieme.
Ma la realtà non va sempre come la si immagina, e le loro vite evidentemente non erano destinate
ad essere una sola.
Quando il motore dell’automobile smise di rombare e l’acqua nell’ampolla di oscillare, la ragazzina
aprì di scatto la portiera e corse sul molo con il piccolo acquario tra le mani. Salvo poi inciampare.
Mentre cadeva gettò in alto la sfera nel vano tentativo di non perdere i suoi due amati pesciolini.
Non fece in tempo neanche a vederla ricadere, che l’oceano se l’era inghiottita in un sol boccone.
Quando Libera si svegliò era distesa sull’algido fondo dell’oceano con un gran mal di testa.
«…e questo è tutto. Il resto del tempo l’ho passato a cercare Jin. Mi manca da morire,» disse
lasciandosi sopraffare da un lieve singhiozzo.
Rimasi un attimo in silenzio a guardarla con dolcezza.
«Vorrei tanto strofinarti e consolarti. È una storia bellissima. Tu sì che hai vissuto una vita vera!»
«Eh sì…ora però devo andare. Grazie di avermi ascoltata tutto questo tempo. Addio.»
Non ebbi neanche il tempo di dire una parola che già era scomparsa lasciando dietro sé un mare di
lacrime come piccoli tristi soli.
Non riuscivo a prendere sonno. Ripensavo a Libera: era il primo vero incontro della mia vita. Le
sue rivelazioni mi avevano sconvolto. La vita di prima mi sembrava piccola piccola dopo aver
scoperto tutte quelle cose. Ero allo stesso tempo terrorizzato, eccitato, curioso, ma più di tutto triste
per la sua dipartita. Se ne era andata com’era venuta. Troppe informazioni mi infestavano la testa.
Troppi collegamenti tra una novità e l’altra. Troppe sensazioni in così breve tempo. Libera nel giro
di poche ore mi aveva devastato la vita. Non ci capivo più niente.
Mi sentivo attratto da quella visione angelica, da quella voce dolce e sincera, da quei discorsi
sconclusionati così diversi, così lontani dalle mie astratte congetture logico-matematiche. Non
avevo mai provato niente del genere, nemmeno per Filo. Era qualcosa di diverso. Lei mi affascinava
coi racconti dei suoi viaggi, delle sue esperienze con la razza umana, dei luoghi in cui aveva
vissuto. Cos’ero io al suo cospetto? Solo un pensiero astratto, un sogno senza senso. Cos’avrei
potuto raccontarle? La mia ricerca di qualcosa di più grande? Più grande di cosa? Qualcosa più
grande della mia vita insulsa? L’avrei di certo annoiata, o peggio ancora, sarebbe scoppiata a
ridermi in faccia. Chi volevo prendere in giro?
Una cosa mi è venuta in mente in quella lunga notte illuminante. E se questa in cui vivo non fosse
una sfera? Se fosse anch’essa un’ampolla di vetro usata dagli umani come acquario per i pesci? In
questo caso dovrebbe certamente avere un’estremità aperta no?
Cominciai a scavare come un forsennato nel buio pesto respirando sabbia fin quasi a soffocare. Non
c’era niente da fare: più scavavo e più mi accorgevo che era tutto inutile. Se solo Libera fosse
rimasta avrebbe potuto aiutarmi. Forse scavando io dentro e lei fuori con un po’ di pazienza…
AMORE
come uscire dalla sfera dell’incomunicabilità e raggiungere l’anima gemella
Sono passati molti giorni da quando vidi Libera per la prima e ultima volta. Ebbi il tempo di
pensare e ripensare a quello che mi aveva raccontato. Per come la vedevo io la vita in fondo
all’oceano doveva essere migliore di quella sulla terra ferma. Qui l’unico pericolo a cui eri esposto
erano gli Dei che in un sol boccone ti potevano mangiare. Su invece c’erano gli umani che
decidevano tutto per te: ti potevano arrostire vivo, vendere a un estraneo, darti in pasto a un gatto,
lasciarti morire di fame, o affogare nell’aria puzzolente.
Ma che parlo a fare se nessuno mi ascolta? Chi prendo in giro? Meglio qui, peggio lì…ma magari
un pescione mi mangiasse e mettesse fine alla mia triste vita! Sono stufo di stare rinchiuso in questa
gabbia trasparente. Non ce la faccio più a sapere che là fuori c’è un mondo da vivere, da rischiarci
la pelle. Un mondo di avventure, di incontri, di posti verdi, rosa, azzurri come il cielo, non questo
buio pesante che mi opprime da una vita!
Una notte fui risvegliato da un continuo ticchettio. Aprii appena gli occhi, senza vedere.
«Jin» sussurrò una voce angelica. «Jin.»
«Sì…che vuoi? Chi sei?»
«Sono io. Sono tornata per stare per sempre con te! Mi sei mancato. Non posso più vivere senza di
te!»
«Allontanati un attimo per favore, fidati.»
Appoggiai le labbra all’estremità superiore della sfera e cominciai a spingere con tutte le mie forze.
Ad un tratto, mentre il sudore intorpidiva l’acqua che avevo sugli occhi, la sfera si sollevò dal suolo.
Quando fui sufficientemente alto chiesi a Libera di venire al mio fianco passando dall’apertura che
si era creata tra il fondo e l’ampolla.
«Eccomi Jin!» mi sussurrò all’orecchio con dolcezza.
La guardai un istante negli occhi prima di far ridiscendere la sfera al suo posto originale. Mi
investirono lacrime fredde e un mare di calorosi abbracci e strofinii.
A quel punto avvenne un black-out improvviso e quando tornò la luce mi ritrovai a strofinarmi
contro la sabbia che non era ancora giorno.
La sognai per molto tempo ancora. La immaginavo sempre più bella. Profumata, con venature
arcobaleno, snella, occhi dolci e languidi, pelle morbida e sensuale. Ogni giorno che finiva ero
contento di prendere sonno e rivederla nei miei sogni, toccarla, parlarle, baciarla.
Venne il giorno in cui tornò in carne e ossa.
«Ciao. Ti ho portato questo.»
Teneva tra le labbra un filo d’erba rigido con in cima una corona gialla e lilla, un colore simile al
rosa e al viola, ma più appariscente.
«Te lo metto qui. È un fiorellino d’aria dolce» disse posandolo sull’apice della sfera.
«Dove sei stata?»
«Qua intorno. Ho chiesto se qualcuno conosceva un pesce di nome Jin, ma niente.»
«Mi dispiace che tu non l’abbia ancora trovato.»
«Grazie.»
«Ti potrà sembrare stupido, ma sognando mi è venuta un’idea.»
Le spiegai il punto esatto dove doveva scavare. Insieme, io dentro e lei fuori, rimanemmo a spostare
sabbia con foga fino a sfiancarci. Dopo un po’ le dissi di lasciar perdere, era solo un’idea bizzarra
scaturita dalla solitudine.
Stavo riponendo una pietra sopra le mie speranze di farmi una vita come tutti gli altri, di uscire da
quella prigione, di seguire Libera nel suo peregrinare, nella sua ricerca impossibile. Sperare mi
rendeva triste e angosciato. Meglio arrendersi e accettare la condizione in cui mi trovavo. Potevo
accontentarmi di sognare la vita che avrei potuto vivere là fuori, e questo mi doveva bastare.
Ma il mio destino forse era un altro. Ripreso fiato Libera mi disse di tenere duro che se lo sentiva.
«Nella vita non ci si deve arrendere mai!» gridò grintosa.
Riprendemmo a scavare più veloce di prima. Ingoiavo sabbia fino a soffocarmi. Usai tutta la rabbia
che avevo in corpo.
L’oceano era buio e freddo. Laggiù negli abissi tutto era velato da un’immobilità blu e senza tempo.
Ma in quell’immensa voragine c’erano anche due pesciolini dai colori d’argento che sgargianti si
affannavano come due colibrì.
Scavammo finché le nostre labbra si sfiorarono. Ero libero. Potevo uscire. Potevo vivere.
Mentre tenevo sollevata la sfera col mio corpo Libera la bloccò con un sasso. Feci un bel respiro a
piene branchie ed uscii lentamente.
Per la prima volta in vita mia ero fuori. Rimasi con la coda appoggiata alla sfera osservando
l’infinito.
Ero rapito dalla visione di un mondo nuovo. L’avevo sempre visto attraverso un sottile strato di
vetro. Ora era lì di fronte a me senza filtri. Cercavo di assorbirne ogni colore, ogni forma, ogni
movimento. Cercavo di cogliere ogni dettaglio. Ero immerso nei miei pensieri a tal punto da
dimenticarmi della presenza di Libera.
Mi girai verso di lei e mi accorsi che piangeva.
«Sei tu?»
«Certo che sono io. E chi dovrei essere?»
«Sei tu davvero?»
«Te l’ho detto, sono io!»
Si fiondò contro le mie labbra baciandole.
«Wow…
«Ma che c’è? Perché continui a piangere?»
«Piango di gioia. Piango perché sono felice. La pesciolina più felice di tutto l’oceano.»
Solo allora realizzai.
Realizzai che la mia vita sarebbe cambiata.
Realizzai che avevo anch’io un passato.
Realizzai che non sarei stato più solo.
VITA
come godersi brevi attimi di felicità destinati inesorabilmente a dissolversi
Ora ho un nome, Jin. Una compagna, Libera. E una vera e propria casa, non una prigione.
Quando la bambina ci buttò nell’oceano, io sbattei la testa più volte contro la boccia e persi la
memoria. Non c’era altra spiegazione.
Libera mi parlò a lungo di com’ero intraprendente e coraggioso e pieno di vita.
Mi raccontò che il giorno in cui mi aveva visto nella sfera, avevo un’aria familiare. Ma la mia voce
le giungeva cavernosa e il mio viso, deformato dalla curvatura, era abominevole.
Tutto ciò che avevo osservato nell’interminabile periodo all’interno dell’ampolla, si era presentato
ai miei occhi fallace e depistante. Non corrispondeva alla realtà. Pur somigliandovi non era lo stesso
mondo che vedevo ora quando mettevo la testa fuori dalla sfera.
La tempestai di domande per giorni e giorni. Volevo sapere tutto. La cosa che più m’importava era
sapere di me. Di com’ero un tempo. Non dormivo dalla fibrillazione. E quando lei sfinita la sera
tardi si accasciava sul lettone di alghe, io la pregavo di raccontarmi ancora un po’ di quella storia
infinita.
Le chiedevo che tipo ero. Se ero sincero, onesto. Se ero socievole o introverso. Volevo sapere come
mi vedevano lei e gli altri pesci, che giudizio avevano su di me.
Un giorno le dissi che non volevo che mi amasse per quello che ero stato, ma per quello che ero ora.
La prendevo un po’ in giro e le dicevo che quella storia se la sarebbe potuta inventare tutta di sana
pianta solo perché le piacevo e perché voleva stare con me nella mia sfera di cristallo. Allora lei si
arrabbiava e alzava la voce.
«E perché avrei dovuto farlo?!
«Non ho bisogno di una casa io! Voglio vivere libera, leggera, voglio scoprire il mondo io!»
Quando si arrabbiava mi faceva tenerezza. Mi veniva naturale sorriderle e strofinarla forte forte. E
non lasciarla mai più.
Per prima cosa arredammo la nostra “nuova” casetta (era sempre la stessa boccia ma era tutto
diverso, se capite ciò che intendo) con sassi variopinti che lei andava a prendere chissà dove. Lei si
occupava di esplorare i dintorni e recuperare tutto ciò che ci poteva tornare utile. Io facevo le
faccende di casa e aspettavo con apprensione che tornasse.
Più passava il tempo e più ci amavamo. A volte si litigava un po’, ma poi era ancor più bello far la
pace e stare di nuovo insieme.
Libera insisteva che l’accompagnassi nel suo girovagare. I primi tempi avevo provato a seguirla, poi
la paura mi vinse. Anche lei cominciò ad arrendersi. Se ne andava via sola e non tornava mai prima
di un’ora. Credo le servisse non tanto per ritrovare un po’ di solitudine, ma più per sfogare la sua
smania d’avventura. Ho sempre pensato che se non mi avesse amato, se ne sarebbe andata via già
da tempo. Ma mi amava, e l’amore la legava a me e alla nostra casa, alla nostra piccola vita
sedentaria.
La gioia più grande della mia vita la provai quando si schiuse il primo ovetto. Divenni padre. Io e
Libera eravamo una famiglia.
Oltre al primo se ne schiusero altri sei.
L’ultimo tardò molto. Si schiuse quando oramai si intravedeva in cielo la luna, una luna piena
grande e luminosa da sembrare quasi un sole. L’ultima pesciolina decidemmo quindi di chiamarla
Luna.
Avevamo sette pesciolini da amare e far crescere.
«È questo che intendo per amore universale. Un amore incondizionato. Se tutti i pesci viventi
amassero il prossimo come io amo i miei sette figli, non credi che sarebbe un mondo migliore?»
«Hai ragione, ma è un’utopia.»
«È un’utopia se tu la credi tale. Se già noi due nel nostro piccolo cercassimo di aiutare il prossimo
con tutte le nostre forze, sarebbe un buon inizio. Dovremo poi spiegarlo in giro, spargere la voce,
contaminare gli altri col virus della bontà e dell’amore!»
«Tu non conosci il mondo là fuori. C’è chi non aspetta altro che approfittarsi delle persone buone.
Se ogni tanto venissi con me a fare una passeggiata te ne accorgeresti coi tuoi occhi. Ci sono pesci
pagliaccio che si alleano con gli squali, e per avere salva la vita confidano loro i nostri nascondigli.
E a volte capita che gli squali quando hanno fame si mangino pure loro. Gli umani non facevano
altro che ripetere “pesce mangia pesce”.»
«Pesce mangia pesce?»
«Riassume il concetto.»
«Ma allora visto che il mondo là fuori è così malvagio e pieno di insidie, perché non ce ne stiamo
qui dentro con i nostri pesciolini? Chi ce lo fa fare di rischiare la vita? Non stiamo forse bene qui?»
Libera rifletté alcuni istanti.
«Perché secondo me questa non è vita! Non è tutto! Ci dev’essere dell’altro.
«E poi vale più un giorno vissuto come dico io che mille tutti uguali.»
«Sì esatto, tutti uguali, ma fantastici, unici!» ribattei.
«No, non capisci. Non ha senso stare qui per sempre.» Fece una breve pausa e ricominciò.
«Sentiamo: come li educheresti i tuoi figli dentro una sfera di vetro? Loro hanno bisogno di vedere
la realtà, di toccare con pinna, di assaporare il gusto di vivere, di scoprire. Anche tu, anche se non te
lo ricordi, hai fatto un sacco di esperienze. È normale, è così che dev’essere!»
«Io la realtà me la immagino. Sta tutta dentro la mia testa. La creo, la mescolo con quel poco che
vedo, la immagino come voglio io. Non mi manca niente.»
***
«Li porto a fare un breve giretto, vieni?»
«Vi aspetto qui.»
Attesi con impazienza. Dentro di me crebbe un po’ d’ansia. Osservavo l’immensa e uniforme massa
blu che avevo davanti agli occhi farsi sempre più scura mentre il sole si allontanava. Ogni ombra
che scorgevo in lontananza mi faceva sperare che fossero loro, ma il tempo passava e ancora non
venivano. Mi assalirono i primi chiari sintomi di una paranoia che presto mi avrebbe divorato le
cervella. Presi a mettere ordine nella sfera. Feci e disfeci più volte i lettini di alghe che avevo
preparato con cura per i miei pesciolini. Riordinai i sassolini con precisione millimetrica. Ma nulla
mi distraeva dal pensiero fisso che non sarebbero più tornati. Forse uno squalo se li era divorati tutti
e Libera si era sacrificata per difenderli.
Cominciai a sporgermi dalla sfera e a gridare sperando mi sentissero e ritrovassero la via di casa.
Nulla. Solo il solito rumore di fondo dell’oceano. Solo quello.
«Sorpresa!»
Da dietro una roccia poco distante sbucarono i miei sette pesciolini e mi assalirono riempendomi di
baci. Libera mi guardava e rideva d’amore.
Le cose andavano sempre meglio. Io e Libera ci alzavamo presto al mattino. Facevamo la colazione
insieme, parlando della vita, dell’universo e della felicità, osservandoci negli occhi innamorati.
Sempre insieme, svegliavamo i pesciolini. Scoprii che non c’è niente di più bello che guardare i
propri figlioli dormire beati, baciarli e accarezzarli con dolcezza. Provare a svegliarli e guardarli
mentre si lamentano.
Durante la mattinata io e Libera ci dividevamo i compiti. Io insegnavo ai ragazzi la ginnastica, la
meditazione e il sogno lucido. Libera aveva il compito di educarli alle discipline pratiche come ad
esempio saper riconoscere il pericolo, nascondersi tra le pietre e orientarsi per ritrovare la via di
casa.
Quando il sole giungeva al culmine della sua traiettoria quotidiana, ci si trovava tutti e nove dentro
casa per mangiare e rilassarsi. Il pomeriggio era dedicato ai giochi con indovinelli e gare d’abilità.
Si premiava la squadra vincente e i perdenti si occupavano di preparare la cena. Chi vinceva aveva
tutto il tempo di dedicarsi alla creatività personale o di gruppo. I dintorni della sfera abbondavano di
castelli di pietra, tunnel e decorazioni con le alghe.
Prima di coricarsi io e Libera raccontavamo le nostre storie. Le mie inventate e le sue reali. Quando
tutti i pesciolini dormivano, noi due ce ne uscivamo e stavamo per qualche attimo senza fine a
intravedere la luna e le stelle.
Alla vita non chiedevo nulla più di quello che già mi aveva dato. Avevo una compagna e dei
pesciolini che amavo tanto. Nessuno ci disturbava. Stavamo in pace col mondo e con noi stessi.
Temevo però che Libera non la pensasse così. Anche se lei cercava di nasconderlo, non potevo non
notare nei suoi occhi chiari una tempesta di lampi, una fiamma che le bruciava nel profondo.
SOGNO LUCIDO
come fuggire dalla realtà e raggiungere paradisi artificiali
«Papi!»
«Arrivo,
«Che c’è pesciolini miei?»
«Papi! Sono riuscito a fare un sogno lucido!!!»
«Bravo, caro! Sapevo che prima o poi ce l’avreste fatta! Hai voglia di raccontarlo a me, alla
mamma e a i tuoi fratellini?»
Nell’ampolla l’atmosfera era euforica mentre fuori tutto taceva buio come ogni mattina.
«Allora…ero nell’oceano che nuotavo da solo. A un certo punto mi sono visto inseguitato da…»
«Inseguito, caro, si dice inseguito.»
«…sì papi, ho capito, fa lo stesso!...ero inseguito, ok?, da un grosso squalo bianco. Ho cominciato a
nuotare più veloce che potevo come mi ha insegnato la mamma. Lo squalo cattivo mi inseguitava a
tutta velocità. Allora continuavo a fare zig-zag e zig-zag come faceva sempre la mamma. Andavo
su e giù e di là e di qua più veloce della luce. Ma lo squalo mi stava per prendere perché sentivo il
suo fiato sulla coda. Finché non ho più visto nulla. Tutto buio.
«Lo squalo mi aveva inghiottito. Sono arrivato nel suo stomaco ma non ero da solo. C’era anche
una piccola pesciolina. Le dissi “non piangere, ti proteggo io!” ma lei continuava. Allora le ho detto
che mi ero fatto mangiare apposta per venire a salvarla. Lei mi abbracciò con le sue minuscole
pinne. Le dissi di stare lì ferma immobile che la tiravo fuori io. Mi allontanai. Cercai dappertutto
qualcosa di utile. Trovai un barattolo di latta mezzo aperto e mezzo chiuso. Era come quelli in
fondo all’oceano che ci ha fatto vedere la mamma che li hanno buttati giù quegli stupidi degli
umani. Vero mamma?»
«Sì caro, è come dici. Loro ci mettono dentro il tonno.»
«Il tonno? Papi cos’è il tonno?»
«Il tonno? È un pesce cattivo grande grande che se ti vede ti mangia! Dovete sempre stare attenti al
tonno! Ok?»
«Ma papi,» disse Luna, la pesciolina più piccola «un amico della mamma l’altro giorno ci ha detto
che al tonno gli umani ci tolgono la pelle e lo lasciano vivo e poi lo tagliano che lui è ancora vivo e
poi lo mettono nelle macchine trituratrici che lui urla e grida perché muore di male e il sangue gli
spruzza via mentre muore! È vero papà? Vero che è vero?»
Mi girai verso Libera con gli occhi che lagrimavano. Lei non sapeva cosa dire e mirò lo sguardo
dritto a terra.
«No ragazzi, l’amico di mamma stava dicendo le bugie. Gli uomini non sono così cattivi. Ma ora
volete o no sentire come finisce il suo sogno?»
«Sììì!» gridarono in coro mentre il cuore mi pesava come non mai.
«Allora ho preso il barattolo tra i denti e l’ho usato per tagliare la pelle dello squalo. Ho ritagliato
un buco e poi ho preso la piccola pesciolina e l’ho spinta fuori dal buco e poi sono passato anch’io
dal buco. Lo squalo allora si è girato, mi ha preso tra dente e dente, e mi ha spappolato vivo. Poi mi
ha sputato via in cinque pezzi. Mentre cadevo verso l’alto papi, ho visto la piccola pesciolina che
prendeva la mia testa e mi inseguitava per portarmela. Quando è arrivata vicina vicina mi sono
trovato di fronte i miei occhi. Tutti e due. Allora ho capito che qualcosa non andava. Poi ho pensato
che era impossibile che ero in tanti pezzi e non avevo sentito male. E poi non perdevo neanche
sangue. Ho controllato dove era la coda e ho visto che si era attaccata e che adesso ero tutto d’un
pezzo. Allora ho pensato a te papi che ci raccontavi i tuoi sogni lucidi e non ho avuto più dubbi che
stavo sognando.
«Allora ho preso la piccola pesciolina e gli ho detto “adesso andiamo a vendicarci!” e lei mi ha fatto
un sorriso che era contenta che andavamo a vendicarci. Raggiunto lo squalo bianco ho cominciato a
morderlo sul naso mentre lei gli mordeva la coda a quel cattivo! E poi piano piano ce lo siamo
mangiato tutto finché le nostre labbra si sono incontrate e poi ci siamo baciati e sono nati tre
piccolini pesciolini, più piccoli di Luna, che ci hanno detto ciao e poi te, papi, uffi!, mi hai
svegliato!»
Quello fu il primo, ma non l’unico. Anche gli altri pesciolini riuscirono a intrufolarsi lucidamente
nei propri sogni. Oramai la colazione la passavamo a raccontarci i nostri sogni. L’unica a non
riuscirci era Libera. Non capiva come fosse possibile essere coscienti mentre si dorme. Le spiegai
più volte che era un dormiveglia e non un sonno vero e proprio. Niente da fare, lei sosteneva che
era sbagliato fare quello che facevo. Non dovevo insegnare ai nostri figli a passare la vita a
dormire e a raccontarsi tutto il giorno i sogni fatti durante la notte. Lei continuava a ripetermi che
la vita andava vissuta veramente, “non dormendo, ma muovendo il sederino…”
2
y
Sapevo che prima o poi sarebbe successo. La convivenza aveva seguito un'iperbole discendente fino
a giungere una piattezza assoluta. Eppure non riuscivo a rinunciare a lei. Non volevo affrontare il
mondo da solo.
“No, ti prego! Non lo fare, non ho altro che te!”
Mi vergogno a dirlo ma la pregai come un bambino viziato che vuole la mamma.
La scongiurai tra le lacrime: “Ti prego! Ti amo, Salomè! Ti amo tanto!”
Non parlava mentre si preparava.
“Non ce la faccio senza di te! Ti prego, aspetta! Cambierò!”
Non apriva bocca. Fece un giro veloce in casa e afferrò la maniglia. Cominciai a gridare
aggrappandomi ai suoi jeans. Piangevo a dirotto, come un deficiente. Sapevo che non sarebbe
tornata. Singhiozzavo mentre la vedevo scendere gli scalini con lo zaino in spalla e il trolley nella
mano destra.
A quel punto vidi mia madre spalancare la porta del suo appartamento.
“Torna pure in Spagna, puttanella! Vai a farti fottere, ladra del cazzo!”
Non mi uscivano più parole di bocca, solo gemiti e singhiozzi.
Avrei voluto dirle ancora che l’amavo.
Udii il portone chiudersi.
“Tirati su, campione!" disse mia madre, "vieni dalla tua mamma.”
Mi prese tra le braccia e mi sollevò mentre scivolavo a terra. Mi trascinò nel suo appartamento.
Ammiravo inconsapevole i suoi nervi tesi, scivolando sulle mie stesse lacrime.
Mi portò sul lettone. Mi levò le scarpe. Mi tolse la camicia e mi distese sul letto. “D'ora in poi
penserò io a te.”
Mi sfilò i pantaloni e i calzettoni uno per volta con delicatezza.
“Lasciami stare, mamma. Non ne ho voglia.”
Mi baciò sulla fronte.
“Piccino, adesso sei della tua mamma. Solo e per sempre delle tua mamma.”
Si sbottonò la camicia e se la sfilò. Estrasse un seno molto più grande di quello di Salomè. Lo
avvicinò alle mie labbra. Lo schivai voltandomi di lato. “Penserò a tutto io ora.” Sentii una mano
raggiungermi lì.
Funzionava.
Alla faccia di Salomè!, pensai.
“Rilassati, penserò a tutto io, piccino mio."
“No, lasciami, mamma!" gridai. "Che cazzo stai facendo?”
“Rilassati, fai la nanna…”
“Lasciami, mamma, lasciami in pace” dissi col poco fiato che avevo in corpo.
Piangevo mentre lei s’inchinava al mio cospetto.
Radunai tutte le forze che mi rimanevano e gridai: “Adesso basta!”
Allontanai mia madre in malo modo facendola cadere dal letto e coi pantaloni alle ginocchia corsi
via più veloce che potevo verso il mio appartamento inciampando e sbattendo in ogni dove finché
non trovai le scale e le salii rapido e cadendo ripetutamente varcai la soglia e chiusi la porta e girai
la chiave terrorizzato senza capire senza pensare senza sapere senza volere.
y
Non sapevo dov’era Luigi. Non sapevo dov’era Salomè. E non sapevo dov’ero neppure io, se
ancora esistevo. Se ancora aveva un senso esistere.
Telefonai a Zeno e gli raccontai tutto. Gli dissi di mia madre. Mi invitò ad andarlo a trovare. Presi
due settimane di ferie e senza capirci niente mi ritrovai su una nave diretto in Inghilterra. Toccai il
suolo inglese non meno spaesato di quand’ero in Italia.
Zeno mi aspettava al Brighton Pier.
“Ciao.”
“Ciao, Zeno.”
“Lasciamo le valigie a casa, ok?”
“Ti seguo.”
Abitava in centro. In un attico che dava sul mare. L’arredamento era minimale. Grandi quadri alle
pareti e scaffali di libri. Niente armadi.
“E Maria?”
“È in gita con la bambina sulle scogliere di Seven Sisters. Vieni, scendiamo all’aria aperta.”
Camminammo nei vicoletti del centro fino alla spiaggia.
"Come sta tua madre, Giovanni."
"Scusa, ma non ho voglia di parlarne. Ho soltanto voglia di camminare." E stare al suo fianco. Zeno
mi dava tranquillità.
Dopo un lungo silenzio vidi Zeno sorridere e guardare l’orizzonte che delimitava mare e cielo. “Qui
non succede mai nulla di speciale.”
Il vento sferzava gelido.
“Zeno, non sai quanto ti invidio. Tu hai tutto, un lavoro gratificante, una moglie che ti ama e una
bambina bellissima” ammisi a malincuore. “Io non ho niente di tutto questo.”
Restammo di nuovo in silenzio.
Io avevo bisogno di parlare.
“Il mio migliore amico voleva andare a letto con la mia fidanzata, lei se n’è andata per sempre, mia
madre, che prima si scopava il mio migliore amico, ora è in un letto d'ospedale: è lì da quindici
mesi, non fa altro che insultarmi."
Presi fiato e ripresi.
"Sono solo e ho un lavoro che fa schifo. Non so nemmeno più se..."
Mi bloccai di colpo. Non volevo pronunciare certe parole.
“Ne vale sempre la pena, Giovanni” disse Zeno con prontezza. “Non te lo dimenticare mai.”
Perché era sempre così saggio lui? E io così sciocco e così sfortunato da perdere tutto?
“Sono un perdente.”
“Hai solo trentacinque anni, perché abbattersi tanto? Hai tempo per cambiare lavoro e trovarti
un’altra ragazza.”
“Io non sono come te o come quello stronzo di Luigi. Io ho bisogno di garanzie. Non riesco a
buttarmi nelle cose come fate voi. Tu hai avuto il coraggio di sposarti e di avere un figlio quando
ancora guadagnavi meno di me. Luigi ha mollato un posto da quinto livello per scappare dalle
responsabilità. Io non ho nemmeno avuto il coraggio di cambiare lavoro."
Smisi di camminare. Zeno no.
Ripresi a camminare e a parlare.
"Non voglio allontanarmi da mia madre, la sua malattia potrebbe durare ancora a lungo, e io le
voglio stare vicino fino alla fine."
Zeno ascoltava senza guardarmi. Una raffica di vento mi colpì in pieno viso.
“E comunque lo so che questa è solo una scusa: sono ancora un bambino pauroso che non trova il
coraggio di lasciare la strada vecchia per provarne una nuova.”
Finalmente mi osservò.
“Capisco” disse Zeno. “Perché allora non cerchi lavoro qui a Brighton? O a Londra?”
“Il mio inglese fa schifo, nessuno mi assumerebbe.”
“Potresti iniziare con uno stage e poi…”
“Lascia perdere, Zeno, sai che non lo farei mai. In Italia c’è la crisi, e presto arriverà anche qui. Non
posso licenziarmi. Terrò duro, almeno per un po’.”
"Mentre tua madre è in ospedale, inizia a studiare l'inglese, fai dei corsi, poi si vedrà." Rifletté
qualche secondo prima di parlare. “Che dici, ci facciamo una pinta? Dobbiamo brindare alle tue
vacanze, vieni!”
A forza di camminare eravamo arrivati a Hove, una cittadina nella stessa contea di Brighton. In
fondo a un lungo prato c’era un pub. Aveva un tetto di legno corvino sul quale cresceva rigogliosa
una folta erba verde. All’interno non c’era ancora nessuno a parte un barista dalla barba grigia.
Brindammo alle nostre vite.
“Sai che Maria è incinta?”
“Stai scherzando?”
“No, te lo giuro.”
“E non c’è due senza tre!” dissi stringendo una mano sopra la sua spalla.
“Cheers!”
“Cheers!”
Decidemmo di tornare coi mezzi pubblici. L'autobus ci lasciò a una cinquantina di passi da casa di
Zeno. Li percorremmo reggendoci l'un l'altro, più per gioco che per necessità. Maria ci accolse alla
porta.
Salutai la bambina.
“Guarda, Rebecca, cosa ti ha portato lo zio Giovannino” dissi mostrandole un lecca-lecca al
lampone, da sempre il mio frutto preferito. La presi in braccio e la baciai su una guancia.
“Zeno mi ha detto della novità. Complimenti, mammina!” dissi abbracciandola.
“E con Salomè?”
Prima di rispondere andai a sedermi sul divano in eco-pelle bianca. Sulle pareti, anch'esse bianche,
c'era un quadro qua e là. Tutti astratti e per me incomprensibili.
“Non la sento da mesi. Se ne è andata due anni fa e non si è fatta più sentire. Non so come, ma è
riuscita a farsi trasferire a Madrid. Anzi, un’idea ce l’avrei...” dissi mentre fissavo il pavimento.
“Non credo mi abbia mai amato veramente. Le facevo comodo, tutto qua.”
“Non dire così” rispose Maria. “Noi donne amiamo più di quanto voi pensate. Devi averla
trascurata, altrimenti non se ne sarebbe andata.”
Aveva ragione. Nell’ultimo anno non parlavamo quasi più, sedevamo al ristorante come due
estranei, ci baciavamo senza passione, come potrei baciare un uomo.
Li guardai entrambi. “Eppure mi manca, ragazzi, mi manca da morire.”
Sbottai in un pianto improvviso. Venne fuori tutta la tristezza che si nascondeva in me come vomito
in un corpo marcio. “Mi dispiace, scusatemi.”
“Piangi quanto vuoi. Sfogati, ti farà bene” disse Maria passandomi una mano sulla schiena.
Y
Morì nel suo letto dopo mesi trascorsi in ospedale. “Sei un bravo ragazzo, Giova. Continua così,
comportati bene e sarai felice. Scusa se ti ho dato dei dispiaceri. Tuo padre non mi ha mai amata.
Sono contenta se ne sia andato presto, quel bastardo. Siamo stati meglio senza di lui, vero? Io e te
da soli, meglio che male accompagnati, no? Meglio che stare con quella cagna spagnola, vero?” mi
disse qualche ora prima di morire. “Mamma, sei stata una buona madre” dissi sapendo di mentire.
Mi baciò sulla bocca un’ultima volta prima di cadere nel sonno che l’avrebbe condotta alla pace
eterna.
L'anno successivo, nel cassetto del suo comodino, trovai una lettera.
Caro Giova,
non sai quante volte avrei voluto dirtelo, ma ti vedevo sempre così piccolo e indifeso… non volevo
ferirti, ti ho sempre considerato un figlio, il mio unico figlio.
Quando ci siamo sposati io e il mio ex-marito avevamo in progetto una famiglia numerosa. Gli anni
passavano e non rimanevo incinta. Scoprimmo che ero sterile e il nostro matrimonio si sfaldò. Ci
rivolgemmo a un'associazione per le adozioni internazionali e arrivasti tu. Ti chiamammo Giovanni,
era un nome che piaceva sia a me che a mio marito. Il tuo nome era Piotre quando ancora vivevi in
un orfanotrofio nella periferia di Leningrado.
Passò un mese e mio marito mi lasciò. Non riesci a ricordarlo perché non l’hai mai conosciuto, se
non durante quelle settimane. In un certo senso tu l’hai sostituito nella mia triste vita.
Addio mio bel bambino, ti ho voluto bene, forse anche troppo, ma perdonami, non avevo altri che
te.
La tua mamma,
Teresa
Io e quella donna avevamo condiviso tutto: tempi, spazi, ansie, paure, sogni, desideri. Quando mio
"padre" se n’era andato, avevo solo cinque anni.
Avevo rimosso tutto. I ricordi affioravano soltanto ora, assieme alle lacrime.
All'inizio mantenni per me quel segreto.
I primi mesi passavo da lei dopo il lavoro. Ogni domenica andavo a trovarla al cimitero dopo la
messa. Lasciavo un fiore e le parlavo. Poi la sera per stare tranquillo mi bastava una preghiera
prima di coricarmi a letto.
Alla fine scoppiai. Spiegai la scoperta a Zeno in una lunga mail. Mi chiamò pochi minuti dopo
cercando di consolarmi e di farmi rivalutare positivamente la novità. Mi invitò a fare un viaggio con
lui a San Pietroburgo per cercare i miei veri genitori. Mi colpirono le sue parole, pareva se le fosse
preparate da una vita: …una signora impossibilitata ad avere figli per problemi fisiologici, ma che
voleva tanto essere mamma da arrivare a soddisfare ogni tuo desiderio – anche nel caso del
piacere sessuale. Sembra che il suo obbiettivo nella vita – parliamo di una baby-pensionata che
passava le giornate a casa da sola – fosse allevarti nell’evidente impossibilità di amarti come fossi
un vero figlio. Il troppo amore – la soffocante passione con la quale ti ha accompagnato fino
all’età adulta – è certamente dovuta alla sua voglia di diventare madre: possibilità irrealizzabile.
Dopo il fallimento del suo matrimonio – e quindi del suo essere moglie – non le rimaneva che
cercare di diventare madre. Così si è dannata l’anima per decenni per interpretare il ruolo di
mamma – certamente condizionandoti la vita – ruolo che sentiva di non poter interpretare nel
migliore dei modi...
Zeno diceva la verità, quella povera donna mi aveva amato troppo (lo ammetteva lei stessa nella
lettera) condannandomi a essere un piccolo uomo, un eterno sconfitto, un perdente senza nome.
Non raccontai la triste scoperta a nessun altro. In fondo Teresa, una mezza pervertita qualunque
nemmeno in gradi di svezzarmi, di fatto era mia madre, e tale doveva rimanere.
Un giorno passò una giovane coppia a vedere l'appartamento di mia madre.
"Buongiorno."
"Buongiorno, entrate."
Arrivarono a offrirmi mille euro per l’affitto. Ci pensai a lungo. Mi turbava il fatto che degli
estranei sverginassero il corpo fisico dove io e mia madre eravamo vissuti e cresciuti assieme negli
ultimi vent’anni. Cosa me ne facevo di un altro stipendio? Il lavoro mi piaceva. Mi occupava le
giornate. Mi dava la forza di alzarmi ogni mattina. Cosa me ne facevo di altri mille euro?
"Affitta anche il tuo, poi licenziati e vieni a vivere qui!" disse Luigi quando riuscii a mettermi in
contatto con lui.
"Lo sai che il mio posto è qui."
"Ma non hai più nessuno! Che ci fai laggiù tutto solo?"
"Non posso. Il garage senza di me diventerebbe ingestibile..."
"Ma che cazzo te ne frega? Sei scemo?"
"Ormai laggiù mi sento a casa. I colleghi sono la mia famiglia, non posso abbandonarli."
"…"
"Luigi?"
"…"
Era caduta la linea.
Aspettai che mi richiamasse: non lo fece.
y
Senza amici, senza donna e senza madre, non mi rimaneva che il lavoro.
Mi alzavo presto la mattina, quando ancora faceva buio. Uscivo a prendermi il giornale all’edicola
dietro l’angolo e tornavo in casa per leggerlo durante la colazione. Alle sette mi vestivo e uscivo per
andare al lavoro. Ero sempre il primo a timbrare e l’ultimo ad andarmene, così come farebbe un
capo diligente.
Le cose nel garage non cambiavano. Sempre le stesse facce, le stesse occhiaie, i soliti aliti pesanti.
Nonostante la legge lo proibisse, quasi tutti fumavano seduti alla propria scrivania. L’odore di
sudore rancido che emanavano i loro corpi ignoranti era ormai una consuetudine che mi faceva
sentire a casa. Anche se molti mi consideravano un diverso e mi isolavano, i colleghi facevano
riferimento a me. Ero il fulcro del garage. Il motore. Se mancavo io, si fermava tutto. Ero
indispensabile.
Avevo un contratto a tempo indeterminato e una paga che mi permetteva di vivere dignitosamente.
Le cose non mi andavano male. Aspettavo ancora una promozione, ma senza l’assillo dei primi
tempi. Se dall’alto mi avessero finalmente notato, bene, altrimenti mi sarei accontentato di quella
vita semplice e abitudinaria. Mi svegliavo tranquillo. Tornavo a casa nel tardo pomeriggio senza
preoccupazioni. Avevo tutte le sere e i fine settimana da dedicare alle letture e alla televisione.
y
Non ce la facevo.
Nulla aveva senso.
Non ce la facevo a continuare a fingere di stare bene, quando invece il mondo era diventato un
inferno sena senso.
Ero solo. Abbandonato da Dio e dall'umanità. Che mi rimaneva?
Volevo scappare da tutto, rifugiarmi. Nascondermi in un posto buio. Scomparire.
Una mattina anziché andare al lavoro, mi recai al santuario delle Laste. Entrai nel convento e attesi
inginocchiato a terra nell'atrio. Contro il muro bianco.
Dopo una mezzora, entrò un carmelitano scalzo. Era alto, magro e decisamente bello.
"Voglio farmi frate!" dissi senza dargli il tempo di parlare. "Adesso, subito."
Mi guardò a lungo. Dovetti sembrargli un pazzo. Probabilmente lo ero.
"Aspetti, le chiamo il diacono" disse quello con voce gentile. "Un minuto e saremo da lei."
Attesi pochi secondi. Poi mi alzai e scappai. Corsi fino a casa. Senza salire, montai trafelato in
macchina e, completamente sudato, andai dritto in azienda. Speravo di riuscire a timbrare in tempo.
Come se niente fosse successo.
Cancellare. In un modo o nell'altro la mia vita era sempre schiava di un verbo. Cancellare.
Prima d'ora non avevo mai raccontato a nessuno questa storia.
Mi vergognavo. Mi facevo pena.
Mi odiavo.
Y
Quando scrissi a Luigi erano mesi che non ci sentivamo. Sapevo che Salomè era da lui in Brasile,
me l'aveva detto lei stessa. Sapevo anche che Zeno si sarebbe presto stabilito in California con
Maria e i tre figli. Mi tenevo al corrente. Si potrebbe dire che io ero il punto fisso attorno al quale
loro ruotavano senza sosta: ero la base dei loro spostamenti, e ne ero orgoglioso.
Caro Luigi,
sono qui sul divano di casa, come ogni sera, la TV accesa, solo e depresso. Ciò che mi spaventa è la
crisi. I giornali dicono che sta per arrivare, che sarà un evento epocale, che andrà tutto a rotoli. In
effetti le cose non vanno un granché: ci sono fabbriche che chiudono, licenziamenti, casse
integrazione, contratti di solidarietà e ferie forzate: insomma, non si può negare che qualcosa stia
succedendo. Gli esperti dicono che questo non è niente rispetto a quello che accadrà. Mi ritrovo con
il solito dubbio, andare o rimanere? I pochi colleghi ingegneri che incontro per strada mi ripetono
"schiodati da questo schifo, tu che puoi, tu che non hai famiglia!", però, prima di lasciarmi,
aggiungono sempre “comunque, di questi tempi occhio: non è oro ciò che luccica!”, poi ammiccano
e se ne vanno ridendo; oppure “chi troppo vuole nulla stringe, amico mio!”, però anche "scappa fin
che puoi!" gridano facendo il segno delle manette, sempre sorridenti, quasi a indossare una
maschera per coprirne un'altra. Ogni volta mi ritrovo più confuso di prima. L’unico ad avermi
sempre detto di seguire il mio istinto sei tu, Luigi: tu sì che sembravi sempre sicuro ci ciò che era
meglio fare! Comincio a pensare che sia tu il vero genio (anche se hai un voto di laurea molto più
basso del mio): hai realizzato il tuo sogno facendo sempre ciò che ti piaceva, senza pensare al
futuro, vivendo alla giornata.
Ciao,
Jo
La mail di risposta che mi scrisse dal Brasile diceva che… be', ve la riporto tale e quale:
Ciao merdoso,
sempre lì a non fare un cazzo tutto il giorno? Be', anche qui è lo stesso: bici, surf e tante, tante
scopate, naturalmente. Senti, baby, la vuoi smettere di accumulare ferie? Immagino sarai già sopra
ai cento giorni, vero? Guarda che sono un tuo diritto, sacro e santo: pensa a me: sono sempre in
ferie e sto benissimo! Dai, racconta! Come stai, tutto ok?
Senti, Zen è finito in California, l’ho sentito l’altro giorno. Mi ha detto che ha fatto delle consulenze
nella tua azienda, è vero? Fantastico! Avrete fatto un bel casino come ai vecchi tempi, eh?!
Dai, scherzo, lo so che se non ci sono io non ingurgitate manco una triste birra!
Invece mi ha detto che è appena arrivato in California e la famiglia lo raggiungerà tra qualche
tempo. Quindi, è il momento giusto per andare a trovarlo! Ora o mai più! Che ne dici? Io, te,
Salomè e Zen, tutti assieme: meglio di così!
Prenota subito, non deludermi! W i quarantenni!
Baci, bello!
Come al solito era spavaldo e sicuro di sé, sempre pronto a ostentare le sue conquiste sessuali. Però
aveva ragione, mi dovevo dare una mossa.
Aveva ragione anche sulle nostre tristi birre. Zeno era rimasto a casa mia quasi un mese per via
delle collaborazioni esterne con l’azienda e devo ammettere che non sembrava molto felice di stare
qui. Abituato ai ritmi londinesi, agli scenari mozzafiato di Brighton, ai pub, alle scostumate ragazze
inglesi, quando, appena arrivati a casa, mi vedeva accendere la TV, faceva una smorfia. Sapevo di
sbagliare, ma quell'aggeggio era la mia droga, non ce la facevo a spegnerla.
Sono un merdoso, ha ragione Luigi. Passo le serate davanti alla televisione e i giorni a lavorare
insoddisfatto. Zeno deve essersi fatta una brutta idea sul mio conto. Non ho più nessuno stimolo a
uscire, se non a fare la spesa o salutare mia madre al cimitero.
Zeno cercò di portarmi fuori a cena, in un bar, a un concerto. Apprezzavo i suoi sforzi per farmi
evadere da una vita insulsa e monotona. Eppure non mi portò a nulla. Non incontrai la donna della
mia vita, anzi, mi sentii vecchio, inadatto alla vita mondana. Largo ai giovani, io le mie possibilità
le ho avute, e me le sono bruciate: prima perché volevo a tutti i costi un inutile centodieci e lode,
poi perché avevo scelto la donna sbagliata.
Curioso. Dopo la mail di Luigi che mi spronava a prenotare subito un biglietto per la California,
non riuscii a dormire: mi si riaprirono vecchie ferite, vecchi dubbi, vecchie paure. Presi allora in
mano Il Fermo e Lucia che tenevo da anni sul comodino. Lo finii di leggere all'albeggiare del
nuovo giorno. Mi alzai felice, certo che la divina provvidenza mi avrebbe prima o poi aiutato. Il
curioso non era per tutto ciò, ma per la lettera che mi ritrovai sulla scrivania.
Buongiorno,
la nostra azienda le porge le dovute scuse per un errore commesso durante il primo anno in cui lei
lavorava con noi.
Soltanto in questi giorni infatti il nostro ufficio personale ha provveduto a controllare i suoi dati
all’interno della nostra memoria centrale. Si è riscontrata una non corrispondenza che prontamente
abbiamo provveduto ad eliminare, aggiungendo ai nostri dati il suo certificato di laurea.
Ci scusiamo per l’increscioso errore nel quale si è incappati, e con grande piacere e onore le
comunichiamo il suo pronto collocamento non al quarto livello come si potrebbe pensare, ma,
considerato anche il superamento da parte sua di numero sette anni di servizio, direttamente al
quinto livello della nostra azienda, con le dovute scuse.
La preghiamo dunque di presentarsi…
Non finii di leggerla che la strinsi nel pugno della mano destra e lasciai sgorgare le lacrime.
Lacrime di gioia, ma anche di rabbia per uno stupido errore burocratico fonte di sconforto e infinito
dolore per me e mia madre.
Con il viso riverso presi le mie cose e salii le scale senza dire nulla, senza incontrare sguardi, senza
farmi notare. Mentre salivo di gradino in gradino vedevo la luce. Mi sentivo un minatore
intrappolato per anni nella madre terra che riscopre l'esistenza di un mondo illuminato che aveva
ormai dimenticato.
Abbandonavo per sempre il buio stantio e le lampade al neon di quel maleodorante garage.
Vidi le finestre in un trionfo di vitalità. Stavo rinascendo. Mi era stato fatto un torto e finalmente mi
riprendevo ciò che mi spettava: visi sorridenti, gente profumata, scrivanie chiare dal design
ricercato, e soprattutto luce: luce che entrava dai finestroni che circondavano il quinto piano: tanta
luce da abbagliarmi.
Mi avvicinai e guardai fuori: alberi, parchi, montagne: e un leggero riflesso nel quale un uomo
stempiato piangeva come una moglie che pensava di aver perso il marito in guerra e lo vede
ritornare.
“Salve.”
“Salve,” risposi sorridendo, bagnato dalle lacrime.
“Benvenuto!”
Ce l’ho fatta dissi tra me e me.
Ero così contento e pieno di fiducia che decisi, in quel preciso istante, di andare da Zeno negli Stati
Uniti. Sistemai le mie cose sulla nuova scrivania, andai in bagno a rinfrescarmi un po’, e mi
presentai al capo.
“Entri.” Fu quella parola, bastò quella semplice parola a farmi capire dov’ero capitato e perché ci
ero capitato. Quell’entri che poteva sembrare di primo acchito una semplice forma di cortesia,
arrivò al mio cervello come un incubo. Il tono di voce mi fece tornare in mente un passato che
credevo superato.
“Tu entri pure, vecchio Longo!”
“Salve, capo” dissi con tutta l’ironia che riuscivo a dimostrare in quegli istanti.
“Longo, ti piaci allora qui ai quinti?”
Ebbi quasi un conato di vomito, ma risposi. “Sì, capo. Mi trovo bene.”
“Cerchiamo di dimenticare i passati e ricominciamo da capi.”
“Sì, capo.”
“Beni. Molti beni!” disse soddisfatto col solito ghigno. “Ti farò affiancare da uno di colleghi. Tu sei
facile per imparare senza problemi. Impegnati e tutto sarà beni.”
“Sì, capo” dissi mentre afferrai la maniglia per uscire. “Ah, dimenticavo…”
“Sì, Longo?”
Mi bloccai in un attimo di indecisione. “No, fa niente.”
“Meglio così, Longo” disse sogghignando.
Chiusi la porta dietro me. Quell’ultimo ghigno proprio non mi andava giù. Mi dissi “Vaffanculo!” e
senza bussare entrai e con tono secco gli dissi: “Alex, ho bisogno di ferie. Le voglio subito, ne ho
accumulate tante e mi serve un mese subito."
Provai ad abbozzare un tenue sorriso. "Devo digerire questa promozione, non sono abituato a tanta
luce…”
Rimase in silenzio.
“Ferie tu hai risparmiati no valgono. Te saranno pagati in buste di paghe. Ora inizi da capi tuo
lavori. Zero ferie maturati, capisci?”
“Ti prego, Alex, non potete fare così, le ho risparmiate con tanta fatica, non me ne faccio niente dei
vostri soldi, ho bisogno di un mese di relax lontano da qui, sto impazzendo…”
“Ferie no trasferibili. Questo è altri di lavori. Tuoi centoundici giorni pagati in buste paghe, no
problemi.”
“Senti, non me ne frega niente dei vostri fottuti soldi, io voglio…”
“Longo, io sono capi. No parlare così."
Mi guardò per un minuto senza dire niente. "Chiamo superiori.”
Prese la cornetta e con un italiano incerto fece scendere uno del sesto.
“Salve” dissi.
Quello manco mi salutò. “Qual è il problema, signore?”
Signore? Uno del sesto dava del signore ad Alex? Non ci capivo più niente delle dinamiche
dell’azienda. Certamente era Alex ad avermi voluto con sé per potermi umiliare, di questo non
dubitavo. Dopo aver messo le mani su Salomè, e forse anche qualcos’altro, adesso voleva di nuovo
torturare me, forse per quella voglia di far carriera che avevo stampata in faccia i primi mesi in
azienda. Ma ora ero diverso, volevo ancora crescere, migliorare, ma ero tutto tranne che arrivista, la
vita mi aveva piegato.
Questo Alex non lo capiva e chissà quando l’avrebbe smessa di tormentarmi. In meno di dieci anni
quello stronzo era passato da impiegato semplice al terzo, a capo reparto al quinto, e questo senza
spiaccicare una frase senza errori: doveva avere ottimi agganci in alto. Giù in garage si diceva che
fosse stato a letto con la moglie del amministratore delegato e che l’avesse poi ricattato.
“Senta, signor Bongo, dunque…”
“Scusi, mi chiamo Longo, ingegner Giovanni Pietro Longo, per la precisione.”
Quello mi guardò incazzato.
“Ok, senti, taci un secondo e abbassa i toni, ok? Ti hanno appena promosso, non tirartela subito”
disse quello, prendendomi per ciò che non ero.
“Mi scusi” dissi reprimendo a stento una rabbia straripante.
“Visto il nostro increscioso errore le daremo due settimane di ferie non pagate, facendo partire
formalmente il nuovo contratto alla fine di marzo. Per quello che riguarda i mesi di ferie accumulati
al terzo, se non ne ha usufruito, peggio per lei. Mi spiace, ma quelle giornate gliele dovremmo
pagare, e, come saprà, si tratta di poco più di venti euro al giorno. Questo è tutto. Arrivederci e
buone vacanze.”
Se ne andò veloce come era venuto. Alex mi guardava.
“Stavolta hai avuti ferie che volevi. Prossime di volte sarò io a decidere per te, quindi preparate.”
“Sì, capo” dissi. Non sapevo se essere felice o meno. Non tornai nemmeno alla scrivania e uscii a
comprarmi degli abiti degni del quinto piano nel centro commerciale vicino all’azienda.
Mi recai all’agenzia di viaggi sotto casa, nella quale non avevo mai messo piede, e presi il primo
biglietto disponibile per gli States.
Y
Tornai dagli States con la valigia piena di tecnologie: una macchina reflex digitale che nemmeno
sapevo usare, i-pod nani, lettori mp3, notebook, e-book e altre cose di cui non conoscevo l’utilità,
ma che avevo sentito più volte nominare in televisione.
Era stata una vacanza straordinaria. Avevo riallacciato un rapporto sincero con Salomè. Eravamo in
contatto anche prima, ma adesso la sentivo di nuovo, in qualche modo, mia.
La vita passava e io ero sempre solo, a casa e in ufficio. Non avevo amici, non avevo una ragazza, e
nemmeno un parente. Scoprii che con il portatile potevo chattare e video-chiamare chiunque nel
mondo. Era un passatempo migliore della TV. Un diversivo per trascorrere le serate in compagnia e
imparare nuove lingue. Negli ultimi tempi sentivo spesso ragazze dell’est: polacche, russe, rumene:
un giorno avrei scelto la più bella e me la sarei sposata. Può sembrare triste, ma, passati i quaranta,
ci si deve accontentare.
Al lavoro stavo soffrendo le pene dell’inferno. Lo stipendio era più alto, finalmente avevo un PC,
una scrivania pulita, respiravo un’aria profumata, avevo finestre dalle quali vedevo il mondo
esterno: c’erano anche dei contro. Non finivo più di lavorare a metà pomeriggio, uscivo dall’ufficio
sempre dopo le sei. Non era questo il vero problema. Il vero problema aveva un nome e un
cognome: Alex Dengue.
Era lui a obbligarmi a turni massacranti. Dico turni, perché spesso mi imponeva di saltare la pausa
pranzo e arrivare alle sette di sera distrutto, desideroso di una doccia, una cena veloce e un letto
comodo. Fosse stato solo questo, mi sarei anche adeguato.
“Longo, tu vieni ore sette e timbri ore nove, ok?” mi disse quando mi convocò in ufficio al ritorno
dalle mie ferie negli States. “Alle uscite tu timbri come altri di ore, e poi torni qui da me per lavori.”
Lo guardai inferocito.
“Guardi, Longo, che se non c’ero di io, tu ancora giù eri nei garage. Capiti?” disse accendendosi
una cicca e soffiandomi il fumo in faccia. “Come credi io arrivati qui?”
Accennai un sorriso che bene interpretò.
“Longo, tu non capisci di niente. Tu credi cosi sbagliati.”
Fece un lungo tiro di cicca.
“Io sudati tutti livelli. Io fatti te tranelli, ma come credi passaggi da quarti a quinti poi? Io lavorati
duri in anni di sudori. Sempre fermi qui fini a tardi e mattini presto sempre primi di tutti. Uniche
possibilità per crescere in aziende. Capiti?”
“Capiti, capo.”
Un po’ mi faceva pena. Doveva aver lavorato veramente duro in questi anni. E comunque non si
spiegava come un analfabeta fosse diventato responsabile di quinto livello.
Lo capii soltanto anni dopo.
Imparai in fretta. Presi il vizio di portarmi il lavoro a casa, così prima di andare a dormire mi
portavo avanti. Al mattino alle otto in ufficio c’eravamo solo io e Alex. Gli portavo ogni mattina il
caffellatte con la brioche e un’aranciata appena spremuta dal sottoscritto. Mi chiedeva di
accendergli le sigarette, di mettere in ordine la sua scrivania, di eseguire una scansione antivirus sul
suo PC: lo faceva unicamente per umiliarmi. Tra le otto e trenta e le nove, mi dettava la lista della
spesa, della sua spesa per casa, e poi mi dettava delle mail da scrivere e inoltrare per conto suo.
Quando tutti i colleghi erano arrivati, mi permetteva di timbrare l’entrata. Alla pausa pranzo, se
Alex non mi chiedeva di assisterlo, mangiavo coi colleghi in mensa. Quando loro tornavano a
timbrare il cartellino, io correvo a fare la spesa per Alex e poi scattavo a timbrare anch’io, spesso
fuori tempo massimo.
Avevo capito che solo stando con lui e osservandolo da vicino avrei capito il segreto del suo
successo. Era faticoso e frustrante, ma io la consideravo una palestra di vita d’azienda, una
possibilità unica e irripetibile di entrare nelle simpatie di un futuro dirigente di settimo livello. Alex
aveva provato più volte in passato a portarmi via Salomè, ma era riuscito soltanto a portarla a letto.
Aveva calpestato il mio orgoglio di uomo, ma forse potevo sfruttare questo suo attaccamento nei
miei confronti e trasformarmi nel suo uomo di fiducia.
Passai anni a lavorare al suo fianco. Passavo a prenderlo al mattino e lo riportavo a casa la sera.
Capitava cenassimo insieme. Mi aveva presentato sua moglie, una delle donne più belle che avessi
mai conosciuto. Un seno florido e palesemente finto, due gambe lunghe e magre, un viso russo e un
sedere brasiliano. Se la avesse vista Luigi sarebbe impazzito. Prima di incontrare Alex e rifarsi il
seno era una modella.
Entrai nella Famiglia. Vi facevano parte anche alcuni dirigenti dell’azienda. Sentivo che ero sulla
strada giusta. La mia vita si confondeva col lavoro. La sera uscivo per fare da autista ad Alex.
Capitava che mi cedesse qualche sua amichetta dell’est. Cominciavo a prenderci gusto. Non avevo
mai considerato la vita da quel punto di vista. Ci si ubriacava spesso. Avevo iniziato a tirare coca
come gli altri, dirigenti d’azienda compresi. Mi feci molti amici importanti. Partecipai alle orge che
Alex organizzava ogni settimana. Non era la vita che sognavo, ma un trampolino di lancio per
sfondare in azienda – e magari per conoscere qualche bella ragazza con cui edificare una famiglia.
Ma le cose non andarono come avevo previsto.
Un giorno arrivai in ufficio in ritardo. La sera prima me l’ero spassata con un’amichetta di Alex.
“Sei un bastardi!”
“Lo so Alex, lo so, ho imparato da te, caro mio!” dissi distrattamente.
“Abbiamo scoperti quelli tu hai fatti" gridò. "Sei un bastardi! Hai rubati i danari!”
Lo guardai sbigottito. “Di che denaro parli?”
“Finalmente ho scoperti colpevoli! Erano mesi che arricchivi tuoi conti con danari di aziende!
Vergognati, bastardi!”
Compresi dal suo viso tirato che non si trattava di uno scherzo. “Spiegami meglio, Alex, calmati. Ci
dev’essere sicuramente un errore. Sediamoci. Sono stanco, quella tua amichetta era insaziabile,
amico!” dissi cercando di farlo sorridere.
“Amici un cazzi! Non sono più amici! Tu rubavi soldi di aziende. Vali per me meno di zeri!” disse
accendendosi un’altra sigaretta. “Vieni, guardi!”
Mi mostrò sul suo PC un sacco di fatture indirizzate a un conto bancario intestato a mio nome. Con
la coda dell'occhio scorsi un ghigno sul suo volto.
Prese il telefono e chiamò uno del settimo, uno della Famiglia.
“Se fossi stati sinceri, ti avrei perdonati, ma tu non sei uomo di verità!”
Che dovevo dire?
“Buongiorno, Alex, che c’è?” disse. Vedendomi mi appoggiò amichevolmente una mano sulla
spalla facendomi l’occhiolino. “Sior Longo.”
“Tu non devi salutari più mai questi esseri bugiardi!”
“Che dici, Alex?” disse quello facendosi subito serio.
“Vieni, guardi dati su miei computer. Lui rubati soldi a aziende. Guardi!”
Capii. Compresi quello che stava succedendo da un altro ghigno appena accennato sul volto di
Alex. Voleva farmi fuori. Ancora non capivo perché. Chissà cosa nascondeva in quella maledetta
testa metà russa e metà africana.
Il tipo del settimo annuiva con la testa. Ogni minuto si faceva più scuro in volto. Ogni tanto alzava
la testa dal PC per guardarmi con disprezzo.
“Io non ne so niente!” dissi all’improvviso rompendo un silenzio che durava da parecchi minuti.
“Silenzio!” disse quello spegnendo il sigaro nel grande portacenere rotondo che svuotavo e pulivo
ogni mattina. “Abbi almeno la compiacenza di stare zitto!”
Li guardavo pensando che quella storia non poteva che finire male: mi avrebbero licenziato. Era la
fine. Anni passati a leccare il culo di quell’essere spregevole per ritrovarmi in una situazione del
genere.
Mi fecero aspettare nell’atrio. Sarebbe venuta la polizia a prelevarmi a breve. Volevano che i
colleghi mi vedessero in manette. Agli occhi di tutti ero un verme che in tempo di crisi si arricchiva
mandando a rotoli l'azienda. Alex mi aveva fregato una volta ancora.
Ottenni gli arresti domiciliari. Presi il migliore avvocato che potevo permettermi. Mi sentivo
abbandonato da tutti. La Famiglia mi aveva accolto, sfruttato e poi espulso senza che potessi
difendermi. Sospetto che nemmeno il mio avvocato credesse alla mia innocenza. Ero uno straccio.
Soltanto le lunghe telefonate con Salomè e Zeno mi tenevano a galla. Ero accusato di aver aperto un
conto bancario dove avevo accreditato centinaia di fatture per un totale di seicentomila euro.
Non so perché Alex mi aveva fatto questo. Forse era opera sua e per paura di essere scoperto aveva
deciso di trovare un capro espiatorio. Oppure era tutta una bufala inventata per mettersi in bella
mostra all’interno dell’azienda, come nuovo paladino della giustizia.
Il processo durò tre anni. Alla fine fui dichiarato estraneo ai fatti e assolto. Nel frattempo, in via
cautelare, ero stato declassato al quarto livello e Alex era passato al sesto. Quell’animale era un
genio del male. Uno scaltro analfabeta al sesto e un onesto cittadino laureato con il massimo dei
voti, giù al quarto. Nonostante fosse stata dimostrata la mia innocenza, nessuno si fidava più di me.
Decisi di chiudermi a riccio e limitare i miei rapporti coi colleghi a colloqui lavorativi. Speravo che
col tempo capissero chi ero veramente. Avevo cercato di ingraziarmi Alex e la Famiglia per scalare
qualche livello, di questo ero colpevole, lo ammetto, ma per quanto riguarda ciò di cui mi si
accusava, ero innocente. E non fu mai trovato un colpevole. Cadde tutto in proscrizione.
Ora mi ritrovo di nuovo al quarto, come il primo giorno di servizio da neolaureato, quando avevo
soltanto venticinque anni.
Due decenni prima, appena terminata l’università, guardavo il futuro con gioia e speranza, con
ingenuità e voglia di fare: adesso passo le giornate curvo sulla scrivania senza parlare con nessuno,
non vedendo l’ora di tornarmene a casa con la mia solitudine.
Z5 settembre
“Quello che non capisco è perché non te la sei fatta.”
“Perché sono un uomo fedele” dissi rigirando i pollici.
“Ma scusa, eri lontano anni-luce da Maria: una scappatella, la prima e l’ultima della tua vita, mi
pare più che sacrosanta, no?”
Non risposi.
“Ci avete mai pensato?” disse Luigi.
“A cosa?” disse Giovanni che fino a quel momento non aveva ancora parlato.
“Che lei in un certo modo è l’unica persona che ci ha tenuti vicini.”
“Vicini?" dissi.
“Lei è l’unica che è stata vicina a ognuno di noi.”
“In che senso vicina?"
“Forse...” disse Luigi fissandomi negli occhi, prima di tossire fino a sputare sangue.
“Se solo potessi stringerla ancora tra le mie braccia...” disse Giovanni svelandoci due occhi umidi.
“Be', credo non dovrai aspettare molto, vista la vecchiaia che ti porti appresso!” disse Luigi
dandogli una pacca sulla spalla. “E poi ammettilo, Jo, adesso per te esiste solo Klaudia.”
Giovanni cominciò a piangere, in silenzio.
"Scusa" riuscì a dire Luigi. "Sono uno stronzo."
Il sole scendeva lontano diventando sempre più grande e rosso.
“Ah, un’altra cosa, Jo, quasi mi dimenticavo!" disse all'improvviso Luigi come per cambiare
discorso. "Stamattina ho letto il tuo ultimo capitolo: cos'è quella storia di Alex e della tua vita
malavitosa? Cosa cazzo c'entra?”
“Ma se tu hai detto di essere stato settimane nel deserto a mangiare peyote... Proprio tu mi parli di
realtà! Tu che ti sei inventato quella storia palesemente falsa di un autobus londinese rosso a doppia
altezza che se ne va allegramente in cima allo Stelvio, solo per avvincere il lettore... Tu che millanti
di essere vissuto mesi nudo in una foresta mangiando bacche e camminando sugli alberi!”
Luigi s’intristì di colpo.
“Sentite, ragazzini” intervenni io, “non litigate. Per me le bugie di Luigi sono coerenti col
personaggio: gli danno spessore. Mentre la tua, non offenderti, Giovanni, non collima per niente
con l’ingenuità del tuo personaggio. Ma il mio è solo un parere...”
“Forse ho esagerato” disse Giovanni. "Rimedierò."
Luigi ci versò un po’ di tè fumigante e insieme ci godemmo in silenzio il tramonto.
Ripensai all'unica volta in cui cedetti al fascino di Salomè.
La prima e l'ultima volta che tradii mia moglie.
Non lo seppe mai nessuno. Era il nostro segreto, mio e della donna più sensuale che avessi mai
incontrato. La donna che mi aveva stregato il cuore, il cervello e l'anima.
Ancora non so se fu un errore. Furono senz'altro i più bei minuti della mia vita.
Ma, per me, coincisero con l'inizio del declino. Un principio di morte.
Da quella volta passarono anni prima che me la ritrovassi vicina: era nuda e fredda sotto un metro di
terra brasiliana.
Y
Fu la vacanza più bella della mia vita. Ritrovai i miei tre amici fisicamente e spiritualmente. Era
stato come tornare bambini, come diventare amici una seconda volta.
A casa tornai a dedicarmi ai miei studi di storia antica. Negli ultimi anni mi ero appassionato
durante le lunghe serate invernali, quando non guardavo la TV o non ero in internet, alla lettura di
antichi testi di storia. Stavo studiando le varie civiltà perché ero convinto che per capire il presente
era necessario conoscere il passato.
Negli States avevo comprato una tecnologia nuova – cuffie, microfono, webcam - che imaparai a
usare. Mi feci molti amici in internet: passavo le nottate a chattare in inglese con bellissime ragazze
dell’est: allo stesso tempo potevo migliorare il mio inglese e trovarmi una dolce mogliettina.
Ricordo che la notte prima di rientrare al lavoro non dormii. Ero agitato e felice per aver finalmente
raggiunto il quinto livello, ma spaventato a morte dal dover affrontare quotidianamente Alex e le
sue angherie.
Al mattino mi presentai nel suo ufficio tremando.
“Buongiorno, Alex.”
“Tornati?”
“Sì, sono tornati.” Mi pentii subito di averlo preso in giro.
“Beni beni” disse senza accorgersi della mia ironia. “Dimmele, vuoi tu ancora fare carriere nelle
aziende?”
Non mi aspettavo quella domanda. “Certo, signore.”
“Beni. Allori dovrai stringere tuoi denti e tenerlo duro per prossimi mesi e vedere che andrà tutti
beni. Ok?”
“Sì, signore.”
Non mi dispiaceva umiliarmi dandogli del signore, era pur sempre il mio capo. Sapevo che se era
arrivato lì senza saper né leggere né scrivere, e perché conosceva la gente giusta.
Così i mesi passarono e la mia schiena cominciò a incurvarsi sotto a una mole di lavoro tale da
obbligarmi a portare a casa un sacco di scartoffie. Passavo spesso le serate e i fine settimana a
portarmi avanti col lavoro. Rinunciai ai libri di storia. Il tempo dedicato alle chat si fece più
conciso, non più di due ore al giorno. Ogni tanto scrivevo a Luigi e Salomè: entrambi mi ripetevano
di non fidarmi di Alex. E invece io, non avendo altra scelta, mi spaccavo in quattro per
accontentarlo.
A volte video-chiamavo Zeno. Era riuscito a comprarsi la casa sulla spiaggia. Mi raccontava che
sua moglie accudiva i tre figlioli durante il giorno, e a fine giornata era talmente stanca che era
Zeno a dover preparare la cena. Quanto lo invidiavo! Aveva una famiglia numerosa e felice, mentre
io ero il solito Giovanni, solo e con un lavoro che mi opprimeva senza darmi nessuna soddisfazione.
Passò un anno. I duri ritmi ai quali Alex mi aveva sottoposto mi avevano precluso ogni felicità.
Decisi di andare a parlargli del mio futuro.
“Salve, capo.”
“Salvi, soldatini Longo!”
“Senti, Alex, posso parlarti da uomo a uomo.”
“Dì tu pure ciò che tu pensi.”
“Dunque... io sto lavorando duro per te, per l’azienda insomma...” mi corressi prontamente. “Tu
parlavi di mesi per fare carriera. È già passato un anno però, sia io che te, siamo ancora qui al
quinto. Insomma…”
“Ti sbagli, Longo” disse sorridendo col suo solito ghigno. “Io sono passati da tempi al sesti. Ma
continui qui ai piani quinti per potere di stare con te.”
“Ah, sì? E perché non me lo hai mai detto?”
“Tu, Longo, non me hai mai chiesti, giusti?”
“Sì, ma… e di me che ne sarà?”
“Se ti fidi di me, fidati, Longo. Io darò te i posti al sesti.”
Non mi fidavo in realtà. Ma quale alternativa avevo? Per arrivare al sesto, non potevo far altro che
assecondarlo e soddisfarlo.
Nei due anni successivi allentai un po’ il ritmo senza che Alex se ne accorgesse. Portavo ancora
parecchie scartoffie a casa, ma mi bastava lavorare il sabato mattina per mettermi in pari con le
richieste di Alex. Le serate rimanevano mie. Affittai l’appartamento che prima era stato di mia
madre. Erano passati anni da quand’era morta, sono certo avrebbe capito. Quei settecento euro in
più al mese mi consentirono di comprare a rate un’auto degna di tale nome: una BMW station
wagon bianca coi finestrini neri. Me la meritavo. Mi ero laureato a pieni voti, avevo accudito mia
madre nella sua lunga malattia e avevo sempre messo tutto me stesso nel lavoro: ora mi prendevo
ciò che mi spettava.
Ero stato scaltro, per una volta in vita mia avevo agito alla Luigi. Avevo esposto dei fogli nelle
bacheche universitarie della città in cui indicavo esplicitamente SOLO RAGAZZE. Attesi quasi un
mese finché alla mia porta non si presentarono due ragazze australiane, Jenna e Sam, veramente
carine. Mostrai loro l’appartamento e da mille euro magicamente scesi all’allettante tariffa di
settecento euro, spese comprese.
La mia vita cambiò. A quarantadue anni tornai ragazzino. Jenna e Sam organizzavano dei party nel
loro enorme appartamento. Fu in una di queste feste erasmus che conobbi lei, la mia futura
mogliettina.
Gina era un po’ avanti con l’età rispetto alle altre. Forse fu per questo che si accorse di me. Era
leggermente soprappeso, ma in fondo aveva un bel viso. I capelli pel di carota legati dietro, vestiva
con jeans taglia forte e una camicia bianca, anch’essa piuttosto larga. Portava occhiali spessi, senza
i quali era praticamente cieca. Tutto sommato non era granché, lo ammetto, ma che potevo
pretendere? Ero molto più anziano di loro, il mio inglese non era di buon livello, in testa mi
rimanevano ancora pochi capelli: dovevo puntare agli scarti, Jenna e Sam erano inarrivabili, tanto
per capirci.
Gina, soltanto qualche settimana dopo che ci eravamo conosciuti, si trasferì da me. Era una ragazza
semplice. Era cresciuta al Sud, in una valle lontana dalla vita mondana. Mi accorsi presto che era
effettivamente un po’ troppo abbondante per i miei gusti, ma finii con l’affezionarmi a lei, e
l’aspetto fisico passò in secondo piano. Anche se ci stava impiegando dodici anni, presto si sarebbe
laureata. Chissà, magari mi sarei ritrovato una moglie avvocato, o addirittura notaio.
Nel frattempo al lavoro nulla cambiava. Alex era ancora il mio capo di sesto livello mentre io il suo
schiavetto del quinto. Cominciavo a stufarmi di lavorare il doppio dei colleghi ora che avevo Gina a
casa che mi aspettava. Decisi di dare un ultimatum a Alex.
“Ciao, capo!”
“Ciao, soldatini Giovanni Longo!”
“Alex, sono qui per mettere in chiaro una cosa: se non mi date il sesto livello, io smetterò di
portarmi il lavoro a casa. Non è giusto che io mi stia impegnando più di tutti gli altri messi assieme!
Molti hanno già preso il sesto, mentre io sono qui da tre anni, sempre l’ultimo ad andarmene e il
primo ad arrivare, come è possibile?”
Alex si prese del tempo per misurare bene le parole, prima di pronunciarle.
“Longo, i cosi sono cambiati. Ora non è più così facili passare di livelli. Ora crisi economiche. Ora
saranno tanti casse di integrazioni e tanti di licenziamenti. Io dico tu fortunati a essere qui. Pensa
alle genti con famiglie senza lavori, pensa a padri delle famiglie con casse di integrazioni a
ottocento euri e con mogli che no lavori. Pensi?”
Si arrestò soddisfatto accendendosi un’altra sigaretta.
“Tu pensi che devo ritenermi fortunato?” chiesi sinceramente.
“Sì, tu Longo continui lavorare così e appena possibili tu sei al sesti. Poi andiamo insieme ai
settimi.”
Non sapevo che pensare. Avevo sentito che qualcuno era stato effettivamente licenziato, ma non
sapevo se l’azienda avesse in programma di mandare in cassa integrazione altri dipendenti. Che
potevo fare? Se le cose stavano così, mi conveniva stringere i denti e dare il massimo, ancora per un
po'.
Alex aveva detto il vero, negli anni a seguire furono in moltissimi a finire in cassa integrazione,
l’azienda era veramente in crisi. Ciò nonostante nei mesi seguenti alcuni colleghi riuscirono a
giungere al sesto piano, e la cosa non mi andò proprio giù.
Nel frattempo conobbi i genitori di Gina nel loro decadente domicilio di Craco Vecchia, un piccolo
paese della Basilicata, ormai quasi abbandonato.
"Mamma! Papà!"
Appena la videro scendere dalla BMW bianca coi finestrini oscurati, cominciarono a piangere.
"Fermati, fammi scendere!"
Parcheggiai e li raggiunsi accendendomi una Marlboro Light. Vestito Dolce&Gabbana facevo
ancora la mia porca figura, nonostante la pancia.
"Salve, io sono Giovanni" dissi togliendomi gli occhiali da sole e gettando a terra la sigaretta
appena accesa.
"Salve, ingegnere. Venga. Entri pure."
"E insomma vi sposate, è?"
Sbiancai. Mi rimisi gli occhiali e tossii.
"Già."
"Come sono contenta!" gridò quel quintale di sua madre abbracciandomi.
In realtà non avevamo mai parlato di matrimonio, ma effettivamente prima o poi il gran giorno
doveva arrivare.
"Ci sposeremo appena Gina si sarà laureata" buttai lì per tastare il terreno.
"Ah ah ah" fece suo padre.
"Gina, non ci avevi detto che l'ingegnere era anche un uomo di spirito?"
"Chi? Quel pirla lì?" disse Gina indicandomi. "Per piacere, mamma, ma se non sa neanche se è al
mondo."
Scoprii che non le mancavano solo due esami come mi aveva detto quando ci eravamo conosciuti,
ma almeno quindici.
"Dobbiamo brindare!" disse suo padre. "Cara, prendi la bottiglia di quello buono e quattro
bicchieri."
"Giova, hai sentito? Vai a prendere i bicchieri."
"Sì, cara" dissi alzandomi e facendo gli onori di casa.
Andai in cucina sentendomi osservato.
"Vanno bene questi?"
"Ah, lascia perdere, non sei buono a nulla, Giova. Faccio io, come sempre del resto!"
Sentii i genitori di Gina ridere a crepapelle.
Non m'importava più di nulla. Abbandonata ogni velleità di salire di livello, avevo preso l’abitudine
di tornare a casa anche a pranzo. Lei mi aspettava giorno per giorno. Anche la sera mi coccolava coi
suoi prelibati piatti a base di burro che in pochi anni mi fecero ingrassare di venticinque chili. Ci
accontentavamo di una vita semplice.
Venne il giorno. Avevamo deciso di sposarci da lei, a Craco. Oramai Gina aveva abbandonato gli
studi. Aveva insistito per sfollare Jenna e Sam dall’appartamento di mamma, nel quale saremmo
andati a vivere io e lei. Sarei stato io a mantenerla d’ora in poi, lei avrebbe fatto la brava mogliettina
e, se Dio voleva, la brava mammina.
Tutto questo se non avessi invitato Luigi alla cerimonia.
Fu lui a prendermi di peso la notte prima dello sposalizio e portarmi nella BMW dove Zeno e
Salomè ci stavano aspettando.
“Tu non ami quel cesso di donna, Jo!” mi gridò in faccia.
“E allora?” risposi. “C’è bisogno di amarsi al giorno d’oggi?”
Tutti e tre mi guardarono sbalorditi.
“Che ho detto di male stavolta?”
Luigi scosse la testa.
“Ma come puoi essere sceso così in basso?”
“Senti, Luigi, non sarà una bella ragazza, non sarà molto intelligente, ma con lei mi trovo bene, mi
prepara degli ottimi pranzetti e delle prelibate cenette!”
“Como hacìa tu mamà?” intervenne Salomè.
Guardai Salomè negli occhi nocciola ed ebbi un mancamento.
“No, voi non capite!” dissi chiudendo gli occhi. “Non è solo quello, è che lei mi fa compagnia,
dorme assieme a me, forse anche lei non mi ama, ma almeno mi vuol bene, mi rispetta, mi sta
vicino.”
“Come cazzo puoi accontentarti di questa miseria?” disse Luigi incavolato. “Svegliati cazzo! Apri
gli occhi! Quella vuole i tuoi soldi! Che te ne fai di una così? Meriti di più, Jo.”
“Luigi ha ragione” intervenne finalmente Zeno, l’unico di cui mi fidavo. “Non sei costretto a
sposarti per forza. Rifletti con calma. Sembra che quella ragazza ti abbia guidato, quasi costretto, a
fare quello che stai per fare. Rallenta. Quando ci sposammo, io amavo Maria e lei amava me, è
questo che conta, il resto non ha niente a che vedere col matrimonio. Perché vuoi legarti per sempre
a questa donna?”
Iniziai a piangere. E piangendo dissi la verità: “Perché non ho nessun altro!”
Salomè girò la chiave e sgommò alzando un polverone. Guidò fino a Roma, lasciammo la BMW nel
parcheggio dell’aeroporto e prendemmo i primi posti disponibili per il Brasile.Z7 settembre
“La smetti di scrivere scemenze?”
Giovanni fissò Luigi tremando, quasi avesse paura.
“Ti hanno tagliato la lingua?” disse ancora, prima di tossire e sputare sangue.
Giovanni non parlava. Era pallido nonostante il pomeriggio fosse assolato.
Amavo Vigolo in autunno. Le castagne, il mosto, le foglie che volano di qua e di là.
“Ascoltate un attimo” dissi alzandomi lentamente. “Stiamo scrivendo un romanzo per dimostrare
che la vita non ha senso, o che comunque pochi eletti lo hanno trovato. La maggior parte della
gente, il gregge per intenderci, non si affanna nemmeno per cercarlo, vive una vita piatta, inutile,
senza scossoni.”
A quel punto li guardai per capire se avevo attirato la loro attenzione, e tornai a rimirare il cielo
azzurro e terso.
“Poi ci sono alcuni, ed è di questi che noi narriamo le vicende, che si affannano per dare un senso
alla vita, e lo fanno finché hanno energie per farlo, per cercare eternamente un significato che mai
troveranno. Di questi valorosi eroi stiamo scrivendo, cioè di noi tre, noi coi nostri pregi e coi nostri
difetti, con le nostre paure, coi nostri sensi di colpa, noi coi nostri desideri, noi ormai senza più
sogni. Quindi se Giovanni vuol cambiare parte delle vicende, avrà i suoi motivi, l’importante è che
il senso alla fine sia lo stesso.”
Non avevo mai parlato tanto in vita mia, da quando non insegnavo più negli Stati Uniti. Sentirmi
parlare più di un minuto di fila doveva essere una novità. Rimasero infatti in silenzio per qualche
attimo.
“Ragazzi” disse Giovanni, “la verità è che mi vergogno a narrare la mia vita perché il lavoro è
sempre stato così piatto e insoddisfacente che… che veramente mi viene voglia di piangere,
pensando a una vita così inutile, così sempre uguale a se stessa. Fino ai sessant’anni non ho vissuto,
ho fatto sempre e solo figuracce, ho inanellato fallimenti su fallimenti: mi vergogno di me stesso, di
non aver saputo reagire, di non aver alzato la voce e cambiato il mio destino da eterno sfigato."
Mi guardò negli occhi e aggiunse: “Ti sbagli, Zeno: io non faccio parte di quei pochi valorosi che
hanno cercato il significato della vita, io faccio parte del gregge.”
Giovanni aveva gli occhi lucidi. Com’era strano vedere un vecchio piangere. Faceva tenerezza!
“Non è così, Jo!” disse Luigi prendendo fiato a fatica. Il respiro gli fischiava e le parole gli uscivano
a fatica. “Già il fatto che tu sia qui a parlarne dimostra che tu eri e sei consapevole delle tue azioni.
Hai fatto quel che hai fatto per una scelta precisa. Sei rimasto a lavorare nella stessa azienda tutta la
vita per dei motivi condivisibili: un po’ per orgoglio, un po’ per comodità, un po’ per testardaggine,
un po’ per paura della crisi, un po’ per paura di cambiare: ma soprattutto perché oramai lì dentro ti
sentivi a casa."
Luigi riprese fiato. Noi aspettammo che riprendesse a parlare.
"Hai scelto di rimanere e lottare nel posto in cui il destino ti ha portato. Io invece ho sempre
cambiato, seguendo il mio istinto, perché non mi sono mai sentito veramente a casa. Mai mi sono
sentito in patria. Solo ora che sono vecchio e stanco comincio a capire che i miei non sono sbagli,
ma scelte precise basate su una logica di causa-effetto. Ho lottato per dare un senso alla mia vita, e,
così come te, non solo non l’ho trovato, ma anch’io a volte penso di averla buttata via, di aver
sprecato gli anni migliori in una ricerca inutile.”
Tacque per un attacco improvviso di tosse. Noi lo guardammo in silenzio sputare sangue e catarro.
“Pensa a Zen" disse indicandomi. "Lui non fa parte né del gregge né dei valorosi eroi che si sono
prodigati alla ricerca di un senso. Zen è parte di quei pochi fortunati che vedono già la via. Vedono
già in gioventù la strada da seguire. Sono, in un certo senso, illuminati. Anche noi abbiamo davanti
una strada facile da seguire e soleggiata, eppure viviamo in totale oscurità. A volte, durante piccoli
squarci di luce, intuiamo l'esistenza di una via che ci pare quella giusta e la seguiamo, altre volte ci
buttiamo e camminiamo nel buio, chi più prudente chi meno. Finché non cadiamo in un fosso e a
fatica ci rialziamo e torniamo a camminare.
“Ci sono vie che conducono a sfiorare precipizi, come la mia, e vie più regolari, meno pericolose,
come la tua. Ho rischiato di morire molte volte, e me la sono sempre cavata. Voi avete condotto
esistenze più tranquille: entrambi avete dimostrato di essere saggi.”
“Ti sbagli, Luigi” disse Giovanni. “Tu vedi solo i tuoi precipizi fisici, tangibili. Ti assicuro che la
mia via a un certo punto si stringeva sempre più, e, anche se non li vedevo, avevo precipizi a destra
e a manca. Camminavo attento per non precipitare in questi burroni mentali. Spesso ho desiderato
cadere e farla finita, e allora ho cominciavo a correre sulla strada buia fino a crollare per sfinimento,
sempre sulla strada però: io non l’ho fatta finita, come ha fatto lei.”
“Non parliamo più di lei.”
“Scusate, mi è scappato.”
Aiutammo Luigi ad alzarsi. Non riusciva a camminare. Così lo portammo di peso sulla carrozzella.
Ci incamminammo verso casa senza parlare.
Era finita. Lui lottava, ma il suo corpo lo stava abbandonando.
Piansi senza darlo a vedere.
Poi ripensai alle sue parole di quel giorno. Le considero ancor oggi, il suo testamento.
Avrei voluto dirgli che anch’io facevo parte dei valorosi che hanno cercato la loro strada, che hanno
sofferto, che hanno affrontato delle scelte importanti, che sono stati rosi da dubbi angoscianti, senza
mai trovare una risposta alla sola domanda che davvero conta: tacqui, non mi avrebbero creduto.
Y
La verità è questa. Se mai esiste una verità.
Quando tornai dagli States mi accorsi ben presto che la mia vita lavorativa non poteva andare avanti
alle dipendenze di Alex. Chiesi di essere spostato in un altro settore del quinto.
La mattina seguente trovai una lettera sulla mia scrivania.
Buongiorno ing. Longo,
abbiamo riscontrato che i suoi colleghi di piano hanno mal interpretato la sua scalata dal terzo al
quinto; ci sono giunte lamentele dagli impiegati del quinto appunto, che ritenevano ingiusta la sua
istantanea promozione di due “piani”, come vengono oramai definiti in azienda. La sua richiesta di
spostamento inoltre ci aiuta a capire che anche lei soffre la sua nuova collocazione, per tanto la
soluzione migliore, e irrevocabile, ci sembra quella di collocarla al quarto piano, pur mantenendo, è
bene specificarlo, uno stipendio di quinto livello base, che a lei spetta di diritto.
Distinti saluti.
"Mi spostano un’altra volta in basso."
"…"
"Comunque manterrò una busta paga di quinto livello."
"…"
"Altrimenti mi sarei lamentato, ho smesso di farmi trattare come uno schiavetto, ho imparato la
lezione ormai."
"…"
"Vabbe', adesso ti lascio."
"…"
"Tranquilla, tornerò domani, stesso posto, stessa ora. Ciao, mamma."
Uscii dal cimitero, andai a fare la spesa e tornai dritto a casa.
Al quarto, dove speravo avrei ricoperto un ruolo di un certo tipo, mi ritrovai nel settore neo-laureati.
Specificai subito ai nuovi colleghi che ero laureato a pieni voti oramai da una quindicina d’anni.
Raccontai che in realtà ero del quinto, ma che lassù non c’erano più posti e così mi avevano
collocato al quarto per controllare i novellini.
In pochi giorni tutti i giovani laureati facevano riferimento a me per ogni questione, ci fu pure
qualcuno di loro che mi chiese se poteva andare in bagno.
"Ciao."
"…"
"Appena si sono accorti che non ci so fare col computer e con i software di ultima generazione,
hanno preso le distanze."
"…"
"Come chi? I colleghi, mamma."
"…"
"Mi sono pentito di aver detto loro che in busta paga sono ancora di quinto livello. Hanno
cominciato a circolare voci che il collega del quinto che siede tra quelli del quarto è un incapace."
"…"
"Sì, io, mamma, proprio io. In mensa mi sono trovato un tavolo in cui mangiare da solo. Mi evitano.
L’intero piano è contro di me."
"…"
"Hai ragione! Scriverò un’altra lettera alla dirigenza in cui spiego le difficoltà incresciose nelle
quali mi trovo e chiedo loro di spostarmi a un piano superiore, quinto o sesto non fa differenza,
l'importante è che sia lontano da Alex."
"…."
"Certo, oppure, se a loro giudizio non lo merito, di lasciarmi al quarto, sempre mantenendo il quinto
livello, ma percependo uno stipendio da quarto. Così nessuno avrà nulla da ridire."
"…"
"Ora scappo, ciao! E grazie!"
"…"
"Sì, domani la spedisco!" dissi quando ormai ero lontano dalla tomba di mia madre.
A volte davvero mi sembrava di sentirla.
y
Buongiorno signor Longo,
vorremmo sottolinearle che con le sue continue lettere fa perdere tempo all’azienda. Se quello che
vuole è l’abbassamento del suo stipendio, non c’è problema, ma la smetta di importunare la
segreteria dirigenziale con continue richieste.
Cordiali Saluti
Presi con me la lettera e andai allo scanner.
“Problemi, Longo?” disse uno.
“Sì, mi faresti un piacere?”
“Putosto me meno 'na sega, Longo! Spostete e fame laorar, mona!”
Lo lasciai fare, cercando di osservare i suoi movimenti. Dopo una decina di minuti si scansò. Avevo
capito come funzionava lo scanner. Appoggiai la lettera. Acquisisci. Salva con nome. Stampa
formato A0.
Non ci riuscivo. Mi stampava su foglio A0 come avevo impostato, ma l’immagine scansionata
rimaneva in un angolino.
“Scusa, Celine, puoi venire un attimo? Grazie.”
Lei sbuffò voltandosi verso una collega. “Che c’è, Longo?”
“Dovrei stampare questo geipeg in formato azero. Sempre che tu sia capace.”
Lei mi guardò come per dire, non sono mica deficiente.
“Longo” disse dopo due o tre secondi. Attesi che il plotter stampasse. Lei era già seduta sulla sua
scrivania che lavorava. Presi il foglio e passai a ringraziarla, ma lei mi fece un cenno senza neanche
alzare lo sguardo dal monitor.
Appesi con lo scotch il foglio formato A0 sul muro in plastica grigia a fianco alla mia scrivania.
Tutti avrebbero saputo che rinunciavo a un livello di stipendio.
Il primo che passò e lesse mi guardò e mi disse “ma sei scemo?”
Non avevo mai sopportato certe persone ottuse.
Il secondo disse “mah… Longo! Darli in beneficenza, no? Par brut?”
Il terzo “ma ‘n do cazo ‘l gat el zervel, ti? en te ‘l cul?”
Il quarto “gas problemi?”
Il quinto “Longo Longo Longo! Non hai capito un cazzo della vita! Agge da divettitte!”
Me li ricordo così bene perché, non so per quale motivo, cominciai a scriverli in tempo reale in un
file word. Forse me li sarei riletti in un momento di troppa gioia, se mai ci sarebbe stato.
Sesto: “ma ti te sei tut fola’!”
Settimo: “darmeli a mi?”
Ottavo: “Con tutta la gente che muore di fame nel mondo, sei andato a farti ridurre lo stipendio da
questi stronzi che ci sfruttano. Io sono qui a progetto, piglio settecento euro caro mio, me li sogno i
tuoi mille e tre! Capito? E tu vai pure a ridarglieli a quelle quattro teste di cazzo? Mi fai schifo,
Longo!”
Mi fermo qui. Anche perché quest’ultima mi aveva fatto capire che avevo fatto una cazzata. Altro
che eroe, ero lo zimbello del quarto.
(Ecco uno dei precipizi mentali a cui facevo riferimento ieri con Luigi.)
In quel momento avrei voluto mollare tutto e tutti, e lasciarmi morire. Schiantarmi ai duecento
all’ora contro un muro come avevano fatto i genitori di Luigi. Avevo semplicemente voglia di
morire.
È tutto. Tutto ciò che noi umani intendiamo con la parola verità.
Y
La mattina seguente non andai al lavoro: presi malattia: quella settimana non mi andava di vivere,
figuriamoci di lavorare.
Rimasi barricato in casa chiedendomi come fossi finito in quello stato. Ero lo zimbello non solo del
quarto, ma dell'intera azienda.
"Avevi ragione tu, mamma, dopo la laurea ho fatto soltanto errori su errori. Avrei dovuto cambiare
città, come dicevi tu, andare a Bologna, a Padova, a Milano."
"…"
"Quando ero giovane credevo che la piccola vita di provincia fosse più salutare per il corpo e per lo
spirito. Inoltre non volevo abbandonare te."
Piansi in piedi, fissando la tomba di mia madre, incurante del mondo attorno.
"Alla fine eri più tu che ti prendevi cura di me che io di te. Lo so, ti ho riversato addosso i miei
dubbi e le mie paure."
Mi asciugai le lacrime con i palmi delle mani.
"Avrei dovuto andarmene prima, ormai è tardi. Ho quasi cinquant'anni. Non ce la faccio a mollare
le abitudini. E poi, chi mi assumerebbe? Sono rimasto indietro con le nuove tecnologie, non sono
più un novello ingegnere pronto a far carriera. Sono piuttosto un fallito... Come dici?"
"…"
"Sì, mamma, sono un fallito. Non negare l'evidenza. Sono un fallito che si accontenta di vivere nel
posto dov’è nato, anzi neanche dov'è nato, dove tu mi hai portato, e non finirò mai di ringraziarti
per questo!, e di fare il primo lavoro che gli è capitato. Mamma, non ho la forza per cambiare."
"…"
"Luigi? Cosa c'entra Luigi adesso, mamma?"
"…"
"Non so, sarà a fare trekking in Nepal..."
"…"
"Che ne so, mamma! È lui che ha messo al mondo un figlio e otto anni dopo lo ha abbandonato,
mica io!"
"…"
"Bisogno di me? Lui?"
"…"
"Be', se ha così bisogno si farà vivo. Te l'ho sempre detto che alla fine sarà lui a venire a piangere
da me..."
"…"
"Zeno? Zeno ha tutto: villa, carriera e famiglia."
"..."
"Invidiare me? Zeno? Ma va'!"
"…"
"Ti ho detto mille volte di non chiamarla così!"
"…"
"No, non è una cagna e tanto meno una brutta persona. Aveva smesso di amarmi, tutto qua."
"…"
"Ah, sì? E riesci a vederla?"
"…"
"Non sapevo stesse così male. Sei sicura?"
"…"
"Ah. Be', la sentirò via mail. Ma sei proprio così sicura?"
"…"
"Sì, ho detto che la sentirò. Non posso mica scriverle una mail dal cimitero!"
"…"
"Sì, lo so che potrei, ma è un luogo sacro!"
"..."
"Ok, lo farò. Grazie, mamma. Lo sapevo che sotto sotto le volevi bene anche tu. A domani, grazie!"
Uscii dal cimitero un po' scombussolato da quel teatrino bizzarro. Quella volta mi ero talmente
calato nella parte del pazzo che sentivo la mia bocca parlare, ma nemmeno capivo cosa stavo
dicendo. Ero come in trance.
E comunque, benché ovviamente sapessi che erano tutte scemenze, scrissi una mail a Salomè
chiedendole come stava.
Dopo cinque giorni di riflessioni mi ero rigenerato: ero pronto a ricominciare.
Il lunedì successivo mi recai in ufficio deciso a farmi rispettare. Avrei ricucito i rapporti coi
colleghi a costo di aiutarli uno per uno nel loro lavoro, di tenere loro un posto nella fila per la
mensa, di dare passaggi in macchina a chi non l’aveva, di combattere per chi lavorava a progetto:
Passai in segreteria a lasciare il certificato di malattia. La segretaria prese il foglietto senza leggerlo
e mi disse “Mi dispiace!” Capii che non si riferiva alla mia assenza e nemmeno alle frasi che mi
erano state sputate addosso. Era un mi dispiace dal sapore amaro.
Arrivai alla scrivania. C’era una lettera.
Buongiorno caro ingegner Giovanni Pietro Longo,
ci è stato riportato da molti dell’affissione da parte sua, di un cartellone a colori formato A0 della
precedente lettera a lei rivolta dalla dirigenza aziendale.
Le ricordo che si trattava di una lettera strettamente personale a lei rivolta, e non di pubblico
dominio. Inoltre, anche se palese a tutti, le ricordo che il suo compito è quello di lavorare, e non di
perdere tempo in futili scansioni e stampe, peraltro a spese dell’azienda, facendo per di più perdere
ulteriore tempo ai suoi fin troppo gentili colleghi.
Pertanto si senta fortunato se la sua persona sarà ulteriormente scalata al piano terzo, potendo
mantenere uno stipendio di quarto livello, ed un livello di merito pari al quarto, e non più al quinto
come finora. Si ritenga ulteriormente fortunato se al piano terzo potrà assurgere al ruolo di
“dirigente di piano”.
Con la stessa speriamo di non ricevere MAI PIÙ lamentele sulla sua persona, confidando da oggi in
una presa di coscienza del suo nuovo ruolo in azienda.
Distinti saluti,
La direzione.
Un’altra volta declassato. Un’altra volta umiliato. Un’altra volta rinchiuso in una gabbia buia fatta
di neon, grigio fumo di sigaretta e continue folate di sudore rancido.
Y
Mi chiamarono che fuori faceva ancora buio. Parlavano inglese, un inglese stentato. Capii subito
che si trattava di lui. Mi dissero, se compresi bene, che trovarono il suo corpo inanimato in un bosco
a qualche centinaio di chilometri da Katmandu, dove fu trasportato. Non avevano riscontrato
nessuna malattia particolare. Si era semplicemente let die, lasciato morire, credetti di sentire.
Allontanai la cornetta e iniziai a piangere.
Poi feci per riattaccarla, ma una voce sotto ancora gridava.
"What is there also?"
Ammetto che non capii molto di quella telefonata. Un po' colpa del mio inglese, un po' colta del
loro accento. Una cosa però era chiarissima, la ripeterono almeno tre volte: avrei dovuto pagare
all'istante tremila dollari.
"Why?"
"To tly to save him!"
"Is alive?"
"Yes, he's alive! You have to pay to tly to save him!"
Provarono a dettarmi le coordinate bancarie della clinica, ma il mio inglese e l'agitazione mi
impedivano di capire con precisione. Detti loro la mia mail e riattaccai. Accesi il PC, lessi la posta
elettronica e feci un bonifico all'istante.
Luigi non aveva stipulato nessuna assicurazione medica. Stavo rileggendo la loro mail, quando
arrivò la conferma.
"Now we can tly to save him."
Spensi il PC e cercai invano di dormire.
y
Il giorno seguente ero già su un volo diretto all’aeroporto di Katmandu, con scalo a New Delhi:
andavo a riprendermi il mio migliore amico.
Lo avevano già dimesso.
"How is possible?"
"He wanted to go out. He called a taxi and go to his apaltment."
Stava in una pensione in centro. Arrivai in tempo, di lì a qualche giorno se ne sarebbe certamente
scappato chissà dove. Era un quartiere rumoroso e l'edificio nel quale entrai decadente e sporco.
Salii le scale. Bussai e attesi.
Erano quasi dieci anni che non mi vedeva. Appena capì chi ero sorrise e mi abbracciò.
“Quanto cazzo sei invecchiato, damerino?”
Era magro e smunto. “Ciao Luigi! Ti trovo in gran forma!” dissi cercando di tirargli su il morale.
“In gran forma? Dici? Sono tutt’ossa a dire il vero…”
“Non dire scemenze, non invidierai mica la mia pancia?” dissi dandomi un altisonante colpetto sul
ventre nudo. “Hai trovato quello che cercavi?”
Lo vidi impallidire. Non avrei dovuto fargli una domanda così idiota.
“Perché non usciamo a mangiare qualcosa, anche se da queste parti mi sembra tutto così sporco…”
“Non l’ho trovato.”
“Come?”
“Non ho trovato niente di niente. Mi sono solo allontanato da me stesso e dalla verità.”
“Dai, usciamo a mangiare così mi racconti.”
Era triste.
“Ecco il perché di quella pancia” disse senza riuscire a sorridere.
Lo abbracciai di slancio con le lacrime agli occhi. Rimanemmo così per dei minuti. Poi lo guardai e
risi allegramente. Sul suo viso però non c’era ancora spazio per un sorriso.
y
Riattaccai e andai alla finestra. Fuori il sole spariva sotto l’orizzonte e nel riflesso sul vetro
intravedevo un uomo ormai vecchio, scosso dai singhiozzi, con il viso grigio inondato di lacrime.
Mi accesi una sigaretta vecchia di anni e corsi in bagno per piangere e vomitare.
Soltanto quando mi ritrovai seduto con gente svestita che non aspettava altro che partecipare al
carnevale brasiliano, mi resi conto che Salomè era l’unica ragazza che avevo amato. Non avevo mai
smesso di sperare che quell’anima libera all’improvviso tornasse da me. Adesso si trovava dove la
terra finiva e iniziava il cielo.
Pensavo a ciò che Luigi mi disse al telefono: “amava le montagne da scalare: il problema è che
prima o poi la montagna finisce, e si deve tornare.”
Piansi per metà viaggio. Poi chiesi di poter telefonare.
"Sono cinque euro al minuto, signore. Qui è possibile strisciare la carta. Vede?"
"Grazie."
Composi il numero.
"Zeno, non ce la faccio, sto troppo male! Voglio scendere da questo cazzo di aereo!"
"Giovanni, mi stai chiamando dall'aereo? Stai andando da Luigi?"
"Sì. Ma non so con chi parlare. L'aereo sembra un sambodromo!"
Sentii Zeno ridere all'altro capo.
"Mi ascolti? Vedi, lei e Luigi erano sempre in vetta. Io dal basso li vedevo svettare sul gregge. Mi
ascolti? No perché se non mi ascolti io mi butto giù dall'aereo..."
"Sì, ci sono, vai tranquillo. Tanto qui è notte, non ci disturba nessuno."
"Salomè amava arrampicarsi fin dove altri nemmeno potevano sperare di arrivare: amava andare
oltre, anche quando l’oltre non c’era. Amava la montagna, ma allo stesso tempo la odiava. La
odiava per la sua finitezza, per la sua incompiuta bellezza: non era abbastanza, lei voleva sempre
qualcosa di più. Quando era stata sull’Everest non aveva provato nulla. Vedere tutti gli altri
stringersi e abbracciarsi le aveva fatto schifo. Così aveva detto, Zeno: schifo."
"Sì, Giovanni. Ti ascolto."
"Per lei non c’erano vere soddisfazioni. Qualcosa in lei non andava. Un meccanismo rotto in un
corpo apparentemente perfetto. Si era come spezzato un ingranaggio. Non si trattava soltanto di
soddisfazioni. Lei era incapace di vivere. Sorrideva ma non rideva. A volte era felice, ma mai
serena. Sapeva fare sesso, ma non sapeva amare. Andava a letto con la gente, ma si allontanava in
fretta dagli uomini: a parte Luigi, che forse vedeva come un amico speciale, o qualcosa del genere.
Con me lei si confessava. Ci siamo scambiati un sacco di mail in questi anni... Ci sei, Zeno?"
"Sono ancora qui, tranquillo. Ti ascolto."
"Aveva paura degli uomini, forse li odiava: li usava per raggiungere brevi attimi di felicità, e poi li
scaricava, se ne liberava al più presto: disfaceva anziché costruire, scappava invece di rimanere.
Con me aveva retto finché aveva potuto. Mi aveva scelto per dare stabilità alla sua vita. Ecco perché
si era messa con me! Non perché mi avesse mai amato... Rappresentavo ciò che lei non era: io ero
incapace di uscire dalla società, lei incapace di viverci dentro. Era un’anima libera, ancor più di
Luigi. Questo l’ha schiacciata."
Riattaccai senza nemmeno salutare Zeno, che forse si era già addormentato.
3
x
Quando al mattino la luce mi riscalda le palpebre fino a farle sbocciare, capisco che sta per iniziare
un’altra giornata unica e irripetibile.
È quello che ho scritto ieri con un coltellino su una parete.
La mia casa, il mio nuovo nido.
A volte li chiamo appartamenti, ma in effetti sono tre villette di legno sopraelevate, una attigua
all’altra: quella centrale è la mia. Ho installato sui tetti tre enormi pannelli fotovoltaici. Dietro,
verso ovest, ho predisposto un piccolo orto. Davanti un lungo giardino si estende in direzione
dell’oceano. Alla fine del giardino c'è un sentiero che, in due minuti a piedi, porta dritto alle onde.
L'intera proprietà si estende per circa mezzo ettaro.
La zona in cui vivo è verdeggiante. Basta addentrarsi qualche centinaio di metri per farsi avvolgere
dalla foresta pluviale. Spostandosi soltanto qualche chilometro più a sud si incontra la savana.
Sembra quasi una magia della natura.
Manca l’acqua corrente. Sto costruendo un grezzo sistema di canalizzazione che trasporta l’acqua di
una sorgente fin dentro casa. Uso dei filtri in serie per purificarla, ma prima di berla preferisco
bollirla per una ventina di minuti, quantomeno i primi tempi. Ho acquistato una cisterna in lamiera
color pappagallo per poter irrigare gli orti e immagazzinare l’acqua per i periodi di siccità.
Ho dipinto le pareti esterne di rosso, verde e oro, e coperto quelle interne con suzani uzbechi.
Amo dormire fuori: è indescrivibile la sensazione di lasciarsi cullare dalla notte calda e stellata.
I miei vicini sono una coppia di brasiliani. Si sono offerti di aiutarmi senza niente in cambio. Siamo
diventati amici. Grazie a loro il mio brasiliano si è fatto fluente.
Per ricambiare mi sono ripromesso di insegnare a leggere alle loro tre figlie.
***
Arrivò un ragazzino diretto in Alaska. Diceva di aver letto un libro di Thoreau, e di aver capito che
la vita che stava conducendo non aveva senso. Voleva mettersi alla prova e vivere per qualche
tempo da solo, in mezzo alla natura incontaminata. Non me la sentii di spillargli del denaro.
“Bella idea” dissi. “Se ripassi da queste parti, vieni a trovarmi.”
“Ti manderò una cartolina.”
Non ci contavo.
L’anno successivo, mentre era assorto nella lettura di Resurrezione del vecchio Tolstoj, arrivò una
cartolina.
Lui non lo rividi mai più.
E purtroppo fu l'unico che venne a trovarmi.
***
Caro Jo,
la vita qui è semplice. Non ci sono TV, computer e i-pod nani in mezzo ai coglioni. Niente traffico,
cellulari, chiacchiere inutili. Ci sei soltanto tu, i tuoi libri, a volte un giornale della settimana prima,
la radio (quasi sempre spenta), i vicini di casa con cui scambiare due parole, le passeggiate nella
giungla in cerca di frutta, le corse sulla battigia, le cavalcate sul surf, i raid in bicicletta nella savana,
le feste sulla spiaggia, il tuo diario, il sole, le belle ragazze, la vita che hai sempre sognato.
Spesso mi assalgono noia e solitudine, e, se quest’ultima ho imparato a rivalutarla e apprezzarla,
la noia ancora non la sopporto. Ripensi allora allo stress, alle preoccupazioni e ai signor sì,
signore della vita italiana, e impari a conviverci.
Luigi
***
Da un po’ di tempo ho ripreso a scrivere. Mi aiuta a sfogarmi. Scrivo e riscrivo il solito romanzo
breve senza fine. Parla (sì, i romanzi spesso parlano più di noi scrittori) di un pesce rinchiuso in una
bolla: spero tanto che riesca a uscire dal suo invisibile muro d'incomunicabilità!
Certi giorni è più ciò che taglio che quello che scrivo.
X
Le ragazze.
A ogni festa ne conoscevo di nuove. E vi assicuro che c’era almeno una festa ogni sera.
"Hai intenzione di testarle tutte?" mi dicevano i maschi brasiliani che conoscevo. "Non ne lasceresti
qualcuna anche a noi?"
"Devo recuperare il tempo perso."
"Per voi stranieri è facile, vi cadono ai piedi."
"Appunto, perché risollevarle?" rispondevo. "Non ero mai stato con una brasiliana: è tutta un’altra
musica: è lei a guidarti, a rapirti, a farti godere mentre balla un samba indiavolato."
A quel punto ridevano tutti e mi davano dolorose pacche sulle spalle. Io ricambiavo offrendo loro
delle caipirinha.
"Ragazzi, non voglio vincoli alla mia libertà. Non mi va di responsabilizzare la mia vita" dicevo
quando ormai ero ubriaco. "Non voglio innamorarmi, soffrire le pene dell’amore, o stare tutto il
tempo con la stessa ragazza, amarla e rispettarla: preferisco amarle e rispettarle tutte!"
"Sapete qual è la differenza?" dicevo in spiaggia a quelli che surfavano con me.
"Rispetto a cosa?"
"Tra la vita qui e la vita che facevo prima."
"Il numero di ragazze che ti porti a letto?"
"Indubbiamente" dicevo sorridendo. "Ma soprattutto che qui a P. vivo più di pancia che di testa e
più d’istinto che di sentimenti ipocriti."
Ho deciso di scrivere una lettera a Jo, tanto per fargli un po' d'invidia:
Jo, cosa aspetti a venire a trovarmi?
Delle tre casette la più incasinata è la mia. La gente entra e esce a ogni ora del giorno e della notte.
Sole, relax, onde, pedalate e samba, tanto sano samba da ridurti a pezzi. Nel tardo pomeriggio ci si
rilassa fumando dell'erba. La notte ci si ubriaca. Credo non sia mai trascorsa un’intera settimana
senza la resaca del dia despues, come la chiamava Salomè: ti ricordi? Bere ci aiuta a distenderci, a
divertirci, a socializzare. Non lo considero un vizio o un capriccio: ci aiuta a vivere serenamente.
Non è come anni fa, nel sud-est dell'Asia. Laggiù ero caduto nel tunnel dell’alcool e delle droghe,
perché desideravo che quel mondo artificiale mi allontanasse dalla realtà, proteggendomi come una
vulva malata protegge un seme inadatto alla vita terrena. Sono o non sono un poeta, Jo?
Qui è diverso, bevo in compagnia. Non per scappare dalla vita, ma per assaporarla in tutto il suo
potenziale: per avvicinare e confondere sogno e realtà. Mi capisci?
Lo so, non è educativo, soprattutto per un ex-pirlaincalzamaglia. Ma con tutta l’attività fisica che
faccio, qualche canna e un paio di cocktail a sera non mi ammazzeranno mica, che dici?
E tu? Che combini? Dai, scappa da quel vecchio stivale puzzolente: Jo,qui in paradiso c'è sempre
posto anche per te!
Ti aspetto, almeno per una visita...
Luigi
X
Tre villette.
Una spiaggia.
Le onde.
Un sole caldo come il cuore di un bambino + un cielo azzurro come i miei occhi felici = tutto ciò di
cui ho bisogno per vivere bene.
È un'altra poesia che ho intagliato su un asse di legno della mia capanna.
"Che c'è?" mi chiedevano. "Cos'è quella faccia?"
Non riuscivo a dirlo.
"Ci beviamo una caipi?"
Avrei voluto ammetterlo, ma non ce la facevo.
"Non mi va, grazie. Ultimamente ho un po' esagerato."
Una sera andai dai miei vicini e confessai tutto.
"Sto finendo i soldi che avevo messo da parte. Ho bisogno di lavorare. Non so più cosa devo fare.
Ho fallito."
Il pescatore mi prese sotto braccio e mi portò verso il mare. Ci sedemmo sulla battigia.
"Smettila di tremare."
"Non ce la faccio."
"Tu hai rischiato. Hai tagliato le tue radici e sei venuto qui a vivere da solo. Hai avuto fegato. Non
importa da cosa scappavi, ci hai messo tutto te stesso. Hai creduto in un futuro migliore."
"Sì, ma credo di aver sbagliato. Non c'è posto per me qui. Mi sono illuso di poter vivere senza
alzare un dito."
Nonostante fosse buio vedevo i suoi occhi luccicare al riflesso della luna nell'oceano.
"Non hai sbagliato a credere che fosse possibile, è il modo in cui lo fai che non va bene. Hai creduto
di potercela fare, ma ora alla prima difficoltà ti butti giù. La vita è fatta di ostacoli. Non c'è mai solo
discesa, altrimenti che gusto ci sarebbe?"
Tacqui.
"Cosa stai facendo in concreto per realizzare il tuo sogno?"
"Niente, sono mesi che è tutto pronto. Quindi aspetto."
"È troppo poco."
"Lo so, ma cos'altro posso fare, pregare?"
Il vecchio scoppiò a ridere.
"Non ne sei capace."
"E allora cosa posso fare?" dissi lanciando una conchiglia contro le onde.
"Mostrarti."
"Come?"
"Questo lo devi sapere tu" disse appoggiandomi una mano sopra la spalla. "L'importante è farlo
divertendoti."
Ripensai alle parole del vecchio pescatore durante una notte solitaria passata a camminare lungo la
spiaggia alla luce della luna.
All'alba mi venne un'idea talmente banale che capii subito che poteva essere quella giusta.
X
Il primo cliente (odio questa parola, ma non riesco a trovarne un'altra migliore) arrivò per caso.
Cercava un posto tranquillo, fuori dai circuiti turistici. Aveva noleggiato un sidecar con, al posto del
navigatore, una tavola da surf.
"Ivano, ma tu chiamami Antonio."
"Allora, piacere... Antonio" dissi. "Tu chiamami Luigi, se non ti dispiace."
Sbottò in una risata fragorosa. Poi si guardò attorno estasiato.
“E così sarei il primo, eh?”
“Direi proprio di sì.”
“Da quanto tempo sei qui?”
“Quasi sei mesi.”
“E quanto vuoi per un appartamento?”
“Vieni, te lo mostro.”
“Sì, ma prima dimmi quant’è.”
“Non ha importanza. Te l'ho detto, sei il primo.”
Lo condussi nella casetta a nord, la più ben messa. Gli spiegai che doveva spillare l'acqua dalla
cisterna e farla bollire a lungo prima di berla. Gli feci notare che non c’erano elettrodomestici a
parte un piccolo frigo e una radio. Mi guardò stranito e tornò a osservare l’interno della casa. Poi mi
guardò ancora.
Lo accompagnai all’oceano.
“Gestite alla carlona sì, prolet pure, malsane no, squinternato… direi proprio di sì!”
Sorrisi.
“Euro o reais?” disse all'improvviso.
“Fai tu.”
“Trenta euro?”
“Come dici?” dissi posando lo sguardo sui suoi occhi luccicanti. “Trenta euro a settimana? A dire la
verità speravo almeno una cinquantina... Comunque per me va bene.”
“Intendevo trenta al giorno.”
“Ah sì? Così tanti?” feci passandomi una mano sul mento irsuto. “Non credevo valesse tanto quella
catapecchia.”
“Facciamo venti al giorno e non se ne parla più” disse dandomi una pacca sulla spalla. "Mi sembra
un prezzo onesto per il paradiso terrestre."
“No, facciamo trenta a settimana, a condizione che mi insegni a cavalcare quelle fottute onde
laggiù!”
“Qua la mano, amico!” disse distruggendomela.
Fu così che racimolai i primi soldi.
Mi spiegò che si era allontanato dal centro città verso nord trovando, sparsi ovunque, i miei cartelli
MALSANE CATAPECCHIE “PROLET” GESTITE (ALLA CARLONA) DA ITALIANO
SQUINTERNATO. Ne avevo piazzati anche alcuni in inglese che suonavano più o meno così: "OLD
HIPPY SLUM" WRITTEN AND DIRECTED BY LUIGI: THE CRAZY ITALIAN.
Ivano detto Antonio era un professore di ginnastica, precario, ci tenne a sottolineare. Insegnava in
una scuola media sui colli bolognesi. Nel tempo libero si interessava di naturopatia. Passò da me un
intero inverno: uno straordinario inverno con trenta gradi costanti. Escludendo l'infanzia e la nascita
di mio figlio, fu il più bel periodo della mia vita.
Imparai a cavalcare le onde.
Ivano detto Antonio era un genio: m’insegnò a costruire delle panchine in giardino con il legno di
palma e mi confidò i segreti della naturopatia che aveva appreso trascorrendo alcune estati con le
comunità di Elfi sparse sugli Appennini.
“E com’è?”
“L’igiene è quella che è, ma dopo un po’ ci fai l’abitudine, come qui del resto…”
“Ah, sì?” pensai sorpreso. “Ok, ma a parte le sciocchezze, com’è lassù?”
“Non ci passerei la vita, ma andarmene via dopo tre mesi è stata dura…" disse guardandomi da
vicino. "Ti assomigliano, sai?”
Prima di lasciarmi Ivano detto Antonio mi lasciò un libretto di poche pagine sulla naturopatia.
"Ora sei pronto per leggerlo" disse salutandomi per l'ultima volta.
L’altro appartamento rimase vuoto tutto il tempo, ma questo non mi preoccupava, coi quattro euro
al giorno che mi dava Ivano detto Antonio ero riuscito a cavarmela senza problemi. Avevamo
campato della verdura dell’orto e della frutta dei vicini e degli alberi selvatici. Da quando ero
arrivato non avevo più messo piede in città o in un pubblico servizio. Anche grazie a lui, non
dipendevo più dalla società, ma dalla natura.
x
Tra me e chi veniva a stare da me si è sempre creato un rapporto sincero: non ho mai sopportato la
falsità – tranne nei libri.
Più accumulavo denaro, più me ne allontanavo. Compravo piccoli appezzamenti attigui ai miei, o li
spendevo per sistemare le tre capanne. Estesi la coltivazione delle verdure e cominciai a piantare
diversi alberi da frutto. Mi facevo aiutare. In cambio permettevo loro di prelevare verdure e frutti a
piacimento, come se, per assurdo, stessi offrendo loro un all-inclusive.
I miei vicini, la coppia con le tre figlie, vivevano di stenti in una capanna a poche centinaia di metri.
Da tempo insistevo affinché mandassero le figlie a scuola. Ci provarono. La scuola pubblica distava
due ore a piedi e le tre ragazzine si stufarono ben presto di camminare sotto il sole per andare ad
ascoltare un pirla in calzamaglia. Prestai loro le mie mountain-bike. Si stufarono anche di quelle.
Decisi di tornare all'idea originale: rendermi utile in prima persona.
“Verrete lunedì, martedì e mercoledì mattina.”
“Papà dice che dobbiamo aiutarlo a pescare tutti i giorni…”
“Vi fidate di me?”
Carolina e Daiana sorrisero.
“Sarà divertente" dissi. "Andare a scuola è un vostro diritto e, se mi ascoltate, diventerà anche un
piacere.”
Quanto tempo che non calzavo i panni del pirla in calzamaglia... mi ricordava un periodo duro: un
tempo in cui, dopo essere praticamente morto, avevo ricominciato a vivere.
Carolina aveva sette anni, Daiana dieci. Non vedevo una gran differenza nel loro modo di
esprimersi e di ragionare. Una volta imparato a leggere, avrebbero imparato a scrivere. Quello era il
mio obbiettivo.
Joana invece aveva compiuto diciassette anni. Era convinta di poter sopravvivere senza istruzione.
Aveva ragione, anche se a quell'epoca io non l'avevo ancora capito.
Era una ragazza sviluppata. A P. era così, la gente maturava in fretta. L’avevo vista diventare donna
in tre anni. Era cambiata non solo nelle forme: c’era una luce diversa in quello sguardo color terra
di campo: aveva l’aria di chi sa cosa vuole.
Alle feste i nostri sguardi s’incrociavano spesso, ma non avevo mai pensato a lei come a una
ragazza d’amare, l’avevo sempre considerata la figlia del vicino. Credo di non averle mai detto
qualcosa di diverso da come sta papà?
All’improvviso i miei occhi la videro donna. A diciassette anni.
“Senti, perché almeno non mi permetti di insegnarti a suonare la chitarra?”
Sapevo che se avesse accettato, presto l’avrei convinta a imparare a leggere le parole delle canzoni
e piano piano le avrei prestato qualche libro.
“A me piace ballare.”
“Canti molto bene, Joana!” dissi sorridendole. “Se sapessi anche suonare potresti esibirti e
guadagnare qualche soldo divertendoti.”
“Non voglio lavorare per vivere. E poi guadagno già divertendomi.”
***
In quelle settimane, pensando a Salomè, scrissi un nuovo capitolo del mio romanzo breve
sull'****************, firmandomi sempre con lo pseudonimo Gianni Longhi – una specie di
dedica a Jo, se mai deciderò di pubblicarlo.
DESTINO
come subire un futuro che, ahimè, già conoscevi
Avevo sempre saputo che prima o poi se ne sarebbe andata. Non sapevo quando, né come, ma
sentivo che prima o poi mi sarei ritrovato solo.
Accadde un pomeriggio. Io me ne stavo a casa con Luna. Stava poco bene e non se l’era sentita di
uscire in esplorazione.
Ultimamente uscivamo tutti e nove, come una vera famiglia. Libera mi stava convincendo che la
vita non si fermava in quella sfera di vetro, ma l’oceano si estendeva all’infinito in ogni direzione.
Continuava a ripetermi che era meglio vivere un giorno meraviglioso ed eccitante che un’intera vita
piatta e inutile.
Io non ero del tutto d’accordo. Anzi non lo ero per niente, ma pur di non perderla, cedevo. Stavo
troppo bene assieme a lei e ai nostri pesciolini per rischiare di passare in solitudine il resto dei miei
giorni, o per ricominciare tutto da capo. Ero riuscito a costruire una famiglia e dovevo lottare e
crederci fino in fondo.
Ma quel giorno qualcosa andò storto. Il pomeriggio divenne sera e la sera notte. E la notte
lentamente aurora. Alle luci dell’alba quando Luna ancora dormiva sogni tranquilli, mi decisi a
cercarli. Vagai per ore disperate in ogni direzione col rischio di perdermi. Mi perdevo senza paura
in quel blu privo di luce che mi terrorizzava da sempre. Scoprivo nuovi odori vomitevoli e altri
tanto soavi che ne uscivo disorientato. Zigzagavo rapido sfiorando rocce ricoperte da alghe antiche.
Quando il fiatone me lo consentiva gridavo con tutto me stesso lasciando una scia di bolle
argentate. Non avevo più paura del buio o di essere mangiato vivo da qualche squalo, m’importava
solo di ritrovare lei.
Tornai a stento verso casa piangendo disperato. Luna mi sorprese saltandomi addosso gioiosa.
«Papi! Perché piangi papi!?»
Che dovevo risponderle? Che io e lei saremo rimasti soli per sempre? Che la mamma se n’era
scappata perché era stufa di stare con me? Che uno squalo se li era spappolati tutti quanti? Che
dovevo dirle?
«Non sto piangendo cara. È solo un po’ d’acqua…»
«Dov’è la mamma?»
«È partita per un lungo viaggio.»
«E i miei fratellini?»
«Anche loro.»
«Speriamo che tornano presto così giochiamo.»
«Lo spero anch’io, pesciolina mia.»
***
Pensai e ripensai alle parole delle sue amiche “…tira avanti andando a letto col primo che le
capita…”
Abitavo a poche centinaia di metri da casa sua e non mi ero accorto di nulla.
Pur avendo sguazzato per mesi e mesi tra le puttane d’alto bordo, ne rimasi sconvolto: la figlia
minorenne dei vicini era una prostituta.
Decisi di seguirla. Volevo scoprire con i miei occhi come trascorreva le giornate.
Un mattino la vidi passare. La sabbia dorata le usciva dalle mani. Aveva addosso una maglietta
troppo corta e dei pantaloncini di jeans che le coprivano a stento le natiche. La salutai alzando la
mano e finsi di dirigermi verso casa. Non era facile seguirla senza essere visti.
Era un giovedì, una giornata qualunque. Joana si muoveva lentamente guardando spesso l’oceano, a
volte il cielo. Camminò per mezzora senza fermarsi.
La seguivo da lontano nella spiaggia deserta. Quando si sedette, io mi nascosi dietro a una palma da
cocco. La sentivo cantare una bossanova con voce soave. Il suo canto innocente riempiva l’aria di
tristezza. Ebbi un fremito, come se un cubetto di ghiaccio mi stesse scivolando lungo la colonna
vertebrale. Stette per alcuni attimi in silenzio seduta sulla spiaggia dorata. Senz’anima viva a parte
noi. Si alzò e cantò di nuovo, stavolta un samba, accennando qualche passo di danza. Io la
osservavo senza parole.
Non avevo né orologio né cellulare, mi regolavo col sole. Il tempo non mi importava più come una
volta. L’unità di misura del tempo era un concetto superato. A volte mi sembrava inutile anche l’età
della gente.
Qui si viveva nello spazio, non nel tempo: la differenza sostanziale rispetto al mondo che mi ero
lasciato alle spalle.
Quando ero triste, quasi mai per la verità, recitavo questo mantra:
Buio. Ore sei e trenta levataccia. Ore otto e trenta timbratura entrata, ore otto e quarantacinque
appuntamento con avvocato Ciarlatano, ore dieci e trenta dentista Succhiadanari, ore tredici pausa
pranzo presso Osteria Tramezzino, ore quattordici riunione con rappresentanti della Società
Sfigati&Sfigati, ore sedici e trenta incontro con clienti Spaccamaroni, ore diciotto e trenta, salvo
ritardi vari ed eventuali, timbratura uscita. Buio e morte.
Poi ridevo come un matto. Era un mondo che, solo a nominarlo, strideva col mio paradiso: laggiù
erano schiavi del tempo: una società intera dentro al proprio ufficio a far girare un’economia stagna:
lo stress a farla da padrone.
Nella mia vita il tempo era regolato da albe e tramonti, dal brontolio della pancia, dal calare della
palpebra, dalla gola secca, dal desiderio sessuale.
La natura dettava il ritmo, non una stupida agenda degli impegni.
Mentre io ridevo del gregge che avevo abbandonato, Joana sambava senza sosta come in un rito
propiziatorio. Madida di sudore la sua pelle riluceva da lontano. Lentamente si avvicinò all’acqua,
si spogliò e si gettò nell’oceano. Nuotò finché il sole non fu alto sull’orizzonte. Uscì dall’acqua e
rimase in piedi qualche istante. Si rivestì senza fretta e tornò verso nord.
Come eravamo diversi eppure simili... Quanto mi affascinava quella ragazza... La seguii con lo
sguardo fino a quando fui certo che si dirigeva verso casa. Non sapeva scrivere, ma aveva l’aria di
una poetessa, i modi di un angelo e il corpo di una dea. Passava il tempo senza far nulla, e ci
riusciva a meraviglia.
Nel primo pomeriggio andai da lei fingendo di cercare suo padre.
“Ciao, c’è per caso il vecchio?”
“Ciao! Come va? Papà è andato a pescare, ci siamo solo io e mia madre” disse Joana guardandomi
negli occhi. “Anzi ora che ci penso mia madre è andata da un'amica. Vuoi un po’ d’acqua?”
“Lo sai che non posso bere quell’acqua io, poi dovrei passare una settimana in bagno!” dissi
sorridendole. "E io un bagno non ce l'ho!"
“Ti va un tè?”
“Ben bollito, grazie.”
Aveva lo stesso costume che portava al mattino. La osservavo muoversi nella penombra della
cucina. La pancia appena accennata, le gambe muscolose e fine, le spalle larghe, il viso liscio.
Cercavo di non provare nessun desiderio (come predicavano gli ultimi due comandamenti del dio
cristiano). Era donna, eppure minorenne. Non mi sentivo libero di desiderarla. La mia missione era
di aiutarla. Distolsi lo sguardo e pensai a qualcosa da dire.
“Qua da voi è più fresco.”
Lei mi guardò. “Dici?”
“Non so, mi sembra.”
“Può darsi, non saprei.”
“Credo proprio di sì, direi di sì” dissi poco convinto.
Lei portò il tè caldo sulla tavola e mi allungò lo zucchero di canna che preparava sua madre.
“Grazie.”
“Non lo bevi con lo zucchero? Sei pazzo? Lo bevi amaro? Che strano che sei, straniero!”
Perché mi chiamava straniero? Nessuno mi aveva mai chiamato straniero. Però mi piaceva.
“Hai da fare, Joana?”
“Niente, come al solito.”
“Hai voglia di un po’ di surf?”
“No, grazie, stamattina ho nuotato. Per oggi basta acqua.”
“Facciamo un giro in mountain-bike? Lo sai che ne ho quasi una decina a casa?”
“Dieci bici? Che te ne fai?”
“Le do ai miei ospiti.”
“Ok.”
“Ok che?”
“Ok vengo.”
“Bene, andiamo dai. Ti mostrerò un posto fantastico!”
“Uno straniero che mi impara il Brasile? Non farmi ridere straniero!”
“Sì, uno straniero che ti mostra un angolo di paradiso che non conosci. Vieni, Jo!”
Soltanto quando lo pronunciavo mi accorsi che le avevo dato lo stesso soprannome che davo anche
a Giovanni.
“Aspetta, fammi finire il tè! Sempre di fretta voi stranieri!”
“Ho semplicemente voglia di vivere.”
“Anch’io, ma… hai molto da imparare ancora straniero!” disse sorridendo.
Andammo a prendere le biciclette e ci inoltrammo nella foresta amazzonica. Non aveva molto
equilibrio in sella, ma spingeva sui pedali con forza, senza fatica.
Era umido, ma l’ombra degli alberi era rilassante. Percorremmo una ventina di chilometri su una
strada sterrata piena di sassi e radici. A un certo punto avremmo dovuto lasciare le bici e camminare
a piedi.
“Da qui in poi niente bicicletta.”
Le osservai i piedi.
“Non avevo pensato che eri scalza. Che stupido! Come facciamo ora?”
Joana mi guardò e scoppiò a ridere. “Straniero, è da quando sono a questo mondo che cammino a
piedi nudi!” disse incamminandosi. La seguii con gli scarponi da montagna che avevo portato dal
Trentino. In poco tempo giungemmo all’angolo di paradiso che le avevo promesso.
“Superbacana…” disse spalancando gli occhi. Una grande roccia scura, da cui sgorgava una fonte
d’acqua gelida, aveva creato un laghetto. Gli alberi della foresta lo circondavano di verde
rendendola invisibile. Senza guardarmi, si spogliò e si buttò in acqua. Ancora una volta, senza
volerlo me la ritrovai nuda di fronte agli occhi.
“Che aspetti, straniero?”
Mi tolsi la maglietta bianca e mi tuffai anch’io.
“Che matto che sei! Perché hai tenuto il costume?”
Non sapevo che rispondere. Guardai in alto. Mi spostai per prendere in faccia la cascatella. Quando
le fui vicino sentii che mi stava sfilando il costume con i piedi. Non riuscii a oppormi, e lei lo gettò
via.
“Vado a riprenderlo, chiudi gli occhi!”
“Se vuoi vado io" disse lei. "Però gli occhi li devi tenere aperti!”
“Lascia stare. Ma non credere che in Italia ci si comporti così!”
Ero io quello? Ero io che pronunciavo quelle parole? O era quello sfigato Giovanni che si era
impossessato del mio corpo?
“Infatti qui siamo in Brasile! E in Brasile quando si è soli non si fa mai il bagno col costume!”
Non sapevo come controbattere.
“Senti, Joana, come passi le giornate?”
“A divertirmi!”
“Perché non aiuti tuo padre con la pesca? Non ti piace?”
“L’ho fatto per anni. Ora ci sono Carolina e Daiana che lo fanno al posto mio. E poi non è un lavoro
da donne.”
“E qual è allora un lavoro da donne?”
“Quello che fa mia mamma, cucinare, pulire casa, raccogliere la frutta nella foresta, badare all’orto,
vendere il pesce al mercato…”
“Quindi hai intenzione di farti mantenere per tutta la vita?”
Dovevo aver azzeccato la domanda perché lei non rispose. Gli occhi le si fecero tristi.
“Ho detto qualcosa che non va?”
Non rispondeva.
“Non volevo rattristarti” dissi spruzzandole in viso un po’ d’acqua. Lei non reagì, uscì dal laghetto e
si distese sull’erba senza parlare.
Non sapevo che fare. Ero nudo. Attesi che si decidesse a parlare o quantomeno a rivestirsi. Niente.
Rimaneva sdraiata senza parole. Mi domandai se stesse dormendo. Poi mi decisi a uscire. Mi
avvicinai cautamente. All’improvviso lei si alzò e, prendendomi per le spalle, mi sbatté a terra. Si
sedette sopra la mia pancia tenendomi fermi i polsi. Se avessi voluto mi sarei liberato. Ma com’era
dolce rimanere sotto a quel corpo di donna! Chiusi gli occhi. Dovevo aiutarla, non usarla come
faceva il resto del mondo!
“Sono così brutta che non mi vuoi guardare?”
“Lo sai che non è questo il motivo.”
Lei non disse niente.
“Davvero non capisci?”
“Non ti piaccio?”
“Sai bene di essere una bella ragazza.”
“E qual è il problema allora? Ami gli uomini?”
Sorrisi di fronte a tanta ingenuità. Sembrava una donna, ma spesso ragionava come una bambina.
“Joana, ti rendi conto che ho quasi il doppio della tua età?”
Mi guardò stranita. Puntò l’indice verso di me. Poi si scansò per gettarsi a terra e ridere
all’impazzata.
Non la finiva più. Si fermava a guardarmi e rideva ancor di più. Io nel frattempo mi ero messo una
mano lì per cercare di coprire almeno in parte le mie impudicizie.
“Straniero, sei in Brasile da tre anni e hai la testa ancora in Italia!”
“Che intendi dire?”
“Io ho fatto l’amore con uomini molto più vecchi di te. Ho fatto sesso con tanti di quegli uomini che
se lo sapessi non ci crederesti.”
“Quanti? Dieci? Quindici?” dissi. Sapevo che mi sarei avvicinato di più aggiungendo uno zero.
Ricominciò a ridere. Si contorceva sull’erba con il corpo nudo e lucente. Infine si alzò a sedere e si
fece più seria, ma sempre sorridendo.
“Io gli uomini non li odio e non li amo: mi piace solo andarci a letto.
“La prima volta avevo tredici anni. Andai a letto con mio cugino che aveva più o meno vent’anni.
Una settimana dopo con mio zio, il padre di mio cugino. Mio zio aveva esagerato. Non mi piaceva
quello che mi aveva fatto. Ho riprovato con mio cugino dopo che avevo compiuto quattordici anni.
Con lui era sempre bello e divertente. Allora ho provato con altri ragazzi della mia età. Mi piaceva
andare a letto con loro. Dopo però volevo gente più grande, venticinque, trenta, anche quarant’anni
se uno mi voleva.”
Mi guardò con il viso di una che si è accorta di aver detto troppo. “Che c’è? Non mi credi?”
“Sì, Joana, ti credo. Dev’essere stata un’adolescenza vivace la tua.”
“Ado che?”
“Un periodo con alti e bassi…”
“Ti sbagli, straniero. Ho sempre amato fare sesso. Chiedi alle mie amiche. Non ho mai smesso, mi
piace troppo. Non c’è niente di male a godere.”
“Hai ragione, non c’è niente di male se entrambi lo desiderano, se uno non forza l’altro come ha
fatto tuo zio.”
“Che ne sai che non volevo? Lui mi piaceva, è stato solo un po’ violento, ma non cattivo.”
“Non credi che lui e tuo cugino si siano approfittati di te, che ti abbiano fatto del male, che ti
abbiano cambiato la vita?”
“Ero stata io a sedurli. La colpa è mia. Non mi hanno cambiato la vita. Avrei comunque scoperto le
gioie del sesso. Sono contenta della mia vita. Non c’è niente di male in quello che faccio.”
“E cosa fai esattamente?”
Lei ci pensò un po’ prima di rispondere. “Faccio l’amore con chi mi piace… anzi, faccio sesso con
chi voglio, sesso senza amore, ecco cosa faccio tutte le sere.”
“E loro cosa ti danno in cambio?”
“Quello che vogliono. Mi offrono la cena, mi pagano la caipirinha, mi portano a ballare, mi portano
in città…”
“Non ti danno mai del denaro?”
“Cosa cambia?”
“Rispondi alla domanda, Joana.”
Si morse un labbro. “Alcuni mi danno dei soldi. Cosa cambia? Sono loro che vogliono darmeli. E se
poi non voglio più fare l’amore con loro, glielo dico, e loro spariscono.”
“Finora ti è andata bene, ma sai che non potrà andare sempre così. Non devi fidarti di tutti quelli
che incontri. Te ne pentirai.”
“Che ne sai tu?”
“Ci ho pensato. Rischi che il tuo passatempo diventi un lavoro, e questo non va bene.”
Feci una pausa.
“Per non parlare delle malattie…”
“Non capite niente voi! Per noi il sesso è divertimento, è come respirare, non è un lavoro, ma una
cosa naturale, una necessità del corpo per sfogarsi dai pensieri cattivi. Io sento che faccio del bene
agli uomini con cui vado, capito?”
Smettemmo di parlare. Cercavo di concentrarmi sul suo viso. Speravo mi passasse
quell’ingombrante erezione. Eppure il mio corpo era schiavo del suo. I miei pensieri catalizzati su
di lei.
Qualcosa mi diceva di non approfittare di quella ragazza.
La scansai deciso e andai di nuovo in acqua con un tuffo rapido. Nuotai come un forsennato fino a
stancarmi. Lei nel frattempo si era rivestita. Mi guardava e scuoteva il capo lentamente, da una
parte all’altra.
“E comunque io amo solo le donne” disse.
“Non fare la bambina” stavo per dire.
Tacqui. Forse si sentiva rifiutata per la prima volta, e in tal caso non poteva che farle bene. Oppure
non capiva cosa frullava dentro la mia testolina, e allora le davo ragione, perché anch’io non lo
capivo del tutto.
Mi rivestii. Tornammo alle biciclette. Durante il ritorno non disse una parola. La invitai a cena con
gli altri ospiti. Declinò. Ci salutammo, entrambi strani e insoddisfatti.
***
Continuai a dare lezioni alle sorelle. I progressi erano lenti ma continui. Con la lettura se la
cavavano come un bambino di seconda elementare, ma non c’era modo di insegnare loro a scrivere.
Si rifiutavano di prendere in mano una penna e mettere nero su bianco delle parole. Si perdevano in
ghirigori arzigogolati per poi passare a disegnare un tramonto, una spiaggia, un albero di cocco, una
baracca o un fiume, oppure i loro genitori, la sorella maggiore, le loro caprette.
Non importava. Avrei insegnato loro a leggere, e leggendo avrebbero visto il mondo con altri occhi,
e questo mi bastava. Se poi avessero desiderato andare oltre, avrebbero potuto farlo. Ci contavo.
Smisi di seguire Joana. Evitai d’incontrarla alle feste. Io non cercai lei e lei non cercò me.
Non so come riuscii a non cadere nella sua rete per poi finire inglobato tra quelle gambe agili e
vissute.
Nella vita avevo sempre seguito l’istinto. Qualcosa mi diceva di stare lontano da quella ragazza.
L'istinto sessuale mi spingeva da lei, e forse anche il cuore. Ma c’era qualcosa in me che diceva il
contrario. Non so se fosse la razionalità a guidarmi a livello inconscio, o piuttosto un sentimento
difficile da individuare, che mi impediva di avvicinarmi a lei. Non era paura. Era una sensazione
strana, mai provata prima, che mi sussurrava di aspettare tempi più maturi.
X
Ho mentito. Frequentavo un servizio pubblico, ma senza vergognarmene. Dipendevo dalla società:
avevo una tessera della biblioteca di P. I libri - pochi eletti - erano il ponte che mi teneva collegato
con la società, anche se a dire il vero risalivano a società precedenti.
Quando finii di rileggere per la terza volta il libro di Ivano detto Antonio ero un uomo nuovo. Entrai
nel mondo della filosofia olistica. Le letture richiamarono altre letture, crebbe dentro me una
passione per il benessere. Ero convinto che curando il mio fisico, avrei influito sul mio stato
psicologico.
Trovai un libro sull'alimentazione naturale – e non solo – che divenne presto la mia bibbia. Era stato
scritto da un intellettuale e coltivatore locale nel 1977. Un rivoluzionario silenzioso. Ne ho ricopiato
alcuni estratti:
...cominciai a mangiare esclusivamente frutti e verdure freschi, appena raccolti, poiché avevo
scoperto che i nutrienti delle sostanze cotte o surgelate se ne volano via. La mia vita cambiò. Non
perdevo più tempo a cucinare, lavare piatti, fare la spesa in centro una volta alla settimana.
Divenni ancor più indipendente dalla società e dipendente dalla natura.
[...]
Ogni giorno colgo i frutti tropicali della madre terra: avocados, kiwi, papaya, banane, noci di cocco,
mango… qui, nel Brasile del nord-est, ci sono una miriade di specie di alberi da frutto: infatti il
novanta per cento di ciò che ingerisco è frutta, il restante verdura del mio orto. Null’altro, se non,
ogni tanto, acqua di sorgente.
[...]
Ho totalmente eliminato carne, uova, latte e formaggi. Mi sento meglio. Più leggero, più vivo, più
sveglio. Le energie che prima impiegavo per digerire cibi poco digeribili, ora la utilizzo in modi più
costruttivi, come camminare e pensare.
[...]
Se i gorilla, che hanno il novantotto per cento del DNA uguale al nostro, si cibano solo di banane, e
sono grandi e grossi, ci sarà un motivo.
[...]
E poi perché io, uomo adulto, dovrei bere il latte destinato a svezzare giovani vitellini?
Nel sud-est asiatico non si beve latte: hanno tutti l’osteoporosi?
[...]
Ho capito perché in natura gli animali non sono grassi o magri, ma uguali ai membri della stessa
specie. Solo l’uomo e, guarda caso, gli animali domestici, lo sono. L’animale non ha orari, mangia
quando ha fame.
[...]
Non siamo fatti per mangiare altri esseri dotati di anima, ma per cibarci di ciò che la natura ci offre:
frutta e verdura.
[...]
Imparai a sentire i gusti, non gli aromi chimici che avevano sempre ingannato il mio palato fin dai
tempi degli omogeneizzati. Ciò che non aveva un bel aspetto o che puzzava, non lo mangiavo.
Tornai a sentire gli odori. La carne e il pesce puzzano: ecco perché li si è sempre cotti e speziati. Per
non parlare di come si allevavano gli animali al giorno d’oggi: ormoni a non finire per trasformare
in un mese un piccolo pulcino in una gallina pronta da spennare!
[...]
Ecco perché frutta e verdure appena colte erano l’ideale per vivere sani e leggeri! Lo so sembra una
pubblicità, che lo sia pure se serve a farmi stare meglio.
[...]
Siamo ciò che mangiamo.
L’alimentazione non fu l’unica cosa di cui parlava questo genio incompreso:
Vivevo in mezzo a cose superflue che non facevano che distrarmi dalle cose importanti (sempre che
al mondo esistano cose importanti). Eliminai. Tagliai come uno scrittore taglia le parole di troppo,
le frasi inutili, i paragrafi in più, i capitoli inefficaci, i libri mal riusciti.
Inventai una filosofia: la decosificazione.
[...]
Non c’è miglior massaggio che camminare scalzo: naturale, gratuito e gratificante. Quante cose
inutili compra la gente. Quanti sprechi. Poi tutti a lamentarsi che non ci sono soldi per vivere: non
c’è il cervello per vivere!
La verità è che una volta, in molti stati del mondo, non serviva nemmeno un tetto sulla testa. Se il
clima non lo richiedeva, per vivere bastavano un paio di vestiti, e del cibo da mettere sotto i denti.
[…]
Cosa c’è di più perfetto di una vita immersa nella natura? In mezzo all’essenziale. Il resto è falsità.
Un imbroglio nel quale cadono in molti, un inganno al quale siamo stati educati. Il punto è questo:
rompere con la tradizione, non fidarsi di ciò che ci viene raccontato, aprire la mente e non dare
niente per scontato. Dobbiamo rifuggire l'omologazione. Pensare con la propria testa, ecco cosa
manca alla gente, uscire dall’inconscio collettivo.
Tutto ciò l’avevo intuito prima di andare in Brasile, ma solo lì ho potuto viverlo in prima persona.
Ho passato l’infanzia, l’adolescenza e gli anni dell’università ad ammalarmi in continuazione di
ogni genere di malattia: raffreddori cronici, continue influenze, pubalgie, allergie, tendiniti,
reumatismi. I miei amici chiamavano l’ipocondriaco.
In Brasile mai una linea di febbre, un mal di gola, un colpo di tosse, un naso che cola. Forse il
clima, forse l’alimentazione, forse l’ottimismo, fatto sta che rinacqui rigenerato fisicamente e
psicologicamente.
Il giorno seguente regalai ai vicini il mio esiguo guardaroba. Tenni l'indispensabile per entrare in
biblioteca.
Tornai alle piccole cose. Mi alzavo al mattino riposato e correvo sulla spiaggia. Poi mangiavo frutta
a sazietà. Mi lavavo i denti e poi giù in acqua con il surf, oppure un paio d’ore all’aperto a dare
lezioni alle sorelline di Joana. La mattina passava veloce e tornavo in giardino stanco e affamato.
Una coppa di verdura e un paio di frutti per pranzo. Nel primo pomeriggio un pisolino, e mi davo
alla lettura. Un paio d'ore prima che tramontasse prendevo la mountain-bike e percorrevo dai venti
ai cinquanta chilometri sul litorale o all’interno, fin dove la vegetazione era fitta e scura. La sera
invitavo i miei ospiti a cena e preparavo un barilotto di macedonia per tutti, qualche manioca e delle
carote da sgranocchiare. Col tempo smisi di ubriacarmi e cominciai a suonare la chitarra. Non
partecipavo più ai party che davano sulla spiaggia, vicino alla città. Ballare ubriaco mi piaceva
ancora, ma preferivo un altro tipo di divertimento, più intimista.
L’unica cosa che non era cambiata, era il numero di donne che mi portavo a letto. Ragazze di ogni
tipo dai venti ai quarant’anni. Nere, bianche, mulatte, bastava che respirassero. A volte capitava che
alcune mi piacessero veramente – era dura lasciarle andare – altre invece erano semplicemente la
soddisfazione di un desiderio estemporaneo.
x
Un mattino, sempre più affascinante e adulta, passò da me. Erano mesi che non la vedevo. M’invitò
al suo ventitreesimo compleanno. Erano passati quattro anni da quel pomeriggio nella giungla.
Ballava circondata da un’orda di ragazzi e uomini maturi. Tutti a contendersi quel corpo divino. Io
stavo in disparte, parlando con altri surfisti. A mezzanotte brindammo. Lei mi fissava con occhi
luccicanti. Nel buio della notte si avvicinò.
“Ti va di ballare, straniero?”
“Non molto a dire il vero…” dissi.
Lei continuava a guardarmi senza perdere il sorriso.
“Auguri, Joana” dissi baciandola sulle guance. “Sei felice?”
Mi mostrò il bianco perfetto dei suoi denti. “Ti va di fare due passi?”
Camminammo verso est lungo la battigia, facendoci cullare dall’acqua salata.
“Hai deciso cosa fare della tua vita?”
“Potrei farti la stessa domanda, straniero.”
“Hai in mente qualche viaggio?”
“Non potrei permettermelo.”
“Ti ci porterei io…” pensai tra me e me.
Ero agitato, me ne accorsi all’improvviso. Sentivo lo stomaco stringersi, contorcersi, e le gambe
tremare leggermente. Non volevo ammetterlo, ma i sintomi erano chiari. Successe di colpo, eppure
era un sentimento che covavo da anni.
Finsi una naturale rilassatezza. Camminavo al suo fianco finché lei non mi prese la mano senza
smettere di osservare il nulla dell’oceano nero. Le tremava la mano. Non ne ero certo, forse era la
mia a tremare. Avvertii un’altra fitta alla bocca dello stomaco. Ero così abituato a scopare, che
avevo dimenticato come si baciava una ragazza. Avevo paura. La osservavo con la coda
dell’occhio, nell’oscurità, intuendo solamente il luccichio dei suoi occhi.
All'improvviso una goccia calda. Lei si voltò con il viso inondato da lacrime silenziose. Senza dire
niente alzò lo sguardo, si avvicinò, e in punta di piedi mi baciò sulle labbra. Erano inumidite dal
pianto, le sue labbra amare. La strinsi per farle sentire quanto era forte il mio sentimento. Tremavo e
volevo che lei lo sapesse. Non la stavo prendendo in giro, amavo quel fiore acerbo e maturo,
quell’anima cresciuta troppo in fretta. La baciai e mi lasciai baciare. Le mie mani sulla sua schiena,
le sue sulla mia. Si alzò un vento notturno a scompigliarle i capelli. Le posai le dita sul mento, poi
sulla fronte. La guardai a lungo negli occhi prima di baciarla ancora. Quant’erano belle quelle
labbra carnose, quella pelle brasiliana, quel naso piccolo, quegli occhi grandi come bocche da
sfamare.
“Grazie di avermi aspettata” disse. Sapevo cosa intendeva.
Tornammo alla festa. La lasciai coi suoi amici e andai a parlare con due ragazzi messicani che
stavano da me. Si congratularono per aver rimorchiato la ragazza più bella. Confessai che me ne ero
innamorato. Mi fecero un’altra volta i complimenti, ma mi accorsi che non mi credevano. Eppure
era vero, la conoscevo da anni, l’avevo vista crescere: solo ora mi ero accorto che la amavo. Ogni
tanto la osservavo da lontano e lei con la coda dell’occhio si faceva osservare sorridendo. Ogni
secondo era più bella. Ballò con un’infinità di ragazzi per tutta la notte mentre io e i messicani
fumavamo canne su canne aspettando le luci del giorno. Non avevo bisogno di droghe: ero felice,
sentivo che la mia vita stava per salire un gradino senza ritorno.
Al mattino certamente alcuni ancora ballavano. Io me ne ero andato dalla festa poco dopo l’alba
facendole un gesto col capo. Lei aveva sorriso mentre il suo corpo si muoveva infaticabile al
forsennato ritmo di un samba.
Quando il sole era alto mi destai. Aprii gli occhi. Lei era in piedi di fronte a me. Mi guardava senza
parlare. Slacciò il suo costume mostrando due seni giovani e forti. Sfilò il tanga e si sdraiò su di me
baciandomi con la lingua.
Fu quella la prima volta che facemmo l’amore. Avevo aspettato più o meno consciamente quel
momento per anni. Lo facemmo più volte senza uscire di casa fino al tramonto. Dormendo
abbracciati e cullandosi l’un l’altra in un miscuglio di sentimenti, sudori e umori.
“Non potrò amarti.”
“Per me va bene” dissi dopo un po’.
X
La andai a prendere all’aeroporto, in bici. Aveva uno zaino da una sessantina di litri e una valigia in
pelle logora e pesante almeno quanto lei.
"Ecco la mia zingara preferita!" dissi.
Mi sorrise. Lasciai la bici cadere a terra come un bambino, e come un bambino l’abbracciai.
“Fatti guardare!” le dissi allontanandola con un gesto brusco. “¡Wow, chica, eres maravillosa!”
“¡Que no me tomes por culo, tio!”
“¡No, de verdad, eres todavia màs guapa!” Pensavo veramente che fosse bellissima. Aveva
superato i trenta, ma non ne dimostrava più di venticinque. I capelli rasta, la vita fina, i fianchi
stretti e un seno più maturo di qualche anno prima. Un viso ancora liscio con qualche efelide qua e
là. I soliti jeans, una maglietta aderente, le infradito e in mano un tomo, un Dostoevskij in lingua
originale. “Ti conviene riporre I fratelli in borsa, se non vuoi che ti si sciolgano in mano, baby”
dissi. "E toglierti subito quei jeans attillati, se non vuoi colare!"
“Sei il solito porco, Luis… mi vuoi sempre in mutande, eh?”
“Come il solito porco? Se non ti ho mai sfiorata con un dito?”
“Ci è mancato poco però, giusto?”
“Ahimè…”
Sorrise compiaciuta.
“Come facciamo coi bagagli?”
“Stavo per farti la stessa domanda… perché non sei venuto in auto?”
Scoppiai a ridere. “Per esempio perché non ho un’auto…”
“E come ti sposti?”
“Non mi sposto.”
“Iniziamo bene” disse sorridendomi. “Che si fa?”
“Autobus?”
“Ma non abiti in mezzo al nulla?”
“In effetti... però ci dovrebbe essere una fermata a una decina di chilometri da casa mia, dicunt…”
“Senti, ho capito va’, prendiamo un taxi.”
“Sei matta? Ti verrà a costare una fortuna!”
“Tranquillo, fortuna non ne ho mai avuta... non me la possono rubare” disse senza sorridere.
"Comunque cosa intendi per fortuna?"
“All’incirca quello che guadagno io in una settimana,” ammisi.
“Joder, tio, sei sicuro di stare bene?”
“Mai stato meglio, baby!” dissi prontamente. "Lo vedrai coi tuoi occhi!”
“Speriamo bene…” disse richiamando l’attenzione della vettura ferma davanti all’uscita. Il tassista
corse a prendere i bagagli. Non erano molti considerato che quello era un trasloco. Ci avrebbe
portati a destinazione, noi, i bagagli e la bici, per venticinque euro.
Appena Salomè vide l’oceano la bocca le si spalancò lasciando spazio a un sorriso puerile. Le passò
d’un tratto la stanchezza.
Non vedevo l’ora di mostrarle il mio piccolo eldorado.
“Eccoci” dissi a Salomé e all’autista.
Mentre scaricavo i bagagli, lei pagò con una banconota da cinquanta euro ricevendo una sfilza di
reais come resto. Il taxi dopo un paio di manovre se ne andò sollevando una nuvola di polvere.
“Che ne dici?”
Non apriva bocca.
“Salomè, ci sei? Sei tra noi, baby?”
“Non so che dire, è…” disse interrompendosi. “È… non so… strano.”
“Strano?”
“Cioè molto particolare, molto brasiliano” disse facendo le virgolette con le dita.
“Non ti piace?”
“No, non fraintendermi, non è che non mi piaccia, il paesaggio è molto bello, selvaggio e… guarda
che onde laggiù!”
“E allora qual è il problema?” dissi senza capire.
“Forse, ecco, me lo aspettavo un po’ più… non offenderti… pulito?” disse sempre virgolettando.
“Intendi dire che è sporco?” dissi virgolettando pure io.
“Beh… non lo so… non sono mai stata un’amante dell’igiene ma… ecco… mi dà un po’
quest’idea, tutto qua, niente di grave” disse sorridendo esageratamente.
“Non capisco…”
“Non c’è niente da capire, è colpa mia, devo solo farci un po’ l'abitudine.”
Non riuscivo a smettere di osservarla.
“Perché non mi accompagni in spiaggia, Luis?”
"Non ti va di conoscere Joana prima?"
"Preferirei la spiaggia" disse facendosi seria.
"Come vuoi."
Buttai la bici nell’erba, lasciammo i bagagli in giardino, presi Salomè per mano e la trascinai di
corsa verso l’oceano.
"Lasciami. Non ho voglia di correre."
Appena i suoi piedi sfiorarono la sabbia, non seppe resistere, si tolse jeans e maglietta e, in
mutande, si tuffò in acqua. Io la raggiunsi e insieme cominciammo a nuotare verso l’orizzonte.
Al ritorno, in un punto in cui si riusciva a toccare il fondo, si fermò.
"Luis, non vorrei che ti facessi strane idee."
"Che intendi dire?"
"Intendo dire che sono qui in vacanza. Non so quanto rimarrò."
"Per me puoi rimanere anche tutta la vita!"
Sbuffò.
"Perché voi uomini siete così tonti?"
Alzai le spalle.
"Joana mi odierà."
Scoppiai a ridere.
"Tu non la conosci."
"Senti, Luis, smettila di ridere, è una faccenda seria. Io voglio solo stare bene qui. Non voglio
nessun tipo di attrito o frizione... insomma hai capito. Io e te siamo solo amici. Ti è chiaro?"
"Certo, chiarissimo" dissi col cuore spezzato in mille schegge impazzite da un fulmine invisibile. "E
che altro?"
"Bene, volevo solo che lo sapessi."
Uscimmo dall'acqua e ci sedemmo sulla sabbia, fino ad asciugarci.
“Questa è Joana, la ragazza di cui ti ho parlato. È venuta a vivere da me un paio d’anni fa.”
“Piacere, Salomè.”
“Piacere, Spagna?”
“Sì, Spagna! Si vede tanto?”
“Si vede e si sente” rispose Joana in portoghese, invitandola a entrare. “Scusa per il disordine ma
Luigi non mi aveva detto del tuo arrivo.”
“Ah no?” disse lei guardandomi con rimprovero.
“Perché non invitiamo i nostri vicini a cena stasera? Ah, a proposito, ci sono un paio di argentini qui
da noi, vero?” dissi chiedendo conferma a Joana.
“Veramente sono partiti ieri notte per Recife, non torneranno prima di tre o quattro giorni.”
“Ah, non lo sapevo. Potevano dirmelo.”
“Te l’avranno detto, straniero, ma tu come al solito te ne sarai dimenticato!”
“Dici?”
“Dico” ribatté Joana storcendo la bocca.
Salomé sorrise. Capiva abbastanza bene il portoghese.
“Tu che lo conosci da anni, è vero o no che ha sempre la testa per aria?”
“Confermo, testa per aria! …evidentemente non è cambiato!” rispose in spagnolo.
“Ok ok, calmiamoci! Non alleatevi subito contro di me!” dissi prendendo la valigia di Salomé.
“Dove la mettiamo la nostra ospite, Jo?”
“Dove meglio crede, no?”
“Qui o nella villetta vuota?”
“C’è spazio anche qui” disse Joana guardandomi. Quindi rivolgendosi a lei “Dormi dove vuoi cara.”
“Per me va bene anche qui se non disturbo.”
“Come?” disse Joana senza capire.
“Qui sul tappeto” disse Salomè indicandolo.
“No, vieni nel letto con noi” disse Joana. “Non disturbi, cara.”
Riposi la valigia nello stesso punto in cui l’avevo sollevata. Mi faceva sorridere che una
venticinquenne chiamasse cara una ragazza di oltre dieci anni più vecchia di lei. Eppure Joana
dimostrava molto più dei suoi anni, più di quanti ne dimostrava Salomé.
“Ti va un succo di mango bello fresco, cara?”
“Non chiedo altro dalla vita!”
Era la prima volta che sentivo dialogare due persone in due lingue diverse e capirsi a meraviglia.
“One for me, please!” dissi.
“Mi spiace, ma non capiamo l'inglese” disse Joana sorridendo di gusto verso Salomé.
In meno di cinque minuti tutti e tre stavamo sorseggiando una pinta di mango ghiacciato sotto il
sole cocente di un’estate perenne.
x
Caro Zen,
qui la vita è sempre uguale. Passano i mesi e passano gli anni. Io, Joana e Salomè siamo un trio
perfetto. Mai un litigio, mai una discussione. Abbiamo trovato un equilibrio che funziona a
meraviglia.
Mi sento un uomo fortunato. Sono finalmente felice, felice di svegliarmi al mattino e di
addormentarmi la sera tra le loro gambe lisce.
Quando passi a trovarci?
Un bacio,
Luigi
***
Io e Salomè stavamo leggendo in giardino, quando il suo telefonino squillò. Joana era andata a farsi
una nuotata nell'oceano.
Non ci credevo. Giovanni stava chiamando per dirci che era all’aeroporto di Verona in partenza per
Los Angeles. L’avevano promosso al quinto livello.
Salomè nel pomeriggio prenotò un volo P. S. - Los Angeles e di lì a due giorni saremo stati anche
noi dal mistico Zen: mistico fino a un certo punto: stava per trasferirsi negli Stati Uniti d’America,
il signorino.
Il biglietto ci costò un occhio della testa, abituati a vivere senza denaro. Non c’erano soldi spesi
meglio che quelli per andare a trovare vecchi amici in giro per il mondo.
Joana non venne con noi. Era incinta. Al sesto o al settimo mese, non lo sapevamo con precisione.
Non voleva saperne di ospedali. Il suo unico medico era sua madre. Io e Salomè potevamo stare
tranquilli. Joana era in piena salute. Disse che non se la sentiva di prendere un aereo, ma sapevamo
che odiava gli Stati Uniti, soprattutto i posti come Los Angeles. Capiva poco l'italiano, figuriamoci
l'inglese. Sarebbe stata meglio a casa, con la sua famiglia.
Jo e Zen stavano guardando per aria in silenzio nella zona arrivi. Alle mie grida si girarono
improvvisamente. Appena ci riconobbero, ci vennero incontro.
“Ehi, ragazzi, indovinate chi vi ho portato?”
“Come va?” disse Zen col suo solito fare tra lo spento e l’equilibrato. “Tutto bene?”
Jo lo seguiva senza dire niente.
Abbracciai Zen e lo lasciai a Salomè. “Ciao, Zeno! Ti ricordi di me?” disse lei entusiasta facendogli
l’occhiolino. “Come ti sei fatto carino!”
Zeno arrossì e l’abbracciò timidamente.
Andai da Jo e gli scrollai le spalle. “Che c’è, vecchio mio? Non ti accontenti neanche del quinto
livello?” Lo abbracciai forte. Era teso all’inverosimile. “Forza, stringimi! Hai messo su pancetta,
eh?”
“Ciao, Luigi” disse poco convinto.
“Che c’è, Jo? Sveglia, sei in vacanza!”
Finalmente sorrise. Erano anni che non ci vedevamo. Si trattò di un sorriso tirato, niente più. Poi
capii. Era agitato. Non vedeva Salomè da secoli.
“Zen, portaci subito a casa che molliamo la roba e attacchiamo a bere!” dissi mentre Salomè
abbracciava Giovanni.
“Questa è la mia umile dimora. Brindiamo, servitevi. Fate come foste a casa vostra.”
Abituato alle mie catapecchie e alla vita selvaggia in mezzo alla natura, fuori da quattro stupide
mura, non mi sentivo a mio agio in mezzo al lusso, lo trovavo inutile, per nulla accogliente.
“Come cazzo hai fatto a diventare schiavo del capitalismo" dissi. "Ci sei dentro fino al collo, baby!”
“Questa casa me non è di mia proprietà, ma dell’università.”
“E ovviamente non paghi un cazzo, giusto?” dissi.
“Esatto.”
“Però pigli un sacco di soldi” dissi.
“Beh, non direi, cioè… ho semplicemente una cattedra in ingegneria strutturale, tutto qua.”
“Sì, ho capito, pigli seimila dollari al mese per una decina di ore a settimana!” dissi.
“Più o meno” disse Zen con l’umiltà di chi è soddisfatto della vita che conduce.
“E tua moglie?” disse Salomè con fare interessato. “Quando si trasferisce?”
Zen tossì prima di parlare.
“Maria e io ci siamo lasciati.”
“Cosa?” disse lei allontanando per la prima volta il bicchiere dalle labbra.
“Dai Zen, chi cazzo vuoi pigliare per il culo?” gridai.
“Viene tra un mesetto coi bambini” ammise arrossendo il vecchio Zen.
Salomè buttò giù il suo drink rosa in un sorso.
Uscimmo sulla terrazza a rimirare l’oceano. Era estate, un’estate calda che profumava di primavera
e di vita, anche se da quelle parti non sentivo nessun odore che non fosse stato creato dall'uomo.
“Bevete ancora?”
“E ce lo domandi?”
“Hai del Dry Gin?” chiese Giovanni. “On the rocks, ovviamente!”
“E da quando il bel tenebroso Jo è dedito al bere?” dissi meravigliato. “Ti sei dato all’alcolismo,
damerino?”
“Cazzo dici, Luigi, chiudi quella fogna di merda!”
“Ohi ohi, il piccolo Jo ha imparato a mostrare gli attributi!” gli gridai mentre gli saltavo al collo col
braccio sinistro, e con l'altra mano gli soppesavo i coglioni.
“Dai, bisex di merda, lasciami stare!” diceva lui divertito.
“Ragazzini, buoni, arriva Zen con quattro bicchieroni ghiacciati!” disse Salomè andando incontro a
Zen. La vidi sussurrargli qualcosa all’orecchio. Lui sorrise e arrossì.
“Ecco a voi" disse avvicinando il vassoio.
"Brindiamo a Zeno" disse lei, "e agli States!”
“Brindiamo a qualcos’altro, io li odio questi fottutissimi assassini…”
“Luis” disse Salomè facendo la parte della mogliettina. “Non siamo qui per odiare. Siamo qui per
amare. Evviva la nostra rimpatriata!”
Brindammo facendo tintinnare il ghiaccio dentro ai bicchieri colmi di Dry Gin.
“Zeno” riprese Salomè, “che hai fatto tutti questi anni? Hai dedicato tutto il tempo alla famiglia,
fedele alla linea?”
“Fedele alla linea?” ripetei tra di me, quella stava tramando qualcosa. Decisi di lasciarla sola con
Zen. Ero curioso.
“Jo, vieni un attimo, devo parlarti in privato” dissi prendendolo con me.
“E di cosa mi dovresti parlare di così importante?”
“Tu vieni. Ragazzi, torniamo subito” dissi rivolgendomi a Salomè.
Scendemmo in spiaggia. Non era come la spiaggia in cui vivevo. Qui era tutto artificiale. Bello, per
carità, ma finto.
Ci levammo i sandali e ci sedemmo sul bagnasciuga.
“Senti, Giovanni, innanzitutto come va? Come stai veramente?”
Finse di non aver sentito. Rimasi in silenzio pure io.
“So cosa vuoi sapere" disse poi. "Vuoi sapere se penso ancora a lei.”
Finsi anch’io di non aver sentito.
“Sì, penso ancora a lei. La penso sempre. In fondo è stata la prima con la quale ho fatto l’amore”
disse.
“La seconda è stata mia madre” sussurrò poi ridendo tra sé e sé. “O forse no, non ricordo, ho
rimosso...”
Avevo sentito bene?
Riflettei rapido.
Senza trovare spiegazioni razionali.
Pensavo e ripensavo, senza capire.
Decisi di non pensare. E nemmeno di parlare. Ascoltai.
“Sarò sempre innamorato di lei. So che tu e Salomè andate a letto. So che te la spassi con lei e con
la tua compagna nello stesso letto. Non è un problema.” Fece una pausa. “Sono felice per te.”
Ancora non parlavo.
“Come sto veramente? Alti e bassi. A volte mi sembra di aver fatto la cosa giusta, di aver usato il
cervello, di aver scelto la mia strada, di essermi costruito la mia vita come volevo. Altre volte mi
sembra di averla sprecata. Abbiamo quarant’anni, insomma... abbiamo superato il giro di boa."
Fece una pausa.
"Se sono felice?" disse mentre si faceva scuro in volto. "Boh, non lo so, tu lo sei?”
Era il momento di parlare.
“Anch’io non lo so. Ho seguito il mio istinto. Ho ricominciato più volte da zero. Ho due ragazze
bellissime che mi amano, tra un po’ sarò padre…”
Ebbe un sussulto.
Poi capì che a essere rimasta incinta era Joana, non Salomè.
“Congratulazioni.”
“Grazie, eh sì, è successo… chissà se sarò all’altezza…”
“Ce la fanno tutti.”
“Speriamo…" dissi sorridendo.
Il sole si faceva rosso e grande sull'orizzonte.
"Ad ogni modo non mi sento pienamente soddisfatto, sto ancora cercando” dissi con lo sguardo
sullo onde diverse e sempre uguali.
“Cercando cosa?”
“Cercando e basta.”
Sapevo che mi capiva. Eravamo uguali io e lui. Sotto le nostre maschere la pensavamo alla stessa
maniera. Avevamo preso direzioni antitetiche, ma nel profondo entrambi cercavamo qualcosa che
non avevamo mai trovato.
Entrambi rimpiangevamo i tempi in cui, ancora bambini, si rideva e si piangeva tutto il giorno. La
gioia di scoprire le cose per la prima volta, un odore, un colore, un sapore mai sentito, una farfalla,
il naso in su a osservare le nuvole passare, l’abbaiare di un cane: noi che correvamo tra le gambe di
nostra madre quando avevamo paura del mondo.
Quei tempi erano passati, ora eravamo schiavi dell’apatia, della ciclicità, della noia. Io mi sfogavo
nello sport, nel sesso, in una vita dinamica, fatta d’incontri, di cene sociali, di letture entusiasmanti,
ma in fondo era routine anche quella. Avevo bisogno di qualcosa di nuovo, di una sfida, di mettermi
alla prova ancora una volta, di rischiare, di andare all’avventura: le stesse cose che pensava lui.
Solo che lui aveva paura di perdere quel poco che aveva. Era sempre stata una stupida paura a
bloccarlo. Paura che forse ora avevo anch’io. Non volevo perdere Salomè, Joana, il piccolo gesù in
arrivo e la vita che avevo costruito con le mie mani. Che senso aveva costruire e poi disfare? Che
senso aveva scappare?
Ero affetto anch’io dal morbo del possesso. Avere anziché essere. Ma dov’era la soluzione? Si
poteva vivere senza attaccamento? Senza affezionarsi alla propria casa, alla propria compagna, alle
proprie abitudini?
Forse solo Zen sapeva rispondermi. Avrei voluto interrogarlo, ma ero certo che in quel preciso
istante fosse a letto con Salomè, lei impazziva per i timidoni intellettualoidi come Zen. I mesi prima
di venire a Los Angeles, aveva ripreso ad andare a letto con chiunque ne avesse voglia. Non capivo
da dove le venisse tutta quella irrequietezza. Non capivo cosa la tormentasse.
“Senti, Jo, ma com’è che si conoscono così bene Zen e Salomè?”
“Non lo sai? Zeno è anche andato a trovarla a Madrid un paio di volte. Lui aveva iniziato a
collaborare con l’azienda ancor prima che Salomè si trasferisse in Hispagna, quindi, lo so, sembra
impossibile, ma si sono conosciuti proprio per via del lavoro. Le coincidenze della vita. Si sentivano
via mail praticamente ogni giorno.”
“Ah sì, e tu non eri geloso?”
“Di chi? Di Zeno? Sei matto? Zeno è la persona più fedele che io conosca! Sei sempre il solito,
Luigi. Vuoi metterti in testa che noi non siamo come te, tu sei un animale, noi abbiamo un cervello
e dei sentimenti. Sai?”
“Guarda che io Salomè non te l’ho mai portata via, se è questo che intendi.”
“Lo so, e ti ringrazio. Ma cosa dovrei pensare di te? Ti scopavi Teresa!" sbottò. "Ti scopavi mia
madre, pace all’anima sua, e allo stesso tempo ti eri innamorato della mia ragazza… come dovrei
considerarti?”
“Hai ragione” dissi, “ma non è colpa mia se tua madre aveva un fisico da trentenne e tu eri assieme
a una ragazza fantastica...”
Non sapevo cos'altro dire. Non avevo scuse.
Il sole tramontava di fronte a noi.
Fu allora che scorgemmo nelle acque una bottiglia di vetro verde scuro. Una bottiglia piuttosto
capiente, da circa due litri. Di quelle che usavano i miei nonni per il vino rosso. La vedemmo
avvicinarsi guidata da un preciso destino. Rotolò sulla battigia, finché un'onda più irruente delle
altre non la spinse fino a noi. Jo la prese per il collo e la osservò.
"Dai qui!" dissi strappandogliela di mano.
"Devi togliere il tappo, intelligentone" disse Jo.
In effetti la bottiglia aveva un tappo di sughero pregno d'acqua. All'interno non era vuota. C'era un
oggetto cilindrico.
"Hai un paio di chiavi?"
Jo me le porse. Con la chiave cercai invano di spingere il tappo dentro la bottiglia.
"Posso?" disse Giovanni sorridendo. Dovevo avere il volto viola per lo sforzo.
Prese la bottiglia per le estremità e la spaccò sul muretto.
"Il solito italiano di merda" dissi. "Ti ringrazieranno i bambini che li calpesteranno domani..."
Afferrai il cilindro tra i cocci prima che lo facesse Jo. Sfilai il foglio curioso di capire cosa
contenesse.
"No!" gridai. "È in italiano!"
"Veramente?" disse Jo. "Non prendermi in giro!"
"No, veramente, guarda!"
Glielo avvicinai per poi ritrarlo.
Incominciai a leggere.
"Leggi a voce alta, ti prego!" mi supplicò Jo.
Ecco cosa c'era scritto, parola per parola:
dissertazione sulle mille anime morenti
(da consegnarsi al narratore o, in assenza di un narratore, direttamente all'autore)
...alla fine di questo nostro romanzo, null'altro che una vita, ci rimane da spiegare ancora un'ultima
fondamentale finzione: l'illusione delle illusioni.
È noto, i tentativi di comprensione hanno bisogno e di aiuti e di teorie e di menzogne. Lo scrittore
quindi, quello vero almeno, dovrebbe ammettere, alla fine di ogni scritto, tali menzogne. Altrimenti
i casi sono due: o ha scritto un capolavoro, o è un incapace.
Infatti, se ogni romanzo è una finzione, anche i personaggi del romanzo devono esserlo: figuriamoci
ciò che essi rappresentano!
La tripartizione tra istinto, ragione e genio è una semplificazione davvero grossolana. È una
violazione del reale derivante dalle contraddizioni che il narratore, o forse addirittura l'autore, sa di
avere dentro sé. Nessun uomo infatti, tanto meno l'eremita tanto caro al narratore, è così semplice
da potere sperare di spiegarne la natura come una somma di tre elementi. Cercare, quindi, di
illustrare esaustivamente l'anima di un essere umano, perlopiù una mente colta quale quella, si
suppone, del narratore, suddividendola in tre parti, è impresa puerile e velleitaria. Ogni uomo, e così
ogni narratore, anche il più stupido, non consta di tre esseri, ma di cento, mille, infiniti. La sua vita
è un punto che oscilla in una sfera dagli innumerevoli poli.
Anche se la modernità tende a disgregare l'individuo, tutti gli uomini hanno un bisogno innato di
immaginare il proprio io come unità. Quando dunque un uomo arriva a sdoppiare la pretesa unità
dell'io, è già quasi da considerarsi un genio. Se la suddivide addirittura in tre, è una di quelle anime
rare che tendono all'immortalità.
Ecco dunque a chi è rivolta la nostra dissertazione: a colui che tende all'immortalità. Il narratore
pare appartenere a tale categoria. Nell'eventualità che tale dissertazione finisse nelle mani di un
lettore incapace di cogliere al suo interno almeno tre anime, è bene che, per evitare di farsi
scoppiare il cervello, interrompa la lettura e rifletta da sé.
Dicevamo, il corpo è sempre uno, le anime che vi albergano sono infinite: l'uomo è una cipolla da
sbucciare, una corda intrecciata con migliaia di fili, una notte con miliardi di stelle. Benché il
narratore sia dunque persona eletta, egli si comporta come un selvaggio che non sappia contare più
in là di tre: prima che si accinga a concludere il suo romanzo, è bene che rifletta attentamente un
istante sulla prossima frase: l'uomo è un tentativo, una transizione, un ponte tra la natura e lo spirito.
Egli ha paura, e non è il solo. Hanno tutti paura. In fondo all'anima, o meglio in fondo alle anime,
ognuno sa che, per aspirare a diventare uomo secondo lo spirito, deve percorrere la via
dell'immortalità, una via stretta, sconquassata, perigliosa, ma l'unica da intraprendere. Inoltre, come
pare abbia già compreso il nostro narratore, l'uomo non ha nulla da perdere.
Una cosa ancora non gli è chiara, egli crede di risolvere tutto tornando bambino. Vorrebbe ritornare
alla natura, all'innocenza, al principio. Ma ha evidentemente dimenticato che i fanciulli, non sono
per nulla beati, hanno anch'essi i loro conflitti, i loro dissidi, le loro sofferenze. Non è tornando
indietro che si avanza verso l'innocenza e la semplicità! Tutto ciò che è creato, anche le cose
apparentemente più semplici, sono già colpevoli, molteplici, buttate nel sudicio fiume Gange del
divenire. Non possono risalire la corrente, la via verso l'innocenza, verso l'annullamento, verso Dio,
non è un ritorno, ma un proseguire, un divenire nella colpa.
Nemmeno il suicidio è una scorciatoia, anzi, è la via più lunga, più difficile, più faticosa. Invece di
restringere il mondo, di semplificare tutto, dobbiamo accoglierlo, un pezzo per volta, fino a
contenere l'universo intero nel nostro spirito, dolorosamente ampliato per poter giungere un giorno
al riposo.
Tutto ciò può avvenire consciamente o inconsciamente, in una vita o dopo infinite vite: ogni nascita
è separazione dal tutto, distacco da Dio, nuovo doloroso abisso del divenire: fino all'annullamento
dell'io. Ecco perché un uomo, come il nostro narratore, che anche solo intuisce i cieli e gli abissi
dell'umanità, fatica a vivere in un mondo dove regnano il buon senso, la democrazia e la civiltà
borghese.
Se in un bosco grande quanto il mondo, c'è un solo Dio e questo Dio confonde il fungo velenoso
con quello commestibile e l'albero malato con quello sano, Egli, nonostante sia divino, morirà, e
con Lui il suo mondo. Così l'uomo, e di conseguenza il narratore, non può ignorare l'esistenza di
infinite anime (non solo tre, come egli ancora crede!), alcune buone altre cattive, alcune sane altre
malate: altrimenti rimarrà per sempre un uomo morto.
Adesso è tempo di prendere commiato dal nostro ingenuo narratore. Confidiamo in lui e lo lasciamo
narrare per la sua strada: se fosse quassù in alto, tra noi immortali (dove dovrebbe portarlo il suo
lungo e difficile cammino), osserverebbe se stesso sorridendo: a volte ammonendosi, a volte
incitandosi, ma pur sempre sorridendo di gusto.
Salvatore Narra
“Lo sai che vado a puttane?”
Jo sapeva sempre come sorprendermi.
“Cosa c'entra adesso?”
“Avevo voglia di dirlo a qualcuno” disse facendomi pena. “Le solite tre, da qualche anno a questa
parte. Cento euro a botta. Vengono loro da me, una alla volta, una settimana una, una settimana
l’altra, a rotazione…”
"Ma ti rendi conto? Abbiamo appena trovato un manoscritto in una bottiglia in mezzo al mare e tu
mi parli di puttane?"
"Senti, Lu, io non c'ho capito niente di quella roba. Narratore, autore, tripartizione, annullamento,
addirittura Dio: ma scherziamo!" disse scocciato. "Chiunque l'abbia scritto era un folle!"
"O un genio" dissi. "Non è che quando non capisci qualcosa, deve essere per forza una cagata!"
"Portiamola a Zeno, magari lui ce la può tradurre in parole potabili..."
"No, senti, forse hai ragione. Non era destinato a noi. Ributtiamolo a mare."
"Davvero?" disse Jo.
"In fondo a noi non serve. Magari può servire a qualcun altro. Per me sono cose trite e ritrite. La
teoria della molteplicità, delle mille sfaccettature dell'animo umano è vecchia quanto il mondo. Ne
parlava persino Hesse, figurati. E probabilmente anche lui l'aveva letto chissà dove. Ributtiamolo a
mare. Vedi quel cestino?"
Rilessi ancora il manoscritto mentre Jo era via. Quando tornò con una bottiglietta di plastica glielo
porsi.
Ancora oggi mi pento di quel gesto e spero tanto che almeno sia servito a qualcuno. Avrei voluto
tenere il manoscritto, rileggerlo, studiarlo con più attenzione, ma quel che è fatto è fatto.
“E insomma spendi quattrocento euro al mese in puttane, complimenti! Io ci vivo un anno con quei
soldi.”
Gli misi una mano sulla spalla e gli sorrisi. “Andiamo dai, gli altri due avranno finito di scopare,
no?”
“Ma smettila, Luigi, non capisci proprio un cazzo!”
“Sarà…” dissi lanciando la bottiglietta nell'oscurità delle acque.
Tornammo in casa. Il salotto era vuoto.
Aggiunsi il ghiaccio e versai dell’altro Dry Gin per entrambi.
“Che ti avevo detto?” sussurrai. “Saranno in camera a scopare, quanto ci scommetti?”
Jo aveva il viso teso.
“Ti dirò di più. Lei starà sopra con le mani sulle spalle di lui muovendo il culo in senso
antiorario…”
“Basta dire stronzate!” disse con una gocciolina di sudore che gli scendeva dalla fronte. “Non
dovevo essere io quello geloso?”
Mi avvicinai a una stanza, l’unica socchiusa. Origliai, stavano parlando. Sbirciai.
Cazzo, aveva ragione quel pirla di Jo, stavano seduti sul lettone e lui le mostrava un album di
fotografie.
“Ehi Luis, cazzo fate lì? Entrate!” disse lei con naturalezza. “Zeno mi sta mostrando le foto dei
piccini.”
Giovanni mi passò a fianco dandomi una pacca sulla nuca. “Sfigato.”
La sera mi ritrovai nuovamente solo con Jo a passeggiare alticcio lungo la spiaggia illuminata dai
lampioni.
"Senti, ma secondo te è proprio così bello rimanere fedeli tutta la vita alla stessa donna come fa
Zen? Fosse figa almeno..."
"Ma..."
"Maria è una qualunque, la ragazza della porta accanto, niente di più e niente di meno: una donna
con mille gravidanze alle spalle…"
Jo non diceva nulla. Forse anche lui non sapeva rispondere.
"Non ti sembra molto più sano donare il proprio seme a chi ci piace sul momento?" dissi cercando i
suoi occhi proiettati a terra. "L’animale uomo, così come gli altri, è fatto per procreare, non per
inibire il proprio istinto. Sei d'accordo, Jo?"
"Non lo so. Sono l'ultimo che può aiutarti vista mia esperienza."
"Zen sembra felice. Ovvio, non arriva ai picchi che può regalare una vita folle come la mia, ma
almeno lui non ha mai toccato il fondo. Boh..."
Jo non parlava.
"Eppure a eccezione del lupo e di qualche raro uccello, nessun animale sulla terra è monogamo:
perché la razza umana si ostina a volerlo essere? Non siamo animali noi?"
L'argomento non faceva presa su di lui. Lo vedevo triste. Sorrideva poco. Era sempre più bloccato.
Già ai tempi della laurea si sacrificava per lo studio, ma ora stava proprio male, non era più
sacrificio, era stupidità, poca intelligenza emotiva. Chissà che un attimo prima di spirare, proprio
lui, non potrà voltarsi indietro, e rimirare la propria vita di sofferenze e sacrifici, con orgoglio,
soddisfatto e in pace con se stesso, finalmente felice per aver sofferto tanto.
"A cosa stai pensando?" mi chiese destandomi dai pensieri.
"E se la felicità fosse conservativa, come un'energia in un sistema chiuso?
"In che senso?"
"O te la godi un po’ durante, come fa Zen, o ne usi moltissima in certi momenti e pochissima in
altri, come faccio io, oppure soffri perennemente come un cane per tutta l’esistenza e poi muori
beato, come spero riuscirai a fare tu!"
Mi accorsi che avevo esagerato e la buttai sul ridere.
"Dai che scherzo, non prendermi seriamente, lo sai che sono pazzo!"
Jo abbozzò un sorriso.
Sarà davvero così? La felicità è un’energia che si conserva? Che non può auto-alimentarsi? Che va
risparmiata e usata solo quando è strettamente necessario? Non lo so ora, non lo sapevo allora, e
certamente non lo saprò mai, perché mai c’è risposta a ciò che uno cerca: solo questo ho capito.
Finimmo la serata in spiaggia, ubriachi uno sopra l’altro: io con la chitarra in mano, Zen con un
colto clarinetto demodé, e Salomè e Giovanni, a pomiciare abbracciati come ai vecchi tempi.
Non ce ne fregava un cazzo dell’America, dei suoi pregi e dei suoi difetti, della società
consumistica, delle false religioni, delle sorti del genere umano: furono dieci giorni di pazzia, di
ubriacature, di stupidate da adolescenti, di nottate magiche e giornate spente: fu come doveva
essere.
Fu la prima e ultima volta che ci vedemmo insieme, tutti e quattro. Salomè infatti, ci avrebbe presto
lasciato: ma questa è una storia che non mi va di raccontare.
In quei giorni senza tempo cavalcammo la vita a pieni polmoni e chiudemmo un capitolo aperto
tanto tempo prima: era finita l’età del divenire: iniziava per noi l’età dell’invecchiare. Sapevamo di
poter contare l’uno sull’altro, per avvicinarci sereni alla fine, l’uno vicino all’altro: se non
fisicamente, almeno con il cuore.
Era la nostra misera rivincita, la rivincita dei quarantenni senza generazione.
X
"Perché è così cocciuta?"
"Dai calmati, Luis, tra un po' sarà tutto finito."
Rientrò e mi lasciò un'altra volta solo a osservare un cielo senza stelle.
Avevo la fronte madida di sudore e il cuore che batteva irregolare. Mi sentivo svenire.
Da dentro arrivavano soltanto grida su grida di dolore. E io non potevo fare niente se non ascoltare
quella tragedia che durava da ore, anche se non avrei saputo dire quante. Me ne ero rimasto lì, a
volte seduto sull'erba a volte in piedi, a rimirare il sole che se ne andava, cercando di non sentire
quello grida strazianti. A volte veniva Salomè ad aggiornarmi sulla situazione. Altre volte passava il
padre a chiedere se era maschio o femmina.
"Ancora non si sa."
Lui rideva e se ne tornava a passeggiare.
Io me la facevo sotto. Avrei voluto entrare ma Joana non voleva. Avevamo stabilito che sarei
entrato solo in caso di emergenza.
"Luis! Luis!"
"Che c'è?" risposi alzandomi e andandole incontro.
"Buon Natale!"
"Che stupida..."
"Dai, non arrabbiarti. Cerco di sdrammatizzare."
"Lo so, scusami. Sono troppo teso per sorridere" dissi rivolto al bianco dei suoi occhi enormi.
"Novità?"
"Ancora niente" disse baciandomi, "buon compleanno."
Rimanemmo in silenzio. Salomè era fradicia di sudore.
"Però è incredibile."
"Cosa?"
"Che tuo figlio nasca proprio il giorno del tuo compleanno."
"Se non si sbriga, nascerà il 26."
La vidi sorridere nella penombra. La sabbia bianca per lo spicchio di luna. Le grandi foglie di palma
a risplendere quel poco di luce che arrivava. Il rumore antico delle onde in lontananza.
"Senti, se qualcosa non va me lo devi dire, ok? Hai promesso."
"Tranquillo, non c'è niente che non va. A volte capita."
"È da mezzogiorno che grida senza sosta."
"Lo so, ma è così che nascono i bambini."
"Non in Italia!"
Lei sorrise.
"Perché non chiamiamo un medico, Sal? Ti prego."
"No, sai come la prenderebbe Joana."
"Sì, ma è per il suo bene. Sta rischiando di..."
Non volevo pronunciare quella parola.
"Luis, aspettiamo ancora un po', vedrai che non è niente. Joana è forte e sana, e metterà al mondo un
figlio altrettanto forte e sano."
L'abbracciai.
"O una figlia."
"Certo, o una figlia forte e sana" disse scappando di nuovo.
x
Joana ebbe Jesus
la gioia più grande.
Da piccolo avevo piantato un larice nel bosco di Vigolo
ora avevo un figlio
mancava solo un romanzo
uno stramaledetto romanzo.
Fanno un uomo
un figlio, un albero, un libro
fanno un uomo.
Scrissi molte poesie di questo tipo dopo aver tenuto in braccio Jesus quando non aveva che due
minuti di vita: viola, agitato, piagnucolante: eppure magico.
"Non piangere. Sii uomo" mi disse Joana. Era spossata, i capelli fradici, la faccia rossa e stanca.
Con la coda dell'occhio vidi le due ostetriche muoversi. Mi girai e le ringraziai.
"A domani, Joana"
"A domani. E grazie di tutto. Senza di voi non ce l'avrei mai fatta."
Sorrisero e uscirono. Vidi per un attimo Salomè che le salutava e tornava dentro la capanna.
"È il momento più bello della mia vita, Joana. Ti amo e amo questo piccolo germoglio."
"Germoglio?"
"Amo questo regalo che la terra ci ha dato" dissi guardando il viso violaceo e chiuso su se stesso del
piccolo Jesus.
"Regalo? Forse per te sarà un regalo, ma ti assicuro che io me lo sono sudato. Non ho mai sofferto
tanto in vita mia. Giuro. Non pensavo fosse così impegnativo."
"Sì, ma guarda, guarda cos'hai creato! Non c'è opera artistica più bella al mondo di questa creatura"
dissi avvicinandomi a Joana. "Guarda."
"Ora dallo a me. Voglio addormentarmi con lui."
Io mi girai verso Salomè, ma lei non c'era. Se n'era andata.
"Starò qui con voi due tutta la notte."
Joana taceva coccolandosi Jesus. "Va da lei. Non essere stupido. Io starò benissimo qui con lui."
Uscii e camminai al buio fino agli scogli dove si rifugiava sempre Joana. Però stavolta non c'era.
X
Scoprii presto che due donne e un figlio non bastavano.
Crebbe in me una passione che divenne ossessione.
Cominciai ad alzarmi presto al mattino e a inoltrarmi con la mountain-bike nella savana. Dopo una
ventina di chilometri lasciavo la bici nascosta dietro a un masso e mi intrufolavo nell’oscurità
selvaggia: una zona di circa un chilometro quadrato che io chiamavo la mia piccola Amazzonia –
anche se in realtà ero oltre i confini della regione amazzonica. Quando ero felice mi arrampicavo e
passavo di albero in albero: non usavo le liane, ma, come un funambolo, mi spostavo di ramo in
ramo. Quando ero non ero in equilibrio con me stesso camminavo: più mi sentivo triste, più cercavo
oscurità.
All’inizio non erano che brevi escursioni, dalle quali tornavo per pranzo o nel primo pomeriggio.
Col tempo prolungai i momenti di solitudine. A volte passavo la notte in mezzo alla natura pluviale.
Avevo paura. Temevo che qualche strano animale mi aggredisse, che un serpente mi strangolasse,
che un ragno mi avvelenasse, che un insetto mi infettasse. Eppure le nottate in solitaria sotto le
stelle tra le grida selvagge di una fauna invisibile, mi attraevano sempre più. Stavo entrando in un
tunnel dal quale non riuscivo a uscire.
Joana e Salomè mi assillavano di domande.
"Cosa c'è che non va?" mi diceva Salomè mentre facevamo l'amore. "Sei cambiato, Luis. C'è una
strana luce negli occhi."
Vivevo in libertà con due donne bellissime in un paradiso terrestre. Facevamo la vita che avevamo
sempre sognato. Joana coltivava l’orto, nuotava, ballava, cantava e cresceva Jesus forte e sano.
Salomè leggeva, prendeva il sole, si divertiva coi ragazzi del posto e coi viaggiatori di passaggio.
Io invece scappavo.
"Non c’è nulla che non va, Joana. Anche se potessi, non cambierei nulla della mia vita. Me la sono
costruita su misura, non l’ho ricevuta dalla nascita, come quelli del gregge. L’ho cercata e trovata
dopo aver vissuto esperienze che mi avevano fatto capire cos’era veramente importante."
"E cos'è importante per te, straniero?"
"Le piccole cose, le parole dette, quelle non dette, gli sguardi, i rapporti interpersonali, i sentimenti
sani, i tempi lenti e gli spazi mentali."
"Tutto qua?"
"Non sono molte le cose importanti nella vita: meno sono e più è facile essere felici."
Ma la mia vita, il mio destino e il mio io non si accontentavano di un’esistenza perfetta. Il mio
istinto mi portava a scappare dalle persone per rinchiudermi nella natura incontaminata. Non facevo
che camminare ininterrottamente.
Un mattino baciavo sulla fronte Salomè, Joana e mio figlio Jesus mentre dormivano e me ne andavo
per giorni, giorni che divennero settimane. Solo nella foresta.
Da quando sono arrivato in Brasile ho imparato a convivere con la natura e a cibarmi dei frutti che
lei ci dona.
Col tempo ho capito anche come difendermi dai pericoli della giungla: dormire a una certa altezza
elimina più del novanta per cento dei rischi. Per questo quando mi inoltravo in zone che non
conoscevo, cercavo di scendere a terra il meno possibile. Mi fingevo una scimmia, un gibbone
dell'Amazzonia. Sugli alberi dormivo, bevevo dalle foglie, mangiavo bacche e frutti.
Sentivo un richiamo ancestrale. L’odore del legno umido, delle piante ansimanti e della terra
fangosa mi attraevano, mi chiamavano da lontano: millenni antichi e antiche paure. Avevo un
legame invisibile con quei luoghi sconosciuti. Lo sentivo nelle viscere, in una memoria stampata nei
miei geni. Io, un animale selvaggio dentro a una flora ancorata a un antico passato.
Solo.
"Salomè, tu non capisci, la natura mi sta dando la possibilità di tornare a vivere."
"Non è vita quella che fai qui con me, Joana e Jesus?"
"Cerca di capirmi, ne ho bisogno. Sento che la natura mi sta allontanando da una vita artificiosa e
falsa per riportarmi dentro mondi più vividi, dove riscopro il vero carattere, la vera natura, l’istinto
primordiale di sopravvivenza."
"Luis, tu sei troppo fuori anche per me!"
"Non sto male qui con voi: ci sto fin troppo bene: è proprio questo il problema: quando hai tutto,
devi perderlo per riconquistarlo."
"Non c'è speranza di farti ragionare, fai ciò che vuoi."
"Aspetta, non ho finito, Sal. La mia teoria chi non ha niente da perdere è più felice purtroppo
funziona. Capisci?"
"No."
Era ora di mollare tutto un’altra volta.
Ora era più complicato. Non si trattava di lasciare un lavoro o una ragazza della quale non ero più
innamorato, se mai lo ero stato. Questa volta avrei dovuto lasciare un figlio e due donne che amavo.
Le amavo entrambe, a modo mio, e loro amavano me, a modo loro – anche se ancora non avevo
capito cosa fosse l’amore.
Amavo loro e il mio bambino più di ogni altra cosa al mondo, eccetto me stesso. Il mio egoismo
andava oltre. La mia voglia di scoprire i perché di questa vita, era più forte dell’amore per la vita
stessa. Dovevo sapere perché siamo al mondo e se la vita che avevo intrapreso era la migliore:
mancava ancora una risposta.
Partii il giorno del mio quarantacinquesimo compleanno, il giorno in cui Jesus compiva cinque anni,
il natale più caldo della mia vita. La vigilia avevamo fatto una festa. Il piccolo Jesus compiva
cinque anni. Era rimasto sveglio tutta la notte ballando con noi sotto il cielo stellato.
Incamminandomi scalzo portai con me, oltre agli abiti che indossavo, uno zaino da montagna con
dentro un'amaca e le corde per legarla ai rami degli alberi, un coltello e un machete, un sacco-letto
che usavo a mo' di zanzariera per tenermi lontano, per quanto possibile, da ragni e zanzare, e un
centinaio di cannucce filtranti per bere l'acqua, finite la quali avrei dovuto tornare.
Dopo anni passati quotidianamente nella foresta pluviale, contavo di sopravvivere col minimo
indispensabile, senza abusare della natura che mi ospitava.
Mi stavo staccando dalla società preconfezionata, per vivere una vita primordiale, senza maschere
fuorvianti.
Camminare scalzo mi rivitalizzava corpo e mente: un’infinita seduta di riflessologia plantare, un
massaggio continuo.
A volte pioveva. Raramente ricevevo la luce diretta del sole. La foresta mi proteggeva come una
mamma gigante. Camminavo senza sosta, prima per terra, poi, nella fitta giungla, sempre più su, tra
gli uccelli.
Da principio la mente si offuscò, appesantita da pensieri e paure ossessive.
Con l’andare del tempo tutto svanì.
Mi ritrovai a camminare sui rami degli alberi svuotato e leggero come non mai. Mi sembrava di
volare. Poche settimane ed ero tornato selvaggio. Un raccoglitore di epoche lontane. Vivevo per lo
più sugli alberi. Scendevo raramente. Mi lavavo nei punti in cui l'acqua dei fiumi tendeva a
ristagnare e mangiavo bacche e radici, frutti di ogni tipo e dimensione. Mi sembrava di vedere
sempre cose nuove. Nulla si ripeteva. Nulla era uguale a se stesso.
Nei mesi prima di partire avevo fatto delle ricerche in biblioteca. Le foreste pluviali sono
ricchissime in termini di specie diverse: nelle foreste brasiliane si trova ancora più biodiversità –
fauna e flora – che nelle corrispondenti foreste in Africa e in Asia. Si stima che nella regione vivano
circa tre milioni di specie di insetti, tre mila specie di pesci, milletrecento specie di uccelli (il venti
per cento degli uccelli di tutto il mondo vive nella foresta amazzonica – questo dato mi sembrò
poco credibile), millecinquecento specie tra mammiferi, anfibi e rettili. Per quanto riguarda la flora i
dati diventano ancor più insospettabili: sono state classificate quasi cinquantamila specie di piante,
la diversità di specie di piante più alta sulla terra. Quanto agli alberi – la mia pianta preferita – in un
chilometro quadrato si possono trovare quasi centomila diversi tipi di albero. Ecco perché non
potevo conoscere i nomi delle piante, dei frutti e degli animali che vedevo. Inutile tentare di
descrivere ciò che vivevo là dentro: a cosa non corrisponde parola, a parola non corrisponde cosa. Il
linguaggio da imparare era un altro – non quello inventato dall'uomo. Non parlai per mesi. Non
lessi e non scrissi. Eppure comunicai come non avevo mai fatto, con me e con la natura che mi
avvolgeva. Ero me stesso al cento per cento, senza costrizioni sociali, senza subire educazioni
esterne: ero tornato animale: non un animale ingabbiato dal genere umano, ma un animale selvaggio
che lottava giorno per giorno per la sopravvivenza. Non facevo altro che camminare di ramo in
ramo in cerca di cibo, abbandonandomi nell'amaca sul far della sera. Non pensavo più come un
essere umano, ma come un animale selvatico, seguendo l’istinto.
La vita nella foresta era linfa per il mio spirito inquieto e affamato. Solo laggiù, nelle viscere di una
terra incontaminata, raggiunsi una sensazione che assomigliava alla sazietà. Se un giorno
raccoglievo più bacche o frutti di quanti il mio corpo ne necessitasse per sopravvivere, li avvolgevo
con delle grandi foglie, scavavo un buco a terra e vi nascondevo gli avanzi, che a volte mi venivano
rubati da altri animali più furbi di me. Non ero più offuscato dal desiderio di divorare in maniera
compulsiva ciò ch’era in mio possesso. Sfamatomi a sufficienza, l'istinto placava il desiderio: avevo
fatto ritorno a un equilibrio fisico e spirituale.
Procedendo, avevo invertito la rotta. Avanzando, ero tornato indietro. Vivevo secondo le leggi della
natura.
Ero di nuovo senza pensieri, concentrato sul reale.
Soffrivo i crampi della fame, facevo sforzi disumani quando camminavo per giorni senza trovare
niente con cui sfamarmi, e non c’era pioggia torrenziale che potesse fermarmi. Pur nella sofferenza
fisica, nell’ossessione di trovare cibo, nella consapevolezza di poter morire all'istante, ero contento
di essere lì. Sopravvivere a quel modo dava soddisfazione: una gioia continua per il solo fatto di
esistere, di essere al mondo: niente pensieri inutili, niente fatica nervosa.
***
Ripensando a quei tre mesi nella giungla, ho scritto questa poesia.
Taccio.
Ripeto, mentalmente, all'infinito, cose che conosco solo io, parole che ho salvato dopo la
destrutturazione di un linguaggio divenuto falso.
Nel bosco: non parole umane mi parlano ma gocce di pioggia.
Si staccano dalle foglie, lassù, laggiù, lontane, vicine.
Ascolto. Piove. Piove: in mezzo a piante che non conosco.
Piccole. Enormi. Finito. Infinito.
Sono solo nel cuore della vita. Vera.
Folto e divino il tutto. Il mio andare e il mio restare. Piove, e le gocce di pioggia rimbalzano sulla
pelle dura. Mi guardo le mani, le braccia, i piedi, le gambe. Ascolto il mio corpo gridare.
Ieri non c'è. Domani non c'è. Solitario ascolto. E solo non sono. Adesso sono. Mi cibo d'ascolto e
verdura. Foresta. Il crepitio rado, il silenzio. La voce. Ascolto e rispondo. Grido il mio canto e
canto. Grido. Il suono è lo strumento del pianto. Diverso mi sento. Vero. Vetro divento nell'assenza.
Di vento. È pioggia chiara, che diventa acqua scura: lava e sporca. Sporca e lava. Io creatura
terrestre, senza un nome. Senza un numero. Ascolto l'accordo del mondo. Sordo. Eppure ascolto,
sento. Aria verde scuro rotola dentro. Cresco. Io umida ombra remota, trasparente. Tremo di verità.
Mi spengo. Risorgo. Vivo. Scroscio di cascata d'oro mi getto nel dentro. Ascolto. Figlio del dio
rana. Piove in me, realtà. Acque nere di piacere. Perdo la scorza, metto la scorza. Trovo vigore.
Torno rude.
Piove. Spero per sempre. Piove e io ripeto a memoria per sempre il mio mantra primordiale di
parole non-parole. Parole non vere. Parole.
***
Dopo quasi un centinaio di giorni passati a camminare sui rami, quando mi rimanevano soltanto
altre nove cannucce filtranti, vidi un essere umano senza età. Mi guardava in silenzio.
In quell'istante decisi che poteva bastare.
Scesi. Era serio e nudo. La pelle scura e le grida stridule. Si girò e si incamminò. Lo seguii. Si
voltava ogni tanto per guardarmi.
La tribù viveva sulla rive di un fiume d’acqua giallognola. Un affluente del Rio. Dormivano in
capanne. Alcuni portavano indumenti occidentali. Quando uno di loro, all'apparenza più giovane di
me, mi si avvicinò parlandomi in portoghese, capii ch’ero tornato alla civiltà. Mi portarono in una
grande capanna. C’era uno specchio. Per alcuni secondi non riuscii a vedere la mia immagine
riflessa. Quant’era passato? Lo sapevo bene, novantuno giorni. Ma realmente quant'era passato? In
quello specchio non vedevo un uomo, ma un animale primitivo. Ero nudo anch'io, i capelli e la
barba lunghi e sfatti: solo due occhi azzurri mi aiutarono a capire che quell’ominide ero io.
Rimasi per qualche giorno, finché mi accorsi che in un paio di capanne c’era la televisione: era
tempo di tornare da mio figlio.
Passò una barca diretta all’oceano. Fu un viaggio lungo e silenzioso che ora non ho voglia di
raccontare. Mi stavo staccando da un mondo perfetto. Sentivo il mio corpo ribellarsi. Il mio cuore
stava cercando di strappare le radici che ancora mi ancoravano alla foresta.
All'improvviso mi accorsi che della infinità di specie di alberi, ne era rimasta una sola: eravamo
circondati da mangrovie. Questo significava soltanto una cosa: il fiume stava finendo il suo corso.
Alla vista dell’orizzonte infinito dell'oceano, presi coscienza che ero tornato uomo: non ero più un
animale selvatico. Ero tornato civile.
M’incamminai verso sud, verso casa.
X
Quando bussai era mattina presto. Il sole non c'era ancora. Regnava un silenzio rotto solo dalle
onde.
Avevo quarantacinque anni. Erano passati tre mesi lunghissimi da quando ero partito, un caldo e
lontanissimo giorno di natale.
Entrai. Lasciai la porta aperta e intravidi Joana e Salomè dormire nello stesso letto. Tra di loro c’era
un gattino. Lo sollevai di peso, attento a non svegliare nessuno. Uscii in punta di piedi richiudendo
la porta. Camminai rapidamente verso la spiaggia col gattino tra le braccia. Avevo voglia di
parlargli del mio viaggio. Per ore, per giorni, per tutta la vita, se solo avesse avuto voglia di
ascoltarmi. Gli bagnai il viso con l’acqua gelida e salata dell’oceano. Si svegliò strofinandosi gli
occhi. Mi guardò a lungo cercando di mettere a fuoco.
“Gattino… gattino mio…” sussurrai.
“Papi” disse a bassa voce.
“Jesus, figlio mio!” gridai abbracciandolo. “Scusami, scusami tanto, figlio mio” dissi mentre le
lacrime mi inondavano le labbra. “Scusami per averti lasciato.”
“Papi, noi ti abbiamo aspettato, ti vogliamo bene, papi!”
Lo guardai negli occhi. Sorrideva beato. Correva di qua e di là per poi tornare ad abbracciarmi. Io
osservavo quel ragazzino dalla pelle scura, i capelli quasi corvini e gli occhi chiari cercando di
rendermi conto che era mio figlio, che l'avevo messo al mondo io, che non avevo altro che lui: Jesus
era la cosa più importante che avevo creato in vita mia.
“Papi, ho imparato a cavalcare le onde!”
“Che dolce” pensai mentre portava le braccia in avanti e piegava le gambe.
“Jesus! Ti amo, Jesus! Fatti abbracciare, piccolino!” gridai piangendo e ridendo allo stesso tempo.
Era la prima persona a cui ero riuscito a dire Ti amo. “Non correre, gattino!”
Lo presi e lo sollevai da dietro. Lo gettai in aria e lo ripresi. Lui rideva, e ridevo anch’io. Lo lasciai
andare e lo rincorsi. Lo sollevai ancora e lo lanciai. Lo ripresi tra le braccia e cominciai a correre
nell’acqua fino a tuffarci insieme tra le onde. Giocammo a rincorrerle. Era un nuotatore provetto
nonostante la giovanissima età.
“Guarda, papi! Ci sono le mamme che ci guardano!”
Girai il viso verso ovest. C’erano Joana e Salomè che ci guardavano immobili e silenziose. “Ah, sì,
ecco le mamme,” dissi senza gridare.
“Vieni, papi, andiamo ad abbracciarle!”
“Arrivo, vai avanti tu, gattino.”
Camminavo piano. Non sapevo come mi avrebbero accolto.
“Corri, papi! Sei lento come una tartaruga!” disse Jesus in braccio a Joana.
Mi avvicinai tremando. Il cuore mi batteva forte. Uscii dall’acqua con lo sguardo a terra. Vidi i loro
piedi e decisi di guardarle negli occhi.
X
Sorridevano.
Le due mamme sorridevano.
Mentre abbracciavo Salomè, Joana, tenendo sulle spalle il nostro gattino, si avvicinò e appoggiò la
faccia sulla mia schiena. Eravamo di nuovo una famiglia, decisa a rimanere unita.
Mi avevano perdonato. Forse non erano mai state arrabbiate. Ero scappato per più di due anni senza
dire niente. Avranno pensato che ero morto. Quando fai una cosa del genere, non puoi sapere se
tornerai. Parti e basta. E più il tuo viaggio avrà successo, più starai via. Erano stati lunghi mesi di
totale isolamento, mesi felici, dove mi ero sentito vivo.
Avrei dovuto abituarmi un’altra volta alla vita civilizzata, o quasi. Sarei tornato a essere un membro
della famiglia. Il capostipite di una famiglia anomala composta da un padre, un gattino di nome
Jesus e due mamme bellissime.
Ripresi a surfare. Avevo voglia di vedere gente. Tornai a procacciarmi nuovi clienti (non avevo
ancora trovato un sinonimo) in giro per le spiagge o alla stazione dei bus. In poco tempo riempii il
giardino di tende. Creai un campo da beach volley in spiaggia e uno da calcetto nel giardino davanti
casa. Volevo condividere la mia gioia con il prossimo. Due anni di totale isolamento dal genere
umano, avevano fatto crescere in me il desiderio di conoscere altre persone, di farmi raccontare le
loro esperienze di vita, i loro sogni, le loro ossessioni, le loro paure: avevo di nuovo voglia di
ascoltare.
Cominciavo a pensare che la soluzione era condividere, la parola chiave, l’antidolorifico magnifico,
il segreto del vivere. Condividere i momenti tristi aiutava a superarli e a dimenticarli. Condividere i
momenti felici ne aumentava la gioia e ne conservava il ricordo per i giorni a venire. Non ci poteva
essere felicità duratura senza condivisione. Cominciavo a comprendere perché l’essere umano, per
natura non monogamo, si ostina tanto a condividere l’intera vita, l’unica a sua disposizione, con la
stessa persona, come se, il fatto di sposarsi e far durare il matrimonio fino alla morte, fosse il
segreto di un’esistenza felice.
Avevo imparato a dialogare con la natura, un dialogo fatto di sensazioni e di silenzi più eloquenti di
mille chiacchiere inutili. Tornato nella semi-artificialità del mio paradiso terrestre, volevo riempirmi
le orecchie di storie. Volevo conoscere gente interessante. Avevo voglia di viaggiare rimanendo
fermo.
Basta solitudine. Basta eremitaggi. Volevo condividere tutto, le mie esperienze, i miei piaceri, la
mia casa, le mie donne. Diventai quello che molti definirebbero un hippy, un comunista, o qualcosa
del genere: non amavo le definizioni.
Capii che quella vita di condivisioni, di mutuo-soccorso, di confidenze, quel continuo stare assieme
agli altri, mi stava aiutando a vivere, a sorreggermi da una tristezza interiore senza fondo. La
caducità del mondo, la transitorietà che caratterizza il tutto, compresa la vita stessa, mi aveva
stroncato l’anima. Solo cogliendo i piaceri semplici, riuscivo per qualche momento a dimenticare
l’infinita tristezza che mi divorava.
Non avevo smesso di cercare: non mi ero ancora dato per vinto.
Gli anni passavano veloci. Io gioivo come possono gioire un padre e un marito doppiamente
fortunato. La mia vita divenne solida, ben piantata. Jesus cresceva, io gli dedicavo ogni mia energia.
Joana era l’anello che legava me, mio figlio e Salomè. Era lei a dividersi in moglie, madre e
migliore amica. Era lei a tenerci uniti, a sostenere il peso di una famiglia strana come la nostra.
Uno dei rari giorni senza sole, Salomè mi chiese di accompagnarla lungo la spiaggia, sotto la
pioggia scrosciante. Mi confidò un triste segreto. Un segreto che le stava condizionando la vita.
“Mi dispiace. È inutile che continui a volerne uno anche da me, è impossibile, sono sterile” mi disse
senza rivolgermi lo sguardo. “Sono la persona più sfortunata sulla faccia della terra!” gridò
scappando a piangere in qualche angolo di paradiso. L’istinto mi diceva di seguirla, ma le gambe mi
tremavano.
Provai un sentimento senza nome. Mi sentii minuscolo. Quanto ero stato stupido! Capii solo allora
che ogni mia continua battuta sul fatto che non rimanesse incinta, era stata una coltellata al cuore.
Nella nostra comune – non saprei come altro definirla – la gente andava e veniva, ci raccontava la
sua vita, si fermava qualche settimana e spariva. Questo per anni. Fu un periodo statico e felice,
caratterizzato da un continuo via vai di gente fuori dall’ordinario.
Mio figlio Jesus cresceva tra i libri che io e Salomè gli facevamo leggere. Romanzi in inglese, in
spagnolo, in portoghese e in italiano. Speravo tanto che un giorno avrebbe scritto lui il romanzo che
io non ero in grado di scrivere. Gli ripetevo che un uomo per realizzarsi doveva piantare un albero,
avere un figlio e scrivere un libro. Jesus era a un terzo dell’opera, a me mancava soltanto uno
stramaledetto romanzo.
Non lo iscrissi in nessuna scuola, gli insegnavo io quello che necessitava per vivere. Non sarebbe
diventato un ingegnere, tanto meno un chirurgo o un avvocato, ma di certo gli stavo insegnando
quel poco che avevo imparato d’importante per vivere. Non che io fossi felice o avessi trovato il
segreto per vivere meglio degli altri, ma ero certo di aver quantomeno capito come uscire dal
gregge, come non rimanere una stupida pecora schiava della società, di un pastore invisibile e senza
pietà. Jesus sarebbe diventato come Joana, un ragazzo sveglio, precoce, libero, felice di stare al
mondo. Avrebbe avuto anche lui i suoi drammi, i suoi precipizi, avrebbe commesso errori su errori,
ma è così che si impara a crescere: “Jesus, se non provi per paura di sbagliare, hai finito di vivere,
gattino mio!”
Io e Joana gli stavamo insegnando a vivere seguendo i dettami della natura: cresceva a banane e
surf. Di cos’altro aveva bisogno?
Se solo Giovanni fosse venuto qui a vedere con i suoi occhi quanto poteva essere bella la vita! Se
solo avesse smesso di pensare a metter via soldi o a spaventarsi per una fantomatica crisi economica
dei miei coglioni! Dirigeva un intero piano, il damerino, comandava la gentaglia del garage, il
nostro caro e ingenuo Giovanni: sai che soddisfazione!
Non poteva assentarsi per un intera settimana, soprattutto in quel periodo di ristrettezze
economiche: mavvaffanculo, Jo!
Furono anni felici quelli dopo il mio ritorno dall’Amazzonia.
Più che delle villette con giardino, casa nostra sembrava un free-camping con tre bungalow. La
gente veniva, si fermava, lasciava un’offerta, se ne andava, tornava: non potevo chiedere di meglio.
Adoravo condividere le giornate con chi la pensava come me.
A volte venivano a stare da noi famiglie con bambini e Jesus insegnava loro a surfare o li portava a
visitare i suoi nascondigli segreti nella foresta.
La maggior parte delle persone erano più giovani di me, io ormai andavo per i cinquanta. Lo so
suona strano, ma nonostante dentro fossi rimasto un mezzo adolescente, il mio fisico aveva fatto il
giro di boa, e lentamente s’avvizziva, si corrugava, s’indeboliva. Non avevo un filo di pancia e avrei
potuto terminare una maratona in meno di tre ore e mezza.
Quando arrivavano persone più anziane di me, gioivo. Avevo sempre guardato di cattivo occhio i
vecchi, ma ora che mi stavo avvicinando a loro, li osservavo con interesse. Ammiravo la pace, la
tranquillità, il loro benessere interiore: era come se, dopo una vita d’inquietudini e di eterno cercare,
avessero esaurito le energie, e vivessero senza guardare al futuro. Erano rivolti a rimpiangere il
passato, ma il futuro non li spaventava e riuscivano a godersi il presente.
Forse anche loro sapevano di aver fallito, capivano che oramai le loro ricerche di un significato
oltre il mero vivere, erano finite senza una risposta. Eppure non era un arrendersi, era più un “io
c’ho provato, di più non potevo fare: ora mi godo il meritato riposo!”
Osservavo i miei coetanei fumarsi una canna in giardino, e vedevo in loro un senso d’inquietudine.
Dai settanta in su, quando la schiena ormai era curva su se stessa, quando le gambe faticavano a
reggere il resto del corpo, quando le ossa dolevano e ogni movimento era fatica, allora notavo uno
sguardo diverso, così perfetto da nascondere un mistero. Rimanevo ore ad ascoltarli cercando di
carpire il segreto di quella pace spirituale che magicamente si sovrapponeva a una continua
sofferenza fisica.
Ma non era ascoltando le loro parole che si poteva capire qualcosa: li si doveva guardare negli occhi
rugosi, piccoli: veri.
"Se facciamo tutti quella fine" dicevo a Joana che consideravo molto più saggia di me, "che senso
ha sbattersi tanto a cercare un significato? Che senso ha camminare sull’orlo dei precipizi se poi a
un certo punto le energie si esauriscono e diventiamo tutti anime tranquille?"
"Io infatti penso solo a vivere."
"Infatti solo di una cosa sono sempre più convinto: più penso e meno capisco."
"E allora falla finita di pensare e inizia a vivere."
X
"Ci risiamo..."
"Che vi devo dire? Sono fatto così, nessuno è perfetto..."
Joana sorrise.
"Cosa vorresti fare?" disse Salomè. "Scappare ancora?"
"Non lo so" dissi nudo tra i loro corpi nudi. "So solo che qui non ci posso più stare, almeno per un
po'."
"Se ti senti di andare, vai" disse Joana.
"Questa vita privilegiata, da sogno, mi sta stufando. È ciò che avevo sempre immaginato, eppure
non mi soddisfa."
Salomè si alzò sulle braccia. Guardai i suoi seni senza desiderio.
"Sapete come la penso" dissi. "Gli anni passano e nulla cambia. Ogni anno ti ritrovi uguale all’anno
precedente e ti chiedi se questa è vita."
"Non ti capisco, Luis."
"In questi anni abbiamo vissuto bene insieme, abbiamo conosciuto gente fuori dall’ordinario, ma,
vedete, alla lunga anche la gente straordinaria diventa ordinaria."
Le guardai cercando consenso.
"Mi capite?"
"Più o meno" disse Joana.
"Anche quando lavoravo dieci ore al giorno in Italia mi ponevo la stessa domanda: è vita questa?
Trovo ora come allora tutto inutile. Ho due “ragazze” che mi amano e mi rispettano, ho i "soldi" per
campare con dignità senza dover obbedire a un capo se non alla mia volontà: sono "libero" di fare
ciò che voglio..."
"Eppure non sei soddisfatto" disse Salomè.
"Mi manca qualcosa. Non so cosa, altrimenti avrei già cercato di procurarmela. Forse a mancarmi è
proprio un senso da dare alle mie giornate. Mi guadagno da vivere senza alzare un dito. Ho tempo
per divagare coi pensieri all’infinito. Ho smesso da un pezzo di occuparmi di lavoro, carriera,
famiglia... non ce n'è bisogno, da quel punto di vista funziona tutto a meraviglia.
"Ho tempo per dedicarmi ai grandi sistemi, ai grandi temi esistenziali, ai profondi significati del
vivere. Ed è proprio questo il punto."
"Cioè?" chiese Salomè.
"Non ho ancora trovato nulla che mi convinca, nessun punto fisso, nessuna bussola a indicarmi la
verità. Non trovo un solo motivo per alzarmi ogni giorno e cominciare un’altra giornata.
"Non sono solo stufo" sospirai. "Sono deluso, insoddisfatto, vinto da una vita inutile e sempre più
buia."
"Non si direbbe..." disse Joana.
"Lo so, da fuori sembro un re. Ho un sacco di amici e nessun nemico, passo le giornate a scrivere e
cancellare, leggere e surfare sull’oceano. Il sole splende sempre sul mio viso sorridente...
"Eppure in me qualcosa si agita. Non riesco a godere di questa vita da sogno. Sento che il male di
vivere mi succhia via la vita lasciandomi indietro. Come se ci fosse un mistero che non riuscissi a
cogliere. Come se nella vita mi fossi dedicato sempre alle cose sbagliate, a fuggire significato
ultimo. Non riuscirò mai a cogliere il vero mistero del vivere rimanendomene sdraiato per il resto
dei miei giorni."
"Non sono d'accordo" disse Joana. "Ho amici che conoscono il mistero della vita e non si sono mai
mosse da casa."
"Hai ragione, ma per me è diverso. Io sento che devo camminare. È ora che vada. Ho bisogno di
stare di nuovo solo: un mese, sei mesi, un anno, cinque anni, una vita. Non lo so. La vita brasiliana
fatta di musica e gente che ride mi ha rotto."
Joana mi guardò con una faccia insolita.
"Vado finché ho le forze per farlo. Forse non tornerò. Però avrò sempre bei ricordi. Lascio quel che
ho costruito a voi due, le mie due femmine: le uniche vere donne della mia vita."
"Femmine?" disse Salomè.
"Donne" dissi sorridendo. "Ve la caverete anche senza questo ferrovecchio tra i piedi. Il mio
presente non è qui ora. Devo andare lontano per salvare una vita che si è arenata nel nulla, nel
nichilismo di pensieri senza capo né coda, nel male di vivere che non ha cura, se non la fuga."
"Questa frase te l'eri preparata, però!" disse Salomè bevendo un sorso di tequila come faceva
sempre prima di dormire.
"Lasciami finire, per una volta che mi sono preparato un discorso..."
"Finisci" disse tornando alla bottiglia.
"Ditemi se suona bene. Fuggo come ho sempre fatto. Scappo di fronte ai problemi come mi ha
sempre suggerito l'istinto. Raggiungerò alte montagne e silenzi che qui non trovo. Boschi di
solitudini devastanti. Cercherò il mistero del vivere camminando solo in mezzo ad atmosfere
rarefatte, nei meandri di un’interiorità che non ha fine. Mi calerò nel profondo, fin dove riuscirò
ad arrivare, e più in basso ancora. Mi spingerò sul tetto del mondo per scendere in fondo a me
stesso. Laggiù soltanto vedrò il mio vero volto, la verità assoluta, il senso di una vita che mi sfugge
oramai da troppo tempo."
"Che poeta!"
"Scherzavo, dai... stavo citando un passo del libro di Gianni Longhi, a forza di leggerlo l'ho
imparato a memoria."
"Ma chi è questo Gianni Longhi?" chiese Joana. "Un vostro amico?"
Io e Salomè scoppiammo a ridere.
Partirò all’alba. Non so ancora quando, sarà l'istinto a guidarmi.
A quarantotto anni non si intravede ancora la vecchiaia. È lontana anni-luce.
Metterò a letto mio figlio Jesus, il mio gattino ormai grande, e lo riempirò di baci.
Poi farò l’amore con Joana e Salomè nello stesso letto: sarà il mio addio al Brasile, terra che ho
amato e amerò per sempre.
X
Presi la mountain bike sulla quale avevo montato due portapacchi: su quello anteriore avevo
posizionato una sacca, su quello posteriore uno zaino. Volevo risalire la foresta amazzonica. Per
intero.
Uno potrebbe pensare a un'impresa senza eguali, a strade di fango, a notti all'addiaccio sotto una
luna invisibile.
Invece no. Pedalai lentamente, risalendo il grande Rio senza fretta su strade sterrate o d'asfalto,
ritrovando e perdendo me stesso un’infinità di volte, ma senza mai rischiare di ammazzarmi.
Tre mesi di dolci fatiche e sbucai sul Pacifico, a Trujillo, in Perù.
Lì m'imbarcai subito su un’enorme nave che mi avrebbe portato alle Hawai.
Surf, spiagge e sole: la mia inquietudine tornò a farsi viva in meno di una settimana. Mi rimisi in
viaggio verso ovest fino al sud-est asiatico.
Una volta in Thailandia del nord mi fermai. Tornai a Pai dov'ero stato nel mio viaggio attorno al
mondo di tanti anni prima.
Trascorsi qualche giorno in un villaggio di etnia Lahu, una tribù di montagna di rifugiati tibetani.
Per ricambiare l’ospitalità, li aiutai a trasportare il mais dai monti fino al paese, fissandomi sulla
fronte, anziché sulle spalle, gerle che potevano superare i quaranta chili. Loro m’insegnarono a
cucinare il kap khao: riso thai con verdure e curry cucinate nello wok: mi innamorai per la seconda
volta della cucina tibetano-tailandese. Stavolta però non caddi in quegli stessi vizi che mi avevano
rovinato diciotto anni prima.
Ripartii verso il Nepal riposato e pieno di speranza. Un mese di pedalate e ambasciate, e le
montagne dell’altopiano del Tibet mi riempirono l’orizzonte: prima deformandolo, poi
cancellandolo. Era lontano l'orizzonte piatto dell'oceano brasiliano.
I boschi e le rocce mi inghiottirono in pianure d’alta quota.
Regalai la bicicletta a un senza tetto sdentato che si protese in una serie di inchini che mi fecero
cadere una lacrima dall'occhio destro. Gli detti anche la sacca e lo zaino col ricambio di vestiti.
Comprai un piccolo zaino con il necessario e iniziai a camminare con un maglione pesante legato in
vita.
X
Erano trascorsi sei mesi dalla mia partenza.
Avevo perso molti chili, ma non l’ansia che mi avvinghiava il petto. Il tempo aveva perso di senso.
Non avevo chiamato nessuno durante tutto il viaggio.
Salomè avrà avvertito Jo e Zeno della mia partenza, e adesso si staranno chiedendo se sono ancora
vivo. O almeno spero.
Decisi di telefonare al vecchio Jo. In un sacchetto impermeabile rosso tenevo i documenti e la
rubrica delle persone che contavano.
“Pronto.”
“Ehi!”
Silenzio. “Come? Chi cerca? Può alzare la voce per cortesia?”
“Sono io, il vecchio Lu!”
“Luigi?” gridò. “Sei ancora vivo!”
Piangeva.
“Ti credevamo morto, brutto stronzo!”
Singhiozzava.
“Ehi, tutto bene?”
Ancora piangeva a dirotto.
“Luigi, dove cavolo sei finito? Eravamo tutti in pensiero!”
“Scusami” dissi sorridendo alla cornetta. “La verità è che non mi è proprio venuto in mente di
chiamarvi!”
“Ma vaffanculo, va’!” disse dandomi l’idea di soffiarsi il naso tra una frase e l’altra. “Cosa hai fatto
in tutto questo tempo?”
“È una lunga storia... Sono arrivato un’ora fa, a mezzogiorno, e ho pensato di telefonarti.”
“Mezzogiorno? Lo sai che ore sono qui?”
“Sono in Nepal!”
“E cosa cavolo ci fai in Nepal?”
“A dire il vero non lo so ancora… mi sembrava un bel posto dove andare… tutto qua.”
“Ma lo sai che hanno inventato gli aerei?”
“Odio deambulare in quel modo!”
“Però quando si trattava di andare in Brasile per lavoro con la mia donna non mi sembravi così
restio, eh?”
“Non rivanghiamo vecchie diatribe da quattro soldi…”
“Sai benissimo che lei mi ha lasciato a causa tua.”
“Senti, soldatino Giovanni, ti ho chiamato perché mi andava di sentirti, non per litigare. Lei ti ha
lasciato perché stava soffocando tra te e tua madre, aveva bisogno di respirare aria nuova” dissi
divertito e risentito allo stesso tempo. “Ti ho chiamato per dirti che me ne starò tra le montagne per
qualche tempo. Dillo pure agli altri. Non so quanto ci starò, forse anni. Ho bisogno di ritrovare me
stesso. Non avrete mie notizie per un bel pezzo, spero...”
“Avverto io agli altri” disse con uno strano tono, quasi distratto. “Senti, Luigi, ma lei come sta?”
Non sapevo che rispondere.
“Perché non la vai a trovare? Lei e Joana ti accoglieranno a braccia e gambe aperte!”
“Ci penserò…” disse senza ridere.
“Prenditi un po’ di ferie, stacca un attimo, sono certo che avrai mesi di ferie arretrate.”
“Sette mesi e tredici giorni” disse con vanto.
“Che aspetti?”
“Luigi, ora ti devo salutare, il lavoro mi chiama, tra poco inizio…”
“Non c’è problema” dissi pensando che non era per niente cambiato in tutti quegli anni. “Vai dove
il cuore ti dice di andare, al lavoro o in Brasile che sia…”
“Se hai problemi noi sono qui. Ti voglio bene, Luigi!”
“Segui il mio consiglio, non te ne pentirai! ¡Adiòs!”
Riappesi la cornetta sapendo che non sarebbe mai partito. Uscii all’aria aperta e respirai: un odore
acre di merda di gallina s’infilò nelle mie narici. Passò una motoretta a tre ruote. La seguii con lo
sguardo. Lasciò un fumo bianco e soffocante. Alzai gli occhi oltre la case della viuzzola sterrata e
intravidi le montagne che s’ergevano alte, altissime sopra l’orizzonte. Verdi di vita e bianche
all’estremità.
Mi aspettavano.
Faceva freddo lassù. Comprai una tenda e un sacco a pelo nell’unico negozio del paesino. Roba di
scarsa qualità. Qualche chilo in più sulla groppa. Meglio così, la fatica mi avrebbe fatto compagnia
in quell’avventura di cui non riuscivo a intravedere la fine.
x
Che ci facevo lì? Solo in mezzo a gente che non parlava la mia lingua. Gente? Incontravo non più di
una decina di persone al giorno. Incrociavo il loro sguardo e sorridevo. Porgevo un po’ d’acqua
ricevendo in cambio del riso o del pane. Non avevo un posto dove stare. Vagavo per le montagne,
né troppo in basso né troppo in alto. Capitava di dovermi fermare qualche ora in un paesino per
rifornirmi di viveri, ma poi passavo settimane senza vedere anima viva. Mi spostavo senza un
disegno, come in fondo avevo fatto nella vita. Spesso mi ritrovavo a terra con il viso cosparso di
lacrime. Rischiavo d’impazzire. Quando l’eremitaggio diventava ingestibile, mi abbassavo di quota
fino al primo villaggio che incontravo e mi ci fermavo per dei giorni, per tutto il tempo necessario a
ristabilire un equilibrio psico-fisico. Mi ospitavano in umili dimore. Alcune donne senza marito, o
giovani donzelle ancora da maritare mi invitavano a dormire con loro. Io davo ciò che da me si
aspettavano e nulla più. Era passato il tempo del desiderio. Ero concentrato sull'anima, sul cuore,
sulla mente devastata da una ricorrente inadeguatezza al vivere.
Solo un libro avevo portato con me. Lo rilessi fino a quando mi accorsi di conoscerlo a memoria.
In quel preciso istante credetti d’essere finito. Mi corse un brivido lungo la schiena. Cosa stavo
cercando? Un senso, un significato, una risposta, un segnale. Da quanto ero lì? Avevo perso il conto
delle stagioni, forse due anni, forse tre o quattro, non me ne ero mai curato. Non l’avevo mai chiesto
a nessuno di quelli che avevo incontrato. Il tempo aveva perso valore. Non importava se ero nel
passato o nel futuro. Dov’ero veramente? Quale matriosca interpretavo? Esisteva uno specchio
d'acqua nel quale vedermi? Non sapevo rispondere. Camminavo pensando a sopravvivere e
lentamente impazzivo. Non mi importava di vivere o di morire. Nulla aveva più senso. Avevo
vissuto una vita piena. Mi ero dato ad essa ed essa mi aveva restituito emozioni forti. Ciò che
importava era averci provato. Non come quello sfigato di Jo, sempre intento a lavorare, sempre in
preda al panico, sempre passivo come un pensionato in fin di vita! Ho dato quello che potevo dare:
mi lascio morire qui, in mezzo ai boschi: nessuno mi vedrà, nessuno lo saprà, mi penseranno in
qualche parte di universo a godere delle gioie della vita: addio vita, grazie di tutto: grazie di avermi
dato tutto tranne l’unica cosa che chiedevo: un perché.
X
“Certo che apprezzo il tuo invito!” dissi stringendogli il braccio per farmi sentire vicino. “Ma te
l’ho detto, per me non è ancora ora, e spero non lo sarà mai!”
Erano passati tre giorni dal suo arrivo in Nepal. Cominciavo a sentirmi in forma.
“Luigi, tu sei debilitato. Hai perso troppi chili, forse sei pure malato. Vieni per qualche mese a stare
da me, a Trento. Recuperarai le energie disteso sul divano di casa mia tutto il tempo che vorrai!” mi
disse mentre un ragazzino accanto al nostro tavolo masticava una cavalletta croccante.
“Non posso. Joana e Salomè mi stanno aspettando, e Jesus sarà un ometto ormai” dissi sorridendo a
fatica.
“Lo vedi che non sei neanche capace di sorridere, Luigi?”
“Rimani tu invece! Ci sposteremo al caldo, che ne so, a Varanasi o nel Rajasthan, o sulle spiagge
tailandesi, o a Bali! Ci godremo la vita per un po’, ti va?” dissi fissandolo negli occhi. “Poi mi
accompagni in Brasile, Salomè ti aspetta.”
“Luigi, tu non capisci! Entro due giorni devo riprendere il lavoro, come faranno ad andare avanti
senza di me?”
“Capisco che ho fatto bene a scappare dall'Italia! Non che la mia vita abbia più senso, ma almeno
sono libero di vagabondare come e dove voglio senza dover rendere conto a nessuno.”
“La chiami vita questa?" disse infuriato. "E Joana? E Salomè? Non ci pensi a loro?”
Non sapevo che rispondere. Odiavo essere ripreso, soprattutto da una pecora come Jo.
“Tra me, Joana e Salomè non c’è nessun tipo di contratto, ognuno è libero di fare ciò che vuole.”
“E Jesus? Non ti sembra squallido lasciarlo senza un padre? Non ti vergogni, Luigi?”
Le labbra mi tremarono. Iniziai a piangere.
Era sempre stato Jo a piangere di fronte a me, tra le mie braccia. Ora ero io il debole. Io versavo
lacrime amare e lui le asciugava con fare paterno.
“Andiamo” dissi passandomi un avambraccio sopra gli occhi bagnati. “Prenderò il primo volo
charter per le mie catapecchie. Mio figlio ha bisogno di me.”
Jo sorrise e non disse niente.
Passammo la serata a provare distillati di ogni tipo finché la stanchezza e l’ubriacatura non ebbero il
sopravvento. Jo mi riportò di peso alla guest house, ero troppo spossato per camminare.
x
Stavolta avevo intenzione di rimanere. Basta inquietudini, ansie, irrequietezze. Avrei cresciuto mio
figlio, questo era il mio unico scopo per la vecchiaia.
Mi vergognai alla vista di Joana. Mi sentivo tremendamente in colpa. Ero un padre e un marito, non
un puttaniere di passaggio.
“Ciao.”
Lei mi abbracciò e pianse. “Sei magro e malato: mangia e riposati.” Nonostante fosse brasiliana,
aveva il dono della sintesi.
“Mangerò, riposerò e starò con te e Jesus per il resto dei miei giorni.”
Joana mi guardò negli occhi. “Non voglio promesse che non puoi mantenere. Vivi il presente, e
fallo con gioia.”
Aveva quindici anni in meno, e un’infinita saggezza in più. Mi sentivo piccolo di fronte a lei.
Salomè non c’era, era a Rio.
Tornò soltanto un mese dopo e mi accolse con una gioia palesemente esagerata, fatta di pelle tirata,
di grinze e di paresi. Un alito di cachasa e sigarette. La trovai triste e invecchiata.
Cosa la tormentava? Quali segreti nascondeva? Quale demone le soffocava il petto?
X
Mi misi il cuore in pace e cercai di interpretare al meglio il ruolo di capofamiglia.
"Sei stanco, vero?"
"Stanotte non riuscivo a dormire."
"No, straniero, sai ciò che intendo. Da quando sei tornato non sei più lo stesso."
Sbuffai, ma sapevo che aveva ragione.
"Il Nepal ti ha mangiato."
"Mi ha rosicchiato l'anima."
"L'anima? A me pare che si sia portato via la tua energia. Sembri sempre stanco."
"Lo sono. Sarà anche che ho ormai cinquant'anni. Forse è normale."
"Sai che non è così. Due anni fa andavi sul surf anche tre ore di fila. Ora non riesci a starci più di
un'ora. Ti vedo sempre seduto a guardare Jesus."
Tirai un sospiro.
"Forse è meglio così. Ho sempre desiderato essere vecchio, senza più energia. Credo che mi aiuti a
rimanere fermo nello stesso posto."
Lei sorrise. Aveva un viso così dolce che non potei non baciarla.
"Adesso so che rimarrò qui con te per sempre."
"Straniero... non fare promesse che non puoi mantenere..."
"Ne sono certo, non ho neanche la forza di pedalare fino in centro!"
"Stupido! E io pensavo che lo dicessi perché mi vuoi bene!"
Ci baciammo ancora. A volte mi sembrava di amarla alla follia e di non poter vivere senza di lei.
"Lo sai che dobbiamo parlare di una cosa, vero?"
"Salomè."
"Sì."
"Cosa c'è da dire, straniero. Non sta bene. Peggiora di anno in anno."
"Di giorno in giorno ormai."
"Va bene, ma che possiamo farci?"
"Appunto, Joana, cosa possiamo fare per aiutarla?"
"Noi possiamo solo amarla e starle vicino, straniero. È lei che deve guardare in fondo a se stessa e
cercare di superare le sofferenze."
"Sì, ma quali sofferenze? È perché non può avere bambini?"
Joana mi guardò con la faccia di chi non sa se ridere o piangere.
"Ognuno ha i suoi segreti. Anche lei ha i suoi. È una battaglia personale. Noi possiamo solo
sostenerla, ma non combattere al posto suo."
"Sì, ma una battaglia contro chi?"
"Non importa contro chi è la battaglia. Importa solo come la si combatte."
Storsi la bocca di lato e caddi nei miei pensieri lasciando gli occhi guardare un mondo sfocato.
Joana fece per alzarsi. La presi per un braccio, senza vederla.
"Aspetta."
Lei si sedette.
"Secondo me possiamo aiutarla realmente. Nessuno merita di essere lasciato solo. Combatteremo al
suo fianco."
"No. Te l'ho già detto: certe battaglie sono puramente interne..."
"Interiori."
"Sì, interiori, e si combattono qui, in testa e qui, nel cuore."
"Forse dovremmo appoggiarci a uno psicologo..."
Joana mi guardò e scoppiò a ridere. "Lei non ha bisogno di uno psicologo. È già oltre. Ha
consapevolezza di ciò che la affligge, deve solo dimenticare."
Joana era il più grande mistero che avessi mai incontrato. Non leggeva, non aveva mai studiato, non
sapeva neanche scrivere, eppure capiva il mondo e la vita meglio di tutti noi.
"Ma forse è impossibile dimenticare" aggiunse.
X
Negli anni recuperai parte delle energie che avevo perso nei boschi del Nepal. Con delle lunghe
pause a metà strada, riuscivo ancora ad andare in bicicletta fino alla città. Facevo passeggiate nella
giungla con Jesus, a volte fermandoci a dormire in cima a qualche albero.
La gente non aveva mai smesso di venire a trovarci e lasciare un'offerta.
"Deve essere orgoglioso, non è da tutti" disse una ragazza carina coi capelli scuri e lunghi che stava
da noi da qualche giorno.
"Di cosa?"
"Di avere creato lei tutto questo" disse agitando i capelli nell'aria e mostrando un viso giovane,
magro e piacevolmente simmetrico. La guardai attentamente da cima a fondo accorgendomi che mi
piaceva un sacco. Mi ricordava Salomè quando stava ancora con Jo.
"Sì, lo sono. Dammi del tu, ti prego."
"Io se avessi un posto citato sulla Lonely-Planet sarei la persona più felice del mondo."
"Dai, non scherzare che poi ci credo."
"No, è vero. Guardi! Cioè... guarda!"
Mi passò la pesante guida aperta sulla pagina dei pernottamenti di P.
"Prezzi economici. Camping Prolet" lessi a voce alta. "Se ciò che cercate è un paradiso in mezzo
alla natura, lontano dal traffico cittadino, questo è il posto che fa per voi. Seguite i vecchi e
malandati cartelli, sparsi ovunque a nord del centro del tipo MALSANE CATAPECCHIE
“PROLET” GESTITE (ALLA CARLONA) DA ITALIANO SQUINTERNATO oppure OLD HIPPY
SLUM" WRITTEN AND DIRECTED BY LUIGI: THE CRAZY ITALIAN. Luigi sarà lieto di
accogliervi come soltanto lui sa fare."
Alzai lo sguardo verso la ragazza.
"Questo è fantastico. Incredibile. Oddio, mi sento male."
"Sono anni che giro il mondo con queste guide" disse lei eccitata, "ed è la prima volta che in un
posto non viene indicato il costo. Vede? Vedi? Non c'è!"
Poi mi guardò sorridendo e non resistetti.
Le detti un bacio sulle labbra e le proposi di fare una passeggiata nella giungla. La condussi dove
alle cascate dove avevo portato Joana la prima volta che eravamo usciti insieme.
"Sai che non mi ricordo il tuo nome?"
"Amelié."
"Bene, Amelié, sto per portarti in un posto che non c'è nemmeno sulla Lonely Planet."
"Wow..."
Sorrisi e la baciai di nuovo tastando con la mano sinistra la sua natica destra.
Ci incamminammo discorrendo di cose di poco conto: viaggi e linguaggi per lo più.
Arrivati alla cascata mi spogliai e mi buttai nell'acqua.
"Avanti, che aspetti?"
"Mi vergogno."
"Se vuoi mi giro."
"Meglio, grazie."
Mi girai, dando una sbirciatina.
"Eccomi" disse quando già era in acqua.
La baciai, assaporando con le mani quel corpo giovane e sano, che aveva quasi trentanni meno del
mio. Facemmo l'amore sotto la cascata e fu un'esperienza meravigliosa che mi fece pensare ai tempi
andati e ai primi anni brasiliani.
Poi uscimmo e rimanemmo nudi a osservare l'acqua.
"Sai una cosa, Luigi? Non ho ancora capito se sei sposato con Joana o con Salomè."
Feci una risata che rimbombò nell'aria con un'eco senza fine.
"In realtà non sono sposato."
"Ma hai una compagna, no?"
"È una storia molto semplice: io, Joana e Salomè viviamo insieme, giorno e notte intendo, da più di
vent'anni. Jesus, come avrai notato, è figlio mio e di Joana. E questo è tutto."
"E anche loro sono libero di andare con chi vogliono?"
"Certo, tra noi è sempre stato così."
Tacque per un po'.
"Ieri ho parlato con Salomè" disse all'improvviso.
"E?"
"E secondo me non sta bene."
"Be', sai, anche lei ha cinquantotto anni. Gli acciacchi si fanno sentire a una certa età..."
"Tu hai cinquantotto anni?"
Annuii.
"Cavolo. Non avevo mai fatto l'amore con un uomo così..."
"Vecchio?"
"Vecchio."
Non riuscii a ribattere.
"Cosa dicevi prima di Salomè?"
"Dicevo male. La vedo male. Sola."
"Sono anni che è così. A volte la vedi bere e ballare felice e il giorno dopo se ne cammina sola per
la spiaggia senza parlare con nessuno. Hai ragione, non sta bene. Ma sono battaglie che uno deve
superare dentro se stesso. Noi non possiamo fare niente."
"Dici?"
"In realtà ho un piano" dissi, "ma è segreto."
Z11 settembre
“Posso iniziare, ragazzi?” dissi accecato dal sole.
“Ragazzi a chi?” disse Luigi sghignazzando. “Vàra che son qua che moro, vècio!”
Non ho mai capito perché parlare in dialetto lo facesse divertire tanto.
“Sentiamo cos’ha prodotto stavolta la tua mente illuminata.”
Vidi Giovanni sorridere. Eravamo felici nonostante la malattia di Luigi: peggiorava di giorno in
giorno, ma riusciva ancora a scrivere e a camminare col bastone. Il romanzo ci stava tenendo
indaffarati. Ogni pomeriggio ci incontravamo per leggerne dei passi.
Avevo deciso di non scrivere niente che mi riguardasse. Mi dedicavo a descrivere i nostri incontri
quotidiani, oppure mi inventavo qualcosa di strano, come ad esempio mettermi nella testa di una
donna.
“Allora inizio.”
Tossii per avere la loro attenzione.
“Non mi manca niente dell’Italia. Amo la Spagna con tutto il mio cuore.”
“Ma scusa, Zen, non sarebbe stato più credibile se l’avessi scritto in spagnolo?”
“La smetti, Luigi? Allora metà delle cose che hai scritto tu dovrebbero essere in portoghese!” dissi
supplicando il suo silenzio.
“Amo la Spagna con tutto il mio cuore, così come odio mio padre con tutta me stessa.
“A Madrid la vita è rilassante. Mi alzo la mattina verso le nove, mi preparo ed esco. Abito in Calle
Juan Duque, al numero 43. Chiudo la porta, giro a destra e la percorro tutta. Attraverso il parco del
quartiere, mi dirigo verso est e mi faccio inondare dal sole del mattino. Mi lascio cullare dagli
antichi vicoletti cercando di scoprirne di nuovi: uno zig-zag che mi attiva la circolazione e i
pensieri. Passo dal Prado e mi dirigo verso il verde del parco. Mentre aspetto al semaforo assaporo
le chiacchiere della gente, ammiro i loro volti solari segnati dal solco della vita. Attraversiamo. Mi
incammino lungo la via in leggera salita che porta al grande parco della città. Sulla sinistra mi
fermo alle bancarelle dei libri usati. A volte compro un libro, spesso li sfoglio semplicemente e li
ripongo con cura. Mi perdo a fantasticare e quando alzo lo sguardo mi ritrovo dentro al Parque del
Retiro. Mi pervade un senso di benessere. Cammino nei prati, passo dopo passo, lentamente. Non
guardo l’orologio, ma so che c’è tempo prima d’iniziare a lavorare. Così mi fermo a rimirare il lago:
le paperelle annaspano mentre i piccoli seguono ordinatamente in fila un elegante cigno. In
lontananza alcuni ragazzi suonano le percussioni disposti in semicerchio sotto un enorme
monumento in stile greco. Mi riconoscono.
“A quel punto torno alla realtà: guardo l’orologio: ho ancora venti minuti. Faccio il giro del lago e li
raggiungo. ‘Ciao’ dico rivolta all’intero gruppo, ma cercando con lo sguardo Maguette. Quando lo
trovo, mi avvicino. Sta fumando. Gli altri ricominciano a suonare, lui mi viene incontro.
“Non c’è mai stato niente tra me e lui, a parte il sesso. È un ragazzo del Burkina Faso. Alto e
magro, con la pelle color cioccolato amaro. Ha i capelli lunghi raccolti in piccole trecce. Dopo la
prima volta che siamo andati a letto, l’ho sempre chiamato Baguette, per via del suo pene."
Senza alzare lo sguardo sentii Luigi ridacchiare.
“Ho passato infinite domeniche al Parque del Retiro seduta sulle scalinate in riva al lago, fumando
e ascoltando la musica dei negri. C’erano giorni in cui a percuotere gli jambè erano in cento. Io li
guardavo. Molti di loro mi piacevano, e Baguette era uno di questi. Quando si davano il cambio e
uscivano dalla bolgia, io e le mie amiche dell’università li seguivamo e ci presentavamo. Baguette
non è l’unico con cui sono andata a letto. Durante l’università sono stata con almeno dieci di loro,
tutti neri. Questa cosa a quel pirla di Giovanni non l’ho mai detta: chissà cosa avrebbe pensato..."
Sentii Luigi ridere ancora.
"L’ho raccontato invece a Luis. Ricordo che mi disse 'Hai fatto bene, non sei una puttana, hai solo
seguito il tuo istinto!' Io e Luis eravamo sulla stessa lunghezza d’onda. Se lo dicevo a Giovanni gli
veniva un infarto.”
Per un attimo alzai lo sguardo. Temevo che Giovanni se la fosse presa. Invece no, lui e Luigi mi
stavano ascoltando sorridenti.
“Li amavo entrambi, ma in forme differenti. Di Luis mi piaceva l’istintività e l’ottimismo. A
Giovanni invidiavo la perseveranza e la precisione. Che dire di Zeno? Lui sì che era un uomo come
si deve. Era il giusto equilibrio tra quei due pazzi scatenati: l’uno sempre in cerca di novità e l’altro
sempre a piangersi addosso. Zeno sembrava avere già trovato quello che cercava. Come se nulla
avesse importanza. Come se le cose gli andassero sempre per il verso giusto. E se qualcosa andava
storto, lui comunque sorrideva: gli bastava la verità illuminata che aveva dentro."
"Sì, vabbè, abbiamo capito, Zeno" disse Luigi. "Andiamo avanti, grazie."
Giovanni sorrise.
“La verità è che quello per cui avevo perso la testa, era Alex, un collega di lavoro. Quando mi
prendeva, non capivo più nulla, mi sembrava che la vita non avesse senso se non in quei momenti di
estasi estrema..."
"Zeno" intervenne Giovanni, "abbiamo capito che ti piace scherzare, ma ricordati che stai parlando
di una donna che non c'è più. Abbi un minimo di rispetto."
"Lo sai, Jo, che Zen è famoso per il suo umorismo nero..."
"Scusami, Giovanni" dissi, "ogni tanto piace anche a me improvvisare..."
Ripresi a leggere.
"Ma ora ho detto addio all’Italia e agli italiani. Vorrei tanto che Baguette s’innamorasse di me,
anche se io gli uomini non li amerò mai veramente... Da quando sono tornata a Madrid abbiamo
ricominciato ad andare a letto. E anche se Baguette dice che non va con le altre, so che mente. Certi
africani, l’ho imparato a mie spese, non possono vivere una vita monogama. È come chiedere a
Luigi di rimanere a lavorare sulla stessa scrivania per tutta la vita. Sarebbe una tortura. Così io
lascio libero Baguette di venire da me quando vuole. Dare le chiavi di casa a uno spacciatore non è
forse il massimo della saggezza, ma in lui vedo una forza saggia e innata che lo guida al bene. Che
belle le feste con lui e i suoi amici! Girano canne, si suona per ore e si balla avvolti dal fumo. Me la
spasso un mondo. Quando invece mi invitano a uscire i vecchi amici dell’università o i colleghi di
lavoro, la serata trascorre tranquilla e alle due ho già voglia di rincasare, sperando di trovare tra le
mie lenzuola Baguette o, al limite, qualche suo amico.
“Saluto Baguette, lo bacio, do un ultimo tiro di canna e scappo. Sono le dieci e un quarto. Sono in
ritardo, come al solito. Timbro il cartellino e saluto i colleghi. ‘Qualcuno beve un caffè?’ José si
alza. È giovane e prestante. Ha venticinque anni ed è fresco di laurea. Ci sono uscita assieme un
paio di volte, abbiamo finito col far l’amore nei bagni di una discoteca. È un animale da letto, ma
niente più di un foruncolo sul culo di Baguette e soci.
“La sede spagnola dell’azienda, a differenza di quella italiana, ha orari flessibili. Un quarto livello
può entrare tra le nove e le dieci e uscire tre le cinque e le sei. Non è prevista la pausa pranzo, ma
ogni ora si ha diritto a dieci minuti di descanso. Aiuta a socializzare. In genere passo le sette pause
quotidiane mangiando una banana o un mandarancio e raccontando ai colleghi come ho trascorso la
nottata. Il ritmo spagnolo non ha nulla a che vedere con quello italiano. In Spagna se ci sono tre
feste di fila, si fanno tre nottate di bagordi. Si tiene duro e ci si riposa il quarto giorno. Gli italiani
invece devono dormire le loro stramaledette otto ore a notte, altrimenti il giorno dopo non fanno
altro che lamentarsi, arte in cui eccellono. È una differenza importante: distingue la gente che
rinuncia a vivere dalla gente che ama vivere, che sa soffrire pur di vivere. Giovanni non l’ha mai
capito. Con lui si doveva andare a letto alle dieci, sempre insieme, e sempre senza fare l’amore!”
Li guardai.
Giovanni scosse la testa. “Hai dipinto la Spagna come la terra del divertimento e l’Italia come un
paese di vecchi e per vecchi.”
“Ho mentito?” dissi entusiasta. “Io non sono tipo da feste, sapete bene che preferisco un libro a una
ubriacatura. Ma avendo lavorato a destra e a manca mi sono accorto che queste differenze esistono,
non sono facili stereotipi.”
“Zen ha ragione. In Brasile la cosa era ancora più estrema. Potevi passare l’intero week-end senza
dormire, ma se il lunedì dovevi alzarti alle sei per lavorare, ti alzavi, e felice come non mai!”
Luigi si fermò qualche istante per tossire.
“L’italiano medio, soprattutto l’italiano del nord, è intimorito dal senso di colpa. È sempre la stessa
storia: ‘Oddio!, mi sto divertendo, oddio!, domani devo alzarmi alle sette, oddio!, passerò la
giornata con il mal di testa.’ Capisci, Jo? Ti pare che uno spagnolo possa anche solo per un istante
pensare non mi sono mai divertito tanto, però ora basta, domani devo alzarmi presto, meglio se
vado a dormire...”
“Hai scritto altro, Zeno?” disse Giovanni poco convinto.
“Purtroppo no, ma se l’idea vi è piaciuta potrei proseguire.”
“Perché no?” disse Luigi. “Visto che di te non vuoi parlare, vada per Salomè!" Si piegò per sputare
del catarro violaceo.
Poi si alzò e Giovanni lo aiutò a sedere sulla sedia a rotelle. Li guardai dirigersi verso casa, dove
Klaudia li attendeva per la cena. L'antiquato soprabito nero che Giovanni portava sulle spalle a mo'
di scialle, mi fece pensare alla morte che veniva a prendersi il nostro amico sofferente. Scacciai quei
pensieri con una risata silenziosa.
Il sole all’imbrunire metteva fine a un’altra piacevole giornata, una delle ultime purtroppo.
X
A Joana e Luis,
cari miei,
non è colpa vostra, se questo è il vostro pensiero. E non è neanche colpa mia.
Non è colpa di nessuno. Non c’è colpa, in queste cose...
...invece stavolta una colpa c'è.
Ma preferisco tenere per me la triste verità.
Vi chiedo scusa per il vuoto che lascio, vi chiedo scusa per il gesto poco elegante, vi chiedo scusa
se non ho più voglia di lottare.
Vi lascio.
Ho provato in tutti i modi a inseguire la felicità: non era destino.
Questa vita non fa più per me, queste palme, queste onde, questo cielo... è tutto così uguale. Non
accade mai nulla di speciale. Anche passare di letto in letto, di uomo in uomo, non è più come una
volta. Mi appare tutto così scontato, così inutile, così falso. Non fraintendetemi. Qui con voi ho
vissuto la verità più grande che mi sia mai capitata. Vi ringrazio di avermi ospitato come una
sorella. Non sentitevi in colpa, siete stati la mia ancora di salvezza per lungo tempo.
Salutatemi tanto Giovanni: chiedo scusa per il dolore che ho causato.
Date un bacio a Jesus, ditegli che la zia Sal è partita per un paese lontano, dove il sole non sorge e
non tramonta, dove non c’è sofferenza, non c’è ansia. Dite a Jesus che gli voglio tanto bene e che
forse un giorno ci rivedremo.
Non ditegli che la vita non ha senso, non ditegli che non serve a nulla lottare. Dategli un Dio da
pregare, un Dio buono, un Dio ragionevole, un Dio piccolo che lo ami, un Dio facile da amare.
Ditegli di pregare anche per una miscredente come me. Ditegli di non diventare un timorato di Dio,
ché la paura non serve, è solo un blocco che ti impedisce di godere. Ditegli di cercare senza mai
trovare, ditegli di non smettere mai di camminare, ditegli che non esistono bussole, né strade facili
né difficili, e forse nemmeno giuste o sbagliate.
Ditegli di non rinunciare a vivere.
Salomè de la Cruz, anni 58,
ex-straniera sulla terra,
ora abitante del cielo
Lessi e rilessi quella lettera a voce alta assieme a Joana.
“Che c’è? Perché piangi? Hai sempre detto che un vero uomo non piange mai” disse sorridendo.
“Mi sbagliavo, cara” dissi in lacrime, “mi sbagliavo. Tu sei più forte di me.”
Chiamai Jesus. Lo presi sulle ginocchia, nonostante pesasse più di me, e lo abbracciai forte.
“Lasciami!” disse. “Lasciami, papi, mi fai male!”
Si aggiunse anche Joana. Teneva in mano un’altra lettera, senza stringerla. Era serena. Non le chiesi
mai di farmela leggere. Salomè le aveva lasciato un messaggio personale.
Strinsi entrambi con foga. A lungo, finché Jesus non si divincolò e corse verso la spiaggia a giocare
con altri ragazzi con il sole che arrossiva teneramente.
Io e Joana ci guardammo senza dire una parola. Crollò anche lei. Mi strinse forte.
Alle ultime luci del giorno la lasciai. Sapevo dove andare. Non volevo che mi seguisse.
“Dillo tu a Jesus, io non ce la faccio.”
Camminai lento. Piangendo, nonostante non uscissero più lacrime dai miei occhi iniettati di sangue.
Credetemi sulla parola. La vidi là, nel punto immobile in cui sapevo di trovarla. La mia torcia le
illuminava il collo, un collo spezzato dal male di vivere. Il colorito bluastro nella notte. La toccai
fredda come roccia, l’abbracciai solo, sorreggendole il viso, baciandola per l’ultima volta. Sentivo
la sua anima dialogare con la mia. Le stava chiedendo di seguirla nell’aldilà. Erano anime gemelle
le nostre: anime straniere alla terra, anime sconfitte, anime inutili. Sole.
4
Y
Lo abbracciai forte. Mi aveva chiamato soltanto due giorni prima. Ora ero lì tra le sue braccia esili.
Nonostante l’infausto evento, riusciva a sorridere.
“Ciao, maschione!” mi disse pizzicandomi la guancia e abbracciandomi.
“Come stai?”
“Non parliamo di cose tristi, Jo! Fatto buon viaggio?”
“Certo. Ieri ho sentito Zeno, ma diceva…”
“L’ho sentito anch’io, aveva una conferenza, o qualcosa del genere" dissi gioioso. "Allora? Ti piace
il Brasile?”
“Lasciami il tempo di guardarlo!”
“Lo sai che tra due giorni inizia il carnevale?”
“L’ho notato..."
“Dai, vieni. Metti qua.”
“Stai scherzando?”
“È il mio nuovo risciò!” disse tutto contento guardandomi con gli stessi occhi azzurro latte di
sempre. “Tieni, questa è tua. Passami la valigia.”
Presi la bici e montai che lui già pedalava fischiettando.
“Che c’è? Non ne hai mai visto uno? Ho copiato l’idea agli asiatici. Passo le mattinate a dare
passaggi. Gli sfigati li lascio ai taxi! Io tiro su soltanto gente zaino in spalla, prolet e compagnia
bella, se capisci ciò che intendo…”
“La smetterai mai di giudicare la gente per come si veste?”
Faceva un caldo che non avevo mai sentito. Il sole mi stava spaccando la testa nonostante avessi il
berretto che mi aveva regalato Maria a Brighton, una ventina d’anni prima. Ero inzuppato di sudore.
“Senti, Luigi, tu sarai anche allenato e abituato a queste latitudini, ma io mi sto sciogliendo, manca
tanto?” dissi sfinito. “Dopo il Nepal non pensavo saresti riuscito a recuperare tutte queste energie!”
Luigi smise di pedalare e mi guardò sorpreso.
“Mancano una trentina di chilometri, ma è pianura, in un’ora e mezza siamo là!” disse senza il
minimo affanno. “Comunque dopo Kathmandu non ho più raggiunto la forma fisica di una volta.”
“Grazie al cavolo!”
“Ce la fai a pedalare un’oretta?”
Frenai e smontai.
Mi portò in un posto di cui non sospettavo nemmeno l’esistenza su questa terra. Ero abituato alle
spiagge della costa adriatica occidentale, Caorle, Jesolo, Rimini.
“Perché non sei mai venuto a trovarmi? Mi spiace dirlo ma a volte un gesto come quello di…”
“Non nominarla per favore…”
“A volte credo che in un certo senso… insomma... credo che l’abbia fatto anche per te…”
“Ma non dire stronzate, Luigi, per favore!”
“Da ieri ho questo pensiero fisso. Credo che lei si sentisse in colpa. Mi parlava spesso di te, della
vostra vita, di come ti ha lasciato solo come un cane…”
“Cosa c’entra con la sua...”
“Credo che abbia pensato che, se doveva morire, era meglio farlo una settimana prima del
carnevale, in modo che tu…”
"Smettila, Luigi!"
Silenzio.
"Le ho vissuto a fianco per anni, quindi se ho in testa un pensiero e mi va di dirlo, non vedo perché
tacere. Secondo me voleva morire ormai da tempo, sapeva che tu saresti venuto qui per il suo
funerale e ha pensato di chiederti scusa, a suo modo, facendo quello che ha fatto prima del
carnevale.”
“Secondo me l’ha fatto prima del carnevale perché non poteva sopportare l'idea di vedere tutto il
mondo felice e lei morta dentro.”
“Dici?”
Quanto era ingenuo Luigi a volte. Non capiva le cose più elementari.
“Beviamoci due birre ghiacciate."
Arrivammo al tramonto.
“Ecco il mio paradiso! Che te ne pare?”
“Niente male” dissi poco convinto. “Portami in spiaggia, dai!”
Rimanemmo seduti a rimirare le onde che continuavano ad alzarsi per poi infrangersi e scomparire,
un ciclo sempre uguale e sempre diverso: inutile, come tutto il resto.
Da lontano vidi arrivare un ragazzino di corsa seguito da una silhouette femminile in lontananza.
“Ciao, papi! Eravamo preoccupati! Perché ci avete messo tanto?”
“Domandalo a questo tartarugone.”
“Sei tu il famoso Jo?”
Gli strinsi la mano. “Sì, sono io, Giovanni, il tartarugone” risposi in inglese.
Aveva fattezze da adulto, ma il tipico comportamento scherzoso dei bambini.
“Luigi, hai tirato su un figlio poliglotta, speriamo che non segua anche le tue orme poligame!” dissi
ridendo e rattristandomi pensando a Salomè.
“Papi, cosa vuol dire poligame!”
“Dimmelo tu, gattino.”
“Poli etimologicamente significa tanti, ma game? Sembra tipo gameti, giusto?”
“Forse è ancora troppo presto per spiegartelo!”
Nonostante una vita di esosi corsi d’aggiornamento, Luigi parlava l’inglese meglio di me.
“Jesus, devi sapere che quando facevamo l’università, era tuo padre ad avere la pancia! Era lui il
tartarugone quando andavamo a correre!”
“Troppa birra!” disse buttando le braccia indietro. “A proposito… perché non corri a prepararci una
caraffa di Caipi?”
Jesus corse via senza dire nulla. Fu allora che vidi per la prima volta sua madre.
Non scordai mai quel viso, la pelle nocciola, i capelli liberi di volare, il suo sorriso.
“Io sono Giovanni” dissi alzandomi.
“Joana” disse con una voce calda.
Le strinsi la mano.
Negli occhi aveva la luce di chi sa amare, di chi ha sofferto e ha saputo rialzarsi, di chi ha raggiunto
un equilibrio. Mi sentivo piccolo di fronte a quell’angelo.
“Joana non parla inglese né italiano, ma sono certo vi capirete ugualmente.”
Lei sorrise, e in quel sorriso vidi tutto ciò che un uomo poteva volere dalla vita. In quelle labbra vidi
la lentezza, la pace: la voglia di vivere una vita semplice e vera.
Mentre camminava davanti a noi in un costume succinto, inesistente, la osservavo in tutta la sua
bellezza: era una ragazza, una mamma, una moglie: tutto ciò che non avevo mai trovato.
Cenammo felici attorno a un falò, inondando le verdure del loro orto nel pinzimonio. Bevemmo litri
di latte di cocco e succo di mango, terminando la cena con decine di frutti esotici dai colori e le
forme insolite.
Continuai a mangiare e a parlare tutta la sera. Sembrava fossero perennemente in vacanza.
“Ho chiesto ai nostri ospiti di lasciarci soli questa notte. Volevo che conoscessi la mia famiglia in
pace, senza distrazioni.”
“Un bel pensiero. Sono davvero contento, nonostante tutto.”
Rimanemmo in silenzio per un attimo a rimirare il cielo stellato.
“Io vado a leggere un po’. Buona notte, tartarugone!”
“Notte, Jesus” dissi osservandolo. “Cosa leggi?”
“Amado. Me l’aveva prestato zia Sal.”
“Ah. Peccato, non lo conosco. Be', buona notte.”
“Buona notte a tutti!” disse andando a baciare la madre.
Il silenzio ci sorprese ancora. Un vento leggero mi soffiava tra i capelli. Provavo una sensazione che
mi portò alla mente i primi viaggi, quando si partiva con gli amici e non importava dove si andasse,
era sempre e comunque il posto migliore dove andare, anche a pochi chilometri da casa. Peccato
provare solo ora, a cinquant’anni suonati, certe emozioni, le uniche a ricordarti che vale la pena
vivere. Quanto tempo sprecato su una scrivania, o su inutili libri d’ingegneria e di economia, o
peggio ancora davanti a uno stupido televisore.
Aveva ragione Luigi: bisognava mollare tutto e ricominciare lontano dalla nostra società malata.
Ero troppo vecchio, non ce l’avrei mai fatta a vivere senza cappuccino, senza giornale al mattino,
senza scrivania, senza chattare tutte le sere, senza garage: avevo finito con l’amare ciò che odiavo.
Avevo la sindrome di Stoccolma: non era amore, ma attaccamento, abitudine, forma mentis.
“Luigi, ho appena capito una cosa che mi cambierà la vita!”
“Come?” disse mezzo addormentato.
“Ho appena preso una decisione importante.”
“Scommetto che ti licenzi e te ne vieni ad abitare qui!” disse sicuro di sbagliare.
“Mi trasferisco.”
“Davvero?”
"Sì, ma non qui: a Vigolo!”
“Davvero?” disse sfregandosi la barba. “È un’ottima idea.”
“Chissà perché non ci ho mai pensato prima…”
Mi alzai in piedi.
"Non sono mai stato così vivo! Non vorrei dover dormire mai più!”
“E chi ti dice che devi dormire?” disse Luigi come risvegliandosi da un lungo torpore. “Arrivo
subito!”
Entrò in casa mentre Joana mi guardava sorridendomi.
“E le tue sorelle?”
“Salvador!”
“Salvador do Bahia?”
Lei fece segno di sì con la testa.
“Lavoro?” dissi. “Business?”
“Università. Studiare.”
“Davvero?” dissi incredulo.
“Luis enseñò ellas. Agora volven para carnaval.”
Luigi tornò con fare agitato.
“Beviamoci un po’ di guaranà. C’è una festa qui vicino!”
Joana rideva.
“Sono le tre del mattino…” dissi. La festa mi mise in ansia.
“E tu, Joana, vieni?” dissi.
Fece il gesto di dormire.
“Su, forza, bevi che andiamo!” Luigi mi metteva fretta per non lasciarmi il tempo di inventare una
scusa.
“Arrivo, aspetta!” gli gridai quando era già in sella alla mountain-bike.
***
Mi alzai con il mal di testa.
Avrei dovuto fare come aveva fatto Luigi e scolarmi un litro d’acqua prima di andare a dormire.
Avevo passato una delle nottate più lunghe e più belle della mia vita. Mi ricordavo di aver fatto
l’amore con una ragazza giovane dalla pelle scura. Il resto, vuoto totale.
Luigi mi trascinò in una grotta nella foresta. Facemmo un tratto in bicicletta e una scarpinata a
piedi. Sotto un pesante strato di grandi foglie, sassi e terra, c’era il cadavere dell’unica donna che
avessi mai amato.
Era morta. E con lei era morto il mio amore. Mi cadde una lacrima e in quell'istante capii che era
morta anche per me.
Tornai alla luce del sole.
“Mi sposerò” dissi più a me stesso che a Luigi.
In lontananza uno schiamazzo selvaggio mi fece eco e tornò il silenzio.
“I parenti?”
“Solo il padre mi ha risposto, ma mi ha detto che lei non lo avrebbe voluto al suo funerale.”
“Mi dispiace che Zeno non sia qui. Tra di loro c’era un’amicizia profonda.”
“Mi ha detto che verrà appena possibile. Ho già detto a Joana di prendersi cura di lui.”
“E tu?”
“Io andrò qualche settimana nella foresta. Ho bisogno di stare solo.”
Un altro grido disumano, proveniente dall'oscurità, soffocò i nostri pensieri. Luigi mi guardò a
lungo negli occhi, prima di infilare la mani nello zaino.
“Queste sono alcune pagine che ho trovato tra le sue cose” disse con una tristezza per lui insolita.
"Sapeva nascondersi bene.”
Mi porse il plico. “Leggi.”
“Aspetta” dissi. "Anch'io ho qualcosa per te. È un quaderno dove ho trascritto le sue mail. Ci sono
anche delle lettere cartacee.”
“Posso leggerle?”
“L’ho preso apposta, Luigi. È bene che tu sappia. Con me si è sempre confidata. Forse la lontananza
le facilitava le cose. Ho sempre saputo che alla fine non avrebbe sopportato il peso del suo eterno
cercare. Eravate simili voi due…”
“Credi?”
“L’ho sempre pensato. Ma sapevo che tu eri più forte. Ero certo che tu avresti resistito agli urti della
vita mentre lei…”
“Quel che è stato è stato" disse Luigi.
“Forse potevamo aiutarla. Quell'idea di licenziarsi dall’azienda e mettersi in proprio per fare la
designer, quelle frenesie sessuali continue e mai sazie, quell’attaccamento al bicchiere e alle
droghe… dovevamo capire che a Madrid qualcosa non andava.”
“Ognuno fa la sua vita, Jo. Quando si è trasferita qui pareva essersi ristabilita.”
“Lo sai almeno, che non poteva avere figli?”
Annuì senza avere il coraggio di guardarmi. “Me l’ha detto dopo la nascita di Jesus. Era l’unica
cosa importante che mi ha detto negli ultimi vent’anni.”
Il mio dubbio fu confermato: aveva vissuto a stretto contatto con lei senza conoscerla. Provai
rabbia. Luigi era sempre stato superficiale. In ogni cosa. Soprattutto nel rapporto con gli altri.
Luigi all’improvviso cominciò a tremare. Lasciai che il pianto gli inondasse il viso e lo abbracciai.
“Non è colpa tua.”
Continuò a piangere finché non gli baciai la fronte. Alzò gli occhi verso i miei e mi baciò. Mi
strinse forte e si appoggiò sulla mia spalla destra. I suoi capelli odoravano di oceano e di terra.
ZL'autore
Nudo sarei solo.
Ma noi siamo tanti (io).
Sono un nome: perluigi. Molti mi chiamano gigio, alcuni pier, altri gigi.
(Mi apro: gigi non mi piace, mi sembra un nome da vecchio.)
A volte mi firmo gg, per comodità, come se firmandomi così potessi risparmiare tempo e quel
tempo risparmiato divenisse tempo creativo.
Creare. Tempo. Sprecato. Colpa. Senso.
Mi ossessiona il Senso di Colpa di aver Sprecato Tempo (una vita, per la precisione) senza Creare.
Mi chiudo: non ho talento, il talento non esiste.
Nella testa ho idee. Fuggono senza tornare. Dentro, sotto un'infinità di ***, ho qualcosa: da dire.
Non la dico.
Esprimibile a parole? C'è, vive.
Dire
Uscire.
Questa cosa che ho da dire, non riesco a uscire.
È colpa mia. Io la calpesto, la nascondo, la conservo: non la dico. Non so dirla, questa cosa. Nessun
uomo, forse: gli immortali?
ano
dire
qualcosa
tutti
?
tutti
qualcosa
dire
ano
La mia creatività è uno sfogo.
Sono nato nel 1977, la Notte di natale.
Vivo a Vigolo Vaccaro.
Amo il Trentino e la mia voglia di scappare.
Viaggio senza capire. Sto senza capire.
Scrivo per scelta. No vocazione.
Scrivo perché incapace di parlare. Io.
Perché il libro è finito e infinito, perché scrivere costa pochissimo e tantissimo:
perché
mi apro e mi chiudo e mi apro e mi chiudo e mi apro...
Sono una porta. Non voglio essere una porta.
Sono dietro la porta.
Non vivo per scrivere, né scrivo per vivere.
Scrivo per (*********) un me stesso che (non) conosco.
Mi chiudo: scrivo per piacere.
Mi apro: scrivo per piacere agli altri.
Mi chiudo: scrivo perché non conosco (altro) dialogo.
Mi apro: scrivo perché se ho fortuna mi pagheranno per farlo. In euro. Sul conto in banca.
Mi apro e mi chiudo: potrò viaggiare di più.
Mi chiudo: potrò lavorare di meno.
Scrivo: e per scoprirmi e per scoprirmi: che in fondo è un po' la stessa cosa.
Fino a togliere ogni strato: pelle-maschera-menzogna: scrivo, schivo: schivo scrivo.
Io sono tanti.
Nudo mai sarò?
Nudo solo sarò o sarò tanti nudo?
Noi siamo uno.
Mi apro un po'.
Pubblicare.
Godere.
Morire.
Mi chiudo un po'.
Pubblicare.
Morire.
Godere.
Mi apro un po' e un po' mi chiudo. Godere. Morire. Pubblicare.
Venderei me stesso: al diavolo l'anima!
Perluigi
X
Non mi piace il tuo disagio, mi entra sotto la pelle, appena sotto l’epidermide, mi sembra quasi di
vederlo. Il tuo diventa il mio, quello passato, quello che forse sono riuscita a far scivolare fuori
facendolo passare per ogni cellula del mio corpo, o forse no. Il disagio di vivere una vita che non si
capisce fino in fondo.
Vorrei sapere cosa dire e so bene quanto il dire sia inutile. O si sa o non si sa. A volte non serve
ascoltare, e a volte si ha solo voglia di dire. Allora dico qualcosa, che non serve a te ma un po’ forse
serve a me.
Vivere di futuro non è vivere. Non lo è davvero. Perché il futuro non esiste. Sai meglio di me che
oggi è il futuro di ieri e così sarà sempre. Viviamo come se fossimo infiniti ed invece tornando a
casa potrei morire. Succede ogni giorno. In ogni luogo. Alle persone che conosciamo. Vivere di
domani non è vivere. Quando lo si fa si è solo drogati di insoddisfazione, perché in fondo non
vogliamo arrenderci all’essere felici.
Progetti. Il segreto sta lì. Nel cedere le armi al volere sempre qualcosa di troppo grande perché
esista davvero.
Se siamo destinati all’immenso, allora arriverà. Intanto accontentiamoci di quello che sappiamo
fare.
E allora progettiamo, un lavoro, una casa, una persona da amare senza chiederci se ce ne sono altre
di migliori o di peggiori.
Perché i progetti piccoli che si possono avverare ci fanno vivere la vita senza passarla a voler essere
da un’altra parte. Sarebbe triste girarsi indietro e vedere che non c’è quasi nulla se non l’aspettare,
non credi?
E allora buttiamo via le matite e cominciamo ad usare l’inchiostro. Una bic nera per realizzare sogni
su carta bianca. E se si sbaglia non si cancella, che cancellare è peccato. E a forza di sbagliare, di
strappare in due visi di uomini quasi perfetti, di passare giornate a fare e disfare allora si sbaglia
meno o semplicemente si capisce che sbagliare non è poi tanto male.
Via le matite. Bic, nera ed indelebile, per tracciare linee sinuose o spigoli vivi, che il tempo se ne
frega se il foglio rimane bianco o è colorato. Noi no.
Liste. E che anche quelle non si possano cancellare, ma dalle quali spuntare i nostri sogni avverati
modificandole con il nostro crescere. Cose piccole. Per poter cominciare a camminare sereni. E
allora sì ai progetti che fanno paura, perché se poi non saranno quelli giusti, i migliori possibili, chi
se ne frega. Tanto andrà come deve andare ma almeno avremo saputo cosa fare. Avremo avuto una
via da seguire. Tanto il tuo domani sarà come deve essere. Ti piace il buio. Anche a me. Ma con un
fiammifero acceso è meglio, non serve la luce di un faro, se non c’è luna un fiammifero basta.
Non sei inadeguato. Nessuno lo è, non c’è un modo giusto o sbagliato di vivere, lo sai anche tu.
Chissà cosa faremo… dove saremo… sono d’accordo. Ma io vivo come se lo sapessi. Non so se sia
il modo giusto ma è quello che io ho trovato per sopravvivere, nel frattempo. E credo di essere
felice.
Perché se come in una canzone scadente la vita è un viaggio, allora io me ne frego della
destinazione e mi godo il paesaggio. Il treno arriverà comunque al capolinea.
“Sembrava spensierata, invece era di una profondità infinita, se solo l’avessi conosciuta…” dissi. Jo
aveva gli occhi lucidi e sorrideva.
“Questa lettera è di venticinque anni fa. Si era da poco messa in proprio per vendere la propria arte”
disse Giovanni. “Era conscia della tristezza del vivere, già pensava alle piccole cose della vita…”
Se questa mia vita fosse un’altra vita vorrei essere un’insegnante.
Questo sarei se non fossi ciò che sono.
Vivere questa, di vita, mi piace.
Adoro il mio lavoro, i miei lavori, adoro scegliere per gli altri, mettere nero su bianco ciò che penso.
Trovo nel mucchio ciò che gli altri non sanno nemmeno di desiderare.
So dove cercare i pezzi per fermare i tavoli ballerini delle persone che ne hanno bisogno.
Perché le loro anime erano così, solo non lo sapevano.
Lavoro per scoprire quello che gli altri vogliono e non sanno di volere.
E’ il mio vizio e la mia delizia.
Imbratto fogli con la bic, a volte con righe battute.
Eppure, pur amando questa mia vita incondizionatamente, mi chiedo cosa vorrei essere se non fossi
così.
Vorrei essere una fioraia, avere una piccola bottega, piccolissima e super incasinata.
Una bottega dove vender fiori e sogni.
Ma vorrei essere pure un’insegnante.
Meglio la prima, probabilmente m’arrabbierei di meno.
Dico sul serio, mi piacerebbe da morire.
Orari leggeri, niente commercialista, niente burocrazia, niente notti insonni per finire in tempo,
niente liti furibonde coi clienti, vacanze quasi infinite.
Tutta l’estate… una follia per una che pensa a ore.
Certo probabilmente dovrei rinunciare a qualche spesuccia superflua, ma chi se ne frega…
Il mio senso d’utilità verrebbe appagato nel cercar di riempire qualche zucca vuota: vuoi metter la
soddisfazione di far amare un po’ di letteratura? Di far sentire sotto il palato il gusto di un pittore
della parola? Di spiegare il perché dei pensieri dei poeti?
Decisamente insegnante.
Letteratura spagnola.
Terza superiore e a seguire.
Prossima vita.
Me lo appunterò nell’anima, così me ne ricorderò.
Prossima vita pacchia, che in questa sto dando abbastanza.
E oramai da qui non mi muovo, ho trovato la mia strada, finalmente.
“Sai quando te l’aveva scritta, Jo? Un mese prima di venire qui da me!” dissi sbalordito.
“Forse non aveva il coraggio di leggersi dentro” disse Jo, “di ascoltarsi.”
Tornai a sfogliare quei fogli pensando alle parole del mio amico.
Nel frattempo per i prossimi trent’anni cerca di fermarti almeno una volta. Un minuto o un anno.
Non importa. Fermo, in silenzio, decidi cosa vuoi. Qualcosa vorrai pure no? E comincia a spuntare
le caselle.
Ricomincia da lì. E se invece non è vero che sei così inquieto, se invece fosse solo il vestito che
vorresti avere questo del tuo vivere per vivere, allora togli la maschera e sii semplicemente quello
che ti va di essere. Per morire con qualche rimorso in più ma senza rimpianti.
Troppo complicato. L’ho già detto. Lo penso. E penso anche il contrario. Mi fa paura il pensare tu
lo sia davvero. Perché sfioro questo buio con le dita e la sensazione che ne deriva non mi piace.
E’ un salto troppo in giù. Troppi passi indietro.
Liste. Non dimenticare.
“Sai cosa mi fa ridere?”
“Non sarebbe il momento di ridere...”
“È sempre il momento di ridere! Questa lettera l’ha spedita a te, ma potrebbe benissimo essere stata
indirizzata a me.”
“Se lo vuoi sapere l’ho sempre pensato anch'io. Nonostante sembriamo così distanti, io e te non
siamo altro che la stessa persona che ha preso due decisioni radicalmente opposte.”
“Pian coi scavi!, direbbe tua madre” ridacchiai. “La stessa persona forse no, ma ammetto che le
nostre inquietudini sono le stesse.”
Giovanni rimase in silenzio.
“Senti cosa mi ha scritto, quando ancora lavorava a Madrid nella vostra azienda.
“Troppo tempo libero. Una vita che non è la tua. Sono pericolosi questi anni sabbatici, è come
rimanere in vacanza una settimana in più degli altri. Tutti tornano al loro da fare ma non tu. La
tua vita è una vita sabbatica! E allora non è più bello come prima e ci si sente un po’ in colpa. Il
mare non è più così divertente e quasi quasi si vorrebbe tornare a scuola.
“E’ in un certo senso come vedere da dietro la scenografia dello spettacolo.
“Questa mail l’ho conservata nel passaporto tutti questi anni."
"Lei sapeva a cosa andava incontro, al senso di colpa, alla solitudine" disse Jo, "come vedere da
dietro la scenografia dello spettacolo.”
Rimasi in silenzio. “Hai ragione, lei conosceva da sempre il suo destino.”ZL'autore concede il bis
Io non sono un nome.
Io sono *****. Amo rischiare. Sono ingenuo e scafato, intelligente e ignorante. Mi annoio. Cambio.
Ho paura ma non ci penso. Ho le vertigini ma salto, mi butto, volo, cado e volo ancora.
Io sono ********. Sono ambizioso e umile. Schiaccio e mi faccio schiacciare. Mi chiamano idiota
o dotor.
Non mi chiamano mai.
Io sono zen.
Io sono ******. Ho sofferto. Ho voglia di divertirmi. Mi diverto ma non quanto vorrei. Sorrido ma
non come vorrei. Sono malata nell'anima. La mia è una cicatrice aperta che squarcia: sono una
cicatrice da disinfettare con sesso e alcol. La mia infezione è infinita. Nel tempo e nello spazio. Non
trovo pace. La cancrena mi mangia il cuore finché è caldo.
Io sono *****. Vivo in paradiso. Non mi sento ignorante: io so come devo vivere. Io so di essere
felice. Basta poco: un compagno, una compagna, un figlio, un oceano da guardare.
Io sono ******.
Sono un'anima in pena. Sono una donna che si guarda nello specchio, che sa di non avere altro che
un corpo che la sostiene. Vivo nel passato: e ci vivo male. Ho bisogno di essere scopata per sentirmi
viva. Sono triste e sola.
Un corpo perfetto e un'anima malata.
Un'anima qualsiasi e un corpo morto.
Io sono ****. Sono uno stronzi. Sono intelligenti. So dove voglio arrivare. Non so amare. So
scopare. Amo salire le scale.
Morirò di infarti dei cuori nelle scopate di amori nelle saune dei settimi livelli.
Io sono *****.
Sono una ragazza che pensa al futuro. Credo di amare il mio uomo, ma amo solo il suo cervello.
Amo la vita facile e so che non è tutto qui. Ci sono altri uomini. Altre auto, altre case, altre cene,
altri Stati, altra gente, altre mode. Sono una donna che si sente marcire. Una donna tacco dodici.
Una donna senza età.
Io sono ***** detto *******. Sono un insegnante. Amo lo sport. Amo sopravvivere. Amo
viaggiare. Amo la vita così com'è.
Io sono ********. Le ragazze mi chiamano Baguette per le dimensioni del mio fallo nero. Amo
sballarmi e suonare. Sono poligamo e non mi piace lavorare.
Io sono una ex di *****. Ho la cellulite e l'alito cadaverico al mattino. Sono diventata una sorella,
non un'amante. Sono sola.
Io sono un ragazzo di passaggio. Amo la natura, non quella umana. Non tutta, quantomeno. Scappo.
Io sono una ragazza birmana. Sono bella e sporca. C'è chi mi ama e chi mi odia: preferisco morire.
Io sono tutti. Io sono tanti. Io sono pochi.
Io sono uno.
Io sono.
Io.
I.
.
x
Oggi mi sono svegliata innamorata.
Di tutto e di tutti ^_^
C’era il sole, che ora se ne sta andando, e avevo quel “friccicorino ner core”, come dite voi italiani,
che ti fa sentire immensamente buona e generosa. Mi sono piaciuti persino i miei nemici più
acerrimi…
Ma la vita è dura e spietata… dunque le solite avversità quotidiane mi stanno facendo passare tutta
la mia immensa bontà. Per il momento me la godo.
Ci si abitua a tutto anche alla bellezza. E adesso se mi capita di guardare un uomo lo faccio in modo
diverso, non mi soffermo sulle riviste con questi visi perfetti stampati in bianco e nero, però mi
ricordo come qualcuno mi ha stretto la mano o mi ha guadata negli occhi, gli occhi… adoro lo
sguardo degli uomini che sanno cosa vogliono. Ma visto che sono innamorata, mi mordo un labbro
e passo avanti ^_^
Mi sono alzata innamorata, oggi anche di te, oltre che di tutti gli altri.
Oggi mi piace, mi piace scriverti, mi piace pensarti ed esser pensata.
Lascio che sia, anche se in fondo so che non è proprio del tutto giusto.
Lascio che sia, perché ora sono di buon umore ma stanno arrivando le nuvole di nuovo. Le sento
dentro al sangue.
“A volte era felice.”
“A volte.”
Ho preso una decisione.
L’amore.
Chiedere cosa sia è notoriamente stupido.
Io lo faccio lo stesso.
E mi rispondo. Ci provo sapendo già in partenza che sarà un fallimento. Un fallimento consapevole.
Basta questo a giustificare il tentativo, no?
E allora salto, in questo nuovo pozzo, nella ricerca della giusta domanda che presupponga la
risposta più vicina alla realtà.
Tutto (o quasi) è spiegabile, con la fisica, la chimica e la psicologia.
Non rimane nulla al di fuori di questo per la mia mente scientifica.
E l’amore non fa difetto.
Io credo che ci si innamori per bisogno.
Per il nostro essere incompleti.
E che ogni persona della quale ci innamoriamo sia diversa a seconda di quanto noi cambiamo nella
vita.
L’aver bisogno di qualcosa…
Come nella chimica cerchiamo quello che ci bilancia.
Quello che ci rende quieti, quello che ci da pace, quello che ci completa.
E nella strada per la completezza ci struggiamo, facciamo cose inconsulte, cerchiamo, ci
intrecciamo, aspettiamo, facciamo palpitare cuori e pance.
E credo sia di questo che si abbia bisogno. Un cuore che batte. Almeno credo sia così per me.
L’emozione.
E poi ci chiediamo cosa sia l’amore.
L’amore è emozione.
Per qualche cosa.
E’ l’alzarsi al mattino con la voglia di pensarci.
L’addormentarsi con quel pensiero che ci scalda il cuscino.
E’ l’essere sempre ad un passo da una bella sorpresa.
E allora si ama.
Si amano cose, pensieri e persone. Tutto ciò che fa mancare l’aria per qualche secondo, quello che
ci fa sentire come quando prendiamo un dosso troppo velocemente. Un vuoto nella pancia che
brucia.
E si ama per questo.
Combinazione di assenze e desideri.
Di difetti dell’anima compensati con costruzioni ideali e reali dalle impalcature leggere.
Ci innamoriamo di persone diverse.
E sono storie lunghe o storie corte.
Se siamo fortunati sono storie vere.
Se siamo fortunati chi abbiamo scelto non è solo quello di cui abbiamo bisogno ma è la miscela che
più si avvicina a dissetare la nostra voglia di completezza che ci da quello che vogliamo anche
quando non sapevamo di volerlo.
E’ energia che cambia con noi e dunque la teniamo accanto il più a lungo possibile.
Basta pochissimo per far crollare tutto.
E basta pochissimo per essere felici.
Chimica. Fisica. Psicologia.
Il destino porta i candidati.
Può non portare mai per tutta una vita quello di cui abbiamo veramente bisogno.
E allora cerchiamo continuamente confusamente senza sapere cosa.
Innamorati dell’amore si dice, a volte.
Io credo dipenda solo dal fatto che tutti abbiamo bisogno d’essere innamorati ogni tanto.
Quando lo si è di meno o non lo si è da troppo tempo allora riempiamo gli spazi con l’esserlo di
qualcos’altro. Sia il lavoro, sia una passione, sia una persona diversa. Dobbiamo amare sempre per
non morire, ma non possiamo essere sempre innamorati.
E allora dire “ti amo” è una cosa che non mi piace.
Che ho detto poco ma non perché non abbia amato.
Sono parole stupide che ho preferito scrivere solo alcune volte.
Dirle molto meno.
Sono parole che non hanno nemmeno molto senso.
Inflazionate. Dall’uso comune. Vuote. Tutto e niente.
E allora ho deciso.
Non le dirò più.
Perché non voglio siano queste parole comprate dalla pubblicità a rendere quello che può passare
dentro un cuore.
Dimmi la verità, quando senti dire “ti amo” cosa pensi?
Pensi alle emozioni che l’amato/a può dare quando si rivede dopo una lunga assenza?
Pensi al tumulto nel cuore? Allo sconvolgimento totale della vita che provoca l’averlo/a nella
propria?
Pensi a quanto male e bene possa fare il guardare troppo a lungo in fondo a quegli occhi?
Pensi al fatto che nulla ha più senso senza di lui/lei?
Pensi a quando sentire l’odore lasciato sul cuscino è bello quasi quanto l’aver avuto tutto la notte
prima?
Non dirmi di sì, non ti crederei.
Se senti qualcuno che dice “ti amo” non pensi a questo.
Provi la stessa percentuale d’emozione che si prova vedendo alla tele una strage in Darfur. Una
descrizione che non rende l’idea e s’inserisce nella quotidianità lasciandoci quasi indifferenti
mentre mangiamo un piatto di pasta.
Amare invece è come essere lì. In mezzo alla battaglia.
Amare è così. Uno sconvolgimento totale.
Ma non possiamo essere sempre innamorati.
Moriremmo consumati dall’emozione.
Dunque ci innamoriamo e poi amiamo moderatamente fin quando non ne risentiamo il bisogno.
Chimica. Non è altro che uno scompenso da compensare.
Le storie lunghe durano perché chi le vive sa compensare i bisogni in modi onesti o nascondendosi
bene.
Le storie lunghe e felici sono delle persone che non rinunciano a se stesse. Individui che rimangono
individui. Uniti per compensarsi per quanto sia possibile. Consapevoli che nell’altro non si potrà
trovare tutto comunque. Consapevoli del fatto che ci si debba innamorare ogni tanto. Di qualcuno o
di qualcosa. Siano rose, capre, montagne, o siano persone.
L’amore…
Che cosa stupida provare a dire perché sia o non sia.
Per questo non dirò più “ti amo”.
Non so nemmeno la differenza tra amare un uomo e una montagna.
Non lo dirò più.
Non voglio mettere un’etichetta a questo miscuglio di sentimenti perché questo è, un miscuglio di
sentimenti, dargli un nome è troppo complicato e rischioso.
Non voglio sia un titolo in un telegiornale. Non voglio sia la pubblicità di una crociera.
Voglio sia una barca in mezzo a un mare forza sette e voglio che si senta l’odore del sale, e sentire
l’acqua sulla faccia ed il vento nei capelli, l’odore del legno bagnato e non quello della plastica di
un divano nuovo davanti ad una tele a colori sintonizzata su Licha Colò.
Per questo non dirò più “ti amo”.
Non voglio dover essere imbarazzata nel dire parole che non mi appartengono.
Esporre bandierine colorate delle festicciole dei bambini per segnalare un rave in mezzo alla foresta
pluviale con un dio atzeco come guest star sarebbe riduttivo, no?
E allora la prossima volta che mi succederà prenoterò un vulcano che possa esplodere ed annunciare
l’inizio della festa.
Oppure semplicemente troverò il modo di dirlo usando parole diverse.
Magari mi siederò con calma, per capire la differenza tra amare un uomo e una montagna, se ce n’é
una, e magari nel trovarla troverò anche il modo giusto.
Ma cosa sto dicendo? Io sono innamorata! Non c’è più un dio atzeco a battere tamburi che fanno
tremare la terra e forse Eros non passa da qui più volte d’un tempo, ma sono innamorata!
E allora? E allora nessun problema. Ma però la domanda me la pongo lo stesso.
A qualcuno dovevo scriverlo.
Senza motivo.
Senza motivo davvero.
In giornate come questa ci sono cose che si ha voglia di dire anche senza un motivo.
Non ci sono però molti posti dove poterlo fare.
Uomini… donne… persone… montagne… piante… capre… ci devo pensare… devo pensare alle
differenze… se si può amare in modo diverso… ci devo proprio pensare… in due si pensa meglio.
A volte.
A volte in tre si pensa meglio ancora.
A volte.
Spesso no.
E comunque ti amo.
“Hai notato che si riferisce sempre a un tu? Anche quando alla fine dice, e comunque ti amo.”
Annuii imbarazzato.
“Chissà che forse non sia tu quel tu?”
“E chi allora? Tu? Zen? Chi?” dissi agitato. “Chi altri conosceva?”
“Non ci arrivi?”
Solo allora compresi. Non ci avevo mai pensato. Mai in questi termini. Jo sapeva che io non avevo
mai saputo.
“Non era con me che si confidava...”
“Io l’ho capito subito. Mi è bastato uno sguardo a Joana, al suo sorriso, alle sue spalle forti, alla sua
pelle spessa…”
Rimasi senza parole.
“Lu, l’avevi sempre detto che Salomè era di larghe vedute, come hai potuto non capirlo?”
Pensai a lungo prima di aprir bocca. “Loro si amavano, forse più di quanto amassero me. Ecco con
chi parlava del demone che la tormentava!”
“Questo non vuol dire che non ti amasse. Il vostro triangolo funzionava: tutti amavano tutti. Figurati
se due donne così belle si sarebbero accontentate di un solo uomo!"
Lo guardavo sentendomi come un bambino rimasto senza amici dopo la fine della scuola.
“Stai pensando che loro ti abbiano tradito? Che siano state con te solo perché tu gli servivi?” disse,
forse per provocarmi.
“Non sono arrabbiato o deluso. E non mi sento nemmeno tradito. Ripenso alle mie molte assenze:
quando io mancavo, i loro cuori facevano festa.”
“Non credo sia così, Lu. Semplicemente vi amavate tutti e tre, punto. Quando tu mancavi loro
compensavano la tua assenza amandosi. Non andare a pensare chissà cosa. Fermati. Lei è morta.
Non c’è più. È rimasta Joana, è a lei che devi dare tutto te stesso, e consolarla per la morte di
Salomè. Consolatevi a vicenda, ne avete bisogno.”
“Ti avevo giudicato male, Jo. A volte sai essere così illuminante.”
“A volte” sorrise e si avvicinò per abbracciarmi. "Nessuno è imperfetto."
"Al contrario" dissi. "Tutti siamo imperfetti."
"A parte Zeno" disse facendomi sorridere.
"A parte Zeno" ripetei.
Rimanemmo in silenzio per ore a sfogliare quei pensieri scritti nero su bianco, quando Jo gridò
"Eccola!"
"Cos'hai trovato?"
"La lettera d’amore in cui Salomè descrive l'incontro con Joana" disse felice. “Vorrei la leggessi tu,
lentamente e a voce alta. Dopo di che ci alzeremo in silenzio e ce ne andremo da qui per sempre.”
“Va bene.”
Z
L'autore offre un tris di primi
Vorrei aprirmi. Vorrei mi conosceste.
Io sono tutti i miei personaggi, i miei personaggi sono me.
No: io sono più dei miei personaggi. Io sono infiniti personaggi. Se avessi il tempo darei vita a tutti.
Il tempo è poco. Potrei non esserci più.
Per capire me, è necessario capire loro. Per capire loro, può essere utile capire me.
Capire me è impossibile.
***
Qui avrei voluto inserire un tema delle elementari, ma non trovo i quaderni. L'ultima volta che li ho
riletti - sarà stato dieci anni fa - ho provato delle sensazioni bellissime: tenerezza, gioia, nostalgia,
voglia di avere un figlio: vorrei tanto aver condiviso la lettura con voi, mi spiace. Proverò a
chiedere a mia madre, forse li ha presi lei.
***
Questa poesia l'ho scritta a Madrid durante uno stage, dopo la laurea in ingegneria per l'ambiente e
il territorio. È nelle sue menzogne che si cela la mia verità.
ORA SO CHE AMO LA MIA CAPRA
voglio scrivere una poesia sulla pioggia
vorrei che la leggesse il mondo intero
parlerà dell'acqua che bagna
che sporca le nostre voglie represse
che lava il nostro amore sincero
scorre giù fino alle viscere dell'anima
bestemmiando
comincia a mordere il nostro cuore
fa male
"oh...fa veramente un male della..."
molto dolore, davvero molto dolore ;-(
mi sembra d'impazzire
morde il cuore e lo lancia via
lontano da me
bestemmiando
"oh, ma l'acqua è veramente bastarda!"
"porca di quella troia... dove cazzo hai buttato il mio cuore!?!"
mi metto una mano sul petto
cercando di bloccare tutta quest'acqua
che ora entra in me
bestemmiando
prende il posto del mio cuore.
bau!
alzo la testa
non vedo più il mio cuore
attimi
"no, cazzo!!! dove stracazzo è finito?!?"
"era lì per terra a due passi, porca troia!"
il dolore dà il cinque (a mo' di cambio) all'angoscia
"diòs... dove cazzo è rotolato il mio cuore?!!"
inizio a camminare
bestemmiando
piove
(chiaro...per chi se ne fosse dimenticato: questa poesia parla della pioggia!)
tutto è alberi, erba, bagnato
non lo troverò mai più
se lo sarà portato via qualche diavolo
qualche capra dai mille occhi
(dicono che in queste terre sia pieno di capre dai mille occhi!)
sono solo
bestemmiando
non c'è sole
non c'è vita
non ci sono donne ignude con la fica bagnata accanto a me
vago nelle foresta dei grattacieli inventati
"cazzo... se solo incontrassi la capra dai mille occhi che ha preso il mio cuore!!!"
le direi solo "ridammi il mio cuore" e lei
"ok"
Avrei voluto inserire anche un mio saggio di qualche anno fa intitolato L'inquietudine dell'eterno
cercare, ma non amo le digressioni (balle): vorrei soltanto capiste che, è vero, magari non scrivo
bene, ma sono un'anima bisognosa e, forse, sensibile.
A proposito di letteratura, il narratore (pace all'anima sua) in punto di morte mi ha pregato di farvi
leggere l'ultima parte del romanzo breve scritto da Luigi, dicendomi - se ricordo bene le sue parole che è espressamente dedicata a chi vuole leggerla.
Premetto: non so di cosa tratta, lo leggo anch'io per la prima volta.
EDUCAZIONE
come allevare un figlio affinché non segua le tue orme
Non tornarono mai.
A Luna non dissi la verità. Non vedevo perché farla soffrire. Preferivo ci arrivasse da sola in tempi
maturi.
Poter allevare una piccola creatura era una gran responsabilità, un impegno continuo che cercavo di
svolgere al meglio. Divenne l’unico scopo, l’unica via per sopravvivere. Luna era per me la
speranza di una vita nuova. Aver perso sei dei miei sette figli e l’amore della mia vita mi aveva
distrutto. Aspettavo ogni sera che Luna si addormentasse per dar sfogo alle lacrime. Il giorno mi
sforzavo di sorridere con dentro al petto un dolore sempre più forte che mi lacerava l’anima. La
notte piangevo, piangevo tanto che la mattina non avevo più lacrime in corpo e mi veniva spontaneo
dare il buongiorno a Luna abbozzando un sorriso. Lei era l’unico appiglio che avevo col mondo
reale. Se non ci fosse stata lei tanto valeva morire.
Della vita che avevo vissuto in superficie, sulla terra, non ricordavo niente. Nemmeno i racconti di
Libera mi avevano fatto riaffiorare la memoria. Non mi restava che insegnare a Luna quel poco che
avevo imparato da me, e cioè ad usare il cervello in ogni situazione, a stare sempre allerta, a fare
anche la più piccola cosa con la massima consapevolezza: le insegnai a leggere i messaggi nascosti
nelle piccole cose della vita.
Luna cresceva a vista d’occhio e sapevo che non era giusto tenerla per sempre con me. Che se ne
faceva lei di un vecchio papi brontolone? E poi io me la sapevo cavare anche da solo no?
Il giorno tanto atteso in realtà non si fece nemmeno attendere. Un pesciolino giunto da lontano che
passava nelle vicinanze fu attratto dai riflessi della sfera di vetro ed ebbe il coraggio di avvicinarsi.
Si presentò con parche e sagge parole che convinsero me ancor prima di Luna.
Lei era raggiante all’idea di poter vedere il mondo col suo innamorato e non sarei stato di certo io a
ostacolarli. Mentre la osservavo scodinzolare via, trattenevo a stento le lacrime, e quando lei, per
gentilezza, si girava a guardami, le sorridevo muovendo la pinna in segno di commiato.
Ero di nuovo solo.
TRISTEZZA
come porsi di fronte a nuove solitudini e ad abissi di sofferenza
Solo.
Solo e triste.
Triste come se fosse finito un bel sogno.
Passo le giornate a chiedermi dove ho sbagliato. Continuo a ripetermi che dovevo convincere
Libera a rimanere in casa. A non uscire allo sbaraglio con i pesciolini. Sono giunto alla conclusione
che qualcuno se li sia mangiati. La verità è che sarei dovuto essere là con loro per poterli
proteggere.
Ma non ha importanza. Non più. E probabilmente non ha neppure importanza che io abbia
sbagliato.
Mi sfiora l’idea che sia stato tutto un sogno, ma pure questo non ha nessuna importanza.
Sono solo. Ho perso tutto tranne me stesso. Mi ritrovo al punto di partenza: io all’interno della sfera
a pensare. Ma allora perché sono tanto triste? Qualcosa è forse cambiato?
Ho fatto delle esperienze. Ho provato forti emozioni. Ho passato giornate bellissime stretto a Libera
e ai nostri pesciolini.
Forse è proprio questo che mi rende triste. Ho sperimentato sensazioni così belle che nemmeno
pensavo potessero esistere: l’amore incondizionato per le mie creaturine e l’amore possessivo per la
mia Libera.
Non è rimasto niente di niente. Solo un sempre più vago ricordo che fa solo male.
Tanto, male.
t
Un po’ su ed un po’ giù.
Volubile come pochi al mondo.
Improvviso è il mio cuore ed improvvisi i miei sentimenti.
Scrivo per me, ma scrivo a te, mia amata.
Sono una spugna. Assorbo i sentimenti degli altri. Le paure, le angosce, i dubbi, lo sconcerto, la
solitudine. Assorbo e trasformo in malinconia. Ieri al telefono è stato così, con Giovanni. Un’ora di
bombardamento all’anima. Per questo sto lontana dalle disgrazie altrui. Diventano mie. E il mio
cuore non è abbastanza.
Quando gira così, allora sono le domande a rimbalzare nella testa come quelle palline colorate che
tiravamo fuori dalle macchinette con venti pesetas.
Diverse, tante e tutte in movimento contemporaneamente, a sbattere nel cranio in punti distinti.
Una di queste ti riguarda un po’. Una su tante. Ma è lì ed è sempre la stessa.
Perché non lo so, non lo so davvero e non so nemmeno quanto tempo perdere nel chiedermelo
questo perché. A volte basterebbe godersi lo spettacolo senza pensare a chi sta dietro al sipario.
Ma non ci riesco.
Perché ti ho voluto nella mia vita.
Voglio capire il perché. Fermare questa cavolo di pallina rossa nella testa grigia e poi godermi
quello che sarà.
Quando non so rispondere impazzisco.
…come un’idiota cerco la perfezione e poi mi trovo in faccia le mie contraddizioni…
Quanto poco ci vuole per far confusione.
Mi sono accorta di quanto fragile sia il mio equilibrio.
Sono un palazzo dalle fondamenta liquide.
E’ bastato veramente molto poco.
Andavo dritta per la mia strada.
Correvo veloce sul mio filo nero e non guardavo ai lati.
Poi un giorno ho visto qualcosa con la coda dell’occhio, un luccichio in mezzo all’erba.
Potevo andare avanti ma invece no. Mi sono fermata per guardare cosa fosse.
Ho visto.
Un oggetto nuovo, anzi nuovo non proprio. Qualcosa che avevo già visto un milione di anni fa.
Uno specchio magico. Di quelli che riflettono te stessa. Da dentro. Senza pelle.
Uno specchio che risponde e che domanda ma soprattutto che riflette quello che ascolta.
Mi sono guardata. E credo di aver provato la stessa sensazione che prova qualcuno che si vede per
la prima volta dopo un'operazione al viso.
Mi sono guardata dopo tanti anni. Mi sono rivista cambiata, cresciuta, diversa. Ma mi sono
riconosciuta.
Ed ho avuto nostalgia.
Perché il mio specchio magico mi ha ricordato di quando avevo mille sogni e tutto poteva essere
realizzato.
Ora che ho tutto, che ho realizzato quello che volevo, che ho spuntato dalla mia lista ogni cosa
possibile, il tempo mi sembra fermo. Corro veloce sulla mia strada e non cerco più nulla. Ed ho
paura perché non ho più sogni da inseguire.
In realtà io ho sempre sogni da inseguire.
Mi manca la bambina che non ho mai avuto e che mai potrò avere.
Mi manca la bambina che non sono mai stata e che mai potrò essere.
Solamente adesso sono finita in un pozzo.
Ho la sensazione d’essere in mezzo ad un deserto seduta a gambe incrociate a guadare l’aria che
bolle. Tutto piatto ed infinito. Solo sabbia. E sono tranquilla. Guardo. In silenzio e senza fretta.
Voglio capire quante volte dovrò sbattere gli occhi per tornare nella mia giungla verde e rigogliosa,
alla caccia di scimmie parlanti e serpenti ballerini.
Perché la mia vita è sempre stata così, verde avventura.
Ed ora è color oro.
Mi sono fermata perché ho visto uno specchio in mezzo all’erba.
E il mondo che mi correva vicino non era quello che sembrava.
Al contrario della ruota dei colori che quando gira sembra bianca la mia era colorata mentre correva
ed ora si è fermata.
Che stupida sono stata a non accorgermi di quanto stessi sbiadendo.
Quanto poco ci vuole a far confusione.
Perché quando si ha tutto quello che si può volere si può essere felici oppure disperati.
Ero felice. Davvero felice.
Ora mi chiedo se lo sia ancora. Ora che ho visto. Ora che ho visto il mio nuovo viso.
All’improvviso. In uno specchio raccolto per strada. Uno specchio antico come il mondo. Uno
specchio magico.
Ed è di nuovo confusione.
Confusione in una mente che ha bisogno di regole matematiche e ordine per sopravvivere alla sua
sregolatezza.
Ho trovato uno specchio magico in mezzo ad un prato ed è stato come togliere il libro da sotto alla
gamba del tavolo.
Ora che sono di nuovo tornata e che sono in mezzo al caos devo fare pulizia.
Ed aggiustare quel tavolo prima che cada il servizio buono.
Concordo sul ciclico. L’acqua non ha scelta.
Qui, ora, non ci sono corde per ammazzarsi.
Là, poi, non ci saranno che corde per ammazzarsi.
X
Un giorno mi alzai e, per prima cosa, scrissi una frase sul muro di casa: tutto ha una fine, nulla ha
un fine.
Giovanni se n’era andato.
Io, anziché andare nella foresta, passai un mese in tenda nella savana, sempre nello stesso punto.
Avevo bisogno di stare solo e riflettere.
Zeno, quando arrivò, trovò Joana. Fu lei ad andare a prenderlo all’aeroporto e a condurlo alla tomba
di Salomè. Trascorsero insieme una settimana.
Se ne andò senza che ci incontrassimo.
Mi accorsi all’improvviso di avere sessant’anni.
Jesus, una volta raggiunta la maggiore età, se n’era andato a Nova Trento. Aveva trovato lavoro
come insegnante d’italiano in una scuola elementare.
Salomè non c’era più, ma in ogni spazio e in ogni tempo, io e Joana rivedevamo il suo sorriso
spento, ci tornava alla mente il suo alito d’alcool e cicche, e ci venivano alle orecchie le note rauche
di una donna triste dentro e felice fuori.
Non c’era medicina per quel male che odorava di verità. Non c’era speranza. Solo il vento se la
poteva portar via, o la terra marcia di una vita errabonda e fragile. Ha retto finché ha potuto, finché
nulla aveva più senso: finché solo la morte poteva esserle amica.
Io e Joana rimanemmo soli.
Qualche ospite qua e là non era che una pedina grigia incapace di smuovere sentimenti di fanciullo.
Lei non era più in età da figlio. Si passeggiava, si coltivava l’orto, s’invecchiava.
Continuavo a scrivere il mio romanzo breve senza fine. E a cancellare, più del dovuto.
Non ero più guarito. Le gambe cominciavano a cedere. La schiena mi doleva a ogni passo. Provavo
a fingere di essere ancora Luis, lo straniero surfista e dongiovanni di una volta, ma bastava uno
sguardo per capire che i tempi erano maturi. Un virus che non saprei dire se più fisico o più
spirituale, era penetrato in me: nell’anima, nel sangue, nelle ossa. Nella testa.
Il tempo scorreva lento, più lento di un tempo. Me ne stavo seduto a osservare l’oceano per ore
infinite. La mia vita si era fermata. Il tramonto mi sorprendeva impreparato. Giorni uguali. Senza
meta.
Vedevo Joana incamminarsi svelta ogni mattina. Tornava al tramonto per prepararmi una cena
frugale. Anche coltivare l’orto era divenuta un’azione faticosa. Tutto si riduceva al nulla. Mi alzavo,
mi sedevo e la notte arrivava, e così il giorno successivo.
Arrivò una lettera.
Da quando mi sono trasferito qui a Vigolo l’ansia di una vita migliore mi ha abbandonato. Dopo il
lavoro in città, me ne ritorno quassù e mi concedo lunghe passeggiate nella campagna circostante e
nei boschi di faggio. Si respira un’aria sana di montagna qui. Ho preso pure a coltivare la terra e a
mangiare soltanto frutta e verdura del mio orto come mi hai insegnato tu.
Ma non è questo il punto.
Proprio nelle lunghe passeggiate ho incontrato una persona speciale. Mi piacerebbe dilungarmi
sul modo in cui l’ho conosciuta, su quanto sia innamorato, et cetera, ma conoscendoti so per certo
che ti annoieresti: lo so che non ami le storie d’amore! E allora vengo al sodo: MI SPOSO!!!
Sì, hai capito bene, HO DECISO DI SPOSARMI CON KLAUDIA! Anche lei ha sessant’anni e mi
ama per quello che sono. È da mesi che ci frequentiamo ma non te ne ho mai parlato perché mi
avresti riempito la testa di cazzate, sai cosa intendo. Ho voglia di sposarmi, Luigi, ho voglia di
passare il resto dei miei giorni con una persona a cui voglio bene, con la quale condivido la
passione per Dio e per le passeggiate. Tutto qua. Era tutto così semplice! Lo so che tu non puoi
capire, ma non voglio rimanere solo! Ho passato tutta la vita da solo! Ora ho voglia di condividere
ogni secondo, ogni minuto, ogni attimo, ogni esperienza, sono giunto alla conclusione che la vita in
due è più facile e più bella. Lo so che tu ami la solitudine e la libertà, ma vorrei tanto che per una
volta chiudessi quella boccaccia maledetta e venissi a fare il testimone alle mie nozze, tu, e
ovviamente anche Joana.
Voglio che tu e Zeno siate i miei testimoni!
Ci conto!
Ti aspetto alle idi di maggio.
Per la fretta si dimenticò di firmare.
Non volevo che Zen e Jo mi vedessero in quello stato pietoso.
E poi non mi andava di entrare in chiesa: mi faceva rabbia vedere gli altri adulare qualcosa che io
non capivo, credere in un essere superiore del quale io non riuscivo a farmi una ragione, avere
fiducia in un dio inesistente.
Che amara sconfitta la vita.
Piangevo spesso quando ero solo. Non perché fossi triste. Piangevo perché non trovavo risposte. A
cosa era servito tutto il mio peregrinare? Tutte le sofferenze che avevo patito, tutti gli obbiettivi che
avevo raggiunto. Ero impotente e nudo. E per di più senza risposte alle domande che mi ero sempre
posto.
“Datti pace, straniero, datti pace.”
Arrivò una mail di Jo:
L’ho trovata!
Ho trovato la felicità. È spuntata come un arcobaleno dopo mesi di pioggia.
Ho sessant’anni, e solo ora respiro la pace che cercavo. Solo ora ho ritrovato la voglia di vivere che
avevo da bambino. Amo mia moglie, la mia casa e il piccolo paese in cui vivo. Il resto non conta.
Soltanto adesso capisco i miei errori: trasferirmi in città con mia madre e amare per trent’anni la
persona sbagliata.
Il lavoro non è altro che una manciata di ore in gabbia, necessarie o no, ha poca importanza.
Torna qui da me e da Zeno. Ti aiuteremo a finire il tuo romanzo. Vieni, goditi la vecchiaia con noi.
Ti aspettiamo.
Un bacio,
tuo per sempre, Jo
***
Joana, un giorno come un altro, mi disse che si vedeva con qualcuno.
“Un calzolaio di città?”
“Sì, un calzolaio di città. Perché?”
Era una beffa ritrovarmi a settant’anni impotente e cornuto. D’altra parte lei aveva poco più di
cinquant’anni, un fisico sano e una pelle liscia.
“Sei geloso?” disse mentre sorseggiava un succo di mango senza distogliere lo sguardo dall’oceano.
Non risposi.
“Tu geloso, sembra una barzelletta!”
“E invece è la realtà” dissi ridendo di me stesso.
Lei si avvicinò e mi baciò la fronte.
“Ho deciso di tornare.”
Rimase in silenzio.
“Dici davvero, straniero?”
“Sì. I miei amici mi aspettano. Voglio scrivere un libro con loro.”
Feci una pausa per osservare il sole viola all’orizzonte.
“Sarai felice anche senza di me. Ti lascerò quel poco che ho.”
“Non me lo merito, straniero. Tornerò a casa. È vuota ora.”
Le tappai la bocca con un dito.
“Jo, tu mi hai dato un figlio.”
“E tu gli hai insegnato a vivere nel mondo…”
“Io? Non so nemmeno se ha avuto un senso vivere. Se ha imparato qualcosa è merito tuo. Io non
c’ero mai, e quando c’ero gli ho trasmesso inutili sogni: ho costruito per tutta la vita soltanto castelli
in aria.”
“Tu sei speciale, straniero. Sei stato il nostro sole nei momenti di gioia, e la nostra stella nei
momenti bui. I tuoi erano castelli in aria, è vero. Ma è bastato metterci sotto le fondamenta, e sono
diventati realtà!”
Non sapevo se ci credeva veramente, oppure lo diceva per dare un senso alla mia misera esistenza.
“Pensa a Carolina e Daiana. Una è infermiera e l’altra avvocato: ti ricordi quando le chiamavi qui
per insegnare loro a leggere?” disse sempre più convinta. “Tu sei un uomo dai grandi sogni,
straniero, e li hai realizzati tutti. Pensa a Jesus: si è sposato, ha trovato un ottimo lavoro, ha
comprato casa. E pensare che mio padre era soltanto un povero pescatore…”
“Non dire soltanto un povero pescatore. Tuo padre era un uomo semplice e leale. Ed è morto felice,
con una moglie fedele e grata, e delle figlie che lo amavano. Ho imparato molto da lui. Non
abbastanza, purtroppo.”
Joana mi guardò con gli occhi lucidi.
Le sorrisi. Rimanemmo in silenzio.
“Non c’ero quando il mio unico compito era di esserci.”
“Ti sbagli, amore. Le tue assenze ti rendevano vivo. E anche adesso che te ne vai per sempre,
continuerò ad amarti. Perché è te che ho amato, amo e amerò. Se non fossi entrato nella mia vita,
ora sarei morta dentro.
Se ci sarà un’altra vita, la vorrò passare un’altra volta con te.
“Con te e Salomè” sussurrò al mio orecchio.
L’abbracciai per l’ultima volta.
Era un venerdì. Venerdì 13 agosto 20**. Lo ricordo perché da quel lontanissimo venerdì è passato
solo un mese. Ho ancora il biglietto aereo. È qui, appeso sul muro della mia stanza a casa di Jo. Lo
conservo con cura perché so che quello è stato il mio ultimo viaggio. Come una balena ammaccata,
sono venuto qui per morire.
Una famiglia di contadini si offrì di accompagnarmi in aeroporto su un carretto sconquassato.
Certe cose non cambieranno mai, pensavo mentre il carretto, trainato da un povero somaro in cui mi
sforzavo invano di vedere Jo, sobbalzando mi allontanava per sempre da Joana, dalla mia casa e dal
mio sogno infranto.
Prenotai il volo e attesi. Ero bravo ad aspettare. Non sapevo fare altro.
Aspettare.
Aspettare.
Aspettare che la morte venisse a prendermi.
5
Y
Lo trovai invecchiato.
Era il quindici agosto. Pur essendo mattina, faceva troppo caldo per uscire.
Di anni ne erano trascorsi una decina. Si era trasformato: da surfista a vecchio zoppo ricurvo. La
sua schiena era una S dalle forme generose, inclinata in avanti di una trentina di gradi. Camminava
con il bastone nella destra. Il viso si era fatto più rugoso e asciutto. Le gambe erano tanto arcuate
verso l'esterno da formare un tondo quasi leonardesco.
Due cose non erano cambiate: il sorriso perenne e gli occhi di ghiaccio.
Il sorriso però, a volte sembrava una maschera incollata malamente. Gli occhi invece, avevano
ancora una luce indecifrabile, ma, se li si osservava da vicino, vi si poteva scorgere un senso di
morte.
Venne a stare da noi, a casa mia e di Klaudia, nella stanza degli ospiti.
(Fu allora che, nonostante l'afa, andammo a trovare Zeno e iniziammo a scrivere il romanzo che
state leggendo (sempre che l'autore a cui abbiamo affidato le nostre storie sia riuscito a realizzare il
suo, e insieme nostro, progetto))
Ero in pensione da circa tre anni.
Soltanto due mesi dopo che me ne ero andato, in azienda si accorsero del mio valore. Solo la mia
assenza fu in grado di avvalorare la mia presenza. I dirigenti mi telefonarono.
"Salve, ingegner Longo" disse una voce grave. "Con la presente la vorremmo convocare nei nostri
uffici centrali lunedì primo novembre alle ore 8 e 30 per un colloquio al fine di discutere del suo
precoce pensionamento."
"Come precoce pensionamento?"
"Non è mi è dato dirle di più. Si presenti lunedì primo novembre alle 8 e 30 presso i nostri uffici
centrali. Arrivederci."
Riattaccò.
"Kluadia, tu che faresti?"
"Meglio se ti presenti."
"Ma cosa vogliono ancora? Non gli è bastato torturarmi una vita?"
"Be', pensaci con calma, manca quasi un mese."
"Hai ragione. Lascerò decidere al tempo."
***
Cara Salomè,
chissà se lassù, vicino a Dio, potrai mai leggere quanto ti scrivo?
La mia vita è iniziata a sessant’anni, quando mi sono sposato. Il resto non conta. Nemmeno tu conti
più nella mia vita.
Da quando Dio ha preso me e mia moglie Klaudia sotto la sua ala protettrice, il lavoro, le amicizie,
le passioni sono diventate secondarie: il mio unico compito era uno: renderla felice sotto il tetto
divino. Nient'altro a cui pensare.
Forse sono stato tardivo. Ho capito da vecchio come si vive. Se tu non ti fossi tolta la vita, tutto
questo non sarebbe mai successo. Di questo ti sarò sempre riconoscente.
L’amore è ciò che salva l’uomo dall’insensatezza. L’amore è l’unico motore in grado di superare gli
ostacoli della vita. L’amore incondizionato è il fine ultimo. Il resto non conta. Sono solo stupide
domande e altrettanto stupide risposte.
Far carriera? Comprarsi un’auto nuova? Vestire firmato? Farsi un lifting? Inutili surrogati.
Luigi l’aveva capito prima di me, e anche tu. Voi però non avete conosciuto il vero amore.
L’importanza di condividere la mera quotidianità sotto la luce di Dio. In voi è sempre bruciata la
fiamma dell’irrequietezza.
Con Klaudia ho scoperto che se la vita è semplice, è anche vera. È sbagliato dare spazio al
desiderio. La felicità sta in un sereno accontentarsi. Solo donandoci all’altro possiamo guadagnare.
Nell’assenza di scopi ho riscoperto il vero obbiettivo: la pace interiore.
Addio,
Giovanni Piotre detto Longo
Y
Era un pomeriggio come altri. Tirava un insignificante vento da oriente.
Eravamo in pochi. Io, mia moglie Klaudia e Zeno. Dietro di noi Joana e la commessa di un
calzaturificio. Al loro fianco Jesus e sua moglie, senza i bambini. Dietro ancora alcuni vecchi. In
fondo alla chiesa, in piedi, appoggiato con una spalla a una colonna di marmo, c'era anche l'autore,
il Tamanini, o Tama, come lo chiamava Luigi.
Fu triste come doveva essere. Piansi a più riprese. Così anche Joana. Ci consolammo a vicenda per
tutto il tempo, mentre Zeno resisteva stoicamente alle emozioni. Lo costrinsi a salire sul palco e
leggere il vero capitolo finale del romanzo di Luigi.
ILLUMINAZIONE
nus eht semoc ereh
Passarono mesi e mesi prima che capissi che nella mia vita non c’era niente di sbagliato. Ero vivo.
Ero io. Basta col guardare al passato, e soffrire. Basta col guardare al futuro, e sperare.
Presi coscienza dell’unità del tutto. Riscoprii la gioia e la bellezza del vivere.
Mi resi conto dell’esistenza e dell’assenza di ogni cosa: per esempio del tempo infinito e
dell’infinitesimo istante, della mancanza e della presenza, allo stesso tempo, di una coordinata
temporale, e dell’assurdità della dipendenza da un concetto vecchio come quello del tempo.
Se qualcuno m’avesse sentito blaterare a quel modo mi avrebbe creduto pazzo.
E invece tutto mi fu chiaro senza che lo avessi pensato. Non saprei dire se avvenne
estemporaneamente o fu in realtà un processo lungo e sofferto. So solo che la serenità mi pervase
tutto, fin dentro le lische.
Non avevano importanza compagnia e solitudine, il movimento e la sua assenza, facoltà visiva e
cecità: di chiaro e limpido c’era solo il mio stato di non-sofferenza. Mi sentivo illuminato da una
luce interiore.
Mi accorsi solo allora che tutta la mia vita era stata condizionata dal più stupido dei sentimenti: la
paura. E ora che non avevo più paura di uscire allo scoperto e di rischiare, non ne sentivo neanche
più il bisogno.
Messa l’anima in pace le giornate tornarono ad essere piene di gioia. La meraviglia riempiva ogni
attimo, e ogni istante coglievo la bellezza del tutto. Amavo ogni cosa come fosse l’universo intero.
Vedevo l’universalità dell’infinitesimale.
Quando di fronte alla mia sfera passavano altri pesci (veri o semplici proiezioni della mia mente,
non importava) si soffermavano a guardarmi. Sostavano chi pochi istanti, chi diverse giornate, chi
arrivava ogni giorno alla stessa ora, chi si accampava per le notti a seguire.
Al principio si accontentavano di osservarmi da lontano. Non m’importava perché lo facessero, da
diverse lune avevo smesso di chiedermi il perché delle cose. Col passare del tempo, che da un po’
solevo chiamare “coordinata temporale”, presero ad avvicinarsi e ad offrirmi sassolini colorati,
pietre luccicanti, zaffiri e diamanti, pepite d’oro. Si avvicinavano cautamente e lasciavano i loro
doni davanti alla sfera senza nemmeno cercare i miei occhi.
La sfera di giorno in giorno cominciò ad illuminarsi sempre più. Le preziose pietre che attorniavano
la mia piccola casa risplendevano di luce riflessa lanciando in ogni direzione fasci colorati,
arcobaleni spiroidali e luccichii accecanti.
Arrivavano da ogni dove. La notizia di un pesce rinchiuso in un’ampolla di cristallo dai mille colori
doveva essersi sparsa ovunque.
***
Ospitammo Joana, Jesus e relativi partner nelle nostre case. Non avevano mai preso un aereo prima.
Jesus aveva venticinque anni, una moglie, un lavoro dignitoso e due figli che l’aspettavano a Nova
Trento. Joana era esattamente come la ricordavo: una ragazzina di cinquant’anni gioiosa e piena di
vita, silenziosa e sorridente, semplice e misteriosa.
In quella settimana io e Joana trovammo qualche ora per passeggiare. Giunti al castello, mi prese il
viso tra le mani e mi offrì le sue labbra. Non capii quel gesto e rifiutai. Pianse. Non per me, pianse
per la morte di Luigi.
“Perché non gli hai mai detto che tu e Salomè vi amavate?”
“No voleva ferir su orguglio de uomo, sai?”
“Lo amavi?”
“Io sempre amo solo mulhere” disse. “Uomini per me sexo e procreazione de ninhos. Agora solo
mulhere, amore de corazon.”
Avrei voluto spiegarle che l'omosessualità è paura del diverso, come ripeteva spesso il nostro
parroco durante la messa del mattino. Invece tacqui. E l'abbracciai.
Tornammo a casa senza parlare.
Cenammo fingendo allegria. Klaudia e la compagna di Salomè avevano passato il pomeriggio a
cucinare. Jesus era stato in cima alla Vigolana con sua moglie.
Il giorno seguente partirono per Venezia, Firenze, Roma, Sicilia e Sardegna, un tour di un mese nel
bel paese.
Non scorderò mai le parole di Joana quando, poco prima di partire, mi prese in disparte.
“Ela, ne su ventisinque de ani de età, vivia todavia en Madrid, precisa operazione de sterilitade por
culpa de su padre. Padre molestator de ela. Padre viulenzia con ela. Umiliada ela de su corpo de
bambina ani de ani de ani. Ela no voleva nesuno padre de su figli, per esto operazione. Pero medico
de chirurghia dise ela: «Salomè, no se nesesita operazione de sterilitade pra te: Salomè, tu già sterile
por naturaleza de nascita, ya existe disfunzione pra tenere ninhos.» Ela sufierto multo ne su vida.
Sufierto por su padre e por su sterilidade. Solo io e tu amigo Zeno sano de estos problemas de
suferenzia. Agora tu tambien. Niuno otro conose eso.”
Furono quelle poche frasi incomprensibili ad aprirmi mondi immensi.
Piansi per molte nottate a venire.
Ripensai spesso a Luigi e Salomè. Avevano condotto una vita balorda e senza senso. Entrambi
affetti da un morbo incurabile: il passato.
Luigi aveva perso la famiglia in un istante, trovandosi solo al mondo come una pecorella smarrita
nella notte buia e sconfinata. Salomè era stata ripetutamente abusata dal padre per poi scoprire di
essere sterile: e io che continuavo a chiederle un figlio...
Per fortuna c'era Joana, il legante tra due anime in pena. Lei, cresciuta in un ambiente selvaggio,
libera di sfogare i propri istinti, aveva raggiunto la serenità d’animo, senza però riuscire a
trasmetterla a Luigi e a Salomè. Aveva trovato in lui un compagno solare e in lei un amore
profondo.
A volte penso che anche le mie sofferenze sono derivate da traumi: l'adozione, la fuga di mio padre
adottivo quand’ero bambino, l’attaccamento ossessivo di mia madre nei miei confronti…
Io, Luigi, Salomè, Joana, Teresa: siamo state anime sfortunate.
L’unico senza problemi, senza blocchi, senza traumi infantili, è Zeno, cresciuto in una famiglia
modello, suo fratello ricercatore alla Sorbona, suo padre architetto e sua madre poetessa, e dotato di
una mente che gli ha reso la vita semplice, in discesa.
Y
Seguimmo alla lettera le istruzioni di Luigi. Ci alzammo presto al mattino e ci incamminammo
verso la cima. Zeno portava il barattolo nello zaino. Io cercavo invano di seguire il suo passo svelto.
In cima Zeno estrasse il barattolo. Sollevò il tappo lentamente. Si avvicinò a me. Insieme, io con la
destra, lui con la sinistra, lo inclinammo. La cenere fu spazzata via dal vento. Richiuse il barattolo e
lo ripose nello zaino. Ci sedemmo. Nessuno dei due aveva voglia di parlare. Zeno prese una
bottiglia d’acqua, ne bevve un paio di sorsi e me la porse. Bevvi a lungo e gliela ripassai. La ripose
nuovamente nello zaino. Rimanemmo a rimirare l’orizzonte.
“È tutto merito suo se a siamo quassù. In ogni mio passo, in ogni mio respiro, c’era lui a sostenermi
e a spingermi verso l'alto” dissi osservando le guglie della Marzola in lontananza. “Viviamo nel
posto più bello del mondo, e questo è il momento più bello della mia vita.”
“Non piangere, non gradirebbe” disse Zeno sorridendo.
“Lo so” gridai scoppiando in un pianto liberatorio.
Mi rifugiai tra le sue braccia ossute.
Il sole arrossiva sopra la Valle dell'Adige colorando Trento come una pesca matura.
“Che ne dici di dormire quassù?”
“Speravo me lo chiedessi” dissi.
Scendemmo un centinaio di metri fino al bivacco. Mentre io riposavo, Zeno andò in cerca di legna
da ardere. Trovò qualche ramo di pino mugo. Lo accese nella stufa e andò a raccogliere una pentola
d’acqua. Bevemmo un tè caldo e una minestra. Mi addormentai con Zeno intento a leggere vicino al
fuoco.
Il giorno seguente piovve. Decidemmo di rimanere all’interno del bivacco di lamiera mentre fuori
impazzava la tempesta. Tuoni e fulmini per ore. Ci godemmo il tramonto bevendo una bottiglia di
grappa e fumando il tabacco che qualcuno aveva lasciato nel bivacco, senza finire nemmeno una
sigaretta in due.
Al mattino scendemmo lentamente verso il paese. Mentre il tratto più scosceso volgeva al termine,
chiesi a Zeno di poter fare un’ultima pausa.
“E così tu e Salomè eravate confidenti.”
Si fermò senza alzare lo sguardo da terra. “Fratello e sorella.”
“Davvero?"
“Era la sorella che non ho mai avuto. Lo stesso valeva per lei.”
Lo guardai.
“Che c'è?”
“So tutto" dissi. "Joana mi ha detto ogni cosa”
“Ti riferisci al loro amore segreto?”
“Sai a cosa mi riferisco. Alla cosa più sordida che possa capitare a un bambino.”
“Salomè non voleva che tu e Luigi lo sapeste.”
Presi la testa tra le mani e iniziai a piangere.
“Ha subito per anni la violenza del padre con sua madre che non aveva il coraggio di denunciarlo.
Quando compì dieci anni, lei se ne andò di casa lasciando la piccola Salomè sola con il padre!”
gridai alzando il capo.
Zeno attese che mi sfogassi.
“Violentata dal padre e abbandonata dalla madre” disse guardando al cielo.
Non c’erano parole.
Cominciò a piovere.
“Scendiamo prima che inizi il temporale” dissi.
“No, guarda!” disse mentre un tuono rimbombava nell’aria.
Seguii Zeno. C’era una piccola rientranza nella roccia. Posammo gli zaini e ci sedemmo a osservare
lo spettacolo. Il cielo si fece buio. I lampi erano vicini e il loro frastuono, quando toccavano terra,
assordante. Faceva freddo. Indossai la giacca a vento e mi appoggiai con la schiena sullo zaino per
riposare i muscoli esausti. La testa mi pesava. Tremavo.
Sentivamo i tuoni nello stesso istante in cui i fulmini illuminavano il cielo. Nell'aria si respirava
un'atmosfera irreale. Avevo freddo. Vidi Zeno appoggiare sul mio corpo supino il suo spolverino
blu. Poi chiusi gli occhi per la stanchezza.
“Giovanni, meriti di sapere tutto.” Fece una lunga pausa finché riaprii gli occhi. “Sei tu il
vincitore.”
Sapevo che mentiva per farmi felice.
“Sono tutto orecchie” dissi mentre l'acqua gocciolando dalle pareti della piccola grotta ci bagnava
gli scarponi.
“Joana sapeva che Salomè si sarebbe suicidata.”
“Cosa?” dissi incredulo aprendo gli occhi. “E non ha fatto niente per fermarla?”
“No.”
Ci guardammo in silenzio.
“Il loro amore era profondo, noi uomini non siamo abbastanza sensibili per capire. La vita di
Salomè era al capolinea, lei non sopportava più l’infinito dolore, il fardello che aveva sul cuore da
quando era bambina. Joana rispettava la sua scelta di morire.”
“Come puoi pensare una cosa simile, Zeno?”
“Noi siamo superficiali, noi non conosciamo il vero amore: noi siamo solo uomini.”
Non ero d'accordo, ma tacqui.
“Quando sono andato in Brasile a trovare Salomè, ho incontrato per la prima volta Joana. Ho
passato con lei una settimana. Luigi era nella savana e così io e lei abbiamo discusso a lungo. È una
donna forte. Incredibile. Abbiamo fatto l'amore in continuazione per esorcizzare il dolore.”
Rimasi sorpreso. Senza parole.
I tuoni non smettevano di rombare.
Non mi sentivo più così stanco, però sentivo ancora tanto freddo.
“Beato Luigi che le ha vissuto fianco a fianco per un’intera vita!” dissi per rompere il silenzio.
Vidi Zeno sorridere felice. Chissà a che pensava.
“Joana è stata la salvezza di entrambi" disse poi. "Ha sorretto Salomè finché ha potuto, dandole
tutto l’amore che una donna può dare. Ha assecondato Luigi nel suo sogno.”
"Era la loro bussola.”
Zeno sorrise. Dietro il suo viso immobile, un fulmine illuminò l'oscurità.
“E il gesto di volersi legare le tube?” dissi all’improvviso appena prima che un incredibile tuono ci
zittisse.
“Non sarebbe arrivata fino in fondo. Era solo una sfida con se stessa” disse Zeno con sicurezza.
“Hai presente quel pezzo che ho scritto fingendomi lei? Quello che parla di Madrid, dopo che era
stata in Italia? Hai notato che ho usato un tono gioviale e superficiale?”
"Certo.”
“Credo di aver capito come poteva sentirsi. Aveva il cuore distrutto e un corpo che non aveva
dimenticato gli abusi subiti. Eppure lei si comportava esattamente al contrario di come si sentiva.
Te n’eri mai accorto? Viveva in disarmonia tra la sua interiorità e la sua forma apparente: avresti
mai sospettato quello che le era successo? Lei si sforzava di essere felice, di apparire normale, non
voleva che gli altri si accorgessero che era diversa, che aveva passato un’infanzia straziante.
“Mi confidò che appena si era laureata, non trovando lavoro, era entrata in depressione e, presa
dallo sconforto, aveva pensato di rendersi sterile: così non avrebbe messo al mondo nessuno che
avrebbe sofferto come aveva sofferto lei."
“Pensa ai sensi di colpa se lo avesse fatto...” intervenni.
“Sono certo che se avesse avuto un figlio con te o con Luigi, avrebbe trovato la felicità che cercava.
A volte un figlio ti salva la vita.”
Rimasi immobile pensando al figlio che avrei voluto avere con lei.
"Ma Dio non le ha concesso nemmeno questo!" dissi prima di piangere.
Zeno guardava fisso in avanti. Forse piangeva anche lui, forse era solo pioggia.
“Sembra una storia inventata, quanto è triste e complicata”
“Purtroppo è tutto vero. Ed è finita in maniera tragica com’era iniziata.”
Non sapevo più che dire. Persino ogni pensiero che mi passava per la testa assumeva una parvenza
inutile e fuori luogo.
La pioggia aveva allagato la piccola grotta dove ci stavamo riparando, ma riprendere il cammino era
troppo pericoloso. Era quasi sera e il sentiero era scivoloso.
“Se continua così, credo che saremo costretti a passare qui la notte.”
“Spero che Klaudia non s’ingelosisca quando glielo racconterò!”
Zeno apprezzò la battuta e mi guardò.
Tremavo ancora.
Si fece buio. Non c’erano più tuoni e lampi, ma pioveva ancora.
Trascorremmo la nottata settembrina discutendo.
“Zeno, che ne pensi di Luigi?”
“Ci vuole coraggio per fare quello che ha fatto. Si è buttato nelle avventure senza mai guardare
indietro.”
Non credevo alle sue parole, però non glielo feci notare.
“Hai ragione, Luigi ha sempre seguito l’istinto, fregandosene di tutto e di tutti. Io invece ho sempre
ascoltato Teresa e i suoi consigli del cazzo. Mi sono incaponito col primo buco di culo di lavoro che
ho trovato, credendo fosse il migliore.”
“Mi sembra di sentire Luigi, baby!”
“Hai ragione, vecchiuz!”
Non c’era maniera migliore di ricordare Luigi che sorridendo.
“Credi sia morto felice?” dissi accorgendomi che il buio mi impediva di vedere il viso di Zeno.
“È morto esausto. La sua vita ne vale tre delle nostre.”
Zeno mi osservò prima di parlare ancora.
“Diceva sempre che se fosse riuscito a scrivere quel maledetto romanzo, sarebbe stato felice, ma è
morto troppo presto.
"Se pochi attimi prima di morire era felice, questo lo sa solo lui” aggiunse.
“Di certo ci ha provato” dissi. “Ci ha provato più di tutti noi.”
“Così come ci ha provato Salomè…” disse Zeno.
Il sole stava bussando a est. In alto si vedeva la cima della Vigolana illuminata dalla luce rosa
dell’aurora. Lassù, invisibile, sostava immobile una madonnina di roccia che dominava la vallata,
proteggendola. Dio era nell’aria. Lo sentivo dappertutto.
Ci alzammo inzuppati dalla pioggia e prendemmo la via del ritorno.
“L'altro ieri quando dicevo che quello era il momento più bello della mia vita, non scherzavo” dissi
negli occhi a Zeno.
“Lo pensavo anch’io.”
Camminammo in silenzio, stregati dalla natura bagnata dalla pioggia della notte e illuminata dal
sole del mattino.
La discesa era ormai ultimata. Ero contento che Zeno si fosse confessato. Lo trovavo più umano.
Non lo vedevo più come un genio intoccabile, ma come un caro amico col quale trascorrere gli anni
che ci rimanevano.
“Che farai ora, Zen?”
“Perché mi chiami Zen?”
“Qualcuno deve pur farlo!” dissi.
Zeno sorrise.
“Non lo so. Sono vecchio per cercarmi un’altra moglie. Sto bene per conto mio.”
“Io non potrei vivere senza la mia Klaudia.”
“Siamo diversi.”
“Credi?” dissi.
“Io sono un solitario. Ho bisogno dei miei spazi. Ho sempre saputo che prima o poi mi sarei
separato.”
“Meglio a sessant’anni che a quaranta.”
“Che ne sai tu che ti sei sposato a sessant’anni!” disse Zeno dandomi una pacca sulla spalla. “Tu sei
ancora innamorato!”
“E tu?”
“Io?” disse Zeno scoppiando a ridere all’impazzata.
Il resto fu un delirio di grida e ghigni senza senso.
“Io non ho mai creduto all’amore!” gridava al cielo. Poi tornava a sghignazzare come un pazzo.
Lo guardavo immobile. Non era più Zeno. Un demone si era impossessato di quel vecchietto docile
e sensato. Rideva sguaiato, con una smorfia diabolica sul volto.
Fu allora che il mondo mi si rivelò tragicamente.
Capii che non esistono migliori o peggiori, la vita non è una gara a chi è più felice.
Zeno era diverso, e per questo lontano. Solo. Luigi e Zeno erano entrambi fuggiti dalla società:
l'uno criticando apertamente il genere umano, l'altro rimanendo in silenzio. Forse covando un odio
segreto, divenuto inadeguatezza. Nessuno può essere un'isola, neanche un genio come Zeno.
Lo guardai ridere come un disperato, mentre le foglie bagnate dei faggi, sospinte dal vento
dell’addio, cadevano a terra inesorabili, umili pagine scure, a segnare la ciclicità di una stagione
giunta al capolinea.
Zeno si piegò in avanti per riprendere fiato senza smettere di ridere.
All'improvviso cadde: cadde come corpo morto cade.
“Infarto, senza dubbio infarto” mi disse l’infermiere del 118 mentre gli copriva il volto con un
lenzuolo bianco immacolato. “Il cuore ha ceduto.”
Y
“Calmati... Sono qui. Guardami... Apri gli occhi. Eccomi... Mi vedi? Sono io, Zeno.
“Tranquillo, non ti abbandono. Ti tengo la mano. La senti la mia mano? Eccola... Guarda, guarda la
mia mano...
“Sono qua... Giovanni, sono qui vicino a te... Mi senti?”
Sentii un brivido lungo la schiena. Aprii gli occhi lentamente. La pioggia fuori cadeva pesante. La
sentivo nell'oscurità. Girai lo sguardo verso la persona che stava al mio fianco, ma era troppo buio
per vedere qualcosa.
“Chi sei? E l'elicottero? Era per me? Cosa...”
La mia testa ricadde esausta contro qualcosa di soffice. Forse il retro di uno zaino.
Quando riaprii gli occhi, il riflesso del sole su una pozzanghera mi accecò. Ero solo. Raccolsi un po'
di forza e mi sedetti. Aspettai. Tremavo.
Zeno sbucò da un lato e mi porse una manciata di lamponi e fragoline di bosco. Le masticai una a
una, lentamente, in silenzio.
“Ho pensato che eri morto.”
Mi guardò sorridendo. “Che io fossi morto?” disse.
“Quanto ho dormito?”
“Direi... all'incirca ventidue ore.”
“Eh?” dissi invitandolo a parlare.
“Credo tu abbia avuto diverse allucinazioni. La fronte ti scottava. Deliravi” disse facendo una
pausa. “Comunque l'elicottero c'era veramente, ma è solo passato, non era per te.”
“Sono distrutto.”
“Non stento a crederlo” disse aiutandomi ad alzarmi. “Ce la fai ad arrivare fin laggiù?”
Indicò il crocifisso in basso dove terminava la strada bianca che portava a Vigolo.
“Ci provo” dissi riluttante.
“Dai, vieni.” Si mise uno zaino sulla schiena e uno davanti. “Però non correre, sono vecchio!”
Abbozzai un sorriso. “Grazie, Zeno.”
Mi prese sotto la spalla e insieme ci avviammo verso valle.
Al crocifisso Klaudia ci aspettava genuflessa in atto di preghiera.
Y
Venne finalmente il gran giorno. La morte di Luigi, le confessioni di Joana e la lunga malattia che
ne seguì, erano ancora pesanti nel corpo e nella mente.
"Buongiorno."
"Buongiorno, ingegner Longo" dissero a turno i presenti in giacca e cravatta. "Vuole un bicchier
d'acqua o preferisce un tè, un caffè?"
"Niente."
"Beni" disse il più grosso di quelli sconosciuti. "Veniamo subito ai punti, cari miei Longo."
Solo allora capii chi era. Erano passati più di vent'anni dall'ultima volta che ci eravamo visti.
"Sarebbe ora" dissi rivolto a un altro, non degnandolo della minima attenzione.
"Lasci fare a me, sior Alex" disse uno facendo segno che era tutto a posto. Poi mi guardò da vicino
con occhi grandi e felici. "Dunque, sior Longo, lei si è sempre comportato nella maniera più corretta
ed encomiabile durante l'intero arco di tempo in cui ha militato..."
"Venga al sodo, c'è mia moglie chi mi aspetta in macchina."
"Sì, dunque..." disse il più pelato di tutti avvolgendomi col suo alito di caffè e sigaretta. "Quello che
vorremmo proporle sarebbe di tornare a lavorare..."
"Figurarsi!" dissi alzandomi dalla sedia di pelle nera che puzzava di nuovo da far schifo. "Io,
signori, ho compiuto settant’anni già da qualche mese, non avete nessun diritto di..."
"Aspetti, Longo" disse Alex da dietro. "Tu calmi. Tu torni a sedere te."
Allora gli altri mi si fecero ancor più vicini e accomodanti. "Forse non ha capito, dottor Longo. C'è
un equivoco di fondo."
Mi guardò. Aveva la fronte imperlata di sudore. Mi indicò la sedia. Tornai a sedermi.
"Nell'ultimo mese abbiamo fuso terzo e quarto piano, ovvero abbiamo reso, com'era in origine, il
terzo piano un garage e quindi spostato tutti quelli del terzo al quarto, il che, come lei potrà
immaginare, si è dimostrato un disastro."
Sorridevano tutti. Uno di loro addirittura mi faceva l'occhiolino.
"Ora, abbiamo individuato nella sua persona, l'unico in grado di organizzare un'adeguata logistica
per l'intero quarto piano, in modo da sedare gli animi scontenti e far funzionare il tutto. Negli ultimi
due mesi siamo stati tartassati dagli scioperi e dalle minacce di licenziamento di molti dipendenti
che si sono visti affiancare da semianalfabeti pregni di sudore, be', probabilmente lei lo saprà
meglio di noi."
"Signori, ho il piacere di comunicarvi che non me ne frega un bel niente dei vostri problemi. Vi
saluto" dissi alzandomi per la seconda volta.
"Non le abbiamo ancora parlato del suo nuovo contratto."
Rimasi un attimo in silenzio.
"C'è una cosa che non mi torna" dissi, "perché se avevate tanta urgenza, mi avete fissato un
colloquio soltanto ora e non un mese fa?"
"Be', veramente speravamo che la cosa scemasse."
"Inoltre" intervenne uno mingherlino con gli occhiali minimali, "volevamo essere sicuri che il
problema sussistesse realmente prima di disturbarla e farle riorganizzare la propria vita..."
"Ah, ho capito: sono l'ultima spiaggia! L'uomo dei miracoli! Quello da chiamare quando non c'è più
niente da fare, quando sta andando tutto a rotoli. Qualcuno che interpreti il ruolo di colpevole... be',
grazie tante, la mia risposta è no. Arrivederci."
Afferrai la maniglia e feci per uscire.
"Tu non capisci, cari miei Longo" udii dire ad Alex alle mie spalle. "Le nostre proposte sono di dare
te i settimi di livelli."
Mi immobilizzai. Restai pietrificato con la maniglia in mano. Poi iniziarono a cedermi le gambe. A
quel punto, non sapendo più che fare, avanzai a stento e chiusi la porta dietro di me. Di fronte,
sull'altro lato del corridoio, c'era un bagno. Entrai. Passai di fronte a specchio e lavandino e mi
trovai davanti tre porte. Entrai nel bagno centrale, mi sedetti sull'asse senza togliermi i pantaloni,
presi la testa tra le mani e iniziai a piangere perdendo la cognizione di tempo e luogo.
Y
La morte di Zeno, quella vera, se una morte può esserlo, arrivò soltanto qualche mese dopo la
scomparsa di Luigi.
Morì in uno stupido letto d'ospedale.
Solo come un verme.
I suoi figlioli sparsi in giro per il mondo, passarono uno alla volta a trovarlo. Gli dedicarono chi un
paio d'ore, chi un'intera nottata, chi soltanto pochi minuti. Poi ripartirono adducendo tutti
improcrastinabili impegni di lavoro.
Maria, la sua ex-moglie, un giorno venne a salutarlo. Non si vedevano da anni. La incrociai nel
corridoio mentre se ne usciva per sempre dalla vita di Zeno.
“Maria” dissi.
Quasi si spaventò vedendomi.
“Ciao, Giovanni. Come butta?”
Aveva superato i sessanta, ma si atteggiava a quarantenne in carriera. Tacchi compresi.
“Butta piuttosto bene. È a Zeno che non butta granché” dissi.
Ondeggiò la testa abbronzata e fece una smorfia poco comprensibile.
“Non mi chiedi come sto?”
Nemmeno una ruga in quella faccia crudele.
“Come stai?”
“Mio marito è appena stato invitato a una serie di concerti itineranti. Ce ne andremo in giro per il
mondo: cene, gala, resort, spa..." disse facendomi l'occhiolino, chissà poi perché. "Non sto più nella
pelle!”
Avrei voluto risponderle con una battuta sulla chirurgia estetica, ma mi trattenni.
“Io torno da Zeno. Addio, Maria.”
Mi baciò per cinque volte sulle guance. “Magari lo chiamo, un giorno o l'altro.” Se ne andò
lasciandomi nelle orecchie l'eco dei suoi passi che rimbombavano nel corridoio deserto. Non era la
stessa persona che mi consolava a Brighton trent’anni prima, la ragazza cicciottella, gentile e
premurosa che conoscevo.
Ho sempre pensato che le persone non cambiano, che l'anima che abita i loro corpi sia immutabile.
Mi sbagliavo.
Adesso intuivo il motivo del loro divorzio. Non era la voglia di solitudine di Zeno, ma
l'incompatibilità di due anime opposte: l'una introspettiva e umile, l'altra egoista e superficiale.
Zeno morì qualche giorno dopo. Gli tenni la mano. Mi stringeva forte, quasi stesse cadendo e
avesse paura di precipitare in un abisso.
Nel suo ultimo, lungo, infinito sguardo - non ho nessun dubbio - c'era soltanto terrore. Puro terrore.
Y
Sono passati anni da quando ho perso i miei due migliori amici.
Vivo ancora felice con mia moglie Klaudia. Ogni tanto mi giro e rivedo la mia triste vita. Ho
sofferto molto prima di ritrovarmi in questo stato di gioia assoluta, ma l’importante è che ora,
dentro al mio cuore, ci sia la certezza di essere una persona in pace con se stessa: posso vivere e
morire contento.
In un certo senso, credo di aver vinto.
Non so dire se Luigi e Zeno abbiano perso: so che io ho vinto.
È quando la morte si avvicina che uno capisce.
Solo allora sai se hai vinto o perso la partita della vita.
Ho visto morire entrambi. Ho tenuto loro la mano. Ho osservato i loro occhi mentre le anime
abbandonavano i corpi.
Non potrò mai dimenticare lo sguardo terrorizzato di Zeno mentre la vita gli veniva sfilata.
Luigi invece non aveva paura. Nessun terrore nei suoi occhi. Nessun dolore. Niente di niente. Era
spento. Distrutto. Esausto. Sfinito. Aveva lottato come un leone: poteva crepare senza rimorsi e
rimpianti. Aveva vissuto tante vite, scoprendo che nessuna gli calzava come avrebbe voluto. Aveva
colto l'attimo, senza mai voltarsi.
Temeva di morire senza una risposta, ma quando è morto l'aveva trovata. In quegli attimi mi sono
reso conto che sapeva. Sapeva che non ci sono risposte terrene. Gliel'ho letto negli occhi: senza
trascendere, la vita non dà risposte. Se non hai il dono della fede, non c'è speranza. Forse l'aveva
capito negli ultimi respiri o forse lo sapeva da sempre, ma, non avendo ricevuto il dono della fede in
Dio, aveva cercato in tutti i modi di dimostrare il contrario.
Non posso essere obbiettivo. Non DEVO esserlo.
I loro occhi erano eloquenti: puro terrore in quelli di Zeno, buio in quelli di Luigi.
Uno può trarre le conclusioni che meglio crede, ma io che li ho conosciuti per una vita intera, ho il
diritto, e forse anche il dovere, di dare dei giudizi. Non posso fermarmi a delle semplici ipotesi,
altrimenti a cosa è servito scrivere questo libro? Lo scopo era di confrontare le nostre vite tanto
differenti e trarne delle conclusioni di carattere universale: paroloni che alla fine non contano
niente. Uno vive fidandosi di Dio e tutto s'illumina. Tutto il resto ha un solo nome, errori. E tanti
sinonimi: esperienze, prove, follie...
Se Luigi fosse sopravvissuto alla mia morte, avrebbe forse detto: “Ho letto negli occhi di Jo
l'inutilità del vivere: ha buttato una vita intera. Non l'ha vissuta veramente. Crede di averlo fatto, ma
è un'illusione: Jo, mi senti? sei in paradiso? Hai soltanto vissuto un illusione, baby! Dio non
esiste!”
Non sapremo mai cos'avrebbe detto, ma io ho la presunzione (perché DEVO averla, DEVO
spingermi fin qua) che Dio mi abbia prescelto per donarmi la verità: ho fede in Dio, lo amo e so che
Lui non mi può ingannare.
Spero che dall’alto Luigi e Zeno possano vedermi e sapere che il nostro romanzo è stato finalmente
pubblicato. Ho lavorato duramente per coronare il nostro grande progetto.
Spero di averlo fatto nel migliore dei modi.
Vorrei che il libro terminasse con le parole che Zeno aveva scritto di sé, in prima persona: sono
convinto che vi sia celato il mistero dei suoi occhi nel momento di spirare.
A me le cose andavano sempre per il verso giusto. Qualsiasi cosa facessi, la facevo meglio di
chiunque altro.
Forse con le donne non avevo mai avuto troppa fortuna, la timidezza mi aveva sempre bloccato, ma
per il resto nessuno mi stava dietro. Staccavo il gruppo con facilità e naturalezza.
A scuola, pur primeggiando in tutte le materie, compresa l’educazione fisica, nessuno mi aveva mai
odiato. Stregavo tutti con la mia disarmante umiltà e il mio sorriso, forse a volte un po’ falso, ma
pur sempre gentile. Gli animi si placavano, l’invidia di chi aspirava a competere con me,
magicamente spariva sul nascere.
Era semplice.
Era semplice vivere.
Era tutto così semplice.
Luigi aveva cominciato a chiamarmi Zen. Diceva che tutto ciò che mi stava attorno s’illuminava,
assorbiva la mia tranquillità, la mia pace perenne. Non lo nego, gli anni dell’università sono stati
anni gioiosi e sereni. Superavo gli ostacoli senza accorgermene. Mi dispiaceva vedere gli altri
faticare tanto per un concetto che io già avevo assimilato ancor prima che il docente finisse di
spiegarlo.
Terminata l’università i professori fecero a gara per tenermi sotto la loro ala. Io mi limitai a firmare
il contratto che mi propose il relatore della tesi di laurea. Ignorai le pompose proposte economiche
delle aziende private che mi promettevano mari e monti. Non mi interessavano i soldi, preferivo
buttarmi a capofitto nella ricerca. Cercavo una strada stimolante e a suo modo avventurosa.
Ho sempre seguito la logica professata dalla mia mente razionale, e il torrente della mia esistenza è
sempre sceso lento, verso quell’oceano chiamato morte.
Abituato a superare con agilità gli imprevisti, pensavo che se un giorno avessi trovato uno scoglio
insormontabile, sarei caduto nello sconforto, nella depressione.
Sembra facile la vita di chi ha la libertà di decidere, di chi è nato fuori dal gregge.
La vera fortuna è non avere niente da perdere, non avere scelta: seguire l’unica strada che ci ha
portato il destino.
In vita mia non ho mai fatto molte domande, avevo già le risposte. Mi muovevo lento e agile tra le
pieghe della vita. Come fossi perennemente illuminato, come se avessi già la verità.
Come se, appunto.
Come se.
FINE
Postfazione di Joana D. F.
Ho letto il romanzo di Luigi, Zeno e Giovanni appena mio figlio Jesus ha terminato di tradurlo
dall'italiano al portoghese. Avrei potuto leggerlo in lingua originale, ma volevo assaporarne ogni
parola.
Jesus è diventato uno scrittore. Insegna ancora nelle scuole, ma nel frattempo ha tradotto una
ventina di romanzi, alcuni dall'italiano, altri dall'inglese, uno dallo spagnolo. Ha scritto un romanzo
pluripremiato (vincitore del Premio Paolo Coniglio 2051 e finalista al Premio Bruxa).
Gli piace stare coi bambini e camminare.
Nonostante abbia soltanto cinquant’anni, è già due volte nonno. Viviamo insieme a Florianopolis.
Ho venduto i terreni al nord e con il ricavato abbiamo comprato una fattoria.
Jesus ha proposto all'editore italiano questa postfazione (tradotta, corretta e editata da mio figlio
stesso): avevo bisogno di schiarire le idee ai lettori. Non ho niente da dire sul romanzo in sé. L'ho
trovato sincero, e divertente (anche se è stato scritto in pochi mesi durante i quali il mio Straniero
era gravemente malato).
Ciò che non digerisco sono gli ultimi capitoli scritti da Jo (pace all'anima sua).
Mi sta bene che abbia passato la vecchiaia idolatrando Dio assieme a sua moglie Klaudia (pace
anche all'anima sua), ma non vedo perché rovinare un romanzo con dei giudizi di parte e fuorvianti.
Luigi (ancora mi pento di non essere stata al suo fianco nel momento in cui ci ha lasciato) non ha
mai avuto occhi spenti e assenti. Ho sempre visto nel suo sguardo la fiamma del lottatore, il fuoco
della vita. Jo mente. Bullshit! Luigi non si è mai arreso, figuriamoci in punto di morte! Più facile
che sia scoppiato a ridere!
E poi Zen che muore terrorizzato... non me lo vedo proprio. Sono certo che dall'alto (in tutti i sensi)
abbia guardato Jo mentre scriveva quel mucchio di stronzate e si sia messo a ridacchiare. Zen era
preparato da sempre.
Ho trovato inoltre falsa la descrizione di Maria e dei suoi figli. Passano spesso a trovarci qui a casa
e ogni volta trascorriamo momenti magici: è gente per bene.
Lasciamo perdere poi la parte metaletteraria in cui Giovanni finge che Zeno finga che esista un
narratore eccetera eccetera: che inutile stronzata!
E l'autore? Come si può credere che l'autore sia un certo Pierluigi Tamanini. Bullshit! Anche il
lettore più stupido capirebbe che si tratta di un nome fittizio: Pierluigi, guarda caso, è formato da
Pier e Luigi, ovvero rispettivamente Giovanni Piotre Longo e Luigi Alberti.
Perfino il cognome è ovvio: Tamanini si rifersice a Zen. In arabo, infatti, tamanin significa 80. Non
ridete, quello che ho appena scritto non è una faccina carnevalesca o uno smile divertente, ma il
numero arabo ottanta, cioè 8 e 0. Ci siete arrivati? L'8 rappresenta l'infinito e lo 0 il nulla, ovvero i
simboli dello zen, cioè l'arte che unisce l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo, il tutto e il
nulla, lo Yin e lo Yang...
A parte questa incongruenza tra finzione letteraria e realtà, mi sono divertita a leggere il romanzo,
soprattutto i pezzi che mi riguardano. In realtà non sono così bella. Fin da piccola, ho sempre avuto
un po' di pancia, le gambe tozze e le spalle da uomo. Lo vedrebbe anche un cieco che sono
mascolina. E poi non sono così saggia come mi ha descritto Luigi: e, a dire il vero, nemmeno così
ignorante!
Ma, come era solito ripetere il mio straniero preferito, è sempre bello romanzare.
Joana
PS: la cosa che solo io e Jesus sapevamo (e ora anche voi lettori) è che il romanzo breve di Luigi
non è finito: Luigi aveva lasciato a me il finale, promettendomi di non pubblicarlo per nessun
motivo: alla fine ho ceduto.
FELICITÀ
come fare pace con la metà ribelle del proprio io, e vivere felici
Anche se non mi sarei mai stancato di sorridere con la bocca e con il viso e con tutto il corpo, mi
sentivo vecchio e stanco. Non uscivo più dalla sfera, neanche a prendere una boccata d’acqua. Non
ne sentivo più la necessità. Coglievo da dentro, tutta la bellezza e l’unicità dell’universo.
Un giorno un vecchio pesce più coraggioso degli altri si avvicinò e chiese il permesso di parlarmi.
Risposi con un sorriso pieno di benevolenza.
«Sono qui, oh Illustrissimo, per rappresentare il resto dei fedeli…»
Attesi con pazienza che finisse di sbrodolare tutta la sviolinata che aveva studiato da giorni e giorni,
non volevo di certo mancar di rispetto.
Qualche istante dopo presi la parola.
«Ti va di entrare Haruki?» dissi sorridendo.
Il pesce sembrava non capire. Rimase titubante e ammutolito.
«Ti va di entrare in casa, Haruki?»
«Come? Ma io…»
«Vieni, ti mostro l’entrata» dissi sempre più divertito.
Precisai che non m’importava se ora lui e tutti gli altri pesci erano lì veramente o se invece non
erano che il frutto della mia fervida immaginazione.
Quel vecchio pesce mi guardava come se fossi pazzo. Io lo fissavo ridendo come un matto.
La bizzarra situazione nella quale si trovava lo mise a suo agio e cominciò a raccontarmi della sua
vita, della sua ricerca della verità, della sua sete di sapere, del suo tentativo di staccarsi dalle inutili,
a suo dire, abitudini quotidiane.
Mi parlò dei suoi viaggi, delle sue esperienze, delle sue debolezze, dei suoi errori.
Mi parlò dei suoi tanti amori e dei figli che questi amori avevano generato.
Mi parlò delle sue avventure negli oceani e dei pericoli scampati.
Mi parlò di una vita trascorsa a rincorrere qualcosa che ancora non aveva trovato.
Parlava, parlava e parlava. S’infervorava e poi si calmava. E poi parlava ancora. Parlava e parlava,
ancora e ancora.
Io finalmente ero pronto: dopo anni di totale chiusura con il mondo e, prima di tutto con me stesso,
ero felice: felice e contento di ascoltarlo.
L’avrei ascoltato per l’eternità, per tutto il tempo che era necessario, per tutti gli infiniti attimi che
avrebbe passato a parlarmi, a parlarmi del mondo sensoriale, universo del quale io mi ero
ingiustamente privato.
E così fu.
Non è mai troppo tardi.
Non è mai troppo tardi per cambiare.
Non è mai troppo tardi per ascoltarsi.
Non è mai troppo tardi per fare pace con sé stessi.
Non è mai troppo tardi.
Mai.
---FINE---
Il vero autore
Ho deciso di intervenire in prima persona – limitata – e di aprirmi definitivamente al lettore.
La prima edizione italiana, come avrete capito, è uscita senza postfazione. Quando l'editore mi ha
fatto avere l'ultima edizione con la postfazione di Joana avrei voluto strozzarlo con le mie mani. Poi
mi sono calmato. Ho riflettuto ed eccomi qui a strangolare le menzogne con mani di scrittore.
Non dovete credere a una parola di quello che ha scritto Joana: io non sono fittizio: esisto
veramente! Anzi, a dirla tutta, peso quasi 80 chili e non sono figlio di un vetraio! Joana si è
palesemente arrampicata sugli specchi con quella storia del mio cognome e dello Yin e dello Yang
– che tra l'altro non hanno niente a che vedere con lo zen... Lasciate perdere, sono tutte cazzate:
Pierluigi Tamanini esiste ed è qui, here and now, che vi scrive in carne e ossa seduto sulla sua
scrivania di faggio tarlato, in quel di Vigolo.
***
Giulio un giorno mi ha chiesto: "Chi racconta questa storia?"
Eravamo a Trento, vicino a Piazza Duomo.
"Io" ho risposto.
"Cioè?"
"Pierluigi Tamanini."
"No" disse ancora, "chi narra questa storia?"
Non sapevo cosa dire. Non volevo contraddirlo, così dissi semplicemente: "il narratore narra questa
storia."
"Appunto" disse soddisfatto con gli occhi che gli brillavano.
Ho mentito. In realtà non c'è un narratore. O, se c'è, il narratore siamo noi, cioè le mie molteplicità:
il mio io. Io, Pierluigi Tamanini, con le mie verità e le mie, più o meno consapevoli, menzogne: in
fondo quello che facciamo noi scrittori non è cercare la verità con la menzogna?
Non finirò mai di ringraziare Giulio: la sua domanda è stata fondamentale: ho capito soltanto allora
di avere un'enorme responsabilità: che lo volessi o no, io ero l'unico filtro tra il lettore e i loro
racconti orali. (Anche se in realtà prendevano spunto da un testo già scritto di loro pugno.)
Gli altri personaggi non so se esistono realmente, non posso mettere, per così dire, la mano sul
fuoco: posso però giurare su mia madre che io, Luigi, Giovanni e Zeno esistiamo.
***
È stato mio padre a parlarmi di loro.
Fu durante una cena, alcuni anni fa. Mamma aveva preparato gli gnocchi di patate al Puzzone di
Moena, lo ricordo ancora. A tavola c'eravamo io, mia sorella e i miei genitori. Nostro padre ci
raccontò che, mentre raccoglieva funghi nei boschi di Vigolo, sul versante della Marzola, aveva
sentito tre voci anziane discutere animatamente di letteratura. Non si presentò – evidentemente la
timidezza è una caratteristica ereditaria – ma li seguì quel tanto che bastò a capire che volevano
scrivere un romanzo. Sapeva bene della mia passione per la scrittura, e non ci pensò un minuto a
collegare le due cose.
In un paese di mille anime ci si conosce tutti. Eppure né mio padre né mia madre capivano chi
fossero i due vecchietti che frequentava l'ingegner Longo (così i miei chiamavano Giovanni).
Dal giorno seguente, non li lasciammo soli un attimo. Li vedevamo passare ogni giorno pieni di
scartoffie. Mia sorella Elena li spiava nel giardino di Zeno. Mia nonna Gina, che abitava di fronte
alla casa di Giovanni, faceva da vedetta. I miei raccoglievano informazioni di ogni tipo: mio padre
consultando internet giorno e notte, mia madre chiacchierando di qua e di là. L'intera famiglia
credeva nel mio progetto. Io cercavo la maniera migliore per approcciarli.
Alla fine - non starò qui a spiegare come - una sera di ottobre, io e quei tre settantenni colti e un po'
suonati, ci ritrovammo al bar dei Mòri, vicino alla chiesa, ubriachi di vino rosso, a giocare a
briscola e mangiare castagne, mentre gli altri vecchi, attorno, gridavano numeri e bestemmie.
Credetemi: se esisto io, esistono anche loro.
Intendiamoci, non credo a una sola parola di quello che mi hanno dettato nei lunghi pomeriggi
passati assieme nel giardino di Zeno. Credo però alle loro storie: credo alla loro verità quanto credo
alla mia.
Sono passati anni. Luigi, Giovanni e Zeno sono morti. Non ci sono più. Non esistono.
Non saprò mai quanto di quello che mi hanno dettato corrisponda alla realtà. Ma se anche nulla
corrispondesse, di certo era tutto vero.
***
Ho personalmente supplicato l'editore di farmi avere i recapiti di Joana e Jesus: niente da fare. Ho
cercato il sito dei premi letterari brasiliani citati nella postfazione: non esistono. Joana, o Jesus che
l'ha tradotta, o chi per loro, ha mentito.
Una volta Luigi mi mostrò un paio di foto: in una c'era lui con suo figlio mentre facevano surf;
nell'altra due donne in costume tenevano in braccio un bebè.
Dopo la scomparsa dei nostri eroi (per me lo sono e lo saranno per sempre), i miei genitori hanno
fatto delle ricerche approfondite. Per quel poco che abbiamo potuto verificare, non esistono
inesattezze: Giovanni ha veramente lavorato a Trento in una grande azienda per tutta la vita; Zeno
ha lavorato per più di un decennio come professore universitario in una università della California;
Maria, la sua ex-moglie, era nata a Mattarello, un sobborgo di Trento, e vissuta per anni a Vigolo; i
genitori di Luigi e sua sorella sono deceduti in un incidente automobilistico durante una partita
dell'Italia ai mondiali di calcio.
Abbiamo controllato a lungo, finché un giorno mia nonna Gina, prendendomi alla sprovvista, mi
disse: a che serve?
Di Joana e Jesus ho solo un vago ricordo. Li ho visti al funerale di Luigi, ma, data l'incresciosa
situazione, non ho avuto il coraggio di farmi avanti. Non saprei nemmeno dire se erano le stesse
persone della foto che mi aveva mostrato Luigi.
Sarà per sempre un mistero.
Ad ogni modo, rimango io.
E rimane la mia storia: la storia di tre storie: tre storie che ne raccontano altre: e non sapremo mai se
sono reali o inventate.
Credetemi: non ha nessuna importanza: l'unica cosa che conta è crederci.
Giovanni, in fondo, da quando aveva iniziato a credere, era felice: aveva fede in Dio. Si era affidato
totalmente a me, il suo Dio Scrittore. (Intendiamoci, rimango ancora un uomo qualunque per il resto
dell'umanità, altro che dio!)
Crederci.
Crederci e basta, non serve nient'altro.
Forse è proprio questo che intendeva Luigi per atto di fede.
gigio
I veri autori
Non credete a una parola di quanto scrive quel buffone del Tamanini: lui non esiste, non è mai
esistito. Non è lui che scrive: si tratta di uno pseudonimo. Non capiamo ancora come l'editore abbia
potuto... ma lasciamo perdere, diciamo soltanto, "il vero autore del romanzo siamo Io."
Non possiamo però rivelare (ora) la nostra identità.
Al giorno d'oggi parlare d'identità ha poco senso: non c'è letteratura all'infuori del reale. Noi
scrittori interpretiamo, da vivi, il ruolo di fantasmi. La lingua romanzesca vede dissiparsi l'effetto
dei sortilegi che essa raddoppia. La moltiplicazione delle immagini possibili di sé comporta la loro
pura e semplice scomparsa: ogni certezza dell'Io viene così a dissolversi.
Ipotizziamo di saper scrivere. Ogni personaggio dunque diviene reale. Ecco che allora il
personaggio reale (lo scrittore ovviamente, cioè Noi) finisce col chiedersi – a noi è capitato – se non
sia diventato fittizio.
Il giuoco del romanziere fa sì che la verità divenga tanto più presente, quanto meno pretenda di
esserlo: la maschera torna per mostrare la verità del volto.
Per questo Noi, prima della fine del romanzo, siamo scomparsi: ci siamo uccisi tutti (o quasi, come
vedremo a breve). È stato un sacrificio inevitabile. Solo così potevamo sopravvivere.
L'impossibile ciclicità del periodico lutto vs. desiderio inappagato vale più dell'identità di un
autore/narratore che non è altro che un fantasma innamorato della vita romanzesca.
In somma, stiamo parlando di rapporto reale-finzione inteso come verità per menzogna, cioè
attraverso l'ammissione di colpa (perché una colpa c'è sempre quando si ha a che fare con uno
scrittore) dell'impossibilità di narrare il reale col reale.
Quindi possiamo dire senza mentire, "è più vero il falso (del vero) di quanto non sia vero che è più
falso il vero (del falso)."
Per questo non abbiamo scritto una autobiografia ma, probabilmente, un romanzo dell'Io, ovvero un
romanzo del Noi.
Ecco perché abbiamo finto tutto questo tempo.
Non c'è una sola verità: siamo tanti specchi che mal riflettono la stessa luce.
********* ********
Può un romanzo terminare con una enorme menzogna e con logorroiche frasi senza senso?
Può un romanzo dirsi concluso con una serie di paragrafi sconnessi, composti da frasi
incomprensibili, con tutta probabilità scopiazzate qui e là da qualche libro preso a prestito da una
biblioteca di paese, che, peraltro, gettano pesanti ombre sull'esistenza dell'autore stesso (tanto da
farlo passare, se ho capito bene, per un uomo finto, falso, senza identità: fittizio)?
Può un romanzo finire con un capitolo superfluo, quando ormai la trama (se una trama di qualche
tipo c'è mai stata) è già morta e sepolta con tutti i suoi protagonisti?
Può un romanzo?
Un romanzo può tutto.
Ma, per accontentare i più esigenti, questo romanzo terminerà con un tema di quarta elementare che
il Tamanini, firmandosi col precoce pseudonimo Gianni Longhi, dedicò a sua sorella: nessuno si
azzarderà a contestare l'innocenza di un bambino.
23-10-86
Parlo di una persona.
La sorellina Elena ha sette anni. Gioca con me con il lego. È alta circa un metro e venticinque, non
è molto magra, ha i capelli biondi e un po' lunghi, ha gli occhi color verde scuro, ha delle guance
molto grosse e una bocca piccola, però che parla molto. Le piace vestirsi con una gonna a pieghe
verde e una maglia blu. È studiosa e generosa però certe volte è egoista perché vuole che le porto il
bicchiere. Le piace molto guardare la televisione. Un giorno i miei genitori decisero di andare in
"Casarotta" sulla Vigolana. Partimmo, nell'andare c'erano molti funghi belli e freschi, ma non li
prendemmo perché non sapevamo dove metterli. Arrivati, mia sorella era molto stanca. Ma
partimmo subito per la cima. Elena cadde una volta perché s'inciampò, dopo tanta fatica arrivammo
alla croce. Facemmo molte fotografie. Elena era molto stanca. Ci incamminammo per ritornare
verso la "Casarotta". Elena si fece ancora male, al rifugio prendemmo l'alcol e la disinfettammo. Poi
giocammo a carte. Verso le cinque ci incamminammo verso casa. Questa giornata fu una delle
giornate più belle della mia vita.
Gianni Longhi
Salomè
E va bene, lo ammetto.
Non mi sono tolta la vita. Era un piano di Luis.
Per non morire, avrei dovuto rinascere, e quindi, secondo lui, fare un atto magico: ricominciare una
nuova vita.
"Ma è quello che ho fatto venendo qui in Brasile" gli risposi sulle prime.
"Datti una seconda possibilità: la meriti" disse prendendomi dolcemente la mano. "A me è servita.
Non sarei qui con te e Joana altrimenti, ma qualche metro sottoterra."
Mi vidi per un attimo soffocata, immobilizzata, schiacciata: sommersa da una terra marrone,
granulare, pesantissima.
"Hai ragione, Luis" dissi. "Che devo fare?"
"Sparire" disse. "Per sempre."
Era l'unico in grado di capire.
Considero Joana, Zeno e Jo la mia vera famiglia, e ovviamente anche il piccolo Jesus – ai miei
occhi è rimasto ancora un ragazzino. Mi hanno sorretta, in modi diversi, per tutta la vita, senza mai
mancare. Ma è Luis che mi ha capito fino in fondo.
Con capire non intendo solo esprimere a parole ciò che provavo: Luis mi capiva con il corpo, con
l'anima, con l'energia che ci legava.
Starete pensando che sono crudele e vile e stronza. Fingersi morti è un gesto probabilmente
peggiore che ammazzarsi sul serio.
Eppure mi ha salvato: per ricominciare avevo bisogno urgentemente di una nuova identità.
Sembra tutto un gioco, ma se non avessi giocato, ora sarei morta. Luis mi ha salvata.
Non ho mai conosciuto nessuno come lui. Nessun altro era in grado di leggere negli occhi della
gente. Sapeva sempre cosa pensavamo. Forse un'empatia coltivata negli anni, forse un talento
innato.
Da sempre sapeva che tra me e Joana sarebbe nato l'amore. Mi sono troppo divertita a scrivere (o
meglio, a dettare) la scena in cui Jo rivela a Luis che io e Joana ci amavamo... e Luis che fingeva di
non saperne niente... troppo forte! Era un maestro anche nella finzione.
Non gli ho mai parlato di mio padre, di mia madre, della mia sterilità. Sapeva già tutto.
A ucciderlo non fu tanto la consapevolezza che non avrebbe mai trovato ciò che cercava, ma la
certezza dell'assenza di un disegno divino. (Scrivo divino in corsivo perché, come sappiamo, non
amava tirare in ballo dio.)
È anche per lui che ho deciso di scrivere questo libro. Volevo che tutti sapessero. Conoscere ciò che
abbiamo passato può aiutare altre persone. Per questo lascio al mondo le nostre memorie. Ho
cercato di essere più fedele possibile alla realtà. È evidente che non ho assistito a molte delle scene
narrate, ma, conoscendo i personaggi, sono certa di non esserci andata tanto lontana. Dalla verità.
Spesso l'ho buttata anche sul ridere, spero si sia compresa l'ironia. In somma, questa è la mia
versione dei fatti e, per quanto possa sembrare – me ne rendo conto – bizzarra ed esagerata, è ciò
che di meglio ho potuto fare per imitare la realtà. Qualcuno si starà chiedendo se ciò che ho passato
nell'infanzia e tutto il resto è vero... be', ahimè, non c'è verità più vera.
L'ultima volta che lo vidi fu a Kathmandu.
Prima che io scomparissi, ci promettemmo di scriverci una mail ogni tre mesi.
Immagino che per lui non sia stato facile mantenere questo segreto per tutta la vita. Sapeva che
Joana mi amava, che Jesus avrebbe faticato a dimenticarmi, che Jo e Zeno avevano bisogno di me.
Eppure ha resistito. In silenzio. Stoicamente. Recitando una parte per tutta la vita, fingendo di non
sapere la verità, cancellando il passato e riscrivendolo nella propria testa.
Dopo sei mesi che non ricevevo mail da Luis, ero certa fosse morto, e me ne feci una ragione. Avrei
tanto voluto tornare in Brasile da Joana e Jesus, tornare a vivere con loro. Non potevo, avrei
rovinato tutto.
Per questo mi sono decisa solo ora a dettare questo libro. Ho aspettato che Joana e Jesus, pace
all'anima loro, passassero a miglior vita.
Chi vi parla ha superato da otto anni i cento, tanto per capirci. Portati alla grande, però! ^___^
Lo rividi un'ultima volta a Kathmandu, più o meno mezzo secolo fa.
Non ricevevo segni di vita da quasi nove mesi, quando – e per poco non mi venne un infarto –
arrivò una mail con oggetto Scusami, ci sono ancora! Mi raccontava brevemente di essere tornato in
Nepal per cercare la fonte dell'eterna giovinezza. La sua scrittura era insolitamente stanca,
trascinata e piena di errori. Eppure non appena lessi Devi raggiungermi al più presto dovunque tu
sia!, presi il primo volo *** ***** - Kathmandu. Non eravamo distanti.
"…"
"…"
Queste furono le prime parole che ci scambiammo.
Piangemmo semplicemente. In silenzio.
Non ci vedevamo da circa sette anni.
Ci spogliammo senza dire niente e facemmo l'amore.
Avevamo entrambi sessantaquattro anni.
"Sembri ancora una ragazzina" disse il mattino seguente, alle prime luci dell'alba.
"Sarà che da morti non si invecchia più."
Sorrise debolmente.
"Non sono più guarito. Speravo di trovare nuova linfa, nel posto in cui mi è stata prosciugata.
Invece ho trovato te, e la mia anima è tornata bambina, ma il mio corpo è ormai pronto."
"In cosa vorresti reincarnarti stavolta?"
Ci pensò un po'. "In un messia" disse con gli occhi azzurro chiaro che luccicavano. "Vorrei fondare
una nuova religione."
"Tu?" dissi scoppiando a ridere. "Ma se non hai mai creduto nemmeno a te stesso!"
A quel punto, finalmente Luis sorrise.
È così che lo ricordo: vecchio e sorridente, stanco e felice. Pronto a vivere un'altra vita, come lo
sono io ora.
Non credo sarà difficile reincarnarmi in una nuova anima: in una sola vita ho cambiato identità un
migliaio di volte.
Luis sapeva anche questo.
Quella volta a Kathmandu mi disse: "Delle infinite maschere che portiamo ogni giorno, ne rimarrà
una: solo allora, muovendo ripetutamente su e giù la mascella, sorridendo, faremo cadere anche
quella: ed ecco finalmente l'ultima vita, quella vera, quella illuminata.
"Fino a quel momento, non ci rimane che continuare a sorridere."
Addio,
Salomè.
P.S.: comunque il romanzo non l'ho scritto proprio io (sono troppo vecchia). L'abbiamo scritto NOI:
io e il Tamanini – ebbene sì, Pierluigi Tamanini esiste davvero: è il mio giovane scribacchino o
ghost-writer, come ama definirsi.
P.P.S.: adesso è davvero tardi: NOI – il Dio che racchiude il tutto – stacchiamo la spina: bruciamo
per sempre questa matrioska di medie dimensioni, e tutte le infinite matrioska in essa contenute.
GAME
OVER
L'ULTIMA MENZOGNA
Le pareti sono ruvide e scure, di un blu marcio, consumato dall'umidità. Il pavimento, tre passi per
sette, è composto da seicentododici piastrelle rettangolari color Van Gogh. Il soffitto è alto come un
canestro da basket e, negli anni, ha cominciato a scrostarsi sempre più. Tutto ciò che cade lo butto
nel buco. Non ho mai perso niente nel buco perché non ho niente da perdere. Ogni mattina ci defeco
e ogni tanto piscio. Sopra il buco, a un palmo dal soffitto, c'è un tubo dal quale, girando una
maniglia posta sulla parete, a mezza altezza, è possibile far uscire dell'acqua. Di fronte alla doccia,
sulla parete opposta, c'è, a contatto col soffitto, una finestra rettangolare – la finestra – con base tre
passi circa e altezza una spanna. Il vetro è infrangibile, ve lo posso assicurare, e opaco: nulla si è
mai mosso aldilà. Non ci sono altre fonti di luce. Sotto la finestra c'è un materasso. Sono certo che,
nonostante non senta niente, puzza da far schifo. A fianco ci sono due coperte. Le uso quando fa
freddo. Più a destra, nell'angolo, c'è una scrivania di legno, forse in larice, con una sedia dello stesso
materiale. Sono entrambi datati, ma piuttosto comodi. Sotto alla sedia c'è una scatola in cartone con
dentro ottocentotrentuno matite – al principio erano esattamente mille – e quattro temperamatite.
Sulla scrivania stanno il quinto temperamatite e il manoscritto che ho appena terminato di scrivere.
Sulla sedia ci sono io. Nudo con i capelli e la barba infiniti. Sto scrivendo su un foglio posto in cima
al manoscritto con una matita corta e appuntita che profuma di legno. Dietro di me, sulla parete
opposta – la stessa parete della doccia, ma a quasi sette passi dal buco – c'è la carta. All'inizio erano
ventiquattro. Ventiquattro plichi, uno sopra l'altro, da cinquecento fogli ciascuno, ottanta grammi al
metro quadro, colore bianco, A4, marca Tamanini Copy Paper, MADE IN VIGOLO (TN) ITALY. Ho riempito quasi quattromila fogli fronte e retro con ventisei lettere dell'alfabeto, dieci
cifre, qualche misero segno d'interpunzione e due o tre simboli. Sette plichi e quattrocentotrentotto
fogli dell'ottavo per le varie stesure, tra cui quella definitiva. Ho ancora carta per altri due romanzi,
se le cose andassero male...
Mi chiamavo Gianni Longhi. Ho provato a cambiare nome (Luigi, Giovanni, Zeno, Salomè,
Joana...) e riempire di specchi questa stanza. Ora non so più chi sono. Finalmente.
Ho imparato a essere ordinato: i fogli usati li ripongo nell'angolo, di fianco a quelli vergini,
anch'essi impilati con massima cura. Sulla stessa parete, tra la carta e la doccia, esattamente a metà,
c'è lo sportello. È da lì che prendo il cibo. Lo sportello non è che un rettangolo in ferro nero dotato
di maniglia, saldata in orizzontale, con gli angoli smussati. Lo sportello ha le dimensioni di un
bassotto: largo mezzo passo e alto una spanna scarsa. Forse è da lì che mi hanno, in qualche
maniera, introdotto. Oppure dalla finestra. Non ne ho idea, sembrano entrambi troppo piccoli per la
mia mole. Nella stanza non ci sono altri orifizi, a parte il buco. Ogni mattino alzo la maniglia e
trovo un vassoio pieno di ogni ben di dio. Non mi lamento del cibo. È vario e sostanzioso. Mi è
capitato di mangiare pane per tre giorni e bere l'acqua della doccia, ma solitamente i pasti sono
elaborati e cucinati ottimamente. Ho mangiato di tutto, dalla pizza napoletana al cous-cous, dal riso
alla cantonese alle braciole argentine. Prima di essere rinchiuso qui ero vegano. Non mangiavo
carne, né cibi derivati dall'allevamento degli animali. Sono convinto che tutti gli esseri viventi
abbiano diritto a essere liberi. Ma, poiché io non lo sono, mi arrogo il diritto di mangiare ciò che mi
viene offerto, fosse anche carne umana.
Non so perché sono qui. Forse chi leggerà quanto ho scritto (e sto scrivendo) ne saprà più di me: io
non ne ho idea. Un mattino qualsiasi, mentre me ne stavo andando nell'azienda per la quale
lavoravo da cinque anni, qualcuno mi ha colpito al capo. L'ho capito quando mi sono risvegliato qui
con un gran mal di testa e un bernoccolo sulla nuca. Non so chi mi abbia fatto questo. Ho gridato e
pianto per settimane e riflettuto per mesi. Poi mi sono arreso: nessuno che mi conosce avrebbe
potuto farmi questo. Quindi io non conosco il mio aguzzino. O i miei aguzzini.
Ho sempre amato scrivere. Fin dalle elementari mi divertivo a inventare storie. Credo di non avere
mai avuto un vero talento. Alle medie, infatti, volevo fare il calciatore come Diego Armando
Maradona. Alle superiori il regista come Michelangelo Antonioni. Ricordo che negli anni
dell'università provai a buttarmi nella pittura a olio, poi ad acrilico. Infine mi cimentai con la
fotografia in bianco e nero. Soltanto qui ho scoperto che il mio destino è scrivere.
Jo, Zen, lo stesso Luigi (forse il vero specchio che mancava a questa stanza), Salomè, Teresa, Joana
e Jesus mi hanno fatto compagnia in questi sette lunghi anni. E con loro anche l'impalpabilità di
Maria, la divertente cantilena di Alex, l'odore degli operai dell'azienda, il rumore dell'oceano, la
visione delle onde, il seno di Teresa, il profumo della pelle di Salomè... Ho sempre considerato ogni
cosa reale. Parlavo con i miei personaggi, ci discutevo a lungo. Non ho mai seriamente considerato
la possibilità di essere diventato pazzo. Negli ultimi sette anni – ci tengo a ribadire quanto ho
resistito – ho scritto a matita un capitolo indelebile della mia vita: una vita inventata da me, a mio
piacimento. Era l'unico modo per sopravvivere alla solitudine. Rischiavo altrimenti di affogare
nell'oceano dell'incomunicabilità, come un pesciolino abbandonato a se stesso. E invece sono
ancora qua, a galleggiare cieco nella mia laida isola di cemento, in questo schifo di prigione, più
agguerrito che mai. Combattivo ma sereno. Sognatore e cronico ottimista. Non ce l'ho con nessuno.
Ho perdonato da tempo. Non si tratta della sindrome di Stoccolma o cazzate di quel tipo: sembrerà
strano, ma, nonostante tutto, mi sono divertito. È stata dura, lunga: infinita: ma adesso è tutto finito:
sono pronto a uscire. (Basta crederci, no?) A volte mi sembra davvero di essere dentro a un
romanzo. Me lo chiedo spesso ultimamente: e se anch'io, come i miei tanti amici immaginari, fossi
intrappolato in un mucchio di parole?
NOTA DELL'AUTORE
Gianni Longhi è stato rinvenuto esanime nella sua stanza della clinica psichiatrica S. a P. in B. l'1
aprile del 2011. Si è tagliato le vene della mano destra con un pezzo appuntito dello specchio che
aveva appena infranto.
Era in cura da sette anni esatti: dal primo aprile del 2004.
dott. Tamanini
Scarica