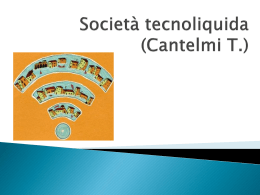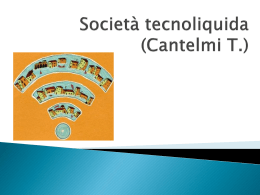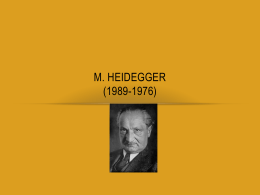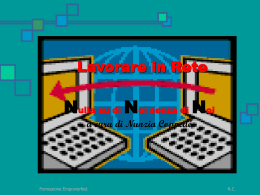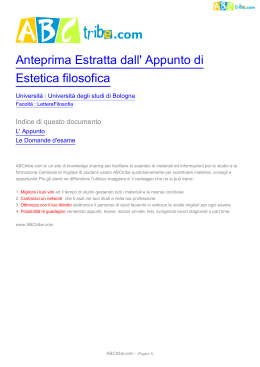MARIO ROCCATO LA FILOSOFIA DELL’ASSURDO Oltre ogni ragione 1995 - 2015 2 Non è tutta un’illusione. Caso mai, è solo un assurdo. 3 4 La parola assurdo deriva dal latino, dalla particella ab (allontanamento) e dal verbo sardare (parlare saviamente). E’ dunque assurda qualsiasi affermazione che mostri di “allontanarsi da un savio parlare”. E’ assurda qualsiasi situazione dove il contrasto tra ragionevolezza (spiegabilità, possibilità di interpretazione) e irragionevolezza (inspiegabilità, impossibilità di spiegazione) è tanto evidente da far apparire inutile, impraticabile, conturbante e persino demenziale qualsiasi tentativo di comprensione. 5 6 INDICE Premessa Prefazione CAPITOLO PRIMO l'esserci del reale e l'assurdità del nulla assoluto 1. l’immediata evidenza dell'esserci del reale 2. l'esserci del pensiero 3. l'esserci del nulla relativo 4. la paradossalità del nulla assoluto 5. l'assurdità del nulla assoluto CAPITOLO SECONDO l'assurdità dell'assurdità degli assoluti Note discorsive Appunto finale 7 8 Premessa Ho iniziato a pensare e scrivere i contenuti che seguono all’incirca quarant’anni or sono, a lunghe tappe separate, su centinaia di pagine che ho poi abbandonato, forse dimenticato. D’altra parte, pur con la mia ormai lontana laurea in filosofia, mi ritengo una sorta di dilettante. Tuttavia qualcosa di tutto questo lavoro s’è sedimentato nella mia mente ed è forse oggi “maturato” in questi appunti brevissimi. Come probabilmente accade per tutti gli scritti di sintesi, anche ciò che qui ho scritto avrebbe avuto bisogno di innumerevoli giustificazioni aggiuntive, e di doverose citazioni accademiche di autori ben migliori di me. Ma queste righe hanno avuto lo scopo semplice di ricordare a me stesso – a sommi capi - il pensiero che in esse pretenderebbe di essere racchiuso e, soprattutto, è stato scritto in modo da poter essere il più facilmente comprensibile a tutti. Al lettore che forse sarà arrivato all’ultima pagina apparirà chiaro che questa mia filosofia non ha alcuna pretesa di verità, pur pretendendo di essere filosofia, e dunque pretendendo di essere verità. Auguro a tutti le cose più belle. 9 10 Prefazione Il testo potrebbe risultare insufficiente per i filosofi, e non essere per altro di agile lettura da parte dei non addetti. Ai filosofi chiedo l’indulgenza dovuta a chi, come me, della filosofia non ha fatto un “mestiere”, ma chiedo loro anche di non sottovalutare le mie osservazioni, caso mai di discuterle; ai non addetti consiglierei di tenere sempre presente una considerazione che percorre lo scritto come motivo portante: la nostra ragione ci conduce, da sola e inevitabilmente, a sperimentare in prima persona i risultati conturbanti dell’assurdità di ogni nostro tentativo di conoscenza autentica, epistemica, e dunque dell'assurdità, anche, del nostro destino esistenziale; ne consegue la facile tentazione di gettarsi a capofitto in una totale irrazionalità; ma questa scelta eventuale si contraddice laddove una irrazionalità autentica è pur sempre razionale ribellione dinanzi alla sconfitta della razionalità stessa, correlandosi così al razionale stesso in modo inscindibile. Per contro è inevitabile chiederci come potremo davvero fidarci di una ragione che, in sé, ci conduce all’assurdo per poi non darci alcuno strumento per poterlo dominare, ricomporre: come potremo abbandonarla laddove è l’unico strumento utile per una conoscenza che pretenda il sapore della verità? Quale la soluzione? La soluzione, forse, non esiste da alcuna parte. Ma volgendo lo sguardo anche e soprattutto agli albori della nostra stessa cultura occidentale, dovremmo avere il coraggio degli antichi eroi greci che, intrepidi e presuntuosi nella guerra, dopo i banchetti usavano versare a terra l’ultimo bicchiere di vino, in onore degli dei. Dèi spesso incomprensibili nel loro fare, e certamente talmente assurdi essi stessi da interferire, senza alcuna necessità vera, nella vita, insensatamente invischiandosi nella vita; divinità talmente potenti da meritare una nostra modestia, o magari un nostro distaccato sorriso. Il testo non mancherà neppure di gettare uno sguardo a quella cultura Zen dell'Oriente antico, quello che precede ogni sua possibile contraffazione contemporanea. In quel pensiero - come in questo libretto - è stato centrale il problema del valore e dell'uso della razionalità, e una soluzione è stata suggerita nell'accettazione dell'estrema paradossalità del conoscere in sé: i Maestri di quel sapere osavano dare tutto l'affidamento possibile ad ogni minima conclusione razionale, mentre contestualmente le negavano il pur minimo valore. 11 Conclusione di queste pagine è la proposta di non permettere alla nostra ragione di far implodere se stessa dinanzi alle proprie, sostanziali contraddizioni, ma di spostare il nucleo del problema sull'assurdità del concetto stesso di assurdo. Lo vedremo. Note importanti preliminari 1. Poiché il nostro pensiero è in grado di affermare l’essere di qualsiasi cosa solo nell’ambito di una dimensione spazio-temporale, in tutto il testo il verbo essere e il verbo esserci saranno considerati sempre come sinonimi, laddove il -ci dell’essere indica sempre l’essere di una cosa "in uno spazio e in un tempo" che sono per noi, appunto, l’unico modo per noi possibile del suo essere. 2. Si noti che tutto il libro è lo svolgersi di un'indagine che, per risultare sufficientemente rigorosa al lettore esperto, avrebbe dovuto essere svolta per paragrafi progressivi dove ogni concetto sarebbe stato ben definito in sé, prima di passare all'analisi del concetto sistemico successivo. Ma questo eventuale metodo avrebbe ristretto la lettura ad un pubblico troppo limitato di lettori. Ho preferito dunque adottare uno stile più discorsivo che comporterà lo sforzo - sicuramente inevitabile da parte del filosofo - di attendere il seguito di ogni paragrafo per poter vedere una più completa esplicitazione di ogni definizione adottata. 12 CAPITOLO PRIMO L'ESSERCI DEL REALE E L'ASSURDITA' DEL NULLA ASSOLUTO 1. L’IMMEDIATA EVIDENZA DELL'ESSERCI DEL REALE C'è un modo molto comune di descrivere la nascita di un individuo: di lui si dice che sia "venuto al mondo". E in effetti tutti noi in questo mondo ci siamo venuti, tutti abbiamo fatto la nostra comparsa - un giorno - sul palcoscenico della realtà. Prima, non eravamo, e dunque alcuna cosa per noi poteva essere; poi siamo apparsi, e con noi ci sono apparse tutte le cose che, da quel momento, ci hanno circondato. Quando moriremo, per noi nulla sarà più, e la morte dunque sarà il ritorno al nostro non-esserci, al nulla di noi stessi e di ogni cosa. Consideriamo ora che il neonato non conosce ancora nulla delle cose che lo circondano: le cose sono per lui delle mere presenze, perché ancora non è in grado di identificarle, di attribuire loro un nome. Noi qui diamo un nome a questo insieme di cose che sin da subito circondano il neonato, e questo insieme lo chiameremo mondo. Daremo un nome anche a quella cosa che, prima o poi il neonato comincerà a riconoscere come "se stesso", e la chiameremo sé. 13 La somma tra il mondo e il sé la chiameremo reale. Dunque il reale è per il neonato l'esserci di tutte le "cose"1 che di volta in volta lo circondano, compresa quella "cosa tra le cose" che è se stesso. Venendo al mondo, il soggetto-pensante il mondo e il mondo-pensato si danno nel proprio esserci in una perfetta contestualità spazio-temporale. Infatti, l'esserci ipotetico del solo neonato è per noi impensabile poiché il neonato sarebbe in quel caso la sola cosa esistente, dimostrandosi così necessariamente infinita, e il nostro modo di pensare non ci concede la possibilità di pensare realmente un infinito2. Appare per altro ovvio che l'esserci del mondo senza un neonato che lo possa pensare - sarebbe insignificante dal punto di vista di qualsiasi approccio conoscitivo: un mondo senza un soggetto in grado di poterlo pensare come esistente è un mondo che non esiste per alcuno, e dunque è un mondo che potrebbe benissimo esistere, ma che sarebbe ingiudicabile sia conoscitivamente che ontologicamente3. Dal punto di vista ontologico dunque, l'esserci delle cose è necessario per l'esserci del neonato, quanto l'esserci del neonato è necessario affinché il neonato stesso possa affermare l'esserci di qualsiasi cosa. In ciò si è sin da subito stabilita un'implicazione reciproca e necessaria tra l'esserci del neonato e l'esserci delle cose che lo circondano: il mondo c'è - per il neonato - perché il neonato c'è, e il neonato c'è solo in quanto c'è un mondo che lo circonda. Poiché - prima della nascita - per il neonato il reale tutto non-era, possiamo ben dire che il reale ha iniziato per lui - in un certo momento - ad esserci; dunque, per il neonato il reale tutto è "venuto ad essere" in una sua completezza. Questo "venire ad esserci" del reale non è stato certamente deciso dal neonato, né ha potuto in qualsiasi modo essere da lui previsto4. Non essendo stato 1 Approfondiremo presto il concetto in sé di "cosa". Sul concetto di infinito si veda oltre. Ontologia è la ricerca conoscitiva attorno all'essere delle cose: cosa sono, perché ci sono, come sono correlate tra loro e con il soggetto che afferma l'esserci. Perché un qualsiasi evento può essere deciso o previsto solo da un soggetto già esistente e, banalmente, la nostra nascita non può essere stata decisa da un noi stessi che non c'era. 2 3 4 14 né deciso né previsto, il "venire ad esserci" del reale è stato per il neonato un fatto del tutto indipendente da lui. Per poter dare una definizione di questo darsi indipendente del reale, useremo il verbo accadere. "Accadere" deriva dal latino, dove era formato dal suffisso ad (verso) e càdere (cadere): accadere significa quindi "cadere verso"; una cosa "accade" quando ci si para innanzi, quando "ci cade addosso" (e dunque, in senso figurato, quando "si impone nella propria presenza", si impone da sé nel proprio esserci. Il reale ci è "caduto addosso" perché non è stato né deciso né previsto da noi: il reale ci è accaduto. Al bambino, dunque, accade di esserci come "se stesso in questo mondo".5 Il bambino è dunque testimone dell'esserci del reale. Questa testimonianza è obbligata perché il neonato non può aver autorizzato le cose ad esserci o nonesserci: le cose, per lui, quando ci sono semplicemente ci sono, e quando non ci sono, semplicemente non ci sono. Un testimone è colui che, essendo presente ad un fatto, ne può sostenere la realtà, e il neonato è in grado di sostenere l'esserci della realtà. Il reale - per il neonato - c'è, e basta, e di questo suo esserci il neonato involontariamente diventa il garante. Consideriamo che nell'accadere del reale - improvviso, imprevisto, non deciso - c'è il senso di una immediatezza. Una cosa "immediata" è non-mediata, e cioè è un fatto che non abbisogna di alcun "medium" per potersi dare: il fatto immediato si manifesta prima e al di là di qualsiasi possibile volontà e considerazione. Dunque il fatto immediato, semplicemente e precisamente, accade. Ancora e in altri termini, consideriamo che per il neonato il reale è, più o meno metaforicamente, "balzato al suo occhio". Etimologicamente una cosa ci 5 Potremmo dire che il neonato è venuto ad essere suo malgrado, ma esprimeremmo allora un giudizio morale, una non necessaria affermazione di disapprovazione per il nascere in sé; preferiamo allora dire che il neonato è venuto al mondo involontariamente e, dunque, questo mondo gli è venuto incontro da sè, non richiesto, senza altro aggiungere per il momento. Che il fatto di esserci ci piaccia o meno, come diceva Heidegger noi siamo stati "deietti" in questo mondo: siamo stati gettati qui senza che alcuno ce ne abbia chiesta l'autorizzazione, e senza alcuna possibilità di rifiuto. 15 "balza all'occhio" quando è “evidente”: la parola evidente deriva dal latino, dove significava "che si mostra da sé". Una cosa evidente è una cosa che balza all’occhio in modo a-problematico e indubitabile, poiché da sola si impone nel proprio esserci. Possiamo allora concludere che l’esserci iniziale delle cose è – per noi - la loro evidenza. L'esserci del reale si dà a noi in questa sua totale evidenza. Una cosa evidente non ha bisogno di alcuna giustificazione per essere in sé evidente: una cosa che per noi c’è, per noi semplicemente c’è, in una sua totale immediata evidenza, e qualsiasi cosa essa sia. Ho appena affermato che una cosa che per noi c’è, per noi semplicemente c’è, nella sua totale immediata evidenza e qualsiasi cosa essa sia. In merito, immaginiamo ora di essere in una stanza, dove ad un tratto affermiamo che c’è qual-cosa che vola nell’aria, un qualche-cosa che, almeno a prima vista, non sappiamo riconoscere: poiché non la riconosciamo, questa cosa è per noi una presenza qual-sia-si (e cioè, “qualunque essa sia”), una cosa non identificabile come qualitativamente differente dalle altre cose e, dunque, una cosa alla quale non sappiamo attribuire un nome. E’ importante notare che, se di questa cosa non sappiamo dire nulla, per cui non sappiamo cosa è, tuttavia sappiamo che questa cosa è (che questa cosa c'è). Solo più tardi (dopo un istante o a seguito di una attenta analisi) forse riusciremo a identificare quella cosa come un pezzo di carta, una mosca, o forse come una foglia trasportata dal vento… Per poterla identificare, avremo dovuto attribuire a quella cosa una o più qualità che a nostro giudizio le appartengono, qualità che ci consentiranno di attribuirle una identità6 appunto, che corrisponde normalmente a un suo nome. Nell’identificazione, attribuendo ad una cosa le sue qualità, descriviamo il modo del suo esserci; ri-conoscere il modo d’esserci di una cosa significa conoscere quella cosa, nel senso che l’avremo estratta dalla sua anonimia e l’avremo elevata ad essere se stessa nella propria individualità differenziante. Per contro, la cosa non-identificata non ha per noi qualità proprie, esclusive, e non dimostra quindi di avere un modo proprio di essere se stessa, La parola identità - da idem e ente - significa qualcosa che c’è (ente) ed è uguale a se stessa (idem): questo suo essere uguale a se stessa significa che è diversa dalle altre cose, per cui tramite l’identificazione io posso affermare che la cosa si differenzia qualitativamente da ogni altra, e questa identificazione mi mette in grado di poterle attribuire un nome proprio che me la fa ri-conoscere in quella sua singolare differenza. 6 16 per cui le cose non identificate sono per noi qualitativamente tutte uguali tra loro (nella loro unica, mera qualità comune di “esserci”): questa uguaglianza le rende anonime, e dunque le cose non identificate vengono sempre e solo percepite nel loro mero esserci, laddove la mera percezione non può mai aggiungere alcuna nozione conoscitiva attorno alla cosa percepita. “Percepire” deriva dal latino per (per mezzo di, tramite) e capere (prendere): nel nostro discorso la “percezione dell’esserci” di una cosa è dunque un suo “essere presa nel suo esserci". Si dà allora che qualsiasi processo realmente conoscitivo ha inizio là dove ha inizio una identificazione, e che ogni identificazione viene sempre preceduta da una percezione della cosa, nella semplice misura in cui noi non possiamo in alcun modo attribuire qualità distintive se non ad una cosa che, innanzitutto, per noi deve essere percepita nel proprio esserci7. L’identificazione di una cosa non è mai di per sé necessaria, tanto è vero che noi viviamo circondati da una grande quantità di cose che non sappiamo o non abbiamo alcuna intenzione di identificare. Nel nostro esempio della cosa che vola, la cosa potrebbe, poi, esser identificata, ma potrebbe non esserlo mai, e dunque potremmo non essere mai in grado attribuirle un nome; in questo caso, rimarrebbe una “cosa e basta”, una cosa che non ha altre qualità a parte la mera qualità di essere una cosa. E qui ci chiediamo: è necessario attribuire conoscitivamente, alla cosa nonidentificata, questa sua qualità di esserci, affinché noi si possa dire che quella cosa c’è? In realtà, questa attribuzione ad una cosa della qualità del suo mero esserci è fatto sempre posteriore e solo eventuale, perché non in sé esplicitamente necessario alla semplice percezione del suo mero esserci: per dire che “una cosa c’è”, infatti, non ho bisogno di ricercare quella qualità di “esserci” che già le è evidentemente contestuale. 7 Non è qui oggetto dello scritto approfondire i modi del conoscere, ma aggiungo solo che tra le qualità identificanti di una cosa ci sono anche quelle di avere un certo tipo di relazione con le altre cose, e quindi di essere implicata causalmente con le altre cose nella relazione reciproca tra le rispettive qualità identificanti individuali. 17 Le cose, per noi, nel loro mero esserci, semplicemente, immediatamente ed evidentemente ci-sono, prima di ogni necessità e/o volontà di attribuire ad esse la qualità di esserci. La qualità di esserci di una cosa non è eliminabile, per cui non è una qualità non-attribuibile; noi dunque non diciamo che una cosa c’è a seguito del riconoscimento/attribuzione della sua qualità di esserci, perché questa sua qualità è immediata, evidente, indiscutibile, insostituibile, indubitabile, ineliminabile e, dunque, è implicita al suo stesso essere una cosa. Per noi dunque, tautologicamente, una cosa c’è in quanto c’è: c’è in quanto è una cosa, ed è una cosa in quanto c’è. 2. L'ESSERCI DEL PENSIERO Consideriamo ora che noi le cose le possiamo guardare e toccare nella loro materialità; ma in realtà sono cose per noi anche quelle, immateriali, che ricordiamo, immaginiamo, ipotizziamo, sogniamo; non a caso, con la stessa facilità con la quale chiediamo “Cosa è quella cosa?” (di un oggetto materiale), chiediamo anche “Cosa hai sognato stanotte”? oppure “Cosa stai immaginando?” o, addirittura, “Cosa hai visto nella tua allucinazione?”. Solo nel sonno senza sogni, e molto presumibilmente nella nostra morte, per noi le cose non ci-sono, dandosi che in queste condizioni neppure noi sembriamo esistere agli occhi di noi stessi8. Per noi dunque l’esserci delle cose è la loro mera "presenza", indipendentemente da qualsiasi considerazione conoscitiva attorno al modo di questa loro presenza e dunque, in termini discorsivi del linguaggio comune, possiamo affermare che le cose, essendo tutto ciò che per noi c'è, sono tutto ciò che ci passa per la testa. 8 Come vedremo meglio più avanti, in queste condizioni non potremmo neppure dire alcunché attorno a questo non-esserci (e cioè a questo nulla) delle cose (delle cose altre da noi quanto di quella cosa che noi stessi siamo). 18 Quest'ultima affermazione ci introduce a trattare dell'esserci di quella cosa che chiamiamo "pensiero". In merito, cominciamo con l'osservare che alcune cose per noi non-ci-sono anche quando dovrebbero in realtà esserci: ad esempio, se siamo molto concentrati sulla lettura di un libro potremmo benissimo non accorgerci che qualcuno ci sta chiamando da vicino e a gran voce: in un caso come questo possiamo dire che l’esserci della voce che ci chiama – per noi – non-c’è in quanto stavamo pensando con molta esclusività ai contenuti della nostra lettura. Per fare un altro esempio, immaginiamo di “scoprire”, al mattino, che una zanzara ci ha punto sulla mano durante la notte: non abbiamo potuto sapere sin da subito, e cioè sin dal momento della puntura, della sua esistenza, perché stavamo dormendo, e dunque per noi le cose che c’erano erano esclusivamente i personaggi di nostri sogni. Per altro e ancora, se anestetizzati totalmente, per noi in quel momento l’eventuale intervento chirurgico cui siamo sottoposti non esiste: l’anestesia esclude l’esserci del dolore. Esempi come questi ci dicono che le cose, per noi, ci-sono o non-ci-sono in relazione ad una nostra particolare capacità di sostenerne o escluderne l’esserci, e questa è la nostra capacità di pensare: cose come la voce che ci chiama, la zanzara o il bisturi del chirurgo per noi ci-sono solo, e solo se, le stiamo pensando. Il pensiero dunque è – in radice - la nostra capacità di “rilevare”9 l’esserci delle cose, dove questa rilevazione è la nostra capacità di far “emergere” le cose dal loro stesso nulla. Prima della mia nascita non c’era alcun mio pensiero in grado di rilevare alcuna cosa; nascendo, abbiamo cominciato a pensare le cose che ci stavano circondando e, in questo pensarle, ne abbiamo rilevato puramente, e semplicemente, l’esserci. Osserviamo ora che nelle note importanti iniziali rilevavo che il “ci” del verbo ”essere” è l’essere di una cosa nella dimensione spazio-temporale necessaria affinché noi si possa sostenere l’essere, di quella cosa; a seguito delle ultime considerazioni aggiungo qui che questo “ci” significa anche quel “per-noi” ( per il neonato, per-me…) che ho già tante volte citato nel mio argomentare: questo per-me significa per il mio pensiero. Senza il mio pensiero alcuna cosa - per me – sarebbe, e quindi per me qualsiasi cosa è nella misura in cui può 9 Uso qui questo verbo, ma il concetto sarà presto approfondito. 19 essere da me pensata. Ciò non significa affatto che le cose non potrebbero in sé esserci senza l’esserci del mio pensiero, ma significa semplicemente che qualsiasi cosa è per-mepercepibile nel proprio esserci solo in relazione al mio pensiero che la possa rilevare appunto nel proprio, mero esserci.10 Prima dell’accadere della nostra nascita le cose per noi non c’erano, e dunque abbiamo potuto ben dire che le cose - per noi - non sono mai state da sempre, ma hanno iniziato ad esserci, sono "venute ad esserci" in un determinato momento. Parallelamente osserviamo che le cose, una volta accadute nel loro esserci – e cioè una volta che siano state pensate - non restano mai per sempre nel nostro pensiero: nella loro singolarità, per il nostro pensiero le singole cose ora ci sono, ora non ci sono. Ad esempio la matita, che ora c’è sul mio tavolo, per me ha cominciato in un certo momento ad esserci, e questo momento è corrisposto al mio aver pensato quella matita: se fossi passato dal mio tavolo senza far caso alla matita, quella matita per me non sarebbe stata. Posso aver iniziato a pensarla perché l’ho vista, o perché l’ho urtata con la mano; ma potrei anche aver pensato a questa matita pur trovandomi altrove, semplicemente immaginando l’”esserci della matita sul mio tavolo” e, allora, questa matita per me ci sarebbe stata nella forma di questo pensiero della sua immaginazione d’essere. Quando avrò smesso di pensare la mia matita, la matita cesserà per me di esistere. E anche il mio gatto, che da poco è rientrato nella mia stanza, prima di rientrare per me non (c’)era: non c’era perché non lo avevo visto o molto semplicemente non lo stavo pensando. Si potrebbe obiettare che io posso ben pensare che una cosa “continua ad esserci” anche quando non la sto pensando (fatto che accade continuamente nella nostra esperienza); ma in realtà, in questo caso quella cosa è pensata sempre e solo come “continuità del proprio esserci”, proprio e solo nel momento in cui la sto pensando in questa sua continuità: ciò significa che, per poterne pensare la continuità la devo innanzitutto pensare e dunque, quando non la sto pensando in questa sua continuità, in realtà non la sto pensando af- 10 In merito notiamo che spesso le cose si "impongono" da sé al nostro pensiero, come ad esempio un sasso che non avevo visto e nel quale inciampo: anche qui, il sasso ha per me cominciato ad esistere poiché vi sono inciampato, e questo suo inizio d'esistenza per-me corrisponde al fatto che l'ho infine pensato come cosa. 20 fatto e dunque la cosa per me non-c'è. Notiamo anche che si potrebbe obiettare che la puntura di una zanzara si dà a me nella forma del dolore cutaneo, e non nella forma del pensiero di una zanzara; ma in realtà io “so” di questa puntura quando me ne accorgo, e cioè solo quando il fastidio cutaneo attrae la mia attenzione costringendomi a pensarlo come “fastidio” per poi, magari, interpretarlo come “puntura” e, poi, magari, come “puntura di una zanzara”.11 Dunque l’esserci di una cosa – per noi – dipende dal fatto che quella cosa noi la si possa pensare, qualsiasi sia il modo in cui la pensiamo. Notiamo infine che una cosa la possiamo pensare perché sollecitati a pensarla – come nel caso della puntura della zanzara o del sasso – oppure in quanto la vogliamo pensare – come nel caso in cui decidiamo di pensare l’esserci delle zanzare, dei sassi o di quant'altro in generale, o quando decidiamo di ricordare l’esserci di una qualsiasi cosa particolare. Vi è dunque un pensiero e vi sono delle cose che sono pensate, e sorge qui una domanda: può il pensiero, in sé, essere considerato una cosa separata dalle cose-pensate? E cioè: può il pensiero esserci indipendentemente dall’esserci delle cose-pensate? In realtà, un pensiero senza cose–pensate non può essere: se anche mi sforzassi al massimo grado di non pensare ad alcuna cosa12, dovrei ammettere che infine sarei costretto a pensare a questa mia condizione di “non pensare alcuna cosa”, dove questo “non pensare alcuna cosa” è e rimane, pur sempre, un cosa-pensata. Un pensiero senza cosepensate, dunque, non può mai darsi, perché ci-sarebbe sempre e comunque 11 Sia chiaro, lo ribadisco ancora e noiosamente, che ciò non significa affatto che le cose, di per sé, non possano esserci senza un pensiero che le stia pensando: tutti noi affermiamo che le zanzare esistono anche se non mi pungono, tanto quanto affermiamo che ci sono una miriade di cose che esistono anche se non le abbiamo mai pensate o non abbiamo mai avuto la possibilità di pensarle o non avremo mai la possibilità di pensarle; il fatto è che – per noi – l’esistenza generale delle zanzare è quel “pensiero della loro esistenza generale” che ci fa dire che le zanzare esistono solo nel momento in cui pensiamo che “le zanzare esistono”: quando non stiamo pensando che le zanzare esistono, per noi le zanzare, definitivamente, non-cisono. 12 Come mi pare avvenga nell’esercizio di molte tecniche di meditazione orientale… 21 il pensiero stesso a costituirsi come cosa-pensata nel proprio modo del “non pensare le cose”. Dunque, abbiamo sin qui rilevato una duplice implicazione: se il pensiero, allora le cose e, contestualmente, se le cose, allora il pensiero. Per noi non vi sarà mai cosa senza un pensiero che la sta pensando, tanto quanto non vi sarà mai un pensiero senza almeno una cosa pensata. Pensiero e cose-pensate sono per-noi reciprocamente e necessariamente implicati tra loro. 3. L'ESSERCI DEL NULLA RELATIVO Definiamo il non-essere di una cosa come il suo nulla. Come vedremo si danno due tipi di nulla: il nulla relativo e il nulla assoluto. Iniziamo con l'esaminare il nulla relativo. Osserviamo innanzitutto che il nostro pensiero è in grado di pensare solo a cose finite: una cosa infinita occuperebbe tutto spazio pensabile, escludendo non solo l'esserci di qualsiasi altra possibile cosa, ma escludendo anche l'esserci di quella cosa che è il nostro stesso pensiero che la sta pensando. Ma le cose sono sempre finite anche in senso temporale, poiché il pensiero di una cosa eterna implicherebbe che la cosa debba essere pensata senza soluzione di continuità, escludendo la possibilità del pensiero dell'esserci di qualsiasi altra cosa, compresa quella cosa che è il nostro stesso pensiero che la sta pensando. Dunque, quando penso ad una cosa, la penso sempre per un tempo finito e in uno spazio finito; ciò significa che la cosa-pensata è pensata con un pensiero che è iniziato in un certo istante del tempo e che finirà in un altro istante 22 del tempo, e che deve sicuramente riferirsi a determinati limiti spaziali. Tutte le cose pensabili, dunque, provengono da un loro non-essere-state, si manifestano occupando una porzione di spazio circondato da altre cose, e sono destinate a non-essere-più pensate (finendo di occupare la loro porzione di spazio). Questo loro esserci è dunque correlato necessariamente con il loro nulla. Tutte le cose emergono da loro nulla e sono destinate al loro nulla; pena, il non poter essere pensate come cose, e dunque il non poter mai essere pensate. L'esserci di una cosa è dunque necessariamente implicato con il proprio nulla, dove questo esserci è relativo al proprio nulla. Contestualmente, il nulla di una cosa è relativo al suo esserci-stata perché, se mai fosse stata, non potremmo mai, neppure pensare il nulla. Essere e nulla sono reciprocamente e necessariamente implicati tra di loro. Le cose dunque appartengono ora al nulla, ora all'esserci, e viceversa, divenendo essere e divenendo nulla: questa è la realtà di ciò che diciamo essere il divenire delle cose. Parmenide aveva affermato che "L'essere è, e non può non essere". In questa affermazione si puntualizzava che il nulla, se pensato, viene necessariamente pensato nella forma del proprio esserci, del proprio essere-nulla. Parmenide, dunque, sosteneva l'impossibilità della nullificazione dell'essere. Come conseguenza tutto il divenire era classificato da Parmenide come pura illusione. Ma qui sosteniamo che non è un'illusione il pensare al non-esserci di una singola cosa: quando penso al mio gatto morto, penso al mio "gatto che non c'è più", non sto pensando al mio "gatto che, ancora vivo, ora è morto". Il gatto o è vivo, o è morto, ma un gatto vivo è una cosa, e un gatto morto è un'altra cosa, non è il ritorno all'esserci del gatto morto. Nel pensare al mio gatto morto - che è il nulla del mio gatto quando era vivo - sto quindi pensando ad una cosa diversa dal mio gatto vivo. Nella sua relatività, dunque, il nulla diventa un modo dell'essere: il gatto che aveva la qualità di "essere vivo", nel suo ritorno al nulla ha per me la qualità di "essere morto". E' vero che questa qualità - di essere morto - è da me attribuita ad un gatto che non la può più ricevere (in quanto ora il mio gatto morto non-è più); ma è una qualità comunque attribuibile perché è relativa al pensiero del mio gatto vivo che ora è il nulla di se stesso: il mio gatto morto è "il pensiero del ricordo del mio gatto vivo che, ora, è pensato come morto", e cioè è pensato come nulla di se stesso. Il suo es- 23 sere morto è una qualità che io attribuisco solo al ricordo del suo esserci stato, e dunque il suo attuale nulla è relativo al suo esserci-stato, e questo suo attuale nulla (con buona pace di Parmenide) non potrà mai essere pensato come un suo continuare ad essere vivo (continuare ad esserci). Infine, il nulla relativo di una singola cosa è relativo anche all'esserci delle altre cose: quando una qualsiasi cosa sparisce nel proprio nulla, questo suo nulla può essere pensato anche, e solo in quanto in relazione al continuare ad esserci delle altre cose: se così non fosse si darebbe una situazione di nulla di tutte le cose, compresa quella cosa che è il mio pensiero, e dunque sarebbe impossibile qualsiasi pensiero, e dunque non sarebbe pensabile neppure il nulla della cosa che è sparita nel proprio nulla. In breve, da questo punto di vista noi possiamo pensare il nulla di una cosa solo nella misura in cui il reale continua per noi ad esserci. LA PARADOSSALITA' DEL NULLA ASSOLUTO Ma si dà anche il concetto di un nulla assoluto, e cioè di un nulla senza alcuna relazione con alcun essere, laddove la parola assoluto deriva dal latino e significa "privo di vincoli, di relazione": una cosa è assoluta da qualsiasi altra quando non risente di alcuna implicazione con qualsiasi altra. Quando tentiamo di pensare, ad esempio, al nulla che ha preceduto il nostro venire al mondo, siamo spesso tentati di risolverci molto semplicemente nell'errore di immaginarci lì, completamente soli, a contemplare l'ipotetico nulla totale di tutte le cose che non ci hanno circondato prima del nostro nascere; ma in realtà prima di nascere anche noi non-eravamo, e dunque anche il nostro pensiero non-era e, senza un pensiero che possa pensare il nulla di tutte le cose altre, lo stesso nulla di tutte queste cose diventa impensabile. In realtà dunque, mentre nel nulla relativo ogni nullificazione è sempre relativa all'esserci di qualcosa, qui la nullificazione di tutto il reale non trova alcun modo di relazionarsi ad alcunché, poiché nel proprio assoluto viene a nullificarsi anche il soggetto pensante questo stesso assoluto. Il nulla assoluto, in de- 24 finitiva, per poter essere pensato, dovrebbe contraddire se stesso con l'ammettere l'essere di colui che lo possa pensare. Consideriamo inoltre che l'esserci del soggetto pensante è correlato necessariamente all'esserci del mondo (come abbiamo ben visto nel §1), per cui il nulla assoluto dovrebbe contraddire se stesso con l'ammissione della necessaria implicazione dell'esserci dello stesso mondo. Quindi per il neonato il nulla è di-venuto essere del reale, ma non sarà mai in grado di pensare autenticamente al nulla di questo reale che ha preceduto la propria nascita. Per tutta la vita, il neonato potrà pensare solo all'esserci del reale, e al nulla relativo delle cose, ma mai potrà pensare all'assoluto nulla del reale. Rimane tuttavia che noi non abbiamo davvero alcuna memoria del nostro non-essere, e dunque dobbiamo presupporre che, prima della nostra nascita, noi sicuramente eravamo il nulla assoluto di noi stessi. Negare quindi la pensabilità del pensiero del nulla assoluto si pone in contraddizione con l'evidenza di qualsiasi osservazione attorno all'effettivo esserci stato, di questo nulla assoluto pre-natale. Ne possiamo immediatamente concludere che il pensiero del nulla assoluto prima della nostra nascita non è per niente inconcepibile perché sorretto dalla assoluta nullità della memoria del nostro pensiero prenatale; ma, contestualmente, è inconcepibile perché il nulla assoluto è in sé totalmente impensabile. Il pensiero di un nulla assoluto è concepibileinconcepibile, ed è dunque un paradosso. 4. L'ASSURDITA' DEL NULLA ASSOLUTO Se sin qui abbiamo parlato di quel nulla che precede la nascita, dobbiamo considerare che lo stesso nulla assoluto ci attende anche dopo la nostra morte: in tutta ragionevolezza, con la morte noi ri-cadremo nel nulla assoluto dal quale siamo pervenuti, e torneremo dunque alla totale assenza di memoria possibile del reale e di qualsiasi possibilità futura del pensiero dell'esserci del reale. Da morti non potremo pensare di starcene lì a guardare il nostro essere-morti: il morto non sa di essere morto. 25 Così noi prima del vivere non sapevamo di non-essere, e dopo la morte non sapremo di non-essere. L'accadere della nascita è stato di per sé un fatto del tutto non-voluto tanto quanto è stato, e rimane, un fatto in sé inspiegabile, che non sa dare risposta alla domanda "Perché le cose, anziché il nulla?"13, e l'accadere della morte ripropone la stessa domanda, rovesciandola: "Perché il nulla, anziché le cose?". Nascendo abbiamo iniziato un percorso carico di domande e senza disporre di alcuna risposta autentica; morendo, concluderemo questo percorso ancora carichi di queste domande e continueremo a non disporre di alcuna risposta. Ma il nulla assoluto pre-natale non comporta normalmente il fondarsi di un vero dramma, perché è un nulla passato, superato dal vivere stesso: una volta che l'esserci delle cose si è definitivamente stabilito, tutto il divenire non fa altro che riproporci in continuazione il continuo "ricambio" dell'essere stesso, e dunque tutto il divenire è la continua promessa di un allontanamento, di una fuga dal nulla assoluto che ci ha preceduto. Noi ci comportiamo continuamente come se questo continuo avvicendamento delle cose dovesse alla fine soddisfare le nostre inevase richieste di senso, perché continuiamo ad illuderci che alla fine questo assommarsi di cose possa costruirlo, questo senso: “Finché c’è vita… c’è speranza…”. Il nostro personale esserci è l'unica cosa di cui autenticamente disponiamo, e disponendo del nostro esserci ci sentiamo parte integrante del nostro stesso divenire quanto del divenire di qualsiasi cosa, per cui il vivere in sé si risolve infine nella semplice accettazione della apparente necessità di questo continuo divenire. E' un'accettazione obbligata, poiché non ammette alcuna alternativa se non il suicidio, ed è un'accettazione che si colora continuamente dell'alienazione del problema autentico del senso14 in sé dell'esserci, laddove l'accettazione del divenire diventa per noi il senso stesso del vivere, pur senza alcuna plausibile spiegazione razionale a questa ipotetica sensatezza. In definitiva, noi amiamo la vita perché finiamo col con- 13 E', questa domanda, la domanda radicale di ogni serio filosofare laddove la filosofia è, alla radice, la ricerca ontologica attorno all'esserci del reale. Il senso dell'essere indica qui la sua "direzione": un accadimento "ha senso", per noi, quando è spiegabile ciò che lo ha provocato ed è spiegabile, infine, ciò che provocherà nella concatenazione degli eventi; il senso finale delle cose - del reale - riguarda in prima persona la Filosofia: "Che spiegazione posso dare all'essere accadute delle cose, e al loro attuale accadere in funzione della loro destinazione ad un totale non-essere futuro?". 14 26 siderare il suo divenire come senso in sé, autentico dell'unica cosa che davvero possediamo, che la vita stessa. In una parola, noi viviamo perché siamo vivi, e teniamo alla vita perché non disponiamo di alcuna alternativa al di là della vita. Ma v'è da approfondire, perché è altrettanto vero che noi teniamo a sopravvivere perché temiamo, sopra ogni cosa, il nulla assoluto della morte. E' dinanzi all'assoluto nulla della morte che il pensiero cade in un profondo, autentico turbamento. Il nulla assoluto pre-natale è cosa passata, è il pericolo scongiurato, scongiurato dal fatto in sé del vivere; il nulla assoluto della morte, invece, è la promessa di una cosa che dovrà ancora accadere: mentre dal nulla prenatale noi possiamo dire di essere sfuggiti, di averlo scampato, non possiamo assolutamente fuggire dalla promessa del nulla finale e assoluto della morte. Nella prospettiva del nostro destino di morte il senso in sé dell'esserci naufraga in un abisso che, se pensato davvero, potrebbe condurci ad una pazzia, perché l'esserci è l'unica cosa di cui disponiamo, e questa cosa è destinata al silenzio più totale, alla sparizione senza alcun spiraglio di alternativa e senza il beneficio eventuale di alcuna possibile, ragionevole spiegazione. Come già anticipato in testa a questo libro, la parola assurdo deriva dal latino, dalla particella ab (allontanamento) e dal verbo sardare (parlare saviamente). E’ dunque assurda qualsiasi affermazione che mostri di “allontanarsi da un savio parlare”. E’ assurda qualsiasi situazione dove il contrasto tra ragionevolezza (spiegabilità, possibilità di interpretazione) e irragionevolezza (inspiegabilità, impossibilità di spiegazione) è tanto evidente da far apparire inutile, impraticabile, conturbante e persino demenziale qualsiasi tentativo di comprensione. Il paradosso di fronte alla quale il pensiero del nulla assoluto della morte deve piegarsi provoca una vera implosione della ragione. Il paradosso qui diventa assurdità tragica perché non si riferisce ad una qualche "curiosità" conoscitiva, ad una aporia che possiamo tranquillamente dimenticare: qui l'assurdità conduce la mente a dover ammettere non una sconfitta qualsiasi, ma la propria totale, e insensata impotenza. L’idea che, con la morte, non saremo più neppure in grado di “accorgerci” del precipizio del nulla nel quale cadremo, che non potremo più sapere alcunché neppure del nulla che avrà sovrastato l’essere avvolgendoci definitivamente, ci risulta dunque del tutto estranea, assurda perché emerge in tutta la sua irragionevolezza: siamo destinati a qualco- 27 sa che non sappiamo neppure pensare! Tutti noi proveniamo da un nulla prenatale che, già da solo, esclude qualsiasi ragionevole spiegazione al proprio essersi trasformato nell’esserci delle cose e di noi stessi, escludendo quindi una qualsiasi soluzione al problema filosofico iniziale, e siamo destinati senza spiegazione, senza motivo ragionevole a dover ri-precipitare in quel buio così totale da annullare persino il buio stesso che lo conforma. La morte, in questo, credo possa essere paragonata al teorico penetrare in uno dei Buchi Neri dell’Universo: lì non sapremmo più, neppure, di essere risucchiati perché lì verrebbero risucchiati (e dunque annullati) sia il tempo quanto lo spazio. L’idea di un buco nero è per noi irragionevole, perché senza uno spazio e senza un tempo la nostra mente non è in grado di pensare alcunché, neppure se stessa. A questo punto ci chiediamo se non dovremmo forse dare ascolto agli Stoici, quando ci indicavano come perfetta ovvietà che, quando saremo morti, sarà morta con noi ogni preoccupazione per la morte stessa. Se fossimo d’accordo con loro il problema della morte sarebbe rovesciato, e non dovrebbe in sé neppure porsi proprio in forza del fatto che “il morto non sa di essere morto”. Ma in realtà ciò che ci angoscia non è il morire in sè, che giustamente annullerebbe stoicamente qualsiasi possibilità della stessa angoscia, ma è l’impensabilità in sé – da vivi - dello stato di morte. Non è il non-esserci che ci terrorizza, ma la sua impensabile irragionevolezza: la sua assurdità. Anzi, contrariamente a quanto predicato dagli stoici, questa angoscia può essere riassunta nell’idea suggerita dal pensiero che “Il morto non sa di essere morto”: l’idea che, morendo, non potrò più neppure sapere di essere morto comporta l’idea di una perdita totale di controllo sul reale. Il nulla assoluto della morte ci terrorizza perché è, infine, il nulla dello stesso nulla. Che ogni nostro affanno e prospettiva debba ricadere in questo vuoto totale è fatto che la ragione non può spiegare se non come l'accadere di una inspiegabile follia. Siamo destinati all'assurdo, e dunque siamo destinati ad una follia della ragione. 28 CAPITOLO SECONDO L’ASSURDITA’ DELL'ASSURDO 5. L'esperienza dell'assurdo Immaginiamo di essere ciechi, e di avere al nostro fianco un cane-guida; immaginiamo che questa cecità sia la nostra radicale ignoranza attorno al senso del reale, e che il cane-guida sia la nostra ragione. Nella quotidianità il cane ci conduce attraverso gli ostacoli del cammino, conosce i luoghi, interpreta gli accadimenti per condurci alle nostre mete. Ma immaginiamo che questo cane, pur conoscendo molte cose dei luoghi, di noi e delle nostre abitudini e desideri, non sappia davvero quale sia il senso di questo suo stesso condurci: un cane che non conosce dunque il perché autentico del nostro stesso aggirarci nella vita. Di quel cane - pur provando per lui il tenero affetto della lunga vita trascorsa insieme, e la riconoscenza profonda per la sua capacità di orientare i nostri passi - dovremo ammettere l’inaffidabilità finale. Ma ora dobbiamo chiederci: chi avrà stabilito la sua inaffidabilità? Chi avrà giudicato la sua inaffidabilità? Non è forse la nostra stessa ragione a farci dire che la nostra stessa ragione (il nostro cane-guida) è ignorante attorno al senso in sé dell'esserci? Lui solo – il nostro cane-guida - conosce e riordina le cose del mondo che ci circondano, e solo lui ha il diritto di interpretarle, solo lui ci permette di mantenere il controllo del nostro esserci donandoci quegli occhi che noi non abbiamo. Se dunque qualcuno dovrà – e potrà – giudicare questa inaffidabilità 29 sarà proprio il cane stesso. Ma allora ci troviamo dinanzi ad un cane affidabile che giudica se stesso dichiarandosi inaffidabile, in una sorprendente contraddizione: se la nostra ragione ritiene se stessa inaffidabile, sarà affidabile il giudizio di inaffidabilità che attribuisce a se stessa? Non v'è soluzione né decretando una cieca fiducia nella totale affidabilità della ragione (fingendo l’inesistenza del problema dell'assurdo del nulla assoluto, che la pur è la ragione stessa a proporci con forza), né decretando la totale inaffidabilità della ragione (in una scelta totalmente irrazionale che, tuttavia, è di contraddittoria attuazione perché un autentico irrazionalismo è negazione radicale di una razionalità che, comunque, deve essere presupposta per poter essere coscientemente negata dalla ragione stessa15). Il problema del nulla assoluto è il problema del paradosso della sua pensabilità come dato esperienziale (nessuno può mai affermare di esserci stato prima di nascere, o di continuare ad essere dopo la morte), e della sua impensabilità poiché è nullificazione del pensiero stesso. Il problema non è dunque neppure risolvibile in una qualsiasi forma di relativismo, poiché nell'assoluto nulla viene a mancare un soggetto qualsiasi in grado di relazionarsi al possibile esserci del nulla assoluto. Ma allora, c’è una soluzione possibile? Torniamo al nostro cane-guida. E andiamo col pensiero – ad esempio - ad alcuni aspetti radicali di quel pensiero orientale antico che ha preso il nome di Zen. Il “maestro” Zen non aveva alcun vero dio in cui credere, quindi alcuna autentica fede in cui rifugiarsi, non sosteneva alcun relativismo filosofico (tanto che era pronto a colpire con la spada chiunque lo accusasse di ciò), si dedicava esclusivamente ai modi e ai frutti della ragione ma non credeva ciecamente nella ragione (tanto che era uso ridere di se stesso e delle proprie conclusioni razionali). Cosa faceva dunque? Affermava l’assurdità di qualsiasi co15 Ne è esempio l’abbraccio ad una fede ultraterrena quando si tenta, infine, di costruire un impianto razionale (una teologia) che dovrebbe supportare ragionevolmente quell’atto finale di ogni autentica fede che è atto squisitamente irrazionale, abbracciando il tentativo di giustificare l’irrazionalità stessa che, per definizione, non dovrebbe rifiutare qualsiasi giustificazione. Per chi lo volesse, si confronti il pensiero di S. Kierkegaard in merito alla natura della fede autentica, che viene descritta come un vero e proprio gettarsi nell’abisso della ragione. 30 noscere tanto quanto la sua non-assurdità, la possibilità di verità di qualsiasi affermazione tanto quanto era raffinato e categorico - come Socrate - nello scovare anche il più banale errore logico: in una parola, sosteneva l'assurda ragionevolezza di ogni assurdo; in una parola, affermava l’assurdità della stessa assurdità, o, se preferite, l'assurdità come condizione paradossale della ragionevolezza-irragionevolezza di qualsiasi argomentazione razionale. Il Maestro in ciò indicava l’esperienza del paradosso, e dell’assurdo che ne deriva, come unica possibile via verso la verità (detta, ai tempi, illuminazione). In altre parole: è la ragione a condurci ad un abisso di contraddizioni sulle quali è impossibile fondare alcuna verità epistemica, ma poiché è la stessa ragione a decretare (come il nostro cane) questa sua radicale incapacità, allora il “vero” (il Tao, l’Illuminazione) non stanno né nella ragione né contro la ragione 16. Il “vero” sta oltre ogni ragione, pur essendo figlio primogenito e ineliminabile frutto della ragione. Ben lungi dall’inventarsi un qualsiasi “dio” a supporto del senso della vita, in questa sua posizione-esperienza estremamente paradossale, assurda appunto, il Maestro tentava di vivere l’assurdo come se non fosse assurdo, sapendo tutta l’assurdità di questo stesso modo di vivere. Semplicemente, ci consigliava di vivere l'assurdità stessa. E, non dimentichiamolo, l’indicazione di questo paradosso non era mai l’indicazione di una verità possibile o magari raggiunta: era solo una indicazione, che tuttavia non voleva mai essere ridotta a pura indicazione17. Quei maestri antichi ci avevano mostrato, quindi, non il fallimento della ragione, ma il fallimento di ogni possibile filosofia, svelando contestualmente tutto l’immenso valore della ricerca filosofica: semplicemente, ci avevano detto che la soluzione al senso autentico del vivere non la troveremo mai pur potendola trovare ovunque: il senso delle cose è sempre e per sempre fuori di noi, pur essendo in noi sin dall’origine18. 16 Nella tradizione delle affermazioni del Taoismo e della Zen: “Il Tao è una porta che non è una porta”, “Il vero è un dito che indica la luna”, “Se lo cerchi, non lo trovi; se lo hai trovato, lo hai subito perso”… Cfr. nota sopra "Mangia quando hai fame, e bevi quando hai sete…" 17 18 31 Credo non vi sia suggerimento più equilibrato e, me lo si consenta, più onorevole da punto di vista razionale. Ma si tratta, ovviamente, solo di un suggerimento. Sull’orizzonte del nostro vivere e cercare, tutta la filosofia – regina indiscussa di ogni radicale esercizio razionale - muore indecorosamente ad ogni rinnovato tentativo di realizzare la propria utopia; ma in qualche modo può ben rinascere dalla propria sconfitta, fenice di un Vero che, assurdamente, può assurdamente celarsi tra le pieghe di un sapere-non-sapere assurdamente saggio19, di un sapere totalmente carico di follia. Cosa ci può attendere, alla fine? Un silenzio, forse. Ma è un silenzio carico di cose, è l'affacciarsi su un vuoto che si rinnova di cose: una domanda infinita, che rimane tuttavia domanda a volte un poco gridata. E' un gesto, che non muove nulla; ma che in qualche luogo sonda le ragioni dell'essere. 6. Senso e arte20 "Oggi è una giornata di gran neve. E’ talmente fitta, che chiude l’orizzonte a pochi metri, come uno sguardo ovale. Adoro la neve, e ne ascolto il frusciare costante, l’ottusità imposta ad ogni suono. In una parola, il silenzio. 19 Credo che Socrate – nel suo famoso “So di non sapere” - sia stato il migliore interprete e promotore di questa forma di saggia-follia, di folle-saggezza. I paragrafi a seguire sono tratti da "Visioni dalla filosofia", dell'autore, 2011 20 32 I quadri che mostrano la neve sono simili a questo momento: ciò che li accomuna è la limitazione dello sguardo (lì la cornice, qui la neve), ed una certa fissità, un movimento del nevicare che sembra immobile. Ogni opera d’arte è immobile, e ben chiusa nel proprio spazio, e pervasa da un silenzio profondo. Ma se l’opera consistesse solo in questa sua fissità e nel silenzio, saremmo allora soggiogati da ogni staticità, e l’arte starebbe allora in ogni assenza del vivere; è possibile che in noi vi sia questa nostalgia che ci fa desiderare che il mondo possa fermarsi, darci pace: “requiescat in pace” - diranno ad ognuno alla fine del travaglio; ma neppure un’opera dell’arte sarà mai realmente statica perché noi stessi ci spostiamo, dentro, nell’osservarla. C’è qualcosa ancora da vedere, in questo pomeriggio di neve. Forse è un’emozione che sta in qualche luogo; forse si trova là, fuori dalla cornice: quella cosa cui ciò che sta dentro sembra volermi condurre. Cosa ci sarà, oltre ciò che la neve mi impedisce di vedere? Oltre la cornice? Dove vuole condurmi il limite di questa tela, oltre che cosa? Il segreto è che questa neve, forse (non so perché e in questo istante non m’importa) mi suggerisce di guardare là, oltre, proprio dove non posso inoltrarmi. Il segreto è dunque fuori; ma forse il vero segreto che mi fa stupire dell’immagine risiede semplicemente nel mio accogliere questa voglia di gettarmi altrove lasciandola lì tuttavia, come un oggetto prezioso da non toccare. Noli me tangere. Cosa c’è, là fuori? Ma subito mi dico - e so che non è così importante saperlo che non mi importa di ciò che sta fuori dalla cornice, visto che ci sarà sempre una nuova cornice a chiudere lo sguardo. Invece, se amo questa neve, è perché la amo lì com’è, nel suo movimento che vuole sfuggire al proprio spazio, pur non varcandone mai i confini. Essere invitati, fermandoci estatici nell’istante singolare dell’invito, della mano che ci indica una via con un gesto misurato: lasciare ogni oltre, là dove si trova, nella sua attesa eterna." 33 7. Il sorridere "Il bambino nasce con il pianto. Ogni volta, ritrovando gli occhi e la presenza della madre, ride. E’ il gioco del rincorrersi e ritrovarsi, del perdere e dell’avere. E’ il gioco degli estremi, la guerra del vivere. Anche la filosofia è un gioco di estremi, una guerra. Ma il vivere non è fatto di soli estremi, così come non è fatto di pura ragione. Tra il pianto e il riso, spesso, ci ritroviamo infatti a sorridere. Il sorriso non è un riso: nella parola stessa v’è una radice, del ridere, ma qui il ridere non matura, non riesce a generarsi. Il “cetti” è il momento dello stupore, è la meraviglia del ritrovamento delle cose, del loro momentaneo senso: in questo è gioia immediata, chiusa sopra se stessa e paga. La gioia è sempre espressione di una riconquista, scaturisce spontanea e irrefrenabile, anche se riguarda solo il momento circoscritto del proprio esserci, dimentica di ogni futuro possibile. Niente di tutto ciò nel sorridere. Il sorriso non è neppure angoscia perché sospende, incredibilmente, ogni previsione del dolore. Se dunque l’angoscia del “bau” è la conseguenza di un’attuale disordine delle cose, di un loro potenziale mutamento verso l’ignoto, se è il paventare una ribellione del mondo che potrebbe condurci alla sua e alla nostra perdita, e dunque al dolore, il sorridere non è dolore, non perché non sappia del dolore, ma solo perché ne sospende il dramma: nel sorridere v’è una sospensione del tempo, di ogni nostro pre-vedere. Il sorridere vede il dolore possibile, ma lo trapassa e non lo calcola. Il sorridere è uno stato interiore stranissimo, che si nutre degli estremi che lo circondano (la gioia, la disperazione) e si mantiene incredibilmente in equilibrio tra di essi; si nutre della vita senza precipitarsi nella vita. E’ paradossale, perché è entrambi questi estremi senza essere alcuno di loro, e in questo non ne è neppure la sintesi: non nasce dunque come parto, ma vive di una genesi propria. Se il sorridere fosse d’altra parte la sintesi di gioia e dolore, allora in questa sintesi sarebbe implicita la possibilità di un senso: gioia e dolore troverebbero infatti il perché del proprio esserci, avrebbero uno scopo e un destino; ma gioia e dolore non possono partorire, non sono genitori della vita, ma della vita solo espressione inevitabile. 34 Il sorridere dunque è uno stato inspiegabile, dove i conti non tornano. E’ un modo sospeso di essere, quasi un modo diverso dall’essere. Paradossalmente, quando sorrido è perché sto afferrando un po’ della mia méta, mi sento bene con quella parte del reale che mi riempie; ma al tempo stesso sorrido (e non rido) perché sono cosciente che questa realtà è solo una parte. Il sorriso è dunque, e forse, l’aprirsi di un orizzonte dove ogni domanda è caduta. Sorrido della cosa, sorrido di me: forse il sorridere esprime una accettazione inaccettabile del mio limite, la sua accettazione insensata; ma è anche nonaccettazione, perché è superamento: in questa mancanza di senso e nella rinuncia, in fondo, di un qualsiasi senso, il sorridere è, probabilmente, una malinconia che conosce a proprio modo il senso. Il sorridere si pone dunque oltre ogni ragione, sembra essere ragionevolmente assurdo, assurdamente ragionevole, impensabile, insensato nella propria sazietà. Ma per altro lo possiamo e lo sappiamo vivere: il sorridere semplicemente accade. Se voglio sorridere posso dunque pensare, ma senza la pretesa di spiegare; posso agire, ma senza la pretesa di costruire. Il sorridere non otterrà da noi, mai, una decente spiegazione e dunque una propria collocazione intelligente; il sorriso forse, che appare e scompare, che non può essere imposto, né fermato o discusso, altro non è che il luogo di una possibile apertura del nostro conoscere verso l’oltre, l’altrove dell’essere. Sono passati molti anni, dal mio primo grido, dal gioco con la nonna e molti ancora dalla mia prima filosofia. Molto tempo è trascorso dalle illusioni di essere più forte d’ogni senso nascosto, più della vita stessa. Più della morte. E con le prime rughe sul volto il sorridere diventa più naturale, congruo, profondo. Anche questo scrivere è stato spesso circondato da un sorriso: le parole scritte, gli amori vissuti, la bellezza inebriante e tutti gli specchi del mondo e il loro dolore sono diventati in questi tratti di vita luci trasparenti, più tenui ma più calde: una brezza senza senso. Forse sorridere è un lasciare l’ultima parte del bicchiere in onore degli Dei: sentire con loro la comunanza dell’impresa, e la sensa- 35 zione non indifferente di essere uomo. Solo un uomo, e per questo un poco grande. Il sorriso forse è, il luogo degli dèi. Non vi fu mai né bene, né male, lassù sul monte più alto dove essi dimoravano tra le nubi mosse dal vento costante di mare. Forse, come per gli dèi di quell’antica patria d’ogni filosofia, il sorriso è il riconoscimento di una grande potenza, e di uno spessore di cielo che comunque e sempre la sovrasta." 36 APPUNTI FINALI Molti anni or sono ho letto qualcosa. Non ricordo dove, né ricordo i nomi. Ma ricordo qualcosa. Un giorno il capo indiano di una tribù (Apache? Sioux?) dall’alto di una collina dove, con i suoi pochi uomini, poteva vedere nel sole splendente l’immenso esercito armato degli Stati Uniti d’America, e dalla cui sommità poteva contemplare anche, lontane, le mandrie pascolanti dei bisonti che tante volte aveva cacciato e ucciso, chinandosi poi su ogni cadavere chiedendo perdono e pregando per ogni loro singola anima; questo capo indiano, levando la sua lancia ornata di mille trofei nella luce, assurdamente disse: “Oggi è un bel giorno per morire!”. Molti anni orsono, a Milano, uno dei maggiori filosofi del nostro tempo tenne una conferenza. Raccontò l’orizzonte possibile dell’esserci e del nulla. Lo raccontò con la perizia consumata di un grande retore, e il rigore stretto di un grande logico. Io, seduto tra le file che davano posto ad oltre 400 persone, ad un certo punto mi guardai attorno: vedevo volti attentissimi, in un silenzio assoluto; e vidi molti taccuini e molte penne che scrivevano sin al più piccolo appunto. Alla fine il filosofo abbassò i fogli degli appunti propri, della traccia, e li diresse attorno alla sala dicendo più o meno queste parole: “Tutto ciò che vi ho raccontato ha forse il sapore di una verità, di qualche verità. Se è così, me ne rallegro. Ma sappiate che tutto ciò che ho raccontato è una favola, una favola forse vera, ma pur sempre e solo una favola.” 37 © Copyright Mario Roccato – Como – marzo 2015 38
Scaricare