l’antifascista fondato nel 1954 da Sandro Pertini e Umberto Terracini Periodico degli antifascisti di ieri e di oggi • anno LXII - n° 5-6 Maggio - Giugno 2015 Mafia capitale prosperata sotto la giunta Alemanno, è un’organizzazione criminale di matrice fascista che ha lucrato sugli appalti e sull'emergenza dei migranti LA BANDA BASSOTTI DEL CAMPIDOGLIO Ha fatto affari con la cooperativa rossa "29 giugno" e una fetta del Pd romano che è stato commissariato Capo indiscusso è Massimo Carminati, con un passato tra i Nar e la banda della Magliana – I guai di Marino L'EDITORIALE Allarme rosso, diffuso rifiuto di questi partiti di Giorgio GALLI Le elezioni regionali e comunali in Italia possono essere meglio valutate se collocate nel ciclo di consultazioni che nel giro di un mese si sono svolte dalla Gran Bretagna (7 maggio) alla Turchia (7 giugno), passando per Irlanda, Spagna e Polonia. Il quadro che ci si presenta è di prevalenza della novità sulla stabilità. A Londra, la netta vittoria dei conservatori di Cameron, che indirà un referendum sulla permanenza nella Ue, la clamorosa sconfitta laburista, la grande affermazione degli indipendentisti scozzesi, la sottorappresentazione in Parlamento di quelli inglesi (oltre il 12 per cento) e dei Verdi, fa scrivere al più autorevole politologo britannico Timothy Garton Ash che “è ora di passare al Regno federale di Gran Bretagna, altrimenti l’esito delle urne, il più sensazionale dal 1945 ad oggi, potrebbe segnare l’inizio della fine della Gran Bretagna e della sua adesione alla Ue”. Nella vicina Irlanda, il 23 maggio il 62 per cento dei voti favorevoli nel referendum sui matrimoni di Teresa PADOVA I n questo numero ci occupiamo dell'inchiesta 'Mondo di mezzo' che ha portato tra dicembre e giugno all'arresto di 81 persone, tra le quali esponenti di spicco della politica romana, protagonisti interni ed esterni alla struttura, rigorosamente bipartisan, di quella che gli inquirenti, coordinati dal procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, hanno denominato “mafia capitale”, una organizzazione criminale di stampo mafioso che opera da anni nel territorio della città di Roma per acquisire la gestione e il controllo di attività economiche, appalti, servizi pubblici. Punto di arrivo di organizzazioni che hanno preso le mosse dall'eversione nera e si sono evolute nel fenomeno della banda della Magliana. wMafia capitale prospera sotto la giunta guidata da Gianni Alemanno dal 2008 al 2013 ma fa affari anche con la cooperativa rossa "29 giugno" e una fetta importante del Pd romano fino a far traballare oggi, alla luce dell'inchiesta, la poltrona dell'attuale sindaco Ignazio Marino. Il racconto di mafia capitale è il racconto di un sodalizio spregiudicato tra storie politiche diverse, opposte, e opposti ideali in nome del profitto e degli affari illeciti. Ma prima ancora è il racconto di un legame tra ex camerati, tra appartenenti ai movimenti eversivi della destra romana degli anni 70, alcuni dei quali poi diventati rappresentanti politici o manager di enti pubblici. segue a pagina 2 La Maturità e la Resistenza La memoria e i suoi paladini non possono andarne fieri: il tema di maturità sulla Resistenza, che è storia contemporanea, è stato scelto da un'esigua schiera di studenti. Ha nettamente prevalso l'opzione sui social e internet preferita dal cinquantun per cento dei candidati. Le altre sei tracce (Calvino, Malala e i quattro temi relativi alla redazione del saggio breve) non hanno stimolato l'interesse degli studenti che si sono concentrati, come detto, sullo sviluppo scientifico e tecnologico dell'informatica che ha trasformato la comunicazione. Giusto, sono temi dell'era moderna. Ma la storia? La Resistenza? Questo deficit degli interessi è colpa solo dei canditati, della scuola? E chi svolge attività di segue in ultima pagina memoria è sicuro che non ha niente da rimproverarsi? (g.m.) Poste Italiane s.p.a. - spedizione in abbonamento D.L. 353/2003 (conv.in. L. 46 del 27.02.2004) - Art.1, comma 2, DCB - Roma Turati Il padre del socialismo di C. TOGNOLI a pag. 4 Ventotene Qui nasceva la rivolta al fascismo di E. VILLAGGIO a pag. 10 Smemorati I simboli "dimenticati" del fascismo di A. VECCHI a pag. 15 2 Mafia Capitale Capo indiscusso di Mafia Capitale è uno di loro, Massimo Carminati, detto il pirata o il cecato. Un passato nei Nuclei Armati Rivoluzionari, i Nar, e nella Banda della Magliana, Carminati esercita un potere assoluto secondo gli inquirenti proprio grazie al suo curriculum criminale e a quella aura di impunità che gli deriva dall'essere uscito assolto dai processi su alcune delle storie più controverse della nostra Repubblica: l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli e il depistaggio della strage di Bologna. Il Cecato finisce in manette nella prima tranche di arresti a dicembre insieme a un suo vecchio amico Riccardo Mancini. Un passato in comune nella destra radicale romana che si riuniva sotto il fungo del quartiere Eur, Mancini viene nominato amministratore delegato di Eur spa da Alemanno sindaco. Quest'ultimo risulta indagato, unico politico nei confronti del quale l'accusa è di associazione mafiosa, oltre all'ex consigliere regionale di Forza Italia Luca Gramazio, finito in manette a giugno. L'elenco delle persone coinvolte nell'inchiesta mafia capitale che vengono da una storia di destra è lungo ma, come si diceva, la struttura dell'organizzazione criminale romana è rigorosamente bipartisan. A partire dal vertice. Braccio destro di Carminati, infatti, è Salvatore Buzzi, fondatore della cooperativa rossa 29 giugno. Alle spalle un passato da detenuto (per omicidio di un complice) modello - il primo in Italia a laurearsi in carcere - e l'idea di fondare una cooperativa per il reinserimento dei detenuti, Buzzi ha la tessera del Pd ed è presente anche alla cena di autofinanziamento organizzata da Matteo Renzi a Roma. Mette la sua cooperativa al servizio di mafia capitale gestendone le attività economiche nei settori della Il “cecato” Massimo Carminati raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, dell'accoglienza dei profughi e dei rifugiati, nella manutenzione del verde pubblico. Tutti settori oggetto di gare pubbliche che Buzzi si aggiudica corrompendo pubblici ufficiali. Tra loro, a libro paga, c'è Luca Odevaine. Membro del Tavolo di coordinamento nazionale sull’immigrazione, ex vice capo di Gabinetto di Walter Veltroni, viene arrestato a dicembre. La figura di Odevaine ha fatto traballare anche il governo Renzi: fu nominato infatti nel gruppo dirigente del Cara di Mineo da Giuseppe Castiglione, ex presidente della provincia di Catania e attuale sottosegretario all'Agricoltura. Uomo di Ncd, il partito del ministro dell'interno Angelino Alfano, Castiglione è indagato. Sel, Lega e M5S ne avevano chiesto\le dimissioni. Una maggioranza trasversale Pd-Fi lo ha salvato dall’arresto respingendo le mozioni presentate alla Camera. Nonostante gli inquirenti affermino con certezza che vi erano relazioni precise, che aumentavano progressivamente, tra Alemanno, sindaco di Roma, e il suo entourage politico e amministrativo, da un lato, e il gruppo criminale che ruotava intorno a Buzzi e Carminati, dall’altro, a rischiare grosso oggi è la giunta di Ignazio Marino dopo l'arresto, insieme agli esponenti del PdL Gramazio e Tredicine, di tre politici del Pd: Mirko Coratti, ex presidente dell'assemblea capitolina, Daniele Ozzimo, ex assessore alla casa, Pierpaolo Pedetti, consigliere comunale e presidente della commissione politiche abitative. A dimostrazione che il cambio di maggioranza al Campidoglio avvenuto nel 2013 con l'elezione di Marino non ha scoraggiato il duo Carminati-Buzzi che subito si attivò per stabilire contatti riuscendo a trovare uomini chiave da corrompere. Il primo cittadino della capitale, finora uscito pulito dalla vicenda, non intende lasciare il suo incarico, nonostante la richiesta di dimissioni dell'opposizione. Con loro, con i suoi predecessori di centrodestra in particolare, Marino ha alzato il livello dello scontro attaccandoli dal palco della festa dell'Unità di Roma: "La destra si deve vergognare, torni nelle fogne", gli ha detto. Le scuse arrivate qualche giorno dopo per aver usato uno slogan caro alla sinistra negli anni 70 non gli hanno risparmiato la querela di Alemanno. Politica Salvatore Buzzi, fondatore della cooperativa “ 29 giugno” ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI ALLARMANTE PERICOLO DI DERIVE POPULISTE LO SFONDAMENTO DELLA LEGA NEL CENTRO ITALIA Le ultime elezioni regionali e comunali, seppur parziali, del 31 maggio scorso (ballottaggi il 14 giugno), sono risultate quanto mai indicative. Come sempre, nell’immediato, si sono confrontate interpretazioni diverse a seconda dell’appartenenza politica. In particolare subito dopo il voto per le sette regioni chiamate alle urne. In effetti, utilizzando il semplice calcolo basato sulla posta in palio, il risultato pendeva nettamente a favore del centrosinistra: cinque a due nei confronti del centrodestra, pur con la rilevante perdita della Liguria, tradizionalmente a guida Pd, e la nettissima sconfitta in Veneto dove la candidata renziana finiva staccata di quasi trenta punti. di Saverio FERRARI Decisiva per le sorti del sindaco tuttavia è stata la relazione del prefetto di Roma, Franco Gabrielli, che ha valutato che non ci sono gli estremi per lo scioglimento del comune anche se ha rilevato alcune manchevolezze di Marino. Nel frattempo la posizione di Renzi e del Pd nazionale nei suoi confronti va dal «Fossi in Marino non starei tranquillo» pronunciato all'indomani dei ballottaggi dal premier passando per il «Marino è una persona onesta ma l'onestà non basta» del ministro per le Riforme, Maria Elena Boschi, al «Lo sosterremo sempre ma serve un salto di qualità» di Matteo Orfini. Qualunque sia il futuro della giunta capitolina una cosa è certa: il Pd romano esce a pezzi da questa storia. Il segretario nazionale Renzi a dicembre aveva azzerato le cariche commissariando il partito e affidandolo a Matteo Orfini: ma dopo sei mesi non ci sono buone notizie. Orfini è finito sotto scorta e dei 108 circoli del Pd a Roma 27 sono stati definiti dannosi e da chiudere da Fabrizio Barca, l'ex ministro che li ha mappati. Non sarà facile rimettersi in piedi e soprattutto rimettere in piedi una storia di difesa degli ultimi, usati in questa vicenda come in un traffico di droga, e contro ogni fascismo con cui invece ci si è lasciati intimidire e corrompere in nome degli affari. I ballottaggi per le comunali del 14 e del 15 giugno (solo per la Sicilia) hanno però inciso, e non poco, sull’esito finale, con otto capoluoghi alla destra, sette al Pd e due ad appannaggio di liste civiche. Pesanti in questo contesto le sconfitte di Venezia, Rovigo, Arezzo e Matera, seguite dalla débacle siciliana, con cinque ballottaggi su cinque vinti dal Movimento cinque stelle. Il risultato di Venezia si dimostrava poi particolarmente cocente, dopo 21 anni di giunte di centrosinistra, con il Pd a poco più del 16% dal 40% di solo un anno prima alle europee. IL PARTITO DI MAGGIORANZA RELATIVA Il dato più rilevante in questa tornata elettorale è stato però quello dell’astensione. La partecipazione al voto, infatti, è precipitata al 52,1%, dal 72,27% di quindici anni or sono (meno 18,6%) e dal 63% delle precedenti regionali. Con un elettore su due che ha dunque disertato le urne. Un fenomeno che si è manifestato in modo più accentuato nelle cosiddette “regioni rosse” (Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna, dove si era votato solo qualche mese prima), con i partecipanti al voto scesi al 44,7%, in aree geografiche con un’affluenza in precedenza sempre al di sopra della media nazionale. QUASI TUTTI I PARTITI CALANO Scomponendo i dati per partito, ciò che emerge è invece il calo generalizzato, in percentuale e in termini assoluti, di quasi tutte le formazioni politiche. Nello specifico: - il Pd, ben lontano dell’exploit delle europee del maggio 2014 (40,8%) scende al 25% (2,1 milioni di voti), al livello delle regionali del 2010 e delle politiche del 2013, con una perdita secca di circa due milioni di voti nel primo caso e di un milione (-30%) rispetto all’era Bersani; - il Movimento cinque stelle, nonostante i successi siciliani, lascia per strada quasi due milioni di voti rispetto alle politiche e 900 mila rispetto alle europee, attestandosi al 15,66% (1,3 milioni di suffragi); - Forza Italia cala di due milioni di voti rispetto al Pdl del 2013 e di un milione rispetto allo scorso anno, fermandosi all’11,30% (sotto il milione di voti); - la Lega raddoppia rispetto al 2013 (più 400 mila voti) e aumenta del 50% riguardo alle europee (13,08%, pari a 809 mila voti), sfondando in centro Italia, il dato più significativo, dove triplica i propri consensi in Toscana e Umbria rispetto a un anno fa. Se si andasse domani alle urne per il rinnovo del Parlamento, stante la nuova legge elettorale (Italicum), con il ballottaggio tra i due principali partiti (sotto la soglia del 40%), alla conta andrebbero Pd e Movimento cinque stelle. Sarebbero loro a contendersi la guida del Paese. PREMESSE DI POPULISMO Stante i numeri, ciò che emerge, al di là delle considerazioni più prettamente politiche relative al giudizio sull’operato di chi governa il Paese o sulle opposizioni, è l’affermarsi anche in Italia di un pericolo populista. Con esso la preoccupazione per la tenuta del nostro sistema democratico. A segnalarlo in primis la fuga in massa dell’elettorato dalla politica. Una disaffezione mai raggiunta in precedenza nei termini di un boom astensionistico. In realtà un vero e proprio “voto di protesta” a fronte del dilagare degli scandali e dei fenomeni corruttivi che stanno investendo le istituzioni, i partiti politici e gli enti pubblici. A esserne particolarmente colpito risulta essere il tradizionale elettorato di sinistra. In questo contesto, la scelta da parte del Pd di non voler più veicolare le istanze provenienti dal mondo del lavoro operaio e dipendente, con l’evidenziarsi di una frattura netta con il principale sindacato italiano (la Cgil), segnala una inedita e profonda crisi di rappresentanza. Il progressivo smantellamento dello Stato sociale, più recentemente le riforme votate o in divenire sulla scuola e sulle politiche del lavoro (Job Act, cancellazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, riduzione degli ammortizzatori sociali) ne stanno costituendo con tutta evidenza la base materiale. L’avanzamento della Lega, dal canto suo, segnala il manifestarsi in ampi strati della popolazione della propensione all’arroccamento, con l’estendersi di paure irrazionali, a fronte del passaggio epocale che investe la nostra società, sempre più a composizione multiculturale e multietnica. Oggi per altro al centro di flussi migratori giganteschi dovuti alle guerre in Africa e nel Medio Oriente. Sotto questa spinta sembrerebbero entrare sempre più in crisi le culture della solidarietà e dell’uguaglianza. Il Veneto, praticamente amministrato (anche dopo il disastro di Venezia) a tutti i livelli dalla Lega, si staglia da questo punto di vista sempre più come un autentico laboratorio. I successi del partito di Matteo Salvini evidenziano anche la labilità della memoria, una costante tutta italiana. Solo un paio di anni fa la stessa Lega era al centro di episodi macroscopici di ruberie e truffe. Tutto rapidamente dimenticato. Qua e là, nei voti recentemente espressi, anche il profilarsi di ulteriori inquietanti episodi. Da segnalare l’elezione a Bolzano, con il 2,4%, di un consigliere di Casa Pound, e di un secondo a Lamezia, in Calabria, con oltre il 6%. Tutte queste tendenze potrebbero nel loro complesso favorire la strada per derive di tipo populista. La stessa riforma della Carta costituzionale va necessariamente collocata in questo nuovo quadro. La cancellazione del Senato elettivo, più in generale il restringimento dei circuiti decisionali verso approdi presidenzialisti, a maggior ragione, non può che suscitare forti apprensioni. 3 4 Memoria TURATI, IL PADRE DEL SOCIALISMO ITALIANO di Carlo TOGNOLI (Sindaco di Milano dal maggio 1976 al dicembre 1986) F ilippo Turati non amava la definizione “riformista”, ma la riconosceva perché permetteva di contraddistinguere la sua corrente, e comunque la accompagnava sempre al ‘socialismo’.Egli fondò nel 1892, a Genova (dove i congressisti si riunirono per usufruire degli sconti ferroviari concessi per le Celebrazioni Colombiane – 400° anniversario della scoperta dell’America) il Partito dei Lavoratori, divenuto poi Partito Socialista Italiano, insieme a Claudio Treves, Leonida Bissolati (che nel 1896 fu il primo direttore dell’Avanti!) Anna Kuliscioff e Andrea Costa. In precedenza c’erano state altre iniziative (la più importante a Milano nel 1882) tutte prevalentemente locali. Quella di Genova, che sancì la rottura con gli anarchici, aveva un carattere nazionale. Turati fu un grande ‘leader’ (diremmo oggi) del socialismo italiano ed europeo. Si identificò con il PSI quanto meno dalla fondazione (1892) sino al 1912 quando venne messo in minoranza. Tuttavia sino alla morte fu la personalità eminente del socialismo e, dopo la sua fuga in Francia del 1926, fu tra i capi più ascoltati ed apprezzati dell’antifascismo. Aveva ereditato da Arcangelo Ghisleri la rivista culturale di orientamento positivista Cuore e Critica, che, con Anna Kuliscioff (la sua compagna della vita e della politica) egli denominò, nel 1891, ‘Critica Sociale’. La nuova pubblicazione, che aveva una cadenza quindicinale, fu la più importante rivista del socialismo italiano. Ad essa collaborarono, tra gli altri, Benedetto Croce, Luigi Einaudi, Olindo Malagodi. Turati morì il 29 marzo 1932, a Parigi, in casa della famiglia di Bruno Buozzi, in Boulevard Raspail, dove era ospitato. Venne considerato un perdente, perché non riuscì ad impedire l’avvento di Mussolini e del regime fascista, di cui aveva lucidamente e profeticamente intuito le intenzioni totalitarie, quando altri, nella sinistra socialista e comunista, lo giudicavano un fenomeno transitorio. Filippo Turati Nel 1982, in occasione del 50° della morte di Turati in esilio, e in parallelo alla crescente crisi del sistema sovietico e del comunismo, ci fu finalmente un dibattito storico politico su scala nazionale che investì la sinistra ed ebbe eco sui grandi organi di stampa e in televisione. Autorevoli dirigenti e fondatori del Partito Comunista, come Umberto Terracini, riconobbero che ‘Turati aveva ragione’. Nel suo profetico discorso al Congresso di Livorno del 1921 (quello della scissione che diede luogo al Partito Comunista d’Italia) il leader socialista aveva tra l’altro detto: «…Ond’è che quand’anche voi aveste organizzato i soviet in Italia, se uscirete salvi dalla reazione che avrete provocata e se vorrete fare qualcosa che sia veramente rivoluzionario, qualcosa che rimanga, come elemento di società nuova, voi sarete forzati a vostro dispetto – a ripercorrere completamente la nostra via (riformista) la via dei socialtraditori di una volta, perché essa è la via del socialismo, che è il solo immortale, il solo nucleo vitale che rimane dopo queste nostre diatribe…». Fu a lungo dimenticato Turati fu poco ricordato nel primo decennio dopo la seconda guerra mondiale. Fatta eccezione per Saragat, per il PSDI e per il gruppo della Critica Sociale - i cui redattori, Ugo Guido Mondolfo e Giuseppe Faravelli, insieme ad altri, tra cui Antonio Greppi - erano stati suoi giovani discepoli. Il ‘riformismo’ infatti non era gradito nei due maggiori partiti del movimento operaio, il PCI e il PSI, uniti tra loro dal patto di unità d’azione, sottoscritto prima della guerra e rimasto in essere sino al 1957. Per la verità nell’ottobre 1948 la traslazione delle ceneri di Turati e di Treves, dal ‘Père Lachaise’ di Parigi al Cimitero Monumentale di Milano, avvenne in un mare di folla. Ma fu l’ultimo riconoscimento delle ‘masse’ ai grandi costruttori del socialismo italiano. Nel PSI c’era rispetto, ma si tendeva a diluire il ruolo di Turati e Treves nella fondazione del partito. Si preferiva ricordare Andrea Costa. Le feroci e sprezzanti parole che Togliatti su Lo Stato Operaio dell’aprile 1932 dedicò a Turati dopo la sua morte avevano lasciato nel PCI il segno negativo nei confronti del riformismo. Craxi rilanciò il riformismo Fu Craxi, con la sua volontà revisionistica e con la sua politica, a restituire al riformismo socialista la sua dignità, a ricordare che senza i riformisti il PSI non sarebbe cresciuto come movimento decisivo per la democrazia italiana, non sarebbero nati sindacati e cooperative, non sarebbero stati conquistati diritti fondamentali per il mondo del lavoro e per il movimento operaio. Vent’anni fa i comunisti più rispettosi della storia diedero ragione a Turati. 5 Memoria Non va quindi ricordato come un perdente, Filippo Turati. Certo dovette soccombere al fascismo, commise degli errori tattici, fu prigioniero della sua lealtà verso il PSI la cui maggioranza massimalista e velleitaria considerava tradimento la partecipazione dei socialisti a un governo democratico di coalizione con ‘partiti borghesi’ (che avrebbe salvato l’Italia). Ma vide giusto e lontano, purtroppo inascoltato. La sua considerazione dell’estremismo di sinistra come comportamento pernicioso per la crescita e le lotte del partito socialista e del movimento dei lavoratori non fu dissimile da quella di Lenin che, pur attestato su altra sponda, vedeva i pericoli del settarismo. Le sue ‘compromissioni’ (una delle accuse dei massimalisti) con i governi Giolitti (con cui ebbe anche scontri notevoli) riguardarono le garanzie (ottenute) per il lavoro delle donne e dei fanciulli, le ‘otto ore’ lavorative, il suffragio universale, le leggi per le cooperative. Il riformismo socialista nel suo periodo storico Il primo decennio del secolo XX vide progressi generali del Paese e notevoli conquiste del mondo del lavoro. Il riformismo socialista era la lotta per la democratizzazione dello stato, per farne strumento anche economico della collettività. Era diffidenza della violenza come matrice della storia. Era l’affermazione dell’umanesimo e della ragione. Era la difesa di una civiltà (che veniva messa in discussione dal nazionalismo esasperato e dall’irrazionalismo). Era il gradualismo nei cambiamenti. Il riformismo socialista fu peraltro ‘di opposizione’ in quanto il PSI non era né al Governo, né al potere, e fu, in origine, bracciantile e contadino: «…il riformismo è il necessario corollario delle organizzazioni dei contadini: probivirato agricolo, contratti di lavoro, assunzione collettiva dei lavori agricoli, cooperative, scuole con insegnamento di agricoltura… l’indirizzo politico della nostra frazione può trovare una base solida ed estesa in mezzo alla popolazione organizzata dei contadini e delle contadine, forse più che in mezzo al volubile, incostante, fluttuante proletariato industriale…» – scriveva nel 1908 la Kuliscioff a Turati. Il riformismo socialista trovò il suo terreno di cultura ‘di governo’ nei comuni: le politiche sociali, dall’assistenza all’igiene, l’estensione dell’istruzione, le biblioteche popolari, la progressività delle imposte locali, il contenimento dei prezzi dei generi di prima necessità, l’introduzione dei servizi pubblici a bassa tariffa (dai trasporti all’energia) – furono gli elementi portanti di un’azione amministrativa tutta tendente a favorire i cittadini a più basso reddito e i lavoratori. Bologna e Milano, ma anche tante altre città, furono gli esempi di ottima amministrazione, socialmente avanzata, ma oculata e ben vista e votata da una parte della borghesia liberale. Turati era contro la violenza, ma era socialista, anche se il suo marxismo era positivista, pratico, etico e critico, mai settario. Voleva la costruzione di una società socialista attraverso la conquista democratica del potere. Sopratutto fu un capo politico che operò per modificare la realtà, per Bauer, Turati, Carlo Rosselli, Pertini e Parri in una rara foto insieme 6 Memoria 7 Memoria Manifesti del Partito Socialista Italiano dei primi del Novecento educare le masse abituandole alla lotta democratica, combattendo l’analfabetismo e i pregiudizi, contrastando l’alcolismo, insegnando la solidarietà. Le scelte ideologiche di Turati, della Kuliscioff e dei riformisti rifuggivano dalle interpretazioni deterministe, per le quali l’avvento del socialismo, date certe condizioni, era automatico. Nel suo programma Agli elettori del collegio di Milano, per le elezioni del novembre 1919, parla del superamento dello stato borghese per trasformarlo ‘da governo degli uomini a governo delle cose’, fuori dal visionarismo storico che rifiuta il riformismo perchè fa interventi parziali e graduali e alla fine diventa ‘governo autoritario sugli uomini’. La crisi L’azione di stimolo verso i governi Giolitti, che portò molti risultati al mondo del lavoro, non si tramutò in partecipazione al governo. Turati rifiutò tale prospettiva nel 1911. Giolitti offriva, per un governo liberale-radicale-socialista, suffragio universale e stabilizzazione delle assicurazioni sulla vita per devolverne gli utili alla Cassa di Previdenza dando il via alle pensioni operaie, ma il ‘leader’ socialista (malgrado l’opinione differente di Bissolati e Bonomi) non ritenne maturi per tale scelta, né i tempi, né il PSI. La decisione di intraprendere la guerra di Libia, riportò Turati e i socialisti su una linea di ostilità al governo. Nel frattempo si rafforzava la sinistra massimalista, guidata dal Direttore dell’Avanti!, Benito Mussolini, che al Congresso di Reggio Emilia del 1912, riusciva ad ottenere l’espulsione di Bissolati, Bonomi, Cabrini, Podrecca e altri nove deputati, che diedero vita al Partito Socialista Riformista. L’accusa era di avere portato la loro solidarietà al Re, che aveva subìto un attentato. Si fa risalire a quell’ anno la sconfitta della tendenza riformista. Certo Turati uscì indebolito, dopo l’espulsione di una parte dei riformisti, ma mantenne una autorevolezza che nessun altro aveva nel campo socialista. Dovette battersi contro Mussolini, che sosteneva i sindacalisti rivoluzionari, lo sciopero generale ‘politico’ e svalutava il gradualismo in cui parte del PSI e soprattutto gli elettori si riconoscevano, anche per i risultati raggiunti. La guerra Dopo Serajevo si scatenò in Europa il finimondo, da tempo in preparazione. La scelta dei socialisti fu subito per il neutralismo, che però non fu condiviso a livello internazionale da altri partiti socialisti che seguirono linee patriottiche a difesa delle nazioni di appartenenza (Austria, Germania, Francia). Tuttavia le posizioni dei socialisti italiani non furono così schematiche e antinazionali come si è superficialmente detto. Già Anna Kuliscioff nel 1914 aveva intuito che i socialisti e l’Italia, pur mantenendo la neutralità, avrebbero dovuto schierarsi con le nazioni ‘più democratiche’, cioè quelle dell’Intesa, e non per ragioni di rivendicazioni nazionalistiche, ma per motivi ideali e politici. Anche Turati, pur con un atteggiamento rigido contro la guerra, guardava con simpatia verso Francia e Inghilterra, nazioni democratiche. Mussolini, Gramsci, Togliatti, Bissolati, Salvemini e Nenni (che allora era repubblicano) furono ‘interventisti’, a favore della guerra, contro Austria e Germania. I primi tre perché ne intravvedevano un’occasione rivoluzionaria, gli altri perché ne vedevano un completamento del Risorgimento. La prima guerra mondiale fece registrare in Italia, seicentomila morti, centinaia di migliaia di feriti e di invalidi. Fu un conflitto lungo (nessuno l’aveva previsto) di ‘trincee’ contrapposte. Dopo la rivoluzione sovietica, ottobre 1917, quando Lenin fece uscire la Russia dal conflitto (trattato di Brest-Litovsk a tutto vantaggio dei tedeschi) sembrava che la Germania dovesse uscire vincente. Lo sfondamento avvenuto sul fronte italiano a Soldato nella trincea dopo Caporetto Caporetto pareva essere la riprova del rafforzamento austro tedesco. Nel momento di difficoltà per l’Italia, Turati, pacifista e neutralista, seppe trovare le parole giuste per far uscire i socialisti dall’isolamento in cui erano finiti. L’avversione alla guerra non doveva tradursi nella indifferenza verso le sorti del Paese che rischiava di essere ancora occupato dagli austriaci. L’entrata in campo degli Stati Uniti, maggiori aiuti all’Italia dagli alleati, la sostituzione di Cadorna con Diaz, uno spirito patriottico popolare per la difesa dei confini, portò alla vittoria nel novembre 1918. Purtroppo la saggezza di Turati non fu sufficiente a impedire gli atteggiamenti estremisti e irresponsabili dei massimalisti nel dopoguerra, che furono una delle concause del successo del fascismo, verso il quale guardarono molti cittadini della classe media e anche molti proletari scontenti del velleitarismo dei loro capi. Verso il fascismo Il dopoguerra registrò alle elezioni del 1919 (con la legge elettorale proporzionale e il suffragio universale) il trionfo dei socialisti e il successo dei cattolici. Gli orientamenti massimalisti del PSI che predicavano l’avvento della rivoluzione e la necessità di istituire i soviet, portarono, dopo l’occupazione delle fabbriche, alla reazione violenta delle squadracce fasciste. Un esempio di comportamento saggio e di grande sensibilità verso i temi della politica internazionale avvenne con l’adesione di Turati alla linea del presidente americano Woodrow Wilson, propugnatore della Società delle Nazioni e sostenitore dell’autodeterminazione dei popoli. La sua presenza al ricevimento che il sindaco Emilio Caldara organizzò a Milano a Palazzo Marino il 5 gennaio 1919 in onore di Wilson, fu il segno della sua scelta, condivisa da Anna Kuliscioff. Turati, Treves, Buozzi, D’Aragona e altri riformisti, malgrado l’orientamento contrario alla partecipazione all’incontro deciso dal direttivo della sezione socialista milanese, non si tirarono indietro, e Caldara affermò nel saluto di parlare anche in nome delle idealità socialiste, in particolare a favore della autodeterminazione. Per questa iniziativa il Sindaco di Milano venne deferito alla Direzione del PSI per i provvedimenti disciplinari, anche se un anno dopo i massimalisti non rifiutarono la sua guida nella lista socialista che, grazie Anna Kuliscioff a lui, rivinse le elezioni amministrative e consentì l’elezione di Filippetti nel 1920. Si è detto ripetutamente che Turati, il quale previde in tempo le conseguenze nefaste dell’ondata massimalista e velleitariamente rivoluzionaria e il pericolo fascista, avrebbe dovuto con decisione costituire un governo con i cattolici e una parte dei liberali (anche a costo di una rottura del PSI) per bloccare il nascente fascismo. La storiografia contemporanea ha potuto chiarire come le cose non fossero così semplici e non dipendessero da Turati. Giolitti era ormai diffidente verso i socialisti. I cattolici pure. I riformisti erano una parte minoritaria del PSI. Il danno era già stato fatto nel 19191920 quando i moti ‘rivoluzionari’ senza rivoluzione, avevano provocato la reazione e compattato i ceti medi con l’ establishment agrario, industriale e clericale. Non fu sufficiente il magnifico e solido intervento ‘Rifare l’Italia’ con il quale Turati compose alla Camera, nel 1920, un moderno programma di governo: «…un discorso socialista e nello stesso tempo un programma di ricostruzione e di rinnovamento per tutto il Paese …il programma fondamento di un governo democratico socialista…» come aveva suggerito la Kuliscioff. La scissione da cui nacque, dal PSI, il Partito Comunista d’Italia nel 1921 (Bordiga e Gramsci) e l’espulsione, provocata da Serrati, di Turati, Treves e Matteotti che fondarono il Partito Socialista Unitario nel 1922 – furono alcuni degli atti che facilitarono l’ascesa di Mussolini alla Presidenza del Consiglio. Non fu una breve parentesi, come aveva intuito Turati. L’assassinio di Matteotti, segretario del PSU, mise definitivamente in luce che cosa si stava profilando con il governo Mussolini. Turati sconfitto e invecchiato non perse mai la sua grandezza d’animo e la visione lucida del dramma che aveva vissuto. Dopo la definitiva affermazione fascista, l’esilio era obbligato: a Milano egli era guardato a vista e intercettato. Con i poliziotti sul pianerottolo era quasi prigioniero nel suo domicilio, gli aprivano la posta e non gliela consegnavano. Per questo la fuga (organizzata tra gli altri da Carlo Rosselli e Sandro Pertini, suo discepolo) divenne inevitabile. Il ‘regime’ forse avrebbe preferito che rimanesse in Italia per dimostrare la sua tolleranza verso un oppositore. L’inevitabile silenzio imposto al grande leader sarebbe diventata complicità. A Parigi fu invece un faro dell’antifascismo, della democrazia, della pace. Redasse giornali, tenne viva la Concentrazione antifascista, favorì l’unificazione socialista con Nenni segretario del residuo PSI (1930), e denunciò il carattere totalitario e liberticida, oltreché del fascismo, del comunismo sovietico. La visione del socialismo di Turati e dei riformisti fu, per i tempi, moderna e democratica e in parte ancora attuale. Ristudiare Turati, che di nuovo rischia di essere dimenticato, farebbe bene alla sinistra italiana. Come scrisse Angelo Tasca «il socialismo italiano ha un destino ben tragico, poiché l’alta coscienza di taluni suoi capi gli è fatale quanto l’incoscienza degli altri». 8 Personaggi Personaggi Medaglia d’oro della Resistenza. «Visone» fu un eroico e irriducibile antifascista PESCE, UNA VITA "SENZA TREGUA" di Roberto CENATI I l 27 luglio del 2007 ci lasciava Giovanni Pesce, leggendario comandante partigiano, che ricordiamo con profonda commozione e rimpianto. Pesce nasce a Visone d'Acqui Terme il 22 febbraio 1918. Era ancora un bambino quando la sua famiglia dovette emigrare in Francia. A 13 anni era già al lavoro in una miniera della Grand'Combe, la zona mineraria delle Cevennes in cui vivevano i suoi. Aderì ancora ragazzino al Partito comunista e divenne anche segretario della Sezione giovanile. Fu uno dei discorsi a Parigi di Dolores Ibarruri, la Pasionaria, a convincerlo della necessità di arruolarsi nelle Brigate Internazionali, che nella Guerra civile spagnola sostenevano il regime democratico contro i fascisti di Franco. A Parigi, intanto, c'era stato l'appello di Pietro Nenni, Randolfo Pacciardi, Giorgio Amendola, dei fratelli Carlo e Nello Rosselli, riuniti nel Comitato unitario antifascista italiano, perché fosse costituito un battaglione di volontari nel nome di Garibaldi. Pesce fu tra i più giovani combattenti italiani inquadrati nelle Brigate Garibaldi. Ferito tre volte, sul fronte di Saragozza, nella battaglia di Brunete e al passaggio dell'Ebro, portò nel corpo, per tutta la sua vita, le schegge della ferita più grave. Rientrato in Italia nel 1940, Pesce viene arrestato ed inviato al confino a Ventotene. Ventotene fu per Pesce, come per molti confinati, una sorta di università proletaria. Servì a fargli conoscere la realtà del Paese, ad apprezzare l’amicizia e la solidarietà di tanti suoi compagni di prigionia. I più vicini alla sua crescita culturale furono Umberto Terracini, già quarantaquattrenne, avvocato, ebreo, in galera dal 1926 e Camilla Ravera, cinquantenne, insegnante, del gruppo dell’Ordine Nuovo di Gramsci. L’esperienza della Guerra di Spagna Gli antifascisti erano uomini non cresciuti soltanto nelle ideologie, ma erano ricchi anche di esperienze pratiche, politiche e militari. Gran parte di loro erano personaggi che avevano saputo mettere a frutto gli anni della guerra di Spagna. È il caso di dire che se il fascismo in Spagna vinse la battaglia iniziale della Seconda Guerra Mondiale, ancora in Spagna l’antifascismo creò i quadri e le premesse per la vittoria finale del 25 aprile. Infatti, quasi tutti i volontari italiani delle Brigate Internazionali, furono poi comandanti e commissari, dirigenti politici della Resistenza italiana ed europea. La guerra di Spagna dunque, se fu utilizzata dal fascismo per soggiogare il libero popolo spagnolo, seppe creare al tempo stesso l’unità dell’antifascismo che sta alla base del successo della Resistenza in tutta Europa. Nelle lezioni su “La Resistenza in Lombardia” tenute tra il febbraio e l’aprile del 1965 nella sala dei Congressi della Provincia di Milano, Francesco Scotti svolge una brillante relazione. Così raccontava della nascita delle formazioni Garibaldi: «L’annuncio dell’armistizio diffuso dalla radio la sera dell’8 settembre del 1943, ha colto tutti di sorpresa, anche a Milano, malgrado un simile evento fosse atteso da un giorno all’altro. Tuttavia una cosa fu subito chiara a molti di noi: che l’ora della lotta armata del popolo italiano contro i fascisti e i tedeschi era scoccata anche nel nostro Paese. Per la verità si era già provveduto a far rientrare clandestinamente dalla Francia alcuni militanti, forgiati politicamente e militarmente nella guerra di Spagna, poi in Francia, dove, nel corso di tre anni, si erano perfezionati come franchi tiratori e partigiani contro i tedeschi» 1). Proprio la mattina dell’8 settembre 1943 arrivarono a Milano Francesco Scotti ed Egisto Rubini, col compito di organizzare la lotta armata contro tedeschi e fascisti. Gappista a Torino e Milano Nel settembre del 1943 Giovanni Pesce è tra gli organizzatori dei G.A.P. a Torino; dal giugno del 1944 assume a Milano, dopo l'arresto e la morte di Rubini a San Vittore, il comando della 3ª G.A.P. Rubini. Con il suo arrivo nel capoluogo lombardo e il risveglio dell’attività gappista, si scatena una lotta senza quartiere ai nazifascisti, attraverso attentati, colpi di mano, sabotaggi, esecuzioni di spie e di torturatori. Dopo essere stato inviato a organizzare la lotta clandestina nella Valle Olona, Giovanni Pesce torna a Milano e rimane alla guida dei gappisti dal dicembre 1944 sino alla Liberazione. A guerra finita gli viene conferita la medaglia d’Oro al valor militare consegnatagli direttamente da Umberto Terracini, senatore della Repubblica e Presidente dell’Assemblea Costituente. Nella motivazione della Medaglia d'oro al valor militare concessa a "Visone" (questo il nome di battaglia di Giovanni Pesce, autore del bel libro “Senza tregua”), si legge tra l'altro «Ferito ad una gamba in un'audace e rischiosa impresa contro la radio trasmittente di Torino fortemente guardata da reparti tedeschi e fascisti, riusciva miracolosamente a sfuggire alla cattura portando in salvo un compagno gravemente ferito… In pieno giorno nel cuore della città di Torino affrontava da solo due ufficiali tedeschi e dopo averli abbattuti a colpi di pistola, ne uccideva altri due accorsi in aiuto dei primi e sopraffatto e caduto a terra fronteggiava coraggiosamente un gruppo di nazifascisti che apriva intenso fuoco contro di lui, riuscendo a porsi in salvo incolume…». Il 14 Luglio 1945, giorno della presa della Bastiglia, si sposa con Nori Brambilla, sua inseparabile compagna, che Giovanni ha conosciuto nella 3ª Gap, da lui diretta. Nell'ANPI Nel dopoguerra Giovani Pesce continua la sua attività nel PCI dove svolge incarichi legati alle tematiche resistenziali sino allo scioglimento del partito, iscrivendosi successivamente a Rifondazione Comunista di cui ha fatto parte sino alla sua scomparsa. Consigliere comunale a Milano dal 1953 per oltre dieci anni, Giovanni Pesce è stato Presidente dell’AICVAS (Associazione Italiana Combattenti Antifascisti di Spagna), esponente autorevole del Comitato nazionale dell’ANPI sin dalla sua costituzione e Vicepresidente Provinciale dell'ANPI, nonchè Presidente dell'ANPPIA di Milano e Presidente Onorario dell'ANPPIA Nazionale. Chi ha conosciuto la tenacia e la passione di Giovanni Pesce sarà difficile che dimentichi il suo fondamentale contributo all’arricchimento e alla conservazione della memoria storica, memoria che diventa cultura e quindi patrimonio di un popolo, della storia di una comunità. Nella sua azione e nei suoi scritti ha sempre richiamato il movimento democratico alla necessità di una forte presa di posizione a fronte della sempre più preoccupante ondata revisionistica che da anni si sta abbattendo sul nostro Paese, esortando nel contempo all’iniziativa e alla necessità di una ferma e urgente mobilitazione antifascista. Instancabile è sempre stato il suo impegno per tramandare alle giovani generazioni, con le quali è sempre riuscito a stabilire uno straordinario rapporto, il testamento dei Combattenti per la Libertà, i valori in nome dei quali essi lottarono, sacrificando le loro giovani vite. Per questo non smetteva mai di andare nelle scuole a parlare con gli studenti. Quando raccontava ai ragazzi squarci della sua vita complessa e ricca di contenuti, suscitava immediatamente la loro attenzione tanto che potevano stare delle ore ad ascoltarlo. «Se oggi siamo liberi – amava ripetere - è perché allora abbiamo combattuto». Tino Casali, allora Presidente dell’ANPI Provinciale di Milano, in un’affollata assemblea svoltasi il 18 settembre 2007, dopo la scomparsa di Pesce, nella storica sede dell’ANPI di via Mascagni, così ricordava Giovanni Pesce: «Sei stato uomo di parte, fiero di esserlo, come di parte sono gli uomini costretti a scegliere e quindi a prendere posizione in un momento cruciale per la storia nazionale. Scelta che fu per la libertà, scelta che facesti per tutti; scelta che diviene chiara e pienamente compresa attraverso i tuoi scritti. La tua vita ha espresso una chiara eticità che contraddistingue gli uomini onesti, leali ed intransigenti. Moneta rara in tempi così difficili e confusi». Rimangono indelebili la sua onestà intellettuale, la modestia e ironia e, a volte, il suo scanzonato modo di affrontare anche questioni importanti; la sua incessante passione di combattente per la libertà e per la politica, intesa nel senso più alto del termine. La Spagna nel cuore Pesce amava ricordare, tra i periodi più significativi della propria vita, quello trascorso in Spagna, con le Brigate Internazionali, impegnate nella guerra contro Franco e il nazifascismo. Nel libro-intervista di Giannantoni e Paolucci Giovanni Pesce “Visone” un comunista che ha fatto l’Italia, Pesce dichiara: «In Spagna ero un povero minatore che andava a combattere a fianco di tanti volontari italiani e stranieri. Gente che aveva lasciato la propria famiglia, genitori, fratelli, mogli e figli, gente che aveva gettato nella lotta la propria vita per quella di un altro popolo in grave difficoltà. Una storia altissima. Questa esperienza mi diede forza ideale, mi fece capire cosa fossero in concreto i valori della solidarietà, dell’umanità, dell’amicizia che a quei livelli non mi capitò mai di poter ritrovare né rivivere. Nella Resistenza eravamo tanti gruppi diversi, io ho fatto il gappista spesso da solo, anche se alle spalle avevo il Partito e il comando garibaldino. Ma era cosa diversa, l’afflato umano era minore. La Spagna ha rappresentato invece il richiamo per eccellenza ai più alti ideali di tutto il Novecento. Una storia che ha unito le persone più diverse in un comune percorso ideale. E’ stata l’ultima grande epopea del secolo breve». 2) E all’intervistatore che nel libro gli chiede cosa direbbe ad un giovane diciottenne per orientarlo politicamente e moralmente in un Paese come è oggi l’Italia, Pesce risponde: «Gli direi quello che hanno detto a me allora,. di avere fiducia e di coltivare la speranza. La fiducia si conquista con la lotta quotidiana ma è anche una fede; la speranza è il motore che ti fa andare avanti. Ricordo che quando facevo il gappista, soprattutto nel periodo di Torino, solo in casa, al limite della disperazione, compreso nei pensieri dell’azione che avrei dovuto compiere, sopravvivevo perché ero fiducioso e perché speravo che la lotta un giorno si sarebbe conclusa vittoriosamente». E conclude: «Ho ancora fiducia e speranza. Ho vissuto sempre così e morirò così». 1) Comitato per le celebrazioni del XX Anniversario della Resistenza (a cura di), La Resistenza in Lombardia, Labor, Milano, 1965; 2) F. Giannantoni, I. Paolucci, Giovanni Pesce “Visone” un comunista che ha fatto l'Italia, Arterigere, Varese, 2005; 3) F. Giannantoni, I.Paolucci, op. citata Nori Brambilla sotto un murales dedicato a Giovanni “Visone” Pesce 9 10 Luoghi della Memoria 11 Luoghi della Memoria Ponza e Ventotene: è qui che i confinati organizzano la Resistenza di Elisabetta VILLAGGIO L a bellissima isola di Ponza, che Folco Quilici definì tra le più incantevoli del mondo, si affaccia nel Mar Tirreno di fronte al golfo di Gaeta. Un lembo di terra stretto e lungo, che raggiunge poco di più di sette chilometri nel suo punto più lungo e due nel punto di massima larghezza, circondata da un mare i cui colori vanno dall’azzurro chiaro al blu notte e al verde-grigio. Questo luogo incantato è stato la dimora di alcuni confinati. Già all’inizio del secolo scorso, intorno al 1910, arrivarono i primi: libici catturati durante la guerra d’Africa. Durante la Prima Guerra Mondiale furono mandati al confino prigionieri politici sospettati di essere vicini alla Germania o l’Austria e tra il ’21 e il ’28 vennero mandati militari in punizione. È con il 1928 che l’isola inizia ad avere una vera e propria colonia di confino politico assieme alla vicina Ventotene. Molti di loro, all’epoca giovani socialisti o comunisti lontani dal regime, divennero poi famosi. Tra il 1928 e il 1943, le due isole pontine, a un braccio di mare da Formia e Gaeta, ospitarono il gotha dell'opposizione al regime fascista: Sandro Pertini, Pietro Nenni, Luigi Settembrini, Giorgio Amendola. In quegli anni sbarcarono circa 4.400 confinati politici (2.100 a Ponza e 2.292 a Ventotene) e vi trascorsero periodi a volte molto lunghi, pagando così la loro opposizione al fascismo. L’ironia della sorte fu che, per undici giorni, dal 27 luglio al 7 agosto 1943, dopo la caduta del regime, anche Benito Mussolini è relegato a Ponza. In quegli stessi giorni c’è anche Nenni. Mussolini e Nenni erano diventati amici nel 1911: dopo aver partecipato a una manifestazione contro la guerra in Libia, avevano condiviso la stessa cella nel carcere di Forlì. Benito, romagnolo di Predappio, ha 28 anni, socialista massimalista, è figlio di un fabbro; Pietro, romagnolo di Faenza, 20 anni, repubblicano, è cresciuto in un orfanotrofio. Trent’anni dopo si rivedono. È luglio 1943 quando Nenni apprende dal maresciallo Lambiase una notizia sbalorditiva: Mussolini sta per essere trasferito dai carabinieri proprio lì, su quell'isola di reietti. Nenni si affaccia, scopre che è tutto vero e annota sul diario: “Dalla finestra della mia stanza ora vedo col cannocchiale Mussolini: è anch'egli alla finestra, in maniche di camicia e si passa nervosamente il fazzoletto sulla fronte. Scherzi del destino! Trenta anni fa eravamo in carcere assieme, legati da un’amicizia che paresse sfidare le tempeste della vita, oggi eccoci entrambi confinati nella stessa isola: io per decisione sua, egli per decisione del re”. E anni più tardi proprio Edda Ciano racconterà a un giovane Zavoli: «A quei due li legava la Romagna, la povertà, la testa dura. E la galera». Racconterà Sandro Pertini ciò che successe nella redazione dell’Avanti!, il 28 aprile 1945, quando arrivò la notizia della fucilazione di Mussolini: «Nenni aveva gli occhi rossi, era molto commosso, ma volle ugualmente dettare il titolo: Giustizia è fatta». Su questo argomento è stata realizzata l’opera teatrale, “Confinati a Ponza” da un’idea di Francesco Maria Cordella, che la dirige e la interpreta, e che sarà riproposta il prossimo inverno. «L'idea è venuta un anno fa quando, tornando a Ponza, seppi della morte, avvenuta nel 2012, a 104 anni, della signora Luisa De Luca. Era stata per anni a contatto dei confinati, da Pertini a Nenni. La signora ha aiutato molto Nenni che era arrivato in condizioni tragiche. Era una donna con un grandissimo cuore che aiutava come poteva i confinati», racconta Cordella. L'isola di Ventotene negli anni Trenta Contattiamo Salvatore Spignesi, il terzogenito della signora De Luca. Salvatore è un arzillo ottantenne che ricorda quel periodo, anche se aveva solo 5-6 anni. Signor Spignesi cosa ricorda di quel periodo? Ero piccolo, ricordo solo poche cosette. Mi ricordo di Amendola che mi teneva sempre con lui, mi chiamava il cicchitto, e questo nome mi è rimasto. Ogni tanto mi mandava a comprargli noci o fichi secchi. C’era Pertini, si era fidanzato con una ragazza di Ponza, Giuseppina Mazzella, che poi è andata in America. (La signora Mazzella, tornando in Italia, incontra Pertini negli anni ’70 quando lui era Presidente della Camera. In una conferenza a Ponza di qualche anno fa racconta che la sua famiglia si oppose a quell’unione e lei era sempre controllata e pedinata. ndr) Foto di gruppo dei confinati a Ventotene nel 1940 Com’erano i confinati e che rapporto avevano con i ponzesi? Erano brave persone che non davano fastidio. Erano gentili e mia madre era la loro cuoca. Mio padre e mia madre li dovevano sorvegliare. Quando arrivavano i familiari da fuori a trovarli mio padre chiudeva un occhio. Sua madre le raccontava qualcosa? Mia madre raccontava sempre a chi piaceva la cucina così a chi colà. Ha cucinato anche per Mussolini che le diede una lettera da dare al parroco Don Luigi Dies. Dentro, oltre la lettera che chiedeva una messa per il figlio Bruno caduto in guerra, c’erano mille lire. Ce l’ho ancora la lettera e dice: «Sono Benito Mussolini e non per mia volontà mi trovo a Ponza, le accludo mille lire e le chiedo di fare una messa in suffragio di mio figlio Bruno». Al momento dell’arrivo, i confinati ricevevano un libretto rosso sul quale erano indicate le regole del confino. I confinati giungevano a Ponza e a Ventotene a piccoli gruppi, incatenati fra loro. L’impatto con la nuova vita era devastante. Oltre alla promiscuità nei cameroni, si dovettero adattare alla precarietà dei rifornimenti, alle angherie dei militi, alla mancanza di comunicazioni, alla fame e alla noia. Nonostante le privazioni, i confinati organizzarono biblioteche, mense autogestite, attività artigianali, corsi di studio. A Ponza e a Ventotene si formò una parte rilevante della classe politica che avrebbe fatto la Resistenza e sarebbe stata protagonista della Repubblica. A Ponza, che assieme a Lipari fu la prima colonia di confino politico istituita dal regime mussoliniano, vi transitò anche Giorgio Amendola, che dedicò a questa esperienza un celebre libro, L’isola, da cui il regista Carlo Lizzani ricavò uno sceneggiato televisivo. Giorgio Amendola, arrestato nel giugno del 1932, mentre era in missione clandestina a Milano, non fu processato e fu mandato, senza processo, al confino nell'isola di Ponza dove, il 10 luglio1934, si sposò civilmente con la sua fidanzata francese, Germaine Lecocq. Scriveva Amendola: «Mi sorprende, oggi, ricordare come sopportai agevolmente quella condizione per me innaturale, col mio carattere espansivo ed estroverso. Mi organizzai la giornata. Ordinai subito Il capitale, La divina commedia, e fu la prima lettura accurata di quel libro ricco di passioni umane e civili, del padre della nostra letteratura. Ordinai pure un manuale di ginnastica da camera. Germaine manifestò subito la sua volontà di ottenere il permesso di raggiungermi e di sposarmi. Invano le prospettai le difficoltà della vita al confino. Sotto un’apparente remissività c’era in lei una forza di volontà che si manifestava nelle cose essenziali, una durezza interna anche, la capacità di saper attendere, pur di raggiungere quello che aveva deciso. L’amore non si misurava, per lei, nella molteplicità dei rapporti, valutabili quantitativamente, ma nella loro qualità, intensità, profondità. Romanticismo? Può darsi. Per me non è un’offesa». Il confino a Ponza nonostante la bellezza del luogo fu duro non solo per i confinati ma anche per gli isolani stessi perché durante la guerra non arrivavano più rifornimenti di viveri dalla terra ferma a causa dei continui bombardamenti degli inglesi alle navi che varcavano quel tratto di mare. Oggi il luogo dove furono relegati i confinati, sotto la Torre dei Borboni, è stato trasformato in albergo. 12 Personaggi 13 Personaggi Mariano Girotti: l’indomito antifascista conosciuto come “il Lupo dell'Appennino” di Alberto DI MARIA I n questi tempi in cui, in particolare nella politica, si registra una profonda crisi di credibilità e la carenza di figure di riferimento, può essere una buona idea rivolgere lo sguardo al passato e interrogare la Storia affinché ci restituisca vicende esemplari, anche di personaggi meno noti, che possano ridare fiducia e rappresentare modelli di virtù per chi è deciso ad impegnarsi seriamente nella cosa pubblica. Vicende come quella di Mariano Girotti, nato nel 1882 a Castiglione dei Pepoli, un piccolo ma importante centro della provincia bolognese, precisamente incastonato sulle pendici dell'Appennino tra la regione emiliana e quella toscana. La storia politica di Mariano Girotti, come ha raccontato lui stesso allo storico Luciano Bergonzini, inizia nella primavera del 1896 quando assistette, giovanissimo, a una «marcia della fame» di alcuni abitanti di Baragazza, una frazione di Castiglione, che «con uno straccio rosso per bandiera» assalirono i forni del pane del capoluogo, per poi essere duramente repressi dalla forza pubblica. Erano gli anni della crisi che colpì l'Italia di fine Ottocento, quando disoccupazione, carovita e malattie provocarono gravi disordini come a Milano dove, nel maggio del 1898, il generale Bava Beccaris diede l'ordine di sparare sulla folla, rendendosi responsabile di un centinaio di morti e di un migliaio di feriti. Castiglione era in quel periodo un paese governato da alcuni signorotti, responsabili di una gestione privatistica del comune e inamovibili dalle proprie posizioni di privilegio, garanti di quella rete clientelare che assicurava al deputato liberale del collegio di riferimento un sicuro bacino voti. Notabili protagonisti di abusi come il far pagare la concessione del passaporto per l'interno, indispensabile per andare fuori del comune per lavoro, una scelta obbligata per le famiglie meno abbienti di una montagna povera di superfici coltivabili, che sopravvivevano grazie alle rimesse dell'emigrazione stagionale. Tuttavia, fu proprio grazie alle migrazioni stagionali che giunsero in montagna gli esempi e le idee fondamentali del socialismo che altrove era già una realtà diffusa. In quegli anni infatti, il Partito socialista italiano (Psi) di Andrea Costa e Filippo Turati, fondato a Genova nel 1892, era in piena ascesa soprattutto nell'area padana dove sviluppò un particolare legame con il bracciantato, base decisiva per le sue prime affermazioni elettorali. Non a caso storici come Guido Crainz o Maurizio Degl'Innocenti, hanno più volte sottolineato come la componente rurale sia stata un fatto peculiare del socialismo italiano, con pochi eguali se non, per certi versi, unico in Europa per dimensioni. La penetrazione e l'espansione dell'economia capitalistica nelle campagne padane, negli anni Ottanta dell'Ottocento, aveva portato a una radicale proletarizzazione del lavoro contadino e ad un generale peggioramento delle condizioni di vita dei braccianti che furono motivo di una progressiva crescita di coscienza dei propri diritti e causa scatenante - a partire dai moti de «La boje!» del 1884 e del 1885, con epicentro il Polesine - dell'antagonismo Foto segnaletica dal CPC di Mariano Girotti dei lavoratori delle campagne. Si cominciarono a sperimentare la cooperazione di lavoro per scongiurare disoccupazione ed emigrazione; a immaginare nuove forme di rappresentanza sociale ed economica, le leghe di mestiere; e ad avanzare piattaforme rivendicative che ammettevano il ricorso allo sciopero. Si presero le distanze, nota lo storico Renato Zangheri, dalla «rivolta disordinata e senza speranza». Questo modelli si estesero per contagio, raggiungendo anche le popolazioni delle montagne dell'Appennino e di paesi come Castiglione dei Pepoli dove, abbiamo visto, cominciarono ad essere sventolati i primi «stracci rossi». La genesi del movimento socialista di Castiglione fu scandita da alcune date significative tutte legate alla figura di Mariano Girotti: nel 1898 nacque per sua iniziativa la prima sezione socialista del paese; nel 1906 la cooperativa di consumo di cui fu il primo presidente; nello stesso 1906 fu eletto consigliere comunale ed era la prima volta che un socialista entrava in comune. Come amministratore si impegnò in battaglie come quella per l'assistenza sanitaria, quella per l'estensione dei servizi essenziali alle frazioni del paese, e nell'incessante opera di denuncia della sovrapposizione tra gli interessi pubblici e quelli privati dei notabili che fino a quel momento avevano governato indisturbati il paese. Di pari passo con l'attività politica, lungo il primo decennio del Novecento, Mariano Girotti – da allora noto come “il lupo dell'Appennino” - si impegnò anche nell'attività sindacale, organizzando i lavoratori di due importanti cantieri pubblici del castiglionese: quello della strada provinciale tra Castiglione e Camugnano e quello dell'imponente diga delle Scalere. L'attivismo mise inevitabilmente al centro delle attenzioni delle autorità colui che nei rapporti di polizia veniva definito in modo sprezzante il «capo del partito socialista di Castiglione dei Pepoli e di un gruppo di giovinastri del luogo». Innumerevoli le denunce e le condanne subite: per ingiurie, oltraggio, affissione abusiva di manifesti, manifestazione non autorizzata, disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi notturni, rissa, resistenza e violenza; fino a quando, nel giugno del 1910, fu proposto per l'ammonizione giudiziaria, uno strumento di restrizione delle libertà personali, spesso utilizzato per impedire l'attività di personaggi ritenuti pericolosi per l'ordine sociale e politico. La proposta, che il periodico socialista “La Squilla” definiva una «canagliata poliziesca» volta a sanzionare l'attività politica di un'«anima bella d'impulsi generosi e di fede», fu tuttavia respinta dal Tribunale di Bologna. Puntualmente riconfermato nella carica di consigliere in tutti gli appuntamenti elettorali, la svolta nella carriera di amministratore avvenne nel marzo del 1916 quando, in circostanze eccezionali, fu nominato sindaco del paese. Nel luglio 1915 infatti, con l'Italia in guerra da pochi mesi, l'allora sindaco di Castiglione, convinto interventista, si dimise per rispondere alla chiamata alle armi. Il paese rimase senza guida per diversi mesi fino a quando Girotti fu designato dal consiglio come successore. Unico consigliere socialista del comune, la sua nomina ebbe del sorprendente. Tuttavia, come rilevato dall'allora sottoprefetto di Vergato, la tragica situazione economica del comune, aggravata dalla guerra, richiedeva che l'amministrazione comunale fosse consegnata in mani esperte e Girotti, «il più capace degli amministratori», sembrò l'unica scelta possibile». Sicuramente l'esperienza acquisita come presidente della cooperativa di consumo faceva di lui la persona più adatta per gestire una questione di cruciale importanza: il contenimento della spesa e il concentramento delle risorse economiche sul reperimento degli approvvigionamenti destinati alla popolazione. Durante la Grande guerra furono soprattutto gli amministratori socialisti, laddove governavano, ad affrontare con maggiore decisione i vari problemi riguardanti i consumi e l'assistenza alla popolazione. Bologna si distinse per le coraggiose iniziative prese dal primo cittadino Francesco Zanardi: il «sindaco del pane» concentrò l'azione del suo governo sul versante dell'entrate, rivedendo le aliquote in senso progressivo, come da tradizione del «municipalismo popolare», per finanziare provvedimenti e iniziative sociali a favore dei ceti popolari più deboli, maggiormente colpiti dalle conseguenze del conflitto. Come Zanardi a Bologna, anche Girotti a Castiglione s'impegnò personalmente nel reperimento e la distribuzione di granaglie tra la popolazione. Per tutto il suo mandato il sindaco socialista riuscì a controllare le proteste sulla scarsità del pane, anche grazie all'autorevolezza riconosciuta dalla popolazione, tanto che in quegli anni Castiglione fu uno dei pochi paesi del circondario nei quali non si verificarono agitazioni e manifestazioni di protesta contro la guerra, mentre altrove si registrarono spesso scontri con le forze dell'ordine, sassaiole contro le case dei possidenti e invasioni di municipi. Nel primo dopoguerra Girotti aderì alla corrente massimalista del PSI, si dimise dalla carica di sindaco e, nel «biennio rosso», organizzò le manifestazioni di protesta dei disoccupati del castiglionese che chiedevano di essere impiegati nei nuovi cantieri del Brasimone e in quelli della Grande Galleria dell'Appennino, imponente opera parte del tracciato della Ferrovia Direttissima tra Bologna e Firenze. L'impegno gli valse il trionfo personale alle elezioni amministrative dell'autunno 1920, in seguito alle quali fu eletto consigliere provinciale a Bologna e nuovamente sindaco di Castiglione, nominato da una lista socialista che aveva raccolto quasi il 94% dei consensi. Pochi mesi dopo fu il delegato dei socialisti castiglionesi al congresso di Livorno. In autunno aveva aderito alla circolare Marabini-Graziadei e al congresso fu tra coloro che uscirono dalla sala del Teatro Goldoni e, intonando l'Internazionale, si recarono al Teatro San Marco per dare vita al Partito Comunista d'Italia (PCdI). Nell'aprile del 1921, nel pieno dell'ondata di violenza scatenata dallo squadrismo fascista, si tennero le elezioni politiche. Quelle del 1919 avevano visto una straordinaria affermazione del PSI. L'esito delle elezioni non modificò sostanzialmente lo scenario politico del paese, sostanzialmente ingovernabile se non attraverso alleanze impossibili tra le principali forze del paese: socialisti, popolari e liberali. Novità assoluta in Parlamento furono i 35 deputati fascisti, tra i quali Benito Mussolini. Anche nella provincia di Bologna - dove Mariano Girotti, candidato nella lista del PCdI, con sole 1040 preferenze ricevute non riuscì ad essere eletto in Parlamento - l'esito della consultazione elettorale, nonostante le gravi violazioni della libertà di voto e l'atmosfera di terrore nel quale si era svolta, non mutò gli equilibri. Fu allora che i fascisti decisero di mettere in atto una seconda ondata di violenze nella provincia rurale. Castiglione dei Pepoli, località fino a quel momento non raggiunta dalla violenza delle squadre d'azione, divenne un importante obiettivo per i fascisti, interessati a sostituirsi ai sindacati “rossi” nella rappresentanza dei lavoratori disoccupati nella loro battaglia per essere assunti nei cantieri della Direttissima. Nell'estate del 1921 gli agguati fascisti a Castiglione culminarono il 29 agosto in un grave fatto di sangue avvenuto a Baragazza dove, in seguito al ferimento di un militante socialista e alla morte della moglie di uno degli autori del ferimento, un noto squadrista bolognese, le rappresaglie delle squadracce di Peppino Ambrosi con le forze dell'ordine conniventi furono violentissime. In seguito ai «fatti di Baragazza» i 27 arrestati, tutti socialisti e comunisti, subirono nella primavera del 1923 una sentenza politica che li condannava a più di trecento anni di carcere in totale. Nei primi giorni del settembre 1921, il movimento socialcomunista di Castiglione si sfaldò completamente perché in molti scapparono, la maggior parte diretti in Francia, per sfuggire ai propositi di vendetta dei fascisti. Girotti, si rifugiò a Firenze, dove in novembre gli fu notificato un decreto regio che lo destituiva dalla carica di sindaco di Castiglione, perché ritenuto responsabile di avere sobillato «le masse con ogni sorta di veleni», di averle influenzate con «uno spirito rivoluzionario altissimo» e di avere fatto «propaganda contro i poteri dello Stato». Nei primi mesi del 1922, Girotti fece ritorno a Castiglione ma la sua presenza non fu tollerata dai fascisti di Castiglione: i vecchi notabili liberali che avevano indossato la camicia nera e i loro rampolli. La sua casa fu ininterrottamente assediata, i suoi familiari minacciati e intimiditi, mentre i fascisti inscenavano manifestazioni di protesta. Nel febbraio del 1922 l'ex sindaco, anche per volontà della famiglia, lasciò definitivamente Castiglione dei Pepoli e l'Italia. Poco meno di un anno dopo, nell'ottobre del 1922, con la Marcia su Roma, Mussolini si insediò al governo. Negli anni Venti e Trenta, Girotti visse in Francia e in Belgio per poi stabilirsi a Nizza. Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale, fece ritorno in Italia ma gli fu impedito di dimorare a Castiglione. Si stabilì prima a Roma e poi a Bologna, dove fu un punto di riferimento costante per i partigiani della celebre Stella Rossa-Lupo che operavano nel castiglionese, a ridosso della Linea Gotica. Nel secondo dopoguerra tornò a Castiglione dove, all'inizio degli anni Cinquanta, come a chiusura di un cerchio rimasto per troppo tempo aperto, fu eletto nuovamente sindaco del paese, a distanza di circa trent'anni dalla sua destituzione, avvenuta per decisione di un governo e di una monarchia che si dicevano liberali ma che cedettero al ricatto dello squadrismo fascista. Rimase in carica oltre dieci anni, fino a poco tempo prima della sua morte avvenuta nel 1963. Mariano Girotti tra la gente di Castiglione dei Pepoli Italia smemorata 14 15 Personaggi Storia di un fiero antifascista, Claudio Cecchi, pesarese cultore degli ideali di giustizia COSÍ SCONFIGGEMMO I NAZISTI NELLA BATTAGLIA DI PARAVENTO SIAMO INVASI DAI SIMBOLI DEL FASCISMO EPPURE FACCIAMO FINTA DI NON VEDERLI Foto e testo di Alessandro VECCHI di Filippo SENATORE Q uando un uomo proviene da una famiglia adamantina educata alla scuola della lealtà e del dovere non possono sorgere in lui che atti di slancio e giustizia. Claudio Cecchi era un ragazzo che aveva visto la fulgida carriera diplomatica del padre Igino dissolversi di fronte al dissenso aperto verso il regime di Mussolini pagato duramente con la prigione e l’esilio. La sua solida passione etica si forgiava nelle avversità familiari conservando quel carattere pieno di slanci e di entusiasmi per un mondo migliore. La sua adesione alla Resistenza partigiana nelle Brigate Garibaldi costituì l’approdo naturale di un sentimento morale. Nato a Pesaro il 20 gennaio 1922 (ivi morto nel 2013) Claudio apparteneva ad una gioventù che aspirava alla conquista del sapere e all’amore per i vinti. Ne suo diario Cronistoria della mia vita (1922- 1950) Cecchi descrive e decifra quel mondo spezzato dal fascismo, attraverso diari e saltuari appunti suoi e dei famigliari più cari. Si ha un senso di sgomento nel vedere un giovane affrontare la vita senza lasciarsi prendere dal disincanto. Il 19 giugno 1944 una piccola squadra del distaccamento Pisacane, guidata dal commissario politico Claudio Cecchi ebbe uno scontro a fuoco con un automezzo tedesco nella zona di Acquaviva di Cagli. I tedeschi erano in ricognizione per trovare un posto dove far acquartierare un'unità di alpini (Alpenjäger) della V divisione di montagna in sosta nella zona di Cagli, probabilmente destinata a potenziare la difesa sulla Linea gotica. Un germanico fu ucciso, un altro, ferito, riuscì a fuggire e altri due furono fatti prigionieri dai partigiani. Un’unità motorizzata partita da Cagli portò uomini e armi in prossimità dell’accampamento partigiano situato su un costone del Catria che dominava la valle, in località Paravento. Claudio Cecchi, protagonista di quei fatti così ricorda: «L'arrivo dei tedeschi fu fulmineo. Dopo meno di un paio di ore, intorno a mezzogiorno, scorgemmo a valle lungo la strada una lunga colonna motorizzata proveniente da Cagli, costituita da numerosissimi camion e vetture militari. In breve tempo il reparto ci fu sotto, e subito iniziò lo scontro al quale nel frattempo ci eravamo frettolosamente preparati. Loro, vicini e protetti da un ciglio roccioso, noi, una quarantina, con a disposizione una mitragliatrice Breda, un mitragliatore, qualche fucile e alcuni Sten. Più dietro, utilizzato sotto stretta sorveglianza nei preparativi necessari per un eventuale o improvviso ordine di ripiegamento, avevamo un gruppo di una trentina di persone, diciannove delle quali appartenevano agli organici della Questura di Pesaro, dalla quale avevano preso prudentemente il largo. Si erano presentate in due tempi, parte il 14, parte il 15, portando seco due motofurgoni Benelli, la mitragliatrice, dei moschetti, dei caricatori e del vestiario. Asserendo lealtà, chiedevano protezione nel verosimile intento di precostituirsi qualche merito in previsione di una non lontana liberazione della città. Il combattimento, durissimo, si svolse con nostra ferma resistenza fino a quando cioè l'oscurità costrinse finalmente i tedeschi a ritirarsi (quel pomeriggio estivo ci sembrò assai più lungo di quanto già non fosse). Così si concluse vittoriosamente quella memorabile giornata che segnò il nostro primo successo. I partigiani cercarono di arretrare per sfuggire all’accerchiamento e trovare una nuova posizione di difesa. «Occorreva, perché riuscisse, infatti effettuare un'operazione molto ordinata e composta, che non facesse trapelar nulla dei nostri movimenti e nel contempo non lasciasse tracce capaci di dar adito a un'impressione di sbandamento. Dovevamo non solo provvedere allo sgombero di quanto c'era nell'accampamento ma altresì contenere il più a lungo possibile l'avversario onde consentire lo svolgimento sicuro della nostra manovra. Questo compito, ce lo assumemmo io come commissario politico, e due compagni che si offrirono coraggiosamente a restare con me: io alla mitragliatrice Breda di nuovo acquisto, uno dei due armato di uno Sten, l’altro di un fucile. Eravamo fortunatamente provvisti di un sufficiente quantitativo di munizioni. Lo spostamento del distaccamento e del gruppo di civili, favorito dal bosco sul limitare del quale ci eravamo costruiti il nostro piccolo villaggio (costruito con tronchi d'albero, con rami frondosi e pelliccia di prato) e dalla buona conoscenza del luogo grazie alla presenza di alcuni compagni di Cantiano e di Chiaserna, riuscì perfettamente. Col successo quasi in pugno, i tedeschi non seppero sfruttarlo. Molto critica si era fatta invece la situazione di noi tre. Non so come riuscimmo a cavarcela, ma tenemmo duro per oltre mezz'ora, fino a quando, cioè, giudicammo che il nostro reparto fosse al sicuro. Nel momento di lasciare la postazione, che era quello di maggior pericolo perché non più difesa, fummo a un tratto avvolti ed occultati da una nube così fitta che, se da un lato scomparimmo del tutto alla vista del nemico, dall'altro ce ne insorse qualche difficoltà di movimento e il rischio di qualche brusco quanto mai indesiderato incontro. Appesantiti com'eravamo dai nostri fardelli, vagammo a lungo perduti nel bosco fino a quando ci accolse per la notte un piccolo capanno (…). All'alba la giornata si presentava serena. Riprendemmo il cammino e nella tarda mattinata raggiungemmo finalmente il distaccamento che trovammo integro in località Pian d'Ortica, nella sella tra le due vette del monte Catria. Si era molto temuto che fossimo stati uccisi o catturati e rivederci fu di grande sollievo per tutti ». Giunse sul posto una delegazione di quattro persone capeggiata da un prete, con la notizia che i germanici, per rappresaglia alla perdita di tre uomini (il sottufficiale morto e i due soldati catturati), avevano preso in ostaggio a Cagli trenta persone che sarebbero state fucilate se non avessero liberato i due militari. Cecchi mandò a dire ai teutonici, attraverso la delegazione, che i due prigionieri essendo austriaci si consideravano vittime del nazismo e avevano deciso di passare le linee per ricongiungersi agli alleati. Cecchi non cedette al ricatto e dopo alcuni giorni giunse la notizia del rilascio. Il Pisacane si ricongiunse al resto della brigata. Cecchi ebbe l’affidamento del comando dell’intero I battaglione, di cui il Pisacane era solo uno dei distaccamenti, insieme al Fastiggi e al Gramsci. Claudio Cecchi in questa azione partigiana utilizzò le sue conoscenze (parlava in modo impeccabile il tedesco ) e una raffinata tattica, usata magistralmente nei momenti di grave pericolo. Così con poche armi e uomini risolse a favore della sua brigata l’esito della battaglia. Fatti memorabili che ricordano episodi omerici dove gli eroi, scaltri e senza macchia, vincono le più belle battaglie della vita. Bassorilievo di Mussolini a cavallo a Palazzo Uffici. Eur, Roma La maggior parte di noi ci passa accanto senza notarli. Li calpestiamo, li guardiamo. Senza vederli. Li abbiamo nel centro storico e nelle periferie, all'ingresso di edifici pubblici, sui tombini e sulle fontane, sui lampioni e sui muri, scritti in latino o in italiano. Alcuni monumentali e sfacciati, altri piccoli e defilati: i simboli del fascismo, e quelli che al fascismo inneggiano, riempiono il Bel Paese. Con “simboli del fascismo”, non si intende parlare delle architetture razionaliste presenti in tutto lo stivale, né dei segni vergati da contemporanei reazionari che riempiono muri con spray e cartellonistica nostalgica. Il riferimento è, invece, a quelle tracce tangibili del ventennio, giunte fino a noi, sopravvivendo alla rabbia popolare, ai reduci, alle associazioni antifasciste, alle istituzioni, alle comunità ebraiche, al '68, al vandalismo, alle migliaia di manifestazioni di stampo antifascista. Sopravvissute al Tempo e alla Storia: a un tentativo di Damnatio Memoriae iniziato nel dopoguerra, e mai completato nell'immediato dopoguerra. Rimangono lì e, in gran parte, a portata di mano. L'assenza di volontà nell'affrontare la questione è evidente. Le tracce del fascismo sono abbandonate a se stesse o ristrutturate, senza che vengano contestualizzate, storicizzate, commentate. Così troviamo l'obelisco che riporta - a caratteri cubitali - il nome di Mussolini al Foro Italico di Roma, dove mosaici esortano al mai morto “molti nemici, molto onore”, o ricordano chi ha votato la propria vita alla “causa” con la frase “Duce la nostra giovinezza a voi dedichiamo”. L'ingresso del comando della polizia municipale di Pomezia, con due enormi fasci littori a colonne d'ingresso; e, ancora, l'iscrizione che campeggia sul palazzo dell'INA a Piazza S. Andrea Della Valle a Roma, omaggio alla guerra d’espansione: 'Italiae fines promovit bellica virtus et novus in nostra funditur urbe decor'. In questi ed altri luoghi, come le decine di paesini italiani che hanno scelto di restaurare le frasi attribuite Italia smemorata 16 Italia smemorata 17 Fascio littorio a Piazza Affari sullo sfondo il “Dito” di Cattelan un “saluto fascista mozzato”, Milano Regionale della Libera Università di Bolzano. Eccone uno stralcio: “[...] Storicizzare significa fare in modo che il Monumento alla Vittoria e il “duce a cavallo” di piazza Tribunale appaiano, in forme chiare e inequivocabili, quali segni della loro epoca storica. Attraverso un’appropriata opera d’informazione va reso esplicito il loro spirito totalitario e contrario a ogni sentimento di umanità: chiunque vi passi davanti, locale o turista che sia e soprattutto se giovane, deve immediatamente percepire e avere l’opportunità di comprendere come tali monumenti siano figli di un regime, che si è servito della violenza, del razzismo e della guerra quali strumenti di potere e che ha eretto tali architetture per esaltare i propri inaccettabili fini.” Lapidi alla stazione centrale di Milano (una ricorda i deportati l'altra i soldati morti nelle guerre coloniali fasciste) al Duce con tanto di firma in calce, non un pannello, non una spiegazione, non uno stimolo all’interpretazione e alla contestualizzazione storica. Sono presenti fasci littori persino ai confini del ghetto di Roma. Ne è piena la maestosa stazione di Milano: la stessa che ospita il memoriale della Shoah “Binario 21” dove campeggiano inoltre, per la fiera dell'assurdo, due targhe, a pochi centimetri, divise solo da un gladio (!): una che celebra i fascisti caduti nella guerra d'invasione d'Etiopia, e l’altra le vittime delle deportazioni appena citate. Incredibile pensare che quando posero la seconda, in anni recenti, non si sia avvertito lo stridio dell’accostamento. Ogni singolo lampione di Piazza del Duomo a Milano è marchiato con 3 fasci e, eccezion fatta per uno di questi sfondato con un martello(?), gli altri sono tutti intatti. Così, diverse scuole italiane riportano sulle facciate segni inequivocabili: il più impressionante è forse il Liceo Righi di Bologna, dove è visibile un manipolo di uomini che si adopera in un virile saluto romano. D'altronde, la riprova che il sentore comune sia intorpidito riguardo a certi temi arriva da Bari, dove l'università (oggi Aldo Moro) fino al 2010 era intitolata a Benito Mussolini. Sporadicamente si levano voci su questo o quel caso, ma a oggi difficilmente si è usciti dalla dimensione locale, come se il fascismo non avesse interessato tutto il Paese, come se non fosse tutta la nazione a doverne affrontare la memoria. È cronaca degli ultimi giorni la dichiarazione del Presidente della Camera Laura Boldrini che a margine di un incontro con i partigiani ha, in una battuta, auspicato la cancellazione del nome di Mussolini dall'obelisco del foro italico come se la soluzione per affrontare il proprio passato potesse passare per la sua archiviazione, la sua negazione. Bolzano, al contrario, sembra aver voluto fare i conti con la propria storia: dal 2014 un percorso didattico e un'installazione si contrappongono all'immobilità di quel regime, raccontando attraverso l'epopea stessa del gigantesco Monumento alla Vittoria, ora sede del museo, la dittatura fascista prima, e l'invasione nazista poi. Per giungere a questa soluzione è stato necessario un appello degli storici della zona, primo tra questi il professor Andrea Di Michele - ricercatore del Centro di Competenza Storia La soluzione non è, quindi, coprire o rimuovere, come argomenta lo stesso Di Michele: “Paradossalmente l’evento scatenante (che ha spinto alla stesura dell'appello - ndr) è stato il progetto di rimozione o copertura dell’intero, gigantesco bassorilievo che si trova in piazza Tribunale e che comunemente viene chiamato Il trionfo del fascismo. […] Pareva ridicolo che a 70 anni di distanza ci si riducesse a “mettere le mutande” al bassorilievo, piuttosto che interrogarsi sui suoi significati, sui motivi della sua durata, sull’utilizzo dell’arte da parte del fascismo, sul coinvolgimento degli intellettuali e via discorrendo. Si tratta poi di un’opera di uno scultore sudtirolese che ha un indubbio valore artistico (e qui sta il problema con molte delle eredità del fascismo di pietra, che hanno un valore artistico che va comunque considerato). Anche l’idea di togliere il bassorilievo per metterlo dove? In un museo appositamente creato che gli avrebbe dato ben maggiore status? Ci sembrò fuori tempo massimo. Da qui l’idea di fare finalmente i conti con il nostro passato e il nostro presente architettonico, approfondendo i problemi invece che coprendoli o rimuovendoli.” Il caso di Bolzano è uno dei pochi arrivato alle pagine di cronaca nazionale. Secondo il professore, il 'modello Bolzano', seppur eccezionale, potrebbe essere estendibile: “La situazione locale è sicuramente unica per l’importanza e l’impatto dell’architettura e della simbologia fascista e perché questa è sempre stata un elemento di divisione delle due comunità linguistiche. Questo aspetto non può ovviamente esserci in una realtà come, ad esempio, Roma, dove però certo non mancano i simboli del regime. Credo effettivamente che il nostro caso sia in qualche modo “esportabile” o che comunque varrebbe la pena far conoscere anche al di fuori dell’ambito locale.” Da Roma gli fa eco Alessandro Portelli, storico e professore a La Sapienza: “Credo si debba decidere caso per caso, sia in base alla natura dei segni sia in base al contesto in cui sono collocati. Ma la presa di distanza deve essere chiara e immediatamente riconoscibile. Nel caso delle pietre sulle imprese del regime al Foro Italico ad esempio, la semplice aggiunta di una che ricorda il 25 luglio non basta, è praticamente invisibile.” (NdR: il riferimento è alle pietre monumentali, che durante il regime furono messe al foro italico per “Obelisco Mussolini” al Foro Italico Italia smemorata 18 raccontarne le tappe, e alle quali ne è stata poi aggiunta una che, in maniera didascalica, ne segna l'epilogo.) È necessario un passo indietro per provare a comprendere come, dopo tanti anni, questi simboli siano ancora visibili e non abbiano subito alcun intervento, se non di tipo artigianale. Come prosegue il professor Portelli, “da parte delle forze democratiche ha forse prevalso la falsa sensazione per cui il fascismo è obsoleto e superato e questi segni sono ormai irrilevanti – se non addirittura “testimonianze storiche” (che è poi quello che rivendica la destra). D’altra parte l’antifascismo non è stato realmente fatto proprio da molte delle forze di governo, incluse parti della DC e anche parti del craxismo anni ’80. Da metà anni ’90 in poi l’Italia è stata governata da coalizioni esplicitamente anti-antifasciste. [...] È un intreccio fra complicità, indifferenza, pigrizia. E anche un po’ l’idea che il fascismo era sostanzialmente bonaccione, non cattivo come il nazismo...” Secondo quanto affermato dal professor Di Michele poi, in riferimento alle targhe presso la stazione di Milano “[...] in larga misura sono segni svuotati di significato, incapaci Facciata del Palazzo Ex Gil a Roma di richiamare l’attenzione di chi vi passa davanti. Si tratta di elementi basati su di una formula comunicativa che oggi non funziona più. Inoltre c’è molta ignoranza! Quanti sanno chi ha condotto le guerre coloniali italiane e in quali periodi? Dove siamo stati, cosa abbiamo fatto, con quali mezzi...” La memoria divisa e l'inerzia sembrerebbero gli elementi che a 70 anni dalla caduta del fascismo hanno portato l'Italia nella situazione odierna, in cui i più non si interessano alla questione, e i pochi attenti sono trincerati dietro atteggiamenti da “ultras”, contribuendo a uno stallo e un unicum all'interno dell'Europa. Infatti, gli ex paesi sovietici si sono rapidamente sbarazzati di statue e simboli che rimandavano al comunismo, e sistematica fu la denazificazione in Germania e Austria. Il 22 giugno 1946 entrò in vigore - non senza resistenze da parte di partigiani e perseguitati politici - il Decreto presidenziale di amnistia e indulto relativo al periodo dell’occupazione nazi-fascista. La legge fu proposta dall'allora Ministro di Grazia e Giustizia e segretario del PCI, Palmiro Togliatti. L'amnistia - che prese il nome dallo stesso ministro - comprendeva il Italia smemorata condono della pena per reati comuni e politici, dal collaborazionismo coi tedeschi fino al concorso in omicidio, commessi in Italia dopo l’8 settembre 1943. È facile immaginare come in questo clima, dove è evidente la priorità individuata dal governo di allora, i segni fisici del fascismo poterono passare in secondo piano. È forse qui che risiede dunque l'origine del fenomeno tutt'oggi visibile o è magari nella totale assenza di memoria storica e coesione nazionale che si deve scavare per portarne alla luce le dinamiche? Quali che siano le ragioni la speranza è che l'arte, la cultura e la politica sappiano affrontare una volta per tutte un passato lontano, ma non lontanissimo, e che non si continui a fingere di non vederne i segni tutt'ora presenti nelle pietre e non solo d'Italia. A onor del vero, anche Milano si è espressa al riguardo in modo, però, artistico e irriverente, che certo non è passato inosservato: il famoso “dito” di Cattelan (L.O.V.E.) in Piazza degli Affari rappresenta infatti una mano intenta in un saluto fascista, ma con tutte le dita recise, ad eccezione del medio, risolvendosi in un invito ben meno violento e volgare dell'originale. Perché a Bergamo onorano come fosse un eroe uno squadrista fascista? di Mimmo FRANZINELLI La deplorevole vicenda del Lager polacco posto in vendita sacrario della grande guerra – nella Torre dei caduti restaudalle autorità nazionali ripropone le problematiche dei rata e inaugurata lo scorso 24 maggio – il busto di Antonio luoghi della memoria e della loro valorizzazione, deter- Locatelli, dedicato dallo scultore Giovanni Avogadro all’eminante per la percezione nella società contemporanea di roe della rivoluzione fascista, squadrista nel A1920-22 e poi episodi epocali che hanno segnato, nel bene o nel male, la podestà della città, vantato infine dal regime quale aviastoria. Le Ferrovie di Stato polacche hanno preannunciato tore caduto nella campagna d’Abissinia (dove sganciò iprite di voler vendere all’asta (con una valutazione-base di 39.000 sugli indigeni). Assai opportunamente, l’Istituto bergamaeuro) l’edificio adibito a campo di sterminio di Belzec, dove sco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea ha osservato che «I nel 1942-44 furono luoghi raccontano la uccise centinaia di storia delle città, ma migliaia di persone, anche le loro memoin gran parti ebree. rie. Ognuno in quanto La notizia ha sollecittadino è chiamato vato scalpore e indotto ad essere responsabile l’Associazione Naziodella memoria della sua nale Ex Deportati a città ed è per questo che chiedere l’intervento chiediamo all’Amminidell’Unione Europea strazione di considerare per evitare lo scempio. se non è giunta l’ora E in Italia? Da noi, il di fare i conti con la problema non consiste memoria di Locatelli, certo nella (im)possidi guardare alla sua bile vendita dei Lager figura storica, al suo di Trieste e di Bolzano, significato nella storia ma in un fenomeno del fascismo nazioben più insinuante nale e chiedersi perché che rivaluta – ripropocontinuiamo a ritenere nendoli all’attenzione eroe cittadino un rivodei cittadini – reperti luzionario fascista», fascistissimi del trascurando invece chi ventennio, restaurati Simulazione di Piazza della Vittoria a Brescia con il “Bigio” si sacrificò nella lotta a spese pubbliche. Due di Liberazione. Invece di studiare criticamente una storia casi recenti ed emblematici riguardano Brescia e Bergamo. A ottant’anni dalla sua collocazione in piazza della Vitto- negativa, la si celebra, riproponendola pari pari. Uno dei più insidiosi veleni del fascismo è stata l'identità ria, al centro di Brescia, della grande statua simboleggiante l’Italia littoria, rimossa dopo la Liberazione per evidenti stabilita tra fazione e Patria, sancita dalla legge e divulgata motivi, si discute accesamente in città sull’eventuale ritorno dal ministero della stampa e propaganda, nonché insegnata del “Bigio” (denominazione popolare della scultura), propo- nelle scuole del Regno. I dissidenti furono bollati quali sto dalla precedente giunta di destra e sospeso dall’attuale elementi antinazionali: non erano esuli politici, bensì fuoruamministrazione di centro-sinistra. L’operazione urbani- sciti. L'Italia littoria divenne, nel nome del nazionalismo più stico-architettonica dell’architetto Marcello Piacentini, che esasperato, strumento di negazione della libertà all'interno nel 1927-32 spianò un rione popolare per plasmare la monu- e in politica estera. Molti artisti e intellettuali in genere mentale piazza Vittoria, è pervasa da valenze ideologiche, furono sedotti o corrotti per cantare le glorie del regime, con la creazione di uno spazio monumentalizzato funzio- creando dei simboli destinati a imprimere nell'immaginario nale all’estetica e alla mobilitazione «dall’alto» delle masse. collettivo le strabilianti vittorie del duce. Nel ventennio nero, il modello militarista venne imposto Il “Bigio” costituiva l’anello di congiunzione tra grande guerra e dittatura, nella plastica rappresentazione dell’eroe ad ogni livello. Personaggi come Antonio Locatelli o padre fascista, vittorioso prima sugli austriaci e poi sul «nemico Reginaldo Giuliani, volontari nella guerra d'aggressione interno». In lui, insomma, trovarono compiuta sintesi vitto- all’Abissinia, furono decorati post mortem con la medaria militare e predominio politico. Mussolini lodò il lavoro glia d'oro e celebrati con monumenti e titolazioni di edifici dello scultore carrarese Arturo Dazzi, riconoscendovi le pubblici. A settant’anni dalla Liberazione, la ricollocazione stigmate della romanità imperiale tanto cara al regime e la di reperti fascistissimi in luoghi pubblici esprime subalcapacità di immortalare nel marmo l’Era Fascista. Un’opera- ternità culturale ai moduli politico-ideologici plasmati da zione sostanzialmente analoga, di riproposizione dei reperti Mussolini, subdolamente presentati come "patriottismo" artistico-ideologici del regime, è stata attuata a Bergamo, mentre veicolano i disvalori di un'Italia antidemocratica, dove l’amministrazione cittadina ha esposto al centro del sciovinista, guerrafondaia. 19 20 Cultura A PALAZZO CUSANI DI MILANO RASSEGNA DI FILM DEDICATI ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE “ Il caimano del Piave” e quell’inconfondibile vizio dello stile italico: la caccia al privilegio di Martina PARODI P rosegue la rassegna di film “Giugno 1915, guerra e limiti di una nazione” a Palazzo Cusani a Milano a cura di Maurizio Cabona. Il 22 giugno è stata la volta de “Il caimano del Piave”, un vero e proprio docu-film. Un secolo fa il Regno d’Italia era al primo solstizio d’estate di guerra: mobilitazione quasi completata, ma quasi dissolta l’illusione che l’aveva determinata: sceglier l’alleanza che permettesse di sedere al tavolo della pace in autunno alle migliori condizioni. Nel mese trascorso dal 24 maggio 1915, passato quasi ovunque all’offensiva su erti crinali, si era presa solo Cortina. Trento e Trieste restavano lontane e i sudditi di lingua italiana di quelle zone continuavano a morire non per i Savoia, ma per gli Asburgo sul fronte orientale, lungo una linea tra Serbia e Baltico (all’incirca la stessa oggi in fiamme tra Macedonia e Ucraina). Varie decine di migliaia di militari italiani in quei 30 giorni erano già morti o feriti o prigionieri o malati o dispersi. Le perdite austroungariche erano inferiori, sia perché quelle truppe erano rimaste sulla difensiva (salvo che sull’altipiano di Asiago), sia perché i confini del 1866 erano sfavorevoli al Regno d’Italia. Il patto di Londra, risalente all’aprile 1915, era ancora segreto nei dettagli e lo sarebbe rimasto fino al 1917, quando la diplomazia segreta avrebbe smesso di esser tale per la scelta di Lenin - appena giunto al potere in Russia di pubblicare le intese che avevano coinvolto l’Impero zarista. Quello che, nelle attese italiane della primavera 1915, doveva liquidare l’Austria-Ungheria, dandoci di rimbalzo la vittoria quasi gratis, come aveva fatto la Prussia a Sadowa nel 1866. Ma i nuovi alleati del Regno d’Italia non erano così forti, né i nuovi nemici erano così deboli come si credeva. E il prestito chiesto e ottenuto a Londra, durante le trattative per l’entrata in guerra, si stava rivelando esiguo per finanziare lo sforzo bellico di un Paese che in Europa aveva davanti più Stati di quanti ne avesse dietro. Perfino i francesi, che dal luglio 1914 pagavano Gabriele d’Annunzio e Benito Mussolini perché facessero la propaganda bellicista in Italia, nel giugno 1915 capirono che il vero vantaggio ottenuto con l’entrata in guerra del Regno d’Italia era di poter spostare dalle Alpi le loro truppe, gettandole nel lungo fronte tra la frontiera svizzera e il Mare del Nord, per arginare l’avanzata tedesca in Belgio e nella stessa Francia. I primi mesi del 1915 avevano dunque visto vano il buon senso di Giovanni Giolitti, maturato peraltro solo dopo il semi-disastro del 1911-12 in Tripolitania, Cirenaica e Fezzan, di cui lui stesso era stato responsabile, nel tentativo di dare la “quarta sponda” agli interessi cattolico-finanziari del Banco di Roma e, simultaneamente, il suffragio universale agli interessi del Partito socialista. L’impresa coloniale cercata, col consenso francese, contro un avversario debole - l’Impero Ottomano - per celebrare degnamente il mezzo secolo d’unità nazionale aveva invece mostrato come il Regno d’Italia fosse ancora fragile. Nemmeno i biglietti da visita di trecento parlamentari neutralisti (larga maggioranza) lasciati nella casa romana di Giolitti fermarono la marcia verso la guerra. Essa peraltro aveva una logica, perché l’Italia non era così periferica, come Portogallo e Grecia, da estraniarsi dal conflitto. Finito il regolamento di conti tra grandi potenze, chiunque avesse vinto avrebbe punito un’Italia neutrale. Del resto il ritiro delle truppe del Regno d’Italia da ciò che nel maggio-giugno 1915 ormai si chiamava Libia, aveva lasciato anche queste coste in mano ai nemici: Tobruk era presto diventata la base dei sommergibili tedeschi. Nel 1916, con la dichiarazione di guerra del Regno d’Italia anche all’Impero germanico, ciò avrebbe avuto conseguenze sui rifornimenti italiani, che giungevano essenzialmente dal mare. Giolitti non si lasciò dunque trascinare né da Antonio Salandra, presidente del Consiglio, né dal suo sodale e ministro degli Esteri, Sidney Sonnino. E ciò urtò Vittorio Emanuele III, che pur era cinico quasi quanto lui e non stimava il suo popolo. Giolitti vedeva un rischio troppo alto nelle guerra, così come il re lo vedeva nella neutralità. Avevano ragione entrambi. Giolitti ebbe ragione prima, a fine 1917, con lo sciopero militare di Caporetto. Il re ebbe ragione dopo, a fine 1918, con l’avanzata di Vittorio Veneto, resa possibile però soprattutto dal disgregarsi della Duplice Monarchia. Gli esiti della guerra vinta furono comunque nefasti anche per la dinastia: dieci anni dopo il trattato di Versailles (1919), il Concordato col Vaticano avrebbe reso la presa di Roma il 20 settembre 1870 un vuoto ricordo; ventisette anni dopo, il Regno d’Italia avrebbe cessato di esistere. Ma l’infrastruttura della nazione (forze armate, magistratura, classe dirigente, codici civili e penali, sistema economico) sarebbero restati quelli, coi loro difetti e i loro pregi (prevalenti, detto col senno di poi). Proprio questo ruolo - vincitore della guerra e perdente della pace - del Regno d’Italia spiega perché il cinema della neonata Repubblica Italiana, tra nascita dell’Alleanza atlantica e crisi di Trieste (i suoi giorni di vera gloria), Cultura INTERESSANTE MOSTRA A ROMA PER I 100 ANNI DI PIETRO INGRAO Nell’ambito dei festeggiamenti per i cent’anni di Pietro Ingrao, nato il 30 marzo 1915, si è tenuta la mostra “Per un ritratto di Pietro Ingrao” con acrilici, olii e disegni di Alberto Olivetti, a cura di Silvia Litardi, nella bellissima cornice del Casino dei Principi a Villa Torlonia, a Roma fino al 10 maggio. La mostra nasce da più incontri tra Ingrao e Olivetti, due uomini che hanno trent’anni di differenza, dove abbandonano la loro veste abituale, il politico l’uno e il professore di Estetica l’altro. La mostra si compone di oltre quaranta tra dipinti e disegni realizzati in momenti diversi: nell’84 e nel ’94. Le opere sono accompagnate da una serie di fotografie inedite eseguite da Sergio Castellano che ritraggono Olivetti e Ingrao nel corso delle sedute a Lenola. Ci sono infine fotografie, corrispondenza e appunti messi a disposizione dalla famiglia Pietro Ingrao e dall’archivio Pietro Ingrao. Relative a situazioni private e familiari. Nell’estate dell’84 Alberto Olivetti esegue i ritratti a Lenola, in provincia di Latina, città natale di Ingrao nella casa di famiglia. L’abitazione è una vecchia casa molto amata, nell’entroterra sulle colline dietro al mare di Sperlonga. Ingrao siede su una poltrona e corregge le sue bozze. Davanti a lui Olivetti dipinge le tele montate su un cavalletto. S’incontrano di mattina per evitare il caldo estivo e trascorrono molte ore seduti l’uno di fronte all’altro mentre Ingrao corregge i testi delle sue poesie e Olivetti costruisce i ritratti su carta. Le carte che sceglie sono grandi per consentirgli di fare quei ritratti a grandezza naturale. Alcune volte dopo i loro incontri scendono al mare insieme per una breve passeggiata o semplicemente per una chiacchierata seduti sulle sdraio in riva al mare. Dieci anni dopo s’incontrano di nuovo, sempre d’estate, nello stesso luogo che assume una qualche magia che si era instaurata in quel rapporto impalpabile tra due uomini diversi, che potrebbero essere padre e figlio. Qui Olivetti realizza altri ritratti, questa volta molto piccoli, di trenta centimetri quadrati. Questa mostra ha la capacità di evidenziare un diverso Ingrao, il politico convinto e presente nella storia della politica democratica italiana. Qui vediamo un uomo forse più malinconico ma sicuramente poetico. S’intuisce anche l’amicizia tra due uomini di età diverse e diverse scelte esistenziali. Hanno qualcosa in comune questi due uomini entrambi oltre la soglia della vita che viene chiamata vecchiaia, un sessantenne e un centenario. Guardando i ritratti di Ingrao e pensando a questo grande uomo viene da pensare che non è facile invecchiare in una società proiettata così nel futuro, una società che non tiene conto dell’esperienza. E non è facile vivere una vita che duri così tanto senza disperdersi. Pietro Ingrao invece ce l’ha fatta, ha vissuto una lunga vita di cui nemmeno un minuto è andato perso ed è invecchiato con convinzione e allegria rimanendo sempre se stesso. È un testimone del nostro tempo, il testimone di un secolo intero (e.v.). lasciassero ampio spazio sia alla simbologia monarchica, sia all’aristocrazia e al suo ruolo patriottico. Intrisa di decadentismo, come in Senso di Luchino Visconti (1954), o avanguardia della nazione in armi, come ne Il caimano del Piave di Giorgio Bianchi (1950), è la nobiltà che, sul grande schermo, colma le lacune di una borghesia esigua per numero e per dignità. Ciò che non era sfuggito a Dario Niccodemi col suo dramma La nemica e che, mutatis mutandis, non sfuggirà a Giuseppe Tomasi di Lampedusa col suo racconto lungo, Il Gattopardo: lo sviluppo sociale dell’Italia non era proporzionale alle ambizioni. Comunque restava l’aver tenuto duro del Regno d’Italia in un conflitto dove erano andati in pezzi imperi secolari. E anche i “vincitori” del 1918, come Gran Bretagna e Francia, si erano incamminati proprio allora sulla via del declino, a vantaggio degli Stati Uniti. Insomma l’Italia non era diventata forte come sperava, ma poteva riprendere il cammino lunghissimo tra l’essere un Paese coloniale in Europa (1300-1860) e l’essere un Paese colonialista in Africa (1935-36). Questa dimensione intermedia emerge dal film Il caimano del Piave, uscito nel 1950, che lunedì 22 (ore 18.30) è stato proiettato a palazzo Cusani di Milano, sede del comando dell’esercito, per la rassegna “Il grigioverde in bianco e nero”, ideata da Maurizio Cabona nel centenario del 1915 e realizzata dalle Forze Armate in collaborazione con la Cineteca del Friuli. Che cosa distingue le classi dirigenti degli inizi del '900 da quelle della metà del ‘900? Ed entrambe da quelle odierne? L’esempio che avevano come riferimento. Chi sapeva di avere un ruolo egemone nell’Italia dei Savoia, doveva pur giustificare i diritti coi doveri. E anche morire per la patria. Le classi dirigenti successive hanno invece avuto come riferimento, essenzialmente, l’arricchimento personale. Che, agli occhi degli esclusi, ha avuto e ha un nome: privilegio. 21 22 Cultura Cultura “Gli altri”, il fascismo torinese visto da Adduci cui cresce l'ostilità. Lo sviluppo e il successivo rafforzamento della Resistenza diventano dunque possibili in un contesto di questo tipo. Il movimento di resistenza interpreta ampiamente le aspirazioni della comunità che per parte sua dimostra simpatia per i “ribelli” e quando può li aiuta a costo di gravi pericoli. Tedeschi e fascisti identificano ad un certo punto la comunità con i resistenti. Non importa se nei villaggi ci sono quasi sempre solo vecchi, donne e bambini: tutti diventano nemici da distruggere ed è per questo che la violenza scatenata non è più contro anonimi e indistinti civili ma contro un soggetto che cerca, spesso inconsapevolmente, di opporsi e resistere al proprio annientamento. di Boris BELLONE Frutto di una lunga e rigorosa ricerca storica, il volume analizza le vicende del fascismo repubblicano e delle sue organizzazioni militari in relazione alla comunità. La Torino devastata dai bombardamenti alleati e ferita dalle violenze tedesche e fasciste fa da sfondo a quella rapida trasformazione nei rapporti tra il partito fascista repubblicano e i torinesi. All'iniziale senso di estraneità, presente nella dimensione comunitaria, si sostituisce in breve un sentimento di alterità dai fascisti, gli “altri”, che culmina nella loro espulsione dalla comunità cittadina. Poiché conosco Nicola Adduci, sia per la sua lunga attività di ricercatore sia come amico, l’ho pregato di rispondere ad alcune domande per presentare in modo originale ai lettori de “L’Antifascista”, il suo libro. L’intervista che segue consente di centrare meglio gli obiettivi che questo lavoro si è posto. Vorrei partire dal titolo del tuo libro, perché “Gli altri”? Il titolo nasce dalla proposta interpretativa con cui cerco di leggere le tragiche vicende del biennio 1943-1945 di cui fu artefice – insieme ai tedeschi - il fascismo repubblicano. “Gli altri” indica estraneità, sottende un “noi” che risulta ampiamente maggioritario e si identifica in una diversa scala di valori. Appena ritornati sulla scena pubblica, i fascisti assumono rapidamente un ruolo altro rispetto a quelli che sono gli interessi della comunità non solo torinese, ma nazionale. indispensabile ritornare esplicitamente e con insistenza sugli orrori.... A mio avviso, c'è il rischio che la minuta descrizione delle torture, dei massacri o delle violenze sessuali consumate nelle caserme della Rsi finiscano col dare una rappresentazione riduttiva del fascismo di Salò. Contrariamente alle consuetudini della maggior parte della saggistica storica hai scelto di dare al tuo lavoro un'impostazione cronologica anziché tematizzare i vari argomenti. Non ti pare che ci sia il rischio di essere dispersivo? Devo dire che mi sono posto il problema più volte durante la fase di progettazione. Alla fine, però, credo che la scelta di un'esposizione cronologica, capace di contemperare piani diversi, sia in realtà solida, direi un punto di forza. Al lettore viene offerto un quadro d'insieme del fascismo repubblicano torinese colto lungo tutto l'arco del suo farsi e disfarsi attraverso la contemporanea interazione di numerosi aspetti e avvenimenti tra loro diversi. Il filo rosso che ne permette una lettura coerente ed evita il ricorso alla tematizzazione è dato dalla scelta della chiave interpretativa. In questo modo il lettore non è costretto a ritornare indietro nella cronologia ogni volta che inizia un nuovo argomento, con il rischio di perdere la visione unitaria dell'analisi storica che necessariamente nella realtà si forma contemporaneamente su più piani. Cosa intendi? Il problema è duplice: da un lato c'è il pericolo di restringere il campo degli aguzzini a poche centinaia di psicopatici criminali totalmente scollegati dalla Rsi, dall'altro accettare che i fascisti fossero tutti e solo “belve”. La realtà è invece molto più complessa e occorre ragionare a fondo.Queste situazioni, così ampiamente presenti, furono possibili e talvolta “normali”, in un clima di violenza diffusa che permeava da molto tempo le relazioni tra le classi, i generi e le generazioni. Durante il ventennio il regime aveva consolidato questa realtà, si pensi al maschilismo imperante, alle campagne d'Africa e di Spagna, ai fucili di legno dei balilla o al premilitare per i ragazzi o alle botte date ai genitori di chi non si presentava. Ad un certo punto tutto ciò viene amplificato a dismisura dalla guerra e poi con l'8 settembre dall'oppressione di uno stato collaborazionista violento e autoritario sottomesso alla crudele tutela tedesca. Se si forniscono al lettore questi dati, se si racconta la quotidiana convivenza con questa enorme carica di violenza non è necessario scendere in morbosi e orripilanti particolari ma si lascia la possibilità di immaginare un seguito che già conosciamo, ossia le atrocità che porta con sé la guerra contro la comunità. I fascisti e i tedeschi commisero molte efferatezze ma nel tuo libro non sembri volerti soffermare più di tanto su questi aspetti terribili... La scelta di non indugiare sui particolari orrendi dei crimini commessi dai tedeschi e dai fascisti, peraltro ormai ampiamente documentati dalla letteratura storica, ha una sua ragione. Me ne sono convinto leggendo tempo fa in un saggio un lungo verbale processuale relativo ad uno stupro su una partigiana caduta nelle mani dei Rau (Reparti arditi ufficiali). Ad un certo punto mi veniva quasi la nausea per i dettagli riportati nel lungo documento pubblicato. Mi sono chiesto molte volte se sia A proposito di questa espressione, hai usato sovente tale categoria. Mi fa venire in mente quella di guerra ai civili individuata anni fa da Paolo Pezzino a proposito delle stragi nazifasciste sull'Appennino tosco-emiliano. Immagino che la tua definizione sia un sinonimo e in tal caso perché non hai utilizzato la stessa definizione? No, in realtà non è un sinonimo. Il concetto di guerra ai civili pur rappresentando - a mio avviso - un importante tentativo di spiegare, concettualizzandolo, il problema delle stragi su migliaia di persone inermi non mi sembra del tutto soddisfacente, direi che è figlio degli anni 23 Novanta e di quell'impellente bisogno di capire, seguito alla scoperta dell'armadio della vergogna in cui erano occultati migliaia di fascicoli processuali relativi alle stragi tedesche e fasciste. I nomi di paesi come Sant'Anna di Stazzema o Marzabotto sono noti a tutti. Le vittime, come sappiamo, sono in gran parte donne, bambini e anziani, dunque soggetti difficilmente in grado di imbracciare un'arma e rappresentare un concreto pericolo per tedeschi e fascisti. Eppure essi vengono brutalmente uccisi. In Piemonte le stragi furono indirizzate invece in larghissima misura contro i maschi, non importa di quale età. Ad esempio nella strage di Cumiana, 54 fucilati, trovano la morte numerosi anziani compresi tra i 60 e i 70 anni e diversi giovanissimi. Le stragi indiscriminate di civili, a mio avviso, sono da collegare al concetto di comunità, ossia un certo numero di persone su un territorio ben preciso. La difesa delle risorse umane e materiali atte a garantire la propria sopravvivenza porta la comunità in rotta di collisione con i tedeschi e i fascisti. Questi ultimi sono altro da essa; il loro obiettivo, totalmente opposto, è proseguire a tutti i costi la guerra, attingendo ad ogni risorsa possibile, sia essa umana (arruolamenti di giovani, sequestri di massa per il lavoro militare e deportazioni) o materiale (cibo, oggetti, mezzi di trasporto, animali), anche a costo di annientare la comunità verso Parli spesso di comunità. Non la stai mitizzando un po' troppo? Spero che non sia così. Quando parlo di comunità non intendo affatto riferirmi ad un soggetto “positivo” o esprimere un giudizio etico, anzi; la comunità – ai suoi vari livelli - di per sé non è né buona, né cattiva. Esprime una propria moralità e attua delle scelte, talvolta – come ho detto – discutibili o non del tutto consapevoli che appaiono come il frutto di comportamenti prevalenti via via assunti al proprio interno e hanno come orizzonte l'autoconservazione, cioè la salvaguardia delle proprie risorse, siano esse materiali o umane. A tal proposito, un esempio interessante è dato da ciò che accade ai giovani militari del Regio esercito dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. In quei giorni, le donne, in particolare, si rendono protagoniste di un'imponente azione collettiva di salvataggio degli ex soldati, in larga parte giovani, per sottrarli alle retate tedesche, nascondendoli e poi fornendo loro abiti borghesi. In sostanza, un comportamento ritenuto riprovevole fino a poco prima, ossia la fuga davanti al nemico, diviene in quel frangente moralmente accettabile e trova anzi il sostegno diffuso della comunità non solo torinese, ma direi nazionale. Altre volte, invece, gli avvenimenti non sono di così semplice lettura come mi è capitato di constatare durante le ricerche condotte in questi anni; può infatti succedere che gli atteggiamenti espressi dalla comunità risultino talvolta decisamente contraddittori e in quel caso occorre provare ad interpretarli tenendo conto di questa variabile che in definitiva è propria della natura umana. Qual è stata la parte più impegnativa del tuo lavoro? Credo gli ultimi due capitoli, quello sul collasso e il crollo della Repubblica sociale e l'ultimo, sulla resa dei conti, in cui si analizza ciò che avviene dopo la fine della guerra. La fatica più grande è stata quella di provare ad elaborare una dimensione concettuale capace di dare strumenti per provare a spiegare quel “sangue dei vinti” che in questi decenni si è imposto nel modo che tutti conosciamo. Il saggio si conclude con un'appendice biografica degli “altri” piuttosto corposa, un'ottantina di profili. Di solito questa parte è poco amata dai lettori. Era proprio necessaria? A dire il vero, l'idea dell'appendice è nata quasi per caso. Inizialmente, nel citare un personaggio, mettevo in nota i riferimenti biografici di base. In seguito, la ricchezza dei materiali che andavo via via raccogliendo mi ha convinto a scorporare le note dal testo creando un'appendice autonoma ma allo stesso tempo integrata con la narrazione. Il lettore può decidere se conoscere in anticipo cosa avverrà del personaggio citato oppure riservarsi una lettura in sequenza alla fine. In ogni caso, la ricostruzione di molte biografie di gerarchi e gregari ha fatto emergere un quadro certamente già noto ma non per questo meno sorprendente nella sua visione d'insieme. Cioè? Dopo la guerra, tra amnistie, latitanze e fughe all'estero furono davvero pochissimi quelli che in qualche modo pagarono per le proprie colpe, sia fra i tedeschi che tra i fascisti. Anche feroci criminali di guerra furono scarcerati dopo pochi anni senza grossi problemi. Insomma, nella nuova Italia democratica i reduci di Salò ebbero (nonostante tutto) un'altra possibilità. Viceversa, è fin troppo facile immaginare cosa sarebbe accaduto agli antifascisti se le cose fossero andate diversamente. 24 Arte IL FASCISMO RACCONTATO DA UN GRANDE ANTIFASCISTA: BEPPE MIGLIORE S ono nato nel 1926, in pieno regime fascista, quarto di sei fratelli e sorelle. Mio padre, originario, come tutti i suoi avi, di una piccola frazione di Pradleves, nel cuneese, all’età di sei anni, poiché nelle famiglie montanare di allora la vita era durissima e le bocche da sfamare tante, venne mandato da parenti a Torino. La vita non era facile, non mancava l’indispensabile, ma il superfluo non esisteva. Nel ‘33 iniziai le scuole elementari e anelavo di servire la Patria, il Re e il Duce! A scuola, oltre all’insegnamento, vi era una continua propaganda sulla grandezza della nostra Italia fascista, faro di civiltà nel mondo, ma ricordo che, quando nel 35, vi fu la conquista dell’Abissinia, mi domandavo se fosse giusto invadere terre altrui per aumentare il nostro prestigio, al prezzo del sacrificio di tanti soldati e civili. Nel 1938 fu emanata quell’infame legge razziale che privava gli italiani di razza ebraica di tutti i diritti civili, del lavoro e dei beni materiali. A scuola, il mio compagno di banco, ebreo, figlio di un colonnello dell’esercito in servizio e decorato di medaglia al valore nella prima Guerra mondiale, era assente. Chiesi notizie al maestro che mi rispose che il colonnello era stato trasferito d’urgenza. La famiglia di questo mio compagno abitava nel nostro quartiere e fu così che mio padre, nei giorni seguenti, vide per caso il colonnello in abito borghese, che trascinava con il figlio, un carretto carico di masserizie, perché gli era stata confiscata la casa in quanto ebreo. Provai, per la prima volta un moto di ribellione unito ad una grande pena per queste persone. Il 10 giugno 1940 il Duce, per non essere da meno dell’alleato nazista, dichiarò la guerra a Francia ed Inghilterra. Quello stesso giorno i nostri alpini, male equipaggiati e male armati, attaccarono la Francia, già in ginocchio dopo l’invasione tedesca del ’39. Il Duce pensava che ormai la guerra sarebbe durata pochi giorni e non voleva perdere l’occasione di sedersi al tavolo della vittoria e poter annettersi la Savoia e il Nizzardo. Dopo venti giorni la Francia chiese l’armistizio, ma erano bastati quei pochi giorni di guerra a farci intuire in quale avventura ci eravamo cacciati. Intanto a Torino, nella notte del 10 giugno, ci fu il primo bombardamento aereo con le prime vittime civili, a conferma della fragilità delle nostre difese antiaeree. Il duce, comunque, continuò nella sua politica di aggressione per emulare l’alleato tedesco e aggredì la Grecia, la Jugoslavia e inviò un'intera armata in Russia, a combattere a fianco dei tedeschi. Non voglio dilungarmi a raccontare l’epilogo della tragica campagna di Russia, esiste ampia e documentata letteratura dei pochi superstiti, fra cui Bedeschi, Rigoni Stern, Nuto Revelli e altri, che hanno raccontato da testimoni gli orrori e la tragica fine di migliaia di alpini mandati a morire in una guerra assurda. Dalle montagne cuneesi, provenivano gli alpini della Divisione Cuneense, quasi completamente annientata in Russia. Ho conosciuto così, da vicino, la disperazione di tante famiglie, tutte o quasi avevano chi un marito o figlio o fratello che non hanno più fatto ritorno! 8 settembre 1943 Torino era semidistrutta dai bombardamenti subiti nei tre anni di guerra; appresi dalla radio la notizia della resa incondizionata dell’Italia e dell’armistizio firmato dal Re. Una folla festante si riversò per le strade illudendosi che la guerra fosse finita, non sapendo che le massime autorità militari, compreso il Re e la famiglia reale, erano fuggiti da Roma per consegnarsi a Brindisi agli Alleati anglo-americani e salvare la pelle temendo la vendetta dell’ex alleato tedesco, all’oscuro della decisione di resa dell’Italia. L’esercito italiano rimasto senza ordini superiori si trovò allo sbando. I soldati dislocati nelle caserme si diedero alla fuga abbandonando le armi, per non cadere nelle mani dei tedeschi. Al fuggi fuggi dei militari, la popolazione stremata dalle privazioni e dalla fame si diede al saccheggio delle caserme ormai deserte, per arraffare quanto più potevano. Ricordo che trovandomi con altri due ragazzi nei pressi della caserma Valdocco, incontrammo un signore che ci convinse a prendere le armi abbandonate dai soldati, che, ci disse, avrebbero potuto esserci molto utili. A più riprese raccogliemmo armi e munizioni avvolte in coperte militari e le nascondemmo in una cantina di via San Donato. Nei giorni seguenti, transitando in piazza Statuto, vedemmo una lunga colonna di militari italiani dell’ultima leva (1924), riconoscibili anche se non più in divisa, dalla testa rapata, che venivano avviati sotto un’esigua scorta armata tedesca, verso la stazione Dora, per essere deportati in Germania. Una piccola folla si era radunata ad assistere imprecando contro i tedeschi; l’uomo che ci aveva convinto a prendere le armi e che ci accompagnava in quei giorni (seppi poi, a distanza di tempo, che era un ex confinato politico comunista, Battista Gardoncini, che divenne comandante di una formazione garibaldina, caduto e decorato di medaglia d'oro al valor militare), ci condusse alle scuderie della caserma Valdocco dove prendemmo alcuni cavalli che lanciammo contro la colonna dei prigionieri per creare scompiglio. Mentre i tedeschi sparavano agli animali, molti soldati riuscirono a fuggire e a nascondersi con l’aiuto della popolazione. Due ore dopo, ripassai da Piazza Statuto: i 4 cavalli uccisi dai tedeschi erano stati fatti a pezzi e portati via dalla folla affamata. Mi unii alle squadre clandestine che si formarono in quei giorni e con esse partecipai ad alcuni sabotaggi alle linee ferroviarie e alle cabine elettriche, finché, nel novembre 43, durante la fuga dal luogo dei sabotaggi, inseguito dalle Brigate Nere, saltando uno steccato, mi ferii al ginocchio. Portato in ospedale di nascosto con una falsa documentazione di infortunio sul lavoro, fui operato ed ingessato. Rimasi in quell’ospedale (San Vito), protetto da medici e infermieri fino alla guarigione. A fine gennaio '44, fui avviato dai Comandi partigiani clandestini in Val di Lanzo, dove già operava un gruppo di partigiani garibaldini. Rimasi pochi giorni, perché fui subito in contrasto con le loro idee estremiste. Tornato a Torino decisi di raggiungere mia sorella maggiore, sfollata a Pradleves, la quale era già in contatto con i partigiani di Giustizia e Libertà in Valle Grana. Fu lei che mi presentò ai Comandanti i quali mi accolsero nella banda. Conobbi così, in una baita fumosa, le figure prestigiose di Dante Livio Bianco, Duccio Galimberti e Nuto Revelli, i quali mi fecero scoprire i valori della democrazia e della libertà; io pendevo dalle loro labbra, mi si schiudeva davanti la visione di un mondo nuovo. Mi spiegarono perché era necessario fare la guerra ai tedeschi e ai risorti fascisti per un’Italia repubblicana, senza più guerre, dove “fare politica” vuol dire combattere su un piano di rigorismo morale per il bene collettivo. Intanto, per effetto dei bandi di chiamata alle armi del Governo repubblichino, delle classi 1923-24-25, molti giovani scelsero di salire in montagna e aggregarsi alle bande partigiane già esistenti. Cominciarono le rappresaglie ed i rastrellamenti per distruggere le organizzazioni ribelli che impegnavano molte forze nazifasciste, Memoria distogliendole dal fronte di guerra contro gli Alleati. Ma veniamo al più grosso rastrellamento nazifascista dell’ agosto ’44, in occasione dello sbarco alleato in Provenza, che coinvolse tutte le forze partigiane dell’arco alpino cuneese. La mia banda combatté in località Colle del Mulo, a 2000 mt. di altitudine, per contrastare il grosso della 90ª Divisione tedesca che voleva arrivare in Francia in aiuto alle esigue forze di occupazione ivi dislocate ed impedire l’avanzata degli Alleati. In effetti, l’azione delle forze partigiane in Valle Stura e Grana, grazie anche alle armi ricevute con i lanci alleati che permisero di far saltare ponti e chiudere strade, riuscì a ritardare di una settimana l’avanzata della Divisione tedesca verso la Francia. La cosa ebbe tale importanza per i tedeschi che la citarono nel loro bollettino di guerra. L'unica volta che le formazioni partigiane italiane vengono citate nel bollettino del Comando Supremo della Wermacht. Un altro brutto momento lo passammo nel periodo dal 27 al 30 novembre '44, quando a causa della stagnazione del fronte di guerra, fu possibile ai tedeschi distogliere truppe dal fronte e utilizzarle contro i partigiani: iniziò contro la nostra formazione un poderoso rastrellamento, perché si erano resi conto che a Pradleves era concentrato il più consistente gruppo dell’organizzazione partigiana G.L. e Garibaldi. Impiegarono forze fasciste e tedesche: il battaglione Vestone della divisione 25 Monterosa, reparti tedeschi addentrati sui fianchi e brigate nere sul fondovalle. I comandi partigiani, dopo un agitato dibattito, decisero di rientrare ciascuno nella propria sede, svicolando con i loro reparti attraverso le maglie del rastrellamento. Si trattava di riuscire a sotterrare le armi pesanti, recuperare le armi leggere e poi buttarsi nei valloni laterali tra la boscaglia. Purtroppo alla mia banda, che si trovava in alta montagna, fu impartito l’ordine di fronteggiare il nemico che ci stava aggirando alle spalle, ripiegando poi, per non essere sopraffatti, sul Monte Bram. Nella notte del 27 novembre, dopo aspri combattimenti, a 1600 mt. di quota, con la neve alta circa 2 metri, mentre cercavamo di defilarci arrampicandoci faticosamente, sprofondando ad ogni passo, dato il carico di armi e munizioni, l'alba ci sorprese ben visibili sul nevaio. Ci spararono con i mortai e fu allora che venni colpito dalle schegge del proiettile caduto nella neve a breve distanza, mentre lo spostamento d’aria mi fece cadere dalla montagna, rotolando finché non fui fermato da rocce sporgenti. Prima dei ripiegamento avevo dato ordine di non fermarsi per nessun motivo, per evitare ulteriori perdite. Rimasi privo di sensi non so quanto tempo, quando rinvenni era notte fonda. Sentivo di non essere in grado di reggermi in piedi, sapevo che nessuno sarebbe venuto a soccorrermi. Il freddo era intenso, soffrivo per le ferite riportate e mi stavo congelando. Passò molto tempo (seppi in seguito che erano 3 giorni), alternavo periodi di lucidità ad altri di incoscienza; ad un certo punto non sentii più dolore e cercai quindi, con le poche forze rimastemi, di trascinarmi al riparo. Fortuna volle che, non lontano ci fosse una piccola grangia di pastori, disabitata, dove mi rifugiai. Finito il rastrellamento, due miei partigiani venuti a prendere il mio corpo, videro delle tracce sulla neve e, seguendole, mi trovarono. Mi portarono in una frazione appena bruciata per rappresaglia e mi sistemarono nell’unica stalla rimasta in piedi. I montanari della frazione, che si erano nascosti durante la rappresaglia, tornarono alle case semidistrutte e mi portarono quel poco latte dell'unica mucca che si era salvata. Un partigiano scese a Pradleves e informò mia sorella Rita delle mie gravi condizioni. Lei accorse con l’unico medico della nostra divisione, il quale mi disse con tristezza: “non posso fare nulla per te, non possiedo neanche i ferri chirurgici per amputarti le mani ed i piedi, se sopravviene la cancrena”. Ringrazio il buon Dio che non avesse gli strumenti! I montanari allora diedero a mia sorella un rimedio antico di cui non si conosce la ricetta, a base di grasso di marmotta e chissà quali erbe, raccomandandole di massaggiarmi il più possibile mani e piedi. Dopo qualche giorno cominciai a sentire un insopportabile formicolio in tutto il corpo. Avrei urlato dal dolore, tanto che i miei partigiani, preoccupati che facessi un gesto insano, mi tolsero la pistola. Nei giorni seguenti, a bordo di una slitta venni trasportato a Pradleves. Lungo il percorso si aggiunsero altre slitte che Beppe Migliore, al centro, con alcuni compagni Partigiani 26 Cultura trasportavano, per le esequie, i corpi di 7 caduti durante il combattimento. Dicembre 1944 Dopo il proclama di Alexander, comandante delle truppe alleate, che invitava i partigiani a rientrare nelle proprie case nell'inverno per riconvocarli in tempi migliori, non solo non prendemmo in considerazione quell’ordine, ma ci fece arrabbiare e reagire nel senso di mantenere intatti i reparti, non scioglierli, sfollare solo gli ammalati. Ma si rendeva comunque, necessario per sopravvivere al duro inverno, sfoltire le bande inviandone una parte nelle Langhe, dove si era formato un vuoto nelle zone partigiane a seguito delle gravi perdite subite nei rastrellamenti. Io ero destinato a rimanere in valle a causa delle mie condizioni di salute: avevo mani e piedi fasciati ed insensibili. Il Comando voleva mandarmi in ospedale, ma io rifiutai perché preferivo morire in combattimento piuttosto che fare la fine del topo. Inoltre i miei partigiani mi pregarono di andare con loro, a costo di portarmi in spalla. La banda Monte Bram, a cui appartenevo, partì nella notte del 31 dicembre da Pradleves. Mi misero su una bicicletta perché non ero in grado di camminare, ma riuscivo a pedalare pur con i piedi fasciati. Io viaggiavo in avanscoperta; ricordo che a un certo punto, caddi riverso in un rigagnolo a lato della strada, con l’acqua che mi lambiva il naso e non riuscivo a rialzarmi. Dopo qualche minuto sentii arrivare un partigiano che mi stava cercando e diceva agli altri ragazzi, c’è la bici, ci deve essere anche Beppe! Mi rialzarono e riprendemmo il viaggio per strade secondarie; di notte, fermandoci solo all’alba presso cascine amiche. Sette notti dopo arrivammo finalmente a Dogliani, diretti a Somano dove era stata stabilita la sede della banda. La guerriglia partigiana nelle Langhe era completamente diversa da quella cui eravamo abituati in montagna, dove potevi sbarrare l’accesso alle valli con blocchi di uomini sul fondo; nelle Langhe c'erano tante strade tra le colline e i fascisti o i tedeschi potevano arrivarti addosso da tutte le parti. I rastrellamenti poi arrivavano con mezzi motorizzati, di sorpresa, e quindi dovevamo essere sempre all'erta e pronti a combattere. Nel marzo '44 ricevemmo due lanci dagli inglesi e dagli americani contenenti viveri, divise, armi e munizioni ed anche un cannoncino anticarro con ben 30 proiettili! Questo ci permise finalmente di rintuzzare il nemico, con armi e munizioni in abbondanza e di poter armare ed equipaggiare altri numerosi giovani del posto che chiedevano di far parte del nostro gruppo. Il rapporto con la popolazione era ottimo, tant'è che nell’occasione dei lanci, di notte, i contadini vennero ad aiutarci a trasportare e nascondere il materiale ricevuto. Il 15 aprile, in accordo con le formazioni della zona effettuammo un attacco concentrico su Alba per dimostrare al nemico occupante e alla missione alleata, la nostra forza e preparazione. L’azione riuscì pienamente e tornammo alle nostre basi, euforici e soddisfatti. 25 aprile 1945 Il Bgt Monte Bram, - forza 126 uomini - facente parte della 3 Divisione G.L. nelle Langhe, ricevette nella notte tra il 25 ed il 26 aprile '45, l’ordine di mettersi in marcia, a tappe forzate, per eseguire le direttive dei piano d’insurrezione “Aldo dice 26 x 1” e portarci su Moncalieri per iniziare, unitamente a numerose altre formazioni partigiane, l’offensiva su Torino e distruggere le forze nazi-fasciste ivi rimaste intrappolate. Per radio avevamo già sentito che era iniziata l’insurrezione di Genova e quindi l’ordine non ci prese alla sprovvista anzi, l’aspettavamo con impazienza. Raggiungemmo Bra il 26 sera e sostammo lì per mancanza di mezzi di trasporto. Il mattino del 27, reperito chissà dove, un camion con rimorchio, (miracoli della vita partigiana), ci dirigemmo su Torino. Durante il percorso, lento perché il camion era vecchio e asmatico, dovemmo fare diverse soste anche per fronteggiare gruppi di nemici asserragliati nei cascinali. Le direttive erano di portarci a Moncalieri, ma il nostro autista sbagliò strada e ci trovammo nella notte del 27 a Pino Torinese e con il mezzo in panne! Armi in spalla, trainando a mano il cannoncino anticarro paracadutatoci dagli inglesi nelle Langhe, iniziammo cautamente la discesa su Torino, guidati dal fragore delle esplosioni e dagli spari delle armi automatiche. Dopo brevi scontri con il nemico, arrivammo in corso Casale dove una parte del nostro reparto con il cannoncino si aggregò alle forze partigiane della Divisione Matteotti, che, da ore, combattevano contro i repubblichini per liberare la Caserma di via Asti, tristemente famosa in quanto sede di torture e fucilazioni di resistenti caduti nelle loro mani. Seppi, più tardi, che soltanto pochi giorni prima, grazie ad uno scambio di prigionieri, era stata liberata mia sorella Rita, staffetta partigiana, catturata oltre due mesi prima a causa di una delazione. Era stato il mio Comandante a nascondermi il fatto, perché sapeva che mi sarei fatto ammazzare pur di cercare di liberare mia sorella. Occupata la caserma, il Ricordo mio reparto si riunì sul corso Casale per cercare di forzare il passaggio del ponte Vittorio Veneto ed entrare in Torino dalla piazza omonima, ma fu respinto dal fuoco di un carro armato che sbarrava la strada. Piazzato il cannoncino, con l’aiuto del bazooka e molta fortuna, forzammo il blocco ed entrammo nella piazza. Mi ricordo che nel breve momento di silenzio dopo la sparatoria, sentimmo un cigolio di persiane che si schiudevano, brevi parlottii di persone, noi eravamo già pronti a sparare su possibili nemici quando, invece, dalle case uscirono, delle persone che festosamente ci vennero incontro abbracciandoci e offrendoci quel poco che avevano. Ricordo con commozione una vecchietta che mi diede un cartoccio di giornale che conteneva alcuni mozziconi di tabacco, scusandosi di non potermi offrire altro! Percorremmo via Po verso piazza Castello dove occupammo la Prefettura, poi seguendo le segnalazioni di alcune staffette partigiane proseguimmo verso via Roma, obiettivo l’albergo Nazionale, sede della Gestapo, luogo di interrogatori, torture e uccisioni di partigiani catturati. Fra tante vittime, in quell’inferno, subì la tortura e fu ucciso Renato Martorelli, esponente socialista del CVL, medaglia d'oro della Resistenza, di cui non si trovò mai il corpo; rimane di lui soltanto la lapide a ricordo affissa alla colonna del porticato di fronte all’albergo. Pensavamo che il nostro compito fosse finito, ma ci sbagliavamo: cominciava la lotta al cecchinaggio, che ancora tante vite innocenti avrebbe mietuto, nei tre giorni seguenti. Io stesso fui nuovamente ferito da una bomba a mano lanciata da un cecchino nascosto fra le rovine di una casa bombardata, in Piazza San Carlo. La stessa mattina, il 28 aprile, a poche centinaia di metri da dove mi trovavo, moriva mio fratello Nino, di 24 anni, già riformato dalla Marina per problemi cardiaci, che si trovava in strada con altri giovani desiderosi di partecipare alla liberazione, quando all’improvviso gli si arrestò il cuore. La notizia l’appresi, purtroppo, soltanto il giorno dopo, quando arrivato a casa e non trovando nessuno, seppi dai vicini che i miei famigliari erano andati a riconoscere la salma di mio fratello e anch’io li raggiunsi. Intanto, si continuava a combattere per snidare i fanatici cecchini che sparavano dai tetti delle case, o dalle soffitte. Vi furono ancora molte perdite di partigiani e civili. Il 1° maggio Torino era finalmente liberata! Nella notte tra il 2 e il 3 maggio arrivarono le prime truppe anglo americane in una città ormai libera, con tutti i servizi essenziali funzionanti. 27 Mario Corona, eroe antifascista sardo perseguitato dal regime mussoliniano di Maurizio ORRÙ N ella memoria storica collettiva antifascista dei sardi, esistono personaggi e luoghi che, per svariati motivi sono stati dimenticati dalla Storia. A tale riguardo, mi riferisco, alla straordinaria figura di Mario Corona, comunista e antifascista di Monserrato. “Un piccolo grande eroe”, che ha saputo tenere testa al Fascismo e ai suoi sodali, in molteplici e tormentati episodi della sua vita di dirigente politico e sindacale comunista. Facciamo un passo indietro. Mario Corona nasceva a Monserrato il 19 settembre 1916. Primogenito di 6 figli di Fedele, stimato e laborioso agricoltore e apprezzato improvvisatore campidanese di Eleonora Dessy (detta Giovanna). Corona, a causa di una grave malattia del padre, lasciava gli studi per dedicarsi totalmente ai lavori agricoli divenendo improvvisamente capo-famiglia, e quindi venendo catapultato nel mondo del lavoro. Questa situazione gli permise di conoscere i problemi della sua categoria professionale e i generi e le problematiche economiche mondiali. Monserrato, negli anni 1931/1932 pullulava di uomini e donne in camicia nera. Opportunismo o convinzione negli ideali fascisti? Forse non risolveremo mai questo machiavellico dubbio sugli ideali dei monserratini. Intanto Mario, anche se “debole” da un punto di vista scolastico, era sempre interessato alla storia e all’economia della sua Sardegna. Prendeva coscienza della condizione sociale ed economica dei lavoratori, vessati dalla ferrea dittatura fascista. Mario Corona, con i pochi risparmi guadagnati, comprava un normografo, utile per la stampa dei volantini contro il regime fascista. Egli intensificava i rapporti di amicizia e di politica con un gruppo di giovani del suo paese, guidati da Antonio Tinti (per tutti lo sceriffo). Anche a Sestu, piccolo paese dell’entroterra campidanese, Mario allacciava forti rapporti politici. Soprattutto con l’agricoltore antifascista Giuseppe Spiga. Fra il 1935 e il 1936 l’O.V.R.A, l’odiata polizia politica fascista, effettuava una serie articolata di arresti in tutta la Sardegna. La zona più colpita era il territorio minerario del Sulcis Iglesiente. Molti antifascisti sardi conobbero il Foto segnaletica dal CPC dell'antifascista Mario Corona Tribunale speciale. Anche Monserrato diveniva protagonista delle persecuzioni politiche antifasciste, ai danni di Efisio Foddis, Emanuele Spiga e Alfonso Argiolas. Nel gennaio 1937, Mario Corona veniva reclutato per il servizio di leva militare, con destinazione Firenze. Il suo incarico era quello di telefonista al settimo autocentro. Veniva arrestato nell’ottobre 1938, con l’accusa di essere un dirigente e fondatore dell’Associazione sardista e comunista, ovvero un aggregato politico avverso all’imperante fascismo. Il Tribunale fascista condannava Mario Corona per associazione diretta a distruggere il sentimento nazionale e propaganda di un’ associazione sovversiva. La pena detentiva fu di sei anni. Mario Corona, nel suo memoriale, dal titolo: “Ricordare non è peccato” (Edizioni dell’Erba, aprile 2000) affermava che: «(…) non nascondo che quei sei anni di galera mi permisero di continuare gli studi (…)». Scrive ancora Mario Corona: «(….) Presi a leggere, a studiare seriamente, ad esercitare la memoria e riuscii, in quei sei lunghi anni di galera, a trasformare un cervello, che si era impigrito nella pace statica dei campi, in un enorme contenitore dove ho accumulato, sia pure nel più completo disordine, impressioni, ricordi e poesie (…)» ( tratto da Non è possibile bagnarsi due volte nello stesso fiume, Editrice Letteraria Internazionale ). Trasferito nella casa circondariale di Castelfranco Emilia, Corona veniva destinato in cella con due detenuti politici di profonda fede comunista: Luigi Grasso di professione meccanico e Paolo Basiaco laureando in filosofia. Rispettivamente condannati, il primo a 18 anni di reclusione, il secondo “solo” a dieci anni. Mario Corona, grazie alle lezioni e riflessioni dei suoi compagni di cella, apprendeva lezioni di filosofia, di diritto e di storia. Questo periodo di detenzione e di convivenza carceraria, diveniva per Mario Corona, una vera e propria scuola di vita e di conoscenza profonda dell’ideologia comunista. In seguito, Mario Corona, veniva trasferito in alcuni penitenziari della penisola. Iniziava un lungo viaggio, o meglio una vera odissea: Castello di Saluzzo (in provincia di Cuneo), Pianosa e Massa. Dopo una rocambolesca fuga di prigione, raggiungeva il comando partigiano di Empoli, e da qui il comitato di Liberazione di S. Croce sull’Arno. Mario Corona, per tutta l’estate del 1944, partecipava attivamente alla Resistenza. Egli, successivamente, a Fucecchio, rifondava, con alcuni suoi vecchi compagni di militanza politica, una Sezione del Partito Comunista Italiano. Mario Corona, rientrava a Cagliari nel 1945. Egli veniva inserito negli organismi dirigenti del PCI, con la responsabilità delle Federazioni provinciali di Sassari e Nuoro. Nel 1946, veniva eletto consigliere comunale a Cagliari e membro della Segreteria federale, con l’incarico di responsabile del settore Agricoltura. Mario Corona, in seguito, continuava la sua carriera politica e sindacale all’interno della Confedeterra provinciale di Cagliari. Egli, per motivi di lavoro e impegno sindacale, lasciava la Sardegna, per il Veneto. Infatti la CGIL, aveva gli riservato un importante e delicato incarico nella associazione dei contadini della Confederterra di Treviso. Con il susseguirsi del tempo, Mario Corona, diveniva consigliere comunale di Fucecchio, e in seguito sindaco (19751980) L’antifascista sardo ha scritto due volumi: “Ricordare non è peccato” e “Non è possibile bagnarsi due volte nello stesso fiume”. Mario Corona è stato una splendida figura di combattente antifascista. Ma, ahimè, un personaggio dimenticato dalla storiografia sarda, anche se presente nella coscienza collettiva dei democratici locali. Scrive Mario Corona nell’introduzione alla sua autobiografia: «(….) Nessuno deve perciò dimenticare il prezzo che noi carcerati politici dovemmo pagare per assicurare a tutti l’esercizio dei diritti fondamentali. Dimenticare questo debito di riconoscenza nei nostri confronti sarebbe davvero un peccato mortale». 28 Memoria 29 Noi Ricordo del partigiano D'Artagnan e di sua moglie recentemente scomparsa Interessante serata al Circolo De Amicis promossa da Anppia, Fiap, Anpi e Fondazione Aniasi LA CADUTA DEL GOVERNO PARRI FU UN COLPO DI STATO? I ragazzi che sognavano di volare Presentato il libro di Michelangelo Ingrassia sul tema – Il parere degli storici di Maurizio GALLI di Filippo SENATORE A casa di Lilia Moia e Amos Messori, quando le imposte sono aperte, il vento è di casa. Sulla collina di Ivrea è un dato costante e soffia lieve o tempestoso secondo le stagioni. Nel salotto tantissime piante rigogliose, che prima della sua scomparsa, avvenuta lo scorso ottobre curava personalmente la padrona di casa.Lilia era nata in Argentina da genitori italiani. Dopo la morte del papà, la mamma in difficoltà economiche, si era rivolta alla sorella che viveva nel Basso Canavese la quale li accolse in casa. Lilia aveva 10 anni. Erano tempi duri, fatti di miseria e sacrifici. Nel 1936 dopo la scuola dell’obbligo cercò lavoro all’Olivetti. La condizione per essere assunti erano quella di avere parenti in azienda o essere residenti ad Ivrea. Lilia chiese alla zia se conoscesse qualcuno. Questa segnalò un lontano cugino magazziniere all’Olivetti. Venne assunta, aveva solo 16 anni e dopo l’apprendistato, fu assegnata all’ufficio che organizzava le colonie estive e le attività del dopolavoro. Amos è nato in Emilia a Correggio da una famiglia contadina. Entrò a 17 anni all’accademia militare e nel 1941, allo scoppio della guerra, diventò sergente del genio aeronautico. Con l’equipaggio aereo il sergente Messori effettuò varie missioni per il rifornimento di materiale strategico tra il Dodecanneso e le Colonie africane fino a quanto il velivolo militare italiano venne abbattuto da un aereo da guerra inglese. Tre perirono e tre si salvarono. Amos in acqua si strappò i lembi della sua camicia per tamponare la ferita del commilitone dissanguato cui salvò la vita. L’aviazione italiana era allo stremo e dopo la convalescenza il sergente Messori venne assegnato a una officina di manutenzione militare a Torino. A causa dei raid aerei alleati del 1943, l’officina si trasferì ad Ivrea. Dopo l’8 settembre Amos salì in montagna e incontrò tramite una staffetta partigiana Mario Pelizzari detto “Alimiro”, dipendente Olivetti fondatore della brigata “Rosselli”. In breve tempo il sergente divenne il vice del comandante Alimiro. Amos, che nel frattempo aveva assunto il nome di battaglia “D’Artagnan”, con un permesso della Olivetti entrò in fabbrica in incognita per studiare un raid contro i tedeschi che l’avevano militarizzata. Lilia lo notò subito e venne avvertita che era un partigiano. Lei faceva parte di una cellula di Giustizia e Libertà e forniva informazioni sulla partenza dei convogli in Germania. La Brigata Rosselli riuscì ad intercettarli e la “refurtiva” venne stivata i n un luogo segreto della Olivetti, recuperato dopo la guerra. L’obiettivo più ardito della Brigata Rosselli fu la distruzione del ponte di Ivrea per bloccare i rifornimenti bellici da Aosta, salvando così la città dai bombardamenti alleati. Un altro merito della brigata fu l’evacuazione dal Canavese delle truppe tedesche e fasciste sconfitte senza spargimento di sangue. “D’Artagnan, dopo la Liberazione, tornò per un breve periodo a Correggio e capì che il suo destino era l’Olivetti. La prima persona che vide alla stazione di Ivrea fu Lilia. La riconobbe e l’abbracciò in un impeto di gioia per la vittoria della guerra di Liberazione. Si accese in quell’attimo di baci innocenti una passione che è durata tutta la vita. Al matrimonio, celebrato nel 1948, il comandante Alimiro fece da testimone. Così Lilia apprese che il sabotaggio del ponte di Ivrea fu “confezionato da D’Artagnan e Alimiro in persona. A Il Partigiano “D'Artagnan” - Foto di Rita Comoglio Amos chiese di entrare in Olivetti da semplice operaio per evitare favoritismi. Frequentò le scuole serali e divenne geometra. Dopo anni di carriera, fu nominato responsabile per le costruzione degli stabilimenti Olivetti in tutto il mondo, compresa la Russia. Amos e Lilia, dal matrimonio ebbero due figlie Paola e Daniela. Amos aveva un compagno partigiano ebreo polacco che si era trasferito in Israele. Le figlie, per il tramite dell’amico di Amos da ragazze si recavano in Israele durante l’estate per lavorare in un kibutz. Paola, laureata in storia moderna, è diventata un’ottima traduttrice anche di ebraico e ha sposato un professore universitario esperto di Medio Oriente. Daniela è un medico specializzato in microchirurgia per la mano alle Molinette di Torino. Dopo la scomparsa di Lilia, Amos vive el ricordo di sua moglie, pensiero che lo sentire meno solo e soprattutto orgoglioso di avere coltivato valori e ideaa li, assieme a Lilia, da trasmettere alle nuove generazioni. In memoria di Rita Comoglio Aveva compiuto 102 anni nello scorso novembre la compagna Rita Comoglio, vedova Bazzanini, che era l'iscritta più anziana dell'ANPPIA di Torino. Rita era stata un'attivista partigiana nelle file garibaldine (PCI) per cui venne incarcerata. Il marito operò nella Resistenza quale commissario politico di una divisione Garibaldi in Valle Varaita (Cuneo). Rita era una donna energica e coraggiosa, legata agli ideali del comunismo, proseguendo nel corso degli anni la sua attiva militanza e lasciando di se l'esempio di una profonda fede nella libertà e nella Democrazia. L'ANPPIA Nazionale si unisce alla Federazione di Torino nel ricordo di Rita. Che la terra ti sia lieve. l Circolo di via De Amicis di Milano è stato presentato il libro “Il colpo di stato del 1945 - La caduta del governo Parri e l’autunno della Resistenza”. Sono intervenuti gli storici Mimmo Franzinelli, Aldo Giannuli, Giorgio Galli, Maurizio Punzo, oltre a Ferruccio Parri junior e Roberto Cenati. Ha coordinato i lavori, Gino Morrone, presidente della Federazione milanese dell’Anppia. In apertura, davanti a un foltissimo pubblico, Gino Morrone ha letto un messaggio del sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Ecco il testo: “Cari Amici, ho ricevuto con piacere l’invito del presidente Gino Morrone e della Federazione Milanese ANPPIA per la presentazione del libro di Michelangelo Ingrassia sulla fine del Governo Parri. Pur non potendo essere tra voi per ragioni di lavoro, tengo molto a inviare il mio saluto a tutte le Partigiane e ai Partigiani presenti, e a tutti coloro che tengono viva oggi la memoria della Resistenza e la difesa dei fondamenti della nostra libertà. ANPPIA, ANPI, FIAP e la Fondazione Aniasi sono protagonisti in questo lavoro di vera testimonianza civile e democratica. Ferruccio Parri, milanese di adozione, ha vissuto tutta la sua vita politica e professionale con Milano come cuore di una vicenda personale e pubblica fatta di limpida e coraggiosa testimonianza antifascista. Il libro di oggi contribuisce a far luce sulla fine del primo governo dell’Italia libera dopo il fascismo: una fine che segnò una netta involuzione della vita politica di quegli anni. Milano che ha ripreso in questi anni il percorso della memoria e della lotta contro i totalitarismi rende omaggio a Parri come ad un vero milanese, che ha combattuto per la libertà. Grazie a tutti voi per la giornata di oggi, che aggiunge un tassello di luce e di verità alla nostra coscienza storica e civile”. Secondo la tesi dell’autore prevalse negli anni a venire la linea della continuità dello stato liberale prefascista pur con l’avvento della Repubblica e Franzinelli, Giannuli, Punzo, Galli, Ingrassia, Morrone, Cenati e Parri al Circolo De Amicis della Costituzione così come prevalse il sistema consociativo dei partiti maggiori sulla democrazia partecipata sognata dalla Resistenza. Alla vigilia della caduta del governo, il premier disse apertamente che si trattava di un colpo di Stato. L’autore incardina tutto il racconto su questo presupposto. Ma gli storici sopracitati non concordano perfettamente su questa tesi dando, ognuno, dal suo punto di vista, interpretazioni diversificate. Mimmo Franzinelli sottolinea che in effetti ci fu un tradimento di alcuni obiettivi politici della Resistenza: già nel precedente governo Bonomi, i socialisti e gli azionisti erano usciti dalla coalizione. Maurizio Punzo contesta che si sia trattato di un colpo di Stato non essendoci gli elementi costitutivi tipici di un golpe. Giorgio Galli sostiene una tesi intermedia sottolineando la fine del fronte del Cnl e il dissolvimento del partito d’Azione che determinò di lì a breve l’affermazione dei nuovi partiti di massa (socialisti, comunisti e democristiani). Aldo Giannuli rileva che la successiva amnistia voluta da Togliatti aveva come obiettivo quello di avere l’appoggio di una parte dei fascisti nel referendum contro la monarchia. Parri ha concluso che il nonno fu avversato dai liberali e dai comunisti pur avendo posto la questione di una tassa patrimoniale e del potere di legiferare alla Costituente. La caduta del governo determina la fine di tali obiettivi. Cenati tratteggia la figura del comandante Maurizio, i suoi grandi meriti, i suoi valori, la fedeltà agli ideali di giustizia e libertà. Facendo un salto in avanti, si può dire senza tema di smentite che Ferruccio Parri fu un uomo di grande coerenza e onestà Egli sostenne la battaglia contro il rigurgito neofascista del 1960 dopo i fatti sanguinosi di Genova e le sue lotte per la democrazia continuarono, impregnato com’era di quello spirito mazziniano che gli aveva trasmesso la sua famiglia. Ingrassia, ovviamente, difende con ardore la tesi sviluppata nel suo libro. In complesso, una serata di cultura e di acceso e proficuo dibattito che ha interessato e appassionato gli intervenuti. La numerosa presenza di pubblico per la serata organizzata dall'ANPPIA di MILANO 30 Noi Noi ANPPIA NAZIONALE VERONA 31 UN VIAGGIO NEI TERRITORI DELL’EX JUGOSLAVIA PER RICORDARE TRAGICI AVVENIMENTI DI UN RECENTISSIMO PASSATO JASENOVAC, SREBRENICA, SARAJEVO, MOSTAR comunicazione Ci rivolgiamo a tutti i soci e le socie perchè l'anppia è interessata a raccogliere ed ereditare libri, documenti, diari, ricordi, fotografie dei nostri cari, che ricordano l'antifascismo. Documentazione che verrebbe dall'anppia catalogata, ordinata, informatizzata e messa a disposizione di studiosi, appassionati e cittadini. Vi preghiamo quindi di diffondere la notizia. L'ANPPIA ha in programma di ampliare la propria biblioteca e il suo patrimonio archivistico.Il Presidente Guido Albertelli GRUPPO RICERCA STORICA Il Presidente Nazionale Guido Albertelli ha comunicato al Comitato Esecutivo la necessità di creare un gruppo di ricerca storica ANPPIA, composto da qualificati elementi esterni ed interni all'Associazione. Questo gruppo sarà coordinato dal Prof. Caludio Natoli. Hanno già accettato di farne parte il Prof. G. Casula, il Prof. Livio Berardo, il Prof. Giorgio Repetto, ed altri a breve daranno la loro adesione. La funzione di questo gruppo di lavoro sarà quella di valutare le proposte di pubblicazione pervenute dalle Federazioni locali, nonchè da ricercatori e professori in merito ai nostri temi istituzionali. Il gruppo è aperto a elementi qualificati suggeriti dalle nostre Federazioni e sezioni locali. Il Presidente Guido Albertelli Comunicazione Urgente ANPPIA di Roma L’ ANPPIA Provinciale di Roma (Associazione Nazionale Perseguitati Politici e Razziali) informa che nell’assolvimento del proprio compito istituzionale volto a far ottenere ai propri iscritti il c.d. assegno di benemerenza, richiede agli interessati esclusivamente quanto segue: - iscrizione all’associazione - un contributo pari a 50 euro al momento dell’istruttoria della pratica - un rimborso spese forfetario, solo ad assegno ottenuto, di 200 euro. - nessuna percentuale sugli arretrati o sulle mensilità così ottenute viene richiesta. Per maggiori informazioni potete contattare l’Associazione al numero 06.6896959 (gli uffici sono aperti il martedì e il giovedì dalle ore 9:30 alle 13:30) o scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected] SOTTOSCRIZIONI: Fenoglietto Elena, in ricordo del marito BATTUELLO Matteo: 50 Euro Silvio e Gabriella Formento, in memoria del padre GIOVANNI: 100 Euro L’ANPPIA di Verona in collaborazione con l’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, l’ANPI e l’ANED ha organizzato nei giorni dal 1° al 9 maggio 2015 un viaggio nell’ex Jugoslavia toccando diversi luoghi di grande interesse e suggestione. Il nostro Viaggio della memoria (tredicesimo della serie) ha visto la partecipazione di quarantuno soci ed è stato fatto in pullman partendo da Verona. Durante il viaggio sono stati proiettati filmati e tenute relazioni per cercare di ricostruire gli avvenimenti accaduti in Jugoslavia negli anni della seconda guerra mondiale al cui termine si instaurò un forte stato nazionale di matrice comunista guidato dal Maresciallo Tito. Sono stati esaminati anche i fatti susseguenti alla morte di Tito, vale a dire lo sfaldamento dello stato unitario nei primi anni Novanta e l’inizio di lotte intestine e massacri fra popolazioni che fino a pochi anni prima erano convissute pacificamente. Lo storico e socio ANPPIA Carlo Saletti, profondo conoscitore dei fatti che hanno devastato questi territori e che in precedenza aveva visitato i luoghi delle uccisioni di massa, ha inquadrato gli avvenimenti di quel tempo. La nostra prima meta è stata il campo di concentramento di Jasenovac a un centinaio di chilometri a sud-est di Zagabria, vicino all’attuale confine croatobosniaco. Il campo, uno dei più grandi per dimensioni dopo Auschwitz e Buchenwald, era stato creato dallo Stato indipendente di Croazia retto da Ante Pavelic con l’appoggio dell’Italia fascista e della Germania nazista. Il numero di quanti vi persero la vita è rimasto imprecisato, ma si parla di parecchie decine di migliaia di serbi, bosniaci, sloveni, ebrei, zingari, croati, musulmani tutti identificati come oppositori del regime degli Ustascia. Nel pomeriggio del secondo giorno abbiamo raggiunto Srebrenica che nel luglio 1995 è stata teatro del primo genocidio accaduto in Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale. Le truppe paramilitari serbobosniache di Ratko Mladic massacrarono più di ottomila uomini di ogni età di religione musulmana dopo che le truppe ONU olandesi li avevano consegnati inermi nelle mani dei loro carnefici. Il memoriale di Potocari, un sito che ci ha impressionato e commosso inaugurato dall’ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton nel 2003, Il cimitero di Sebrenica ricorda questo immane massacro. La terza tappa del nostro viaggio della memoria è stata la città di Sarajevo che durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina fu sottoposta a un assedio prolungatosi per quasi quattro anni: dall’aprile 1992 al febbraio 1996. Durante questo tragico periodo la città fu devastata dai bombardamenti dell’esercito serbo-bosniaco malgrado l’intervento di truppe dell’ONU. Si contarono gravi perdite fra i combattenti e anche le vittime civili furono numerose (si parla di circa 12000 morti e 50000 feriti). Di quell’assedio è ancora vivo nel nostro ricordo l’immagine dell’incendio che distrusse la Biblioteca nazionale e universitaria della città. Gran parte del patrimonio di libri e manoscritti andò così perduto per sempre. Quasi a simboleggiare la volontà degli abitanti di Sarajevo di far rinascere la loro città, il palazzo della Biblioteca è stato ricostruito con fondi internazionali ma attualmente è in atto una disputa fra organi statali se utilizzare l’edificio ancora come biblioteca o invece per altre finalità. Un’altra meta del viaggio è stata Visegrad teatro di violenti combattimenti e uccisioni fra le truppe serbo-bosniache e i bosniacchi; la città è celebre per il ponte sulla Drina (ora in fase di restauro) ricordato da Ivo Andric nel suo romanzo omonimo che gli valse il premio Nobel per la letteratura. Nel percorso verso Mostar abbiamo sostato al museo che ricorda una delle battaglie più importanti avvenuta nel 1943 tra formazioni partigiane titine e l’esercito occupante italotedesco supportato da collaborazionisti ustascia e cetnici; durante il viaggio avevamo visto il film “La battaglia della Neretva”, un kolossal della fine degli anni Sessanta. Di quella produzione della cinematografia jugoslava sono ancora visibili i resti del ponte sul fiume ricostruito appositamente per il film, poi fatto saltare in aria e lasciato lì per ricordare l’eroica lotta del popolo jugoslavo contro l’oppressore fascista. Mostar ci ha accolto con la suggestiva visione del suo ponte iscritto dall’Unesco fra i siti Patrimonio dell’umanità. Questo prezioso manufatto dell’architettura ottomana venne distrutto, come gran parte del quartiere musulmano della città, dai bombardamenti dell’esercito croatobosniaco il 9 novembre 1993; fu ricostruito nel 2004 seguendo i progetti originali e utilizzando una pietra del luogo. Ci siamo trasferiti quindi nella Repubblica del Montenegro visitando Podgorica (durante il periodo jugoslavo si chiamava Titograd) e l’antica capitale del Regno del Montenegro Cetinje che ancor oggi può considerarsi il centro culturale e spirituale del paese. Dopo aver brevemente sostato a Cattaro sulla costa montenegrina, siamo rientrati in Croazia per l’ultima parte del viaggio visitando mete turistiche più tradizionali quali Dubrovnik (l’antica Ragusa del dominio veneziano) e Spalato; entrambe le città sono ricche di antichi palazzi e monumenti di grande bellezza. Anche questi luoghi però negli anni Novanta del secolo scorso subirono lutti e devastazioni. L’intricato reticolo di etnie e religioni diverse, gli odi che spesso hanno animato queste comunità, gli interessi palesi e occulti di varie strutture statali sono alla base di questa tragedia accaduta ai nostri confini e in cui dobbiamo sentirci coinvolti. Malgrado le vicende di quel tempo siano di difficile comprensione, la ricostruzione dei fatti condotta da valenti studiosi, anche italiani, ci permette di tentare un’analisi sull’ex Jugoslavia la più equanime possibile. L'Editoriale segue dalla prima pagina l’antifascista Mensile dell’ANPPIA Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti Direttore Responsabile: Luigi Francesco Morrone gay dimostra quanto sia cambiato un Paese a fortissima tradizione cattolica. In Spagna, gli indignati “Podemos” di Pablo Iglesias (vicino a Tsipras) hanno ottenuto nelle elezioni amministrative il dieci per cento dei voti, due loro donne preparate e combattive governano la capitale nazionale, Madrid, e quella catalana, Barcellona, mentre sono crollati i popolari al governo, succubi di Bruxelles. Nelle elezioni presidenziali in Polonia ha vinto, col 53 per cento dei voti, il nazionalista di destra Andrzej Duda, che ha sconfitto il moderato Komorowsky. In Turchia il partito islamista tutt’altro che moderato del “sultano” Erdogan ha perso quasi il dieci per cento dei voti e la maggioranza assoluta in Parlamento, soprattutto grazie al successo (13 per cento) del partito filo-curdo del giovane leader Selahattin Demirtas, premiato dal voto femminile e giovanile. Con esiti diversi, è il medesimo vento di insoddisfazione diffusa verso i partiti tradizionali che ha soffiato in Italia, con l’astensione di metà dei votanti alle regionali (flessione minore alle comunali, comunque con un calo dal 73 al 64 per cento, grazie alle molte liste civiche e candidati). Anche se il confronto con le elezioni europee dello scorso anno va avanzato con prudenza, data la differenza dei contesti, la perdita di oltre due milioni di voti da parte del Pd (dal 41 al 25 per cento), e di quasi un milione dei Cinque Stelle sono dati di tale entità da consentire valutazioni specifiche. Per Renzi è una battuta d’arresto dopo un anno e mezzo di cavalcata trionfale (dalle primarie del Pd dell’8 dicembre 2013), mentre per i Cinque Stelle, dopo il sorprendente successo del febbraio 2013, relativamente improvvisato nelle ultime settimane e quindi potenzialmente effimero, il risultare secondo partito al 16.5 per cento dopo dissensi interni e abbandoni, può essere ritenuto positivo, in una campagna elettorale con Grillo solo sullo sfondo e un nuovo gruppo dirigente di buon livello che si sta delineando. Se il declino di Forza Italia continua (poco sopra il 10 per cento), il fatto che la Lega di Salvini sia il solo partito a ottenere più voti nonostante la crescente astensione, giungendo al 14 per cento, ci presenta un soggetto diverso da quello prima inventato e poi semidistrutto da Bossi, descritto come populista e del quale mi paiono importanti aspetti che definisco di anticapitalismo di destra, aspetto che può preoccupare una sinistra in difficoltà anche per l’evolversi del suo anticapitalismo in un liberismo del quale il suo elettorato diffida, come appaiono chiaramente indicare il voto delle regioni dette rosse, ove aumentano sia l’astensionismo (di molto) sia i suffragi alle Lega (per ora limitati). I ballottaggi alle comunali, senza liste civiche, hanno visto l’astensionismo superare quello delle regionali (meno della metà di votanti), mentre la sconfitta del Pd è anche più evidente, da Venezia ad Arezzo. Casson non era il candidato dei centri sociali, tanto che, alla vigilia del voto, ha presentato come futuri collaboratori della sua giunta l’economista ultraliberista Francesco Giavazzi, il patron della Diesel Renzo Rosso, l’ex assessore leghista a Milano Philippe Daverio e la general manager di Uber Benedetta Arese Lucini, personalità di prestigio, atte per ottenere voti di centro e non di sinistra. Altrove i candidati sconfitti erano renziani e quanto è accaduto è chiaro: commentando i successi elettorali del Pd del segretario, Ilvo Diamanti li attribuiva alla confluenza di chi votava per il Pd di Renzi e chi lo votava nonostante Renzi. L’astensionismo penalizza tutti, salvo la Lega, ma quello a sinistra indica che chi votava il Pd nonostante Renzi, tra il 31 maggio e il 14 giugno non lo ha votato più. Questo fa prendere in considerazione altri aspetti: il nove per cento ottenuto dagli scissionisti del Pd in Liguria (per quanto vicino al risultato nazionale dei “Podemos”), è troppo regionale per essere indicativo. Ma l’assemblea della Coalizione sociale di Landini tra l’una e l’altra elezione, è motivo di riflessione per la sinistra. Appunto con un occhio al contesto europeo e un altro alla Lega. In Redazione: Maurizio Galli SEDE: Corsia Agonale, 10 – 00186 Roma Tel 06 6869415 Fax 06 68806431 www.anppia.it [email protected] HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: Boris Bellone, Roberto Cenati, Alberto Di Maria, Saverio Ferrari, Mimmo Franzinelli, Giorgio Galli, Maurizio Galli, Maurizio Orrù, Teresa Padova, Martina Parodi, Filippo Senatore, Carlo Tognoli, Alessandro Vecchi, Elisabetta Villaggio TIPOGRAFIA Graffietti Stampati PROGETTO GRAFICO Marco Egizi www.3industries.org Prezzo a copia: 2 euro Abbonamento annuo: 15,00 euro Sostenitore: da 20,00 euro Ccp n. 36323004 intestato a l’antifascista Chiuso in redazione il: 15/07/2015 finito di stampare il: 22/07/2015 Registrazione al Tribunale di Roma n. 3925 del 13.05.1954
Scaricare





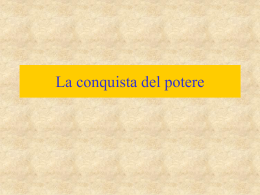

![Le origini e la presa del potere [g]](http://s2.diazilla.com/store/data/000068864_1-7a3b7b6cfdf5e3492d6f39a327d65d39-260x520.png)

