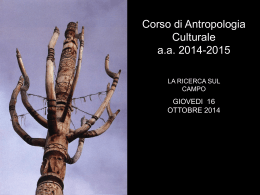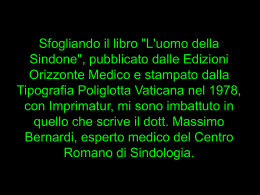Etnicità e identità culturali1 di Bernardo Bernardi Etnicità, identità ed etnocentrismo Pochi dizionari contengono la parola “etnicità”, che non esiste nel lessico italiano, ma che ha tutti i diritti di esserci. L’etnicità non è altro che l’espressione, astratta, della qualità dell’etnia. Il rapporto tra etnia e identità è intimo. Bisogna tuttavia tenere presente che l’identità è dinamica. Ognuno di noi ha un passaporto, una carta d’identità che “cristallizza” la nostra identità in quanto indica la data di nascita, il colore degli occhi e dei capelli e altre particolarità. L’identità non è solo questo, ma qualcosa di molto più vivo, che esiste perché indica la diversità degli altri. Nell’essenza stessa dell’identità esiste una contraddizione: siamo identici a noi stessi perché siamo diversi dagli altri e proprio perché ci differenziamo, scopriamo la nostra identità in costante mutamento. Ecco perché l’identità è dinamica: non esiste un momento in cui poter affermare che “l’identità è fissa”. In questo momento, infatti, noi possediamo un’identità comune ma allo stesso tempo diversa. Io sto comunicando e la mia identità, in questo istante, è quella di una persona che scrive e cerca di comunicare le proprie idee; la vostra identità, invece, è quella di chi legge e pensa, ma individualmente ognuno di voi è autonomo e giudica quanto apprende. Quando diciamo “sono a casa” intendiamo la regione, la città in cui viviamo o la strada in cui si trova la nostra abitazione. Essere a casa significa anche essere nel nostro appartamento, in cui troviamo la nostra identità, ma all’interno del quale distinguiamo tra la sala da pranzo, in cui mangiare, lo scrittoio, dove lavorare, o la stanza da letto. L’identità è quindi un elemento, una qualità, che si precisa in rapporto ad un contesto in costante mutamento. L’orgoglio etnico ci coinvolge tutti perché ognuno è identico a se stesso. Ne consegue un altro aspetto riguardante il concetto di etnia: “l’etnocentrismo”. Ognuno ha bisogno di appartenere alla propria etnia. Per comprenderlo è sufficiente immaginare un bambino che si sente abbandonato, che non ha più la famiglia. Quando da ragazzo ho letto il romanzo “Senza famiglia” ne sono stato toccato profondamente e nell’animo mi è rimasta la paura di restare solo perché in noi esiste un forte e naturale bisogno di appartenenza. Mi ha sempre impressionato il senso di appartenenza degli africani, particolarmente nei giovani, ad una determinata società. Questo testo, a cura di Silvia Bruno e Gabriella De Fino, è una versione rivista della registrazione della lezione magistrale del febbraio del 2005 tenuta da Bernardo Bernardi per tsm‐Trento School of Management. Il testo mantiene volutamente l’immediatezza dell’oralità. L’intervento non è stato rivisto dal relatore. 1 Etnicità e identità culturali – di Bernardo Bernardi 1 Nelle culture orali il periodo dell’iniziazione costituiva il passaggio dalla condizione di adolescente a quella di adulto; i giovani venivano allontanati dalla comunità, istruiti sulle loro tradizioni e in seguito imbevuti del senso di responsabilità degli adulti. Solo a partire da quel momento potevano occuparsi di attività quali la protezione della società e la sua continuità attraverso il matrimonio e la paternità. Ogni segno di sofferenza avrebbe screditato il ragazzo soprattutto agli occhi delle ragazze che non lo avrebbero considerato adulto, perché non era in grado di sopportare il dolore. Questa situazione riassume esattamente il rapporto tra “appartenere all’etnia” ed essere allo stesso tempo “individuo”. In una conferenza sull’etnocentrismo mi è stato chiesto quando si verifica il passaggio dall’etnocentrismo positivo a quello patologico, che può diventare una malattia sociale. Non esiste un termometro in grado di individuare la “febbre etnocentrica,” ma ci sono espressioni linguistiche capaci di esprimere il senso negativo dell’etnocentrismo, e ciò accade quando si dice “quel tipo là”, “quella bestia là”, e ancora “quello austriaco là” o “quel polentone là”. Se raccogliessimo le espressioni di disprezzo verso gli altri, capiremmo che i termini sono moltissimi e che questi atteggiamenti possono portare alla violenza. La “pulizia etnica” è una forma di violenza etnocentrica. E’ fondamentale sottolineare la contraddizione di quest’espressione. Si parla di “pulizia”, quando, in realtà, è violenza che porta all’uccisione degli altri. Esistono episodi recenti, come la Jugoslavia, ma quello che rappresenta maggiormente il significato di etnicità è la storia del Sud Africa. Mi trovavo lì nel 1948, quando l’apartheid ha iniziato ad affermarsi. La segregazione è cominciata con l’introduzione della “colour bar”, cioè la barriera di colore. Ricordo che quando frequentavo l’Università di Città del Capo, l’ufficio postale aveva due sportelli, ma un unico impiegato. Un giorno fu esposto un cartello con “blank – nie blank”, e le file divennero due e distinte: quella dei bianchi e quella dei neri ed era ovviamente sempre la prima ad andare avanti. Il senso di umiliazione che ho provato in quei giorni è indescrivibile. Sappiamo tutti com’è andata la storia dell’apartheid: è finita precisamente in uno stato poliziesco e persecutorio. I bianchi hanno affermato la propria superiorità non facendosi più chiamare “boeri”, ma “afrikaner”. I boeri erano i discendenti degli Olandesi che nel 1600 sbarcando nel Golfo di Città del Capo (allora Capo di Buona Speranza),avevano occupato l’intero territorio. Si sono sentiti investiti di una missione e, quando hanno assunto il nome “afrikaner”, hanno scelto “bantu” per gli altri. Da quel momento gli afrikaner erano considerati superiori e i bantu inferiori con la conseguente divisione iniqua delle terre. Chi, come Nelson Mandela, resisteva a queste ingiustizie veniva imprigionato. Nella sua autobiografia “A long way to freedom” racconta le sue sofferenze durante i vent’anni di prigionia e quello che ha significato la sua liberazione. Ancora più interessante è quello che è avvenuto in seguito, nel momento in cui si è compreso che era impossibile vivere nell’astio gli uni verso gli altri ed è stata quindi cercata una riconciliazione. La “Costituzione della Repubblica del Sud Africa” del 1996, in cui sono abolite tutte le divisioni etniche, è stata il primo passo. Oggi tutti appartengono ad un’unica etnia, la Etnicità e identità culturali – di Bernardo Bernardi 2 cittadinanza sudafricana. Nella prima Dichiarazione Fondamentale è affermato: “There is a common Southafrican citizenship”. In realtà una diversità esiste e consiste nel riconoscimento della diversità linguistica: oggi le lingue ufficiali della Repubblica Sudafricana sono undici e tutti gli atti del governo sono pubblicati in queste lingue. In base alla Costituzione, tutte le lingue parlate dalle minoranze devono essere riconosciute (tedesco, greco, indu, portoghese, tamil, telego, urdu, arabo, ebraico, sanscrito e le altre lingue usate per significati religiosi). In altre parole, ci troviamo di fronte alla massima apertura verso la diversità linguistica, ma non verso quella etnica, che ha avuto come terribile conseguenza la sola violenza. L’euforia della riconquistata libertà si è esaurita rapidamente. La condizione sociale era particolarmente preoccupante: il problema della mancanza di case, legato alla continua immigrazione verso la città e quello della piccola criminalità, tipico fenomeno delle grandi metropoli, erano i problemi maggiori. Quello del Sud Africa è un esempio di come la questione dell’etnicità possa essere interpretata in maniera diversa e con conseguenze così estreme l’una dall’altra. Che cos’è la cultura? Antropologia sociale e antropologia culturale Per comprendere che cos’è la cultura è importante spiegare i termini “antropologia sociale” e “antropologia culturale”. Il primo è la denominazione tipica dell’ambiente scientifico anglosassone e interessa lo studio della società. Il secondo riguarda sia la sfera sociale sia quella culturale, cioè gli elementi ideologici ispiratori. Gli elementi ideologici ed essenziali della cultura possono essere distinti in quattro categorie. Due di queste possono considerarsi “elementi umani” e le altre “elementi naturali”. Gli “elementi umani” sono “antropos” ed “etnos”. “Antropos” identifica il singolo individuo, cioè la persona umana. E’ l’individuo, posto alla radice della cultura, a percepire la realtà, a tentare di esprimerla, sforzandosi anche di indovinare nuovi termini. “Etnos” invece è la “collettività, costituita dalla somma dei contributi dei singoli individui, cioè degli “antropos”. Se ogni interpretazione restasse all’interno dell’individuo, morirebbe con esso e non avrebbe quindi un riflesso nella continuità, nell’acquisizione culturale e del sapere, necessari a tutti. Gli elementi naturali sono “oikos” e “kronos”. “Oikos” è l’ambiente all’interno del quale si svolgono le attività degli agricoltori, dei pastori, degli agricoltori misti e dei cacciatori. Essi attribuiscono un diverso valore all’ambiente, che viene rispettato maggiormente che non dalle civiltà occidentali. “Kronos”, invece, indica il tempo, elemento fondamentale della cultura, che è dinamica e non statica, è qualcosa che cresce “eundo”, nell’andare. La cultura, nel concetto antropologico, è un qualcosa di vivo che non si chiude mai, che si adatta continuamente alla realtà, che si modifica mediante la presenza di nuovi individui. Etnicità e identità culturali – di Bernardo Bernardi 3 Il proverbio nigeriano “Ricordati che la terra è un’eredità degli antenati, che devi rispettare e che devi portare intatta per i figli che nascono” sintetizza il concetto di cultura, cioè di “etnos”, di “oikos” e di “kronos”. Il significato della cultura e del modo di concepire la realtà dipende da questi due ultimi elementi, ben distinti. La cultura è legata all’ambiente in cui io mi trovo. Per “globalizzazione” si intende l’estensione della presenza di molte etnie e, quindi, del rapporto delle comunicazioni, che a loro volta sono frutto della facilità degli spostamenti. Un tempo erano in pochi a viaggiare, mentre oggi tutti si spostano con estrema facilità. Il turismo è diventato parte della nostra vita. La globalizzazione è la conseguenza dell’apertura politica: non c’è più nessun limite. Non esiste luogo che oggi non sia una meta di visita da parte dei turisti. Questo significa che la globalizzazione non è semplicemente turismo perché il suo vero fondamento è la natura stessa dell’uomo: l’uomo per natura è migrante; “homo migrans” è l’essere umano per natura. Essendo un africanista ho studiato da dove si è mosso l’homo sapiens. Ho potuto toccare con mano i resti di Lucy, la prima madre dell’umanità di cui si è trovato lo scheletro ad Adis Abeba. L’homo migrans continua ad essere tale. Oggi l’Italia assiste ad un fenomeno diverso da quello di decenni fa, quando era un Paese di emigranti: “la fuga dei cervelli”. I nostri governanti non promuovono la cultura e non sostengono gli studi e la ricerca, quindi chi vuole occuparsene deve farlo all’estero. Rita Levi Montalcini ripete spesso che la sua fortuna è stata l’essere andata via dall’Italia. Noi dobbiamo riflettere su questi aspetti e quindi favorire, e allo stesso tempo rispettare, quanti vengono oggi nel nostro Paese come immigrati. Non dobbiamo “tollerarli” o “sopportarli”: ricordiamoci che siamo tutti “migranti”. Studiare le culture Quando si studiano le culture africane un elemento essenziale risulta essere la “ricerca sul campo”. Trattandosi di “culture orali” e quindi prive di “scritti”, è decisivo andare tra la gente, compiendo una “osservazione partecipante”, in base al metodo classico della ricerca di campo. Ho svolto la mia prima ricerca tra i Meru avendo come maestro Isaac Shapiro. Si tratta di una famiglia linguistica che non ha generi grammaticali ma classi nominali. C’è chi ne enumera soltanto nove, mettendo insieme singolare e plurale; c’è chi ne enumera diciotto, distinguendo singolare e plurale. La prima classe riguarda gli esseri umani; la seconda gli esseri di grande rispetto, come gli animali. Esistono inoltre classi di nomi riguardanti le esagerazioni al dì sopra dell’uomo (“grande”, “piccolo”, ecc.), oppure esseri inanimati (“kintu” – plurale “ditu”, che in questo caso è “un essere” ma non “umano”; “muntu” è l’essere umano; “bantu” sono gli esseri umani). Nonostante la famiglia della lingua latina abbia un fondamento grammaticale‐fonetico sostanzialmente identico, il contadino siciliano comprende il vicino e via via sempre Etnicità e identità culturali – di Bernardo Bernardi 4 meno chi vive più lontano, fino ad arrivare alla Spagna e al Portogallo. La stessa cosa si verifica nel caso delle lingue bantu, che si estendono dal Camerun al Kenia. Queste lingue hanno alcune enclave, formate da pigmei, che abitano su un fiume al confine tra il Congo ed il Sudan. I “Sandawe” sono una piccola popolazione – quasi preistorica – che sopravvive ancora oggi e che comprende i “Khoi”, meglio conosciuti come “boshimani” (che significa “uomo del bosco”). Era divertente ascoltare Shapiro, figlio di commercianti russi trasferitisi in Africa. E’ stato lui a spingermi verso lo studio di una lingua bantu, la lingua dei “Tetsuro”, una popolazione che oggi appartiene allo Zimbawe (nel 1948‐49 Rodesia del Sud, colonia inglese). Questa popolazione, appartenente al gruppo etnico “Shona”, è uno dei due gruppi principali delle popolazioni africane. L’altro gruppo è quello dei “Ndebele”, guerrieri come gli “Zulu”. Gli “Zulu” sono discendenti di una monarchia, il cui re “Shaka” (detto anche “Napoleone d’Africa”) seppe rinnovare completamente la struttura guerriera del popolo. Gli uomini di questo popolo combattevano con una lancia, che dopo avere lanciato perdevano frequentemente, riuscendo poi raramente a recuperarla. Il re sostituì la lancia con un giavellotto e in seguito proclamò una legge, secondo la quale chiunque lo avesse perso sarebbe stato condannato a morte. Organizzò i guerriglieri, giovani dai 15 ai 30 anni, in reggimenti disponibili ai suoi ordini e che vivevano nelle vicinanze della sede reale. Fu un vero riformatore. La sua severità però lo portò a cadere vittima di un attentato in cui perse la vita. Questo mostra la varietà della famiglia delle lingue “bantu”, le cui caratteristiche tipiche sono due: pur avendo una struttura grammaticale fondamentalmente identica, presenta la varietà di dialetti tipica delle lingue latine; tutte queste popolazioni sono formate inoltre da agricoltori e non da pastori. Questa zona, prima dell’arrivo dei bianchi, era descritta come “Masai land”, ossia “territorio dei Masai”. Il primo viaggiatore inglese, Joseph Thomson, racconta che i portatori entravano in questo territorio da Mombasa, risalivano l’altopiano e molti fuggivano impauriti quando udivano parlare i Masai, essendo questi ultimi temibili guerrieri. Erano anche uomini, quindi era necessario un “senso di incontro”, un “senso umano”, andare immediatamente alla ricerca della loro guida e non del “loro capo”, trattandosi di una società acefala. Veniva rispettato il principio dell’uguaglianza, un concetto centrale in molti saggi sulla “società dell’uguaglianza”. L’uguaglianza è tra coloro che appartengono ad uno stesso periodo di iniziazione, solitamente quanti affrontano i riti iniziatici (la maturità, cioè il periodo in cui dall’adolescenza entrano nell’età adulta) durante uno stesso periodo, combinato in maniera tale da coprire quindici anni. In seguito si distinguono quattro classi: la prima è costituita da chi precedentemente veniva chiamato “celibe”. L’elemento importante non era il celibato, ma la condizione di guerrieri giovani che per quindici anni dovevano difendere gli armenti e il territorio dai ladri, tra i quali gli stessi Masai appartenenti però a diverse parentele. Il furto degli animali era reale e avveniva soprattutto in occasione delle guerre civili, talmente frequenti che con l’inizio dell’epoca coloniale (segnata dai Congressi di Berlino del 1880 e di Bruxelles del 1885) Etnicità e identità culturali – di Bernardo Bernardi 5 le potenze coloniali giustificarono la loro presenza in Africa affermando di voler pacificare questi popoli inclini alle armi, parlando di “pax britannica” e “pax gallica”. Avendo bisogno delle armi per difendere gli armenti anche dagli attacchi degli animali, gli inglesi requisirono ai Masai esclusivamente gli scudi utilizzati nelle guerre tra uomini, lasciando loro la lancia e la clava. Fino alla fine della Prima Guerra mondiale i tedeschi furono i colonizzatori del Tanganica, divenuto in seguito Tanzanìa o Tanzània. Fu Julius Nyerere, primo Presidente di questo territorio, ad unire Zanzibar e Manganica. I Masai vivono in questo territorio e costituirono un notevole problema per i colonizzatori, che per l’amministrazione delle colonie avevano bisogno di capi, ossia di rappresentanti delle popolazioni locali che avessero funzione di trait d’union tra il Governo coloniale e la popolazione e fossero in grado di spiegare il significato delle leggi e degli ordinamenti. I colonizzatori appresero che i Masai rispettavano profondamente alcuni anziani, tra i quali “Bakian”, considerato un profeta, ma in realtà un curatore in grado di fornire indicazioni su come comportarsi di fronte ai problemi e come avventurarsi in situazioni impegnative per tutta la comunità. Quando i colonizzatori si resero conto che il nipote di Bakian non era rispettato dalla popolazione come il padre e il nonno, perchè considerato uno sciocco, imposero altri capi di elezione governativa. Capirono allora che la società non era organizzata sulla base di una struttura monarchica e che si trattava invece di una società acefala. Divenne un tipico caso di studio perché per gli europei l’assenza di capi era inconcepibile. Com’era possibile mantenere l’ordine sociale senza un capo? Edward Evan Evans‐Pritchard visse tra i “Nuer”, una popolazione del Sudan senza capi e a cui dedicò la sua l’opera “The Nuer. A Description of the Modes of Livelihood & Political Institutions of a Nilotic People”2 I Nuer, insofferenti all’autorità, che non riconoscono, hanno basato il loro ordine sul rispetto assoluto per la parentela. Il “Capo del leopardo”, chiamato così perché indossa una pelle di leopardo come distintivo, ha una funzione prevalentemente rituale e non politica. Nello studio di Evans‐Pritchard si trova la chiave per comprendere le società acefale, elemento che permise ai colonizzatori europei di conoscere la struttura sociale e politica dei Masai. Al 1950 risale la sua prima visita a Nairobi, diventata una città perché destinata a deposito di materiale nel corso della costruzione della ferrovia che collega Mombasa a Kampala, capitale dell’Uganda e residenza del “Kabaka”, ossia il re. L’antropologa Lucy Mair, nel suo libro “Primitive government“3, riporta la descrizione delle gigantesche capanne utilizzate come abitazione dal re e dagli ufficiali. Si legge che 2 Evans‐Pritchard, E.E., 1965, The Nuer. A Description of the Modes of Livelihood & Political Institutions of a Nilotic People, London, Oxford university Press; trad. it. 2003, Bernardo, B., a cura, I Nuer, un’anarchia ordinata, Milano, Franco Angeli 3 Mair, L., 1962, Primitive Government, Baltimore, Penguin Books; trad. it. 1982, Governo primitivo: i sistemi politici tradizionali nell’Africa orientale, Milano, Franco Angeli Etnicità e identità culturali – di Bernardo Bernardi 6 i primi esploratori arrivati a Kampala rimasero impressionati dalla bellezza di queste capanne, talmente perfette nel taglio da poter essere paragonate ad “un taglio di capelli fatto dal miglior parrucchiere di Londra”. Questo aneddoto sottolinea l’importanza dell’aspetto ambientale rispetto allo studio delle culture “orali”. Dall’assenza della scrittura nasceva il grave pregiudizio in base al quale la maggioranza delle popolazioni africane veniva definita primitiva perché non era in grado di leggere. Il termine “primitivo” però era legato anche alla teoria evoluzionistica. In una cartina ottocentesca dell’Africa meridionale, si legge: “Nazione selvaggia che, si dice, non abbia nemmeno l’uso della parola” (espressioni tipiche del linguaggio illuministico del Settecento). Scrivendo “si dice” e limitandosi così a registrare un’opinione diffusa: “si dice non abbia neppure l’uso della parola”, l’autore non si assume la responsabilità. In genere tutti gli africani venivano considerati “primitivi”. Io stesso, da studente, fui invitato a scrivere un saggio sulle “Religioni dei primitivi” all’interno di un volume sulle religioni del mondo. In seguito pubblicai anche un libretto intitolato “Le religioni dei primitivi”, che considero un peccato di gioventù. All’interno del libro “Alla scoperta dei primitivi” ho messo in luce il fatto che, in realtà, questi popoli hanno una cultura, posseggono una concezione della vita, del sociale, dei miti e soprattutto l’organizzazione della parentela e della società. Esistono popolazioni che differiscono per l’organizzazione sociale: vi sono società acefale; “società di capitanati” in cui il capo di un lignaggio è capo della società; vi sono infine capi monarchici assoluti, come il Kabaka dell’Uganda, che godeva di potere di vita e morte sui sudditi. Questa visione complessa giustifica l’impegno necessario nello studio delle culture orali dell’Africa, per il quale è imprescindibile “andare sul posto”. Il metodo della ricerca antropologica è da attribuirsi al grande antropologo Bronislaw Malinowski, che ha incentrato i suoi studi sull’Oceano Pacifico, in particolare nelle Isole Trobriand, partecipando alla vita dei trobriandesi. E’ curioso come gli eventi della storia si riflettano sulla vita e sulle ricerche dei singoli individui. Allo scoppio della Grande Guerra Bronislaw Malinowski, di origine polacca, si trovava in Australia, e per evitare il campo di concentramento pregò le autorità di inviarlo su un’isola dove avrebbe potuto impegnarsi in un’attività scientifica. Si ritrovò nelle isole trobriandesi, dove rimase tre anni, durante i quali studiò le popolazioni e scrisse “Argonauts of the Western Pacific. An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea”4, divenuto un classico dell’antropologia culturale. “Vivere in mezzo alla gente” significa impararne la lingua, i dialetti, partecipare alla loro vita e quindi rendersi conto delle concezioni che determinano le loro azioni, prendere parte ai rituali scoprendo quali credenze li ispirano. L’insegnamento antropologico sostiene esplicitamente che “ogni ricercatore è responsabile e fattore del proprio metodo”, ossia che l’antropologo stesso deve “fabbricarlo”. Quello che si studia è un apparato teorico, che fornisce la preparazione per studiare 4 Malinowski, B., 1922, Argonauts of the Western Pacific. An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea, New York, EP Dutton & Co. Inc.; trad. it. 2004, Argonauti del Pacifico Occidentale. Riti magici e vita quotidiana nella società primitive, Roma, Bollati e Boringhieri. Etnicità e identità culturali – di Bernardo Bernardi 7 concretamente sul posto ed è proprio sul posto, in relazione alle persone e sull’argomento che si ha in mente, che deve essere definito il metodo. Il detto di Marcel Mauss “sapere tutto quello che si sa per scoprire quello che non si sa” è emblematico. E’ fondamentale, quindi, prepararsi su tutta la problematica antropologica per realizzare una ricerca sul posto e allo stesso tempo essere pronti ad alterare completamente le convinzioni in conformità a ciò che si scopre nel corso della ricerca. Il metodo deve essere adattato alla situazione specifica in cui il ricercatore si trova. Gli antropologi Gary Marcus e James Clifford hanno evidenziato l’ineliminabile effetto alone delle proprie convinzioni nello studiare una cultura “altra”, arrivando a sostenere che l’atto antropologico, ovvero la metodologia, si ridurrebbe alla “narrazione stessa dell’antropologo”. Questo ha portato probabilmente a una deriva dal punto di vista del relativismo, in quanto nell’atto conoscitivo le proprie convinzioni, sono ineliminabili; diversamente sarebbe come “voler vedere senza occhi”. A questo proposito è importante ricordare un intervento dell’antropologo inglese Edmund R. Leach, il quale affermava: “quando Malinowski parla dei trobriandesi, parla di Malinowski; quando Leech parla dei birmani, parla di Leech”. Ogni antropologo esprime dunque il proprio modo di vedere la realtà. Le ricerche non costituiscono delle “riserve di caccia” e non è pensabile che non si possa ritornare dove un antropologo abbia già operato. E’ importante che altri lo facciano, tenendo però presente la diversa collocazione temporale degli studi compiuti in precedenza. C’è stato, ad esempio, chi ha compiuto ricerche nello stesso luogo in cui Margaret Mead aveva lavorato, sostenendo che l’antropologa avesse “alterato” la situazione, che appariva troppo diversa agli occhi dei ricercatori impegnati nello studio. Erano trascorsi cinquant’anni ed è evidente che in quel lasso di tempo si era verificato un cambiamento. Quando ero in Sud Africa venni incaricato della realizzazione di una ricerca di campo tra gli “Tetsuro”. Tornato a Città del Capo il mio resoconto venne pubblicato nelle comunications della Scuola di Studi Africani dell’Università. In seguito la stessa ricerca venne riproposta altre tre volte, a distanza di dieci anni l’una dall’altra. Tutte mettono in risalto la consistenza iniziale della prima, i cambiamenti avvenuti con il passare degli anni e quindi il significato metodologico, ma anche problematico, che questo comporta. Nell’ambito del metodo antropologico bisogna pertanto tener presente l’importanza del ritorno sul campo. In antropologia non si può dire: “Io ho commentato Dante e quindi nessun altro lo può fare”. I diversi approcci dell’antropologia L’antropologia applicata si pone come principale obiettivo lo studio della condizione presente di una determinata cultura, analizzandone gli elementi costitutivi della concezione del mondo e la struttura parentale. Altro fine di grande importanza è anche la scelta migliore da fare per possibilità. E’ fondamentale tener presenti le competenze di ciascuna categoria; l’antropologo deve descrivere la situazione delle culture in se stesse. Se, ad esempio, dovesse fornire Etnicità e identità culturali – di Bernardo Bernardi 8 suggerimenti sull’Aids, potrebbe semplicemente individuare i rapporti di assistenza vicendevole che si stabiliscono, ma per avere pareri sulle condizioni di diffusione della malattia si dovrebbe rivolgere ad esperti dello sviluppo e della condizione medicale. In altre parole, “a ciascuno il proprio lavoro”: l’antropologo non può essere un “tuttologo”. Questa nuova concezione è una conquista perché un tempo gli antropologi erano considerati “enciclopedici della popolazione che studiavano”. Un recente lavoro sull’africanistica e sulle sue culture orali indaga la scuola anglosassone, quella francese e quella italiana. La scuola anglosassone tende generalmente allo studio dei sistemi di parentela e sociali dell’organizzazione. La scuola antropologica francese si interessa invece alle concezioni cosmologiche, alle visioni del mondo. In occasione di una breve polemica con un’allieva di Marcel Griaule, fondatore della scuola francese di antropologia e studioso dei sistemi cosmologici dei Dogon, Jack Goody ricorda che Meyer Fortes, uno dei massimi rappresentanti della scuola anglosassone, in occasione del matrimonio a Cambridge di una coppia appartenente alla popolazione dei Tallenti (nord del Ghana), tenne un discorso nella loro lingua. Riportando questo episodio disse: “Quando mai un antropologo francese parla la lingua del popolo che ha studiato!”. Nella scuola anglosassone, al contrario, nessuno si serve dell’interprete, perché l’antropologo è tenuto a conoscere la lingua del popolo che studia. Esistono quindi divergenze e particolarità, perchè diversi sono i modi di condurre la ricerca. Anche in questo caso occorre tener presente i tempi: ecco ancora il significato del “kronos” nel concetto di “cultura”: “distingui i tempi e ti renderai conto della realtà in maniera più specifica”. Diverso è il caso della scuola italiana: a causa della rigidità delle norme della docenza universitaria, che non consentono di sospendere l’attività didattica per un lungo periodo, per terminare una ricerca gli studiosi impiegano anni. Si è pertanto di fronte ad una “discontinuità di ricerca”. La scuola italiana si interessa alla ricerca sociale e contemporaneamente di carattere religioso e rituale. In Africa occidentale, in particolare in Nigeria e in Congo, esistono scuole in cui si incoraggia la preparazione artistica dei giovani. Ciò nonostante quando si parla di “arte africana” si intende l’arte dell’Africa occidentale del passato. Nella maggior parte dei casi si tratta di maschere in bronzo usate per danze rituali perché le opere in legno non si sono conservate. Gli artisti africani contemporanei sostengono di non poter essere ripetitori dell’arte del passato, ma di voler far parte dell’arte internazionale, con la quale potersi confrontare, presentandosi alle esposizioni, ai giudizi, alla critica internazionale al fine di ottenere consensi o dissensi. Etnicità e identità culturali – di Bernardo Bernardi 9
Scaricare