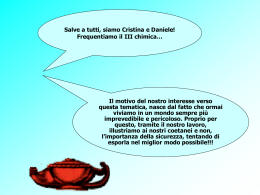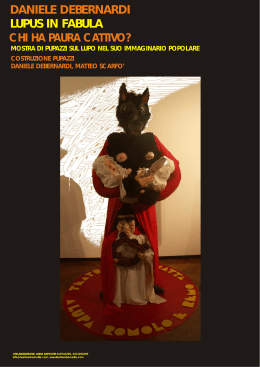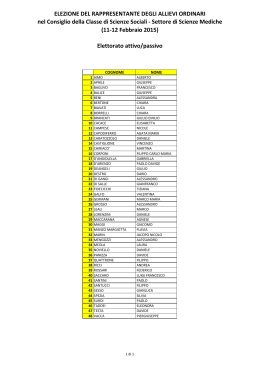De Maghreb Vulgate (ovvero come lo intrigo si dipana a sud est dell’Atlante) Stefano Gueraldi (REV 2 – 05 giugno 2006) © La proprietà letteraria ed artistica di questi racconti è riservata all’autore. Ne è consentita la diffusione telematica purché non a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta l’attribuzione all’autore originario e che questa dicitura sia riprodotta. Se dobbiamo raccontare qualcosa, che sia almeno dall’inizio. E l’inizio è più tormentato del viaggio: tra tariffe aeree inesistenti, prenotazioni fantasma e l’improvvida tendenza a risparmiare qualche spicciolo, ce ne sarebbero per tediare un buon lettore per più di qualche ora. Basterebbe accennare alla reazione fastidiosamente stupefatta della giovane signorina dell’agenzia quando, all’atto della conferma del volo già prenotato, ci ha redarguiti starnazzando come un’oca e farfugliando – e non auguro a nessuno di trovare un’oca che starnazza e farfuglia insieme – di prenotazioni immaginarie (le nostre), per capire che paese che vai usanze che trovi; e la nostra bellitalia c’ha proprio delle strane usanze. La più comune è quella di prendere delle prenotazioni per dei voli Alitalia in promozione dimenticandosi di segnalare ai malcapitati clienti l’imminente scadenza; poi fuggire in vacanza all’ombra di qualche palma da frutto tra le sabbie scintillanti delle isole tropicali, infine lasciare l’ingrato compito di segnalare l’incauto errore a un’oca che oltre a starnazzare ha forti problemi di farfugliamento. Ah, pensiero di rivalsa nei confronti delle tue membra riposate, signorina che te ne stai all’ombra della palma da frutto! Che riposino per sempre in pace e così sia, amen. Il terminal è quello di Venezia, il giorno designato per la partenza lo stesso per tutti. Gli orari coincidono, la destinazione invece no. Il dinamico trio non attende che pochi minuti dall’arrivo all’aeroporto Marco Polo che subito si separa. Un terzo raggiungerà Casablanca in giornata, i rimanenti due arriveranno il giorno seguente dopo aver trascorso una notte a Madrid. Come anche il lettore meno attento avrà intuito, dopo aver banchettato davanti alla signorina dell’agenzia con i resti della gentile collega che se ne stava all’ombra della palma da frutto, la giovane, sempre farfugliando ma evitando di starnazzare (cosa per altro comprensibile quando qualcuno vi banchetta davanti con i resti della collega di lavoro che credevate in vacanza all’ombra di una palma da frutto), è riuscita a piazzare due prenotazioni su tre in un volo Iberia a costi promozionali. Unico neo, lo scalo a Madrid con una coincidenza poco coincidente con il volo per Casablanca in partenza ventiquattro ore dopo. E mentre con drammatico senso del dovere Omar viaggia da solo alla volta di Casablanca, nome che suscita in lui ancestrali ricordi, in due partiamo alla volta della Spagna ritardando l’approccio alla meta. Ora, mai ci saremmo aspettati proprio a Madrid di cadere in un infido tranello volto a colpire nel momento della debolezza due assonnati viaggiatori. Certo, una volta arrivati all’ostello, già vedendo la finestra della camerata aperta, alcuni dubbi avevano iniziato a sfiorare il nostro Subconscio che drammaticamente cercava di suonare il campanello d’allarme. Non ascoltato però dal SuperIo che, in tutta franchezza, mai potrebbe accettare consigli da qualcosa che, pur consapevole, sempre al di 2 sotto rimane, e con gli ultimi neuroni rimasti in uso privilegiato all’Ego che riusciva solo a fantasticare sul viaggio in terra africana, nonostante tutto quello scampanare siamo stupidamente caduti in una imboscata ordita dal Supremo Ordine dei Sacher Socks. Come si può intuire già dal nome (Sacher), questa organizzazione massonica venne identificata per la prima volta a Vienna, benché sia dimostrabile una sua attività sin dai tempi antichi quando l’essere umano scoprì l’uso del calzare (Sock). L’Ordine Supremo dei Sacher Socks (o del Calzino Viennese, come viene tramandato dalla tradizione italiana) si propone di diffondere su tutto il globo terracqueo l’asfissia e lo stordimento temporaneo dell’uomo attraverso l’inganno e, nonostante agisca senza secondi fini, si tratta di una organizzazione assai pericolosa, volta a concupire l’essere umano portandolo verso il lato oscuro con il cattivo esempio. Il tutto si è compiuto in quei pochi secondi che separano l’apertura della porta della camerata dalla sua chiusura dietro le nostre spalle, ormai costrette nella trappola. Una camera che avrebbe potuto provvedere alla sistemazione di non più di quattro persone ospitava più di otto corpi sprigionanti ogni tipo di secrezione corporea, investendo con un muro di aria viziata e pesa qualsiasi cosa si trovasse nelle immediate vicinanze. Tramortiti dall’effetto anestetizzante di un’aria ormai del tutto priva di ossigeno, non possiamo che arrancare debolmente verso le brande dove ci accasciamo inebetiti con indosso la frustrazione di chi non è riuscito ad evitare la trappola. Finalmente abbandoniamo una Europa piovosa e grigia per volare sul cielo del soleggiato Marocco. Che a quanto pare è soleggiato ben poco. Il cielo si preannuncia coperto o parzialmente nuvoloso con possibilità di piogge sparse. Ora, posso capire che qualcuno possa prenderci gusto a confondere le idee già dopo le prime cinquanta righe, ma una lettura veloce del bollettino meteo prima di gettarsi lancia in resta nel mondo dei proverbi dove non ci sono più le mezze stagioni e una rondine non fa primavera, dove con il rosso di sera il bel tempo si spera, dove l’erba del vicino è sempre più verde e per la saggezza popolare non c’è più spazio? Insomma, arriviamo a Casablanca tra una rondine fuori stagione e un vicino senza saggezza ormai sempre più verde. Fortunatamente, il cielo inizia ad aprirsi mentre il dinamico trio si ritrova alla stazione di Casa Voyageurs dove si riunisce sotto un’unica stella – la terza a sinistra e poi zigzagando sino al tramonto – per partire alla volta di Marrakech. Nell’attesa che ci separa dall’arrivo del treno, decidiamo di dare ascolto alle voci che grugniscono dalle profondità dello stomaco cercando un bar nelle vicinanze che possa soddisfare l’impellente necessità di nutrirci. Usciamo dalla stazione e, avendo cura di evitare i numerosi tassisti che assalgono il potenziale cliente per portarlo in capo al mondo, ci infiliamo in un posto poco distante sedendoci all’aperto. Giusto il tempo di appoggiare gli zaini 3 che il cameriere s’appresta a prendere le ordinazioni. Sfoderando un francese impeccabile, Daniele ordina due pietanze a base di carne scelte casualmente dal menù e possibilmente un terzo piatto vegetariano. Non è una facile impresa trovare pietanze senza carne o pesce, ma con un po’ di pazienza solitamente si riesce sempre a trovare un accordo. Il cameriere sorride e annuisce. Nessun problema, giusto il tempo di preparare qualcosa. A distanza di pochi minuti arrivano sul tavolo le posate per due. Poi il pane per due, infine il cibo per due. Insomma, loro due mangiano, io no! Chiediamo lumi al cameriere cercando di capire se l’ordinazione fosse stata correttamente recepita. Immaginatevi quale stupore si dipinse sui nostri volti al sentirci rispondere dal cameriere che lui, purtroppo, il francese non lo parla. Daniele, colto di sorpresa, rimane impietrito. Le ordinazioni, le richieste accessorie, le spiegazioni successive. Dieci minuti di un monologo frantumatosi drammaticamente contro il muro delle incomprensioni linguistiche. Dieci minuti passati a parlare con un interlocutore che solo alla fine, giusto per non interrompere un discorso dal suono morbido, rivela con un po’ di soggezione di non conoscere la lingua. Daniele è ormai diventato una statua di sale, neanche si fosse girato per vedere Sodoma e Gomorra bruciare tra le fiamme del castigo divino. Se avesse proferito parola, credo avrebbe persino balbettato – farfugliare mai, il solo ricordo della collega della signorina che giace all’ombra della palma da frutto provoca in lui ancora terribili reazioni allergiche. Pur partendo con un’ora di ritardo, il treno s’appresta a lasciare Casablanca alla volta di Marrakech. Sono circa duecento i chilometri che ci separano dalla città che ha legato il suo nome all’immaginario collettivo grazie alla famosa canzone di Crosby Stills & Nash o al film di Salvatores. Duecento chilometri attraverso i quali la piana terra si fa collina e le dolci colline talvolta prendono forma di piccoli picchi di roccia rossa che dominano i pascoli. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, infatti, al di qua dell’Atlante il Marocco appare come una terra florida e fertile e il verde domina la vista. È terra di pastori e di comunità rurali, come quelle che accompagnate dai loro greggi di capre accolgono il lento passaggio del treno tra gli altipiani nebbiosi del Ben-Guerir. Guardando fuori dal finestrino – e riuscendo con difficoltà a distogliere lo sguardo calamitato dalla giovine francesina dirimpetto (memorandum: ricordarsi di imparare il francese!) – è quasi impossibile non essere piacevolmente incuriositi dai viaggiatori in attesa ai marciapiedi delle stazioni. Ad osservare con attenzione le diverse persone che attendono quel treno che in direzione opposta porta a Casablanca, è difficile non accorgersi della molteplicità ed eterogeneità delle persone che vivono in questo paese. Qui non è difficile scorgere fianco a fianco ragazze completamente occidentalizzate e ragazze che prediligono invece una più ortodossa scelta religiosa; oppure altre ancora che, pur rispettose della propria tradizione, 4 non rinunciano alla modernità. Le diverse anime della società sembrano convivere pacificamente, lasciando ai deboli quello scontro tra civiltà che tanto spazio sta trovando in certe mentalità occidentali. La serenità con la quale dialogano queste differenti e antitetiche scelte di vita è disarmante, dal momento che ben sappiamo quali sono invece le reazioni che la nostra società esprime di fronte a persone con comportamenti religiosi apertamente ortodossi. Oltre il finestrino non appaiono le divisioni, i contrasti, le contraddizioni, ma una partecipazione continua alla vita sociale senza distinzioni evidenti. All’uscita dalla stazione ferroviaria, situata nella nouvelle ville, siamo assaliti da decine di tassisti in un vociare caotico e ridondante tra mani sudate e appiccicose che s’allungano da ogni dove. Pattuiamo un prezzo, che come sempre si rivelerà più caro del dovuto nonostante l’apparente economicità, e dopo aver sistemato gli zaini sul tetto dell’auto nel poco affidabile portapacchi, saliamo sul simpatico e sgangherato Petit Taxi dal color senape che ci porta dritti dritti alla piazza principale. Trovare un posto dove passare una notte non è un’impresa difficile a Marrakech, le vie che portano alla città vecchia nascondono piccole ed economiche sistemazioni all’interno di abitazioni adattate alle esigenze del mercato. Più problematico è invece trovare un posto che sia pulito e affidabile senza ricorrere alle catene alberghiere occidentali. Anche perché, spesso, l’apparenza inganna e le magagne vere le scopri solo vivendo. Così, dopo aver trovato un buco che ha successivamente rivelato delle condizioni delle lenzuola che ci costringono ad usare i sacchi a pelo – perché va bene che il viaggiatore s’adatta, ma da qui all’avvolgersi con lenzuola dal colore indubbio ce ne vuole – ci gettiamo in quella bolgia dantesca che è Djema el Fna. E se di giorno appare più pragmatica, è solo alla sera, quando iniziano ad arrivare i ristoratori con i propri banchetti, che riesce a imporsi in tutto il suo splendore. Così, travolti dai mille colori della piazza, ci lasciamo cullare dagli odori forti dei cibi cotti all’aperto, dai rumori delle vivande che sfrigolano nelle teglie e dai richiami dei ristoratori che avvolti dai loro banchetti propongono le proprie specialità. Ceniamo anche noi, seduti sulle panche che avvolgono il banco prescelto. Un banco all’apparenza uguale agli altri con i suoi lunghi tavoli che vanno a circondare la cucina e i cibi ben illuminati a dar mostra di sé, ma che trova il suo punto di forza nel sorriso ammaliante della giovane ristoratrice che infonde con un solo sguardo un’innata simpatia. Non sembra vero: ci alziamo con la nebbia! Dev’essersi trattato di un sogno; siamo ancora a casa nostra, avvolti dal caldo tepore delle coperte – la nebbia! E mentre una luce fioca traspare dalla finestra quel tanto da destarci dal sonno, scarsa è la voglia di lasciare le coperte calde per avventurarci nell’aria fredda che avvolge la stanza. Eppure la sveglia segna inequivocabilmente le sette e trenta. È ora di alzarsi. Non c’è scampo al 5 duro risveglio. Strano sogno, strano davvero. Il Marocco! Meta lontana, apparentemente enigmatica, alquanto piovosa e sorprendentemente accogliente. Storie di prenotazioni inesistenti e tassisti insistenti. Rumori e sapori sconosciuti eppure inequivocabilmente reali e immaginifici. Che sogno. Il Marocco! Prima o poi devo trovare il tempo per volare laggiù. Come dicevo, neanche fossimo in piena pianura padana, ci alziamo immersi nella nebbia, una nebbia avvolgente che rende la città surreale. Vedere Djema el Fna svuotata e immobile, percorsa solo da qualche mattiniero avvolto nella pesante jalabba, quasi appartenesse a una diversa dimensione dove le ombre prendono forma e i colori sopiscono al contatto con la poca luce, lascia piacevolmente disorientati. Oggi è giornata di partenza. Ci adoperiamo per noleggiare un’auto evitando le proposte insistenti del tassista che, prendendo autoritariamente l’iniziativa, invece di portarci nel luogo pattuito ci lascia nelle mani di un suo vecchio cugino che per campare fa l’autonoleggiatore. Pur con mala destrezza riusciamo a svignarcela e, dopo aver recuperato un’auto adatta alle nostre esigenze, partiamo con la nostra Peugeot 206 color del cielo alla volta della catena montuosa dell’Atlante, in direzione Ouarzazate. Usciamo dalla città e ci inebriamo dei sapori magrebini. Le case di mattoni, a mano a mano che s’inizia a salire sulle alte montagne dell’Atlante, lasciano il passo a più semplici case di fango. Non vi è differenza cromatica tra le case e il paesaggio che le circonda: la terra è la stessa, l’una plasmata dalle intemperie, l’altra dall’abilità dell’uomo che la impasta con la paglia per ottenere un composto più resistente. Lungo le valli che salgono verso il passo, fiumi vigorosi sono convogliati su più piani, ad altezze diverse, da canali artificiali creati con lo stesso impasto di terra e paglia che contraddistingue tutta l’edilizia indigena. E l’effetto è quello di ritrovarsi di fronte a una sapiente e antica conoscenza delle tecniche di irrigazione che per secoli ha aiutato le popolazioni a convogliare le preziose acque. Pranziamo a Taddert, in cima al passo; tappa obbligata per tutti coloro che si dirigono verso l’importante casbah di Ait Benhaddou. Taddert è un paese molto piccolo, ma con più locali dedicati al ristoro dei viandanti che abitazioni private. L’una fianco all’altra le bettole paiono sormontarsi in un gioco di odori, colori e rumori, tra gli schiamazzi della gente e il lento vagabondare delle donne. Dicono sia preferibile scegliere luoghi maggiormente frequentati per pranzare perché, maggiore è l’afflusso di clientela, tanto più le vivande vengono rinnovate. Ovviamente noi, per non mancare al nostro spirito di avventura scegliamo il posto meno affollato – e quando dico meno affollato intendo vuoto – ma sicuramente quello col miglior panorama, con l’oste più simpatico e un cibo ottimo, guardando le cose col senno di poi. Com’era prevedibile, e per non smentire la tradizione, dopo pochi minuti dal nostro arrivo altri clienti si siedono ai tavoli attigui ai nostri. Proseguendo sempre tra le valli dell’Alto Atlante svoltiamo verso l’antica e abbandonata casbah di Telouet inoltrandoci in una strada che, benché 6 asfaltata, si presenta difficile e perigliosa. Non sono molti i chilometri che ci separano da questa meta intermedia, ma la velocità talvolta inferiore ai venti chilometri orari a causa delle condizioni della sede stradale rende il tragitto a tratti estenuante. La casbah è un po’ defilata dal paese vero e proprio che si staglia in lontananza e, benché un po’ malandata, riesce ancora a raccontare di un periodo che l’ha vista florida fortezza dei potenti berberi locali. Internamente il palazzo della casbah è completamente decorato. Stucchi con disegni complessi decorano i capitelli delle colonne, mentre mosaici geometrici di grande effetto rivestono pareti in cui le massicce porte lignee si aprono maestosamente su grandi saloni un tempo dedicati alla vita di corte. Purtroppo, poco viene fatto per evitare l’usura quotidiana e il palazzo, che non riversa in ottime condizioni, paga l’offuscamento dovuto alla vicina e più famosa Ait Benhaddou. La mancanza di finanziamenti adeguati al restauro, come ci informa il guardiano, è un peccato contro la cultura di questo paese che meriterebbe di essere maggiormente valorizzato. Il sole inizia a calare e dobbiamo raggiungere al più presto la vicina Ait Benhaddou. Sfortunatamente la strada che sin qui è stata comunque praticabile, diventa molto pericolosa. Gli abitanti di Telouet ci sconsigliano di proseguire, soprattutto sul far della sera quando la luce si spegne tra le montagne e le buche sul tracciato diventano ostacoli invisibili. Cercano gentilmente di dissuaderci dal proseguire e, ascoltando i loro consigli, ritorniamo sui nostri passi raggiungendo Ait Benhaddou con il sole ormai all’orizzonte. Poco male. Decidiamo di salire lo stesso verso la cima di questo ksar abbarbicato sulla collina per assaporare i colori del tramonto, accompagnati dal freddo vento della sera che attraversa i nostri vestiti. Ognuno, raccolto in pensieri forse troppo personali per essere condivisi, ritrova la propria individualità in seno al gruppo. Dimentichi delle perigliose vie della casbah con i suoi commercianti sempre attenti al passaggio di possibili avventori, credevamo di aver concluso la giornata. È così che scendendo dalla collina, poco oltre quello stesso fiume che prima brillava dei riflessi pregiati del sole, veniamo avvinghiati in un momento di debolezza da un simpatico giovane desideroso di avviare trattative di vendita con gli ultimi clienti della giornata. Ed è sedendosi sopra a consumati tappeti, accettando piacevolmente il rito del tè alla menta, che ognuno di noi si è sentito, nel profondo, decisamente incastrato. Un sentimento tutt’altro che spregevole o negativo, ma attorno al quale ruota la filosofia del commerciante arabo. Naturalmente ognuno è padrone di se stesso e, se uscendo da un negozio di questi paesi con qualche mercanzia tra le braccia, si crede ingannato, ricordi che in ogni momento può recidere le trattative e ritirarsi dall’acquisto. Ovviamente non senza essere accompagnato dalle pantomime del commerciante che da teatrante consumato cercherà in ogni modo di far desistere il potenziale cliente dalla 7 decisione presa. Ad ogni modo, data l’occasione e visto che, avendo intenzione prima o poi di comprare qualcosa da portare a casa, un posto vale l’altro, decidiamo di lasciarci accarezzare dalle proposte di vendita per poi sferrare l’affondo nella contrattazione. E mentre Daniele e Omar si dedicano a un paio di tappeti, io provo a cercare qualcosa che possa essere di interesse per mia sorella. Non volevo niente di appariscente e neanche di troppo costoso; un presente che potesse comunque essere apprezzato. Dopo un’estenuante ricerca tra i gingilli berberi che pareva sconfortare lo stesso venditore, l’attenzione ricade su alcuni braccialetti tuareg di buona fattura e, nonostante il mio SuperIo cercasse di sdebitarsi dopo la brutta figura di Madrid suonando tutti campanelli d’allarme possibili per avvisarmi del pericolo, mi butto a capofitto nella trattativa. Quando i venditori fanno il loro primo prezzo le sparano veramente grosse. Ora, se cercate di pensare a qualcosa di veramente grosso e immaginate di averlo trovato, avrete una magra sorpresa a scoprire che per quanto grosso l’abbiate pensato non sarà che una piccola parte di quanto vi chiederanno in partenza. Infatti, è molto probabile che l’oggetto della contrattazione valga sino a un quinto del prezzo iniziale e solo con un po’ di esperienza si riesce a spuntare il prezzo voluto. Comunque, indipendentemente dal valore vero e proprio dell’oggetto desiderato, uno dei metodi per affrontare una trattativa – perché ci vuole metodo – è quello di dare alla merce un proprio e del tutto personale valore di riferimento oltre il quale non si è disposti ad andare. Una volta individuato il valore di riferimento, si cercherà di spuntare il prezzo migliore senza mai perdere di vista quanto ci siamo prefigurati di spendere. A ben guardare, il braccialetto che avevo pensato di comprare ricordava alcuni gingilli che avevo già visto nelle varie botteghe del commercio equo e solidale. E se la memoria non mi ingannava, il costo di questi preziosi in argento non superava i trenta euro e questa era la cifra oltre la quale non ero disposto ad andare. Certo, non avrei guadagnato niente rispetto ad un acquisto fatto in Italia, ma almeno non avrei speso più soldi del suo valore sul mercato italiano. Come preventivato, il prezzo di partenza è assolutamente fuori scala. Per portarmi a casa il braccialetto dovrei sborsare seicento dirham (circa sessanta euro): una follia! Da parte mia propongo un prezzo di partenza non troppo basso e questo, forse, è il mio errore dovuto principalmente alla poca esperienza. Infatti, dopo circa un’ora di lenti aumenti e di più magnanimi ribassi che ci avevano portato ad arenarci tra i duecentocinquanta e i trecentocinquanta dirham, così, d’improvviso, probabilmente dopo aver percepito uno sguardo complice dal compare che stava concludendo la vendita dei tappeti con Omar e Daniele, accetta il mio prezzo lasciandomi in bocca una vittoria dal sapore amaro. Non è semplice spiegare perché, nonostante fossi riuscito a spuntare un prezzo che personalmente ritenevo onesto, mi sentivo gabbato. Probabilmente la sua scelta repentina di accettare la mia proposta, 8 rinunciando in un sol colpo a cento dirham (una bella cifra anche per chi è abituato a maneggiare soldi), mi ha disorientato a tal punto da pormi dei dubbi sul reale costo del braccialetto. Comunque, ben poche sono le volte in cui, pur uscendo sorridenti con l’oggetto desiderato da un negozio, non si abbia l’impressione di essere stati sottilmente fregati. E anche questo fa parte del gioco. Quando usciamo dal negozio ci accorgiamo che sono quasi le undici di sera, che abbiamo trascorso in compagnia dei commercianti quasi tre ore e che non abbiamo ancora un posto dove dormire la notte. Proviamo nell’unico albergo dell’oasi e fortunatamente, senza troppi impicci, riusciamo a trovare una stanza concordando anche un prezzo ragionevole che comprendesse cena e prima colazione. La mattina presto siamo già in piedi per visitare la casbah con la luce dell’alba prima di ripartire. Il sole si alza creando forme plastiche e giochi prospettici mentre camminiamo nuovamente tra le pareti fortificate di questo ksar. Il paese è ancora addormentato e, vagabondando tra gli odori acri delle strette vie che portano verso la cima, respiriamo quella calma e tranquillità che solo a certe ore della giornata si riesce ancora a scorgere. La brezza mattutina aiuta a destarci mentre dall’alto della fortezza dominiamo nuovamente con lo sguardo la pianura intenta pian piano a svegliarsi. Oggi è venerdì, giornata dedicata al riposo e alle funzioni religiose. Ed è forse per questo che ci stupiamo nel vedere come nei canteri stradali gli operai continuino tranquillamente il loro lavoro e nei villaggi i negozi rimangano tranquillamente aperti nella speranza di poter servire alcuni clienti. Certo, a mezzogiorno la funzione nella moschea richiama gli uomini del paese e risulta quasi difficile attraversare in quei momenti la via principale dato che si riempie di persone che entrano ed escono dalla moschea, ma sembrerebbe che al di là della funzione religiosa la giornata venga condotta come tutte le altre. Infatti, attraversando questi piccoli villaggi, dove anche tra le poche case svetta sempre un minareto, si nota che la religione non è vissuta in modo ossessivo; conduce la vita della persona, ma senza imposizioni di sorta. Una condizione non dissimile da quella vissuta sino a pochi anni fa nella cattolica Italia. Forse, è solo per i bambini che il venerdì si presenta come una giornata di festa. Almeno così sembra vedendo gli allegri ragazzini giocare a pallone negli spiazzi o le ragazzine spensierate che si divertono giocando a campanaccio, mentre altre compagne più grandi preferiscono parlottare sul bordo della strada, sedute sulle scale che portano in casa. Non è difficile strappare un sorriso dal volto sereno e disteso delle giovani che guardano con interesse e curiosità al passaggio degli stranieri. Un sorriso o un saluto disinteressato che allargano il cuore a noi freddi e misurati occidentali sempre più chiusi in certo individualismo. Quante volte ci siamo ritrovati a rinunciare a un gesto spontaneo, quante volte abbiamo represso la nostra umana socialità per paura, per diffidenza, per disinteresse, quante volte abbiamo preferito un’espressione tesa a un sorriso distensivo? Ebbene, il calore che riceviamo 9 dalla gente è più importante di mille paesaggi ed è probabilmente per questo che le gole del Todra verso le quali ci siamo diretti, tutto d’un tratto, perdono d’importanza e sfumano di fronte ai volti dolci delle ragazze o ai sorrisi dei bambini. Il sole adombra i monti, mentre risplende nei sorrisi delle genti. A Tinerhir ci fermiamo per un pranzo rigenerante. E mentre ci apprestiamo a consumare l’ormai imprescindibile tajine, uno stufato di carne o verdure cucinato in una ciotola di terra cotta, veniamo avvicinati dal simpatico giovane del tavolo attiguo intento a bere del tè alla menta con degli amici. Scopriamo quindi che la cittadina è una città mineraria e che per la maggior parte è abitata da immigrati che lavorano per la società che gestisce le miniere di rame. Lo stesso giovane è originario del Sahara Occidentale e lavora come geologo per questa società. Prima di ripartire, il ragazzo ci chiede un passaggio fino alla piazza centrale della città. E qui subodoriamo aria di seccature – non che abbiano un odore diverso, le seccature, ma se il cervello non è impegnato a coinvolgere in pensieri effimeri la maggior parte dei neuroni, dovrebbe facilmente accorgersi di certa aria pesa. Infatti, non tardiamo ad arrivare al centro città che, se non fosse per uno scorbutico e insistente vecchio che chiede a sua volta un passaggio e impedisce così al ragazzo di portare a termine le sue intenzioni, di lì a poco saremmo stati invischiati in un’altra, nuova, contrattazione di tappeti. Perché spesso è questo ciò che accade. E non per chissà quale avida propensione a raggirare lo straniero, come i maligni potrebbero pensare, quanto per una spiccata necessità che porta ad aiutarsi l’un l’altro trovando sempre nuovi potenziali clienti agli amici degli amici. In questi paesi il commercio è la vita di un popolo e non è semplice spiegare a chi non abbia ancora avuto l’occasione di attraversare certe terre come qui “commercio” sia sinonimo di ragnatela. Certamente, una ragnatela. Perché di questo si tratta: ognuno conosce sempre qualcun altro che, sicuramente, conoscerà qualche d’uno che, in un modo o nell’altro, finalmente sarà a conoscenza di colui che potrà definitivamente risolvere il nostro problema. Ed è per questo che anche un invito disinteressato a bere in compagnia un bicchiere di tè per sdebitarsi del piacere, può trasformarsi nell’occasione giusta per proporre qualche buon affare. Prendiamo la strada per Erfoud quando il sole è ormai al tramonto. La strada che ci separa dalla meta prevista per la notte è lunga, e solamente gli innumerevoli ouadi (letti torrentizi) che attraversano la sede stradale, riconoscibili per essere delimitati da alcuni paracarri bianchi ai bordi della carreggiata, riescono a spezzare la monotonia del viaggio. Ed è proprio in prossimità di un’oude che Daniele decide autoritariamente di fermarsi nel buio della sera. E mai scelta autoritaria fu più appropriata: il silenzio, unito 10 al buio assoluto tutt’intorno, e le porte del cielo spalancate ai nostri occhi ci riportano a ricordi ancestrali in cui l’uomo era un tutt’uno con la natura e le sue scelte di vita si sviluppavano in sintonia e non contro di essa. La volta celeste diventa un prolungamento dello spirito rendendoti partecipe del tutto e del nulla, del finito e dell’infinito, dell’essere e del non essere. Quando arriviamo a Erfoud cadiamo nell’incauto errore di chiedere un’informazione circa la direzione da seguire per raggiungere l’hotel che sapevamo essere nelle vicinanze. Il ragazzo in bicicletta interpellato per l’informazione, intravista una probabilità di guadagno, cerca in tutti i modi di indirizzarci verso altri hotel più lussuosi e costosi facendo innervosire non poco Daniele. Non che ci voglia poi molto a farlo innervosire: se siete petulanti, insistenti e se le parole escono talmente copiose dalla vostra bocca da assumere un atteggiamento farfugliante – ebbene sì, non si è più ripreso dopo il colpo gobbo giocatogli dalla collega della signorina che giace all’ombra della palma da frutto – non avrete scampo. Insomma, Daniele inizia a manifestare da subito i sintomi dello scatto d’ira e, nonostante cerchi di trattenersi, il suo lato oscuro sarebbe esploso con tutta la sua dirompente energia di lì a poco. Le sue parole fluiscono lente e misurate, benché pronunciate con un tono grave e pesante; il suo viso si tende sino a mostrare un sorriso sardonico e feroce; il sudore scende freddo e acre sporcando il colletto della camicia pulita. Aspettiamo da un momento all’altro il colpo di mano con sadico interesse e, dopo pochi minuti di battibecco, questo non tarda ad arrivare. Tutto d’un tratto Daniele, decisamente incollerito, accelera bruscamente e gira all’incrocio sgommando sul ruvido terreno bituminoso. Al ragazzo, sconcertato, rimane in bocca solo il sapore aspro del copertone bruciato. Di mattina presto si parte per Merzouga, un villaggio nelle vicinanze del confine algerino alle cui spalle si erge l’unico vero erg sahariano del Marocco. Partiamo accompagnati da Rashid che per pochi dirham ci farà da guida. Ci si prospetta una giornata prettamente turistica con l’inevitabile viaggio a gobba di dromedario attraverso l’Erg Chebbi. Ma come poter prescindere dal provare ad addentrarsi tra le sabbie sul dorso di un camelide? Ah, terribil domanda che ad ogni dolor sentire dovei portar meco, dalle stanche membra ad ogni ignoto danno ch’al corpo mio arreco. E non sol tal questione ch’alla mia mente garriva 11 foss’anco bandiera, ma un’altra seco cui prodest domanda compagnia le facea. L’unico modo per poter raggiungere Merzouga è quello di attraversare l’hammada, il deserto sassoso che contraddistingue la maggior parte delle terre aride e inospitali, inoltrandosi tra piste sempre in movimento e non proprio in ottime condizioni. Avendo tosto l’occasione di trovare un punto panoramico dal quale osservare l’hammada, si notano con facilità come i tracciati sghimbesci delle piste s’incrociano spesso tra loro. Non esiste infatti una sola pista che porta al villaggio, piuttosto una serie di tracciati che variano a seconda delle condizioni del terreno. Ed è solo grazie alla capacità dell’autista che è possibile scegliere la giusta via. Solo un occhio esperto, infatti, riesce ad evitare l’insabbiamento, aiutato nel seguire il tracciato più adeguato da piccoli cumuli di pietre che segnalano la direzione preferenziale. E ancor più difficilmente si riesce a raggiungere senza competenza alcuna il villaggio di Merzouga. Come ci racconta Rashid, l’ultima tragedia era avvenuta solo pochi mesi prima quando due francesi erano morti per disidratazione dopo essersi persi nello sconfinato territorio dominato dall’hammada. Dopo esserci insabbiati un paio di volte, riusciamo a raggiungere senza colpo ferire il villaggio dove, adducendo la scusa – perché non poteva che essere una scusa – di dover andare a trattare il prezzo per dei buoni cammelli, Rashid ci lascia in compagnia dell’immancabile amico commerciante. Ora, non so se siamo solo noi a non riuscire a venirne fuori indenni, fatto sta che Omar nonostante le resistenze iniziali esce con qualche soldo in meno in tasca e qualche tappeto in più sotto braccio. Inevitabilmente, la domanda si pone con sempre maggior forza: era proprio necessario? Mentre questa domanda esistenziale frulla nella mia testa, entrano nel salone principale del negozio due ragazze francesi. Sguardo trasandato, atteggiamento vagamente alternativo, abbigliamento decisamente poco consono. E se la prima indossava una più casta gonna leggermente sopra le ginocchia, l’altra prorompeva in tutta la sua carica sessuale: l’ombelico scoperto e un reggiseno scuro a balconcino che risaltava le forme non potevano che attirare l’attenzione degli astanti. Nonostante certa inevitabile, sintomatica attrazione, una tale mancanza di rispetto nei confronti di una cultura diversa si dimostra quantomeno vergognosa. Una mancanza di rispetto che lascia amareggiati, soprattutto per quella insensibile sfrontatezza di stampo colonialista che violentemente impone le regole del gioco. Partiamo per la cammellata lasciando Rashid al villaggio e ci lasciamo condurre dal nostro nuovo accompagnatore, Mohammed, un ragazzo di circa quindici anni. Lentamente ci dirigiamo all’interno dell’Erg Chebbi dove le dune ci accolgono tra i colori caldi e accesi. Non so quanti abbiano 12 mai avuto l’occasione di salire sul dorso di un dromedario. A tutti, prima o poi, è capitato di vedere qualche film che parlasse delle carovane del deserto o delle imprese di Thomas Edward Lawrence, ma solo chi ha avuto un incontro ravvicinato con un cammello o un dromedario è in grado di capire quanto sboldri siano questi animali. Che ondeggino tra le sabbie o sostino ai caldi raggi del sole, rimangono bestie dall’atteggiamento trasandato e decisamente impastato. Alpha Blondie, Hendrix, e Bob Marley sono infatti stati subito ribattezzati Voglia di Fare, Bavosa Guglielma e Maledetto Sborone. Il primo per la sua innegabile capacità di voler evitare ogni ostacolo che potesse minimamente affaticarlo (il che è stato in un paio di volte pericoloso per il sottoscritto), il secondo per la sua incredibile tendenza a paciolare senza ritegno ettolitri di bava (che finivano sempre sulle spalle del sottoscritto) e infine il terzo, troppo fiero e aristocratico per una ciurma scomposta e variopinta come la nostra. Lontani dall’insediamento, e avvolti dalle alte dune colorate, solo il rumore del vento che fischia tra le orecchie riesce a rompere il silenzio. Mentre i disegni creati dai percorsi solitari degli scarabei stercorari sembrano impreziosire con fantasiosi arabeschi le sabbie ocra del deserto. In circa due ore arriviamo nell’insediamento che si apre nella valle di sabbia e, dopo aver lasciato i cammelli a qualche passo di distanza, ci sediamo sopra dei tappeti consunti all’ombra di una tenda berbera sotto un sole cocente. Al nostro arrivo veniamo accolti da due ragazzini che si occupano di badare alle tende dell’insediamento; ci fanno accomodare e gentilmente iniziano a prepararci il pranzo. Invitiamo anche Mohammed a sedersi attorno al basso tavolino rotondo per chiacchierare e pranzare insieme a noi, ma all’inizio rimane un po’ stupito dell’invito. Rifiuta. Sostiene che la portata è per noi, che il pranzo non prevede la compagnia della guida. Fortunatamente, con un po’ di determinazione e qualche sorriso riusciamo a convincerlo e, seduti tutti attorno al tavolo, iniziamo allora a mangiare come si conviene tra i berberi. Dall'unica portata centrale e aiutati da piccoli pezzi di pane, prendiamo il cibo con le mani conversando piacevolmente riparati dalla calura esterna. Al rientro a Erfoud, in serata, una richiesta anomala da parte del giovane Rashid pone le basi per una serie di eventi incontrollati che ravvivano questo fine di giornata. Poter disporre anche se per pochi minuti di una bella auto da sfoggiare con gli amici sarebbe stata una bella soddisfazione per Rashid. Infatti, mostrarsi in paese alla guida di una macchina quando in pochi possono permettersi al massimo un vecchio motorino sarebbe stato motivo di invidia per molto tempo a venire. Insomma, Rashid ci chiede insistentemente di prestargli l’automobile, proprio una di quelle pretese che portano il nostro caro amico Daniele a innervosirsi con facilità. Per non lasciare libero il lato oscuro della sua personalità il buon Daniele decide allora di assecondarlo, ma ad una condizione: lo avrebbe accompagnato 13 quale che fosse la sua destinazione. Un po’ recalcitrante, ma vista l’assoluta fermezza della proposta fattagli, la nostra guida accetta, ingrana la prima e schizza via tra le stradine del suo quartiere sfrecciando come un pazzo a fari spenti nella notte (forse per vedere se poi è tanto difficile morire). Ora, se Daniele non ha avuto un infarto in quella situazione, credo non abbia più motivo di dubitare che possa accadergli. E mentre noi, ignari di tutto questo, attendevamo nella nostra camera, i fatti continuavano a spiegarsi nella loro drammaticità. Cosa avesse veramente in mente Daniele, infatti, nel momento in cui ha avuto l’ardire di chiedere a Rashid se sapeva quanto sarebbe potuta costare una jalabba, non lo so. Fatto sta che, dimentico della regola che l’amico dell’amico ha sempre un altro amico che conosce un amico che forse può aiutarti, in pochi secondi con la sua richiesta Daniele fa precipitare le cose. Rashid sterza bruscamente e, invertendo la direzione disegnando sull’asfalto una grande U (non metaforica, proprio vera), porta Daniele da un vecchietto che gestisce un piccolo negozio. Da quando siamo arrivati in Marocco, Daniele ha sempre avuto un debole per la jalabba; e perché effettivamente si tratta di un abito particolarmente curioso, e perché si tratta di un abito tradizionale marocchino ben diverso dalle leggere jalabba mediorientali, ma soprattutto perché assomiglia al saio di Obi Wan Kenobi. Ora aveva l’occasione per procurarsene una. Peccato non avesse al momento la minima intenzione di farlo. Il rito del tè accompagna tutta la trattativa nella quale un riluttante Daniele si vede abbassare il prezzo del vestito dai milleduecento dirham iniziali a seicento dirham, un costo comunque non indifferente. Daniele, sostenendo di averla vista a Marrakech per duecento dirham, non è disposto a spendere un solo centesimo in più, ma per non lasciare il commerciante con un pugno di mosche decide di comprare comunque un piccolo souvenir per la famiglia. Il vecchietto, per nulla intimorito, cerca di vendergliene almeno due. Come tornare a casa senza un ricordo per la fedele compagna? Ah, se solo il vecchio l’avesse saputo prima. Nessuna fedele compagna attendeva a casa il giovane Daniele, nel quale la ferita d’amore ancora fresca bruciava d’orgoglio. Non c’erano più dolci occhi che attendevano il suo ritorno, né cuori in trepidante attesa. Ah, se solo l’avesse saputo prima! Perché, se l’avesse saputo prima, non avrebbe certo aspettato tanto per proporgli l’affare della sua vita – sua del negoziante, ovviamente. Nonostante possa apparire alquanto surreale, senza attendere altro tempo, il vecchio coglie al balzo la situazione e informa Daniele di avere una bella e giovane sorella da maritare proponendogli poi un veloce accordo per il matrimonio. Per circa trentacinque cammelli di dote, Daniele avrebbe potuto avere in sposa, chiavi in mano, la giovane sorella. La proposta lascia talmente basito Daniele che a malapena riesce a rifiutare l’offerta. Dopo un pensante silenzio calato sulla contrattazione, Daniele decide di non proseguire oltre apprestandosi a pagare i due souvenir. Il vecchietto si avvicina e, con fare delicato, gli porge la jalabba: quattrocento dirham. A questo punto il lato oscuro della forza prende nuovamente il sopravvento 14 di Daniele che ostentando una certa calma nonostante il feroce sorriso rigetta la proposta. «Ho detto no! Cos’è, non ci siamo capiti? Il mio francese non è forse comprensibile? No significa no! Ca-pi-to? No!». Allora il vecchio negoziante inizia una pantomima degna del miglior attore drammatico. Sostiene di avere anche lui una famiglia da mantenere e dei figli da sfamare. Non ha voluto la sorella in sposa, la jalabba nemmeno, cosa potrà mai comprare da mangiare per i suoi figli con quel misero guadagno. E abbassa il prezzo di altri cento dirham. Ma non c’è nulla da fare, Daniele ha una parola sola. No ha detto, e no sarà. A questo punto il vecchietto rimane pensoso per alcuni minuti, la stanza è avvolta in un silenzio quasi religioso. Il negoziante osserva Daniele con lo sguardo meditativo mentre il tempo sembra scorrere molto, molto lentamente. Dopo di ché si avvicina furtivamente e, sussurrando lievemente all’orecchio il nuovo prezzo, capitola: duecentocinquanta dirham, e sia. Partano i titoli di coda, si dia inizio alla musica struggente che conclude ogni film degno di rispetto, che la parola fine sia da felice compimento. Il giorno seguente è dedicato interamente allo spostamento. Dobbiamo raggiungere, al più tardi nel secondo pomeriggio, il villaggio di M’Hamid, un piccolo paese di confine nelle vicinanze di Zagora. Nei nostri propositi c’è l’intenzione di sfruttare la luce radente delle cinque per fare qualche scatto a questo paese che, se le informazioni che abbiamo sono corrette, si dovrebbe presentare come un polveroso villaggio di frontiera ancorato al passato. Non molto dissimile da Merzouga, quindi, dove abbiamo però preferito qualche chiacchierata fuori programma con il buon Mohammed sul far del tramonto alla necessità di voler documentare attraverso l’occhio clinico dell’obbiettivo certe condizioni di vita da noi ormai dimenticate. Un’occasione di dialogo sicuramente più importante di qualsiasi soggetto fotografico. Attraversiamo dunque per l’intera giornata le strade strette e polverose che portano a Zagora, circondati da un paesaggio desertico e arido che si staglia col suo color ocra sul cielo cobalto. Il caldo torrido delle regioni al di qua dell’Atlante e la lunghezza del viaggio rendono estenuante il trasferimento, tanto da riporre nella meta aspettative eccessive. E forse è proprio a causa di questa idea di ritrovare un po’ di tranquillità che l’accoglienza invadente e ossessiva all’arrivo a M’Hamid ci coglie alla sprovvista. Arrivati al piccolo villaggio di M’Hamid, posto alla fine della strada che porta verso il confine algerino, veniamo assediati ancor prima di scendere dall’automobile. Cinque e più ragazzi si fanno intorno all’auto desiderosi di procurarci un albergo per la notte. Il vociare confuso e insistente, quelle mani che non sembrano trovare barriera tastando ogni dove per attirare l’attenzione, quella sottile aggressività nel promuovere ognuno un albergo diverso ci fa desistere. Ingraniamo la retromarcia e ritorniamo sui nostri passi, accostando qualche 15 chilometro più indietro per raccogliere le idee dopo la brusca accoglienza. Tempo qualche minuto e al rumore di motorini scarburati segue quello di voci urlanti che promettono hotel dalle mille e una notte, quelle stesse voci che fino a poco prima ci stavano ossessionando all’ingresso a M’Hamid. Infastiditi da questo tormento senza fine decidiamo allora di lasciare definitivamente il villaggio per fermarci più a monte, in uno dei paesi che avevamo già attraversato. La situazione che si è venuta a creare ci fa sprofondare in un completo disagio. Per quanto la condizione economica di questa parte del Marocco sia più difficile e dura, mai avremmo pensato di diventare oggetto di una irruente contesa nostro malgrado. Gli unici clienti da contendersi in un gioco a somma zero che alla fine non ha risparmiato nessuno. Omar, sguardo di ghiaccio rivolto verso la strada, non riesce a trattenere il suo nervosismo. L’idea di aver gettato alle ortiche una giornata intera lo stava portando verso il lato oscuro della forza e, benché nei sedili posteriori Daniele vestito con la jalabba di Obi Wan Kenobi cercasse di dissuaderlo, quasi nulla avrebbe potuto riportarlo sulla retta via. Quasi, dicevo. Perché d’un tratto, usciti da un piccolo villaggio, vediamo alla nostra sinistra una partita di calcio stagliarsi sul tramonto. Giovani in divise gialle e verdi giocano su un campo polveroso rubato al deserto, mentre tutt’intorno bambini e ragazzi seguono con interesse la partita. Omar inchioda. «Tanto, peggio di così non può andare» sembra dire con il suo gesto. «Guardiamoci almeno questa partita e chissà che non ci aiuti a sbollire gli animi». Intanto frotte di bambini curiosi si sono fatti intorno all’automobile. Così tanti che per un animo inquieto avrebbero potuto essere l’ultima goccia che fa traboccare il vaso. Una sola è la decisione da prendere. E va presa in pochi secondi: scendere o partire? Scegliamo la prima. Alle 18.00 ci cambierà l’intera giornata. Non appena scendiamo dall’auto veniamo circondati dai bambini eccitatissimi. Il frastuono di parole confuse si accompagna a voci più distinte che cercano di attirare la nostra attenzione. «Missiu, Missiu» chiamano a gran voce in un improbabile francese cui seguono le classiche richieste di bon-bon e stilò. L’accoglienza è quella riservata ai divi hollywoodiani, tutti si fanno intorno e ormai più nessuno è interessato alla partita. Lo stesso allenatore, intervenuto per allontanare i chiassosi e simpatici bambini, non presta più attenzione ai suoi ragazzi intenti a giocare la finale del torneo. Siamo il centro dell’attenzione. Non capita spesso che tre stranieri si fermino incuriositi in queste zone. La fine della partita non si fa attendere e da quel momento veniamo letteralmente presi d’assalto. Si viene a creare un grande interesse verso di noi, tanto da farmi arrossire quando capisco che desto curiosità in quanto rappresentante della mia cultura. Purtroppo non conosco il francese e i margini di comunicazione sono ristretti. Ma la voglia di comunicare è molta, e il fermento dato da 16 questa necessità si fa ancora più forte. Nomi e richiami s’incalzano l’uno dietro l’altro e sul momento rimango leggermente disorientato. Poi, quando mi viene presentato l’unico ragazzo presente in grado di parlare in inglese, capisco. Il sole è ormai tramontato quando, in modo del tutto spontaneo, veniamo invitati dagli organizzatori della partita a cenare con loro. Accettiamo con piacere pur rimanendo con le orecchie ben tese. Perché è inutile negarlo, per quanto la situazione si dimostri piacevole è sempre meglio cercare di aprire bene gli occhi. Una piccola e ben celata diffidenza, spesso aiuta a non lasciarsi incastrare in spiacevoli situazioni. E, bisogna ammetterlo, un minimo di circospezione non è mancata quando, accompagnati alla sede della loro organizzazione, abbiamo attraversato luoghi bui e per nulla illuminati che s’addentravano tra le vie polverose del villaggio allontanandosi sempre più dalla strada principale. A guardare le cose da un punto di vista esterno, il nostro arrivo sembrava aver sortito lo stesso effetto che ha un sasso lanciato in un formicaio. Accomodati nella sala principale della casa, assistiamo a un via vai di persone che entrano ed escono con sorprendente rapidità: c’è un gran movimento e noi siamo il centro ideale attorno al quale ruota questo turbine. Tutto il paese è in subbuglio. Fortunatamente, dopo qualche decina di minuti tutto ritorna alla normalità e con la calma e tranquillità che contraddistingue le popolazioni maghrebine veniamo messi completamente a nostro agio. Seduti per terra come si conviene, sopra semplici tappeti, riprendiamo le conversazioni interrotte al campo di calcio. È così che apprendiamo, accompagnati dal tradizionale rito del tè, di essere ospiti di un’associazione culturale di indirizzo progressista che opera nel piccolo paese di Tagounite. I ragazzi che la gestiscono ci spiegano come questa associazione, chiamata Al Michaal, sia ramificata in tutto il Marocco e si preoccupi di promuovere azioni sociali volte a migliorare le condizioni delle persone. Un occhio particolare è dedicato soprattutto alle donne e alla diffusione di quegli strumenti indispensabili alla loro emancipazione. Giusto in occasione della Festa della Donna, vengono organizzati tre giorni di festa per promuovere nel villaggio l’alfabetizzazione femminile, uno dei capisaldi dell’associazione, e sottolineare l’importanza che questa riveste per avviare qualsiasi processo di emancipazione. In un contesto dove spesso manca un confronto dialettico la possibilità di condividere le esperienze con persone nuove è una rara opportunità. Per quasi tutta la serata ho l’occasione di parlare con Madani, presidente dell’associazione, un giovane professore di ventisei anni, insegnante di arabo presso la scuola locale. Di buona famiglia, avrebbe potuto intraprendere una carriera al nord, nella capitale. Alla vita di città ha preferito invece il ritorno al suo piccolo paese dove spendersi per migliorare una situazione ancora difficile. Da quanto ho appreso, sono diverse le anime che danno corpo all’associazione ma, nonostante le sfumature che le contraddistinguono, tutte hanno un unico obiettivo: migliorare le condizioni 17 sociali della propria gente. Questo malgrado le pressioni da parte degli anziani del paese siano fortissime e il raggio di azione pericolosamente limitato. È indubbio infatti come, all’interno di uno stato monarchico autoritario, benché non dittatoriale, le libertà d’azione siano limitate e anche il più piccolo errore rischi di compromettere le attività dell’associazione. I contatti con altre associazioni straniere sono abbastanza frequenti, anche se è molto difficile promuovere le proprie iniziative all’estero. Infatti, la stessa libertà di circolazione delle persone e delle merci sembra andare a senso unico. Se per visitare il Marocco le formalità che permettono a noi italiani di entrare sono di una semplicità disarmante, purtroppo non è vero il contrario. E le migliaia di immigrati clandestini di origine marocchina che entrano illegalmente ogni anno nel nostro paese lo dimostrano ampiamente. Ciò che invece raramente viene menzionato, sono i motivi che alimentano un così grande flusso di clandestini. E questi motivi sono tutti italiani. Ricevere un visto per entrare in Italia infatti è tutt’altro che facile. Non importa se tu abbia o meno un lavoro, se tu sia o meno una persona rispettabile, se tu appartenga a un ceto sociale più o meno elevato: il visto turistico viene rilasciato solo se qualcuno in Italia può garantire per te. Finanziariamente. Nessun’altra possibilità di azione. Nessun’altra scelta. La globalizzazione va in un’unica direzione e la libertà di circolazione tra i paesi è di fatto una chimera. La serata trascorre cordialmente cenando attorno a un piccolo tavolo tra discussioni sulla instabilità della situazione internazionale e qualche discettazione culturale su Gramsci e Umberto Eco, finché a tarda notte non siamo costretti ad abdicare alla stanchezza. Per la notte siamo invitati a restare come ospiti. Sullo stesso pavimento che prima aveva accolto il vivace brulicare di persone vengono preparati i giacigli per la notte. Qualche coperta e dei cuscini comodi bastano per abbandonarci agiatamente alle braccia di Morfeo. Ci svegliamo sotto gli sguardi incuriositi dei bambini che, arrampicati alle inferriate delle finestre, fanno capolino sorridenti. La sera prima, uno di loro era stato designato da Omar custode ufficiale dell’auto e già di prima mattina attendeva il nostro risveglio per accaparrarsi la ricompensa. Alla luce del sole ci appare più chiara la costruzione dove siamo stati ospitati. Differentemente da molti villaggi incontrati sulla strada che porta a M’Hamid, quello di Tagounite è costruito prevalentemente con mattoni di calcestruzzo e la casa dove abbiamo dormito non fa eccezione. Realizzata su un piano soltanto, ma lasciando il secondo non finito in attesa di futuri ampliamenti, ha il pavimento dell’intero pian terreno in terra battuta. Unica stanza a divergere è proprio quella dove siamo stati ospitati, la sola con il pavimento cementato. Una stanza che diventa soggiorno, salotto e camera da letto a seconda della necessità d’uso. Il giovane padrone di casa ci mostra con soddisfazione il risultato dei suoi sacrifici, ottenuto con anni e anni di duro lavoro nella sua piccola piantagione di datteri nell’oasi poco distante. È incredibile come la vita riesca a svilupparsi anche in luoghi così inospitali. 18 Basta una piccola riserva d’acqua, una falda o una sorgente e anche in un territorio desertico dove da ben sette anni la pioggia si fa attendere può svilupparsi una piccola agricoltura di sostentamento. I datteri raccolti vengono preparati per poi essere venduti al mercato Marrakech, dopo un lungo viaggio che impegna lo stesso giovane per diversi giorni al dorso del mulo attraverso i monti dell’Atlante. Purtroppo dobbiamo lasciare il villaggio, ma prima di partire non mancano di offrirci la colazione, dimostrando ancora una volta quanto sia importante per loro il concetto di ospitalità. Sul tavolo rotondo, attorno al quale sediamo insieme al padrone di casa, viene poggiato del pane, l’immancabile tè e una piccola ciotola ricolma d’un liquido denso e dall’odore forte. Seguendo l’esempio del giovane, anche noi iniziamo a inzuppare il pane nel liquido denso assaggiandolo con un po’ di circospezione, come farebbe un animale al quale viene offerto del cibo. Lascia stupefatti scoprire che si tratta di olio di oliva aromatizzato, che ben si accompagna al pane azzimo e al sapore del tè. Un tè decisamente particolare, diverso e più corposo del tradizionale tè diffuso nella regione. Come sia arrivato sin qui non ci è dato conoscere, probabilmente introdotto da qualche studente universitario che a suo tempo ebbe modo di gustarlo in qualche città più fornita. È un tè giapponese chiamato Leone del Deserto, non molto diverso esteticamente dal Powder che è però più rotondo quanto questo è oblungo e simile a un chicco di riso. Forte, corposo, intenso. Sicuramente il miglior tè che abbia mai assaggiato. Partiamo un po’ a malincuore, anche se ci rendiamo conto che l’orizzonte davanti a noi non può che essere sempre in movimento. Ciò che lasciamo possiamo solo portarlo dentro di noi perché viaggiare è portare con sé ciò che si lascia alle spalle. La direzione è quella che porta a Ouarzazate passando da Zagora. Ed è proprio prima di Zagora che ci fermiamo, attirati dal piccolo paese di Tamegroute. In realtà il paese non appare poi così diverso dai molti che abbiamo lasciato scorrere attraverso i finestrini della nostra auto. Eppure decidiamo di fermarci, senza renderci conto che Tamegroute non è un paese normale. Qui la gente ha la pelle color dell’ebano, pronipoti probabilmente di quegli schiavi trasportati generazioni or sono dalle carovaniere che arrivavano dal Mali. I bambini ci seguono curiosi attraverso le vie polverose del villaggio, tra rottami di auto lasciati arrugginire e donne che rovesciano i liquami della notte poco oltre la soglia di casa. Siamo osservati, questo è certo, ma nessuno sguardo si posa su di noi con fare sospetto; piuttosto destiamo interesse, tra gli uomini raccolti all’ombra del palmeto come tra i ragazzini che tornano da scuola. Non riusciamo purtroppo a scattare alcuna foto di una splendida venere nera che si presenta ai nostri occhi nei panni di una giovane contadina. Benché fosse bendisposta a farsi ritrarre, abbiamo dovuto abdicare all’arrivo dell’anziana madre che, nonostante il fare bonario e scherzoso nei nostri confronti, mostrava verso il comportamento malizioso della figlia una certa intransigenza. 19 Soggiaci così racchiusa nella memoria, intrappolata; finché il passar del tempo i ricordi miei non spenga; al sol ricordo, oh nera musa sarai così la Venere sognata. A ben pensare, forse è venuto il momento per spiegare come mai in questo scritto prosaico fanno capolino ogni tanto dei giochini in rima. Solo che non saprei da che parte cominciare, non è poi così semplice mettere le cose nero su bianco. È un po’ come abdicare alle proprie responsabilità. E poi avevo promesso di non proferire parola alcuna, ma mica posso tenerlo nascosto ancora per molto. Insomma, ne va anche dello stile di questo mio scritto. Vediamo, da dove posso iniziare? Beh, forse dalla cosa più semplice: non li scrivo io. Ecco, l’ho detto. Finalmente mi sono liberato di questo fardello. Il mio psicoanalista ne sarebbe felice se non fosse in cura per una crisi depressiva. Ora però resta da spiegare chi sia il vero autore di questi versi. E al solo pensare di doverlo svelare, un poco mi vergogno. Certo, con quella sua insistenza potrebbe ottenere qualsiasi cosa. La luna, le stelle, l’universo intero. Eppure gli basta così poco; ma per quel poco è capace di capovolgere il mondo. Un bambino che punta i piedi gridando con voce stridula e assordante appare come una dolce visione al confronto della sua petulanza. Sua del mio psicanalista. Proprio lui, poverino! Credeva d’essere un gran poeta, benché la sua fosse fatica sprecata; e se talvolta scrive qualche verso, colgo occasion di pubblicarlo in questo testo. Riattraversiamo l’Alto Atlante per ritornare al punto di partenza. Dopo una settimana passata tra i paesaggi polverosi e desertici del sud est marocchino, riprendiamo contatto con i verdi e rigogliosi versanti montani attraversati dai numerosi torrenti che scorrono tra le valli. Guardando le donne lavare i panni nelle limpide acque dei torrenti montani, non posso evitare di pensare alla loro dura ma dignitosa vita nel villaggio abbarbicato su un leggero pendio. Lavano come avevano lavato i panni le nostre nonne quando anche l’Italia era un paese di emigranti: il torrente come acquedotto, un tinello e la forza delle braccia come lavatrice. Non sono infastidite dagli sguardi curiosi e continuano il loro lavoro con caparbietà, lanciando ogni tanto saluti benevoli nella nostra direzione. Oggi abbiamo avuto il nostro primo incontro con la polizia locale. Beninteso, avevamo avuto più e più occasioni di incrociare uomini in divisa mentre controllavano lungo la strada altre automobili, ma sin’ora mai una volta avevano dato modo di preferire l’automobilista straniero agli 20 automobilisti locali lasciandoci sempre passare tra ampi sorrisi. Sembrava quasi vi fosse in atto un tacito accordo di non belligeranza. Ma come tutti gli accordi di non belligeranza (questo poi era pure tacito), non poteva prima o poi che venir meno. Cosa frullasse nella testa dell’amico poliziotto non ci è dato sapere, certo non si trattava di ligio senso del dovere. Quando siamo stati fermati, il poliziotto si trovava alla nostra sinistra a cavallo della linea mezzana che separa le due corsie giusto sul lato del conducente. Intanto noialtri eravamo già pronti per presentare tutti i documenti del caso: quelli dell’auto, la patente, i passaporti e via dicendo. E mentre io e Daniele ci arrabattiamo per cercare nella confusione quanto necessario, sentiamo il poliziotto che con una voce autoritaria ci intima: «potreste mica moderare la velocità, per piacere». Ora, è probabile che noi si sia abituati troppo bene con i nostri poliziotti che, quando ti fermano, dopo averti squadrato dal capo ai piedi ti chiedono tutti i documenti possibili e immaginabili che la burocrazia italiana abbia mai inventato, anche quelli che (puoi starne certo) hai dimenticato a casa. E tu lì, preso dal piacere masochista di prodigarti in tutte le loro richieste mentre l’adrenalina inizia a scorrere nelle vene. «Patente, celo. Libretto, celo. Bollo auto, ah, ah, celo. Assicurazione, assicurazione, assicurazione… Dov’è l’assicurazione! Eppure celo. Da qualche parte, ma celo. Sì, mi scusi agente, è questione di un attimo. Dove l’avrò messa? Pronto? Cara, sì sono io, sai dove ho riposto il tagliando dell’assicurazione quando l’ho rinnovata l’altro giorno? Per fortuna, e dove sarebbe? Ah, è vero grazie, come farei senza di te, sì, sì ciao, anche tu, sì, no, adesso devo andare, no, è che c’è la polizia, no, no, niente, un controllo, no, non pensare male, no, cosa, no, ma, insomma…» click. Come dei bambini viziati che pretendono sempre il migliore dei giochi, anche noi ci aspettavamo chi sa quale caccia al tesoro tra la confusione che regnava sovrana nell’auto dopo una settimana di viaggio. E invece? Invece ci chiede solo di moderare la velocità, garbatamente, con gentilezza, quasi fosse a nostra discrezione. Omar basito annuisce. Insallah, grazie e arrivederci. Arriviamo a Marrakech nel primo pomeriggio e con un po’ di ritardo consegniamo l’auto rischiando di vederci conteggiare un giorno in più rispetto a quanto stabilito. Assistiamo a una bella tirata d’orecchie da parte del capoufficio al giovane che ci aveva noleggiato l’auto. Si portano in una saletta attigua, ma lasciano volutamente la porta aperta discutendo animosamente in francese perché anche noi potessimo vedere e comprendere. «Non è così che si fanno gli affari, non si può promettere al cliente di arrivare all’ora che vuole fregandosene dei regolamenti. Questa volta passi, ma alla prossima i soldi escono direttamente dalle tue tasche». Un colpo al cerchio e uno alla botte. Noi e il giovane ci sentiamo molto fortunati. 21 Ultima giornata in Marocco. Già il pomeriggio dobbiamo prendere il treno per Casablanca, così da essere lì in serata. E mentre attraversiamo ancora una volta la città, questa condizione pesa sulle nostre spalle. Manca il contatto con la gente e camminiamo soli nella moltitudine. Il viaggio è venuto meno, giriamo la città da turisti tra i tanti turisti. La giornata è veramente torrida. Probabilmente la pioggia arrivata con la perturbazione che ci aveva accolto all’inizio del viaggio aveva portato un po’ di frescura. Tutto d’un tratto, sembra di ritrovarsi in pieno luglio in una città italiana, con la differenza che qui l’inquinamento non è un giochino per amministrazioni distratte e, sommato alle condizioni climatiche, si rivela fatale. La maggior parte delle auto non è catalizzata e il sapore aspro del benzene ti costringe i polmoni rendendo la respirazione decisamente pesante. Sarà stato questo, sarà stato l’intestino che proprio nell’ultimo giorno ha deciso di risvegliarsi dal suo torpore, sarà stata la zuppa della sera prima consumata alla luce della luna sui tavolini all’aperto di un locale verace, sarà stato il solo pensiero di affrontare per l’ennesima volta un pranzo a base di carote e patate stufate (le poche volte che si riesce a scorgere nella tajine dei ceci o dei piselli è giorno di festa grande), fatto sta che mi sento decisamente sbattuto. Un lenzuolo ambulante in cerca dello stendino. Cerco di tirarmi su con un pranzo a base di vitamine. Qualche arancia, una banana e delle mele sono bastate per riportarmi sulla retta via anche se, bisogna ammettere, l’odore delle verdure stufate che contornavano il pollo nei piatti dei miei commensali hanno rischiato di farmi sprofondare nuovamente tra le braccia di Vomitus, il dio greco della nausea. La medina di Marrakech è piena di scorci interessanti e i souq che l’attraversano ritraggono il lato più umano della città. A differenza infatti del grande souq che parte da Djema el Fna, prettamente turistico, nella medina si trovano i negozi dove si riforniscono gli abitanti della città. Tra le strette vie polverose ci si imbatte nelle botteghe di calzolai e artigiani intenti nel loro lavoro. Mentre le macellerie dirimpetto mostrano compiaciute la loro merce preziosa, posata sul banco, a disposizione. Qui odori acri e profumi intensi s’alternano confondendo le narici, mentre i colori accesi delle vesti della gente distraggono gli occhi. La medresa Ali Ben Youssef, il più grande collegio di teologia del Marocco, oggi divenuta uno splendido museo dove poter ammirare l’architettura araba è un’occasione da non perdere visto che la maggior parte dei luoghi religiosi in Marocco sono interdetti ai non mussulmani. Camminiamo per ore, perdendoci tra le anguste celle degli studenti coranici che ricordano in qualche modo quelle dei monaci cristiani e gli ampi saloni comuni decorati da preziosi stucchi. Le finestre delle sale danno nel soleggiato cortile interno dove al centro si trova una imponente vasca che rinfresca dalla calura. Riparati in un angolo all’ombra, rapiti dai giochi di luce creati dall’acqua, ci riposiamo qualche istante per rimettere un po’ d’ordine ai mille pensieri. Poi riprendiamo la strada che porta alla stazione. 22 Ed eccoci qui, pronti per ritornare a Casablanca dove tutto è iniziato. Salgo sul treno che mi porterà a destinazione un po’ svuotato, come alla fine di ogni viaggio. La tentazione di guardare indietro è forte, ma non si può voltare le spalle all’orizzonte. Mi rammarico per il poco tempo dedicato a questa splendida terra abitata da un popolo cordiale e amichevole. Certo, avrebbe necessitato di molti più giorni per essere capito a fondo, per essere compreso. Ma il pensiero è rivolto al futuro, a quello che sono e a quello che sarò. Mi ritrovo a pensare alle persone incontrate, a quelle ancora da incontrare, in quel gioco delle probabilità che è la vita. E mentre sprofondo nei miei pensieri, il ridondante rumore del treno ci traghetta verso una nuova esperienza. 23
Scarica