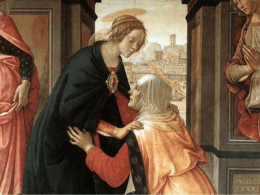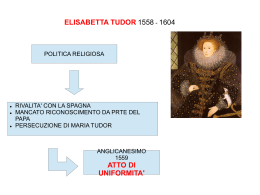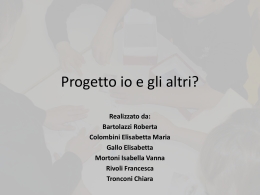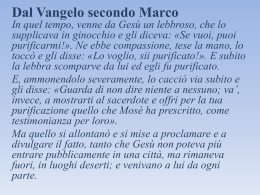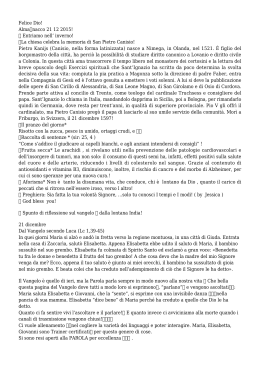leggi, scrivi e condividi 10 righe dai libri http://www.10righedailibri.it Heroes MARGHERITA GIACOBINO L’ UOVO FUORI DAL CAVAGNO I edizione giugno 2010 © 2010 Elliot Edizioni s.r.l. via Isonzo 34, 00198 Roma Tutti i diritti riservati Cover design: IFIX project ISBN 978-88-6192-142-9 [email protected] www.elliotedizioni.com www.myspace.com/elliotedizioni Breve vita e improvvisa morte di Gioia Non è mai troppo presto per imparare a difendersi. A cinque anni mi misero gli occhiali. Si ruppero quasi subito, mentre mi azzuffavo con un bambino che mi aveva presa in giro per quella grossa montatura scura che mi sballonzolava sul naso mentre correvo. Ho dimenticato il nome di quel bambino, però ho ancora sulla mano la cicatrice che mi procurai rotolando sugli occhiali mentre ci prendevamo a calci e pugni. Gli occhiali costano, mi disse Elisabetta versando alcol sulla ferita. Il prossimo paio vedi di fartelo durare, io non sono mica una banca. Qualche giorno dopo la madre del bambino venne al ristorante a lamentarsi che avevo rotto un ombrello in testa a suo figlio. Le avrà fatto qualcosa anche lui, disse Elisabetta. Non sarà mica un innocentino. L’altra madre se ne andò sdegnata. Che piattola, commentò lei. Temevo che mi rimproverasse perché gli ombrelli costano, ma non disse niente. L’ombrello comunque era di quell’altro, non nostro. È in seguito a episodi come questo che ho cominciato a sospettare che il mondo non fosse stato fatto per me. Nel senso che Dio, o chi per lui, non l’aveva progettato all’esplicito scopo di soddisfare le mie esigenze, prevenire i miei desideri e innalzare il mio ego. Nei momenti più neri avevo perfino il sospetto che Dio avesse avuto un occhio di riguardo per i miei nemici. Non ero solo contrariata, ero sbalordita. Se Dio non aveva fatto il mondo perché fosse ai miei ordini, per quali altre perverse e futili motivazioni aveva agito? Sapevo poco di Dio, a parte che era stato lui a creare l’universo, cosa che non andava certo a suo credito. In casa nostra non c’erano crocefissi né Madonne, e quando le chiesi informazioni su 7 Dio (dove abita, come si fa a sporgergli un reclamo, perché ha creato le formiche rosse e i prepotenti), Elisabetta mi disse che prima o poi qualcuno me l’avrebbe spiegato, ma quel qualcuno non sarebbe stata lei. Perché? Perché io non c’entro, disse lei. Togliti dai piedi che ho da fare. Tua madre è una comunista barbetta, mi disse Cecca. Non crede in Dio ma fa male, verrà il momento che se ne accorgerà. Che momento? La pocalisse, ansimò Cecca accendendosi una Camel senza filtro. La poca che? La fine del mondo! tossì lei. E quando viene? Presto, rumoreggiò cupamente Cecca. La gente è sempre più marcia. Ah non tarderà! Tu non credi in Dio? verificai con Elisabetta un momento che mi sembrava di buonumore. Non è che non ci credo, disse lei tirando la sfoglia degli agnolotti. È che non ho niente da dirgli. Lui al suo posto, io al mio. Senza togliere niente a nessuno. Ma lui può punirti se non ci credi? Mi punisce già tutti i giorni, disse Elisabetta. Devo sopportare te e tuo padre. Come si vede, ero circondata da enigmi. Il mio cervellino di bambina doveva darsi da fare. Decisi che sarei cresciuta in fretta. Nel frattempo, e in attesa di capirci di più, informai Cecca che Elisabetta la barba non ce l’aveva. È barbetta lo stesso, disse lei, perché non va in chiesa ed è comunista. Neanche tu vai in chiesa. Cosa vuol dire comunista? Io non ci vado perché non mi piacciono i preti, ma adoro Dio. I comunisti invece adorano Stalin. Chi è Stalin? Un diavolo rosso. Uau! E dove abita? Tu lo conosci? In Russia, ma è morto per fortuna. È andato all’inferno. È all’inferno o in Russia? È lo stesso. E dov’è l’inferno? Sottoterra. Come la cantina? Mi ci porti? Non dire tavanate. Tu all’inferno non ci andrai perché sei il mio ovetto benedetto. Tu andrai in paradiso con gli angeli vestiti di bianco. Ma prima bisogna stare sulla Terra e divertirsi un po’, basta parlare di queste cose. E così Cecca mi portò a prendere il gelato, cioccolata e pistacchio, i miei gusti preferiti. Più crescevo, più risultava evidente che la vita era un indecifrabile miscuglio di piacere e dolore, desiderio e frustrazione, pace e guerra. Dovevo aguzzare l’ingegno e attrezzarmi per la difesa. Sulla forza fisica non potevo contare, ero un ragnetto di bambina; di bellezza neanche a parlarne, esteticamente sono sempre stata borderline tra l’insignificanza e la bruttezza. Decisi che in un futuro il più possibile prossimo sarei diventata un genio, preferibilmente del male, e di conseguenza molto potente. L’essere umano più potente della Terra e dintorni, al punto che anche Dio avrebbe dovuto rispettarmi. Dovevo ancora lavorare sui dettagli, tipo come fare, ma l’idea base mi sembrava buona. Non credo di essere stata più bellicosa di qualunque altra creatura in età prescolare; amavo e odiavo e anelavo alla distruzione dei miei nemici più o meno come tutti gli altri. E infatti non pensavo di essere diversa dagli altri. Ma spesso mi rendevo conto che erano gli altri a essere diversi da me. Le altre bambine, soprattutto. A volte cercavo di aiutarle a superare questo handicap, ma con scarsi risultati. Il mio avventuroso viaggio nel mondo dei diversi da me cominciò alle elementari, grazie ai miei genitori, che pensarono bene di mandarmi a una scuola privata frequentata da tesorucci di famiglie mediamente molto più ricche della nostra. Bambini che facevano la settimana bianca a Courmayeur e avevano le tate. Mocciosi le cui mamme andavano in analisi e a ristrutturarsi nelle beauty farm e mettevano su laboratori di tessitura al telaio e gallerie d’arte per realizzarsi e combattere la depressione. Elisabetta fa la cuoca e mio padre è maître e sommelier; lavorano diciotto ore al giorno, ecco perché mi hanno mandata alla Sinite Parvulos, un covo di letale perbenismo urbano. Non solo una scuola privata di ricchi, ma una scuola cattolica! I miei sono tutt’e due costituzionalmente atei. Si può essere più contraddittori di così? Ma Elisabetta si difende dicendo che 8 9 non aveva tempo per guardarmi crescere, un’occupazione mortalmente noiosa per cui solo le mamme ricche hanno tempo, nonché denaro per pagarsi la psicoterapia inevitabile nel momento in cui il desiderio di strozzare i loro pargoletti minaccia di travolgerle. In prima elementare, quando ho capito di dover restare per buona parte del giorno in compagnia di smorfiose col culetto fasciato dai pantacollant e scarsissimi segni di attività cerebrale (i maschi non erano meglio, anzi erano più primordiali, ma più diretti), mi sono sentita in un gulag. Non che allora lo chiamassi così, il mio vocabolario era ancora rudimentale. I miei compagni di classe avevano quella specie di sofisticazione che non viene dalla cultura, dall’intelligenza o dalla sensibilità artistica, ma dall’appartenenza a una fascia privilegiata di consumatori. Mi guardavano dall’alto delle MasterCard dei loro papà; nei loro sguardi vidi improvvisamente riflessa la mia immagine, e capii che dovevo vergognarmi, come Eva. Non perché fossi nuda, ma perché ero vestita decentemente, pulita lavata e stirata e niente più, mentre loro invece erano griffati e finti trasandati, con i lacci delle Nike che si trascinavano per terra e, i più grandi, il cavallo dei pantaloni che gli arrivava al ginocchio, per non parlare della biciclettina cromata con dodici cambi tenuta religiosamente per il manubrio dalla remissiva filippina o peruviana ombrosa che li aspettava nel viale davanti a scuola. La differenza di classe era già abbastanza irritante, ma la questione dei generi sessuali era decisamente esasperante. Io amavo le bambine, ma non i loro giochi; amavo i giochi dei maschi, ma non i maschi. Avrei voluto giocare alla guerra con le bambine, e che i maschi se ne stessero a casa ad accudire le nostre bambole mentre noi ce ne andavamo in giro a mettere il mondo a ferro e fuoco. Scoprii che non era praticabile. C’era qualcos’altro ancora, di più sottile: quei bambini, maschi e femmine, sembravano essere tutti al corrente di un segreto che io non sapevo, o addirittura parlare una lingua che era solo apparentemente la stessa che parlavo anch’io, e solo in modo superficiale coincideva con l’italiano che ci insegnava suor Divina Misericordia. In realtà, quando si dicevano le frasi più banali tipo “passami la gomma”, evocavano regole arcane, certezze inarrivabili ed elaborati cerimoniali di etichetta di cui io ero all’oscuro. Loro erano giusti e io non lo ero. Ma giusti per cosa? Quando Cecca veniva a prendermi a scuola, le mie compagne si scambiavano sguardi complici, ridacchiando. La mia raccolta di etichette di vini, di cui andavo fiera, cadde nel più totale disinteresse. Risultai la sola bambina a dichiarare che da grande voleva fare il chirurgo. Ma si può sapere perché tu devi essere sempre diversa da tutti gli altri? mi chiese Elisabetta quando la tata di una compagna mi riconsegnò spiegando, in un italiano gutturale, che mi ero macchiata di un delitto efferato: avevo tagliato i capelli alla Barbie della Elvira. E tu perché non mi hai mandata alla scuola statale? sbottai io. Alla statale in fondo alla strada c’erano i pidocchi e la droga, e giravano certi tipi tosti che li avrebbero tagliati alla Elvira, i capelli, altro che alla Barbie. Io anelavo di andarci. Sta’ zitta, disse Elisabetta. Con te facciamo i conti dopo. La Elvira è una piattola, dissi. Elisabetta mi lanciò un’occhiata abrasiva. Ma è vero! protestai. Lei mi tirò dentro, salutò la tata straniera, chiuse la porta e mi mollò una sberla. Così impari che la verità si dice a tempo e luogo, mi disse. Non è giusto, dissi io. Adesso me ne dai un’altra per la Barbie. Chi se ne frega della Barbie, disse lei. Le ho sempre odiate io, quelle robe lì. Mi fanno schifo. E se ne andò in cucina. Io la seguii, con gli occhi lucidi di amore e dolore. 10 11 Elisabetta è stata la mia prima donna ideale. Il modello di ogni perfezione. La dea senza nome. Questo mondo imperfetto e ostile l’avrà anche fatto Dio, un maschio, ma sotto sotto, dentro di me, nella profonda inesplorata foresta pluviale del mio cuore, negli abissi del mio spirito, vive una dea senza nome, e la sua prima incarnazione è stata Elisabetta. Ero giusta o no per Elisabetta? Quando eravamo lei e io sole, avrei giurato di sì. Anche se pettinandomi mi strigliava come un cavallo riottoso, e uscivo dalle sue mani piagnucolante e con gli occhi alla cinese tanto era stretto il nodo dei capelli, riconoscevo nel suo tocco l’amore e l’appartenenza. Io ero cosa sua e lei mi avrebbe protetta e difesa contro chiunque. Ma le rare volte in cui veniva a prendermi a scuola, le sue dita si stringevano nervose attorno al mio braccio e mi trascinavano via in un modo che mi inquietava. Avrebbe forse preferito come figlia una di quelle piccole smorfiose sempre pronte a sedurre e a fare la spia? Vedeva in me qualcosa che non andava? Qualcosa che la faceva segretamente vergognare? – bella forza, lei aveva ventisette anni e io ero una bebè calva e scalciante con le natiche arrossate – le conferisse un diritto di prelazione a vita sull’appellativo che mi designa. Per lei io sono Gioia, che piova o faccia sole. Che io sia uguale o diversa, asina o laureata, etero o omo, un successo o un fallimento, sono sempre Gioia per lei. E io glielo concedo. A volte, abiettamente, mi rassicura. C’è del buono nell’essere sempre ancora e soltanto Gioia per lei. Le bambine mi hanno procurato molti guai. Le bambine erano una ferita sempre aperta. C’era qualcosa in loro che mi induceva a stuzzicarle, e qualcosa in me che le induceva a tradirmi. Le bambine erano crudeli. Tutti i bambini, maschi e femmine, sono notoriamente dei sadici per i quali avere il potere di far soffrire qualcuno è un motivo valido e sufficiente per farlo. Ma le femmine lo sono in modo più raffinato, disdegnano la rozzezza delle botte e degli insulti e si servono di mezzi più sottili: sguardi, allusioni, rifiuti. Mi hanno insegnato molto, ma l’apprendimento è stato intessuto di sofferenza. Gli uomini, dai tre anni in su, pensano che tra donne ci sia soltanto disinteresse o competizione. Si sbagliano. C’è una vera e propria guerra. Una lotta subdola, efferata, all’ultimo sangue. Credetemi, io ci ho lasciato le penne, in questa guerra. Ho capito presto che la mia strategia doveva essere il cinismo, e la mia arma le parole. Avevo bisogno di parole contundenti da lanciare contro il nemico, parole fumose per accecarlo, parole seduttive per conquistarlo, ma anche parole da tenere per me, come esorcismi o preghiere o formule magiche. Le parole erano lì, attorno a me, fluttuavano come farfalle dalle grandi ali rosse e blu, svolazzavano come pipistrelli, e io qualche volta le acchiappavo e le mettevo sotto vetro, cercavo di appiccicarmele addosso come uno di quei finti tatuaggi che piacevano ai miei compagni di classe, quelli che si lavano via il giorno dopo. Ora invece ho dei tatuaggi veri, che non verranno mai via a meno che non mi faccia asportare lembi di pelle, cosa che non ho nessuna intenzione di fare, per il momento. Ne ho sette, in vari punti del corpo. Sette tappe della mia versione personale di avventure nel mondo, il mio viaggio spericolato attorno al continente Dolores. Elisabetta non li sopporta, i miei tatuaggi, i tuoi sfregi li chiama. Inoltre, Elisabetta si ostina a non chiamarmi Dolores. Come se il solo fatto di essere arrivata per prima a darmi un nome Amavo le bambine, lo ammetto. Non era solo sesso. Mi coinvolgevo. Perdevo la testa, come tutti gli innamorati. Sentivo il bisogno irrefrenabile di sedere nello stesso banco della mia amata, di condividere con lei le mie merende, le mie matite, i miei libri. La mia massima aspirazione era appartarmi con lei nell’intervallo in un luogo intimo e accogliente, come lo stanzino delle scope al primo piano, e lì baciarla e toccarla e disfarle i codini intanto che le raccontavo le storie che avevo inventato per lei di notte, prima di dormire. L’amata di solito ci stava per un po’, poi vedendomi nelle sue mani si negava, mi snobbava e alla fine mi scatenava contro le sue accolite, come una muta di graziose cagnette dai denti aguzzi assetate del mio sangue. La mia avventura erotica più clamorosa fu Veronica, con cui giocavo al dottore a sette anni. Carina, occhi scuri, capelli afro, le mancava la esse. A scuola eravamo collocate più o meno sullo stesso gradino della scala sociale, quello delle paria piccolo-borghesi, e forse per questo la sua famiglia mi accolse ignara nel suo seno. Ci vedevamo da lei, nella sua cameretta in legno naturale che faceva pensare a uno chalet di Pragelato. E lì, distesa sul lettino di abete, con la gonna rialzata sopra il materasso ergonomico, sotto gli occhi da pervertito di un Pinocchio appollaiato tra i libri illustrati di Beatrix Potter, Veronica si sottoponeva alle mie amorevoli cure. In preparazione della mia futura carriera di chirurga, io le facevo dei trapianti. Dolorosissimi. Veronica si contorceva compiacente sotto le mie mani, gemeva, rantolava mentre le estraevo il fegato (una presina di velluto color melanzana), glielo sventolavo davanti agli occhi e le dicevo: Cara signora, vede che avevo ragione? Il suo vecchio fegato fa veramente schifo, era ora di sostituirlo, mi creda! Faccia prefto, dottore, la prego! implorava lei, nuda dalla cintola in giù. 12 13 Dovrò farle un po’ male, dicevo io acchiappando svelta una manciata di pastelli “Paint and Wash” e applicandomi a tracciarle impressionanti cicatrici sulla pancia. E immancabilmente scendevo giù, in quel punto un po’ rigonfio, dove la carne si ripiega su se stessa e si apre, come la morbida crosta di un soufflé che rivela al suo interno una materia semicruda, plasmabile e calda. Retrospettivamente, credo che Veronica traesse più profitto di me da questo mio apprendistato chirurgico. Almeno a giudicare dai suoi sospiri appagati mentre facevo scorrere avanti e indietro il pastello sul suo soufflé. Poi il pastello si affacciava cauto nel punto dove il dentro e il fuori confinano, e swish!, si gettava nel cedevole abisso. Il mio modello per compiere questa operazione era naturalmente Elisabetta: sua era la mano precisa e professionale che immergeva il coltello nel soufflé dentro il forno rovente e lo ritirava fuori pulito, appena velato di un gentile umidore. È cotto! devo aver strillato un paio di volte, ma Veronica non mi sentiva neppure, era troppo concentrata nell’essere solo una femmina passiva. Continua, mi diceva. Non fmettere. Eh no, signora, dicevo io severamente recuperando il mio ruolo di luminare del bisturi. Abbiamo già trapiantato fegato, reni, milza e animelle, per oggi basta, l’infermiera deve andare a casa subito in permesso di allattamento! Era una questione di potere, naturalmente. Le invidiavo il suo lasciarsi andare, la sua ingorda passività mi appariva allettante e allo stesso tempo temibile, volevo recuperare il controllo della situazione e punirla. Inarticolatamente, sapevo di essere per lei soltanto il pastello che le procurava piacere, uno strumento masturbatorio (anche se questa parola non era ancora entrata nel mio lessico), un sostituto di quella mano che probabilmente non usava e non avrebbe mai usato, preferendo farsi oggetto sotto le mani, e i pastelli, altrui. Sapevo che quello che facevamo non era del tutto lecito – la zona mutande del nostro corpo era da sempre circondata da un alone di succulento mistero – ma non immaginavo il canaio che sarebbe successo quando ci scoprirono. O i colori non erano così lavabili come vantava la pubblicità, o Veronica quella sera trascurò le sue abluzioni, o io ci avevo dato dentro con più energia del solito, fatto sta che sua madre, misurandole il due pezzi da incitamento alla pedofilia che le aveva comprato per le vacanze a Diano Marina, si accorse che gli inguini im- plumi di sua figlia avevano un colore insolito. Pensò a dei lividi, pensò a un bruto, pensò a suo marito – era il bruto più a portata di mano – e, prima di rendersi conto che si trattava soltanto degli stessi pastelli con cui la sua rampolla si era impiastricciata la faccia a carnevale, era già in deliquio. Veronica confessò prontamente che il bruto ero io. Mia era stata l’idea, io l’avevo traviata. Mancò poco che dicesse che l’avevo costretta con la forza, puntandole alla tempia la mia Colt .45 di plastica. Sua madre telefonò a Elisabetta. Nel frattempo si era calmata e appariva aperta, ragionevole e moderna. In fondo erano gli anni Ottanta, mica c’era da farla tanto lunga se due bambine facevano un po’ di sesso consenziente usando i loro giocattoli preferiti. Ma lei, per quanto moderna e aperta, disse che non era igienico. Come! tentai di protestare io, i pastelli li lavavo sempre con la saliva, prima. Elisabetta mi zittì minacciando una sventola. Però non me la diede, perché si sarebbe sentita al telefono. Potevano venirle delle malattie, gemette dall’altra parte del filo la madre di Veronica. Potevo rovinare sua figlia per sempre, esalò. Era una di quelle donne la cui voce conosce una sola modulazione, quella del lamento. Donne per cui verbi come affermare, asserire, dichiarare, sostenere, perorare, e perfino il semplice dire, sono sprecati. Queste donne non parlano, emettono un perenne piagnisteo, come vecchie gatte artritiche e bisbetiche. La vita gli deve qualcosa, il mondo è in debito con loro, sono vittime e dunque hanno il diritto di rovinare l’esistenza agli altri il più possibile. Insomma era quel tipo di donna che mi fa considerare con simpatia il vecchio de Sade. Come avrei potuto rovinare Veronica per sempre? Immaginai la mia amichetta alla decrepita età di vent’anni, infelice e segnata a dito perché tutti sapevano (ma come?) che sotto le mutande il suo soufflé era giallo e viola e blu. O sua madre intendeva dire che si sarebbe presa il vizio e non avrebbe più potuto fare a meno di me e dei miei pastelli? La madre di Veronica espresse la gemebonda opinione che forse dovevo farmi vedere da uno psicologo, e si spinse fino a fornire, non richiesta, nome e indirizzo di un valido professionista raccomandatole da sua cognata. E la miseria lo psicologo! disse Elisabetta. Sono cose da bambini, non facciamone una montagna! 14 15 Che palle! Questa è logorroica e anche bacata, disse poi sbattendo giù il telefono così forte da far tremare il vaso di Murano sul tavolino. E partì verso la cucina. Dopo tre passi si voltò, tornò indietro e mi mollò la sventola che stava lì pronta per me da un quarto d’ora. Cosa ti viene in mente! Cosa ti frulla nel cervellino! Cosa ci trovi in quella gattamorta! disse pulendosi le mani nel grembiule, come se io, o la sberla, gliele avessimo sporcate. Più tardi, in cucina, la guardai scaraventare nel pentolone di alluminio una tonnellata di lumache vive. Andarono giù con un rumore di cocci, un rumore delicato e stridente come tazze di porcellana gettate dal balcone una fatidica sera di Capodanno. Una rimase indietro, aggrappata con i suoi fluidi viscosi alla bacinella, ed Elisabetta la spazzò dentro con un colpo secco, woosh!, della mano disadorna e impietosa da cuoca. Non è vero che le lumache muoiono in silenzio. Urlano, prima di morire nell’acqua bollente. Stridono arrampicandosi sulle pareti di alluminio, poi ricadono giù sotto il mulinare del cucchiaio di legno. Non credeteci quando vi dicono che la cucina è un luogo miracoloso, meraviglioso, poetico. È una camera degli orrori, un mattatoio. La cucina del mostro di Milwaukee, quello che metteva i pezzi dei suoi amanti occasionali in frigo, non è più sanguinolenta di una qualunque incensurata cucina borghese, specialmente quella di un ristorante. Soprattutto un ristorante tipico piemontese, un posto per cannibali, con tutti quei bolliti, le interiora, e la perversione polimorfa per le lumache e le rane: un luogo che somiglia alla stanza segreta di Barbablù con i suoi cadaveri in conserva. Dopo che ebbe spacciato le lumache, Elisabetta si voltò, si asciugò la fronte sudata e spacciò me. La prossima volta, mi disse, non fidarti. Ti credi furba, tu, ma sei una stupidina. Non c’è da fidarsi delle donne, non lo sapevi ancora? Nel frattempo in sala avevo fatto conoscenza con un’altra Veronica, una trans. Veronica due era uno schianto: alta, bionda, con il collo taurino ed enormi occhi verdi sopra zigomi aggressivi e sporgenti come ossa pelviche. Tutto in lei sprizzava fuori dal contenitore: i bicipiti, le tette, la voce, tanto che ci si poteva chiedere chi gliel’avesse fatto fare di infilarsi in quel tubino nero, il sudario della femminilità occidentale. Ma forse era proprio questo l’effet- to che voleva ottenere: il troppo. Era un cono gelato maxi, un materasso a quattro piazze, era una donna king size. Agli uomini piaceva. E anche a me. L’hai visto quello? disse mio padre eccitato, con un ghigno lascivo che non riconoscevo. Datti una calmata, disse Elisabetta concentratissima nel deporre uno sbuffo di maionese sull’insalata russa. Vai al sedici che vogliono la carta dei vini, vai. Non capii subito che “quello” era Veronica. L’avevo adocchiata mentre vagolavo per la sala, annoiata – era una di quelle serate morte d’estate, quando Elisabetta sventagliandosi meditava trucemente sulle ragioni per cui non avevamo mai i soldi per mettere su il dehors. “Non fissare la gente” era una delle massime di Elisabetta, e io l’avevo assimilata insieme alla farina lattea e ai pizzicotti che mi dava quando c’erano troppi spettatori per tirarmi una sberla. Perciò per fissare Veronica mi misi in posizione defilata, dietro il banco del bar, da dove potevo adocchiarla nello specchio senza essere vista. Ero affascinata da quella megadonna, soprattutto perché cominciavo a pensare che sarei rimasta sempre piccola, come in effetti è successo. “Tu di grosso hai solo la parlantina” era la compassionevole epigrafe di Elisabetta. Guardavo nello specchio i suoi muscoli e intanto mi carezzavo le braccia e le gambe, mi tastavo concentrando la mia forza di volontà nei polpastrelli, neanche avessi potuto trasfondere in me le sue pienezze e sentire il miracolo del verbo farsi carne sotto le mie dita. Lei si accorse di me, sentì il mio sguardo puntato e si voltò a cercarmi con gli occhi. Ci guardammo un momento, poi mi fece cenno di avvicinarmi. Come ti chiami? mi chiese. Eva Kant, dissi con aria puerile (ero brava a fingermi un po’ ritardata, forse perché il confine tra genialità e ritardo è sottile, come ha sempre sostenuto Elisabetta). Avevo ritrovato da poco una scatola piena di vecchi numeri di Diabolik appartenuti a mio padre, e mi ero affrettata a leggerli tutti prima che Elisabetta facesse piazza pulita chiamando l’uomo della carta, probabilmente l’ultimo rimasto in città, con la sua Ape scalcagnata. Quelle labbra piene e scarlatte mi sorrisero, misteriose e invitanti e un po’ tremanti. Ero una bambina magra secca, in bermuda a fiori e canotta blu stinta, due enormi lenti da miope sul naso, codini 16 17 sventolanti e la Colt .45 di plastica che penzolava dal cinturone appoggiato sui fianchi inesistenti. Sotto il suo sguardo seducente provai il primo turbamento della mia vita. Le facevo tenerezza, le piacevano i bambini, cercava simpatia là dove poteva trovarla? O forse aveva solo quel sorriso a disposizione? Non lo so, ma so che mi invaghii di lei all’istante. Sulla testa aveva un’impalcatura così complessa e ingegnosa che al confronto la cupola del Guarini in Duomo era un gioco da ragazzi. Le sue palpebre erano iridescenti, come se una grossa, sensuale lumaca vi fosse appena strisciata sopra. Vuoi un Diabolik? le chiesi. Ero riuscita a salvare di nascosto due o tre albi, e d’impulso gliene offrii uno come pegno d’amore. Li tenevo in fondo allo scatolone dei giocattoli vecchi, in magazzino. Non accettò, ma si commosse. La rividi più volte, quell’estate, in compagnia di uomini diversi. Mio padre la seguiva con sguardi appiccicosi, ma Elisabetta le dava un buon tavolo e non faceva commenti. Io le gironzolavo attorno finché, verso la fine del pasto, lei non mi invitava a sedermi e parlavamo di me o di quando lei era piccola, e l’uomo di turno sorrideva con distacco e a volte con un certo fastidio. Prima di andarsene lei mi avvolgeva in un abbraccio profumato. Senza sapere come, mi era chiaro che veniva per me. Una sera – l’ultima – venne con un tipo né alto né basso (e quindi molto più basso di lei) con la faccia gonfia e irta di spuntoni di barba, vestito di nero e con una voce lenta e costruita, una di quelle voci che parlano da una stanza buia e fumosa in cui la mente sta rintanata a elaborare visioni perverse del mondo. Mentre sedevo al loro tavolo adocchiando il dessert lasciato a metà dal nerovestito (panna cotta con salsa al cioccolato fatta da Elisabetta, un’esperienza sensoriale estrema che mia madre riteneva inadatta alla mia età), Veronica andò in bagno. La guardai procedere sull’ampio pavimento a scacchi bianchi e neri, inclinandosi leggermente prima su un fianco e poi sull’altro, mentre i polpacci guizzavano a ogni passo nelle calze a rete, che minacciavano di spaccarsi come melagrane mature e spillare sul pavimento i rossi chicchi dei muscoli. Veronica è bellissima, dissi rapita al mio commensale. Ti piace? disse lui. Era la prima volta che mi rivolgeva la parola e gli fui grata che mi parlasse come a un’adulta. Vorresti essere come lei da grande? No, dissi senza bisogno di pensarci su. Voglio sposarla. Ma davvero, disse lui con aria grave e ponderosa. Questa da te proprio non me l’aspettavo. Ma forse i tuoi genitori avrebbero qualcosa da ridire. Mio padre, gli sussurrai in tono confidenziale, dice che Veronica è un maschio. Ma non è vero, si vede che è una donna. L’uomo in nero mi guardò. I suoi bulbosi occhi azzurri, trincerati dietro le lenti come i miei, si fecero largo tra il fumo della sigaretta e mi squadrarono come due periscopi nemici su un mare piatto. Lo era, disse poi la voce lenta e costruita, ma adesso non lo è più. Ora è una donna come te. Anzi, è più donna di quanto tu non sarai mai, probabilmente. E come ha fatto? chiesi interessata, dimenticandomi della panna cotta. Ma quanto sei curiosa, disse lui. Ci pensò sopra e poi, quando non mi aspettavo più una risposta, Con un’operazione chirurgica, disse. Avrei dovuto saperlo! pensai trionfante. Era ovvio. Tu l’hai vista? chiesi impaziente di dettagli. No, disse lui pensoso. Io non c’ero. Era sola. Questa assenza, e la solitudine di Veronica nel momento cruciale, sembrarono suscitare in lui una certa malinconia, e non aggiunse altro. Spense il mozzicone e ingollò la panna cotta residua in un solo boccone. Allora, disse Veronica quando fu tornata, non ti ho ancora chiesto come ti chiami stasera. Sì, me l’hai già chiesto, mi chiamo Nemo, dissi io tastando il libro di Verne che tenevo infilato nella cintura di plastica bianca con la fibbia dorata sul vestitino di cotone. E tu, come ti chiamavi quando eri un uomo? chiesi. Lei trasalì, poi cominciarono a tremarle il mento e tutta la faccia, e la voce che di solito era ricca e densa come crema-gianduia diventò cigolante e tagliente come un apriscatole arrugginito. Chi te l’ha detto? Chi ti ha detto una cosa del genere? chiese. Non fare così, disse il tipo prendendola per un braccio. Gliel’ho detto io, dietro sua richiesta. Gesummaria! disse Veronica con un rapido segno della croce. A una bambina l’hai detto! Sei un pervertito, un finocchione sei! È perfettamente in grado di capirlo, disse lui guardandosi attorno imbarazzato, ma dal tono non mi parve così sicuro. Poi chiese il conto e la portò via in fretta prima che potessi chiederle cos’era un finocchione. 18 19 Veronica due dopo quella volta non tornò più a mangiare da noi e io ci rimasi male e capii che avevo commesso un errore fatale, ma non sapevo quale. Cos’è un finocchione? chiesi a Cecca, e lei disse Non ripetere mai più quella parola. Perché? Perché no. Piantala di fare la signorina Perché. Cecca era la mia adoratrice nonché guardia del corpo ufficiale per la maggior parte dei pomeriggi e fin dai miei primi mesi. Era un’operaia in pensione che viveva in due stanze al pianterreno, nel basso caseggiato in fondo al cortile. Era una donna magra con il naso lungo e la dentiera che quando la toglieva la metteva dentro un bicchiere, e quando c’era gente la teneva in bocca e faceva di continuo un movimento ruminante con la mandibola per rimetterla a posto perché quella era insubordinata e se ne andava per conto suo. Stavo molto a casa sua, e spesso ce ne andavamo anche in giro per la città mano nella mano. Almeno finché lei ce l’ha fatta. Cecca fumava come una ciminiera e aveva imparato a fare tutto fumando, lavare i piatti, mangiare, pregare, perfino dormire. Passava delle ore a parlarmi ruminando e sbuffando fumo. Tua mamma quando ti ha messa al mondo ha fatto l’uovo fuori dal cavagno, mi diceva Cecca. Cosa vuol dire? Vuol dire qualcosa di speciale. Speciale come te. Che al mondo non ce n’è un’altra. Ma fuori dal cavagno l’uovo non ha paura? E se qualcuno lo schiaccia? Tranquilla, ci penso io a covarti. Fidati di Cecca. Le storie che mi raccontava erano appassionanti come solo le storie macabre possono essere. Suo padre e i suoi zii erano morti nel fango delle trincee nella guerra del ’15-18, il più giovane dei suoi fratelli era stato partigiano nella seconda, e i tedeschi gli avevano prima dato fuoco e poi l’avevano fucilato; una sorella emorragica si era accasciata in un lago di sangue in fabbrica; un nipote incosciente si era schiantato sotto un tunnel ed era ridotto una larva umana. Lei aveva “fatto uno sbaglio” a vent’anni, in seguito al quale non poteva più avere bambini, perciò perché sposarsi? Il matrimonio è un cattivo affare per la donna, diceva, se finisce lo scopo dei figli tanto vale farne a meno. Sospetto che fosse stata gaudente, ai suoi bei dì; adesso era ridotta male, con le dita uncinate dall’artrite, il mal di schiena e la bronchite cronica. Aveva avuto tante amiche, i nomi si confondevano, ma ormai erano quasi tutte morte; con le amiche andavano a ballare, in gita, a giocare al casinò. Quelle che erano ancora in vita la deludevano amaramente; sono ridotte delle ciospe, diceva, delle vecchie carampane rimbambite; nessuna che venga a trovarmi, e quando vengono parlano solo di malattie. Lei preferiva me. Le piaceva pettinarmi, toccare i miei capelli, prendermi in braccio. Poi si scocciava perché non stavo mai ferma, e mi diceva Va’, va’, che mi pesi. Non mi resta nessuno, piagnucolava nei giorni neri, quando i dolori la rodevano, sono qui sola come un cane. Meno male che almeno ci siete voi, diceva indicando me e il suo altare. In camera da letto Cecca aveva un altarino con una statuetta in plastica della Madonna di Lourdes che conteneva l’acqua miracolosa, un’immaginetta di Gesù Bambino tutto inamidato e vestito d’oro, una foto di Padre Pio, fiori freschi quando ne aveva, altrimenti finti, varie altre fotografie (tra cui una mia a Carnevale, in costume di Carmilla la vampira con i dentoni e il mantello nero), il libretto della pensione, biglietti del tram usati, scontrini della farmacia e altre cose che, per il solo fatto di essere lì, mi apparivano investite di significati misteriosi. Prima che mi mandassero alla Sinite Parvulos, la mia educazione religiosa era delegata esclusivamente a Cecca, e forse questo spiega perché sono venuta su con idee poco ortodosse. Ma chi è Dio tra questi? ricordo di averle chiesto più di una volta. Dio è l’essere supremo, diceva lei per tutta risposta. E poi: Zitta, non nominare il Suo nome invano. Secondo me non lo sapeva. Fino a sei anni, rimasi col dubbio: Dio era la donna col mantello azzurro, il bambino coperto d’oro o il vecchio frate con la barba? O io vestita da vampira? O il libretto della pensione? O tutte queste cose assieme? Poi suor Beata Concezione mi rivelò l’esistenza di personaggi dalle incredibili potenzialità narrative come Gesù Bambino, la Ma- 20 21 donna, il buon San Giuseppe, la Maddalena pentita e tanti altri. Capii senza difficoltà Maria e suo figlio, non mi stupii affatto del ruolo del tutto secondario del falegname Giuseppe, mi appassionai ai santi, soprattutto ai martiri, con tutti quei bei supplizi che piacevano tanto a Cecca, ma Dio con la sua barba bianca mi rimase estraneo, suscitando in me soprattutto diffidenza. Era poi sicuro che fosse stato lui a creare il mondo? O, com’ero ormai propensa a ritenere, il mondo era frutto della mia immaginazione? E allora il fatto che fosse recalcitrante ad adeguarsi ai miei desideri si spiegava con l’imperfezione di questa mia immaginazione, che però un giorno a furia di lavorarci sarebbe diventata potente e precisa e infallibile, e allora tutto sarebbe andato come decidevo io. Ma se proprio un Dio doveva esserci, al posto del vecchio col barbone ci avrei visto meglio la Madonna, quella che sale in cielo in gloria schiacciando il serpente con il piede, o Gesù con quei bei capelli biondi e gli occhi nocciola alla James Dean, o in mancanza almeno un bel marcantonio come l’Arcangelo Gabriele. Loro sì che avevano il physique du rôle. Un giorno sull’altarino di Cecca comparve un grosso foglio di plastica nero a macchie bianche, si ergeva lì contro il muro a fare da sfondo a quella miscellanea polverosa. Quel nuovo aspetto di Dio era inquietante e ancora più curioso. Cos’è? chiesi. Sono i miei polmoni, disse tossendo. I tuoi polmoni? I raggi, disse lei spazientita. E ricominciò a tossire. La tosse di Cecca era epica. Era un rumore primario, uno dei grandi, spaventosi suoni della natura. Era un abbaiare cavernoso, gorgogliante di catarro, un boato che le scuoteva le costole, un’eco che quando sembrava spenta esplodeva di nuovo come una carica di dinamite; e frammezzo a questi suoni lacerati di montagna che crolla, c’erano fischi, sibili, trilli di uccelli in gabbia, voci di sirene semisoffocate nella profondità delle sue viscere. A volte tossiva nel sonno, di pomeriggio quando bisognava fare il pisolino. Io ero piccola, mi stendevo accanto a lei sul letto, e mi risvegliava questo rumore terribile e maestoso. Mi chiedevo come facesse, così magra secca e trasparente, a produrre suoni di quella portata. Non dirglielo a tua madre, mi diceva ogni tanto accendendosi una sigaretta. Se ti chiede, dille che ne fumo una o due. Io non lo dicevo, ma Elisabetta me lo annusava nei capelli, nei vestiti. Poi Cecca un giorno sparì. Mi dissero che era andata da sua sorella in Veneto. Le scrissi un biglietto per Natale e una lunga lettera. Lei non mi rispose. Un giorno mi chiamò al telefono. Piangeva e non capii quasi niente di quello che diceva. Poi qualche settimana dopo mi dissero che era morta. Dopo la sua morte, ricevetti una cartolina con una veduta delle Dolomiti. In una grafia quasi indecifrabile, c’era scritto: UN AFFETTUOSO SALUTO AL MIO OVETTO, TUA CECCA. Pensai che mi avevano mentito. Non era morta, si era trasferita in montagna. Poi, siccome non ricompariva, pensai che era morta davvero, e mi aveva mandato una cartolina dal paradiso. Quel posto pieno di angeli vestiti di bianco in cui ero attesa con impazienza, a sentire lei, e invece Cecca adesso c’era andata da sola. Che traditrice. Mi mancava, Cecca. I miei pomeriggi erano vuoti. Dopo pranzo, quando mi assopivo sul sofà nella casa deserta, mi svegliava di soprassalto il silenzio che aveva preso il posto della sua tosse. Cantavo arie d’opera con voce il più possibile rugginosa e gracchiante. I miei pensarono che stavo diventando ancora più strana e mi iscrissero anche al doposcuola, sempre alla Sinite Parvulos, gettandomi nella disperazione. Quando venne la sorella di Cecca a sgombrare l’alloggio, mi fecero scegliere un ricordo, e io presi l’altare, tutto compreso. Sotto lo sguardo di riprovazione di Elisabetta, cacciai in una scatola di cartone la radiografia, la statuetta, le foto e il resto della paccottiglia. Misi tutto sotto il letto, dove rimase per mesi, finché un giorno Elisabetta non fece sparire quegli oggetti inutili che ormai non erano più Dio, ma solo un’assenza. 22 23 È stata Cecca a insegnarmi a leggere. Ho cominciato a compitare sul suo vecchio sillabario con le pagine ingiallite, con le figure ingenue di animali esotici, cioè ormai praticamente tutti a parte cani e gatti: A come Asino, C come Colibrì, R come Rospo. Ho proseguito sui libretti d’opera che lei tesaurizzava in un cassetto del comò. A volte la sera, a letto, quando parole e frasi si confondono e il libro mi cade di mano e non so più che anno è, rivedo il suo viso rugoso chino su me bambina, risento le sue dita che mi carezzano i capelli e la sua vociaccia roca che canta piano, solo per me: Nel frattempo avevo avuto un paio di avventurette con altre bambine, niente di importante, niente che toccasse davvero i miei sentimenti profondi, scossi dalla rottura con Veronica due e dal trasferimento di Cecca in montagna, o in paradiso. E poi rividi Veronica uno, a una festa di compleanno, e le proposi di riprendere la nostra attività chirurgica, ma stavolta con un valore aggiunto: le avrei cambiato sesso. Cosa mi spinse a farlo? Sapevo che sarebbe finita male. Sapevo che mi avrebbe tradita di nuovo. Non l’avevo ancora perdonata. Le stavo offrendo una possibilità di riscatto? Forse fu la depressione profonda in cui mi gettavano sempre le festicciole dei bambini a rendermi imprudente. Forse volli sfidare il destino. Forse fu il semplice richiamo del sesso. Ci appartammo in una camera, tanto le madri di sorveglianza non ci avrebbero mai cercate, anzi sarebbero state grate di averne due di meno a cui badare. Lei, che in un primo momento non sembrava restia a una ripresa delle nostre manipolazioni, con o senza i “Paint and Wash”, si tirò risolutamente indietro quando le spiegai che avrei fatto di lei un uomo. No, questo proprio no. Veronica, che si sarebbe fatta espiantare qualunque organo da me, e manipolare non da un solo bruto ma da un esercito di bruti, si rifiutò in modo categorico di essere qualcos’altro che femmina. Bastava l’idea a darle le convulsioni. Era sacrilega. Io voglio effere una donna e fpofarmi e avere dei bambini, disse lei. Il fatto che prendesse così sul serio la mia proposta mi lusingò marginalmente – non credevo che le avrei davvero cambiato sesso – ma la sua risposta mi lasciò a bocca aperta. Sapevo che le donne hanno la tendenza a sposarsi e fare figli, ma che lo facessero apposta, che pianificassero addirittura di farlo, mi coglieva di sorpresa. Mi era sempre sembrata una carriera di ripiego per individui poco dotati. Le donne in gamba non si sposavano, se potevano farne a meno. Per Elisabetta il matrimonio era stato una ridicola formalità a cui si era assoggettata per sfinimento, perché papà la assillava giorno e notte con la sua insistenza. Era chiaro che l’aveva fatto per cavalleria e generosità, perché le anime forti sentono il dovere di sobbarcarsi le più deboli e non abbandonarle al loro destino. Che palle! dissi. Non vorresti essere qualcos’altro? Un grande chirurgo, il capitano di una nave? Una balena bianca? Una vampira? Tu chi vorrefti effere? disse lei con un barlume di interesse. Ero incerta fra Carmilla ed Eva Kant. Mi piaceva molto, Eva Kant. Fredda, impassibile. Alta e bionda, con quegli zigomi mongoli. E perché non Diabolik? mi chiesi. Se ero lui, sarei stata altrettanto ganza, e in più avrei potuto baciare Eva Kant, il massimo. Fei anormale, mi disse Veronica. Hai delle brutte tendenfe. Dal suo modo compiaciuto di sputare fuori quelle parole era chiaro che stava rimasticando l’imbeccata materna. In famiglia dovevano aver parlato di me fino alla nausea. Ti cucineranno in tutte le salse, aveva detto Elisabetta. E lei di salse se ne intendeva. E tu sei una madametta culostretto, controbattei. Culoftretto? ripeté Veronica perplessa. Quella l’avevo sentita dire dai miei quando pensavano che non ascoltassi. Non sapevo cosa volesse dire esattamente, ma mi evocava la godibile immagine della mamma tipo della Sinite Parvulos in tailleur di Armani seduta sul water a denti serrati, sotto sforzo intensivo. È una brutta parola, disse lei, tra offesa e apprezzativa. 24 25 Parigi oh cara noi rivedremo… Di quell’amor ch’è palpito dell’universo intero croce e delizia delizia al cor… Oh che gelida manina se la lasci riscaldar… In fondo, nei profondi cunicoli, nella grotta risonante dentro di me, c’è una dea senza nome e Cecca è una delle sue incarnazioni. È la vecchia che amerò sempre, la pelle morbida e vizza, la voce roca, le mani spolpate con le nocche grosse. Ci sono delle vecchie meravigliose in giro. Facce rugose che mi feriscono con la loro bellezza. Sono capace di dirtene anche di peggio, dissi saltando giù dal letto su cui ero salita con le scarpe e tutto. Afpetta, disse. Dove vai? Venga qui, dottore, ordinò, tirandosi giù le mutande. Non vorrà mica andarfene ora che fono pronta per il trapianto. Risalii sul letto. Non c’erano pastelli in vista. Arraffai un oggetto di forma fallica sul comodino e glielo spinsi dentro. Era un’innocua boccettina di collirio, ma la spinsi con tale violenza che sparì all’interno di Veronica. La recuperai a fatica, sospettando che se fosse rimasta dentro avremmo avuto dei guai. Veronica si divertì moltissimo, ma a me l’arrabbiatura non era passata. Tornammo alla festa di compleanno, dove riuscii a dare un calcio alla festeggiata senza farmi scoprire, nella ressa generale. Le mamme erano k.o. in cucina, e mi parve che una stesse piangendo nella boccia di sangria analcolica. La sera, alle nove e quaranta, il telefono suonò mentre Elisabetta era nel bel mezzo di uno zabaione. Vai tu, io non posso, disse a mio padre. Lui ascoltò con aria sempre più compunta, ballando da un piede all’altro e toccandosi la barba. E datti una mossa che la gente aspetta, sibilò lei passandogli accanto con la salsiera. Lui riagganciò e mi guardò come se fossi un graffio sulla sua macchina nuova. Elisabetta intercettò la sua occhiata. Da quel momento la sera prese a scorrere lentissima. Le guance mi bruciavano già in via preventiva. Quando fummo soli, venni a sapere che la mamma di Veronica aveva rinvenuto il coperchio del collirio nelle verginali mutande della sua figliola, mentre costei faceva pipì. Inutile dire che Veronica aveva confessato le mie efferatezze senza farsi pregare. Ma allora sei proprio scema, disse Elisabetta. A cosa ti serve essere tanto intelligente, se sei così scema? Quella donna è morbosa, disse mio padre. Sempre lì a fare le ispezioni corporali a sua figlia, le verranno delle turbe. Un po’ di privacy, perdio! Taci Igino, disse Elisabetta, non è il momento. Non mi picchiò, cosa che mi preoccupò moltissimo. Il giorno dopo la suora mi guardò in modo strano. Mi interruppero mentre scrivevo il temino (“Una bella festa di compleanno”) e mi portarono in direzione. Quando entrai vidi che c’era già qualcuno lì dentro, oltre alla suora direttrice: una mamma in tailleur, non di Armani, con la borsetta sulle ginocchia e le spalle curve. Ci misi un momento a riconoscerla. Era Elisabetta. Sentii il cielo cadermi addosso. Per una scemenza del genere, disse Elisabetta con voce scossa. E comunque le bambine erano in due. Se adesso quella gattamorta dà tutta la colpa a Gioia, non vuol dire che… La nostra Gioia è una bambina un po’ difficile, mormorò la direttrice. Mi risulta che… Ma no che non è difficile, la interruppe Elisabetta, è sana come un pesce, è intelligente, dove la metto sta, non mi ha mai dato problemi. È un po’ testarda, questo sì. Se fa qualcosa che non va, lei le dia una bella sberla, e vedrà… Noi non picchiamo i bambini, signora Bosco. Non so se questa figliola ha avuto un’educazione religiosa, in casa sua, mi chiedo come cresce, che cosa vede intorno a sé. I primi valori morali sono quelli che si recepiscono in famiglia… Valori morali? Ma è una bambina, signora direttrice! Non ha mica rubato! Non l’ha mica violentata, quella gattamorta! Mi chiami sorella, la prego. La bambina va seguita. Noi pensiamo di inserire sua figlia in un’altra classe, più piccola, dove le insegnanti possono dedicarsi meglio… Una classe più piccola? Sì, una classe apposta per bambini che devono, diciamo, avere un’attenzione particolare, essere seguiti con più cura… La vuol mettere insieme ai deficienti? Signora, la prego, certi termini non si usano più, per fortuna. Noi le proponiamo semplicemente un cambiamento… Sì sì, disse Elisabetta alzandosi di scatto, sì ha ragione, qui ci vuole un cambiamento, e subito. Cambiamo scuola. Non si disturbi, la strada per uscire la so. E mi pilotò fuori con freddo furore. C’era un sole estivo e il riverbero sul piazzale mi abbagliava. Vacillai. Lei non mi sostenne. Non mi toccò. Sarai contenta, disse. Finalmente andrai alla statale, come hai sempre voluto. Tornammo a casa in tram e per tutto il percorso non mi parlò. 26 27 Per sette anni sublimai tutto. Sesso, amore, passione. Tutto. Alla scuola statale non trovai gente come me. Trovai gente di- versa da me in molte maniere, il che era già un bel sollievo. C’erano bambini violenti, maschi e femmine, bambini di famiglie disagiate, bambini portatori di handicap, sieropositivi, extracomunitari. E poi c’ero io. Mediamente passavo abbastanza inosservata. Anche perché non avevo amici. Il fanciullo Eros mi lasciava in pace, ma in realtà mi sorvegliava con un ghigno sardonico. Io lo tenevo a distanza e mi illudevo di essere diventata invulnerabile alle sue frecce. Che idiota. Mi sentivo molto furba e saccente. Al di sopra delle meschine faccende di cuore e di figa. Finché non incontrai la mia nemesi. Stef. Non è del tutto vero che avevo chiuso con il sesso e la passione. Avevo semplicemente optato per la privacy, seguendo i consigli di mio padre. Le mie fantasie erano prese dai libri, dai film e dai fumetti e rielaborate con cura meticolosa fino al più piccolo dettaglio. Erano sontuose, galattiche e spudoratamente kitsch. Guerre spaziali, astronavi, tribù visigote, samurai, mondi sommersi: non indietreggiavo davanti a niente. La mia eroe era di solito una guerriera solitaria e ascetica che, armata quasi unicamente della propria intelligenza sovrumana, ingaggiava una lotta senza quartiere contro i potentati mondiali. Va da sé che la vittoria, dopo inauditi spargimenti di sangue, comportava anche la resa amorosa dei vinti. Si gettavano ai suoi piedi, principi e principesse, la imploravano, si denudavano il petto offrendole la spada perché li trapassasse, preferendo di gran lunga la morte al suo rifiuto. Questa scena la facevo scorrere più e più volte, da diverse angolazioni: i vinti, clamorosamente belli e sempre almeno due, un uomo e una donna, sono in ginocchio davanti a lei/me, un po’ danneggiati dalla battaglia ma non troppo, forse un lento rivolo di sangue che scorre su una coscia muscolosa, o una cicatrice che sfregia una guancia altrimenti troppo liscia. Sono di una bellezza luminosa e offesa, una bellezza calpestata che lei, il mio glorioso alter ego, sta per calpestare ancora di più. Sono nelle mie mani: il principe dai lunghi capelli e dagli occhi chiari, delicato come una ragazza, e la principessa, una vichinga atletica dagli zigomi piatti e dalle braccia possenti. Sono miei. Posso fare di loro quello che voglio. 28 E lo faccio. Oh se lo faccio. Lo faccio sul tram, mentre viaggio avanti e indietro da scuola. Lo faccio mentre la prof spiega una materia che, nel mio snobistico concetto di cultura, ritengo del tutto secondaria. Lo faccio la sera tardi davanti alla tele quando resto sola a tu per tu con la notte, nella privacy più totale. Lo faccio davanti allo specchio, qualche volta, nei pomeriggi in cui la noia irradia attorno a me il suo calore torpido. Mi basta un panno, una sciarpa, una camicia a rovescio, ed eccomi trasformata in uno dei miei personaggi. Recito le mie battute a mezza voce, fisso il nemico, arretro, svengo, muoio e resuscito, stermino. Lo faccio sui miei quaderni – Ma quanti ne consumi? mi dice Elisabetta –, che si riempiono di segni e disegni criptati, parole in codice. Il piacere che ricavo dalle mie fantasie è mentale, e irrora il mio corpo come una linfa virtuale. Posso quasi vederlo scendere nelle mie vene, tra le fibre dei muscoli, illuminando dall’interno l’opacità della mia carne. Trascendo il sesso, ma a volte la bassa carnalità ha le sue esigenze e accontentarla non mi costa granché. Non metto molta fantasia nei dettagli tecnici della masturbazione, non mi tocco quasi mai: è la mente il motore di tutto, non dimentichiamolo. Mi basta cogliere l’attimo in cui i circuiti del corpo e quelli della mente si sintonizzano in un lampo di luce, stringere appena le gambe e voilà, il gioco è fatto. A quattordici anni, sono un mondo autoconcluso, autosufficiente. Non ho bisogno di nulla e di nessuno. La sola persona di cui riconosco l’esistenza al di fuori di me è Elisabetta. Quella del lunedì – giorno di chiusura del ristorante – era la sera in cui guardavamo insieme il film alla televisione, e il momento in cui lei mi trasmetteva la sua esegesi del mondo. Nel film c’era quasi sempre almeno una scena in cui: 1) la donna si stringeva frenetica all’uomo supplicandolo di non lasciarla; 2) la donna veniva picchiata dall’uomo, ma non lo lasciava perché lui aveva bisogno di lei; 3) la donna fuggiva urlando mentre l’uomo la inseguiva con un’accetta. Che palle! Mollagli un calcio, deficiente! Mandalo a stendere! Ma fatti furba! commentava Elisabetta. A volte il suo disgusto per la lagna femminile era così forte da farla passare all’avversario: Sbrigati 29 a farla fuori che ci ha stufato, consigliava al killer-stupratore-fidanzato violento, mordendo fieramente un cioccolatino di Peyrano. Ne avevamo sempre una scorta, era la tangente che esigeva da mio padre per le sue sortite, sempre più strenue per lui e il suo fegato, con quelli dell’Arcigola. Da giovane mio padre aveva bazzicato Lotta Comunista e la Quarta Internazionale, mosso dal nobile intento di riscattare il proletariato (in senso teorico, perché praticamente non sentì mai il bisogno di dare una mano al proletariato che aveva in casa, cioè sua madre e suo padre) e di costruirsi una personalità abbastanza interessante per rimorchiare le studentesse. Poi era passato al PCI, una scelta matura e sostenibile, compiuta appena in tempo prima che il PCI si biodegradasse nell’ambiente. Lì aveva conosciuto Elisabetta, che faceva la cuoca in un circolo operaio dalle parti del Lingotto, e dopo cinque o sei anni di tira e molla si erano sposati e avevano rilevato una trattoria (mi ha presa per stanchezza, si giustifica lei). In principio lui si vergognava di fare l’oste, ma poi entrò nella parte; delusi dalla politica, lui e una combriccola di amici si lanciarono sui valori che restavano: i fagioli in tofeja e il vero culatello di Parma, l’arneis del Roero e la bonarda dell’Oltrepò Pavese. Così, con le pance che diventavano sempre più imbottite di vero lardo di Colonnata, lui e un manipolo di audaci degustatori, solenni e alticci, sostituirono alla falce e martello il coltello e la forchetta e diedero vita all’unico vero movimento frizzante e attuale che la sinistra italiana abbia prodotto sullo scorcio di fine millennio: lo slow food. A te non ti manca mai la politica? chiedo a Elisabetta. Figurati, quello è un gioco per gli eterni bambini, li tiene occupati, così hanno la scusa per non lavorare, dice lei. L’unico che le manca, lo so perché ha una sua foto appesa in cucina, dove altri tengono il crocefisso o la Madonna di Lourdes o Ganesh (i nostri vicini dell’Indian Garden), è Berlinguer. Non Stalin, come sosteneva Cecca. Berlinguer se ne sta lassù vicino alla cappa di aspirazione dei fumi, con la sua faccia intensa, scavata e sofferente; lei ogni tanto gli pulisce le cacche di mosche sul vetro con un gesto energico e affettuoso, ma il suo culto finisce lì. Non è una sentimentale, Elisabetta. Quei lunedì, in pieno relax, impegnate solo a decidere se mangiare prima quello col ripieno di castagna (a forma di castagna) o quello più ambiguo a forma di chiocciola (cosa ci sarà dentro?), era- vamo sole; e durante la pubblicità mi arrischiavo a rivolgerle qualche domanda mirata. Ma secondo te le donne sono tutte così? Ma che ne so, bella razza le donne, brontolava lei, uffa qui c’è il pistacchio, non mi piace il pistacchio, lo vuoi tu? e mi porgeva un farcito da cui avrei potuto ricavare un calco delle sue arcate dentarie, peraltro assolutamente perfette. Elisabetta è passata immune attraverso il femminismo degli anni Settanta. A quell’epoca lei era impegnata a servire polenta e spezzatino e a scrollarsi di dosso mio padre. Però possiede un femminismo di marca personale, così radicale che è facile confonderlo con la misoginia. Le donne reali mediamente la disgustano, ma solo perché ha in mente uno standard femminile molto alto. D’altra parte chiunque avesse avuto per sorella zia Manu non poteva che diventare misogino. È quasi peggio di zia Manu eh, quella lì? dicevo masticando e accennando all’immancabile Donna Remissiva sullo schermo. Quella cretina, diceva pensosamente Elisabetta succhiando un cremino alla nocciola, un giorno o l’altro ci lascerà le penne. Manu era sua sorella; aveva dieci anni di meno e cromosomi completamente diversi. Da una vita stava con Michael, detto familiarmente “il tossico”, che la picchiava mediamente una volta al mese, e le aveva già fratturato un certo numero di ossa. Qualche volta compariva a casa nostra, e io ammiravo la sua bellezza bruna e misteriosa e deteriorata, ma i miei tentativi di attaccare discorso andavano quasi sempre frustrati. Zia Manu era persa in un suo universo, ora letargico ora vibrante e disperato, e ogni volta che lei ricompariva la ruga che Elisabetta aveva sulla fronte, tra le sopracciglia, si faceva più profonda. Tu non hai mai avuto un’amica? chiedevo a Elisabetta. Altroché. Sono io la mia migliore amica. Sul serio. Non ti piacerebbe? E quando ce l’avrei il tempo per l’amica, sentiamo, su, diceva lei sistemando meglio i piedi sulle mie cosce. Io restavo immobile senza protestare, a volte cercavo di respirare con la bocca perché i suoi piedi puzzavano dentro le calze di nylon e le caviglie mi incidevano delle tacche nella carne, ma resistevo e dopo un po’ non sentivo più niente, a parte il suo peso concreto e consolante sulle gambe. Perché ti sei sposata? 30 31 Te l’ho già detto, tuo padre mi ha rotto talmente l’anima. Ma non eri incinta (io ero nata due anni dopo il matrimonio, quindi ero ineccepibile). Che ti frega. Non sono fatti tuoi. Ma se tornassi indietro, ti sposeresti ancora? Sì, con Tom Cruise. E se fossi un uomo chi sposeresti? La figlia di Agnelli. Io comunque non mi sposo. Fai bene. E adesso sta’ zitta. E dopo un po’: Ma guarda questa! Sì, l’abbiamo capito che lo ami, dacci un taglio! Dov’è il telecomando? Vediamo se c’è un western, che ’sta roba mi fa venire il latte alle ginocchia. Dopo un po’ si stirava le gambe, le lasciava cadere pesantemente a terra e si alzava. Ora di andare a dormire, diceva. Subito, facevo io, un attimo solo. Vai a nanna, che domani sei in coma, mi arrivava la sua voce dal bagno. Poi i passi verso la camera da letto, il soffice plop plop delle piante dei piedi, perché Elisabetta cammina quasi sempre scalza in casa, anche d’inverno. Mio padre era via, approfittava della sera libera per andare a documentarsi sulle realtà enogastronomiche del territorio, vale a dire trincare e strafogarsi. Va bene, buonanotte, mugolavo io dalla poltrona, la mano stretta sul telecomando. Mettevo il volume al minimo e restavo lì. Per ore. A vedere di tutto, film, pubblicità, talk-show, spogliarelli, aste, documentari, cartoni animati, qualunque cosa, fino al momento in cui le immagini non avevano più alcun senso. Sentivo la notte avvilupparmi nel buio della casa, il rumore delle macchine si straniva, suoni astrali attorno alla nostra stazione orbitante, non più stridio di gomme e ronzio di motori lontani ma il rombo di astronavi aliene in transito. La mia poltrona, un asteroide nello spazio esterno. Il tessuto liso sui braccioli, odoroso dei nostri corpi. Facevo scorrere l’unghia tra le coste del velluto, sbattevo le palpebre sugli occhi arrossati. Ero sola nell’universo. Mi veniva una malinconia cosmica. Sentivo sotto di me il respiro esausto della Terra, il rantolo dei ghepardi colpiti dai cacciatori di frodo nel bush africano, lo scalpicciare stanco degli schiavi bambini che vanno al lavoro prima dell’alba, il fruscio brulicante dei topi nelle discariche che stanno invadendo il pianeta. Mi lasciavo cullare dal senso della fine imminente. Facevo parte di un mondo condannato, senza futuro, la pocalisse di Cecca mi faceva l’occhiolino. Vivevo su un pianetino di quarta categoria tra intelligenze inferiori che respiravano una vecchia broda tossica chiamata aria. A cosa mi serviva un titolo di studio, una professione? Chi me lo faceva fare, di diventare una rockstar, un premio Nobel per la biologia, una scrittrice di fama mondiale o di lanciarmi in un’altra carriera adeguata alle mie ambizioni? Tanto sarei morta giovane, forse inghiottita dalle fiamme di un incendio colossale, o divorata da un’orda di cannibali metropolitani. Infamia e gloria si mescolavano nel mio breve, pirotecnico futuro, illuminato da una luce lividamente erotica. E mi rituffavo nelle mie fantasie androgine e bisessuali. In questa fase sperimentale, il principe mi dava quasi altrettanta soddisfazione della principessa durante i preliminari. Mi piaceva torturarlo, asciugargli lacrime e sangue, spremergli sospiri di voluttuosa sofferenza. Ma quando i circuiti mentali si facevano incandescenti, era a lei, alla principessa, che mi rivolgevo. La tenevo in serbo per il momento culminante. Era lei che cercavo con gli occhi quando la luce stava per esplodere in un flash abbagliante. Era verso di lei che protendevo la mano avida. E quando finalmente la toccavo, partiva il flash. Mi scioglievo sulla vecchia poltrona di velluto, scossa da un brivido, davanti al televisore acceso. Due spettacoli solitari, paralleli, non comunicanti. Finché non arrivò Stef. 32 33 Comparve un giorno sulla porta della classe, poco prima di Natale, con l’aria di una Lady D braccata dai fotografi e una vecchia tracolla scalcagnata piena di libri. Mi si fermò il respiro. Boccheggiai e quasi subito mi venne il singhiozzo. Galliano Stefania, disse la prof d’italiano senza alzare gli occhi dal registro. Io invece non riuscivo a staccarli dalla nuova arrivata. Puoi sederti, vediamo dove, la prof sorvolò la classe con un’occhiata radar, lì nel terzo banco. Galliano Stefania era alta e bionda, aveva un corpo da atleta e occhi grigi marezzati di verde. I capelli corti color paglia erano scompigliati e una ciocca umida le stava appiccicata alla fronte. Indice Breve vita e improvvisa morte di Gioia 7 Debora, la ragazza-gluteo 56 Dalle ceneri di Gioia nasce Dolores 79 Debora va in città 99 La guerra di Dolores 117 Debora fa la crocerossina (ma non salva il mondo) 133 Dolores la bugiarda 143 Debora senza acca 150 Dolores e la nera signora 169 La tv cambia la vita di Debora 183 Dolores trova la strada di casa 196 Selavì 212 Chi bussa alla mia porta? 230 HEROES / / / / / / / / / / / Martita Fardin, valeANA Gisela Scerman, Vorrei che fosse notte AA.VV., Padre Simona Baldanzi, Bancone verde menta Angela Bubba, La Casa Sacha Naspini, I Cariolanti Sergio Nazzaro, Dubai Confidential Emiliano Gucci, L’umanità Ju Amoruso, Mi chiamo Scrivo Michele Cocchi, Tutto sarebbe tornato a posto Irene Chias, Sono ateo e ti amo RAGGI / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Daphne Rooke, Io e Mittee Francis Wyndham, L’altro giardino Samuel Fuller, Il Grande Uno Rosso (1a ristampa) Gerald Basil Edwards, Il libro di Ebenezer Le Page (1a ristampa) Dorothy West, Le nozze Francis Wyndham, Mrs Henderson e altre storie Evan Hunter, Il seme della violenza Mickey Spillane, Tre romanzi di Mike Hammer T.R. Pearson, Breve storia di una piccola città (2a ristampa) W.S. Burroughs, Strade morte Enrico Pea, Il Romanzo di Moscardino Peter Rushforth, Kindergarten Daphne Rooke, Germogli Norman Rush, Accoppiamenti Roberto Amato, Il disegnatore di alberi Henry H. Bashford, Augustus Carp T.R. Pearson, Verso il dolce domani R.T. Raichev, Alla ricerca di Sonya Dufrette (1a ristampa) Manlio Cancogni, La sorpresa András Nyerges, Non davanti ai bambini Tim Krabbé, Marte Jacobs Xu Xiaobin, Il Serpente Piumato W.S. Burroughs, Terre occidentali Juan Damonte, Ciao papà R.T. Raichev, La morte di Corinne William Humphrey, My Moby Dick Ioan Petru Culianu, Il rotolo diafano Raimond Gaita, Romulus, mio padre R.T. Raichev, Delitto a Ospreys Ulla Berkéwicz, Sopravvivenza Halide Edip Adıvar, La figlia di Istanbul Norman Rush, Bianchi SCATTI / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Francesca Lia Block, Angeli pericolosi Anna Stothard, Isabel Rebecca Godfrey, La gonna strappata Roman Dirge, Lenore. Piccole ossa (2a ristampa) Roman Dirge, Lenore. Piccole ossa crescono (2a ristampa) Christopher Moore, Un lavoro sporco Eileen Favorite, Il bosco delle storie perdute Katherine Dunn, Carnival Love Elizabeth Hand, Non credere ai tuoi occhi James Fogle, Drugstore Cowboy Christopher Barzak, La voce segreta dei corvi Francesca Lia Block, Echo Libba Bray, Una grande e terribile bellezza Robert Cormier, Scomparire Shelley Klein, Tra di noi Roman Dirge, Lenore. Ossa e frattaglie (1a ristampa) Karen Russell, Il collegio di Santa Lucia per giovinette allevate dai lupi Libba Bray, Angeli ribelli Lise Myhre, Nemi. Cuori borchiati Lise Myhre, Nemi. Amori metallici Christopher Moore, Il Vangelo secondo Biff Shaun Tan, L’approdo (3a ristampa) Donald Ray Pollock, Knockemstiff Inês Pedrosa, Senza di te Paul Torday, L’irresistibile eredità di Wilberforce Perihan Mağden, In fuga Rebecca Godfrey, La ragazza che doveva morire Sebastian Fitzek, Il Ladro di anime (3a ristampa) Christopher Moore, Suck! Libba Bray, La rivincita di Gemma Warren Ellis, Con tanta benzina in vena Sven Regener, I berlinesi ANTIDOTI / / / / / / / / / / / / / / / Christopher Moore, Fool Shaun Tan, Oggetti smarriti (1a ristampa) Roman Dirge, I mostri nel mio pancino Herman Brusselmans, Ex Drummer Sebastian Fitzek, Il bambino Mark Oliver Everett, Rock, amore, morte, follia Malinda Lo, Ash Paul Torday, La ragazza del ritratto Beate Teresa Hanika, Cappuccetto Rosso deve piangere Joshua Mohr, Tutto quello che amo in questa vita al contrario Francesca Lia Block, Pretty Dead Sebastian Fitzek, Schegge Roman Dirge, Lenore. Ossa e frattaglie a colori Christopher Moore, Sesso e lucertole a Melancholy Cove Erik Raschke, Il libro di Samuel / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Richard A. Posner, Il piccolo libro del plagio Robert I. Sutton, Il metodo antistronzi (8a ristampa) Robert Farris Thompson, Tango Michael Zielenziger, Non voglio più vivere alla luce del sole Beau Fraser, David Bernstein, Bill Schwab, A morte le Vacche Sacre Cali Ressler, Jody Thompson, Perché il lavoro fa schifo Robert I. Sutton, Idee strampalate che funzionano Charles R. Morris, Crack (nuova edizione aggiornata) Anna C. Salter, Predatori Rosalind Miles, Chi ha cucinato l’ultima cena? (2a ristampa) Emmanuel Hirsch, Imparare a morire Alex Kuczynski, La bella e la bestia Charles R. Morris, Idee per un’economia responsabile Gianpaolo Luzzi, Siamo tutti debitori Joshua Cooper Ramo, Il secolo imprevedibile Jeremy Salt, La disfatta del Medio Oriente David Jou, Riscrivere la Genesi Jeff Rubin, Che fine ha fatto il petrolio? A. Segre e G. Pavoncello (a cura di), Judenrampe (1a ristampa) AA.VV., Labirinto Iran Jean-François Gayraud, Divorati dalla mafia Robert I. Sutton e Jeffrey Pfeffer, Tra il dire e il fare Michael E. O’Hanlon e Hassina Sherjan, Afghanistan Nicola Antolini, Fuori dal cerchio READING THEATRE / / / / / / / Ray Bradbury, Fahrenheit 451 Eliam Kraiem, Sedici feriti Alan Rickman e Katharine Viner (a cura di), Mi chiamo Rachel Corrie Kristin Linklater, La voce naturale Mohamed Kacimi, Terra santa Brian Friel, Afterplay Ann-Marie MacDonald, Belle Moral FUORI COLLANA / / / / / / / Emily Dickinson, Herbarium (1a ristampa) Perri Knize, Piano solo K. Witherspoon e P. Meehan (a cura di), Come ho imparato a cucinare Stacey O’Brien, Wesley il gufo Catherine Guillebaud, L’ultima carezza (2a ristampa) Vito Bruno, L’amore alla fine dell’amore BikeSnobNYC, Bike Snob Finito di stampare presso Puntoweb – Via Variante di Cancelliera snc – Ariccia (RM) per conto di Elliot Edizioni s.r.l.
Scarica