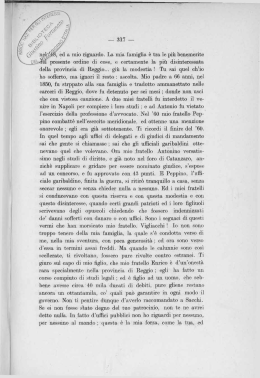PASSATO REMOTO Ho visto uno scadenzario e pensai alla mia vita. Anche la vita ha il suo gennaio, il suo maggio ed il suo dicembre; ha la sua primavera, il suo autunno ed il suo inverno, è appunto una successione di scadenze irrevocabili ed ineliminabili. E' inutile voler trattenere la giovinezza perché fatalmente deve trapassare. Non è difficile fare un bilancio della propria vita: basta segnare le scadenze di anno in anno, dopo aver ricavato dalla memoria quanto in essa rimane della fanciullezza. Una cosa sola non potrò appuntare. "Sono morto". Questa è la conclusione di ogni gioia ed ogni dolore. Dopo verranno le estreme scadenze quelle che mi spaventano maggiormente, mi spaventano assurdamente perché non riguardano la mia persona. Alludo alla perdita dello scadenzario, alla morte di tutti coloro che mi hanno conosciuto e serbano di me un ricordo, onde sarà come se mai fosse nato. Rimarrà forse più a lungo l'epitaffio sulla mia tomba. Rimarrà forse qualche ricordo delle mie ricerche, se hanno una qualche importanza, come è possibile. Ma prima o dopo svanirà tutto, con la scomparsa di ogni vivente sulla terra e della stessa terra in qualche catastrofe cosmica. Assurdamente ciò mi spaventa molto di più del pensiero della mia morte personale. Ma allo sconforto subentra l'euforia quando penso alla mia consapevolezza, al mio io, al quale nonostante tutto attribuisco la massima importanza. Io sono infatti il pensante, il veggente, il vivo. Gli altri sono semplicemente cose pensate, vedute, alle quali attribuisco di essere solo perché immagino che siano copie di me stesso, che ritrovo nella mia consapevolezza. Essi sono in me e di me non possono fare a meno per essere perché io sono lo strumento della loro genesi. Ed anche l'incommensurabile universo delle nebulose e degli atomi è tutto dentro di me; ha senso perché glielo dò, forma perché la vedo. Dunque devo ammettere che io sia una cosa notevole, anzi l'unica cosa notevole. Quasi non ci credo che un giorno potrò non esserci. Il mondo senza di me sparirebbe come le più fugace delle forme, che mostrano le nubi sotto la spinta del vento. Vivo e lascio brandelli alle mie spalle, pezzi del mio essere di un tempo, disperdo il mio io. Forse questo è il motivo per cui morirò, come muoiono tutti gli altri che raffiguro. Ma se andassi alla ricerca di questi pezzi perduti, se riuscissi a trovarli tutti e li racchiudessi in un involucro incorruttibile ? Dovrei prendere nota di ogni mio respiro, di ogni mio gesto, di ogni fantasia che mi viene in mente per godere dell'immortalità? Sarebbero i miei Campi Elisi, il mio Walalla, un fascicolo di fogli manoscritti? No, non voglio fare il mestiere dello spazzino, anche se dovessi raccogliere i detriti del mio stesso io. E' meglio trascinare una vita abietta e miserabile che lasciarsi cadere nel crogiolo del diario ponendo esso come scopo a fine della vita. Mai venderò un attimo della mia potenzialità di operare costruttivamente per curare la mummificazione di me stesso. Si disperda il diario intimo ed un fuoco crepitante distrugga tutto ciò che di me è passato, bruci il mio corpo morto e faccia presa anche sull'anima, se illusa dalla falena dell'immortalità, vorrà affacciarsi nell'inferno dell'al di là, ove è segnata la sua condanna per l'empietà in cui sono vissuto, negando i dogmi e rifuggendo dalla fede. Perché allora questo scadenzario? Non lo so con esattezza. Forse perché ogni tanto possa sfogliarlo in modo che l'anima sempre più inaridita dall'età, si inebri per qualche istante sentendo il profumo della giovinezza e sorrida di colui che allora sentiva armonie melodiose e pasceva gli occhi con colori splendenti. Il passato infatti commuove con dolcezza e con pudore. Potrò forse meccanizzare la nostalgia svelando quali sono i sentieri sui quali ci si muove con la mente per costituirla, ma ciò nonostante essa commuove ugualmente. E la commozione è stranamente gradevole. Sì, è un balocco questo scadenzario un trastullo! Mi illudo di prepararmi un'oasi dove possa appartarmi in solitudine, in cui riparare di quando in quando per sfuggire al faticoso errare nel deserto ed alle belve che lo infestano. Mi illudo che in essa potrò, sdraiato su morbidi cuscini, distillare il mio spirito in un alambicco d'oro; potrò lontano da tutti, passare da involuzione in involuzione e dall'alto di me stesso buttarmi nei miei stessi abissi, nuotare sotto il mio fluire in una sublime ebrezza. Potrò del mio vero io incontaminato, indifferente alle insidie, alle lusinghe, alle corruzioni, godere liberamente. Sì, quest'oasi che mi costruisco è il paradiso in cui trovo le Uri della giovinezza; è il grande specchio della mia anima la quale man mano che si sviluppa e degenera lascia in essa un residuo, una traccia, un'aspirazione di immortalità. Non mi salverà della morte, ma renderà anch'essa un'esperienza di vita. 1919-1924 Mio padre e mia madre si sono sposati ed io sono nato il 23 febbraio 1919. Così mi è stato detto. E' invero un gran mistero la nascita, ma di essa non è il caso di parlare in uno scadenzario. Infatti non è una scadenza, ma il capitale originario, che nel corso della vita consumerò con una serie di addebiti. Mi si dice che sono stato una sorta di animaletto che piangeva e rideva, che non aveva chiara nozione di alcunché e neanche di se stesso. Mi si dice che strillavo, battevo le piccole mani come muovendomi in sogno. Ma io a tutto questo non credo. Infatti so che nacqui solo quando pensai, quando fui il germe da cui provengo, con memoria, intelligenza, carattere, temperamento, animus ed anima. Si dice che in quest'età mitologica in cui non ero ancora me stesso abbia avuto una pericolosa polmonite. Nel salotto era esposta una foto sbiadita, che avrebbe rappresentato me all'età di un anno. Storie che si dicono! Nacqui a Giammoro, frazione di Pace del Mela, comune nella provincia di Messina. Ivi rimasi fino al 1924, cioè fino a quando compii sei anni e dovevo andare a scuola. Questo fu il gennaio della mia vita, un gennaio in cui sulla volta celeste splendeva il sole più stupendo, mai offuscato da nuvole. Tutto era ridente e giocondo, invaso da un prepotente bisogno di vivere. Ricordo la luce ed i colori di un mondo meraviglioso. Io ero piccolo e le piante della villa retrostante alla casa, mi superavano in altezza. La mia piccolezza mi permetteva però di osservare minute strutture che ora più non distinguo, meraviglie di arabeschi e di forme. I fiori erano stupendi e su di essi posavano le grandi farfalle multicolore, la "farfalle Cavaliere", come mia madre le chiamava, facili a prendersi. I neri calabroni ronzanti mi riempivano di terrore, volando da un fiore all'altro per succhiare. C'erano anche le vespe, nonché strani insetti verdi, bitorzoluti, animaletti striscianti e volanti di tutte le fogge. Talvolta prendevo le leggiadre cocciniglie, coperte da una epidermide alare rossa, con puntolini bianchi. Stavano a lungo quiete sul dorso della mano, ma poi finivano per andarsene volando. Un'aria magica avvolgeva quel paradiso, un'aria che recava il profumo delle glicine, carezzava il rosso dei garofani, il candore delle rose sotto i miei occhi entusiasti di bambino. Ma il gennaio durò poco! Forse un'arcana provvidenza aveva voluto farmi balenare un lembo del paradiso, affinché rimanesse nella mia fantasia come un miraggio non impossibile. Da molto tempo dubito dell'effettiva esistenza della luce nel mondo ove ora vivo. Tutte le volte che sono venuto fuori dai miei buchi ho visto l'inverno e la tenebre, ho visto la pioggia monotona e triste, le strade infangate, ombrelli aperti, persone avvilite od infuriate. Ma allora nel mese di gennaio splendevano il sole, la gioia, il rigoglio della primavera. Più tardi, desideroso di rivedere quel mondo meraviglioso tornai nella villa. Ma ero ormai andato troppo avanti con gli anni! Non potevo più scorgere il flusso di luce traboccante dalle corolle dei fiori come l'opulenza dalla cornucopia della dea, non più gli animaletti e le leggiadre farfalle, non più i fiori profumati. Tutto era scomparso da quella villa, devastata dagli anni tristi sopravvenuti. Le stesse piante erano rade e basse, le stradicciole invase dall'erba. Compresi che era inutile ogni ricerca perché la magia della luce e del colore si manifesta solo agli occhi dei bimbi. Mi sforzo di ricordare qualche evento clamoroso accaduto in quel gennaio. Intravedo mia madre che imbottisce con una fascia di seta, sulla quale erano disegnati uccelli del paradiso, un suo alto cofano in vimini pieno di tutto l'occorrente per cucire. Ricordo la prima volta che salii sull'automobile. Allora non c'erano i vetri ma i così detti "laterali", che si attaccavano e staccavano. Entrava un spiffero e mia madre era preoccupata che mio fratello ed io ci buscassimo un malanno. Ricordo mio fratello che indossava un cappotto rosso con bottoni dorati. Ricordo una grande figura di Fortunello, un famoso personaggio del Corriere dei Piccoli, che il giornale aveva mandato come regalo agli abbonati. Essa provocò un tremendo litigio tra me e mio fratello perché ambedue volevamo esserne gli unici proprietari. L'ebbe mio fratello ed io esplosi in un dirotto pianto tanto che nostro padre, per consolarmi, scarabocchiò qualcosa che avrebbe dovuto essere una copia, a suo dire identica all'originale. Ricordo assai vagamente qualche episodio della notevole vivacità e discoleria di mio fratello che costringeva i nostri genitori a prenderlo a sculacciate, ma egli si rotolava per terra e si agitava tanto da sfuggire al castigo. Era convinzione dei nostri genitori che, per non suscitare gelosie ed invidie tra noi due, dovessero trattarci assolutamente nello stesso modo. Io, di solito buono e tranquillo, dovevo perciò essere sculacciato come mio fratello. E poiché non mi agitavo e non mi difendevo finivo per essere castigato delle marachelle da me non commesse. Non serbavo rancore a nessuno, ma sentivo di essere vittima di un'ingiustizia. Ero anche molto pauroso e tacitamente convenivo con mia madre che avrei dovuto nascere donna. Mia madre soprintendeva che tutte le sere, andando a letto recitassimo le preghiere. 1925-1930 Nel febbraio della mia vita ci trasferimmo a Milazzo perché avevo raggiunto l'età di andare a scuola. Mio padre andava e veniva in automobile da Milazzo a Giammoro, ove era installata la sua fabbrica di sapone. Noi tornavamo a Giammoro nelle vacanze e facevamo i bagni sulla non lontana spiaggia, ove mio padre aveva fatto costruire in legno una grande baracca sopraelevata. A Milazzo abitammo nel villino Greco, caratterizzato da una torre. Io trovavo grande interesse nella stanza da pranzo sulle cui pareti, tra decorazioni floreali facevano spicco frasi sentenziose, che mi facevo spiegare da mia madre, come "le bon vin n'à pas besoin d'insegne", "laboravi fidenter", "audaces fortuna juvat" e altre che mi sfuggono. C'era lo scantinato, buio, pieno di ragnatele , rigurgitante di mobili ed oggetti vari, ivi depositati dai Greco, padroni della casa. Mi avventuravo in esso con curiosità, quasi come esploratore di un paese selvaggio, ma anche con un po' di paura. Oltre che nella villa intorno alla casa mio fratello ed io indugiavamo sul terrazzo e correre con i monopattini. Particolare fascino aveva però il farci scivolare seduti lungo il muretto in declivio che copriva la scala. Era un gioco pericoloso perché ci andavano di mezzo i calzoncini ed erano sculacciate. Ma su tutte le nostre attività ovviamente dominava la scuola. Mio padre non aveva voluto inviarci a quella pubblica cosicché veniva a casa nostra per darci lezioni una maestrina che valeva poco onde era nostra madre che doveva prendersi la briga di insegnarci come fare le aste e dopo l'alfabeto, i numeri e la famigerata tavola pitagorica. Mio fratello, bambino precocissimo, che già a due o tre anni recitava lunghe poesie a memoria, imparò a leggere e scrivere da solo, vedendo me. Così a cinque anni fece la prima elementare, quando io ne avevo sei. Dopo fummo insieme a scuola fino all'università ed egli era sempre più bravo di me, anzi era costantemente il primo della classe. Io ero troppo timido per competere con lui. Ricordo che agli esami per passare dalla prima alla seconda, che mio padre volle facessi per controllare la mia preparazione, ero così confuso che per un pelo non fui bocciato. Comunque dopo cambiammo maestra ed andammo dalla signora Grillo, la quale era molto brava e dava lezioni private anche ad altri bambini: Dino e Pitta (figli dell'avvocato Vece), Ciccio e Virginia. Mio fratello ed io eravamo i più bravi, ma senza esserne consapevoli o comunque senza inorgoglirci. Non c'era tra di noi alcuna emulazione. La maestra era molto buona con me, forse perché si rendeva conto della la mia timidezza. Ricordo che spesso mio fratello e Dino litigavano per farsi correggere il dettato per primi, mentre io me ne stavo in disparte. Allora la maestra prendeva il mio quaderno credo non tanto per punirli, quanto per farmi capire che ero meritevole di tanto onore. Mio fratello era bravissimo nel calcolo mentale mentre io eccellevo nella storia e nella geografia. Ricordo che nella quinta elementare conoscevo tutti gli arcipelaghi dell'Oceania. Con sommo stupore un giorno mi resi conto perfino la maestra non li sapeva. Mia madre faceva venire, mi pare da un editore di Brescia, dei libri per ragazzi. Da allora divenni un infaticabile lettore. Divoravo addirittura quelli di Gherardo Ugolini, che erano dei sunti dell'Iliade, dell'Odissea ed esposizioni della mitologia greca e della germanica. L'altro autore preferito era Carlo Dadone, che mi fece venire una vera e propria passione per l'astronomia. Non ero stato mai a scuole pubbliche ed andai all'esame di ammissione al ginnasio atterrito, convinto della mia nullità. Grande fu il mio stupore quando seppi di avere avuto la media di otto e di essere stato il primo. Da allora il demone dell'orgoglio si affacciò in me. Mio fratello non poté sostenere l'esame con me perché non aveva l'età. Lo fece però l'anno successivo a luglio ed ad ottobre quello del passaggio di prima in seconda cosicché fummo di nuovo insieme. Quella fu la grande età dei giochi in casa e nel giardino. Amavo le miti galline, sulle quali imperava Donna Grazia come su tutto ciò che riguardava la cucina e le faccende casalinghe. Mi ricordo vagamente, ma con nostalgia, di Buzzazza, povero pulcino dall'infanzia solitaria perché nato da un uovo covato dai colombi. Ti eri affezionata a me ed io a te. Forse quando sei morta non ti ho pianto. Ero ormai presuntuosamente grande e serio. Avevo dimenticato le mosche che acchiappavo con maestria per dartele da mangiare, avendo notato che ti piacevano. Avevo dimenticato che l'estate, quando ci recavamo a Giammoro per le vacanze te ne preparavo una certa quantità per rinvigorirti in attesa che anche tu arrivassi insieme con le altre galline chiusa nel gabbione trasportato dal lento carro tirato dai buoi. Ma il cortile non credette alla mia indifferenza ed anche le piccole cose sussurravano tra di esse dicendo che ero triste e montarono la leggenda che mi coprivo il viso per non fare vedere le lacrime. Ma hai avuto la tua bara, la tua onorata cassetta che ti distinse dal volgare coniglio, che fu sepolto nella semplice terra. Povero coniglio! La terra smossa lasciò per qualche anno il segno. Mio fratello proponeva spesso di scavare per vedere il tuo scheletro. Ma io riuscii sempre a dissuaderlo temendo l'orribile ghigno della morte. La bara di Buzzazza la fece Cernuto, che era il guardiano della sontuosa villa fatta costruire da mio padre, dopo essere stato sorvegliante degli operai che con i muratori procedettero alla sua costruzione. Cernuto era una persona notevole e di spiccata intelligenza, abilissimo in mille lavori manuali. Sebbene ignorante era uno straordinario narratore. La sera mi intrattenevo per ore a sentirgli raccontare, tra le tante cose, le vicende degli ubriachi e di altre persone caratteristiche di Pace del Mela. Spesso gli davo dei libri da leggere ed egli poi mi raccontava quanto aveva appreso, ovviamente trasfigurandolo con la sua fantasia e sistematicamente storpiando i nomi, come spesso fanno i siciliani. Ad esempio, lo interessò moltissimo la storia di Galilei, che per lui era Galileo Galilui. Quando completata la costruzione ci trasferimmo nella villa, Cernuto restò come guardiano. Tra le altre mansioni aveva quella di dare da mangiare alla ventina di gatti ivi allogati, che si affezionarono a lui al punto che quando usciva per strada lo seguivano come un codazzo tra la meraviglia delle persone ed il suo disappunto. A proposito delle villa è da ricordare che nel giardino aveva sede anche il fantasma dell'Anello Cuomo che, essendo stato decapitato in quel posto girava con la testa sotto il braccio. Molti di notte non osavano passare per la strada davanti, ma i miei ridevano di questa superstizione ed io non avevo paura, forse per questa ragione, forse perché ero ormai grandicello. Infatti da bambino mi spaventavano perfino gli aereoplani quando volavano, temendo che mi cadessero addosso. Talvolta a letto stentavo di addormentarmi per paura del buio. Spesso finivo per chiamare mia mamma chiedendole di portarmi un bicchiere d'acqua, avendo vergogna di confessarle il vero motivo. Il mistero, l'arcano, lo spettro, lo scheletro mi atterrivano. Contro le magiche potenze chiedevo l'aiuto del buon Dio e la protezione dell'angelo custode. Mia madre diceva che non mi abbandonava mai ed anche la notte si sdraiava accanto a me. Una sera, desideroso di farlo stare comodo, mi spostai tanto verso l'altro bordo del letto che caddi per terra. Quando abitavamo nel villino Greco avevo paura di passare in un corridoio che era separato da un buio stanzino retrostante con un tendaggio. Questo stanzino infatti me ne faceva venire in mente un altro, visto in un film (mi pare "Koenigsmark") in fondo al quale c'era un armadio con dentro uno scheletro. Ma quella fu anche la grande stagione dei giochi. Il gioco! Talvolta medito sulla tua sublime essenza e sulle radici che affondi nel seno della vita. Tutti giocano. Vedo i grandi che sperperano le migliori energie per collezionare svariati oggetti che li dilettano, tra i quali primeggia il denaro. Ritengo siano preferibili quelli dei fanciulli, che non sono materiati in calcoli economici. In essi una sottile finzione contraffà la realtà delle cose, le riconduce a fiabe, dà vita a ciò che non è, ma sarebbe bello se fosse. Quanto sono migliori i giochi dei fanciulli di quelli dei grandi! Mi sono abbandonato ad essi con tutta la mia inventiva. Quanti ne ho escogitati godendo momenti di entusiasmo e di passione ! Gli aereoplani di carta compendiano quattro saghe della mia vita. La più antica è quella degli aereoplani a lunga portata, per i quali era lecito usare qualsiasi ingrediente aggiuntivo come colla, pezzetti di ferro o di piombo, ecc. Erano ferree leggi, che io decretavo in sostanza solo per me stesso, dato che mio fratello aveva altri interessi come costruire congegni con il "meccano", giocattolo che invece non destava in me il minimo interesse. Lanciavo i miei aereoplani dalla torre del villino Greco verso il teatro Trifiletti sorvolando un lungo tratto che allora era un giardino, in cui come unica costruzione sorgeva il cosiddetto "casotto di Giovannino", ove dormiva un garzone al servizio della famiglia, casotto di fronte all'immondezzaio, paradiso delle galline quando erano lasciate in libertà, ma al quale noi non dovevamo avvicinarci. La mia ambizione era quella di farli giungere prima o dopo al muro di fondo. A superarlo non ci pensavo assolutamente considerando questa un'impresa superiore alle forze umane. A questo periodo fa capo la gara contro Carmelino Bartolone, cimento da lui proposto. Avrei dovuto temerlo perché egli, abitando nell'appartamento annesso al Teatro Trifiletti, conosceva perfettamente, i miei apparecchi, assistendo spesso ai loro lanci. Ma l'accettai con l'eroica noncuranza del pericolo tipica degli antichi cavalieri. Ignoravo le insidie e l'invidia, il mio animo era puro, il mio spirito agonistico immenso. Egli millantava che un suo aereo lanciato dal palchettone del teatro era giunto al palcoscenico, ma non gli credetti sapendo quanto con la fantasia andasse lontano. Ad esempio pretendeva di aver costruito delle scarpe con molle sotto la suola che permettevano di spostarsi a grande velocità con salti. La gara doveva svolgersi nel recinto antistante al teatro, cioè su un terreno pianeggiante non propizio ai miei apparecchi, adusi ad essere lanciati dall'alto della torre. Vi erano inoltre, spettatori imprevisti, alcuni parenti di Carmelino, tra cui un capitano di lungo corso, uomo di una certa cultura, che conoscevo perché gli facevo chiedere da Carmelino o suo fratello Pippo, spiegazioni su concetti scientifici che non mi erano chiari. Carmelino tirò il suo aereo che, svolazzando in modo ridicolo e forse facilitato dal vento, giunse tuttavia molto lontano. Con rammarico estremo mi resi subito conto che i miei migliori aerei, su quel terreno piano facevano cilecca. Anche l'asso degli assi, "Genova", città prediletta per qualche motivo inconscio, così come preferivo il colore giallo ed agli altri numeri l'otto, fallì ignominiosamente. Allora tentai l'estremo rimedio. Corsi a casa e presi il "museo", cioè una cassetta di legno, munita di lucchetto, fabbricatami da Cernuto, nella quale tenevo serbati tutti i grandi del passato che, nonostante le imprese gloriose, non potevano competere con i prodotti di una tecnica sempre più perfezionata. Trassi il primo che mi venne sottomano, un certo "Roma", fino ad allora da me non molto considerato, che invece con estrema facilità superò di un buon tratto il punto ove era giunto l'aereo di Carmelino. Il mio entusiasmo aveva avuto il giusto premio! Rimisi "Roma" nel museo, come il grande tra i grandi, che non doveva degradarsi più in disuguali cimenti. E lì rimase avvolto nel suo mito finché qualche barbaro distrusse la cassetta con il suo contenuto. Questa è la preistoria. Dopo venne la storia degli aereoplani della nuova progenie, cioè del tipo che chiamai "Alfa Romeo", nata in seguito alla mia invenzione di piegare il foglio di quaderno in un modo nuovo. Per non dilungarmi devo tacere su tante gloriose vicende e di spiegare il criterio con cui compilavo le classifiche, omologavo i records, ecc. Ora anche mio fratello mostrava di avere un qualche interesse per questi cimenti; ma incapace di costruire modelli in grado di cimentarsi con i miei assi, escogitò un inganno in combutta con Ciccio, l'autista. Contravvenendo sfacciatamente alla leggi da me decretate che quegli aerei dovevano essere fabbricati unicamente con un foglio di quaderno senza l'uso di colla e peggio ancora di altri ingredienti, fabbricò un prototipo che nella punta aveva un pezzo di piombo. La gara si svolse durante le vacanze a Giammoro sulla strada nazionale ove allora circolavano pochissime macchine. Lanciò l'aereo che giunse lontanissimo e fu subito raccolto e messo in tasca da Ciccio perché non potessi esaminarlo. I miei assi furono incapaci di contrastarlo. Inutilmente lo cercai in casa in tutti i posti possibili. Pensai allora che fosse nascosto nel garage. Perciò un giorno che Ciccio era uscito con l'automobile per portare da qualche parte mio padre ed aveva chiuso a chiave il garage, mi calai dall'alto muro retrostante l'atrio e senza fatica lo trovai sotto una delle automobili. Escogitai poi altre soluzioni, come quella degli aereoplani plananti che non dovevano essere lanciati; fissai nuovi criteri e vi furono nuovi teatri di lotta come il terrazzo della nostra casa di Messina ove ci eravamo trasferiti per frequentare il liceo. Il vincitore ero sempre io. Carmelo escogitava modelli sempre più perfezionati, sempre entro l'ambito delle leggi da me fissate, ma perdeva inesorabilmente. "Bologna", "Norimberga", "Pola", "Batavia", "Hemden" sono i nomi dei miei assi più prestigiosi, che dovrebbero meritatamente passare alla storia accanto ai precursori non plananti quali "San Marino", "Chicago", ecc. Altra mia grande passione, quando eravamo ancora a Milazzo, furono gli aquiloni, che mio fratello non volle mai costruire e disprezzava preferendo costruire portentose macchine con il suo meccano come un grande orologio a pendolo, che segnava effettivamente le ore. I miei aquiloni erano protagonisti di voli che a me sembravano stratosferici. Quando erano fermi nel cielo tagliavo il filo e prima di ricongiungere i pezzi infilavo un pezzetto di carta che spinto dal vento saliva fino a raggiungerli. Non era un'invenzione mia e Ciccio, che me la aveva insegnato, chiamava il giochetto "mandare un telegramma all'aquilone". L'impresa più memorabile fu quella di un aquilone che lanciato a Milazzo sorvolando il mare e spinto da un vento propizio giunse fino a Giammoro. Nessuno ci credette perché si trattava di molti chilometri. Ma posso assicurare, senza falsa modestia, che è la pura verità perché legato il filo mi feci condurre da Ciccio in automobile a Giammoro e lo vidi proprio in alto sulla casa di Don Peppino Speciale, davanti a quella in cui ero nato. Fui anche un maniaco della bicicletta e nelle strade mi piccavo di superare tutti gli altri ciclisti in cui mi imbattevo, consapevole del mio dovere al cimento, come l'antico cavaliere, che errava per i boschi ed i deserti in cerca di avventure. Mi piccavo di essere velocista, passista ed arrampicatore, cioè asso completo, come il prediletto Binda, per il quale parteggiavo contro il popolaresco Guerra. Questa passione e questa scelta mi erano state inculcate dall'autista Ciccio, con il quale mi appartavo a leggere la Gazzetta dello Sport. Su questo punto mi ero allontanato da Cernuto che era tifoso di Guerra. Quante altre cose vorrei ricordare prima di rivangare gli eventi accaduti dal 1931 in poi! Non posso tacere i molti giochi di guerra, in cui ero sempre il glorioso sconfitto perché la vittoria non poteva non essere di mio fratello. I miei soldatini di piombo, le mie flotte di carta facevano prodezze inaudite, ma la vittoria finiva per arridere sempre a lui. Questo era un tacito patto. Ma più che le vittorie guerresche erano importanti le "avventure" sulle quali fantasticavamo, essendo rimasti suggestionati da quelle del "tenente Russell", protagonista di un film visto al cinema Trifiletti. Certamente nessuno ne aveva avuto di più straordinarie di quello che chiamavo, per antonomasia, "il mio soldato", un cavalleggero che stava appiedato a gambe aperte perché si era rotto il suo cavallo. Basti dire che esplorando, legato ad un filo, l'interno del ciminiere della cucina, cadde dentro e fu trovato casualmente nella cenere dopo qualche settimana. Successivamente, lanciato con un paracadute dalla torre, cadde sull'incancellata. Passò nella strada una donna e strappò la carta portandola via con mia grande costernazione, essendo convinto che avesse voluto rapirmi l'eroe. Avvertii subito Donna Grazia del misfatto e lei rincorse la donna insolentendola. Costei le buttò in faccia la carta, ma ahimè il soldatino non era attaccato ad essa. Dopo qualche giorno mi accorsi che era rimasto impigliato nell'incancellata con i fili con cui era legato. Avventura inaudita! Eppure dovevo ammettere che la più gloriosa di tutte fosse quella di un soldatino di mio fratello, l'"Ammiraglio". Egli sosteneva che, caduto nel mare di Giammoro durante uno dei bagni estivi, fu ritrovato un anno dopo sulla spiaggia dentro una latta. Non pensavo neanche lontanamente di poter smentire questa fandonia! Quando abitavamo ancora nel villino Greco eravamo oltremodo interessati anche a cercare nel giardino le "pietre preziose". Io avevo un'imponente raccolta di smeraldi, zaffiri e brillanti, ma la più preziosa di tutte, di inestimabile valore, il "radium", la aveva solo mio fratello ed era assodato che non se ne potessero trovare altre. Queste pietre potevamo commerciale mediante carta moneta da noi stessa emessa. Ma io, anche perché non sapevo disegnare fregi adeguati, potevo fare solo dei "milioni". I "miliardi" erano monopolio di mio fratello. Per altro l'impagabile "radium" era fuori mercato. Devo sorvolare su tante altre vicende, anche su quelle del buon cane Febo, compagno dei nostri giochi, talvolta anche cattivi, che egli sopportava senza protestare. Quando ci trasferimmo a Messina rimase a Giammoro con mio padre, disprezzato da tutti coloro con cui aveva a che fare perché, pur essendo un cane da caccia, aveva tanta paura delle fucilate che scappava a casa per trovare rifugio sotto il letto della cameriera. Lo tormentava soprattutto Ciccino Ricciardi, che gli tirava i baffi (era uno spinone). Costui, come del resto quasi tutti i locali, era un arrabbiato cacciatore. Arrivava al punto di sparare alla cieca in alto la notte, quando sentiva il grido degli "aroi" (uccelli di passa). Ma egli era vittima soprattutto delle "caccarazze", un maligno uccello che si posava sistematicamente a circa cento metri distanza, cioè fuori tiro, ma tuttavia non tanto da fargli rinunciare a sparare. Tornando al povero Febo, quando nelle vacanze tornammo da Messina a Giammoro, lo trovammo così inebetito da neanche riconoscerci. Poco dopo morì. Devo aggiungere che in questo febbraio della mia vita, cioè prima di trasferirci a Messina, ci fu un evento che rivoluzionò la mia vita: il ginnasio. Mio padre volle fosse da noi fatto privatamente (non avendo fiducia nella scuola pubblica di Milazzo) ed ebbimo come insegnante di lettere il bravissimo Prof. Caliri, che mi rivelò il mondo della cultura classica, facendomi commuovere con i poeti ed esaltarmi con gli eroi. Una notevole influenza esercitò su di me la signorina Picholz, ebrea oriunda polacca, che veniva da Messina per darci lezioni di tedesco. Lei mi fece conoscere tra l'altro Zweig e Rilke, oltre ai grandi della letteratura tedesca. Mi faceva capire di essere convinta che le mie notevoli capacità intellettuali mi avrebbero portato lontano. Continuai a frequentarla nei primi anni che ci trasferimmo a Messina, ove insegnava in alcune scuole, finché fu trasferita a Salerno e non ebbi più sue notizie . Il piacere datomi da quella sia pur rudimentale cultura ed il travaglio della pubertà provocarono in me quel sovvertimento che sfociò nell'"io" quale oggi sono e che mi trascinerò per tutto il resto della mia vita. Mi prese la mania dei libri e la seduzione della scienza mi conquistò. L'astronomia mi affascinava. Tutte le sere contemplavo i mondi lontani e cercavo di collegare i puntini luminosi sulla volta del cielo nella figure delle costellazioni. I libri di Flammarion mi vennero tra le mani quasi per incanto, seguiti da quelli di Eddington e di Jeans. Flammarion descriveva con tali accenti lirici la costellazione di Orione (con le due stelle di prima grandezza Rigel e Betelgeuse), il grande cacciatore seguito dai due cani Sirio e Procione, che io anelavo ammirarlo. Ma non sorgeva ancora ad un orario possibile, cioè prima di andare a letto. Dovevano passare un paio d'ore. Perciò una notte non riuscendo a prendere sonno, mi alzai e spalancai la finestra. Stavo in estatica ammirazione quando sentii alle spalle la voce di mio padre, che avendo sentito del rumore si era alzato anche lui. Mi chiese cosa facevo ed ai balbettamenti, con cui abbozzavo una spiegazione, esclamò: "chistu pacciu è" (costui è pazzo). Fu anche in quel periodo che provai per la prima volta la passione dell'amore. Era una fanciulla di nome Anna, alla quale non osai mai avvicinarmi e rivolgerle la parola . 1931.1935 Profumi diversi hanno la fanciullezza e la giovinezza. Una è pervasa da un sottile aroma, l'altra di un forte olezzo. Avevo dodici anni quando feci gli esami di ammissione al liceo. Mi confusi in quelli di matematica e fui bocciato. Nelle altre materie ebbi otto o nove. Poi ad ottobre mi fu dato un sette nell'esame di riparazione. Restai umiliato; ma la colpa era non tanto mia quanto della professoressa che mi aveva impartito le lezioni private insieme con una miriade di ragazzi di diversa età, tutti insieme in uno stanzone. Però ciò nonostante mio fratello ebbe otto anche in matematica. Ci trasferimmo a Messina. Per la prima volta andammo ad una scuola pubblica e per la prima volta mi fu consentito di uscire solo per le strade. Ero perciò fortemente arretrato rispetto ai miei coetanei per esperienza di vita. Un po' per volta imparai a vincere le mie manifestazioni più patologiche di timidezza, come quella di arrossire chiedendo al barbiere di tagliarmi i capelli od al commesso di libreria domandando un libro. Eravamo stati troppo ben preparato dal Prof. Caliri per incontrare difficoltà nelle materie letterarie. Perciò, per così dire, vivemmo di rendita mentre i nostri compagni ci consideravano degli sgobboni. Senza fatica mio fratello era sempre il primo della classe ed io il secondo. Nelle materie letterarie però il più bravo ero io, il solo che prendesse otto nei temi di italiano. Non stimavo molto i miei professori, tranne quello di matematica. Cominciavo ad essere autodidatta, studiando poco i libri di testo e leggendo molto per mio conto. Presto feci la scoperta di Nietzsche e considerai il suo "Così parlò Zaratustra" una sorta di Bibbia. Avevo avuto sempre, un interesse estremo per la "verità" alla quale ora si associavo l'avversione alle superstizioni. Ma tremai la prima volta che mi sorse il dubbio se Cristo fosse effettivamente un Dio. Pregai il Padre, cioè la divinità conclamata ed onnipotente che mi dicesse chiaramente se il mio dubbio aveva o meno fondamento; ma la risposta non venne. Un po' per volta l'abbandono del cattolicesimo, auspice Nietzsche, divenne l'abbandono della religione. Consideravo quest'autore come il sommo ed ineguagliabile pensatore. Per il resto il mio interesse si rivolgeva anzitutto alla scienza. Passai dall'astronomia alla fisica. A quattordici anni conoscevo abbastanza le teorie sulla struttura degli atomi e mi azzardavo a scrivere saggi sulla teoria della relatività di Einstein. Ricordo che quando ero ancora al primo anno del Liceo Scientifico aspettavo con ansia il passaggio al secondo in cui si iniziava l'insegnamento della filosofia e della fisica, le mie massime aspirazioni. E quando venne il momento in cui una professoressa, suppongo culturalmente piuttosto modesta, cominciò ad impartire le lezioni di filosofia, ascoltavo con tale interesse e rispondevo alle interrogazioni con tanto acume, che lei prese l'abitudine di chiamarmi "il filosofo". Se mal non ricordo qualche volta mi fece addirittura tenere qualche lezione ai miei compagni. Per il resto la mia vita a Messina si svolgeva tranquillamente e piacevolmente. Non ebbi amici, ma solo qualche conoscente. Abitavamo in un appartamento adiacente a quello dell'Avv. D'Amico, mio zio per aver sposato una sorellastra di mio padre, entrambi ottime persone. Essi avevano due figlie di pochi anni più grandi di me e mio fratello: Lilia e Mariuccia. Con le cuginette trascorrevamo insieme parecchio tempo in vari giochi, come lunghi "campionati" con le carte. Fu in quel periodo che mi appassionai del gioco della "pulce" che, con la mia inventiva perfezionai al punto da renderlo un agone di ardimento, freddezza, saldezza di carattere. Costringevo mio fratello a cimentarsi con me ancora a Milano quando frequentavamo l'università. Apparentemente risibile, il gioco consisteva nel colpire un gettone sul bordo con un altro in modo da farlo saltare e possibilmente coprire un terzo, posto ad una certa distanza, che allora veniva eliminato. Ma se il colpo era mal dosato il gettone cadeva accanto all'avversario che poteva coprirlo con facilità. Perciò ogni colpo comportava un rischio. Le innovazioni da me imposte consistevano anzitutto nel dividere i gettoni in due squadre nemiche. La mia era quella dei bianchi e dei gialli. Quella di mio fratello dei neri e dei rossi. Ogni gettone aveva un nome di personaggio storico, leggendario od anche di vita quotidiana. In sua corrispondenza mio fratello, con la macchina pirografica di mamma, incideva un disegno. Quando il colpo aveva successo il gettone guadagnava un punto ed i punti si sommavano. Essi venivano segnati a matita sul retro del gettone. Il tutto avveniva su un tavolo e c'erano delle posizioni, chiamate dei "terzini" in cui il punteggio era doppio e ce n'era una per ogni squadra, chiamata della "porta", in cui era triplo. Per ogni gara si faceva una classifica, ma poi c'era una classifica generale in cui si sommavano i risultati parziali. Le lotte erano accanite ed i campioni per difendere o migliorare la loro posizione in classifica dovevano commisurare l'ardimento, sfociante in pericolosi tiri, con la prudenza od opportunismo, cercando di invogliare gli avversari a tirare su di loro per approfittare dei loro errori. Tra i miei brillavano per valore soprattutto lo Spazzino, Teseo ed il Gangster, tra quelli di mio fratello Bertoldo, il Negus ed il Duce. Ricordo vagamente la tenacia di Bertoldo a difendere il primato il classifica generale rintuzzando l'audacia del mio Spazzino ed il tempismo di Teseo. Andavamo spesso a trovare lo zio Antonio, fratello di mio padre, che viveva in albergo da scapolone qual era, nonostante le pessime condizioni di salute, tormentato com'era dall'uricemia, che l'aveva colpito anche agli occhi rendendolo quasi cieco. Aveva un difficile carattere e sistematicamente litigava con il personale dell'albergo del momento e perciò si trasferiva in un altro, per passare ad un altro ancora finché, esauriti tutti quelli della città, doveva ricominciare il ciclo. Egli aveva una fabbrichetta di sapone , ma dopo un certo tempo preferì chiuderla per vendere quello prodotto nel grande stabilimento di mio padre. Era dottore in chimica ed aveva un'ottima cultura. La sua amicizia la concedeva presso che unicamente a professori. Esternava un grande affetto per me e mio fratello, che si concretava soprattutto nel regalo di libri su libri. Quasi tutte le domeniche veniva per il pranzo a casa nostra ed allora sorgevano discussioni accanite di politica. Lo zio Antonio era un violento antifascista in quanto liberale d'antico stampo e prediceva un esito catastrofico per la guerra d'Etiopia allora in corso. Mio fratello lo secondava, mio padre faceva il neutrale, ma io ero per Mussolini. Convinto che in un mondo di imperialisti bisognava esserlo altrettanto per non lasciarsi sopraffare, approvavo quella guerra. Di riflesso cercavo di giustificare il regime fascista sotto tutti gli aspetti, intravvedendo in esso un modo di conciliare le lotte di classe ed un dinamismo idoneo a superare l'abulia e la debolezza della democrazia. Confesso che la vittoria di Mussolini fu anche la mia e che cominciai a cambiare opinione sul suo conto solo quando si intromise nella guerra di Spagna. I miei interessi spesso si rivolgevano a cose troppo grandi per me. Testardamente lessi buona parte del primo volume della "Critica della ragion pura" di Kant. Comprendevo poco, ma andavo avanti lo stesso. Ero convinto di avere notevoli doti intellettuali, ma non ben chiaro in quale settore dovessero estrinsecarsi: se nella letteratura, se nella filosofia, se in qualche scienza. Scrivevo aforismi in prosa ritmica e componimenti scientifico-filosofici volti a tentativi di realizzare una grande sintesi tra il mondo dei viventi e quello delle cose inerti cercando nessi logico-metafisici. Provavo un grande diletto a constatare che potevo porre una connessione tra le vedute di Eddington circa la "morte calda dell'universo" come conseguenza del secondo principio della termodinamica, il concetto nietzschiano del "divenire ciclico" ed il panteismo indiano. Ero stato suggestionato dall'indianesimo: fantasticavo su Buddha e coltivavo la speranza di potermi procurare prima o dopo un esemplare del "Mahabharata". Al terzo liceo avvenne un fatto nuovo. L'insegnante di matematica, Prof. Cassisi, che a suo tempo all'esame di ammissione mi aveva bocciato, ma ora mi considerava come uno dei suoi alunni più bravi, fu trasferito. Lo sostituì una brutta e saccente professoressa con la quale tutto cambiò. Non so perché, ma è certo che mentre ero stato bravissimo a risolvere i complessi problemi fondati sull'applicazione dell'algebra alla geometria e sulla discussione dei risultati, con la nuova professoressa non riuscii a portarne più uno a compimento, sempre perché nello svolgimento commettevo errori materiali. Mio fratello e gli altri compagni più bravi erano nella stessa condizione. Però mentre un po' per volta quasi tutti gli altri si rimisero sulla carreggiata mio fratello ed io restammo sempre disorientati. La situazione era per me intollerabile. Allora presi la decisione, e convinsi mio fratello ad imitarmi, di saltare la quarta classe e presentarci direttamente agli esami di maturità. Mio padre non era d'accordo e mi accusava di indulgere alle solite fantasticherie, di guardare le stelle anziché le cose del mondo, ma alla mia fermezza dovette cedere. Avrei voluto che ci ritirassimo dalla scuola per poterci preparare meglio, ma su questo punto egli fu irremovibile nell'opporsi. Aggiungo che alcuni nostri compagni avevano preso da tempo la decisione di saltare il quarto anno ed avevano cominciato a prepararsi fin dall'estate precedente, programmando tra l'altro di dare alcune materie agli esami di settembre. Nonostante che ci separassero solo tre mesi, la mia decisione fu radicale: dovevamo dare tutti gli esami a luglio. Consideravo questa una prova degna di me per la sua audacia. Costringevo mio fratello, sempre riluttante, ad alzarsi come me alle tre del mattino per studiare. La sera prendevamo lezioni di matematica da un bravo professore che in quel brevissimo lasso di tempo ci fece studiare tutto il programma del quarto anno. Per le altre materie non volemmo professori, che ci avrebbero fatto perdere inutilmente tempo. Del tutto impassibile agli ironici commenti della professoressa di matematica, misi tutta la mia anima nell'avventura. Mio fratello invece si comportava con la sua solita calma e non intendeva eccedere nello studio come io pretendevo facesse. Naturalmente la preparazione fu molto affrettata. Ricordo che non arrivammo in tempo a leggere alcuni classici sul traduttore neanche una volta, né a studiare adeguatamente il corso di geografia, programma di scienze del quarto anno. Invece eravamo ben preparati nella matematica. A metà anno la professoressa di storia e filosofia che aveva di me un'altissima opinione fu trasferita. La sostituì il Prof. Jezzone, molto bravo ma anche strano. Presso di lui non riuscii mai a mettere in mostra le mie virtù di "filosofo" perché non interrogò mai, né me né i miei compagni, asserendo che la filosofia era una materia troppo difficile per i giovani. Interrogava solo in storia e dava in filosofia voti corrispondenti, inferiori mi pare di un'unità. Devo però dire che le sue lezioni erano affascinanti. A corrente dell'impresa che mi accingevo a compiere, una volta che mi incontrò per strada mi fermò e con il suo bonario sorriso mi raccomandò di non studiare troppo perché non ne valeva assolutamente la pena. Annui, ma neanche da lui mi lasciai convincere. Venuta la fine dell'anno scolastico, fummo naturalmente ammessi al quarto anno, però con un "6" in matematica, molti "7" e pochissimi "8". Evidentemente la nostra avventura non era ben vista neanche dai nostri professori. Tra di me me la ebbi molto a male per la loro incomprensione. Finalmente ci furono gli esami: i babiloneschi esami di maturità. Il tema d'italiano toccava uno dei soliti argomenti patriottici, da svolgersi collegando l'Impero Romano con Mussolini. Non potevamo trovare difficoltà per i temi di latino, dato tutto quanto avevamo a suo tempo imparato dal Prof. Caliri. La traduzione d'inglese non era preoccupante. Venne la volta del famigerato scritto di matematica. Mio fratello ed io, che eravamo riusciti a prendere posto nello stesso banco, per così dire lo "assalimmo". Era facile ma, mistero dei misteri, quanto era avvenuto ultimamente tante volte, si ripeteva. I fogli si susseguivano ai fogli, ma l'equazione finale non saltava fuori! Dopo ore di inutili tentativi, stanchi e sfiduciati, consegnammo i molti fogli. La sera andammo mesti dal nostro professore. Gli dicemmo cosa avevamo fatto. Malvagità della sorte , ora all'equazione si arrivava immediatamente. La famigerata professoressa del liceo, venuta a conoscenza della nostra disavventura, una volta che ci incontrò ci trattò ironicamente. "Ci sono ancora gli orali! "Le rispose mio fratello. E finalmente vennero gli orali. Andai un po' male in inglese perché per il mio poco orecchio non ero forte nella pronuncia, ma mio fratello se la cavò bene. Per l'esame di scienza non mi feci un'idea esatta di come avevo risposto. Ero stato interrogato proprio in geografia, la materia che non avevamo avuto il tempo di studiare, ma mi ero difeso affidandomi un po' alla fantasia. All'atteso esame di matematica dissi come esordio al professore che per motivi inspiegabili avevo fatto male il problema, ma che perché sapevo di essere ben preparato, lo pregavo che mi facesse domande sufficientemente difficili per darmi l'opportunità di rifarmi. Egli mi accontentò e fu per me un vero successo. Mio fratello fece altrettanto bene. Gli esami delle materie letterarie furono lunghissimi. Noi due eravamo gli ultimi dell'elenco e non essendo stati esaminati il giorno prima, ci fu dedicata un'intera mattinata. In attesa di essere chiamati, sfogliando i testi mi cadde l'occhio su una novella di Boccaccio, in cui interveniva non ricordo quale personaggio della Divina Commedia. Pensando che potesse essere oggetto dell'interrogazione la lessi a dissi a mio fratello di fare altrettanto, ma egli menefreghista com'era, si rifiutò decisamente. Poco dopo, chiamato prima di me, gli fu chiesto proprio se aveva letto quella novella. Rispose di si con la sua solita faccia tosta. Quindi con un'abilità che suscitò il mio stupore, parlando a vanvera, riuscì a fare dire al professore l'essenziale della trama, sulla quale poi egli tornava ricamandovi sopra. Tirando le somme ero convinto che in qualche materia, saremmo stati rimandati ad ottobre, invece non solo fummo promossi, ma fummo i primi nonostante l'inevitabile "6" in matematica. Mio fratello ebbe al solito qualche voto più di me, ma solo nel disegno. Sui molti candidati, interni ed esterni, vi furono dieci promozioni, essendo stati tutti gli altri bocciati o rimandati ad ottobre. Questi esami di licenza liceale erano chiamati "di maturità", nel senso che, secondo lo spirito della riforma Gentile, dovevano dare un giudizio globale sulla preparazione dei candidati. Non c'era dubbio che noi due eravamo "maturi". 1936- 1941 L'esito degli esami fu anzitutto una mia vittoria contro mio padre che mi considerava come un fantasticatore privo del senso della realtà. Nessuno degli amici e conoscenti si aspettava quest'esito e per la verità anch'io restai un po' sorpreso. Come premio andammo, tutta la famiglia, per una diecina di giorni in Svizzera. Partimmo da Milano in automobile e girammo in lungo ed in largo. Mi fece soprattutto impressione l'ascesa alla Jungfraujoch con una ferrovia di montagna inerpicantesi in trafori nella roccia. Nel ghiacciaio, al di la del quale si ergeva la vetta vera e propria del monte, era scavata una casa sotterranea. Avrei voluto avventurarmi sul ghiaccio, ma le guide dissero che dovevamo spostarci legati con corde essendoci il pericolo di cadere nei crepacci. Forse era un trucco escogitato per interessare i clienti, ma mio padre vedendo dovunque crepacci ci impose di rientrare nell'albergo. Quindi esclamò a voce alta da buon italiano : "sono bei posti, ma non mi pare ora di andare via per mangiare un piatto di pasta". Da dietro una porta rispose una voce: "glielo farò mangiare io". Il cuoco dell'albergo era un napoletano. Sono le cose futili che restano in mente più facilmente di quelle importanti. Ricordo quanto ridemmo mia madre, io e mio fratello una sera che in ristorante, mi pare di Berna, eravamo tormentati dalle zanzare. Mio padre volendo protestare chiese a mia madre come si traduce la parola "zanzare" (in dialetto siciliano "zappagnuni"). Mia madre non si ricordava bene, le sembrava si chiamassero "papillon". Allora mio padre, con la sua improntitudine, chiamò il cameriere protestando per il fastidio che davano quei "zappiglioni". Per fare l'università, nonostante le titubanze di mio padre, per altro subito superate, fu deciso che dovessimo andare a Milano. Poiché si ritenne che eravamo troppo giovani per vivere da soli, fummo accompagnati dalla mamma. Affittammo un appartamento nella Città degli Studi e ci trasferimmo con la cameriera Donna Grazia. Per un siciliano Milano è un mondo nuovo: il clima freddo, umido, nebbioso ed il contatto con persone che spesso non nascondono una certa avversione per i meridionali furono delle novità alle quali però ci abituammo presto. Restammo a Milano cinque anni, a parte il periodo delle vacanze estive, tanto quanti ne occorrevano per la mia laurea in chimica industriale e per quella di mio fratello in ingegneria chimica. Al primo anno eravamo un centinaio, tra cui molte ragazze. Mi innamorai di una di esse, figlia per altro del professore di chimica generale ed inorganica, il cui corso frequentavamo, ma non le svelai mai i miei sentimenti vittima della solita timidezza. Ho saputo tempo fa per caso che questa ragazza si è sposata con uno dei compagni di scuola, mentre l'altra, oggetto del mio primo amore, è fidanzata. Dopo parecchi mesi divenni amico del compagno Bernard Zeltzer, rumeno ed ebreo, poi suo tramite con Helmut Simon, ebreo tedesco, ma in modo molto meno intimo. Zeltzer era figlio di ricchi industriali ed aveva vissuto a lungo in Francia. Era discretamente intelligente ed aveva il naso un po' ammaccato per aver praticato la boxe. I nostri rapporti furono improntati ad una sincera amicizia, da parte sua perché mi stimava molto, da parte mia forse per semplice istinto di socievolezza, dato che tra i compagni non avevo altri veri amici. Superato il biennio ci separammo. Io rimasi a Milano, egli si trasferì all'università di Pavia , facoltà di chimica pura, sia perché a Milano c'era un rigida selezione in quanto per gli studenti del terzo anno erano disponibili solo una ventina di posti, assegnati a coloro che avevano le medie migliori, sia perché si sarebbe laureato un anno prima, fatto per lui importante essendo attese le famigerate leggi per la protezione della razza, che Mussolini doveva promulgare per non irritare Hitler. Il primo anno non studiai eccessivamente, ritenendo che le mie collaudate capacità intellettuali sarebbero state sufficienti per sostenermi agli esami. D'altra parte non avevo un'idea esatta dell'importanza dei voti riportati nelle singole materie per la determinazione di quello finale di laurea. Invece di studiare a fondo sugli appunti da prendere ascoltando le lezioni, perché di solito mancavano le dispense, leggevo decine di libri, fatto che, se era utile per farmi una più ampia cultura sull'argomento, dal punto di vista strettamente esamistico era negativo. Cominciai abbastanza bene avendo riportato un "30" in mineralogia ed un "27" in chimica generale ed inorganica. Invece ebbi immeritatamente un "24" in matematica, materia in cui ero preparatissimo. D'altra parte, reso presuntuoso dal successo negli esami di maturità, unico tra tutti i miei compagni, avevo voluto dare tutti gli esami nella sessione di luglio. Il secondo anno le cose andarono meno bene. Ebbi solo 24 in chimica organica essendomi preparato su vecchie dispense in cui c'erano delle formule errate. Il Prof. Contardi si infastidì delle mie proteste dicendomi che avrei dovuto studiare sulle nuove. Soprattutto mi andò male l'esame pratico di Chimica Qualitativa, sebbene avessi fatto in modo esatto l'analisi d'esame. Durante l'anno non avevo mai pietito dietro gli assistenti per farmi aiutare, essendo convinto che quelle analisi avessero solo uno scopo pedagogico. Invece il professore si riferì proprio ad esse, che erano spesso sbagliate, per darmi il voto, asserendo che "non avevo lavorato abbastanza". Non nascondo che mi infuriai anche perché quel risultato negativo veniva a corroborare l'opinione di mio padre sul mio conto, secondo la quale ero " pasticcione" e "poco positivo". Purtroppo ad ottobre, quando mi ripresentai per quell'esame, perdurava ancora la malaugurata influenza delle esercitazioni fatte durante l'anno e non fui di nuovo ammesso all'orale. Probabilmente influirono contro di me le proteste a suo tempo sollevate che, avendo fatto in modo esatto l'analisi d'esame avrei dovuto essere promosso. La cosa era seccante perché rischiavo di non essere ammesso al terzo anno e dover quindi cambiare università ripiegando su quella di Pavia come tanti altri miei compagni. Aver superato l'esame di Chimica Analitica era considerato indispensabile da Cambi, preside del triennio di specializzazione in Chimica Industriale, professore famoso per il suo rigore ed il carattere dispotico, tanto da essere designato come "il padrone". Ma egli non era in buoni rapporti con il Prof. Sborgi, a sua volta "padrone" del biennio e trovando che in complesso i miei voti erano abbastanza buoni e soprattutto per il "27" riportato in Chimica Generale, mi accettò. Credo che abbia trovato una contraddizione nel fatto che ero stato trovato bravo in chimica inorganica dal punto di vista teorico e non nelle applicazioni pratiche. Devo invece convenire a questo proposto che in tutti i lavori sfocianti in attività manuali, si tratti di scienza o di attività delle vita quotidiana, sono un "disastro", come suol dirsi. Forse spinto dal carattere ansioso sono indotto a fare presto piuttosto che bene. Sospetto anche che sulla mia la mia bocciatura abbia avuto qualche influenza l'ecatombe di bicchieri, filtri e vetreria in genere da me provocata. Per fortuna nella vita non mi è toccato di dover fare analisi chimiche. Umiliato da quanto mi era accaduto, decisi di cambiare sistema e fare come i miei compagni, cioè lasciare alcune materie per la sessione autunnale e prendendo appunti studiare a fondo solo ciò che dicevano i professori in lezione. Feci un'alleanza con Carlo Fornara ,il più bravo dei miei compagni, studiando insieme con lui. Ovviammo alla difficoltà della mancanza dei libri di testo scrivendo le dispense di molti corsi. Prendevamo separatamente appunti alle lezioni, poi li confrontavamo e compilavamo il testo. Il peso del lavoro gravava però soprattutto sulle mie spalle, perché con la mia macchinetta da scrivere dattilografavo il testo con la carta carbone in più copie. Per altro avevo a questo proposito una certa esperienza avendo l'anno precedente scritto le dispense del difficile corso di fisica, tenuto da Polvani, senza dire nulla al professore. Avevo dato le copie a Fornara ed a qualche altro, che fecero sulla loro scorta brillanti esami. Non fu invece così per me. Dopo aver iniziato brillantemente, riuscendo addirittura a citare lo spazio curvo secondo Einstein, facendo certamente la figura del presuntuoso, mi bloccai su una sciocchezza , cioè non ricordavo la lunghezza di un angstrom. Polvani si infuriò e voleva darmi un "18". I membri della commissione, tra i quali c'era Bozza, il professore con il quale dopo mi sarei laureato e finì la sua carriera come rettore del Politecnico, intervennero. Dopo un concitato dibattito Polvani dicendomi: "non io, ma la commissione ti dà "24" buttò il mio libretto sui banchi dell'anfiteatro. Mentre andavo a raccattarlo aggiunse: "quando sarai sul letto di morte ricordati come tuo ultimo pensiero, che un angstrom è 10 elevato alla meno 8 centimetri". Non sono ancora sul letto di morte, ma una delle poche cose di fisica che ricordo è questo valore. Nel terzo e quarto anno d'università studiai in modo pazzesco. Tutte le mattine eravamo impegnati con le lezioni, tutti i pomeriggi con il laboratorio. Stavo con i miei libri e la macchinetta da scrivere fino a tarda notte. Rinunciai ad andare la domenica pomeriggio al cinematografo con mia madre. Erano il senso del dovere e l'amor proprio che soprattutto mi spingevano, trattandosi di argomenti che in definitiva mi interessavano poco. Con Fornara scrissi anche in forma ufficiale, cioè con il consenso del professore e la pubblicazione in edizioni curate dal Guf, che per altro comportavano un modestissimo compenso, anche i corsi di Chimica - Fisica e di Elettrochimica, tenuti dal giovane e brillante Prof. Piontelli. Agli esami arrivavo così stanco del lavoro, che non sempre brillavo come avrei meritato. Comunque fui senz'altro annoverato come il più bravo dopo Fornara e la mia media salì rapidamente con la stessa progressione con cui quella di molti miei compagni scendeva. Con Fornara ero diventato inseparabile così come lo ero stato con Zeltzer, il quale ora si era un po' allontanato da me sebbene abitasse a Milano pur frequentando a Pavia i corsi universitari. Insieme con Fornara lavoravo anche in laboratorio. Un giorno esperimentavamo sotto la cappa una bromurazione. Il bromo è un liquido che emette vapori estremamente irritanti ed è molto pesante. La pipetta da cui lo facevamo gocciolare non era bene ingrassata e l'operazione sfuggì al nostro controllo, il bromo venne giù a rivoli. Sentendo i vapori irritanti chiusi la cappa, spalancai la finestra e trascinai con me il riluttante Fornara, che avrebbe voluto restare per terminare l'esperimento. Gli imposi di venire con me al cinema ed egli mi confessò che da anni non ci andava preferendo studiare anche la domenica pomeriggio. Ovviamente mi superava non solo come chimico, ma anche come schiavo del lavoro. Anni dopo seppi che, diventato ufficiale, dopo il corso al Reggimento Chimico (in esso ci eravamo ritrovati per qualche tempo facendo il servizio militare dopo la laurea), era morto in laboratorio intossicato proprio dal bromo. Non ebbi il coraggio di chiedere notizie più precise a sua madre, una vedova che viveva solo per idolatrarlo. Alla fine del quarto anno diedi tutti gli esami, compresi i tre del famoso Cambi, cioè Chimica Industriale Inorganica, Chimica Industriale Organica e Metallurgia. Era prassi darli come ultimi e nessuno ci andava tranquillo perché l'imprevedibile"Padrone" tra l'altro si lasciava guidare da simpatie ed antipatie. E' inutile dire che mi presentai quasi tremando pur essendo certo che non gli ero antipatico. Infatti un giorno mentre sedevo nel primo banco attento a non perdere una sillaba, mi disse: - scrivi esattamente queste parole...." e ripetette la frase. Poi aggiunse: - presso gli egiziani gli scribi avevano tale importanza che il Faraone...(disse un nome che mi sfugge) diede ad uno di essi in moglie la figlia. Non posso fare lo stesso con te, dato che non ho figlie. - Al mio stupore per queste parole, rivolgendosi ai tre professori che per dare orpello a tanto maestro assistevano sempre alle sue lezioni, indicando me, aggiunse: -osservate la sua testa di dolicocefalo mediterraneo, la razza eletta, confrontatela con quella di questo brachicefalo della valle padana- ed indicò un mio compagno seduto dietro, che in verità era uno dei meno bravi. Mi presentai tremebondo agli esami ed egli mi chiese:-vieni per farli tutti e tre?- Ed avendo io annuito tornò a domandarmi:- quali voti vuoi?- Rimasi senza parola, non osando rispondere. Ed allora scandendo le parole aggiunse: -In Chimica industriale inorganica "30" lo merito solo io; perciò a te posso dare un "28", della organica non si sono mai occupata e sono certo che a te l'hanno insegnata bene. Perciò ti posso dare "30"; in quanto alla Metallurgia possiamo fare una via di mezzo. Ti va un "29"? Stupefatto risposi di si. Egli allora di alzò in piedi, puntò l'indice contro di me e soggiunse: - ti dico allora che sei fesso e fesso resterai per tutta la vita, perché se mi avessi detto di volere "30" in tutte e tre le materie te li avrei dati". Quindi andò via ordinando al suo assistente Jacini: -interrogalo fino a quando ritorno. -Tardò moltissimo a tornare ed il povero Jacini ad un certo punto non sapeva più cosa chiedermi. Convenni che questo trattamento riserbatomi dal "Padrone" che, a quanto ne so, non aveva precedenti, era il premio che mi spettava per quanto avevo lavorato. Chiesi e naturalmente ottenni una tesi di laurea sugli olii ed i grassi, cioè il settore in cui da industriale operava mio padre. Me ne fu assegnata una sulla ossidazione delle paraffine per trasformarle in acidi grassi, relatore il Prof. Bozza, di origine ingegnere, ma talmente dotto in chimica da aver aggiornato con note il famoso trattato di chimica analitica di Treadwell. Come ho detto, dopo la guerra fu nominato rettore del Politecnico. Fui abbandonato a me stesso da Bozza , al quale l'argomento non interessava e che venne solo una volta nel laboratorio ove lavoravo ma solo per insegnarmi come si saldano i tubi di vetro. Il caso volle che mio fratello, studente al Politecnico e divenuto beniamino del famoso Prof. Natta, luminare che sarebbe stato insignito del premio Nobel per la chimica, si fosse imbattuto in una pubblicazione tedesca sull'argomento della mia tesi. Infatti in Germania si era riusciti addirittura ad ottenere olii commestibili dalla paraffina. Mi procurai subito il trattatello, ignorato da Bozza e dagli altri miei professori, e lo saccheggiai spudoratamente. In quanto alla parte sperimentale della tesi inventai esperienze e fantasiose interpretazioni dei loro risultati. Avevo tentato di determinare il peso molecolare dei prodotti delle mie ossidazioni. Dovevo ricorrere al metodo ebullioscopico, ma per un "pasticcione" come me non c'era da pensare che potessi ottenere un qualche risultato plausibile. Ad esempio, bastava avvicinarsi al becco Bunsen, che scaldava l'apparecchio, perché per il movimento della fiamma si avessero risultati assurdi. Ma finsi di aver fatto tutto per benino ed a essere pervenuto a risultati importanti. Il "Padrone" mi aveva rimproverato di non essere furbo, mi ritenevo in un certo senso da lui autorizzato a darmi da fare per diventarlo. La tesi fu molto apprezzata e sebbene avessi una media solo di "27", ebbi il massimo dei voti, fatto piuttosto raro all'Università di Milano. Fornara ebbe in più la meritatissima lode. Dovevo convenire però che al successo scolastico corrispondeva un mio immiserimento culturale. Leggevo soltanto romanzi di secondo piano come quelli di H.G. Wells o di J.London. Il mondo plebeo, tramite la chimica ruffiana, mi aveva preso tra le sue spire e credevo di non avere altro ideale oltre a quello di diventare un bravo tecnico in attesa di essere un grande industriale come mio padre. Ma provavo tuttavia un senso di insufficienza, sentivo di aspirare a qualcosa di eccelso che non identificavo bene o meglio che avevo dimenticato. Da ragazzo ero stato attratto dal richiamo maliardo di una cultura di ben altra natura. Su tutti i miei atteggiamenti si ripercuoteva una sorta di sfasamento, che si ripercuoteva spesso sui miei rapporti con il prossimo. Troppo ero avanti negli anni quando mi fu concesso per la prima volta di uscire solo di casa. Forse mio padre non si rende conto che non sarò mai un grande industriale ed una persona che sa badare ai suoi interessi, in conseguenza di questo fatto. Io ero l'unico tra i miei coetanei che non parlasse di donne e non si vantasse di successi con esse, l'unico che non raccontasse barzellette e non sentisse il bisogno di denaro. Per molto tempo la sola idea di avvicinare una donna mi spaurì e quando finalmente mi decisi al gran passo, rimasi quasi nauseato. Con colori troppo smaglianti la mia fantasia di adolescente aveva vagheggiato la femminilità perché non rimanessi insoddisfatto della volgarità e della grossolanità di quelle che si concedevano solo per denaro. Ero decisamente un introvertito che non riusciva ad inserirsi armoniosamente nel consorzio dei suoi simili. Ma qualche volta, forse per reazione alla consapevolezza della mia timidezza e fragilità, reagivo in modo sproporzionato ed addirittura spettacolare. Ricorderò sempre i giorni in cui si attendeva l'entrata in guerra dell'Italia. Come quasi tutti i miei compagni, ero convinto che essa sarebbe stata un funesto errore in base alla semplice considerazione che restando neutrali ci sarebbe andata bene un ogni caso: se avesse vinto Hitler avremmo beneficiato del vantaggio di essere suoi amici, se gli altri di non averli voluto attaccare alla Maramaldo. Di quest'argomento all'università per un certo tempo si parlava abbastanza liberamente. Cambi, consigliere nazionale fascista, era ovviamente per la guerra ed un giorno si sfogò in lezione con noi contro Piontelli, che essendo di opposto avviso, a conclusione di una discussione gli aveva sbattuto la porta in faccia. Ma successivamente, evidentemente in seguito ad ordini venuti dall'alto, le cose cambiarono. Perciò un giorno mentre esprimevo il mio punto di vista fui violentemente apostrofato ed insultato da un compagno, che aveva la carica di capo della gioventù universitaria fascista (Guf). Gli altri, pacifisti e fino ad allora spacconi, non dissero parola, ma io per tutta risposta presi a schiaffi il gerarchetto. Si verificò così per la prima volta un evento che molte volte si sarebbe ripetuto nel corso della mia vita. In condizioni normali le persone si fanno avanti e si proclamano capaci di grandi azioni, non nascondendo una sorta di compatimento nei miei riguardi; ma quando le cose si fanno serie, le loro bellicose schiere si sgretolano ed io resto solo in prima linea. Allora acquisto automaticamente grande sicurezza e coraggio. La cosa si seppe e Piontelli stupito che proprio io, ritenuto mite e del tutto inoffensivo avessi osato tanto, mi cercò per stringermi la mano. In quell'occasione fui in un certo senso orgoglioso di essere siciliano, cioè di provenire dal paese della mafia. Tenendo sul banco ove sedevo un coltello aperto, accusai il gerarchetto di essere pagato dai tedeschi e lo minacciai che se avesse fatto una denuncia contro di me mettendomi nell'impossibilità di trattarlo come meritava, sarebbe venuto dalla Sicilia qualcuno per fargli la pelle. Egli tacque e non mi diede alcun fastidio. L'ultimo anno di università la domenica mattina si doveva fare il corso "premilitare". In divisa fascista, inquadrati in un plotone, un gerarca comandava le solite esercitazioni: avanti march, fianco destro, fianco sinistro, ecc. Io, abituato la domenica a lavorare accanitamente, ero indignato per dover sprecare così prezioso tempo. La situazione divenne poi intollerabile quando il gerarca vedendo sul cappello universitario mio e di mio fratello le cinque striscie indicanti che eravamo al quinto anno, cioè due più avanti di tutti gli altri, ci insolentì in modo assurdo e balordo, diffidandoci a non darci arie nei suoi riguardi. Mi fu poi detto che aveva un figlio della nostra età, ma così cretino da non essere riuscito a prendere la licenza liceale. Comunque giunto al colmo dell'esasperazione decisi, seguito da mio fratello, di non andare più a quelle esercitazioni. Era una decisione sbagliata perché senza il certificato di aver prestato il servizio premilitare, chiamati alle armi dopo la laurea, non avremmo potuto fare il corso allievi ufficiali, cioè avremmo dovuto partecipare alla guerra da soldati semplici. Per fortuna, quando a suo tempo venuto a conoscenza della cosa ed ormai deciso di comportarmi da furbo, mi recai alla sede del Guf e feci le richieste per me e mio fratello. Quando tornai per ritirare i certificati ovviamente non avevano trovato nulla. Mi dissero che dovevano fare altre ricerche. Ritornato ancora recitai molto bene la parte dell'indignato, asserendo che nell'Italia fascista tanta disorganizzazione ed inefficienza erano intollerabili. Fui rabbonito e poco dopo i due certificati mi furono dati. di Giuseppe Vaccarino Prima parte
Scaricare